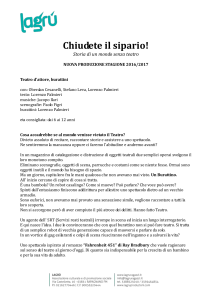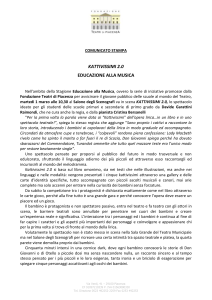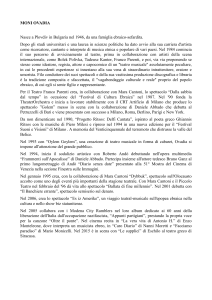Clelia Falletti
Teoria e storia della scenografia
Saperi e tecniche dello spettacolo teatrale, cinematografico, digitale – I anno
Sul significato politico della struttura scenica
mediadass edizioni
INDICE
1. Béla Balázs, Sul significato politico della struttura scenica, da: Béla Balázs, Scritti di teatro.
Dall’arte del teatro alla guerriglia teatrale, a cura di Eugenia Casini Ropa, Firenze, La
Casa Usher, 1980, pp. 87-88
2. Béla Balázs, Ruggisci Cina!, da: Béla Balázs, Scritti di teatro... cit., pp. 89-91
3. A. Gvozdiev, Ruggisci Cina!, 23 gennaio 1926 (trad. dal francese di Giusy Pignotti)
4. Konstantin Rudnitski, Du «masque social» au portrait théâtral, da: Konstantin Rudnitski,
Théâtre russe et sovietique, Paris, Editions du Régard, 1988, pp. 197-198 (trad. dal francese
di Giusy Pignotti)
5. Béla Balázs, La teoria del dramma: Festa e spettacolo, da: Béla Balázs, Scritti di teatro...
cit., pp. 33-37
6. P.M. Keržencev, Il teatro creativo. Teatro proletario negli anni ’20 in Russia, Roma,
Bulzoni, 1979, pp. 179-181
7. Clelia Falletti, 3. Musici commedianti, scenografi e ballerini nei teatri pubblici di Venezia,
da: Clelia Falletti, Teatro italiano. II. II Cinquecento e Seicento, pp. 270-282
8. Scenotecnica nel Seicento: Illustrazioni
9. da Jean Dubuffet e da George Braque: Riflessioni sulla visione (tradotte da Giusy Pignotti)
10. Susan L. Foster, brani da: Coreografia e narrazione, Roma, Dino Audino Editore, 2003, pp.
pp. 5-11 passim, 63-64, 68, 78-84, 155-56, 160, 244-46, 265-66, 273-74
11. Scenotecnica nell’Ottocento: Illustrazioni
12. Max Milner, La Fantasmagoria. Saggio sull’ottica fantastica, Bologna, Il Mulino, 1989, pp.
257-263
13. Clelia Falletti, Max Reinhardt
1
Béla Balázs, Sul significato politico della struttura scenica
C’era una scena molto prima ancora che esistesse una letteratura drammatica e ci sarà una scena
quando questa sarà sparita da un pezzo. L’architettura scenica ha una storia sua propria che,
indipendentemente dalle opere che in essa vengono rappresentate, con ogni variazione determinante
nella struttura costituisce un’espressione simbolico-architettonica del sentire del tempo. (In tempi di
anarchia spirituale si recitano spesso nuove opere su vecchie scene, ma anche vecchie opere su
scene nuove). Il dispositivo scenico su tre piani e con tre ripartizioni della Piscator-Bühne, con gli
schermi cinematografici, su cui è stato rappresentato Hopplà, noi viviamo!, potrebbe avere un senso
del tempo, quindi un significato politico, anche di per sé come architettura, indipendentemente
dall’opera di Toller. Tanto più che non rappresenta un’invenzione occasionale, eccezionale, ma in
una parte del teatro sovietico è già arrivata alla forma stabile della “macchineria teatrale”.
Un esempio storico ben noto serve di chiarificazione. La scena costruita su tre piani dei misteri
medioevali era anch’essa una struttura fissa. Quella costruzione a tre piani che indicavano il
sovrapporsi di inferno, terra e cielo, poteva rimanere fissa indipendentemente dalle opere
occasionali, perché era la proiezione architettonica della stabile e precisa visione del mondo che
avevano i contemporanei. Quei nostri antenati, essendo realmente contemporanei, non recitavano
opere che non fossero generate da questa comune visione del mondo. Vedevano e vivevano tutto
sub specie aeternitatis e le costruzioni a tre piani della loro scena erano la rappresentazione
schematico-simbolica della loro aeternitas.
Il significato delle strutture sceniche della nuova Russia e di Piscator mi sembra essere questo: si
tratta anche qui della rappresentazione simbolica di una visione del mondo, soltanto non mistica, ma
sociale. Determinante sia qui che là è la presenza globale dell’intera visione del mondo. Come nella
scena medievale dei misteri dove l’inferno sotto la stanza del contadino e il cielo sopra erano
visibili contemporaneamente, così anche qui ogni scena e scenario è soltanto un angolino del tutto
sempre presente e che si vede interagire. Anche il più intimo stralcio di vita appare, già attraverso
l’allestimento scenico, come una parte organicamente condizionata della totalità. Una idea politica
espressa attraverso la struttura scenica.
2
Béla Balázs, Ruggisci, Cina! (1)
Ci darà — speriamo — ancora molto da pensare. Mejerchol’d il regista del teatro rivoluzionario di
Mosca, non ha avuto un particolare successo nella rossa Berlino con Ruggisci, Cina!. Invece Fritz
Peter Buch, il regista dello Schauspielhaus di Francoforte, ha avuto con lo stesso lavoro un successo
enorme. E questo non perché la sua messa in scena sia stata meno tendenziosa, meno rivoluzionaria,
ma perché è stata incomparabilmente più tendenziosa, più rivoluzionaria. Entusiasmante. A Berlino
lo spettacolo di Buch sarebbe esploso come una bomba.
La spiegazione più semplice sarebbe questa: nell’Unione Sovietica la rivoluzione è divenuta realtà.
Il teatro là non è un luogo di manifestazione del fuoco, ma solo il suo riflesso. Appare un po’ più
pallido. Il teatro là non è come da noi una piccolissima valvola attraverso la quale si deve sfogare
l’eccitazione rivoluzionaria repressa. Là il teatro non lancia più scintille nel barile delle polveri.
L’esplosione c’è già stata. Il successo toglie qualcosa al valore della tendenza. A questo punto l’
arte sovietica, per così dire alleggerita, sembra dedicarsi con tutte le forze rese libere ai nuovi
compiti della ricostruzione.
(Già il gruppo teatrale operaio « Bluse blu » si era mostrato a suo tempo molto più artistico, più
esteticamente attento del nostro teatro operaio). Per quanto riguarda lo sdegno rivoluzionario, anche
il pubblico sovietico sembra essere del parere di voler vedere nel teatro “finalmente qualcos’altro”.
Per la stessa ragione qui da noi si recitano con successo drammi rivoluzionari.
Ma l’incerta accoglienza all’arte di Mejerchol’d deve avere anche altre cause. Fritz Peter Buch a
Francoforte fa giocare l’un contro l’altro eventi sociali e politici. I documenti diventano conoscenza
nel montaggio, quando fa proiettare contemporaneamente notizie di giornali e ordini del giorno,
cifre statistiche sul lavoro infantile, sui salari, la mortalità e i dividendi delle banche inglesi.
L’imitazione della piccola cannoniera sulla scena vien resa da queste cifre lugubremente viva. Il
significato diventa drammatico. La cannoniera assume l’aspetto di un potere senza forma, che punta
i suoi cannoni digrignati sul pubblico. Sul pubblico, perché i coolies, collocati nella buca
dell’orchestra, formano una massa con gli spettatori. Non sono affatto estranei e lontani, non sono
esotici. Sono il proletariato. E queste cifre con cannoni a lunga gittata le conosciamo anche noi.
Riguarda anche noi, Siamo minacciati. Questa la messa in scena di Fritz Peter Buch a Francoforte
sul Meno: dialettica scottante, raziocinio appassionato, raffigurazione scenica di concetti non
individuali, sociali e di significato politico, ratio. E contatto col pubblico. Uno spettacolo
occidentale, senza lontano esotismo, senza irrazionalità misteriosa.
Ben diverso quello di Mejerchol’d. I suoi personaggi sono esotici. Non soltanto come cinesi. Le
maschere etnografiche qui sono solo facciata e maschera di un’altra lontananza, quella lontananza
che giace al di là della nostra concettualità e in occidente viene percepita come strana (étrange),
quando la sentiamo aggirarsi in noi stessi. È l’irrazionale. A questa cosa non formulabile in parole
Mejerchol’d dà forma nel ritmo decorativo del movimento.
Per questo ha potuto fare così poco con gli europei del dramma. Lo spettacolo formato se li porta
dietro come materia prima grezza. Anche nei cinesi il “principio biomeccanico” di Meyerchol’d
appare con completezza convincente soltanto in due di loro: un vecchio coolie e un piccolo boy.
Queste sono splendide maschere del movimento. Ma perché proprio queste due figure sono così
pienamente valide? Perché ambedue sono collocate fin da principio al di fuori della ratio. Un
vecchio decrepito e un bambino. Appare in loro spiritualità senza raziocinio. Ogni gesto denso di
significato, ma come nel sogno. Ci toccano profondamente nel punto in cui ci tocca la musica.
“Emotivo” lo chiamano i russi e gli attribuiscono grande importanza. Ritmo e decoratività sono
vincolanti e a-personali. Eppure è proprio questa decoratività a troncare il contatto immediato col
nostro pubblico e con ciò ogni elementare possibilità di efficacia. Perché il danzatore si stacca coi
suoi movimenti dallo spazio comune. Egli si delinea in un fregio autonomo, chiuso, senza accesso:
il danzatore è inaccessibile.
Come ha potuto un’arte scenica così inintellettuale sbocciare proprio nell’Unione Sovietica, nel
mondo della regolarità calcolata, razionale? Che cosa può avere a che fare con lo spirito comunista
un’arte del genere? Tenterò di rispondere soltanto alla seconda domanda.
Attraverso la composizione ornamentale la massa sulla scena assume una forma. Non è più caos
amorfo. Non quell’elemento stupido e confuso, cieco e senza volto — perché così appariva sempre
la massa nell’arte borghese. Per il rivoluzionario ha un’anima, un’anima comune e perciò una
forma. E questa forma non è qui solo un ornamento imposto dall’esterno; non è “impressione”, ma
“espressione”. La massa rivoluzionaria, che non è organizzata come un reggimento militare o un
corpo di ballo, ma è un organismo vivente, ha i suoi gesti di massa e la sua fisionomia di massa,
così piena di sentimento, come può essere soltanto l’espressione di un singolo viso.
Questa fisionomia della massa rivoluzionaria in cui il singolo sparisce, ma non come in qualcosa di
più basso in cui sprofonda, questo essere collettivo animato diviene ora realmente visibile nelle
scene di gruppo di Mejerchol’d. Ha appena sette uomini in scena, ma è una massa. Non per numero,
ma per carattere. Come una briciola di pane è ugualmente pane. Perché quei sette uomini mostrano
un volto che non appartiene a nessuno di loro: è il volto della massa. Le cento comparse di Buch a
Francoforte non avevano questo atteggiamento di massa.
E tuttavia anche questa massa appare come una forma chiusa in sé. Convincente, ma non
entusiasmante; incapace di trascinare ad una discussione che si trasferisca dalla scena alla platea,
come da Piscator. Da Piscator nella Wallnerstrasse il pubblico viene accerchiato dallo spettacolo,
viene provocato alla partecipazione, trascinato, entusiasmato. Non penso certo con questo di toccare
cose trascendenti e porre la questione dell’essenza dell’arte. Ma il teatro di Piscator è senza dubbio
rivoluzionario, Così si deve fare da noi, se non soltanto la Cina deve ruggire.
“Die Weltbühne”, 15 aprile 1930.
1
Sergèj M. Tret’jakòv (1926 (N.d.T.).
3
A. Gvozdiev, Ruggisci, Cina!
(23 gennaio 1926)
Per il suo primo lavoro indipendente, Ruggisci, Cina!, V. Fiodorov trae beneficio dal metodo
utilizzato in Boubous. Lo applica nella scoperta della psicologia di Cinesi poveri che si levano nella
lotta consapevole contro l’imperialismo europeo. Per le scene cinesi, specie dell’ultimo atto, si
adotta un ritmo lento, le voci salmodianti risuonano sul fondo di uno sfumato accompagnamento
musicale, i gemiti e i gesti di dolore s’ingrossano fino a diventare la tragedia straziante di una massa
che emerge dal proprio nulla.
Sfila davanti gli spettatori un corteo di cinesi poveri, superbamente ritratti con precisione
etnografica, e le maschere degli attori si incidono indelebilmente nella memoria dello spettatore. I
volti sfiniti, le mani callose, le schiene curve e gli accenti insicuri e frammentati, molto
differenziati, fanno piazza pulita delle “cineserie” da teatro, inutili e barocche, e le sostituiscono con
una sincera penetrazione della vita del lavoratore cinese.
Lo spettacolo di S. Tretiakov, che l’autore chiama “vicenda in nove anelli”, è presentato in
modo tale da implicare un rifiuto delle regole tradizionali della drammaturgia e sostituirle con scene
libere montate a partire da episodi di vita quotidiana. Il conflitto si svolge fra una cannoniera
britannica e dei coolies cinesi, e la messa in scena mette in risalto questo elemento essenziale. Sul
fondo del palcoscenico la cannoniera si staglia molto in alto, con in suoi cinque piani sui quali sono
disposti cannoni, marinai, ufficiali, turisti, missionari e altri passeggeri della nave da guerra che
minaccia di bombardare la piccola città cinese. Una vera striscia d’acqua, con delle barche, separa
la cannoniera dal largo proscenio sul quale sono recitate tutte le scene dei coolies cinesi. La
chiarezza di questo schema rende lo spettacolo comprensibile ed accessibile. Soltanto gli episodi
europei, che mancano dello spessore nella caratterizzazione dei personaggi, impallidiscono rispetto
le maschere molto accentuate dei Cinesi, resi da un’interpretazione molto realistica. Questo
spettacolo solleva un vivo interesse non solo presso lo spettatore russo, ma anche nei rappresentanti
delle minoranze nazionali e delle popolazioni orientali e offre, per la prima volta nei teatri europei,
un’eco penetrante del destino del proletariato cinese.
Colloquio con il corrispondente della “Vetchernaia Moskva” (1926)
Un fatto svoltosi un anno fa, qui a Van-Tsian, è stato lo spunto per il tema del dramma Ruggisci,
Cina! Il villaggio di Van-Tsian è situato lungo il fiume Ian-Tsa. È uno sperduto angolo della Cina,
dove gli accaparratori di pelle europea sono giunti solo recentemente. Circa un anno fa, un
Americano rimase ucciso lottando con un Cinese sulla riva. L’Unione locale dei Battellieri, alla
quale si era rivolto per avere giustizia il comandante della cannoniera inglese che era lì ormeggiata,
rispose che il responsabile era fuggito, non volendo consegnare l’assassino. Il comandante pretese
allora che gli fossero portati, per essere giustiziati, due membri dell’Unione Battellieri, sia che
fossero implicati o meno nella vicenda. Diede anche un ultimatum di ventiquattr’ore minacciando di
bombardare il borgo se non avessero ottemperato le richieste. Per risparmiare il borgo, i battellieri
tirarono a sorte fra loro e portarono al luogo convenuto due loro compagni che furono giustiziati. Il
comandante inglese si ritenne soddisfatto e Sir MacDonald, all’epoca capo del governo laburista di
sua maestà Re Giorgio V, approvò la condotta del comandante durante una seduta della camera di
Comuni.
Per quanto riguarda i principi della messa in scena, V.F. Fiodorov ha deciso di impostare le
scene europee nello stile del Teatro delle Maschere; gli europei, con la loro posizione rispetto gli
eventi, parlano e agiscono in modo automatico, secondo degli stereotipi, dei luoghi comuni e delle
formule di comando pre-elaborate. I sentimenti umani reali, che a loro mancano, sono esclusivo
appannaggio dei Cinesi, ed è per questo che le scene cinesi sono trattate con uno stile tanto vicino
alla vita. […]
4
Konstantin Rudnitski, Théâtre russe et sovietique
Da “maschera sociale” a ritratto teatrale
[…]
Nel 1926, lo spettacolo Ruggisci Cina! di Serge Tretiakov, uno dei membri più ortodossi del LEF,
fu montato al teatro Mejerchol’d. Fu subito evidente che questa opera aveva perso la coerenza che
aveva caratterizzato le produzioni della scuola, e che al contrario mostrava delle sintomatiche
contraddizioni. Il sistema fino ad allora compiuto ed integro del “teatro della maschera sociale”
mostrava segni di rottura.
In parte, ciò si spiegava col fatto che a curare la messa in scena fosse stato il giovane Vassili
Fedorov, invece che lo stesso Mejerchol’d. Il maestro non aveva fatto altro che correggere la prima
dimostrazione autonoma di un allievo dotato; aveva apportato delle importanti modifiche, senza
poter cancellare la rottura di tono che la messa in scena manifestava.
Tretiakov aveva estrapolato il soggetto da un articolo di giornale relativo ad un uomo d’affari
inglese trovato accidentalmente morto in Cina, annegato nello Yang-Tse-Kiang. Il comandante
della cannoniera inglese sulla quale si trovava l’uomo, non riuscendo a scoprire i colpevoli della
morte, aveva ordinato l’esecuzione di due giovani marinai cinesi sorteggiati a caso. “Tali furono i
fatti, ho dovuto cambiarli solo un poco” dichiarò orgogliosamente Tretiakov nel prologo del suo
spettacolo. Lo spettacolo non si limitava dunque a presentare “i fatti”, tesseva gli elogi delle azioni
di taluni dei suoi personaggi.
Il regista si era basato su una divisione semplicissima dello spazio: la parte bassa della scena
apparteneva ai cinesi poveri e oppressi, la parte superiore era il dominio dei colonizzatori europei,
caratterizzati dal pronome “loro”, mentre i Cinesi erano “noi”. Una barriera separava “loro” da
“noi”: un fossato riempito d’acqua (percepibile solo dai palchi, invisibile invece dalle poltrone di
platea), delle giunche cinesi scivolavano sull’acqua e più distante si distingueva la mole minacciosa
della cannoniera. I cannoni erano puntati sui coolies cinesi e dunque, anche sul pubblico.
Lo spettacolo induceva una divisione della scena in due parti poiché riguardava due gruppi
antagonisti, gli Europei e i Cinesi. Il regista decise di accentuare questo contrasto rappresentando i
cinesi con dei tratti autentici e gli europei attraverso caricature. In questo modo, le “sezioni” cinesi
dello spettacolo erano animate di una vera vita, mentre le “sezioni” europee davano l’immagine
esasperata di una “Europa del fox-trot”. Ufficiali arroganti con uniformi cariche di decorazioni,
turisti con mogli disinvolte, missionari untuosi e bambinaie civette; nessuno di questi personaggi
era diverso da quelli dello spettacolo D.E. Per i Cinesi tutta un’altra storia. Per quello che li
riguardava, il Teatro Mejerchol’d si scoprì con un gusto sconosciuto per l’esattezza etnografica:
nella riproduzione dei costumi, dei dettagli della vita quotidiana e delle abitudini. Fu allestita
un’intera collezione di strumenti musicali per la messa in scena. Dalla Cina fu importata una grande
quantità di oggetti diversi. Degli studenti cinesi di Mosca furono invitati alle prove per verificare
l’esattezza dei gesti e dei dettagli della vita quotidiana. In scena comparivano oltre a marinai e
portinai d’albergo, anche portatori di risciò, mercanti di confezioni, venditori di ventagli, un
barbiere, un pedicure, un arrotino e così via.
La rappresentazione iniziava con una scena eccessivamente lunga (durava dieci minuti) in cui dei
coolies cinesi caricavano nelle stive della nave centinaia di balle di thé.
Nonostante eccessi di questo genere, lo scopo fu raggiunto: invece delle solite false “cineserie”, il
pubblico poté contemplare dei veri quadri di vita cinese, di rara precisione. Le scene di folla
ricordavano quelle del primo TAM e nei resoconti abbondarono gli epiteti “ etnografico”,
“dimesso”, “terra terra”, ecc. La scena dell’esecuzione dei due cinesi, “mostrata con tutti i dettagli
ripugnanti”, scosse la critica. Su questo episodio, Markov scrisse ironicamente che certamente
suscitava l’indignazione verso i colonizzatori, ma allo stesso tempo “dava voglia di protestare anche
con il regista”. Le “sezioni” cinesi dello spettacolo colpirono più che gli episodi caricaturali degli
europei. “La borghesia che imputridisce al suono del fox-trot” confessa Sergej Radlov, “non suscita
la collera, ma la depressione”. La delicata figura del ragazzo cinese interpretato dalla Babanova,
aveva un ruolo a parte nella rappresentazione dualistica della messa in scena. Il ragazzo cinese,
servitore degli europei, stava dalla loro parte della barricata che separava i bianchi dai gialli.
Babanova, che recitava en travesti per la prima volta, sottolineò eloquentemente la tragedia di vita
di questo adolescente in mezzo a padroni irriducibilmente stranieri, recitando con precisione e
passione i contrasti fra la levigata disciplina di un servo obbediente e gli improvvisi accessi di odio
contro i suoi oppressori. Verso la fine dello spettacolo, il ragazzo appare solo sul ponte vuoto della
nave. Babanova canta in sordina una canzone melanconica e cade in ginocchio, congiungendo le
mani nella posa della preghiera; poi salta in piedi e corre fino all’albero maestro e si arrampica.
Con gesti abili fa in fretta un nodo scorsoio, con la paura di essere scoperto. Un instante dopo la
sottile figurina con un ultimo sussulto delle spalle, penzola al pennone. Tale è stato l’apogeo tragico
della rappresentazione, meravigliosamente composto dal regista e reso alla perfezione dall’attrice.
Complessivamente, la messa in scena non si scostò dal sistema di opposizione diretta fra
oppressori e oppressi che era la regola delle pièces di agitazione e propaganda agli inizi degli anni
Venti. Ma Mejerchol’d riuscì a concludere l’azione in modo molto efficace. L’intera scena
cominciava a sussultare e la cannoniera avanzava minacciosa verso la riva, ossia la ribalta dove era
raccolta la massa dei cinesi ammutinati. Allineati sul ponte, i marinai inglesi preparavano le armi e i
coolies li fronteggiavano, immobili di fronte alla morte.
Questo finale sollevò degli applausi frenetici, tuttavia le acclamazioni non furono dirette a tutto lo
spettacolo, ma a quest’ultima scena e alla Babanova.
Nel 1927, Sergej Tretiakov dovette ammettere con reticenza, che la messa in scena “costruita da
una parte come uno studio etnografico e dall’altra come un articolo di giornale, apparve alla
maggioranza del pubblico come un semplice e toccante spettacolo esotico”.
[…]
5.
Béla Balázs, La teoria del dramma: Festa e spettacolo
Nel 1920, nell’anniversario della rivoluzione comunista, si svolse a Pietrogrado una grande
rappresentazione, una grande pantomima che simboleggiava la rivoluzione. Il palcoscenico era
rappresentato da un colonnato sotto il cielo aperto in cui agiva una folla che si contava a migliaia.
Dalla più grande piazza di Pietrogrado vi assisteva l’intera popolazione della città. Fra gli spettatori
e gli attori c’era una strada, Una scena dello spettacolo rappresentava la sfilata dei marinai di
Kronstadt. A recitarla erano gli stessi marinai di Kronstadt sugli stessi carri armati e la via che
passava davanti al colonnato era la stessa strada che aveva-. no percorso il giorno della rivoluzione.
Realtà che si ripeteva in dramma, realtà irrigidita in una forma ripetibile, realtà che la ripetizione
faceva emergere dalla corrente del tempo che fa tutto trascorrere. Ripetizione, quindi
rappresentazione. Ripetizione, quindi fermata. Fermata, quindi spettacolo.
La strada davanti al colonnato, su un marciapiede della quale si svolgeva Io spettacolo e sull’altro
stavano ad assistere gli spettatori, si riempì dei marinai che sfilavano e venne a cessare il confine fra
attori e pubblico. Da quel momento l’avvenuto contatto trascinò con sé dentro lo spettacolo la folla
che guardava, e quella rappresentazione divenne una specie di cerimonia festosa del popolo
entusiasta di Pietrogrado.
E fu come se vedessimo il ricominciare del cerchio immane di uno sviluppo millenario concluso. La
tragedia è nata dall’inebriato coro di massa delle feste dionisiache greche. Ma il cordone ombelicale
si è spezzato e il dramma si è sviluppato in ben altra direzione. Si è fatto intimità estetica di teatri di
corte, champagne di séparé spirituali, mentre al popolo ha fatto ritorno solo in forma di cadavere
rancido e corrotto. Ora è come se il cordone ombelicale spezzato volesse di nuovo riattaccarsi, è
come se il coro volesse riconquistare il dramma che dal coro è nato. Giunge a conclusione il volgere
di un periodo colossale. Forse qualcosa ha avuto termine.
Ora è il momento di fare delle riflessioni sulla natura del dramma, . forse proprio perché siamo al
crepuscolo del dramma inteso nel senso di un tempo. La civetta di Minerva inizia il suo volo di sera
***
L’arena greca, in cui ebbe origine il dramma europeo, era chiusa all’intorno da un muro verso la
vita terrena, ma era aperta verso l’alto. È questo il puro simbolo della festa. Perché quando gli
uomini fanno festa, le loro azioni e la loro disposizione d’animo non sono collegati mi per le
intenzioni né per il fine al domani e le loro cause non sono nate dall’ieri. L’azione festiva si distacca
dalla catena ininterrotta delle cause e dei fini. La festa, rispetto alla vita, è isolata e completamente
circondata, entro il tempo, come l’arena. È aperta soltanto verso l’alto. Questa totalità chiusa in se
stessa della festa fa sì che sia l’isola di uno stato fisso nel fiume della vita. Per questo nella vita
nulla è ripeti- bile, solo la festa e l’arte. Perché la vera arte è l’immagine dell’uomo totale. E se
anche non rappresenta l’uomo festivo, tuttavia l’artista che l’ha rappresentato l’ha guardato con
occhio festivo. Guardare l’uomo, rappresentare l’uomo, è un atteggiamento festivo. Non ha una
causa pratica, non ha uno scopo pratico. È come la cerimonia dell’ostensione dell’ostia; ostensione
dell’uomo. Non l’ha causata l’ieri e non sarà la causa del domani. È aperta soltanto verso l’alto.
Le azioni festive si distaccano dal corso continuo degli eventi della vita come i suoni di una melodia
dal corso ininterrotto delle voci e dei tumori. Perché l’intera melodia è già presente quando si
innalza il suo primo suono; già allora è una totalità a sé stante, dal significato completo. Appare nel
susseguirsi l’un l’altro dei suoni, ma non nasce da loro e con loro. Con alcuni eventi della vita nasce
“la vita”. Ma la festa vive a priori; non la fanno nascere le cerimonie. Anche la frase, tutta insieme e
come totalità, esiste già quando esprimo il soggetto, anche se poi il predicato viene espresso molto
più tardi. Anche qualunque arte è una simile totalità senza tempo. E anche le arti temporali, la
musica e il dramma. Qui sta la stretta parentela, la interdipendenza radicale tra il dramma e la
cerimonia festiva da cui è sorto.
***
Nella tremenda macchina della società d’oggi le cose sono diventate merci e gli uomini funzionari
Il rapporto degli uomini tra loro è quello tra lavoratori e datori di lavoro, rapporto d’ufficio o
d’affari fra impiegati e clienti, non rapporto umano. Solo nell’amicizia e nell’amore e in alcuni
rapporti personali riusciamo a infrangere questa orrenda catena della disumanizzazione. L’adunata
festiva è il solo stato degli uomini in cui essi si trovano insieme coi loro simili in un rapporto non
individuale e tuttavia umano. E anche l’adunata del dramma autentico. Con la decadenza della
religione questo significato e valore della ecclesia e della adunanza cessò. Ma ai sentimenti degli
uomini l’un verso l’altro sono state offerte nuove possibilità. Gli abitanti di Pietrogrado che
assistevano a quella rappresentazione festiva non si trovavano certamente gli uni con gli altri in un
rapporto personale individuale, tuttavia sentivano una profonda, reale, umana comunanza.
Così sono strettamente accomunati festa, dramma e pubblico.
Il pubblico
Se guardo a volo d’uccello nel suo insieme e ingenuamente 1’ “istituzione” teatro, osservo questa
stranezza: degli uomini, che tutto il giorno partecipano alla vita, tutte le sere, a migliaia, si radunano
per vedere com’è la vita, per veder quel che loro avviene.
Dobbiamo esaminare questa descrizione del fenomeno teatro quasi parola per parola, per chiarire il
significato e la natura di questo particolare e per così dire esotico rito.
Cominciamo anzitutto dal termine “si radunano”. Il primo e il più grande problema del teatro è
proprio il pubblico. Perché ogni piacere estetico è solitario. Ogni altra arte è un evento intimo di
anime isolate, anzi il suo effetto estremo è proprio questo, che l’arte, mettendomi di fronte ad un
mondo già formato, univoco, costringe anche me all’univocità e mi ridesta ad un aristocratico,
solitario me stesso. Perché mai il teatro differisce, nella sua radice più profonda, da qualsiasi altra
arte? Vi sono dei raffinati “goditori” che credono che anche a teatro sarebbe meglio sedersene da
soli e che il fatto che ci sia il pubblico sia dovuto soltanto a cause materiali e tecniche. Ma chi ha
visto un dramma rappresentato in un’arena (o anche solo un’arena vuota con gli occhi della
fantasia) non parla più così. All’effetto portentoso delle rappresentazioni di Reinhardt nel circo
nemmeno i più raffinati riuscivano a sottrarsi. Eppure lo spettacolo era lo stesso del Deutsches
Theater. Il dramma era lo stesso, gli stessi gli attori; salvo una leggera differenza, per- fino
l’allestimento era lo stesso. Che cosa provocava allora quella grande differenza? È chiaro; non lo
spettacolo, ma il circo. Non gli attori, ma il pubblico per il fatto di essere visibile. Per il fatto che si
stava seduti di fronte, in piena luce, consapevoli l’uno dell’altro, senza scordarsi neppure per un
minuto l’uno dell’altro, sentendosi a vicenda sotto il dominio delle stesse impressioni, vedendo
l’uno sul viso dell’altro il medesimo effetto, tutti nello stesso tempo e in comune! Questo è il
segreto dell’effetto dell’arena: l’emozione comune, il senso della sorte comune che riguarda rotti
nello stesso tempo. Questo è quel che si differenzia da qualsiasi altra emozione artistica, quel che
costituisce la natura intima del teatro. E questa è un’esperienza non estetica, ma religiosa.
Presso gli ebrei non si può tenere il servizio divino se non c’è minjan, se cioè non si trovano
insieme almeno in dieci. Perché la fede non può essere qualcosa di soggettivo e individuale, non
può essere una esperienza intima, privata. Il paradosso della fede è questo: che ciò che vive più
intimamente, più profondamente all’interno delle nostre anime, è proprio quanto c’è di più comune.
Ma finché siamo soli con esso, invano cerchiamo di esternarlo e la più profonda tentazione e
pericolo di ogni persona religiosa è la soggettività e l’estetismo. La nostra fede in una realtà che
esiste anche fuori di noi, possiamo sentirla soltanto nel momento in cui anche altri sentono
contemporaneamente la stessa cosa. Ogni “ visione” ha una sola dimensione, e solo nella visione
dell’altro può esistere la seconda dimensione della mia.
Non a caso quindi sia il dramma antico che il moderno si sono sviluppati ugualmente da un rito
religioso. Anzi la tragedia greca fu “pubblica” prima ancora di diventare dramma. Il pubblico, la
folla furono il seme e la radice del dramma greco, perché prima di ogni altra cosa ci fu il coro
dionisiaco. Le «dionisiae» furono una festa panteistica, il simbolo della cessazione
dell’individualità, l’ebbrezza di un rifluire e dissolversi nell’unità primigenia. La folla dionisiaca
perciò non è un gruppo di singoli individui, ma il simbolo della fusione: il dissolversi dell’uno
nell’altro.
Nella tragedia attica si trattava proprio di questa comunione che il pubblico simboleggia e
rappresenta, di una visione che pervade noi tutti in un sol modo e tempo. Il coro della tragedia greca
rappresenta sulla scena questo pubblico. « Il pubblico della tragedia attica ritrovava se stesso nel
coro dell’orchestra e non c’era in sostanza nessun contrasto tra pubblico e coro. » (Nietzsche, La
nascita della tragedia).
Di qui derivano i molti e singolari paradossi del dramma in cui noi ci imbatteremo nei corso della
nostra analisi. Dal fatto, ad esempio, che oggi è solamente arte e tuttavia è a stento comprensibile
coi concetti e i metodi dell’estetica, perché le sue radici più profonde sono in una esperienza
religiosa, perché questa forma estetica fu determinata un tempo, alla sua origine e per l’eternità, da
una esperienza religiosa.
Questo “essere pubblico” del dramma, strettamente legato alla sua essenza, anche dopo la tragedia
attica col suo coro fu a lungo rispecchiato dalla scena stessa. Il dramma non divenne fredda realtà
estranea ad ogni illusionismo solo perché il pubblico sedeva tutt’intorno nell’arena o nelle
rappresentazioni sulle piazze aperte dei misteri medioevali. I palchi di proscenio che il sipario
separava dal palcoscenico, il ponte praticabile che univa la platea col palcoscenico giapponese, il
gruppo di comparse del tutto inesplicabile sempre presente negli spettacoli classici della Comédie,
tutte queste cose stanno a rappresentare il carattere pubblico del dramma sul palcoscenico stesso.
Anche nella struttura interna del dramma, sino al secolo diciannovesimo, si può rintracciare di solito
qualcosa che corrisponde all’antico coro. Prendiamo ad esempio i « confidenti”, che non erano
certamente soltanto degli ausilii tecnici per autori drammatici poco abili. A questo proposito
possiamo citare anche la “ sfacciataggine” dei personaggi di Shakespeare: non soltanto essi sono
sempre testimoni e partecipi agli sfoghi dei sentimenti più intimi degli altri, ma nemmeno si
prospetta l’intenzione di tacere o di ritirarsi, se non per ragioni di tattica. Perché tutto è rivolto al
pubblico, perfino all’interno del dramma. Ma il nostro teatro di oggi è intenzionale, è consapevole,
è stato creato forse per i fini di un pubblico in festa? Non si studia con tutti i mezzi offerti dalla
tecnica di provocare forzatamente, a dispetto del pubblico, un effetto intimo?
Il nostro palcoscenico già per come è costruito ha un effetto di “rilievo”: si può guardarlo solo da un
lato, perciò l’altro lato dei suoi personaggi, se rispettassimo le conseguenze dello stile, non sarebbe
nemmeno permesso di vederlo. Perché ogni forma è legata allo spazio in cui campeggia. Le tre
dimensioni forzate del nostro palcoscenico sono un assurdo artistico, e ritorneremo a parlare delle
contraddizioni che ne derivano. Il progettista del Künstlertheater di Monaco, col suo palcoscenico
profondo appena tre metri, ha evidentemente voluto attenersi alla bidimensionalità proposta
dall’architettura del palcoscenico odierno. Ciò nonostante la più grande ambizione dei registi del
nostro tempo è quella di riuscire a suscitare nello spettatore l’illusione di una vasta prospettiva. Un
esempio del gioco di rilievo che esiste nella bidimensionalità è stato presentato una volta dal
balletto russo. La particolare bellezza dell’Après-midi d’un faune consisteva proprio nel fatto che si
adattava perfettamente al nostro palcoscenico dimezzato, come l’antica tragedia al l’arena. Ma
questi sono soltanto giochi scenici.
Il nostro palcoscenico a rilievo presenta un difetto ancor più grande di questo errore artistico: la sua
unilateralità lo rende scena illusionistica. Lo spettacolo, privato della sua realtà, inaccessibile
all’intorno, diviene quadro, visione lontana. E l’intenzione della tecnica scenica di oggi è proprio
quella di ottenere quest’effetto, come se nella platea oscurata “io fossi solo”, come se facessi un
sogno o come se spiassi attraverso il buco della serratura e vedessi il dramma in questo modo.
Lo stile del palcoscenico attuale è quindi in contrasto col significato più profondo del dramma, con
lo “ specifico” che ne costituisce l’essenza. (Perché lo specifico di ogni cosa è la sua essenza.) È in
contrasto con l’emozione collettiva dionisiaca, con la liberazione dalla schiavitù del1’”io”, col
significato religioso del dramma da cui ha avuto origine e che ne ha determinato la forma. È in
contrasto col proprio principio formale. Questa è una fra le molte cause, di cui parleremo ancora,
del fatto che la forma attuale del teatro non accontenta del tutto nessuno e ciascuno che se ne
occupa pensa alla sua riforma.
6.
P.M. Keržencev, Il teatro creativo. Teatro proletario negli anni ’20 in Russia
Nello stesso anno Pietroburgo produsse per il giubileo della rivoluzione d’Ottobre un terzo
spettacolo di massa: La presa del Palazzo d’inverno.
Questa volta si decise di erigere non uno ma più palcoscenici. Gli spettatori furono sistemati nella
ex piazza Alessandro, tra il Palazzo d’Inverno e lo Stato maggiore generale. Accanto allo Stato
maggiore furono erette due terrazze, ognuna lunga trenta metri; la destra era bianca, la sinistra rossa
(sia per quanto riguardava la colorazione che l’illuminazione). Tra le due terrazze, un ponte su cui si
svolgevano ugualmente scene particolari: scontri tra bianchi e rossi. L’azione della seconda parte
dello spettacolo aveva luogo principalmente sulla piazza stessa e si spostava poi nel Palazzo
d’inverno. Il pubblico doveva soltanto girarsi per avere di fronte il nuovo luogo dell’azione.
Ognuna delle cinquanta finestre del secondo piano del Palazzo d’Inverno mostrava questo o quel
momento della lotta tra i personaggi. La luce guizzante nelle finestre simboleggiava la lotta mortale
del morente governo provvisorio.
Lo spettacolo riuniva in sé parecchie tecniche teatrali. Sul palco dei bianchi l’azione si svolgeva alla
maniera di una commedia, sul palco dei rossi nella forma di un dramma eroico.
Guidava l’intero spettacolo un gruppo di registi sotto la direzione di N. Evreinov. Presero parte alla
rappresentazione circa diecimila figuranti, tra i quali molte persone che avevano preso realmente
parte all’insurrezione del 1917. Sulla Neva c’era, come al tempo della rivoluzione dell’ottobre
1917, l’incrociatore Aurora, le cui salve di cannone richiamavano vivamente alla memoria gli
eventi reali dell’espugnazione del Palazzo d’Inverno e l’abbattimento del governo provvisorio.
Persino l’aria fu trasformata in luogo dell’azione quando in alto volarono gli aeroplani, suonarono
forte le sirene delle fabbriche e le campane delle chiese.
L’intero spettacolo prese forma in modo collettivo e i dettagli particolari finirono messi a punto in
riunioni separate dei gruppi della guarnigione che partecipavano alla rappresentazione. Agli
spettatori vennero date istruzioni particolari in modo che sapessero fin dall’inizio come si sarebbero
dovuti comportare e in che momento avrebbero potuto prender parte alla rappresentazione.
Il contenuto di questo spettacolo è in breve il seguente.
Buio completo. Un colpo di cannone annuncia l’inizio della celebrazione. Sul ponte si accendono
lampioni. Otto suonatori di fanfara vi sono schierati, dai loro strumenti ondeggiano veli rossi.
Suonano e tutto piomba di nuovo nel buio. Ora si leva la sinfonia di Hugo Warlich che illustra la
situazione del governo provvisorio e del proletariato. Si chiude con la Marsigliese, durante la quale
la piattaforma bianca di Kerenskij appare in una luce abbagliante. Mostra un enorme salone in stile
impero in rovina. Kerenskij riceve con una bandierina rosa in mano i dignitari e i banchieri con il «
prestito della libertà». Tutti marciano ritmicamente al suono di una musica di guerra e al grido: «
guerra fino alla fine vittoriosa ».
Ora risuonano le sirene delle fabbriche e delle officine. La Kerenskiade si spegne lentamente. Dal
buio compaiono i profili del palco rosso del proletariato. Ciminiere, macchine; si sentono pesanti
colpi di martello. Al suono ancora incerto dell’internazionale gruppi isolati di operai si muovono.
Oratori. Sì guarda nel buio e il grido «Lenin, Lenin! » si diffonde sul palco.
Appare di nuovo la scena di sinistra e il bianco ritorna alla luce. Si nota già una certa insicurezza.
Discussioni. Il parlamento provvisorio. Appare ora il palco di destra che risplende di rosso. C’è già
una certa organizzazione.
Così l’attenzione del pubblico si rivolge di volta in volta al palco di Kerenskij e a quello di Lenin. E
via via l’unità dei bianchi si sgretola, la loro Marsigliese diventa sempre più insicura e sfumata.
Dai rossi invece l’Internazionale cresce sempre più; essi sembrano sempre più compatti e più
numerosi. E l’unità delle masse proletarie diviene sempre più solida e minacciosa; bandiere rosse
sventolano nell’aria. Sul ponte, turbamento e inquietudine, corse e confusione. Abbandono della
piattaforma di Kerenskii e afflusso verso quella di Lenin.
Con la marea spaventata dai femminei reggimenti di Kerenskij e di una parte dei cadetti, che
seguono il governo provvisorio e si trincerano nel Palazzo d’Inverno, si spengono tutti e due i
palchi e dal buio spunta fuori il massiccio scuro edificio del Palazzo, le cui 50 finestre prendono
vita l’una dopo l’altra: è l’ultimo baluardo del governo provvisorio. Questo continuo baluginìo,
l’accendersi e spegnersi delle finestre, dà un’immagine vivente del turbamento interno e
dell’esperienza psicologica dell’immenso edificio. Intanto alle finestre illuminate si presentano
scene isolate di combattimento. Crepitano le mitragliatrici. Rombano i cannoni. Salve dall’Aurora.
Si odono sirene, lunghi fischi. Fuochi d’artificio. La folla dalle centomila teste canta
l’Internazionale. Parata con fiaccole.
Nicolas Evreïnov 1879-1953, Exposition, Bibliothèque Nationale, Paris 1981, p. 8: Pianta della
piazza e delle strade con la disposizione dei diversi partecipanti alla Presa del Palazzo d’Inverno
(1920). Gi spettatori, collocati al centro della piazza, sono circondati dai movimenti della folla di
8000 figuranti posti sotto la direzione di Nicolas Evreïnov, che dirige l’azione dal Palazzo
d’Inverno e guida i due gruppi di registi installati l’uno da una parte e l’altro dall’altra del ponte,
l’uno per la scena rossa e l’altro per la scena bianca.
7
Clelia Falletti, 3. Musici commedianti, scenografi e ballerini nei teatri
pubblici di Venezia
Era ormai mezzo secolo che erano attivi a Firenze, a Venezia, a Napoli e in molte altre città d’Italia,
dei luoghi teatrali, che potevano essere semplici “stanze” adattate o edifici appositi, dove si
esibivano con una certa regolarità le compagnie di comici professionisti a pagamento, quando, nel
1637, per la prima volta, una di queste sale pubbliche fu richiesta da un gruppo di artisti per allestire
non uno spettacolo solito drammatico ma un prodotto, il più dispendioso, tipico della più
aristocratica élite: il dramma per musica. Gli artisti non erano i soliti comici di professione, bensì
cantanti e musici, ma anche un architetto e un coreografo. Con la loro Andromeda, libretto di
Benedetto Ferrari e musica di Francesco Manelli, coreografia di G.B. Balbi, allestimento di Alfonso
Rivarola detto il Chenda, s’inaugura il teatro d’opera aperto al pubblico pagante nel teatro dei Tron
a San Cassian a Venezia, ristrutturato di recente.
Degli artisti impegnati in questa impresa faceva parte un gruppetto di musici provenienti da Roma
che avevano rappresentato a Padova l’anno prima l’Ermiona, un’opera torneo strutturata in tre
momenti legati dalla musica e dalla coreografia, con un ballo di Dame, una barriera a piedi e un
torneo a cavallo introdotti da tre azioni drammatiche (Il rapimento d’Europa, Gli errori di Cadmo,
Gli Imenei)27. L’inventore della festa e del “libretto” era stato il marchese Pio Enea II degli Obizzi,
autore della musica Giovanni Felice Sancez, costruttore del Teatro (apposta per il torneo) e di
scene, macchine e ingegni assai complessi il Chenda. Tra i virtuosi del canto c’erano la romana
Maddalena e il marito di lei Francesco Manelli cantante e compositore, e fra gli strumentisti
Benedetto Ferrari detto “della Tiorba”.
È la prima volta. Non possiamo seguire la storia per tutto il Seicento (che è il secolo di fondazione),
possiamo tracciare alcune prospettive a partire da questo primo episodio che analizziamo più in
dettaglio.
Il Ferrari (1604-1681), musico e poeta, mise insieme i cantanti dell’Ermiona e altri della cappella
veneziana di San Marco formando una compagnia su basi sociali28; affittò il S. Cassian e lo gestì
direttamente per allestirvi l’Andromeda. Il tema mitologico si prestava a spettacolari movimenti di
macchine, specialità del Chenda, degne del fasto delle corti più ricche, offerte agli occhi stupefatti
del pubblico delle commedie. Possiamo farcene un’idea dalla dettagliata descrizione dello
spettacolo, dei mutamenti di scena e dei costumi, premessa dal Manelli al libretto29:
La Scena si finge una spiaggia di mare nell’Ethiopia. Sparita la Tenda, si vide la Scena tutta mare, con
una lontananza così artifitiosa d’acque e di scogli, che la naturalezza di quella (ancor che finta) moveva
dubbio a’ Riguardanti, se veramente fossero in un Theatro, o in una spiaggia di mare effettiva. Era la Scena
tutta oscura, se non quanto le davano luce alcune stelle; le quali, una dopo l’altra a poco a poco sparendo,
dettero luogo all’Aurora, che venne a fare il Prologo. Ella, tutta di tela d’argento vestita, con una stella
lucidissima in fronte, comparve dentro una bellissima nube, quale hora dilatandosi, hora stringendosi (con
bella meraviglia) fece il suo passaggio in arco per lo Ciel della Scena. In questo mentre si vide la Scena
luminosa al par del giorno. Dalla Signora Madalena Manelli Romana fu divinamente cantato il Prologo;
dopo del quale s’udì de’ più forbiti Sonatori una soavissima Sinfonia, a questi assistendo l’Autore dell’Opera
con la sua miracolosa Tiorba. Uscì di poi Giunone sovra un carro d’oro tirato da’ suoi Pavoni, tutta vestita di
tocca d’oro fiammante, con una superba varietà di gemme in testa e nella corona. Con meraviglioso diletto
de’ spettatori volgeva a destra ed a sinistra, come più le piaceva, il carro. Le comparve a fronte Mercurio. Era
e non era questo Personaggio in machina; era, perché l’impossibilità non l’ammetteva volante; e non era,
poiché niun’altra machina si vedea che quella del corpo volante. Comparve guernito de’ suoi soliti arnesi,
con un manto azurro, che gli giva svolazzando alle spalle. Fu eccellentemente rappresentata Giunone dal
Signor Francesco Angeletti da Assisi; ed esquisitamente Mercurio dal Signor Don Annibale Graselli da Città
di Castello. In un istante si vide la Scena, di Maritima, Boschereccia [...]. Comparve Andromeda con il
seguito di dodeci Damigelle, in habito Ninfale. L’habito d’Andromeda era di color di foco, d’inestimabile
valuta. Quello delle Ninfe era d’una leggiadra e bizzarra divisa a bianco, incarnato e oro. Rappresentò
mirabilmente Andromeda chi fece il Prologo. Tornò in un momento la Scena, di Boschereccia, Maritima.
Comparve Nettuno, e gli uscì Mercurio nella sua mirabil machina all’incontro. Era Nettuno sovra una gran
Conca d’argento, tirata da quattro cavalli marini. Lo copiva un manto di color cilestre; una gran barba gli
scendeva al petto et una lunga capillatura inghirlandata d’alga gli pendeva alle spalle. La corona era fatta a
Piramidette, tempestata di perle. Fece questa parte egregiamente il Signor Francesco Manelli da Tivoli,
autore della Musica dell’Opera. Uscì dal seno del mare, dalla cintola insuso, Protheo, vestito a squamme
d’argento, con una gran capillatura, e barba di color ceruleo. Servì di questo Personaggio gentilissimamente
il Signor Gio. Battista Bisucci Bolognese. Qui per fine dell’Atto si cantò prima di dentro un Madrigale a più
voci, concertato con Istrumenti diversi; e poi tre bellissimi Giovinetti, in habito d’Amore, uscirono a fare, per
Intermezzo, una gratiosissima danza. Il velocissimo moto di questi fanciulli talora fece dubbiose le Genti
s’havessero eglino l’ali a gli homeri, o pure a’ piedi. A tempo d’una melliflua melodia di stromenti
comparvero Astrea nel Cielo, e Venere nel Mare. Una entro una nube d’argento, l’altra nella sua conca tirata
da Cigni. Era vestita Astrea del color del Cielo, con una spada a fiamme nella destra; Venere del color del
mare, con un manto d’oro incarnato alle spalle. Fu gratiosamente rappresentata Astrea dal Signor Girolamo
Medici romano, e Venere soavissimamente dal Signor Anselmo Marconi Romano. Si mutò la scena in
Boschereccia et uscì Andromeda con la sua schiera. Sei delle sue Dame, qui per allegrezza dell’ucciso
Cinghiale, fecero un leggiadro e maraviglioso Balletto; con sì varie e mirabili intrecciature, che veramente
gli si poteva dar nome d’un laberinto saltante. Ne fu l’Inventore il Signor Gio. Battista Balbi Venetiano,
Ballarino celebre. Uscì repente di sottoterra Astarco Mago, com’Ombra. Era questo Personaggio tutto vestito
a bruno d’oro, in veste lunga, con capillatura e barba lunga, e come neve bianca. Scettro di Negromante,
reggeva la destra una Verga. Rappresentò degnamente questo soggetto chi fece Nettuno. S’aperse il Cielo e
in uno sfondo luminosissimo, assisi in un maestoso Trono, si videro Giove e Giunone. Era Giove coperto
d’un manto stellato, sosteneva la chioma una corona di raggi, e la destra un fulmine. Rappresentò
celestamente questa Deità chi fece Protheo. Qui per fine dell’Atto si cantò prima di dentro un altro Madrigale
a più voci, concertato con Istrumenti diversi; e poi dodici Selvaggi uscirono a fare, per Intermezzo, un
stravagantissimo e gustosissimo ballo di moti e gesti. Non vi fu occhio che non lagrimasse il transito di
questa danza. Ne fu l’Inventore il Signor Gio. Battista Balbi Ballarino sudetto. Si cambiò la Scena in
Maritima; a tempo d’una dolcissima armonia d’Istrumenti diversi comparve da un lato della Scena una
bellissima machina con Astrea e Venere suso. Volgevasi al destro ed al sinistro lato, come più a quelle
Divinità aggradiva. Le uscì a dirimpetto Mercurio, et aprendosi il Cielo assisté Giove nel mezzo. Fece un
maraviglioso effetto questo Scenone per la quantità delle machine e per lo successivo ordine della comparsa
e della gita. In un baleno divenne la Scena maritima un superbo Palagio. Fu bello e caro il vedere da rozzi
sassi e da spiagge incolte nascere d’improviso un ben disegnato e construtto Edifitio. Figurava questi la
reggia d’Andromeda, dalla quale uscì Ascalà Cavaliere. L’habito di costui eccedé di valuta e di bellezza
quello d’ogn’altro. Comparve vestito all’usanza Turca. Con mille gratie di Paradiso rappresentò questo
dolente Personaggio chi fece Mercurio. Di repente, sparito il Palagio, si vide la Scena tutta Mare con
Andromeda legata ad un sasso. Uscì ’l Mostro marino. Era con sì bello artifitio fabricato quest’Animale che,
ancorché non vero, pur metteva terrore. Tranne l’effetto di sbranare e divorare, havea tutto di vivo e di
spirante. Venne Perseo dal Cielo su ’l Pegaseo, e con tre colpi di lancia e cinque di stocco fece
l’abbattimento col Mostro, e l’uccise. Era questo Personaggio d’armi bianche vestito con un gran cimiero su
l’Elmo; e una Pennacchiera alla stessa divisa haveva il volante Destriere su la fronte. Fu rappresentato questo
sogetto angelicamente da chi fece Ascalà. S’aperse il Cielo, e si videro Giove e Giunone in gloria et altre
Deità. Scese questo gran machinone in terra, accompagnato da un Concerto di voci e di stromenti, veramente
di Paradiso. Levati i due Heroi gli condusse al Cielo. Qui la regale e sempre degna funtione hebbe fine.
Sono dei musicisti che si consorziano e producono in proprio lo spettacolo: riesce a loro quello che
non era riuscito a Giovanni Andrea dell’Anguillara quasi cent’anni prima a Roma — riprodurre il
teatro di corte in una sala a pagamento. Ma ora il teatro venduto dei professionisti è esperienza
normale (soprattutto a Venezia) e già da tempo lo spettacolare teatro d’occasione, per sostenere le
spese, mette in vendita i posti per gli spettatori (si pensi al torneo cavalleresco per il quale costruì
un “teatro” il Chenda a Modena nel 1635, per un pubblico misto di aristocratici invitati e di
borghesi e artigiani paganti)30. C’è da aggiungere qualche considerazione sul fatto che l’economia
di mercato, che è alla base della rivoluzione compositiva e drammaturgica dei comici di
professione, è alla base anche di questa operazione dell’Andromeda del 1637: la composizione
musicale è un montaggio di “arie”, pezzi chiusi che sono già nel bagaglio dei cantanti (così il
lamento di Andromeda legata alla rupe è una variazione del celebre “Lamento d’Arianna”
dell’Arianna (1608) di Monteverdi su libretto di Rinuccini, e suscita la commozione con
l’efficacissimo ritornello Piangete mari, sospirate arene, che scandisce il lungo recitativo
rompendo la monotonia)31; la composizione scenografica è un montaggio delle invenzioni ed effetti
già presenti nel bagaglio di uno scenotecnico come il Chenda (basta confrontare la descrizione
dell’Andromeda con la recente Ermiona padovana per constatare un riuso sistematico dei
materiali)32; anche il coreografo ha già un repertorio di balli da inserire come divertissements tra gli
atti; il librettista è colui che compone tenendo conto di tutti questi “saperi” sedimentati e provvede
la struttura formale in cui i diversi moduli rappresentativi trovano composizione in organismo: la
scelta di temi mitologici e pastorali o leggendari e di storia antica aiutava a giustificarli e renderli
plausibili.
Ferrari, virtuoso della musica, usò il dramma come strumento di coesione tra modalità teatrali: fece
capitale dei tesori a sua disposizione e del contesto più vasto del solo testo drammatico (l’esempio
dei comici dell’arte è davanti agli occhi di chi ha necessità di intendere) e montò, giocando sulla
variazione degli “affetti” e con rapidità sinfonie e pezzi cantati, scenografie, macchine, azioni,
danze, orientandosi sul mercato e sul gusto del pubblico. E divenne celebre librettista e geniale
impresario. Per due anni, con i compagni, gestì direttamente il San Cassian allestendovi drammi per
musica. Nel libretto della Maga fulminata, che fu il successo del secondo anno, musica di Manelli,
libretto di Ferrari, coreografie di Balbi, macchine e scene del Chenda, l’autore si vanta che
“operazioni simili a’ principi costano infinito danaro”, mentre lui, “ha potuto del suo e con quello di
cinque soli musici compagni, con spesa non più di duemila scudi, rapir gli animi agli ascoltanti”.
Nel 1639 Ferrari, Manelli, il Chenda e il Balbi si trasferiscono al teatro SS. Giovanni e Paolo, già
sala per commedie rimodellata velocemente da Giovanni Grimani per destinarla all’opera in
musica. (E nel S. Cassian subentra una compagnia concorrente quasi tutta veneziana intorno a
Francesco Cavalli, cantore e musicista della cappella di S. Marco, che inizia un’operosa e fortunata
carriera con Le nozze di Teti e Peleo.) Ferrari e compagni continuarono i successi con Delia di
Manelli e Sacrati nel ’39 e Armida di Ferrari (che ebbero le scene del Chenda), e Adone di Manelli;
ma la gestione è nelle mani del proprietario Grimani. Fra il ’40 e il ’44, Ferrari si spostò al S. Moisè
che gli consentiva di gestire in proprio l’attività (Il Pastor regio, La Ninfa avara, Il Principe
giardiniere, per i quali fornì libretto e musica). Il gruppo iniziale è ormai sciolto, nel 1641 e 1643 al
SS. Giovanni e Paolo si rappresentano opere di Monteverdi (Le nozze di Enea con Lavinia nel 1641
e L’incoronazione di Poppea nel ’43), e poi undici opere dell’emergente Francesco Cavalli; nel ’42
Manelli, con il suo Alcate è al Teatro Novissimo appena inaugurato.
“La struttura economica ed artistica del teatro d’opera veneziano si diffonde e si innesta nel giro di
pochi anni su tutto il territorio italiano...”33: prima della fine del Seicento le città sedi di teatri più o
meno stabili sono una quarantina, di cui Bianconi dà la tabella.
Ai teatri lirici che nel giro di pochi anni furono attivi a Venezia, S. Cassian, S. Salvador, S. Moisè,
SS. Giovanni e Paolo, nel 1641 si è aggiunto il Novissimo. Questo fu il primo teatro eretto non per
la commedia ma per le “eroiche opere in canto”. Fu costruito, completamente in legno, da Jacopo
Torelli su incarico di un gruppo di nobili che gli affidarono anche le scenografie34. Questa
organizzazione semiaccademica è anomala rispetto al panorama dei teatri lirici veneziani (e fallì in
quattro anni), ma è simile a imprese teatrali di altre città italiane sia precedenti che successive.
Con il Torelli al Teatro Novissimo c’erano artisti importanti: l’ormai famoso Manelli e il più
giovane compositore F. Sacrati, il librettista Giulio Strozzi, e il ballerino coreografo Balbi,
“associati ad un’impresa teatrale ancora più ambiziosa, che si proponeva di eclissare, soprattutto
con la grandiosità della messinscena, l’attività degli altri teatri veneziani”35. Fu inaugurato nello
stesso anno con La finta pazza (libretto di G. Strozzi, musica di Sacrati, coreografia di Balbi, e le
scene, “gli splendidi apparati”, di Torelli). Il successo fu tale che fu replicata 12 volte nei successivi
17 giorni e si dovette ristampare il libretto. Entrò nel repertorio dei Febiarmonici che la portarono a
Piacenza nel 1644 e forse i primi di gennaio dell’anno seguente allo stanzone fiorentino di
Baldracca36. I Febiarmonici poi, guidati dal Balbi iniziarono una fortunata attività operistica a
Napoli (e La finta pazza era ancora nel loro repertorio nel 1652). Fu rappresentata anche dagli
Accademici Discordati a Bologna nel 1647. La compagnia di comici italiani di Carlo Cantù la
rappresentò al Petit Bourbon di Parigi nel 1645 davanti al Re alla Regina al Cardinale Mazzarino e
ai familiari della corte: fu la prima opera italiana di cui è accertata la rappresentazione in Francia
anche se davanti a un pubblico ristretto e con una compagnia di attori e non di cantanti, guidati però
da Torelli e da Balbi, senza rinunciare perciò alle meraviglie scenotecniche e coreografiche e senza
rinunciare ai brani più salienti della partitura musicale.
Il Teatro Novissimo fino al ’47 mise in scena opere di Sacrati (Bellerofonte e Venere gelosa),
Manelli (Alcate), Cavalli (Deidamia e La prosperità infelice di Giulio Cesare dittatore), Rovatta
(Ercole in Lidia). Le scene, come si è detto, furono sempre del Torelli, le coreografie di G.B. Balbi.
Questo teatro fragile fu tuttavia più importante di altri più solidi per il sedimentarsi dell’idea che
drammi per musica, scenografie e coreografie sono indissociabili.
Il Chenda, con i primi allestimenti veneziani, determinò la struttura della sala con palchetti ad
alveare, ma fu Giacomo Torelli (1608-1678) di Fano, il “mago della scenografia”, con i suoi
allestimenti di drammi per musica al Teatro Novissimo, a fare del palcoscenico lo spazio autonomo
e racchiuso dell’illusione introducendo il sistema della mutazione a vista mediante quinte
scorrevoli, poi adottato in tutta Europa. Le quinte scorrevano appaiate su “canali” (binari) tagliati
nel pavimento della scena ed erano tutte collegate nel sottopalco a un argano centrale; con un solo
giro dell’argano (la “gran ruota”) si otteneva il cambiamento simultaneo delle quinte e la
trasformazione istantanea di una prospettiva scenica in un’altra. Nell’economia del teatro a
pagamento, è prassi che le scene di un’opera, una volta utilizzate, entrino a far parte della dotazione
fissa del teatro, o diventino proprietà dell’impresario: sempre comunque vengono gelosamente
custodite per essere riutilizzate per altre opere con opportune modifiche; ma Torelli pubblicò le sue
scene del Bellerofonte (1642) e della Venere gelosa (1643) in volumi contenenti descrizioni
dettagliate e incisioni, seguendo più che l’uso dei teatri quello delle corti che dalla pubblicità si
aspettavano prestigio. L’immaginario scenografico (marine, voli, apparizioni, incendi, allagamenti
ecc.) e la scenotecnica relativa, i segreti dei maghi dell’illusione, circolano di corte in corte, e
diventano il repertorio fisso degli inventori teatrali, con l’aiuto anche di trattati che li codificano,
come la Pratica di fabricar scene e machine ne’ teatri di Nicolò Sabbatini, del 1637-3837, ed
entrano nel “corredo di convenzioni sceniche che ogni drammaturgo predisporrà per i propri testi
destinati ad essere rappresentati in musica”38. In altre parole, il palcoscenico funzionale e versatile
del Torelli, l’accoglienza del pubblico in quello spazio che è uno spazio mentale39, le visioni
mutevoli sue e degli altri maghi della scena, fondano la drammaturgia, e non solo dei drammi in
musica.
Furono teatri che durarono fino al Settecento inoltrato e alcuni fino a noi. La nuova moda dei
drammi per musica, quindi, non solo si impose come genere teatrale misto — di poesia musica
coreografia e meraviglie scenografiche — di grande successo presso il pubblico, ma impose, e
veicolò per tutto il secolo fin nel Settecento e oltre, in tutta Italia e nel resto d’Europa, e oltre, anche
la corrispettiva necessaria forma dell’edificio teatrale (il teatro all’italiana), e dell’organizzazione
impresariale.
27
Tra gli interpreti dell’Ermiona, nel ruolo di Apollo, si distinse il figlio di Claudio Monteverdi, Francesco. Vedi
l’ancora utile analisi dell’Ermiona di P. Petrobelli, in «Quaderni della Rassegna musicale», 1965, n. 3, in cui si mette in
evidenza l’uso «retorico» di strumenti di un certo timbro a sottolineare determinate situazioni (timbro grave di cornetti e
tromboni associato alla rappresentazione dell’Ade, del «profondo»), e la presenza di ben quattro «lamenti» nella prima
azione drammatica (di Giove innamorato d’Europa, di Mercurio per una ninfa, di Europa rapita da Giove in forma di
toro, di Agenore per il ratto della figlia Europa) che fanno pensare al modello monteverdiano (e di Rinuccini) del
lamento d’Arianna. Nel saggio viene sottolineata la centralità della figura dell’Obizzi tra Ferrara e Parma negli anni in
cui dalla pastorale con larghi inserti musicali si passa al dramma per musica. Quindici incisioni delle scene
dell’Ermiona sono riprodotte nel libro di C. MOLINARI, Le nozze degli dèi. Un saggio sul grande spettacolo italiano nel
Seicento, Roma, Bulzoni, 1968, 47-61.
28
Su tutto l’argomento si veda L. BIANCONI, Storia della musica. Il Seicento, Torino, EdT, 1982, in particolare il
cap. Il teatro d’opera.
29
Il libretto, pubblicato due mesi dopo (Venezia, Bariletti, 1636), contiene un tributo «a gloria dei signori musici
ch’al numero di sei (coll’autore collegati) hanno con gran magnificenza ed esquisitezza a tutte loro spese, e di qualche
considerazione, rappresentata l’Andromeda». La citazione che segue è tratta dallo Scenario dell’opera Andromeda, cit.
in F. TESTI, La musica italiana nel Seicento, t. I, Milano, Bramante, 1970, pp. 270-272.
30
Su questo evento e sull’importanza del Chenda nella definizione della sala del teatro all’italiana ho potuto
consultare manoscritto l’ampio e documentato saggio di S. Erriquez, I mestieri e lo spazio del teatro: la scena del
Chenda, che sarà pubblicato nella rivista «Teatro e storia». Il committente del torneo di Modena del 1636 fu il duca
Francesco I d’Este che festeggiava il passaggio nella nuova capitale estense del cardinale Maurizio di Savoia: la
soluzione del Chenda di sistemare gli spettatori su palchi disposti su un ovale e sviluppati su tre piani divisi al loro
interno in ampi ambienti per un’elevata quantità di spettatori non solo aristocratici ma anche borghesi e cittadini,
nacque da una necessità economica: il teatro provvisorio fu infatti edificato grazie alla compartecipazione agli oneri di
privati e di piccole società di artigiani. Sul Chenda è ancora utile consulate la voce di E. Povoledo nell’Enciclopedia
dello Spettacolo.
31
Cfr. F. VATIELLI, Operisti-librettisti dei secoli XVII e XVIII, in «Rivista musicale italiana», XLIII (1939), p.
320.
32
Una scheda con la struttura dell’Ermiona e la descrizione delle scene (sulla base delle incisioni relative) è in
Illusione e pratica teatrale, Venezia, Neri Pozza, 1975, catalogo della Mostra dedicata alle scenografie dagli Intermezzi
fiorentini all’Opera veneziana, p. 61: vi sono elencate scene marine, prospettive boscherecce, scene di tutto Mare con i
carri di Nettuno e Venere, di tutto Cielo con le apparizioni di Giove e di Mercurio, di Apollo con le Muse, lo spalancarsi
della grotta con la reggia di Plutone, i voli di Iride che fa il Prologo e di Imeneo che conclude l’opera. Il confronto si
può estendere alle scene coeve dei fiorentini (Ibid., pp. 49 ss.) che hanno ancora una volta il primato delle invenzioni,
grazie al lungo tirocinio di quasi mezzo secolo di feste medicee tra Cinquecento e Seicento al Teatro degli Uffizi (15851628), con artisti come il Buontalenti, e Giulio e Alfonso Parigi. Nel 1637 Le Nozze degli Dèi, grande festa teatrale per
le nozze del granduca Ferdinando II e Vittoria della Rovere, furono il pretesto per le scene e le macchine
«meravigliose» di Alfonso Parigi. Il libretto, di Giovan Carlo Coppola, fu edito con otto incisioni di Stefano della Bella
che riproducono il palco inquadrato da un boccascena e sette delle dieci scene, che possono essere considerate un
repertorio della scenografia secentesca: Firenze, Selva di Diana («boschereccia»), Giardino di Venere, Grotta di
Vulcano, Scena di mare, Scena d’Inferno e la scena finale di Tutto Cielo con un ballo sulle nuvole in vari piani —
esempi ripetuti in numerose varianti e che divengono dotazione stabile nei teatri pubblici a pagamento.
33
Così L. BIANCONI, Il teatro d’opera italiano, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 12. La tabella è a p. 13.
34
Vedi Illusione... cit., il saggio Jacopo Torelli: la scena come macchina, p. 54.
35
Vedi N. PIRROTTA, voce Sacrati, Francesco Paolo, in Enciclopedia dello spettacolo.
36
A.M. EVANGELISTA, Il teatro dei comici... cit., pp. 76-77. Mattias de’ Medici vide La finta pazza a Venezia nel
1641, la giudicò «opera bellissima» (e autorizzò la partecipazione al Bellerofonte dei suoi cantanti A. Melani e M.
Grasseschi).
37
Ravenna 1638. Quello del Sabbatini è un manuale prezioso di scenotecnica continuamente ripubblicato, in
Italia e all’estero, fino ad oggi. Un manuale pratico che prende in esame l’intero edificio è quello del mantovano
Fabrizio Carini Motta, Trattato sopra la struttura de’ Theatri e Scene, Guastalla 1676, ristampato modernamente a c. di
E.A. Craig, Milano, Il Polifilo, 1972; e c’è il punto di arrivo della teorizzazione della prospettiva di G. Bourbon del
Monte (1600), in cui il connubio tra scenografia e scienza prospettica sfida ed esalta le possibilità della nuova scienza, o
del Cigoli (trattato ms anteriore al 1628), la «summa» del Chiaramonti, le applicazioni pratiche per i pittori con
l’«Inganno degli occhi» dell’Accolti (1625), i «Paradossi» del Troili (1672) e la scena come visione del Pozzo (1693)
(su di loro si veda F. MAROTTI, Lo spazio scenico, Roma, Bulzoni, 1974); un’altra opera del Carini Motta, Costruzione
de’ teatri e machine teatrali (1688), è edita ora per la prima volta, insieme a un altro trattato rimasto manoscritto, di
Romano Carapecchia, Pratica delle machine de’ teatri (1689-91), col titolo complessivo Scenotecnica barocca, da E.
Tamburini (Roma, E&A, 1994), che vi premette un ampio saggio introduttivo, Teatri e macchine teatrali: un sapere
nascosto, e vi aggiunge un prezioso Glossario.
38
L. Bianconi, Il Seicento, cit., p. 173.
39
G. Banu, Il rosso e oro, Milano, Rizzoli, 1990, p. 12; ma si veda tutto il libro di Banu dedicato al teatro
all’italiana.
Francesco Guitti, scena de L’Andromeda, Ferrara 1638 Introduzione per musica al Torneo per
nozze. Marina-Scoglio Andromeda-Perseo su Pegaso-mostro dall’onde
Giacomo Torelli, scena de L’Andromède, Parigi 1650
8
Scenotecnica nel Seicento: illustrazioni (v. file a parte)
9
Jean Dubuffet
Prospectus et tous écris suivantes, vol II, Paris, Gallimard, 1967
Sono i vuoti di un quadro ad essere molto importanti, è in essi che sta tutta la sua forza. Inoltre, il
principio della ganga* governa tutta la percezione che abbiamo delle cose; chi le consegna isolate
da questa ganga toglie loro tre quarti del valore. Ogni oggetto sul quale posiamo gli occhi, appare ai
nostri sguardi abituali rivestito, inestricabilmente legato a delle zone confuse, non percepibili; è
importante per il pittore desideroso di dare vita alle sue suscitazioni che ricostituisca questo
ambiente: questo tufferà tutti gli oggetti evocati in un bagno di vita.
Al pittore spetta stabilire questo bagno fondamentale dentro il quale tutto ciò che egli vi vorrà
inscrivere, anche nel più sommario dei modi, prenderà vita con grande forza.
* Ganga: materiale in cui affonda il metallo e la pietra preziosi al momento dell’estrazione e che viene eliminato con la
lavorazione.
George Braque
Entretien avec Hervé Guibert, in “Le Monde”, 6 settembre 1984
C’è della gente che dice «cosa rappresenta il suo quadro?... Cosa?... C’è una mela, chiaro, c’è… non
so… ah! Un piatto: di lato…». Questa gente ha l’aria di ignorare completamente che si dipinge
anche quello che si trova fra la mela e il piatto. E, credete, mi sembra più difficile dipingere il “fra”
che le cose. Questo “fra” mi sembra un elemento tanto capitale quanto quello che chiamano
“l’oggetto”. È per l'appunto il rapporto di questi oggetti fra di loro e degli oggetti con il “fra i due”
che costituisce il soggetto.
10
Susan Leigh Foster, Coreografia e narrazione
Prefazione
Gamba alzata, gonna rigida, piccole ali, testa ornata di ghirlande, capelli arruffati, braccia
arrotondate, sguardo adorante: il tutto si libra a più di un metro e mezzo da terra sul ramo di un
albero. Come ci è arrivata? Forse qualche saltello allegro l’ha portata dal centro del palco alla
quinta di proscenio, da dove esce e si fa strada tra gli altri ballerini e i tecnici fino alla terza quinta,
agguanta il suo fiore e corre su per le scale e fuori fino all’estremità dell’altalena, appoggiandosi ai
sostegni della struttura mentre si rovescia in avanti nell’arabesque. Protesa in maniera seducente,
incontra lo sguardo di un principe infatuato che le gesticola il suo desiderio con una mano sul cuore
e l’altra che si agita dal cuore verso di lei. La sua bellezza eterea o forse la sua apparizione inattesa
l’hanno costretto a inginocchiarsi, ulteriore segno di devozione. Attraverso la figura fluttuante di lei,
parzialmente eclissata, e la dolce diagonale del loro affetto reciproco, i due possono ora mettere in
scena l’atmosfera stregata e l’affascinante spettacolo al quale il pubblico oltre il proscenio
ardentemente desidera assistere. Dietro le quinte, gli assistenti, sempre all’erta e consapevoli che un
movimento falso potrebbe farla cadere, la tengono saldamente, pronti a farla volare in alto e
lontano. La loro abilità nel calcolare la meccanica di dimensioni, peso e fulcro sta alla base
dell’incanto della sua apparizione.
Come ci è arrivata? Dal momento in cui si è aperto il sipario, lui, il principe, è andato alla sua
ricerca perché stregato da lei. Lei gli è sfuggita ripetutamente, ogni volta dandogli nuove speranze
con la sua apparente disponibilità. Appare improvvisamente da dietro i cespugli; smuove tutte le sue
bramosie. La curva ambigua delle sue braccia comunica l’attrazione reciproca, ma anche la sua
familiarità con i confini del decoro. Stando in equilibrio precario tra la ragazza virginale e la
dissoluta, è la ragazza “che amava troppo danzare”.1 Incapace di raggiungerla per la leggerezza e
l’illusorietà enigmatica di lei, il principe è però autorizzato a dimostrare la sua tenera sensibilità, la
fedeltà all’ideale e il suo destino solitario, mentre essa svanisce davanti ai suoi occhi. L’apparizione
seguente mette di nuovo in moto lo stesso meccanismo della passione. Lei è ciò che lui desidera; i
movimenti di lei registrano la sintassi della passione. E, cosa ancora più importante, spingono
avanti la narrazione. E questa è la sua funzione: costretta a comunicare una leggerezza non sua,
inchiodata fra gli sguardi dei tecnici, dello spasimante e dei membri del pubblico, incarna il gesto
fugace del desiderio stesso, senza il quale la storia non potrebbe mai essere raccontata.
Come ci è arrivata? Nata in una delle tante famiglie d’arte che popolano le scene dei teatri europei,
oppure trovatella di origini operaie, ha cominciato a studiare la danza in tenera età. Con gli anni si
allontana dal dominio femminile delle responsabilità domestiche e invade invece lo spazio maschile
dello spettacolo pubblico. Acquisisce un’abilità tecnica nel vocabolario dei passi classici e dei gesti
della pantomima, e nel trasferirli dall’étude di danza al palcoscenico. Impara a navigare tra le
richieste dei coreografi, le rivalità dei ballerini, le imposizioni degli amministratori e i gusti dei
critici, per far vedere la sua danza. Cospira con gli operai dietro le quinte, con i costumisti, i
macchinisti, il direttore d’orchestra e perfino con i membri della claque, responsabili
dell’accoglienza favorevole della sua prestazione. E scende a patti con gli ammiratori per un
sostegno economico e un appoggio che farebbero brillare il suo duro lavoro con il lustro della star.
...Questa storia rovescia la prospettiva tradizionale degli studi che si occupano della storia del
balletto. Scritta dal punto di vista della scena, sbircia da dietro il fondale sia l’azione in scena che il
pubblico, sentendo tutto il tempo lo strusciare dei ballerini e dei tecnici che si incrociano veloci.
Invece di contemplare lo spettacolo come il sublime coordinarsi di colpi di genio, esamina l’azione
di ogni singolo momento come l’incarnazione delle strategie performative di coreografo e ballerini.
Tratta la danza come una forma di lavoro fisico e i ballerini come operai qualificati. Si sofferma
sulle scelte coreografiche, cercando di capire qual è l’atteggiamento nei confronti della costruzione
1
Giselle, insieme alla grande maggioranza delle eroine femminili dell’epoca romantica, si dedicava alla danza sia come
piacere innocente che come seduzione sensuale, come sosterrò nel capitolo quinto. La giovane ragazza “che amava
troppo danzare” è la definizione che dà Gautier della willi.
di identità corporee, individuali, sessuali e sociali. Trova il modo di entrare nelle decisioni
coreografiche, prese durante le prove e gli spettacoli, che teorizzano la corporeità. Qui è
l’atteggiamento speculativo, non quello contemplativo, a posteriori e distaccato, ad esser preso per
scolpirlo (incarnarlo) nelle soluzioni pratiche che emergono, grazie all’impegno attivo dei corpi,
durante la creazione della danza.
...Dal suo punto di vista collocato sulla scena, questa storia riconosce le demarcazioni tra scena,
quinte e sala, e tra l’illusione rappresentata e la macchineria per produrre illusione, e riproduce
queste fenditure nella costruzione non ininterrotta del testo.
...Su questa nuova scena di rappresentazione, la ballerina, insieme all’altalena e tutto il resto,
mantiene la sua posizione mentre la circondano i gesti imbarazzati dei tecnici in vista e le ossessive
ripetizioni del principe – di interesse intrinseco in quanto variazioni di segni. La sua magica
presenza, a maggior ragione irreale per la riflessività critica appena acquisita, affascina gli
spettatori, ma li avvince ugualmente con il racconto della produzione della loro fascinazione. Forse
mentre li conduce attraverso la storia della storia, vedendo quello che essi vedono, le cresce il
desiderio di coreografare l’atto stesso di tenersi in equilibrio che conosce così bene. Forse progetta
una discesa dall’altalena e, ispirata dalla nuova tecnica rappresentativa che tale discesa comporta,
corre nell’étude per cominciare a lavorare sulla propria danza. Ma, un momento: non inconsapevole
del proprio carisma, si ferma, prima di andar fuori, per gettare il suo fiore al pubblico, volendo così
dimostrare la sua gratitudine per la loro attenzione ed anche la sua complicità nel ciclo del desiderio
che la sua danza ha sempre eseguito...
La sponda erbosa
Passando in rassegna i balletti d’azione, fin dai primi troviamo che i libretti indicano l’uso di un
oggetto scenico altamente simbolico, conosciuto come le banc de gazon, “la sponda erbosa”. In un
considerevole numero di balletti, i personaggi vi si sprofondano, vinti dall’emozione. In qualche
caso vi stramazzano, ma più spesso strapiombano lentamente dalla verticale, prolungando la discesa
con una serie di arresti momentanei, soccombendo alla fine alla dimensione orizzontale. La
sottogonna tesa a paniere che fa sembrare le ballerine come tante navi che scivolano a vele spiegate
attraverso il palcoscenico, all’improvviso s’aggrinza, scentrata, si ripiega ancora facendo increspare
le eleganti linee del vestito, e infine crolla. Il corpo maschile, così perfettamente eretto, braccia e
gambe inorgoglite e sicure di sé nella ben calibrata distanza le une dalle altre, all’improvviso si
ripiega su se stesso, con le membra scomposte.
Le emozioni, invece di crescere all’interno dei personaggi, li colgono di sorpresa e li inabissano.
Neanche uno storcimento del torso segnala il germogliare e il crescere del sentimento. Il
personaggio rimane eretto, guarda con ansia di qua e di là mentre arrivano le emozioni, e poi,
lentamente, sotto il loro peso, sprofonda. Forse le emozioni sono una specie di massa liquida o
gassosa, un effetto chimico degli attriti con gli altri. Sembra che stiano sospese sopra e attorno al
ballerino. E quando la loro densità è troppa, lo schiacciano con una forza irresistibile.
Lo spiazzo erboso, curatissimo, sostenta e sostiene i personaggi al loro arrivo dal mondo civile alla
natura. Qui, su un terreno meticolosamente coltivato e attentamente ripartito, possono abbandonarsi
completamente alle proprie emozioni. Qui, perdono ogni coscienza degli altri. Qui, giacciono
svenuti, o addormentati o sognando.
Dopo così tante ore di decisa “verticalità”, questa violazione della posizione eretta è estrema. Crea
un’immagine illecita, antisociale, seducente in sommo grado. Il personaggio è giù ed è anche fuori,
incapace di assolvere la minima funzione indicativa come veicolo di senso pubblico. Prono e ormai
impotente, dimentico del mondo circostante e dello sguardo degli spettatori, il personaggio
trasforma chi guarda in voyeurs. Gli spettatori, divenuti consapevoli dei piaceri e dei privilegi della
propria sensibilità, assaporano questo momento orribile e delizioso, segnalato, fin dal primo istante,
dalla presenza, a sinistra o a destra del palcoscenico, della sponda erbosa.
Destra sinistra, alto e basso
La scenografia del ballet d’action è utilizzata efficacemente per fissare le tensioni strutturali tra
privato e pubblico, tra un gruppo affine e un altro. Spesso la scena rappresenta le residenze di due
famiglie poste sui due lati del palcoscenico e divise da uno spazio centrale comune, oppure mostra
una singola dimora con attorno uno spazio pubblico. Le abitazioni si dividono inoltre in un piano
basso e uno alto, uniti tra loro da balconate, scale interne ed esterne, o addirittura da un albero.
Questa architettura dell’alto e del basso, della destra e della sinistra del palcoscenico offre infinite
possibilità di manovre per scappare senza esser visti, per incontri segreti e avvolgimenti molteplici.
Lui bussa alla porta; lei s’affaccia in alto dal balcone per fargli cenno che scende ad aprirgli la
porta. (È così che passano i minuti a teatro.) Poco dopo che è entrato, torna il marito e, accorgendosi
di aver dimenticato le chiavi, bussa anche lui. Bussa una seconda volta e ancora e poi ancora. Solo
dopo diversi minuti la moglie s’affaccia al balcone. Non appena lo fa entrare, l’amante appare sul
balcone, afferra una corda fissata ad una carrucola, e scivola sicuro diagonalmente fino all’altro lato
del palcoscenico. Oppure due giovani innamorati hanno installato un sistema di segnalazioni tra i
loro balconi. Si mandano lettere d’amore; flirtano e si lanciano baci in alto mentre, in basso, gli
adulti continuano i loro affari. Oppure quelli in alto, i consapevoli, si beffano in contrappunto di
quelli in basso, gli ignari.
Tutto ciò anima vivacemente lo spazio incorniciato dal proscenio. Gli occhi degli spettatori devono
muoversi velocemente dal basso all’alto, da una diagonale all’altra, senza quasi mai potersi
soffermare a capire tutto quello che viene presentato. La coreografia abilmente favorisce i momenti
chiave di ogni cambio di coppia prevedendo spazi di calma e di ripetizione in momenti di equilibrio
delle coppie. Anche la distanza visiva tra gli eventi fa sì che alcune azioni si vedano solo in modo
confuso mentre altre vengono messe a fuoco.
Gli spostamenti degli sguardi dello spettatore attraverso le varie demarcazioni dello spazio sociale
pongono l’accento sugli impliciti conflitti dei quali si nutre l’intreccio, sia che si tratti delle
differenze tra i vari gruppi parentali, o della discrepanza di interessi tra la famiglia e la comunità,
della divergenza di attrazione erotica e doveri famigliari, oppure del divario incommensurabile tra
la tendenza dei genitori ad aderire al contratto sociale e l’ardente, impossibile amore della loro
progenie. Allo stesso tempo, la rapidità e la molteplicità dell’azione dislocata nei vari spazi rende
ancora più convulse le trame macchinate da eros e inganno.
Tele e macchine in scena
...Perfino quando giunse notizia dall’estero del successo delle nuove forme, l’Opéra persistette a
coltivare altri valori, continuando a produrre gli sfarzosi e spettacolari opéras-ballets per i quali si
era fatta una fama internazionale. In un’epoca in cui la gente comune assisteva agli spettacoli del
circo, ai giochi pirotecnici, all’esibizione di deformità mostruose, e agli esperimenti con l’elettricità
e il magnetismo, l’Opéra si distingueva come la più opulenta per gli effetti visivi. Come moltissimi
altri teatri costruiti nel Settecento, il palcoscenico dell’Opéra disponeva di diverse serie di quinte su
ciascun lato con i relativi bordi di cielo pendenti dall’alto, e di fondali, e tutto era dipinto a creare
un’unica scena, che s’allontanava in perfetto scorcio prospettico verso un punto di fuga centrale. La
scenografia poteva ritrarre una grande varietà di luoghi tra loro contrastanti, inclusi giardini ornati,
colonnati marmorei, o piazze gremite di città con il porto in lontananza e le navi nel mare. Le botole
permettevano di integrare una data scenografia con l’apparizione di una statua, una fontana o un
altare. L’ingegno noto con il nome di gloria, capace di trasportare diversi personaggi in una volta,
poteva discendere dalla soffitta mascherato da carro del dio o da nuvola di Cupido. Grazie alle
attività, cronometrate al secondo, che si svolgevano sopra, sotto e dietro il palcoscenico, nel tempo
di soli tre/cinque secondi altre quinte potevano scorrere nella loro sede con i rispettivi bordi di cielo
e i fondali. La nuova scena si ricostruiva a scatti sotto gli occhi degli spettatori, e più di una volta,
durante la serata, il passaggio da un caotico disordine di colori ad un quadro ben composto
incantava il pubblico.14
Le macchine dietro la scena simulavano il tuono e il mugghiare del vento, il fosforo incendiato nella
graticcia riproduceva il fulmine. Riflettori rotanti collocati in prossimità delle colonne verticali di
candele in ciascuna quinta gettavano una luce intensa su alcune zone del palco, e ne lasciavano in
ombra altre. Bocce piene di liquido colorato tenute davanti alle candele bagnavano la scena di blu,
rosso, o verde. Suggestivi com’erano, questi effetti gareggiavano con lo spettacolo elegante creato
dagli stessi spettatori nella sala in penombra ma mai al buio.15 L’attenzione dello spettatore, sviata
verso uno dei tanti palchetti dalla suggestiva posa che assumevano i corpi e dallo sfoggio di stoffe e
gioielli, era catturata nuovamente da una nuova scena strabiliante sul palco, per tornare poi a vagare
tra il pubblico in cerca di uno stimolo in più, visivo e sociale.
La ben meritata fama d’opulenza visiva di cui godeva l’Opéra era superata soltanto dalla
reputazione del suo balletto, noto in tutta Europa per lo sfarzo e l’armonia di scene, costumi e
coreografia. Dopo momenti in cui l’azione era minima e i cantanti dichiaravano formalmente i
propri sentimenti e le proprie intenzioni, improvvisamente incedevano sulla scena corpi ricoperti di
piume, nastri, rasi e merletti. Ogni ballerino, ciascuno ornato e con i capelli acconciati in modo
diverso, contribuiva allo straordinario montaggio di colori, disegni e tessiture che decoravano il
palcoscenico. I balletti coinvolgevano un gran numero di ballerini in disegni che ricamavano lo
spazio con un’infinita serie di configurazioni. I ballerini passavano dalla formazione a ruota alla
disposizione in colonne, sfilavano fino alla ribalta, si giravano per andar via sui due lati, ricreavano
piccoli circoli, si scambiavano singoli ballerini tra i circoli e poi improvvisamente riapparivano in
file ordinatamente distanziate. Singoli ballerini ne conducevano altri lungo percorsi complessi che
intrecciavano i gruppi in montaggi intricati, e ogni montaggio si dissolveva facilmente in quello
successivo.16
I ballerini eseguivano le parate di figure facendo uso di un’energia modesta ma dinamica. I fraseggi
illustravano una gamma, ma senza arrivare alle punte estreme, di velocità e lentezza. Passi del
vocabolario di base spingevano i ballerini lungo traiettorie stabilite, consentendo loro di venire a
contatto l’uno con l’eleganza dell’altro. Le gonne a campana delle ballerine oscillavano da parte a
parte, e a volte facevano intravvedere la flessione e l’arco della caviglia. Il tonnelet maschile, gonna
cortissima tenuta rigida da fili di ferro, da una parte metteva in evidenza il movimento di tutta la
gamba, ma dall’altra segmentava il corpo come il costume delle donne, in una periferia articolata e
in un corpo centrale composto. I passi della ballerina, solo appena visibili, e il movimento tutto allo
scoperto del ballerino, creavano un piacevole confronto durante i loro frequenti unisoni. Ampi
cerchi tracciati con le gambe (ronds de jambes); spostamenti del peso su un lato, davanti, indietro;
slanci; giri – tutto mostrava la sincronia dei ballerini. L’unisono si poteva apprezzare anche
rilevando l’esatta ubicazione del corpo entro una griglia verticale. Il vocabolario dei passi
proponeva numerose altezze per il corpo – i gradi di plié o relevé – ed altrettanto sottili ma precisi
cambiamenti di fronte per il ballerino. Perfino quando i ballerini dirigevano i loro movimenti l’uno
verso l’altro attorno ad un punto centrale, i cambiamenti di fronte e di altezza confermavano la loro
esatta sincronia.
Il palco inclinato conferiva ulteriore complessità e dinamismo all’azione: faceva sì che i ballerini in
fondo alla scena raggiungessero un’elevazione sufficiente per essere distinti al di sopra delle teste
dei ballerini davanti; moltiplicava perciò la varietà ottica entro la cornice del boccascena mentre,
allo stesso tempo, dirigeva l’attenzione dello spettatore sui disegni tracciati sul pavimento dai
ballerini veleggianti attraverso lo spazio. La pendenza del palco rendeva inoltre differenti i percorsi
diretti verso il fondo della scena da quelli che venivano in avanti, verso il pubblico. Infatti, quando i
ballerini risalivano con fatica la modesta ma percettibile rampa, i loro movimenti, seppur non meno
eleganti, si caricavano dello sforzo, e i loro corpi apparivano sospesi nella decrescente prospettiva.
Di contro, i fraseggi eseguiti scendendo verso la parte anteriore del palco esibivano un abbandono
spensierato, tenuto a freno soltanto dal controllo necessario per non valicare i limiti di una condotta
appropriata. Il momento in cui un ballerino nella parte superiore del palco girava su se stesso per
iniziare la discesa trasmetteva un’eccitazione gioiosa; mentre invece il giro per iniziare la salita
confermava la necessità di camuffare il sentimento opposto affettando una facilità completa. Questo
tira e molla creato dagli sforzi variabili dei ballerini vivacizzava le gerarchie simmetriche dei loro
raggruppamenti e arricchiva gli schemi geometrici sul pavimento...
14
Per un’esaustiva analisi dell’architettura e della macchineria del palco settecentesco, vedi Baur-Heinhold, Baroque
Theatre, e Gruber, Les Grandes Fêtes et leurs Décors à l’Epoque de Louis XVI.
15
Theatre Lighting Before Electricity di Penzel fornisce un’ottima descrizione delle condizioni d’illuminazione del
palco e della sala nel ’700.
16
Gallini fornisce i disegni degli schemi del pavimento per alcune di queste configurazioni in A Treatise on the Art of
Dancing, p. 164.
La terra trema, la folgore scoppia
Le cose vanno bene, oppure vanno male. Non importa. Arriva un momento in cui la narrazione
esige un rilancio. Allora la terra trema e la folgore scoppia. Un cataclisma naturale interviene
all’improvviso nel corso delle vicende umane. Questo prevedibile intervento non ha bisogno di una
ragione per esistere. Nulla nell’intreccio fa presagire l’arrivo di una simile catastrofe. Forse indica
l’ira degli dèi, oppure rappresenta la potenza cieca della Natura stessa. Può darsi che redarguisca i
personaggi per le loro azioni, o che renda più disperate le situazioni in cui vivono. Forse servirà a
misurare le loro capacità morali e fisiche. La trama non ha escogitato un modo in cui le azioni
umane possano assolvere a queste funzioni valutative. Ma lo spettatore non si accorge di questa
falla narrativa. La grandiosità persuasiva dello spettacolo ci trascina immediatamente dentro
l’incombente distruzione.
Le nuvole s’addensano e il palco si oscura all’improvviso. Lampi di luce intermittenti illuminano a
tratti la scena. Enormi ondate appaiono sulla marina. Gli edifici traballano e alcuni crollano. I
personaggi corrono da una parte all’altra avanti e indietro – aggrappandosi, agitando convulsamente
le braccia – il loro moto vorticoso accresce lo sconquasso del palco.
Questo spettacolo tecnologico non richiede, da parte dello spettatore, la partecipazione emotiva che
le azioni umane pretendono. Lo spettatore sa dall’inizio che è il movimento delle macchine a
simulare la catastrofe. È l’ordine stesso di grandezza dell’operazione, la complessità del timing e
del coordinamento, sono le stesse trasformazioni radicali della scatola scenica che si imprimono in
modo tanto forte sullo spettatore. L’enormità meccanicistica e tecnologica dell’interruzione provoca
un sobbalzo che le azioni umane non sono in grado di produrre. Dopo aver visto con i propri occhi
un apparato scenico di tale portata, gli spettatori non possono che riconoscere gli effetti catastrofici
di un simile cataclisma nella vita dei personaggi che hanno imparato a conoscere. Il disastro assolve
quindi la duplice funzione di far rabbrividire il pubblico con la sua stupefacente, impressionante
azione distruttiva e di cambiare, incidentalmente, il corso della vicenda narrata.
Fuga nei cieli
Non importa quanto instabile sia la traversata, quanto visibili siano le funi; c’è qualcosa di
irresistibile e delizioso nel librarsi nell’aria. La macchina del volo, la gloria, arriva camuffata da
carro o da nuvola. È tipica degli dèi, che la usano negli spostamenti tra cielo e terra per intervenire
nelle faccende umane. Salgono su una piattaforma nascosta da un dipinto/nuvola e indicano col
gesto la loro destinazione. La nuvola comincia a planare attraversando il fondale/cielo, consentendo
ai passeggeri di formare un gruppo maestoso mentre salgono o scendono.
Gli dèi appaiono in momenti assurdi, in cui è assai chiaro che la storia si è infilata in un vicolo cieco
da cui non può districarsi senza un aiuto aereo. Entrano gli dèi, a raddrizzare le cose, a metterle in
ordine. E tuttavia, non importa quanto possa sembrare fiacco il loro goffo ripristino delle gerarchie
sociali e morali, la loro corsa su e giù dai cieli è inebriante. La gloria è grande ma non
sproporzionata rispetto alle altre nuvole e ai raggi di luce che occupano il cielo. Viaggia abbastanza
lenta da dare la giusta rilevanza alla dignità di coloro che trasporta e all’impresa memorabile di
sollevare dei corpi in aria, ma abbastanza rapidamente da sembrare un miracolo.15 Stanno volando!
Anche quando attaccano le funi direttamente al corpo dei personaggi e li tirano nell’aria, il gesto del
volo resta lo stesso: il corpo ha sfidato le leggi della gravità e della narrazione.
Soltanto i buoni arrivano a farlo, o piuttosto, è un segno della loro bontà d’animo il fatto che i
personaggi abbiano accesso in aria. La discesa in terra mette a rischio il personaggio che scende. Gli
dèi, commossi, coinvolti nelle vicende dell’umanità, possono soccombere al desiderio e alle
passioni che gli fanno corona. L’ascesa al cielo porta la liberazione da tutto questo trambusto. Là,
nello spazio etereo della pura astrazione, i personaggi vedono e fanno solo ciò che è giusto. Il
presentimento di questa esistenza celeste, incarnata nell’atto del volo, dà tensione drammatica alle
vicende terrene.
15
Se tutto va bene, i personaggi planano come per magia. A volte, però, il meccanismo s’inceppa e quello che era stato
un momento maestoso si disintegra nel caos, come in questa descrizione di una serata in onore di Pierre Gardel:
«Riassumendo, il balletto Psyché è lontano dall’essere divertente. Un solo incidente ha suscitato l’ilarità del pubblico;
nel momento in cui Giove, accompagnato da Venere, Amore e Psiche, volle montare su una grande nuvola imbrattata di
giallo e di bianco, che, secondo l’uso antico e solenne serviva da veicolo alle divinità dell’Opéra, la suddetta nuvola si è
mostrata restia, l’orchestra aveva bell’e ricominciata la ripresa, ma la macchina restava immobile. Alla fine, i poveri
immortali, completamente fuori dai loro ruoli, sono stati costretti ad attraversare tutto il palcoscenico per riguadagnare
le quinte, con gran divertimento del pubblico che li salutava con acclamazioni rumorose» (Anon., in «Le Figaro», 25
febbraio 1829, p. 2).
La realizzazione scenica del ‘diversivo’
...il sensazionale salto con cui Carlotta Grisi nei panni della Peri cadeva tra le braccia di Lucien
Petipa nel balletto La Péri (1843), suscitava una tale attesa che se la coppia non l’eseguiva
perfettamente, il pubblico chiedeva di ripeterlo fino a quando non era soddisfatto.29
Se questi momenti che catturavano l’attenzione con la loro spettacolarità distoglievano gli spettatori
dalla narrazione, la scenografia li aiutava ad immergersi di nuovo nell’azione. Scenografi come
Daguerre e Ciceri s’affidavano ai progressi dell’illuminotecnica e disponevano attentamente i loro
tessuti traslucidi per creare un mondo sul palcoscenico che riuscisse a tirare dentro anche il
pubblico.30 In netto contrasto con le scenografie del ’700 e del primo ’800, che per lo più
presentavano spazi pubblici ampi, aperti, simmetrici che spingevano l’azione verso il pubblico,
queste scenografie creavano la sensazione di un’interiorità. Al posto di colonne uniformi schierate
sul palco, i loro paesaggi spesso avevano qualche elemento architettonico o naturale molto alto
nella parte antistante della scena – spuntoni di rocce, un ponte, un’isola – oltre il quale o attraverso
il quale gli spettatori guardavano per arrivare all’interno dello spazio scenico. Allo stesso modo era
disposta la vegetazione, così da stabilire un volume o una serie di volumi digradanti dentro il
quadro scenico.
Attirato in questi spazi, lo spettatore era sopraffatto da una misteriosa malinconia appena
l’abbassamento della luce provocava nel barlume l’enigmatica apparizione e sparizione di giovani
donne. Il balletto delle monache, un rituale di mezzanotte in un chiostro che evocava le monache
dalle loro tombe nel terzo atto dell’opera Robert le Diable, segnò il debutto di questo nuovo tipo di
collaborazione della coreografia con l’illuminotecnica e la scenotecnica. Quando divenne direttore
dell’Opéra, uno dei primi atti di Louis Véron fu di ampliare questa sezione dell’opera per rendere
appieno l’atmosfera di tetro presagio nel momento in cui le suore s’alzano dalle tombe, s’inarcano,
fanno un rapido movimento in avanti e avanzano scivolando nello spazio, fino a creare un vortice
minaccioso di luce e movimento. Nei balletti successivi che contenevano creature soprannaturali, la
luce che si posava sulle gonne a strati delle ballerine mentre esse si libravano fra la profusa
vegetazione della foresta, otteneva un effetto tremolante, traslucido. Complicate macchinerie
consentivano alle ballerine di volare da una parte all’altra del palco. La coreografia poté fare
affidamento sull’indefinitezza ottica ottenuta grazie alla tecnologia, in modo da tenere gli spettatori
impegnati a decifrare l’ombra, l’immagine e il moto. Questa meditazione prolungata sull’illusorietà
stessa, condotta sulle note di una melodia ossessiva, induceva il pubblico in un’alterità che
enfatizzava enormemente quello che l’intreccio e il personaggio potevano dare.
30
Daguerre aveva utilizzato l’appena installato sistema d’illuminazione a gas per la prima volta all’Opéra, nella
produzione di Aladin (1822), che ebbe un enorme successo. Nell’aprile del 1827, si formò una commissione speciale
dell’Opéra per aggiornare la scenografia e la scenotecnica. Il membro più influente della commissione, Henri
Duponchel, divenuto più tardi direttore dell’Opéra dal 1835 al 1840 e dal 1847 al 1849, avviò alcune riforme che
includevano anche la caduta del sipario tra un atto e l’altro, in modo che la scenografia potesse essere più complessa e
quindi più realistica. Duponchel tra l’altro diede ad esempio pieni poteri a Ciceri per le scenografie di Robert le Diable
e della Sylphide. Per una visione generale di questi cambiamenti, vedi Guest, The Romantic Ballet in Paris, pp. 13-15.
Per un’analisi più dettagliata sull’uso di tessuti traslucidi e su altri effetti d’illuminazione e scenici, vedi Allevy, La
Mise en Scène en France dans la prèmiere moitié du dix-neuvième siècle e Join-Diéterle, Les Décors de Scène de
l’Opéra de Paris à l’Époque Romantique.
La Silphide (1832)
...Il fascino profondo di questo libretto risiede nelle categorie fortemente contrastanti – castello e
foresta, strega cattiva e sposa innocente, presenze soprannaturali e paesani reali – che danno vita a
una spettacolarità impressionante e a danze diversificate. La danza delle streghe all’inizio del
secondo atto accentua l’estrema differenza tra la cultura del castello e una natura misteriosa e
sregolata: il cerchio pulsante spingeva i corpi a una contorsione grottesca dei valori classici: dorsi
ingobbiti, salti ponderosi ma minacciosi, dita a ragnatela. Venendo dopo le feste ben ordinate e
gioiose dei paesani del primo atto, che esprimevano la loro festosità in sequenze simmetriche di
balzi, battements e gallops, tutto in stile scozzese, le streghe evocavano un mondo infero buio e
tragico. I bordi cenciosi delle loro maniche, i cappelli appuntiti che fendevano la nebbia
rappresentavano l’antitesi ai lindi kilt di lana e alle gonne e alle braccia arrotondate degli abitanti
del villaggio. Le linee gotiche del castello ugualmente creavano un contrasto con la profusione di
alberi e cespugli in cui vivevano le silfidi. I loro costumi e il vocabolario di movimenti, un
vocabolario che includeva il volo, trasportavano gli spettatori in una terra diversa da ogni realtà
conosciuta.
Le vaporose gonne di mussola, le sissonnes sfreccianti e le corse senza peso, le braccia fluttuanti,
tutto conferiva alle silfidi il loro aspetto etereo. Una macchineria complessa le aiutava ad esplorare
l’aria, suggerendo la possibilità di una leggerezza e di un volo senza precedenti. Alla fine
dell’assolo d’apertura come silfide, Maria Taglioni si precipitava nel caminetto e si aggrappava a
una sbarra nascosta che la tirava su attraverso il comignolo, mentre le punte dei piedi sparivano
come ultima traccia di un unico gesto che convertiva il moto orizzontale in verticale. Quando
passava dalla finestra mettendo il piede su un tavolo sotto il davanzale, manteneva un atteggiamento
diffidente mentre una sezione della tavola la calava dolcemente a terra. Questi momenti di suspense,
accresciuti dall’abilità propria della Taglioni di produrre leggerezza nell’estensione delle membra o
nei balancés en pointe, rendevano credibilissimi gli audaci voli, attraverso tutta l’ampiezza del
palcoscenico, da parte dei membri del corps de ballet del secondo atto. Mentre altre creature della
loro specie stavano appollaiate sulla cima degli alberi che circondavano la radura, le silfidi in
arabesque, con le braccia protese in avanti, scivolavano da una parte all’altra del palcoscenico,
creando l’illusione che la loro comunità abitasse con la stessa facilità sia la terra che l’aria. Altre
ballerine entravano e uscivano dalla vista, assicurate a carrelli che scivolavano su ruote sullo sfondo
dei cespugli al di là della radura. Molti di questi ingegni erano stati usati in precedenti balletti; ad
esempio, Flore et Zéphire di Didelot aveva elettrizzato gli spettatori con il volo delle ninfe. Ma mai
era accaduto che questi effetti si combinassero così fluidamente con il personaggio e il movimento,
da creare un mondo assolutamente convincente ma radicalmente diverso dalle scenografie di
ambientazione contemporanea o storica...
Spazi bui
Nella radura di una foresta, presso la bocca di una caverna, nelle fauci stesse dell’inferno: queste
sono le ambientazioni della danza aberrante. In questi ambienti bui e chiusi le furie agitano le loro
vipere, le streghe preparano i propri infusi, i pazzi dimorano in un’agonizzante introspezione,
apparizioni fantasmatiche brillano debolmente apparendo e scomparendo. Simili ambientazioni
fanno un ottimo contrasto con le forme aperte, ariose e rettilinee della città e le morbide curve
ondulate del paese o di un possedimento in campagna. Circondano un centro d’oscurità con sentieri
serpentini, intricati, nascosti, di luce e di vegetazione, che non offrono certezze tangibili, che non
permettono una via d’uscita. Analogamente, la danza che avviene in questi spazi – angolare,
contorta, grottesca e misteriosa – non somiglia affatto alle agevoli e felici interazioni dello spazio
pubblico. Qui, i valori del corpo socievole sono mutilati, forzati in una direzione al punto da alterare
la scala che misura il comportamento appropriato e perfino il virtuosismo.
Qual è lo scopo di questi spazi? Al pari delle loro controparti, i cieli, garantiscono la possibilità di
dramma nelle vicende terrene. Ma, mentre i cieli agiscono come antica alternativa alla vita terrena,
gli spazi bui simboleggiano la fonte del conflitto. Quelli che hanno perso il senno si ritrovano nella
radura, deliranti, in lotta contro e dentro l’intero volume della loro interiorità, alla ricerca di
un’identità: la foresta avvolge il personaggio come una seconda pelle, rappresentando l’esterno del
suo corpo in maniera tale che il suo intero repertorio di movimenti sta ad indicarne il tumulto
interiore; un gesto distratto, un giro frenetico, la testa rivolta all’indietro, sono azioni che incarnano
la scaturigine del conflitto che avviene nell’anima. In alternativa, coloro che vagano nella tenebrosa
radura possono cadere preda dell’energia allucinatoria e sensuale che questi luoghi suscitano. Resi
vigili dal desiderio, vedono all’improvviso le creature che abitano questi spazi. Sono reali? Sono
una proiezione simile a un sogno? Come in risposta agli interrogativi del personaggio, sfrecciano
minacciosamente vicine e poi lontanissime, chiamando a raccolta i problemi stessi che la storia
deve risolvere.
Non è una rivelazione. Né lo è il fatto che la maggior parte delle creature che danzano e vivono in
questi luoghi siano femminili e di una razza sconosciuta. (Il buio consente la facile trasposizione
d’attributi razziali in sessuali e viceversa.) Circe, che medita davanti alla sua caverna, trama per
trattenere Telemaco. Le Furie, rianimandosi all’arrivo di Don Giovanni all’inferno, danzano verso
di lui seducenti solo per lanciargli una vipera quando egli cerca di far loro da partner. Madge, la
strega, confeziona una sciarpa che catturerà la silfide ma che ne causerà anche la morte. Le
malvagità di cui sono capaci queste donne sono tutte finalizzate a suscitare, negli spettatori, la
compassione per le difficoltà di un maschio e a perpetuare il progresso della felicità di un maschio.
Cosa farebbe la storia senza di loro?
Gli spazi bui e le creature che li popolano s’intromettono nella narrazione, soffocando la storia con i
loro indicibili poteri. Ma nel momento stesso in cui sta per essere strangolata, la storia sempre
rimbalza libera. Trionfante, rivolge tutto il suo peso contro il buio e ne dissolve gli abitanti, non per
sempre, ma almeno fino al crepuscolo, fino a quando avrà bisogno di mettersi di nuovo alla prova.
La storia ha un altro modo per mostrare i muscoli? Forse, ma questo duello con il buio e dentro il
buio è molto pratico. Ci sono tante scenografie nel magazzino, basta ridipingerle e usarle nel
prossimo spettacolo. Le luci conoscono l’inclinazione perfetta, la musica le sinistre melodie. Ah,
eccole che ritornano.
Opéra Giselle, volo
Opéra La Péri, volo
11
Scenotecnica nell’Ottocento: illustrazioni (v. file a parte)
12
Max Milner, La Fantasmagoria. Saggio sull’ottica fantastica
In un articolo che doveva restare memorabile 1, , Jean Bellemin-Noël distingue, a proposito di un
certo numero di racconti fantastici di Gautier, il fantasmatico, che corrisponde al lavoro
dell’inconscio, in quanto produce nel racconto un certo numero di organizzazioni significanti e
procede, come il sogno, per via di spostamenti, di condensazioni e di simbolizzazioni, da ciò che
egli chiama il fantasmagorico, e che rappresenta, a un livello più conscio, l’insieme delle strategie
testuali per cui il fantasmatico acquista la sua forza sullo spirito del lettore. Con un’etimologia del
tutto accettabile, il fantasmagorico sarebbe cosi la maniera con cui l’autore fantastico fa parlare il
fantasma, lo porta alla luce e lo trasforma in oggetto di seduzione, di fascinazione e di godimento
estetico per il lettore.
Quest’ultima incarnazione della parola « fantasmagoria » ci aiuterà a definire meglio ciò che ha
ispirato e orientato la nostra ricerca. Attraverso un uso intensivo lungo tutto il secolo XIX, la parola
ha conservato qualcosa delle proprie origini ottiche, e ci sembra degno di attenzione che essa si sia
imposta a uno dei critici che più acutamente hanno riflettuto sul fantastico. Il problema che cerca di
formula rsi nelle pagine appena lette deriva interamente dal rapporto tra il fantastico e l’ottica che
tale incontro lascia presentire. Proprio perché ci pareva evidente che questi rapporti fossero molto
diversi da quelli che si potrebbero tentare tra il fantastico e l’acustico, o tra il fantastico e la
biologia, per fare un esempio, questa ricerca si è imposta alla nostra attenzione, e ci sembra che essa
ci abbia di continuo posto davanti allo sguardo non una serie di temi, possibili fra altri, della
letteratura fantastica, ma qualcosa che tocca quasi la sua stessa essenza, o le condizioni del suo
funzionamento.
Ciò dipende in parte, come si è visto, dal fatto che tale letteratura si è -sviluppata in un’atmosfera
satura di ottica. Il secolo dei Lumi è stato anche, in un certo senso, il secolo della luce, e lo sviluppo
delle osservazioni e delle tecniche che consentono di dominare le leggi della propagazione della
luce e di rettificare o di modificare, utilizzandole, le apparenze del mondo ha spostato a tal punto le
frontiere tra il reale e l’illusorio, tra l’oggettivo e il soggettivo, e persino tra il presente e il passato,
che ciò non poteva non avere conseguenze sullo statuto dell’immaginario nella letteratura, e
segnatamente in quella sezione della letteratura il cui specifico è di operare sui limiti del verificabile
e dell’inverificabile, del possibile e dell’impossibile, e di imporne la presenza con pari probabilità 2.
Si è spesso notato come la letteratura fantastica si sia sviluppata parallelamente alla letteratura
realistica, e come essa tragga la sua forza dall’applicazione dei principi del racconto realistico a
contenuti che ne minano le basi. Si ha qui ben altro che un semplice conflitto tra ideologie di
ispirazione opposta, come potrebbe far pensare, ad esempio, l’opera di Villiers de l’Isle-Adam.
Nella misura in cui ha aperto spazi sempre più vasti alle diverse modalità del « far-vedere» e ha
diversificato le tecniche di « presentificazione », la letteratura narrativa si è collocata su un terreno
ove il fantastico doveva per forza incontrarla e farle concorrenza mutuandole i mezzi per soddisfare
una pulsione scopica che, secondo gli studi più recenti, è alla base di tutto il lavoro
dell’immaginazione — o perlomeno del modo con cui tendiamo attualmente a rappresentarcelo,
cosa che può discendere, per un effetto di feed-back, dal fatto che vediamo l’immaginazione
attraverso gli occhiali lasciatici in eredità dal XIX secolo, dominato com’era dall’ottica.
Che l’immaginazione sia il regno delle immagini, ossia dei fenomeni mentali che non possiamo
rappresentarci se non sotto forma di scene, di quadri, o di figure presenti a una sorta di occhio
interiore, è un fatto che il lessico ha registrato (e forse accentuato) ormai da secoli 3. In questo
senso, è naturale che l’invenzione o la volgarizzazione di nuovi dispositivi che permettono di
affinare o di modificare la visione dell’occhio reale abbiano influito sulle rappresentazioni che gli
uomini si sono fatte del funzionamento di quest’occhio metaforico. E il primo capitolo ha fornito
alcuni esempi, che si potrebbero moltiplicare e ordinare più sistematicamente, di questo transfert,
mentre la fortuna, in Francia, della parola «fantasmagoria», con le sue connotazioni di evanescenza,
di artificio e di inganno, ma anche di potenza fascinatrice e di metamorfosi poetica del reale, mostra
chiaramente come l’invenzione di una nuova tecnica sul piano dell’ottica permette non soltanto di
qualificare nuove modalità dell’immaginario, ma anche, in certa misura, di promuoverle.
Senonché ciò che avviene nel fantastico non rientra unicamente nella sfera della rappresentazione.
In ugual misura vi ha parte il desiderio dell’uomo, le sue pulsioni e le loro rimozioni, ed è qui forse
che l’incontro tra 11 fantastico e l’ottica si rivela più fecondo, più ricco di mezzi per significare,
sotto le specie di una sovrapposizione o di una disgiunzione di spazi, di una riduzione dal
tridimensionale al bidimensionale, di una duplicazione o di una simmetria, anzi di un’anticipazione
o di un accavallamento temporale, il rapporto « stranamente inquietante » tra una realtà che tende a
darsi a vedere come coerente e compatta e un universo pulsionale che la fende o ne fa vacillare le
prospettive.
Non vi è in questo alcuna casualità. Sin dai primi studi che mettono in campo la nozione
d’inconscio, Freud ricorre all’immagine di apparecchi ottici per far comprendere ai lettori che il «
luogo » in cui egli situa i fenomeni di cui parla è a un tempo tributario delle categorie spaziali, che
danno un senso alle nozioni di trasporto psichico, di spostamento o ai condensazione, e
perfettamente fittizio, o più esattamente virtuale.
L’idea che viene cosi posta a nostra disposizione — scrive Freud nell’Interpretazione dei sogni — è quella di
una località psichica. Intendiamo tralasciare completamente il fatto che l’apparato psichico in questione ci è
noto anche come preparato anatomico e vogliamo evitare con cura la tentazione di determinare in senso
anatomico la località psichica. Restiamo sul terreno psicologico e ci limitiamo ad aderire all’invito di
rappresentarci lo strumento che serve alle attività psichiche pressappoco come un microscopio composto, un
apparecchio fotografico e simili. La località psichica corrisponde allora a un punto, situato all’interno di
questo apparecchio, nel quale si forma uno degli stadi preliminari dell’immagine. Nel microscopio e nel
telescopio si tratta come è noto di località e regioni almeno in parte ideali. nelle quali non esiste alcuna
componente tangibile dell’apparecchio. Ritengo superfluo scusarmi per le imperfezioni di queste come di
tutte le altre immagini analoghe; questi paragoni hanno soltanto il compito di sostenerci nel tentativo di
comprendere la complessità dell’attività psichica, scomponendola e assegnando le singole prestazioni alle
singole componenti dell’apparato 4 .
Queste reticenze e avvertimenti devono senza dubbio esimerci dal prendere alla lettera ciò che non
è se non uno schema didattico di spiegazione. Ma è solo questo? A libro ormai compiuto, ecco
apparire un saggio e un’opera di Gérard Bonnet che portano nuova luce sullo statuto dello sguardo
nell’apparato concettuale di Freud e nei suoi studi clinici, Da essi risulta subito che sin dai primi
lavori di neurologia, Freud annetteva un’importanza particolare al fenomeno della visione, e che il
suo primo studio di un caso di isteria, pubblicato nel 1886, concernente un giovane affetto da turbe
del campo visivo e del senso cromatico, conteneva in nuce un orientamento fondamentale della
psicoanalisi che lo portava a interessarsi del funzionamento dell’occhio interiorizzato, « in altre
parole, dello sguardo nella sua funzione immaginaria, psichica », laddove Charcot non s’interessava
se non del ruolo sensoriale dell’organo 5. Gérard Bonnet mostra anche, analizzando un sogno di
Freud, « il sogno della scala » 6 contemporaneo alla scoperta del complesso di Edipo, quanto la
diade esibizione-inibizione, che domina questo sogno, ponga il fenomeno dello sguardo al centro
del movimento che spinge Freud verso la creazione della sua teoria e, al di là della sua persona, la
psicoanalisi verso la realizzazione dei suoi fini: sognare di denudarsi, significa a un tempo incorrere
nel rischio della riprovazione e della derisione e affermarsi come solo creatore, negare alla sfinge il
suo potere e spodestare il padre (carnale o intellettuale) della sua paternità.
Non meraviglia, in tali condizioni, che la pulsione scopica non si collochi in Freud e in coloro che
hanno voluto mantenere intatta la sua eredità, esattamente sullo stesso piano delle altre. In essa, pii5
che in alcun’altra, si manifesta in effetti questo, che esse hanno tutte in comune, cioè che non si
appagano di raggiungere ‘l’oggetto a cui mirano, ma vogliono aggirarlo, instaurare un circuito nel
quale l’oggetto cercato è sempre, già prima, l’oggetto perduto. La formula di Lacan: « Ciò che si
guarda è ciò che non può vedersi » 7, è trasferibile — e Lacan poi mostra in che modo — a tutte le
altre pulsioni. Ma il circuito ottico è il solo che mantenga l’evanescenza dell’oggetto al di fuori di
ogni equivoco, per cui Gérard Bonnet può ora scrivere: « Si può dire della pulsione scopica che essa
gode di tutte le altre pulsioni, della rappresentazione che se ne fa e includendovi lo scarto che ne
risulta », non trascurando però di osservare « quanto la teoria delle pulsioni in Freud, ma ancor più
dopo di lui, sia condizionata dallo specchio attraverso il quale il desiderio di vedere ci fa apprendere
le cose » 8.
Che per una delle maggiori correnti del pensiero contemporaneo, l’ottica sia la terra di elezione in
cui s’inscrive ciò che avviene dell’immaginario nella sua relazione col reale, Lacan lo esprimeva in
forme argute, nel seminario del 1933-1954; con questa esortazione a quanti lo ascoltavano:
Non mi stancherò di raccomandarvi di meditare sull’ottica. Cosa curiosa, si è fondato un intero sistema di
metafisica sulla geometria e la meccanica, cercandovi dei modelli di comprensione, ma non sembra che si sia
tratto tutto l’uso possibile dall’ottica. Essa dovrebbe tuttavia prestarsi ad alcuni sogni, questa stramba scienza
che si sforza di produrre con degli apparecchi quella cosa singolare che si chiama immagini, a differenza
delle altre scienze, che introducono nella natura una divisione, una dissezione, un’anatomia 9.
Piace trovare in queste parole la giustificazione del nostro assunto. Sognare sull’ottica: gli autori
fantastici di cui ci siamo occupati in queste pagine non hanno fatto altro. E nel far questo, essi non
soltanto hanno integrato alla tematica dei loro racconti ciò che modellava la visione del mondo dei
loro contemporanei o costituiva l’oggetto delle loro preoccupazioni. L’ottica fornisce a tali autori il
mezzo di strutturare in modo nuovo uno spazio immaginario in cui i rapporti tra il desiderio del
soggetto e gli oggetti o gli ostacoli che offre il mondo culturale, religioso, sociale, possono
esprimersi rispettando gli spazi vuoti, i punti ciechi che risultano dalla sua situazione problematica,
o lasciando affiorare l’angoscia che provoca il riempimento immaginario di questi vuoti.
In questo senso, la frontiera tracciata da Bellemin-Noël tra il fantasmatico e il fantasmagorico ci
sembra troppo rigida. La fantasmagoria non è soltanto l’arte di far parlare il fantasma. Attraverso il
rapporto complesso che essa stabilisce tra l’illusione e la realtà, tra il desiderio di vedere o di sapere
e le lacune di un universo narrativo in cui le prospettive contraddittorie si sovrappongono senza
adattarsi, in cui le identificazioni rassicuranti si eclissano, la fantasmagoria giunge alle radici stesse
del fantasma. La fantasmagoria esprime l’evanescenza e il decentramento del fantasma vanificando
lo sguardo nel momento stesso in cui lo riempie, e costituisce così il mezzo per eccellenza di questo
andirivieni intorno ai limiti, di questo garbuglio delle piste e dei riferimenti che porta il lettore ad
affrontare la propria verità sotto la forma di un enigma senza risposta. Attraverso di essa, il
fantastico trasforma il gioco di nascondere-mostrare che è al fondamento di ogni letteratura
narrativa, in un gioco pieno di pericoli, ove il lettore, per definizione troppo curioso, si sente
finalmente guardato, come il Natanaele di Hoffmann, dagli occhi vuoti della Morte.
1.
Bellemin-NoëI, Notes sur le fantastique (Textes de Théophile Gautier), in « Littérature », n. 8, dicembre 1972,
pp. 3-23.
2. Su questi argomenti, si veda l’opera di Irène Bessière, Le Récit fantastique. La poétique de l’incertain, Paris,
Larousse, 1974, in particolare pp. 59-64 e 194-211.
3. Si veda il capitolo, già citato, di Jean Starobinski nella Relation critique. Anche nelle lingue che, a differenza
del francese, dispongono di varie parole per designare questo fenomeno, queste (Einbildungskraft, Fantasie,
fancy) hanno sempre un legame diretto con la sfera del visibile.
4. S. Freud, L’interpretazione dei sogni, in Opere, vol. III, Torino, Boringhieri, 1966, pp. 489-490.
5. Si veda «Psychanalyse à l’Université», t. 6, n. 23, giugno 1981, pp. 495-496.
6. L’interpretazione dei sogni, cit., p. 198. Si veda Gérard Bonnet, Voir - Ètre vu, Paris, PUF, 1981, t. I, pp. 147201.
7. J. Lacan, Le Séminaire, Livre XI, Paris, Seuil, 1973, p. 166; trad. t. Il Seminario, Libro XI, cit., p. 186.
8. Voir - Étre vu, cit,, t. II, p. 181.
9. Le Seminaire, Livre I, Paris, Seuil, 1975, p. 90; trad. t. Il Seminario, Libro I, cit.
13
Clelia Falletti, Max Reinhardt
Della carriera artistica di Max Reinhardt ciò che maggiormente colpisce è la continua
sperimentazione e la festevolezza delle sue produzioni, un’energia appassionata che profuse in più
di cinquant’anni di attività teatrale, agli inizi come attore e poi come regista, creatore di teatri, mago
della visione e formatore d’attori.
Di fronte alla marginalizzazione del teatro Reinhardt reagisce dalla parte dell’attore, da dentro il
teatro, impadronendosi della tecnologia e imbrigliandola ad uso dello spettacolo teatrale al servizio
del contatto vivo tra attore e spettatore.
Artista di successo, creò un impero sviluppando una grande rete impresariale: possedette vari teatri,
arrivò a dirigerne più di dieci, senza sovvenzioni. Iniziò come attore alla Freie Bühne di Otto Brahm
a Berlino (dal 1894 al 1903), e divenne regista creatore di spettacoli improntati a un grande
eclettismo che rispondeva alla ricerca dello stile specifico per ogni dramma. Le sue imprese teatrali,
le lunghe tournées in tutto il mondo, i festival — famoso l’appuntamento fisso di Salisburgo — i
suoi mitici Regiebücher, il repertorio di classici e di autori contemporanei, le molte scuole di teatro
a Berlino, Vienna, Hollywood fino alla sua morte nel 1943, hanno imposto la figura del regista
creatore nel teatro del ’900.
Le sue prime esperienze teatrali furono come giovanissimo appassionato frequentatore del
Burgtheater di Vienna. In piccionaia, con altri giovani spettatori, «non appena si faceva buio e si
alzava il sipario, ci fondevamo in una misteriosa entità... restavamo abbarbicati al soffitto carico di
sfarzose decorazioni, immobili come pipistrelli... con il cuore che batteva forte, con lo stesso ritmo
[degli attori sul palcoscenico] nel respiro. Due compagnie: quella degli attori e quella degli
spettatori...».
Apparteneva a una famiglia di commercianti ebrei. La sua passione per il teatro lo portò a recitare in
provincia e poi alla Freie Bühne. Ma da subito la sua opposizione al naturalismo trova sfogo in altre
contemporanee imprese con un gruppo di artisti amici. A Berlino creano il cabaret Schall und
Rauch (1901) con brevi scene e intermezzi di satira sociale. È uno spazio che l’architetto P. Behrens
adatta a teatro a sala unica con 366 posti. Nel 1902 ottengono la licenza per rappresentare spettacoli
completi e cambiano il nome in Kleines Theater. I numeri da cabaret lasciano il posto a drammi di
impronta psicologica di autori sconosciuti o senza successo a Berlino (Wedekind, H. von
Hofmannsthal, Schnitzler, O. Wilde, Maeterlinck, <C>echov).
La sicurezza economica arriva con il successo dell’Albergo dei poveri di Gorkij nel 1903, e
consente di acquisire un teatro più grande: il Neues Theater am Schiffbauerdamm (ora sede del
Berliner Ensemble), dove Reinhardt può installare alcuni degli avanzati dispositivi scenotecnici per
i quali fu famoso: la scena girevole (mezzo drammatico per magiche illusioni spaziali), l’orizzonte e
un sofisticato impianto luci.
Nel 1905 è chiamato alla direzione del prestigioso Deutsches Theater (di cui diventerà proprietario,
fino al 1934): rinnova la platea, allarga la scena e vi installa una piattaforma girevole di 18 metri di
diametro con il relativo orizzonte fisso; distrugge la scatola ottica, aggiunge un proscenio
aggettante, rende lo spazio flessibile a diversi tipi di spettacolo. Vi integra dei laboratori di
falegnameria, di attrezzeria, per le scene e i costumi — e una scuola di recitazione.
Reinhardt sogna di avere a disposizione tre teatri: uno grande per i classici, uno piccolo per l’arte da
camera dei poeti moderni - perché gli attori non si irrigidiscano in un solo stile ma alternino i due
spazi e i due stili - e poi un terzo per un’arte di dimensioni monumentali, nello spirito dei greci ma
non solo per opere greche: anfiteatro senza sipario, senza quinte, senza apparati scenici e al centro,
affidato alla pura forza della personalità e alla parola, l’attore, in mezzo al pubblico che, fattosi
popolo, diventa esso stesso parte dell’azione.
Terminato il contratto con il Kleines e nel 1906 anche con il Neues Theater, cerca una sala per i
drammi «intimi» di contemporanei e di classici.
Il nuovo teatro ricavato da una sala da ballo ristrutturata furono i Kammerspiele (un nome che
richiama la «musica da camera»). Capienza 346 posti. Ogni minima sfumatura della voce e del
gesto arrivava distintamente al pubblico. Proporzioni armoniose, arredamento semplice e accurato.
Non c’era orchestra e le file dei posti arrivavano fin sotto il palcoscenico, da cui erano separate da
un gradino. Inaugurò con Spettri di Ibsen, scene di E. Munch.
La prima occasione per creare un teatro per il popolo (sul modello del teatro greco antico) gli si
presentò nel 1910 al Festival di Monaco: mise in scena Edipo re di Sofocle davanti a quasi 3000
spettatori nella Musikfesthalle trasformata in arena. Due mesi dopo lo trasferì a Berlino adattandolo
al Circo Schumann.
Nel 1917 poté acquistare il circo Schumann che nel 1918 l’architetto espressionista Hans Poelzig
trasformò radicalmente creando il Großes Schauspielhaus, un teatro per le masse. Era un’enorme
cupola da cui pendevano stalattiti, intorno alla quale girava un grande cerchio di riflettori e luci. Per
l’attore, tre grandi aree d’azione: la scena in fondo, davanti al ciclorama fisso, è un largo podio
rialzato da cui si scende con una gradonata all’avanscena, poco profonda, incorniciata dalla
larghissima apertura rettangolare. L’avanscena è collegata al proscenio con gradini su piattaforme
mobili che abbassandosi creano la fossa dell’orchestra. E il proscenio, emisferico, aggettante,
dispone di piattaforma girevole ed elevatori, e ha tre gradini per scendere nella platea. È un
immenso anfiteatro, la scena tripartita è flessibile a ogni soluzione, purché a scala «eroica».
Il Deutsches Theater, i Kammerspiele e il Großes Theater per gli spettacoli di massa (ma anche i
festival e gli allestimenti all’aperto) costituirono un sistema articolato di spazi e il fondamento
dell’impero teatrale di Reinhardt (fino al 1920).
Creò una compagnia di respiro internazionale, con un cartellone da teatro cosmopolita. Il Großes
Schauspielhaus fu tuttavia un’operazione difficile sul piano economico, artistico e sociale:
Reinhardt si rese conto che solo pochi attori erano all’altezza delle condizioni acustiche, pochissimi
drammi rispondevano a quella vastità di dimensioni, il pubblico non era l’auspicato pubblico
popolare. Il fallimento del Großes Schauspielhaus fu uno dei motivi che lo fecero dimettere dalla
direzione dei suoi teatri berlinesi nel 1920, e trasferirsi a Vienna dove nel 1924 aprì il Theater in der
Josefsstadt. Ma i contatti rimasero.
Max Reinhardt formò attori come Alexander Mossi, Emil Jannings. Mise in scena i classici: tra tutti
ricordiamo di Shakespeare Il sogno di una notte di mezza estate che allestì più volte dal 1905 al
Deutsches Theater, al giardino di Boboli a Firenze (1933), a Hollywood (1934), fino alla
trasposizione cinematografica con Olivia de Havilland (Titania) e un giovanissimo Mike Rooney
(Puck), nel 1935. E poi Schiller, Goethe, Molière. E i contemporanei, tra tutti Hugo von
Hofmannsthal. E le pantomime, come Sumurun (1910), per la quale usò l’hanamichi, o Il Miracolo
di Karl Vollmöller, per il quale trasformò il teatro in una immensa cattedrale gotica e arrivò a usare
200 musicisti, 500 coristi, 1000 comparse, piattaforme scorrevoli, elevatori elettrici, grandi fasci di
luce che si spostano dirigendo l’attenzione in uno spazio globale unitario in cui non c’è separazione
- ma neanche traccia - di sala e scena.
Un teatro, diceva Reinhardt, è vitale solo quando si può sostenere da sé. Schall und Rauch fu ospite
di teatri stranieri ancor prima di disporre di una propria sala a Berlino, che fu ristrutturata con i
guadagni di quelle tournées. I successi che gli allestimenti del Kleines e del Neues Theater
riscuotevano in tournée non portavano solo vantaggi economici ma consolidavano la fama di
Reinhardt a Berlino. E come un buon attore Reinhardt amministrava il proprio repertorio.
«Il teatro si compone di due elementi: attore e spettatore... Lo spettatore non è una base economica,
bensì la fondamentale base del teatro...». Individua il teatro del futuro in un teatro che non ha
bisogno di altro che dell’attore, senza macchinismi né costumi. In spazi a pianta centrale, in mezzo
agli spettatori, l’attore, costretto a rinunciare alla scenografia, sostenuto solo dalla forza della
parola, dovrà sviluppare e curare l’armonia della voce, l’espressione e il movimento. Creò spazi per
l’arte dell’attore e poi scuole per creare attori all’altezza di quegli spazi. A Berlino la prima scuola
di recitazione, nel 1905, annessa al Deutsches Theater, della durata di due anni: I. Educazione del
corpo e della voce. II. Studio dei personaggi e lavoro d’insieme. Vi si insegnava musica, danza,
movimenti ritmici, acrobatica e canto, assoluto controllo della parola e della voce. L’ultima sua
scuola di recitazione fu quella di Hollywood.
«Il più grande punto di forza dell’attore è la verità, la verità ultima, più intima, più bruciante.
Mostrate coraggiosamente a coloro che portano una maschera il vostro volto...
...Non urlate. Siate tranquilli e raccolti... Imparate a conoscervi. Cogliete impietosamente ogni
vostra bugia. Diventate essenziali. Non è il mondo dell’apparenza, quello in cui entrate oggi, è il
mondo dell’essenza».
Dopo la perdita dei teatri berlinesi, nel marzo 1933, per le leggi razziali hitleriane, collaborò in
modo fisso al Festival di Salisburgo, fece regie a Vienna, a Firenze, a Venezia, continuò le
iniziative in America.
Dal 1938 il ritorno in Austria gli fu definitivamente precluso, così concentrò il lavoro in America
intorno a tre fulcri: 1. il festival californiano per creare una nuova Salisburgo; 2. la scuola per
insegnare ai giovani americani recitazione voce danza scherma trucco scenografia regia
drammaturgia e amministrazione teatrale, e inoltre cinema e radio; 3. un teatro di repertorio con una
compagnia stabile da creare a New York sull’esempio europeo (e contro lo star system).
Morì a New York nel 1943.
Con lui lo spazio diventa uno spazio magico a cui è affidato il primo impatto sul pubblico. Teatro si
può fare ovunque, basta creare all’attore lo spazio giusto per agire in un contesto. E per creare lo
spazio, nota Cruciani (1992), a Reinhardt basta la magia della luce: elimina il quadro scenico,
articola lo spazio in zone differenziate, esalta l’arte dell’attore. Ma, conclude Cruciani, il suo teatro
non offre resistenze, o rischi, non crea durata. E accetta di essere un teatro per il pubblico di teatro.
«...Sono una vecchia guardia di confine, sull’incerta frontiera tra realtà e sogno. Tutta la mia vita
l’ho passata su questo stretto confine e ho contrabbandato merci di qua e di là. Il cammino era ora
in salita, ora in discesa e negli ultimi tempi è stato così ripido, da farmi perdere un poco il fiato»
(1930).
Max Reinhardt. I sogni del mago, a cura di Edda Fuhrich e Gisela Prossnitz. Introduzione di Giorgio
Strehler, Milano, Guerini e Associati, 1995
Fabrizio Cruciani, Lo spazio del teatro, Bari, Laterza, 1992
J.L. Styan, Max Reinhardt, Cambridge University Press 1982
M. Reinhardt, Der Bettler
M. Reinhardt, Faust, Salisburgo
M. Reinhardt, Grosses Schauspielhaus
M. Reinhardt, Il Miracolo
Reinhardt-Stern, scena girevole