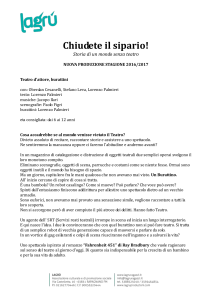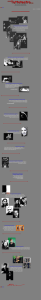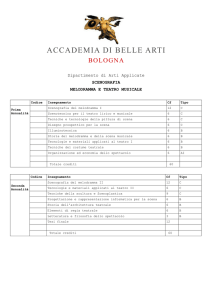PIER’ ALLI FULL IMMERSIOn
nELL’ALLEGORIA DEL TEATRO TOTALE
C
di Ivana D’Agostino
onvinto epigono delle innovative idee di spettacolo totalizzante pioneristicamente sostenute da
Richard Wagner, e di cui non casualmente si fecero promotori gli artisti della prima e della seconda
avanguardia, lo scenografo costumista regista Pier Luigi Pieralli, in arte Pier’ Alli, inizia la sua
ricerca teatrale alla fine degli anni ’60 del secolo scorso. La qualcosa anch’essa non dovrebbe
apparire incidentale se si considerano i sui studi di architettura di quegli anni, avvalorati dall’idea, appunto,
di teatro come full immersion assoluta: un’idea che, condivisa spesso dalle ricerche teatrali più innovative e
dai laboratori universitari dell’epoca, lui deduceva inoltre dal metodo Stanislavskij importato in Italia da
Tatiana Pavlova, di cui seguiva le lezioni, e che lo insegnava alla Scuola d’Arte drammatica del Piccolo
Teatro di Firenze – una propaggine toscana di quella di Milano -, che certamente si rivelò sostanziale per il
gruppo sperimentale Ouroboros costituito da Pier’Alli nel 1968.
Direi fondamentale, capace di segnare un filo rosso di coerente continuità da qui ai successivi traguardi della
sua ricerca verso la scrittura drammaturgica e l’uso del linguaggio cinematografico in scena, si pone l’opera
contemporanea Morte della geometria - in cui lui compare anche come mimo, oltre che esserne il regista e
l’ideatore dello spazio scenico -, scritta da Giuliano Scabia nel 1972, l’anno successivo alla morte dell’artista
Paolo Scheggi a cui è dedicata, e andata in scena a Firenze nel 1975.
Significativa si è detta in quegli anni la convergenza della ricerca sperimentale tra arti visive e scena, tant’è
che la modularità delle opere di Scheggi venne utilizzata proprio come astrazione di
uno spazio scenico, in Visita alla prova dell’isola purpurea, commedia di Michail
Bulgakov, rappresentata al Piccolo di Milano con la traduzione di Giuliano Scabia,
poeta, narratore e drammaturgo considerato un «viandante del tempo sospeso».
Considerazione rilevante, questa, se si valuta il portato innovativo di questo
genere di produzione letteraria, coerente a contigue ricerche musicali che
perseguono obiettivi simili, affini, gli uni e gli altri, agli esiti ambientali
perseguiti della coeva ricerca astratta, tra Spazialismo di Lucio Fontana,
concettualismo, arte Programmata e Cinetica, così da rendere sempre più labili
i confini tra le arti: l’uso della performance, del video, della parola come suono
puro, dello spazio inteso in senso assoluto, della luce come espressione
simbolica, delle potenzialità strutturali e dinamiche della linea che costruisce
nuove architetture spaziali, sono gli esiti di un nuovo linguaggio moderno, verso
cui Pier’ Alli naturalmente si orienta, tanto più, che lo spazio per lui, che è
anche architetto, rappresenta l’ insieme con tutto ciò che vi è in essere.
Ed è così, appunto, in Morte della geometria, dallo spazio ordinato, strutturato
seguendo direttrici spaziali longitudinali e trasversali.
I corpi stessi degli attori sono linee dinamiche che mutano continuamente la
percezione dell’insieme. Si è detto a questo proposito, si sono fatti confronti, con lo
spazio neoplastico di Mondrian, a cui andrebbero aggiunte le riflessioni sul
laboratorio teatrale del Bahuaus, sul costruttivismo russo, la conoscenza dei ballerini
sui trampoli di Schawinsky e della Danza delle verghe di Manda von Kreibig: tutte
esperienze fondamentali alla nascita di uno spettacolo di assoluto rigore formale
come questo, memore, a mio dire, anche della ricerca di François Morellet, artista
visivo francese di quegli anni tra i più importanti del dopoguerra, le linee delle cui
opere proiettate nello spazio per creare reticoli percettivi sempre nuovi per l’occhio
dello spettatore, presentano non poche assonanze con i gesti disegnati in forme
geometriche dai corpi degli attori e dei mimi di Morte della geometria.
Un modo raffinatissimo e concettuale, astratto dunque, di costruire lo spettacolo che
Pier’Alli utilizza ancora oggi, epurandolo, come è ovvio, degli aspetti più radicali
dell’avanguardia di quegli anni, accrescendolo, nel tempo, delle innovazioni del
linguaggio cinematografico e delle nuove tecnologie digitali, ma mai, allora come
oggi, interessato ad ottenere risultati visivi realistici, per perseguire sempre, e
comunque, l’idea di «immergere il palcoscenico in una Allegoria assoluta».
Allegoria assoluta che implica anche la ricerca sulla parola e la possibile integrazione
tra essa e la musica.
Gabriella Bartolomei, la «Grande Attrice» per definizione di Sylvano Bussotti,
interpreta Signorina Giulia di August Strindberg con la regia di Pier’ Alli nel 1972,
ed è presente, sempre come interprete di Giulia, nella riscrittura di Giulia round
Giulia fatta dal regista nel 1980 avvalendosi delle musiche di Sylvano Bussotti, che
le compose anche per la messa in scena di Winnie, dello Sguardo del 1978, con la
Bartolomei qui interprete della Winnie di Samuel Beckett.
La messa in scena, tratta dal paradossale, e bellissimo, Happy days beckettiano, a
lungo stroncato dalla critica – sebbene, poco dopo, nel 1982 lo rappresentasse anche
Giorgio Strehler – identifica in Pier’Alli, secondo Bussotti «il massimo creatore
teatrale, non ufficiale, del nostro bel paese», che proprio con questo spettacolo va
delineando alcuni elementi portanti della sua ricerca. Se, come è evidente,
quest’opera segna il superamento del divario tra opera teatrale e opera musicale,
determinando la premessa per sperimentazioni analoghe con Salvatore Sciarrino,
autore delle musiche di Vanitas e del Lohengrin tratto da Jules Laforgue collaborazioni che Pier’Alli inizia a breve, tra il 1981 e il 1983, alla Piccola Scala
di Milano -; c’è però anche da dire, che certe scelte sceniche surreali di Winnie,
dello Sguardo si ritrovano ancora in questi due allestimenti.
L’apparente incongruenza in Winnie della lente con cui il personaggio Sguardo, in
abiti magrittiani scruta la protagonista con cui condivide uno spazio assolutamente
kafkiano, proietta l’analogo paradosso sul pianoforte di Vanitas, la cui tastiera, lunga
quanto l’intero boccascena, inquadra proiezioni tridimensionali di vanità, appunto,
seicentesche - strumenti musicali, nature morte, reperti classici -, caduche come lo
sono le loro immagini riflesse. Anche in Lohengrin, dove ancora alla Bartolomei è
affidato di risolvere il personaggio di Elsa con vocalità e gestualità di perfetta
eleganza, l’atmosfera onirica che permea l’intera opera di Sciarrino, si risolve nel
grande letto, spazio del sogno, che si distende sull’intero golfo mistico, dal quale, di
volta in volta, uno alla volta, emergono i musicisti per suonare.
Sempre in quest’opera si enucleano modalità della ricerca che stabiliscono rimandi
ad altre soluzioni affini affrontate da Pier’Alli in altri allestimenti e spettacoli, in
quel continuum di richiami e citazioni, di cui si è detto, che dà coerenza alla sua
intera sperimentazione.
Lo spazio geometrico, assoluto, essenziale, calcolato su direttrici spaziali
ortogonali, originate dall’incipit di Morte della geometria, è presente anche in
Erwartung, una delle opere della trilogia, insieme a Pierrot Lunaire e Die Gluckliche
hand, di Arnold Schönberg, in scena alla Scala di Milano nel 1983.
Ma lo spazio può avere anche uno svolgimento circolare. «San le table [rotonda] le
drame de Giulia n’aurait sans doute pas existé car cette table implique des coutumes
et des comportements»: così il regista individua nella circolarità di un’azione che
ripercorre sé stessa - peraltro così suggerita anche dal titolo Giulia round Giulia - la
ritualità di comportamenti archetipici e sacrali eternamente ripetuti, che se trasgrediti,
non possono che portare all’annientamento e alla morte.
Sarà così anche per Carmen, la cui uccisione per gelosia, nell’allestimento per il
Teatro dell’Opera di Roma del 2006 avviene nello spazio circolare dell’Arena di
Siviglia. Circolare è tuttavia – e così torniamo a Lohengrin - anche lo spazio-tempo
dell’occhio in cui Elsa proietta le sue visioni, i suoi sogni premonitori su Lohengrin.
Dipinto con la luce in un’epoca in cui esisteva solo la luce elettrica, fu spettacolo di
grande successo; e profetico, si potrebbe dire, data la considerazione di Salvatore
Sciarrino come «il Debussy della nuova musica» per gli esiti di poi, quando,
meravigliosamente dipinto con la luce, che le nuove tecnologie consentivano di
realizzare anche in teatro – si pensi agli spettacoli di Lanterna Magica a Praga -,
Pier’ Alli, mise in scena nel 1996 il suo splendido Pellèas et Melisande all’Opera di
Lille, così adeguatamente simbolista che certamente sarebbe piaciuto allo stesso
Claude Debussy. Anche in Pellèas è circolare lo spazio del cerchio luminoso, uno
sguardo ideale, che muovendosi sulla scena rivela come una lente – il riferimento a
Winnie, dello sguardo credo sia pertinente – frammenti del castello di Arkël, della
torre di Melisande, visti come emblemi ectoplasmici assoluti di luoghi evocati dalla
musica. Maturata nell’ambito del melodramma, un nuovo percorso dato al suo lavoro
nel 1983 con L’elisir d’amore per La Fenice di Venezia, questa superba esperienza
teatrale si rese possibile per la messa in campo dell’innovativo supporto
cinematografico: un espediente narrativo aggiunto, che amplificando la percezione
spazio temporale dello spettacolo, proietta l’opera al di là di ogni apparenza sensibile.
Iniziata nel 1986 con l’opera incompiuta di Debussy, La chute de la maison Ucher,
ispirata ad Edgar Allan Poe la nuova avventura che amplifica le risorse dello spazio
teatrale col supporto linguistico cinematografico, essa trova grandiosa applicazione
in Der Ring des Nibelungen, la Tetralogia di Richard Wagner messa in scena al
Comunale di Bologna dal 1987 al 1992. Le visioni simboliche evocate dal mondo
wagneriano, - così pensate, del resto, pioneristicamente da Adolphe Appia –, rese
possibili per l’uso del linguaggio cinematografico che le dota di quella svaporante
e suggestiva indefinitezza suggerita dalla musica, raggiunge qui quella perfetta
fusione così auspicata dal teatro totale di Wagner, in quegli anni portata a così altri
livelli solo da Jovef Svoboda, e da Pier’ Alli.
Egli inventa, di grande bellezza per il suo Oro del Reno, un efficace sistema coassiale
che rende indissolubile il nesso tra la Rocca del Walhalla e la sonda che perfora gli
abissi scavati alacremente dai nani, in ciò prefigurando l’inevitabile crepuscolo degli
dei, determinato da quel mondo acquoreo, e sotterraneo.
Conclusa la sostanziale esperienza della Tetralogia con Die Walküre, Siegfried e Il
crepuscolo degli dei, con Tristan und Isolde, in scena al teatro dell’Opera nel 2006,
si prefigge traguardi ancor più avanzati per interpretare il teatro musicale – Pier’Alli
distingue tra melodramma e teatro musicale, facendo corrispondere a quest’ultimo
solo quei casi eccelsi di perfetta corrispondenza tra testo e musica, come nel caso di
Wagner, musicista e librettista insieme -, attraverso la più totale «globalizzazione
delle arti plastiche e cinetiche contemporanee sotto l’egida di una musica che agisce
nel senso totalmente dinamico della visione».
I sentimenti ineffabili di Tristano e Isotta, amanti immortali uniti oltre la morte,
trovano adeguata rispondenza nella musica di Wagner, e nella purezza astratta, e
illimitata, degli spazi-territori della mente ideati dallo scenografo-regista come
luoghi universali del sublime.
Anche la musica di Beethoven per il Fidelio, in scena nello stesso 2006 al Palau de
les Arts di Valencia, si presta per l’uso delle nuove tecnologie, trovando nella
digitalizzazione delle immagini computerizzate campi d’esplorazione sempre più
immaginifici. Ambienti fortemente evocativi, tra carcere piranesiano ampiamente
rivisitato e sale della tortura clustrofobiche, immettono Florestan nello spazio sempre
mutevole, e labirintico, della prigione del II atto.
D’altronde, già nel 2001, la tecnologia digitale applicata alla resa dello spazio visivo
dell’Aida per il Teatro Comunale di Bologna dava nuovo corso al linguaggio
sperimentale di Pier’Alli. Dilatati gli spazi dell’opera verdiana in magniloquenti
fughe prospettiche che inquadrano le scene in impaginati geometrici, essi, trovano
adeguato riscontro nel linearismo essenziale dei costumi, così da rendere visivamente
l’idea di un Egitto misterioso, e assolutamente spettacolare. Risultati simili di
spettacolarità virtuale si videro anche nell’apertura delle “acque elettroniche” del
Mar Rosso del Moїse et Pharaon allestito nel 2010 al Teatro dell’Opera di Roma.
L’amplificazione data alle potenzialità intrinseche delle immagini attraverso l’uso di
nuove tecnologie – problema costantemente centrale nello sviluppo innovativo delle
arti e della scena, tanto da coinvolgere nel tempo la fotografia, il cinema fino al
video e alle odierne elaborazioni grafiche al computer in 3D – non poteva non
intrigare un operatore culturale come il nostro, da sempre coinvolto in operazioni
visive estranee alla mimesi tout court. Tant’è, che a ciò coerente, egli amplifica
ulteriormente l’uso del digitale con proiezioni su tre schermi per l’opera
contemporanea Memoria perduta di Flavio Scogna, rappresentata a Roma nel 2002
al Teatro dell’Opera. Visivamente grandiosa, rappresenta in modo epico il problema
quanto mai attuale dell’ emigrazione, e per esteso, la storia universale dei soprusi,
dei diritti negati, delle fughe reiterate dagli uomini nei secoli alla ricerca della
speranza, del giusto anelito al diritto e alla libertà. Molto belli sono anche i costumi
che omaggiano Oscar Schlemmer inventati per i personaggi, che sulla scacchiera
del potere, giocano i destini dell’umanità.
Un respiro altrettanto epico sostanzia il suo progetto visivo per l’ Aleksandr
Nevskij, tratto dal film di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn con musiche di Sergei
Prokofiev, trascritte per lo spettacolo a Caracalla del 2012 in una suite in sette brani
musicali, che rievocano momenti salienti della pellicola eseguiti in concerto. Pier’
Alli, lui stesso dice, che fatta eccezione per la memorabile sequenza della “battaglia
sul lago ghiacciato”, pertinente al film, per il resto ha fatto prevalere sul tema svolto
dall’Aleksandr Nevskij – di fatto una committenza staliniana anti nazista
confezionata in maniera impeccabile dal grande regista russo – la creazione di «un
mondo di pure forme simboliche».
Ed è ancora nel 2012, sempre nel disinteresse per una resa realistica dello spettacolo,
che dia, invece, più incisivo senso alla valenza simbolica del sogno, che si muovono
la sua regia e la progettazione scenica realizzate per La metamorfosi da Franz Kafka,
su musiche di Silvia Colasanti per il Maggio Musicale fiorentino. Autore anche del
libretto dell’opera, con questo spostando ancora più oltre l’idea totalizzante dello
spettacolo da lui costantemente perseguita, le scelte fatte sul piano del segno scenico,
lo portano ad ideare una parete-diaframma che dialoga con la scrittura, raccontando
«gli umori interni della casa, le attrazioni e le repulse di entrambe le parti». É nello
spazio-stanza di Gregorio, luogo della sua metamorfosi, che viene usata
maggiormente l’elaborazione computerizzata delle immagini.
Con esse, si materializzano pensieri e allucinazioni del commesso viaggiatore in
forme indefinite e sospese, in prospettive deformate e spezzate, come nel teatro
LA VERITÁ DELL’APPAREnZA
IL TEATRO FUGGITIVO DI PIER’ALLI
T
Silvia, rimembri ancora? Giacomo Leopardi
espressionista, dove, nel II atto, contribuendo a creare una angosciante precarietà
percettiva, fluttuano anche i mobili della stanza di colui che, di fatto, si sta ormai
trasformando in uno scarafaggio. Bellissime le luci che dipingono la scena.
Differenti – dice Pier’ Alli - sono le scelte che qualificano l’allestimento scenico
delle opere di Giuseppe Verdi – sebbene in Aida abbiamo visto un grande impiego
d’immagini computerizzate – o di Vincenzo Bellini, la cui musica non trova
adeguato supporto nelle tecnologie digitali, adattissime, invece, come ampiamente
riscontrato, alle atmosfere e ai sentimenti suscitati dalla musica di Wagner, o di
Beethoven. Motivo questo per cui, dove necessiti, prevale l’uso della scena costruita,
e il pittore di scena riprende il suo posto di diritto.
Tra uragani e fatali premonizioni Il pirata, giovanile melodramma di Bellini in scena
al Teatro delle Muse nel 2007, prende corpo dando voce alle struggenti melodie del
musicista catanese. In un allestimento di grande compostezza formale, scandito da
spazi ritmici alla Appia, classici e resi solenni da busti marmorei su colonne
scanalate, inquadrato come un dipinto romantico, compare sullo sfondo l’immagine
del vascello di Gualtiero in preda alle tempeste. Al contrario opera della maturità, e
che conclude la vita di Bellini, I Puritani, allestiti nel 2008 per il Teatro Massimo
di Palermo, intrecciano la storia d’amore di Elvira ed Arturo allo scontro politico
tra i Puritani e gli Stuart, seguito alla decapitazione di re Carlo I. Per Pier’ Alli lo
scontro armato tra i due schieramenti determina il segno scenico forte con cui
marcare l’intera opera. Spade, dunque, in scala macroscopica sono usate per
delimitare la sala della rocca di Playmouth, comparendo anche nello spazio
visionario, e squadernato, della scena della pazzia, per essere riprese, inoltre, in
modo allusivo, nella verticalità dei fusti delle piante del giardino “nei pressi della
casa di Elvira”, nel bellissimo fondale, dipinto per il III atto come se fosse un arazzo
fiammingo. Bellissimo, e altrettanto dipinto in modo fortemente evocativo, è lo
spazio arboreo della battuta di caccia della Lucia di Lammermoor di Gaetano
Donizetti, alla Scala di Milano nel 1992; risultando, invece, lontanissimo nel
significato e nella forma, dal giardino malefico, come forgiato nei ferri battuti di.
Alessandro Mazzuccotelli, creato per il Mefistofele di Arrigo Boito del 1995 alla
Scala di Milano.
Anche nel 1991 al Teatro La Fenice per il Simon Boccanegra di Verdi, egli privilegia
la scenografia costruita, seppure da pochi essenziali elementi. D’impaginato ampio,
come mostrano anche i bozzetti, con essenziali segni architettonici conferisce
monumentalità solenne ai luoghi che fanno da sfondo alla storia di potere e intrighi,
che ruota attorno al primo Doge della Repubblica di Genova.
Per tirare le fila su questo, mi si conceda, eclettico artista, versatile, interessato a
forme di spettacolo complesse che coinvolgano l’intero sistema percettivo umano,
nel solco di un’idea innovativa della scena, della musica, della parola e del gesto, che
lo vedono così coerentemente impegnato dai suoi esordi, credo opportuno parlare
della Messa da Requiem di Verdi, completata nella sua forma definitiva nel 2008
per il Teatro Comunale di Bologna.
Progetto visivo di ampio respiro assolutamente astratto, che esclude totalmente la
presenza di personaggi, realizzato in toto col supporto di tecnologie digitali, concreta
appieno l’idea di Pier’ Alli di spazio visivo di pura luce. Esaltati nelle immagini i
valori simbolici assoluti provocati dall’intenso pathos della musica, le forme
trascendono la rappresentazione figurale, progredendo nel processo di “sottrazione
visiva” equivalente al viatico dell’anima, che ascende purificata nella luce alla
visione di Dio.
Ectoplasmiche, queste anime fluttuanti nella loro inconsistenza corporea, fatte di
puri tagli luminosi, sarebbero certamente piaciute a Luigi Veronesi – sicuramente
amato anche da Pier’ Alli, oltre che da me -, i cui splendidi film astratti colorava a
mano fotogramma per fotogramma, non disponendo, considerati i tempi, degli
odierni supporti computerizzati. Credo Pier’ Alli un degno erede di quella creativa
stagione astratta, imprescindibile per gli esiti di poi.
© The Scenographer 2013
di Dino Villatico
utta la realtà, secondo Platone, è un teatro di ombre: le figure che le proiettano ci sono precluse, non le vediamo. E se avesse dunque ragione Macbeth? o Miranda?
o Rosalinda? Chi, più di Shakespeare, ha oltrepassato la sottile linea di confine tra sogno e realtà, tra visione e cosa veduta, tra la disperazione di rimettere in
sesto il mondo fuori sesto (Amleto) e darvi perciò un senso e la sconfitta della Ragione che ha perso il bandolo della matassa? Pier’Alli naviga tra mondi
paralleli, insegue il fantasma del vero come Menelao e tutto l’esercito acheo inseguirono invano il fantasma di Elena. E dunque tante sofferenze sarebbero state
vane, tanti eccidi noi li avremmo compiuti e subiti per un fantasma? si domandano i marinai di Menelao giunti all’isola di Faro, dove si trova la vera Elena. Euripide, come
poi Shakespeare, Calderón, ci butta in faccia, nella sua bellissima Elena, una verità che ci rifiutiamo di vedere e di accettare: che il mondo è un caleidoscopio di ombre,
un gioco d’illusioni. Afrodite e Artemide si contendono il primato sulla vita, giocando a dadi con gli uomini, Fedra e Ippolito, vittime sacrificali, appagano il loro orgoglio
di dee detronizzate. Dioniso lo dice esplicitamente a Penteo: la vita non puoi afferrarla che morendo. E per che cos’altro combattete voi uomini, voi maschi, risponde Elena
al Coro, per che cos’altro vi ammazzate gli uni con gli altri, se non per un fantasma. Sofocle è più spietato ancora: Athena mostra a Ulisse la pazzia di Aiace che uccide
le pecore del gregge credendo di uccidere i greci che lo avevano isolato. “Vedi?” domanda Athena. “Vedo, e ho paura”, risponde Ulisse. Ha visto che gli uomini, nelle
mani degli dei, sono dadi di un gioco in cui a perdere è sempre l’uomo. Allora tanto vale abbandonare questo mondo di lotte fratricide e scappare nel mondo degli uccelli,
come suggerisce Aristofane nella commedia più bella che sia stata mai scritta. E Pier’Alli lo abbandona.
Per andare dove? E se fosse un non luogo il luogo della Verità e se la Verità si annidasse nella finzione del Teatro? Fuori di metafora e fuori di ogni luogo la Verità si fa
immagine di se stessa e la parola, invece di continuare a dire, e ripetere, concetti che non riguardano il Mondo, non intaccano la Realtà, si anamorfizza per alludere non
più al mondo in cui ci s’illude di stare, e nemmeno in quello del sogno, ma nel sogno stesso in cui immagine e parola si sognano. Chi sa, potrebbe alla fine uno accorgersi
di essere entrato nell’Iperuranio di Platone. L’Utopia – il non luogo dei desideri più che dei sogni – si rivelerebbe allora come un luogo assai simile a quello sognato dallo
Zarathustra di nietzsche, anch’egli- nietzsche, non Zarathustra - ossessionato, come Pier’Alli, dal Mito greco, dal mito tragico dei greci, in cui i figli uccidono i padri e
le madri uccidono i figli. Zaruthustra sogna la fine degli dei: e Pier’Alli l’ha configurata nel suo bellissimo Anello del Nibelungo.
Apriamo una parentesi. Tra i disastri attuati dal teatro naturalistico, che in Italia si
ostina a perdurare, c’è la falsa idea che tempi e luoghi dell’azione vadano rispettati,
così come li delimitano le didascalie del testo. Alla base di una simile, fuorviante idea
di teatro, sta la supposizione, errata, che i costumi teatrali di un’epoca siano
impunemente trasferibili anche in altre epoche.
Oggi, se la macchina del tempo ce lo consentisse, rideremmo alle rappresentazioni
wagneriane della Bayreuth tardottocentesca. Tanto per fare un esempio, se i costumi
alludono, rozzamente, a un Medio Evo immaginario o a un’ancora più immaginaria
età barbarica, Isolde però si trucca gli occhi come una dama di un buon salotto
borghese di allora e pur vestito di pelli d’orso Sigfrido sfoggia tagli di capelli
modernissimi o Hagen baffi guglielmini.
Dall’altra parte si dimentica che il teatro è sempre lo specchio dell’immaginazione
del pubblico, ma questa immaginazione la trasfigura in metafora e perfino critica
del tempo in cui lo spettatore ama immaginarsi. Eppure, probabilmente non
rideremmo assistendo alla rappresentazione dell’Edipo Re allestito dallo stesso
Sofocle, alla testa del Coro, né alla rappresentazione dell’Amleto allestito dallo stesso
Shakespeare o del Principe Costante allestito dallo stesso Calderón. Goethe mise in
scena a Weimar l’Amleto di Shakespeare, modificando la successione delle scene e
scrivendone di nuove lui sesso. Lo stesso faceva Lessing ad Amburgo. Alfieri recitò
lui stesso il suo Saul, e l’Antigone, per gli amici. In tutte queste rappresentazioni le
scene erano essenziali e i costumi i costumi del tempo. nel teatro elisabettiano e in
quello spagnolo addirittura non c’erano vere e proprie scene, come le intendiamo
oggi. Il teatro classico francese, che divenne poi il modello di tutto il teatro europeo,
ignorava la fedeltà storica di scene e costumi. Questa venne introdotta, appunto, dal
naturalismo. Ciò significa che il teatro si affidava soprattutto all’immaginazione e
all’intelligenza del pubblico. Qualche volta il testo stesso ricordava al pubblico il
rispecchiamento della vita che il teatro mette in scene: per esempio, Shakespeare
affida alla bocca di Macbeth l’illusione tragica della vita che assomiglia all’illusione
del teatro. Corneille intitola addirittura una sua bellissima commedia L’illusion
comique. E Calderón scrive El gran teatro del mundo, in cui gli attori rappresentano
le figure della vita e Dio è un capocomico, e il buffone protesta perché gli viene
assegnato il ruolo del povero. Alla fine di una commedia, da Plauto a Goldoni,
l’attore principale si rivolge al pubblico e chiede clemenza per l’inadeguatezza della
messinscena. Insomma il pubblico è continuamente sollecitato a considerare ciò che
vede una pura finzione, una metafora della vita che vive nella realtà. Ecco perché
Aristotele può teorizzare l’effetto della catarsi procurata dallo spettacolo, perché
l’orrore e l’angoscia della rappresentazione – o la sua ridicola parodia, come in
Aristofane (ma la sezione della Poetica dedicata alla commedia è andata perduta) –
scuote l’animo dello spettatore, lo muove a pietà, o al riso, e si corregge dei vizi e
delle storture di se stesso che vede rappresentati sulla scena. Se a ciò si aggiunge che
tanto ad Atene che a Londra i ruoli femminili erano coperti da attori maschi, la
distanza tra realtà e spettacolo è ulteriormente stigmatizzata. “Siamo il sogno di
un’ombra” scrive Pindaro. Calderón scrive La vida es sueño e Shakespeare fa dire
a Miranda nella Tempesta che tutti noi viviamo come in sogno la nostra vita. Ecco,
semplificando, e molto, potremmo però dire che questo sogno, questa finzione, è il
teatro di Pier’Alli.
Certo, un teatro simile richiede uno spettatore colto, che percepisca le allusioni, le
citazioni, le metafore, i segni – e già! per i greci, gli elisabettiani, gli spagnoli, era
ovvio, scontato, che le cose dette e rappresentate a teatro fossero segni di
qualcos’altro. Per una parte del pubblico di oggi no (e non parliamo dei
sovrintendenti o amministratori pubblici). Ma dove starebbe il male o la colpa? In
un’epoca di populismo dilagante, anzi, se mai, questo è un merito. Schumann scrive
in un suo straordinario aforisma che il filisteo vuole capire subito ciò che all’artista
è costato magari mesi o anni di lavoro. Sarebbe ora che il pubblico di oggi tornasse
a pensare, oltre che a emozionarsi, quando assiste a uno spettacolo teatrale o vede
un film. Il cinema è del resto un’altra della grandi passioni di Pier’Alli, proprio
perché lì l’immagine si fa insieme racconto e pensiero. Si potrebbe obiettare che
molti registi di oggi esagerano nell’attualizzare la rappresentazione. Intanto il
termine attualizzare è sbagliato, semplicemente i registi più intelligenti (dei cretini
non è il caso di parlare) leggono un classico come se fosse scritto nel momento in
cui lo leggono. E non facciamo tutti così quando leggiamo Dante o Petrarca? perché
per il teatro non si dovrebbe fare? In ogni caso all’obiezione si potrebbe obiettare che
se molti registi esagerano nell’attualizzare, quelli che non lo fanno,
autoproclamandosi “tradizionali”, esagerano il più delle volte nella banalità. Ma non
sta qui il punto. Pier’Alli, come tutti i veri uomini di teatro, sa bene che il testo è solo
un appunto per la rappresentazione, che è la sola e vera realizzazione di un testo
teatrale, così come l’esecuzione sonora è la sola e vera realizzazione di una partitura
musicale: anche chi legge un testo teatrale o una partitura con la propria
immaginazione s’immagina l’allestimento e l’esecuzione sonora. Se non lo fa non
ha capito che siano il teatro e la musica.
Ma, tornando al teatro di Pier’Alli, quali sensi comunicano le sue immagini teatrali?
nell’Anello del Nibelungo, soprattutto nel Prologo, L’Oro del Reno, predominano le
curve, i cerchi, gli anelli. Del resto la Tetralogia wagneriana non s’intitola, appunto,
L’anello del Nibelungo? Ma le stesse curve le ritroviamo nel Tristano. Il segno di un
mondo che si chiude, che ritorna su stesso. E destinato all’estinzione, al ritorno alla
pura figura originaria dell’origine e della perfezione, il cerchio, appunto.
Ma nel Principe costante domina, invece, la linea retta, i limiti di una bara, la vita e
la morte coincidono, nella poesia barocca spagnola la culla, rovesciata, diventa figura
della tomba. Dalla culla alla tomba è il titolo dell’ultimo, sconvolgente, poema
sinfonico di Liszt. Sulla tomba sono sparsi i petali delle rose, come in cielo le stelle
svaniscono, in terra i fiori appassiscono, dicono i due innamorati: anche l’amore?
Certo, anche l’amore.
E il sogno si confonde con la vita dirà un altro personaggio di Calderón.
La linea retta ritorna nel Fidelio. Ma qui sono le sbarre, le palizzate di un carcere.
L’opera beethoveniana, oltre che l’anelito insopprimibile alla libertà, esprime per
contrasto anche tutto l’orrore della costrizione, della reclusione, una rivolta violenta,
irrefrenabile per l’istituzione del carcere. E il terrore del dominio militare. Dentro un
cerchio è poi alluso il mondo, vivissimo, tutt’altro che incipriato, del Settecento, il
secolo forse più grande della Storia d’Europa. E non solo perché è il secolo di
Mozart. Ma anche. E le Nozze di Figaro, come un quadro di Fragonard, un viaggio
impossibile a Citera, si racchiudono in quel cerchio di fantasia leggera che non si cela
i dolori della vita, ma sembra schiacciata, come la memoria di Baudelaire - J’ai plus
de souvenirs que si j’avais mille ans - e come per Baudelaire, anche per Pier’Alli
“tutto diventa allegoria”. L’incubo, allora, veste i panni di un sogno ricorrente, in cui
anche chi ci è familiare diventa un aggressore, un mostro: ogni perseguitato è un
mostro, un alieno, per i suoi persecutori, uno che fa paura. Come nella Metamorfosi,
soggetto tratto dal famoso racconto di Kafka, testo teatrale dello stesso Pier’Alli,
musica di Silvia Colasanti. L’orrore prende la forma di persone bloccate nella
disperazione quotidiana, davanti all’irruzione dell’alieno, del diverso, un tempo
figlio e fratello. La scena disegna immagini e figure che sembrano schizzate con
l’inchiostro di china.
Gli esempi potrebbero moltiplicarsi: Winnie dello sguardo, Giulia round Giulia.”La
tristesse de tout cela”, lamenta Arkel, costatando la morte di Mélisande. Così passano
tutte le cose. Anche le immagini teatrali. Soprattutto le immagini teatrali, che
focalizzano per un istante il passare dell’istante, e lo manifestano già perduto
nell’atto di rappresentarlo. Allegoria di che cosa? Del passare, del trasformarsi, del
non essere più della vita nel momento in cui la si ricorda o – vana illusione di
perpetuarla – in cui la si rappresenta. Il vero sta nella superficie, scrive nietzsche.
Pier’Alli lo prende alla lettera, ma spostando di poco il fuoco del concetto: il vero
sta nell’immagine, anzi no, non nell’immagine, ma nell’apparire e svanire
dell’immagine. Le proiezioni, i film che integrano sempre più spesso le
rappresentazioni teatrali, ne costituiscono forse l’allegoria suprema, in quanto
rappresentano, senza enigmi, senza illusioni, l’illusione stesso dell’apparire, del
passare, e dello svanire.
Il tempo del ricordo, come sapeva bene Leopardi, è sempre un tempo imperfetto.
© The Scenographer 2013
non perdere l’edizione invernale di THE SCENOGRAPHER.
HENNING BROCKHAUS
Un numero dedicato al regista scenografo tedesco
Testi di Guido Barbieri e di Ivana D’Agostino
Prenotala subito a [email protected]
Visita il sito www.thescenographer.org