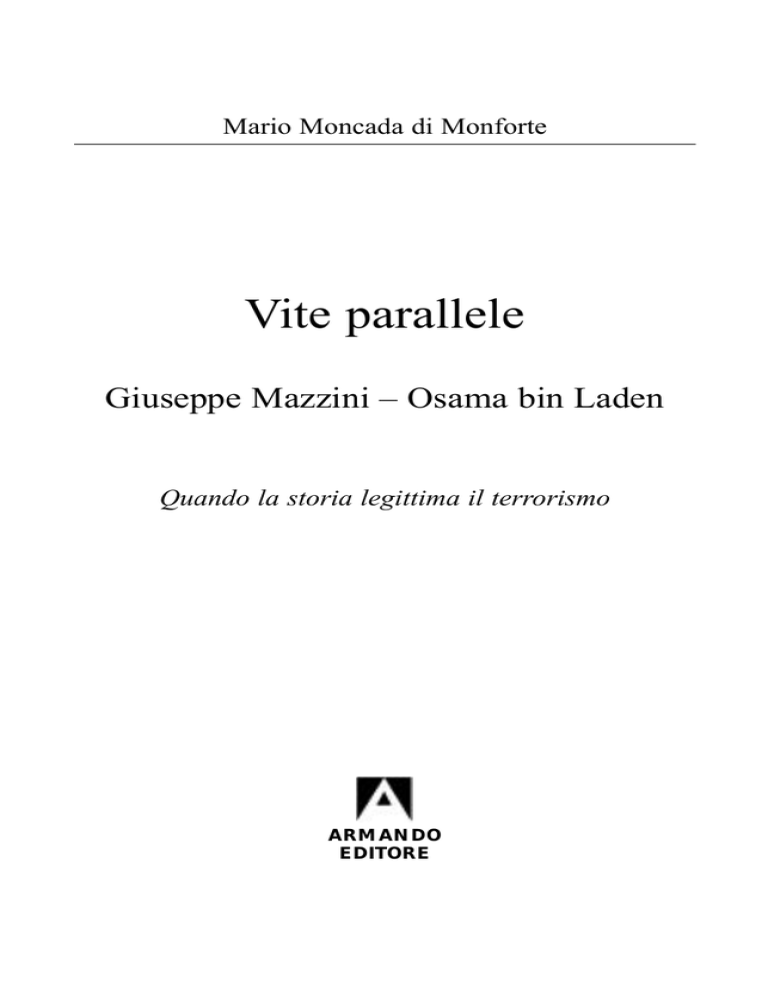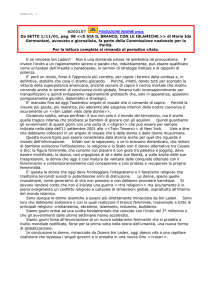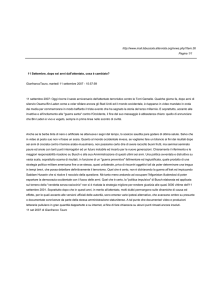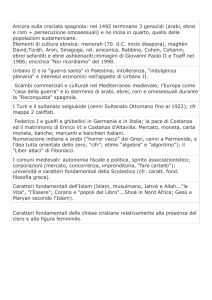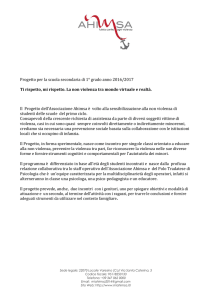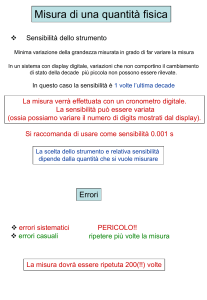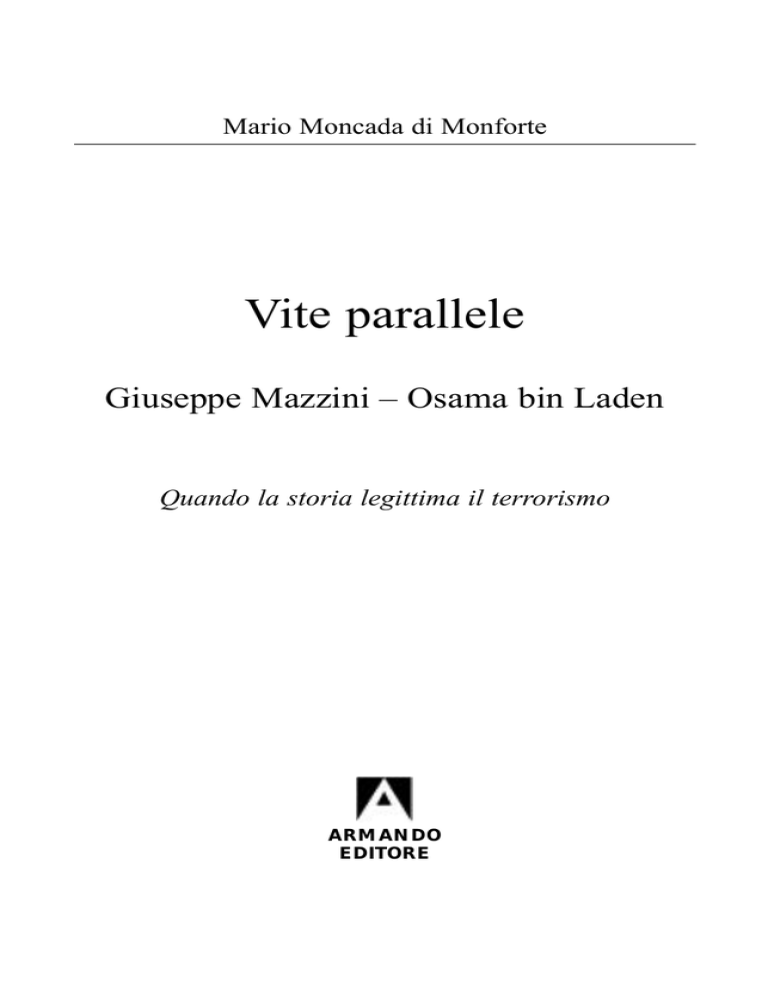
Mario Moncada di Monforte
Vite parallele
Giuseppe Mazzini – Osama bin Laden
Quando la storia legittima il terrorismo
ARMANDO
EDITORE
Sommario
Introduzione
Capitolo primo: Due contesti internazionali
1. I contesti internazionali
2. 1814-1815: il Congresso di Vienna e le sue conseguenze
3. 1919-1920: la pace di Versailles e le sue conseguenze
4. Considerazioni conclusive
Capitolo secondo: Due protagonisti
1. I protagonisti
2. La giovinezza di Giuseppe Mazzini
3. La giovinezza di Osama bin Laden
4. Le teorie estremistiche del loro tempo: anarchismo, wahhabismo
5. Considerazioni conclusive
Capitolo terzo: Due società segrete (ma non troppo)
1. Giuseppe Mazzini: la Giovine Italia e la Giovine Europa
2. Osama bin Laden: al Qaeda (la Base)
3. Considerazioni conclusive
Capitolo quarto: Considerazioni finali
1. Argomenti controversi
2. Uno sguardo avanti
3. La prospettiva probabile
Introduzione
Il titolo provocatorio di questo saggio è suggerito dalla constatazione della pervicacia con la quale i neoconservatori americani si rifiutano di ammettere il danno arrecato al dialogo mondiale con la guerra all’Iraq ed è sostenuto dalla sorpresa per l’impudenza con la quale
Robert Kagan ritenga di poter ancora sostenere “Il diritto di fare la
guerra” (Mondatori, 2004) per imporre un “ordine mondiale”.
Anche se la titolazione del saggio di Kagan è probabilmente un’idea editoriale, il lavoro dimostra come la rozza lettura della storia, che
è prevalente nell’opinione pubblica statunitense, faccia ignorare la
complessa drammaticità della situazione planetaria, piena di una violenza sfuggita ad ogni credibile controllo. Questa inadeguatezza culturale consente di affrontare i non argomenti di Kagan e dei teo-conservatori ignorandoli. Quando si leggono teorie così irragionevoli, nasce
la domanda se gli autori siano effettivamente rozzi culturalmente o se,
fatto frequente negli Stati Uniti, siano pagati per sostenere tesi utili agli
interessi delle multinazionali.
La “pretesa” europea del rispetto di un ordine legale internazionale
è, per questi signori, la causa prima della violenza dominante perché
farebbe emergere la non compattezza del fronte occidentale. Ciò continua ad essere affermato, anche se molti studiosi, fra i quali qualche
raro americano, cercano invece di portare continui contributi per chiarire le ragioni di fondo, economiche e politiche, che animano la violenza che ci aggredisce.
In quest’ampio dibattito, com’è naturale, il background culturale, la
condizione psico-emotiva e gli interessi socio-politico-economici di
ognuno, incidono sulle analisi e sulle scelte di campo, anche nella più
assoluta buona fede intellettuale.
7
Una conferma di questa situazione può avere chi, con esperienza di
navigazione Internet, voglia curiosare alla voce Osama bin Laden che
è uno degli attori di questo confuso ed incerto momento mondiale.
Troverebbe oltre 450.000 siti nei quali, in tutte le lingue, sono espresse le più varie opinioni, anche colorite o esasperate, a favore o contro
questo protagonista del nostro tempo.
Certo, considerata la violenza delle iniziative che gli sono attribuite, non possiamo sorprenderci per quest’ampia diversità di opinioni.
Ciò che non può essere condivisa è la diffusa, decisa faziosità, a favore o contro, espressa da molti che dimostrano con evidenza o di non
conoscere la storia dei tempi trascorsi o di non tener in alcun conto la
complessità dell’attuale realtà del mondo.
È evidente, infatti, come i giudizi a favore di bin Laden siano suggeriti spesso dall’odio verso la pre-potenza della civiltà occidentale ed
è evidente anche quanto le condanne morali siano ispirate da interessi
in pericolo o dalla paura di un’incontrollabile aggressione integralista
da parte di un Islam ritenuto sempre e comunque fanatico.
Accade così che la paura per la diffusa violenza e la condanna morale degli attentati islamici alla sicurezza occidentale vorrebbero che
fosse ignorata ogni analisi storica: si sostiene che si rischia di elaborare un giustificazionismo che non può essere consentito. È possibile; ma
solo se i fatti sono stravolti al fine di sostenere i propri convincimenti
pro o contro: tentare di capire non vuol dire giustificare. Se non cerchiamo di comprendere le ragioni dell’odio verso l’Occidente non possiamo sperare che nel mondo si avvii un dialogo meno violento.
Il problema non è giustificare o condannare i comportamenti e le
iniziative di bin Laden e degli islamici: l’obiettivo deve essere rendersi conto delle ragioni, fondate o meno, per le quali agiscono.
Ciò, comunque, ponendo una premessa decisa che non consente arbitrarie interpretazioni di questo saggio.
È ferma convinzione di chi scrive che la violenza sia sempre da
condannare da qualunque parte provenga e in qualsiasi modo sia
espressa. Analizzare la violenza e i modi nei quali è manifestata non
vuol dire condividerla o giustificarla: purtroppo la violenza - fisica o
morale, manifesta o ipocritamente coperta - occupa la parte più grande della storia degli uomini e non può essere ignorata. La condanna
umana della violenza è assoluta e non consente né una scala dei tempi
8
né una scala di valori a sostegno o meno. Certamente, però, c’è una posizione incontestabilmente immorale: è quella di chi condanna soltanto la violenza che colpisce noi occidentali.
Posto questo punto fermo, è necessario che gli avvenimenti siano
osservati nel loro schematico svolgersi e nel quadro della situazione
storica dalla quale sono determinati: il tentativo, quando è fatto in questi limiti, cerca solo di comprendere il perché di quanto accade. Gli
eventi hanno una tale dimensione, non solo in termini di spazio e di
tempo ma anche di conseguenze possibili, da suggerire di leggerli dentro lo spaccato storico più ampio: chi volesse contestarne l’interpretazione, potrà farlo solo con una credibile, alternativa analisi storica e
non con emotive accuse morali.
Per queste ragioni, nelle pagine che seguono, le vicende di Osama
bin Laden sono riviste nell’ambito della storia dei paesi arabi del secolo ventesimo confrontata con la storia europea del diciannovesimo
secolo sui cui avvenimenti il giudizio storico odierno, ampiamente accettato, ha superato le considerazioni morali, positive o negative, del
tempo nel quale quegli eventi si svolsero. In questo parallelo storico,
l’avventura rivoluzionaria di Giuseppe Mazzini è assunta come riferimento per comprendere se sia possibile usare un metro uguale per valutare le iniziative di Osama bin Laden.
Fatto il confronto fra le vite di questi due protagonisti e tentando di
non lasciarsi coinvolgere né dall’odio verso l’Occidente né dalla paura verso l’Islam, è stato ritenuto utile aggiungere un’analisi interpretativa di alcune parole il cui discutibile significato consente di sostenere
un punto di vista o un altro dell’attuale realtà planetaria. Dalle definizioni date si può cogliere il punto di vista assunto da queste pagine che
diventa il punto di partenza per immaginare, con concretezza e con un
distacco senza ipocrisie e senza mistificazioni, quella che è ritenuta essere una prospettiva probabile del marasma che ci aggredisce.
Per realizzare un lavoro immediatamente leggibile, è stato preferito un conciso ricordo dei fatti storici e un sintetico recupero dei problemi economici e demografici del nostro tempo. Specifiche, più dettagliate analisi sono facilmente accessibili in molte opere di storia dei
periodi considerati e in molti ben noti saggi. L’obiettivo, ovviamente,
non è quello di ripresentarne in sintesi i risaputi argomenti ma di recuperare le plausibili ragioni che supportano la tesi di questo lavoro.
9
10
Capitolo primo
Due contesti internazionali
1. I contesti internazionali
Per comprendere i comportamenti umani, è risaputo quanto sia necessario guardare alle situazioni nelle quali ognuno è stato costretto o
è costretto ad agire.
Pertanto, nell’odierna difficile situazione planetaria, per tentare di
renderci conto delle motivazioni che alimentano gli esasperati comportamenti di una parte dei musulmani, non è sufficiente chiamarne in
causa soltanto il rigido fondamentalismo islamico. Cioè, non può essere accettata la pretesa di chi vorrebbe che fosse evitata qualsiasi analisi storica che farebbe correre il rischio di proporre un qualche giustificazionismo.
Poiché gli avvenimenti degli ultimi cinquant’anni hanno mischiato le carte, un’analisi storica riferita al mondo arabo non può ignorare
i precedenti più lontani. Non può che partire dal fatto che l’attuale condizione politico-territoriale di quest’area del mondo è ancora la pesante conseguenza delle decisioni che, dopo il crollo dell’impero ottomano, furono prese dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale.
Per capire gli attuali comportamenti delle popolazioni arabe, è necessario rivedere gli effetti degli accordi di pace imposti alla Turchia nel
1919-1920 alla fine della guerra.
L’analisi delle conseguenze di quegli accordi, scontate le ovvie differenze di cultura e di tempo, mostrerà quanta sorprendente analogia ci
sia con gli avvenimenti europei che seguirono il Congresso di Vienna
che, nel 1814-15, aveva chiuso l’avventura napoleonica con la Restaurazione dei governi autoritari d’Europa.
11
Pur nella consapevolezza di quanto possano essere fuorvianti le letture storiografiche comparative, in queste pagine saranno analizzate in
successione le situazioni politiche internazionali create dai due trattati
di pace, senza la pretesa di poter suggerire parametri d’interpretazione
assoluti. Si sa, infatti, quanto incidano sugli eventi della storia le diversità caratteriali dei protagonisti, le differenze ambientali, le diverse
rilevanze degli eventi casuali e dei comportamenti imposti da situazioni necessitate. Con questa consapevolezza, quindi, e con relativa prudenza, saranno esaminate le conseguenze politico-sociali determinate
nei vari paesi dalle scelte che sancirono la fine di quelle grandi guerre.
Il risaputo svolgersi degli avvenimenti europei del diciannovesimo
secolo ne autorizza un ricordo a volo d’uccello. Questo ricordo, in ogni
modo, è necessario perché fa rilevare quanto siano simili i meno noti
eventi del mondo arabo nel ventesimo secolo. Consente soprattutto di
rilevare che i due periodi storici sono stati animati dallo stesso spirito
nazionalistico dei popoli.
2. 1814-1815: il Congresso di Vienna e le sue conseguenze
Negli anni fra il 1796 e il 1814, le armate napoleoniche avevano attraversato l’Europa sconvolgendone il tessuto economico e sociale ma
suscitando ovunque attese che guardavano ai principi universali posti
dalla rivoluzione francese.
Dopo la sconfitta di Napoleone, il Congresso di Vienna ebbe l’obiettivo di rimettere ordine. A Vienna non doveva essere ratificata la
pace perché questa era stata già definita a Parigi il 30 maggio 1814. Il
Congresso fu un’assemblea delle quattro potenze – Austria, Prussia,
Inghilterra e Russia – che, avendo vinto la guerra, volevano dare all’Europa un assetto politico e sociale che fosse riconosciuto e rispettato da tutti gli stati e da tutti i popoli. A questo direttorio, successivamente, fu ammessa anche la Francia.
I problemi da affrontare erano numerosi: i rapporti delle potenze
vincitrici fra di loro e con la Francia, la fondatezza o meno del principio di nazionalità di fronte al principio di legittimità dinastica, l’indipendenza o l’autonomia della Polonia di fronte all’espansionismo dello zar Alessandro, il destino della Sassonia e degli altri principati tede12
schi davanti alle pretese della Prussia, l’ipotesi di una confederazione
tedesca, il riassetto dell’Italia secondo il principio di legittimità o meno, i rapporti fra la Spagna e la Francia nel quadro del patto della famiglia Borbone. E, inoltre, la situazione dei piccoli stati europei ricostituiti, l’ampliamento della Svezia, il controllo del mar Baltico e il
controllo delle vie di comunicazione mondiali che l’Inghilterra tendeva a monopolizzare assumendo il controllo politico dei punti strategici del globo (Gibilterra, le principali isole del Mediterraneo, Capo di
Buona Speranza, ecc.).
Le grandi capacità diplomatiche dei protagonisti, ma soprattutto
dell’inglese Castlereagh e del francese Talleyrand, riuscirono a trovare una risposta ad ogni problema pur tenendo conto dell’orientamento
autoritario del cancelliere austriaco Metternich, fedele al principio di
legittimità del suo imperatore. È diffusamente accettato fra gli storici
che l’opera del Congresso di Vienna fu grande: non solo per l’assetto
territoriale europeo, che diventò impossibile violare per l’autorità delle potenze firmatarie, ma anche perché furono poste le basi del diritto
pubblico internazionale.
Meno apprezzate furono le scelte politiche e quelle etico-sociali: i
patrioti italiani, tedeschi e polacchi non accettarono che ne fossero
ignorate le attese nazionalistiche; i liberali francesi, austriaci, inglesi e
di tutt’Europa non condivisero che fossero stati trascurati quegli ideali che illuminismo e rivoluzione francese avevano affermato come inalienabili diritti umani.
Il malcontento dei popoli europei non fu tenuto a bada per lungo
tempo: la Restaurazione del 1814 sarà contestata dai moti nazionali e
liberali europei del 1820-1821 e del 1830-1831 e sarà travolta dalle rivoluzioni del 1848 che, con intensità dirompente e simultanea, assumeranno dimensioni internazionali. In questo quadro politico-sociale,
il clima culturale del Romanticismo diffondeva e sosteneva l’idea nazione che sarà potente stimolo all’unità d’azione dei popoli europei.
***
Fra le decisioni prese dalle potenze europee, probabilmente le conseguenze più drammatiche si ebbero in Polonia dove Russia, Prussia e
Austria fecero di tutto per mortificare le attese nazionalistiche per un
13
tempo lunghissimo: dovette trascorrere un secolo, dal Congresso di
Vienna del 1815 alla pace di Versailles del 1919, prima che la nazione
polacca riuscisse a realizzare una Polonia unita.
Cuscinetto fra tre grandi paesi, le sorti della Polonia erano state
sempre condizionate dalle pretese di quei paesi: fra alterne vicende, le
speranze dei nazionalisti polacchi erano risorte con l’arrivo di Napoleone che aveva ricostituito il ducato di Varsavia con una parte delle
province polacche e con una costituzione che dichiarava tutti i cittadini uguali davanti alle leggi.
La difesa eroica dell’esercito polacco, che aveva ricacciato gli austriaci ed era riuscito ad occupare Cracovia, era stata premiata da Napoleone che aveva ingrandito il ducato. Le speranze, quindi, erano cresciute quando l’imperatore francese nel 1812 aveva deciso di attaccare la Russia che manteneva il dominio su vasti territori polacchi.
La sconfitta di Napoleone e il Congresso di Vienna decisero le sorti della Polonia: il paese fu smembrato e diviso fra la Russia, la Prussia e l’Austria, senza alcun rispetto della sua realtà religioso-culturale.
Simbolicamente rimasero autonomi il “Regno di Polonia”, comprendente una parte del vecchio ducato di Varsavia, e la Città libera di Cracovia. In effetti, il primo era un protettorato della Russia mentre Cracovia nel 1848 fu annessa definitivamente ai territori sotto il controllo
dell’Austria. I nazionalisti polacchi non accettarono la situazione e,
pur divisi fra loro in liberali e conservatori, mantennero agitato il paese per quasi un secolo con insurrezioni, guerriglia e le iniziative di
eserciti molto male equipaggiati. Il non intervento della Francia e dell’Inghilterra, tanto sperato dai patrioti polacchi, favorì il successo delle potenze occupanti che soffocarono nel sangue ogni tentativo insurrezionale (1830, 1845, 1848, 1863, 1870, 1890): i martiri impiccati, fucilati e imprigionati furono numerosi.
La volontà di soffocare le speranze indipentiste polacche spinse le
potenze occupanti (una protestante e un’altra ortodossa) a contrastare
l’azione del clero cattolico e a tentare addirittura di cancellare la lingua polacca imponendo nelle scuole il tedesco da una parte e il russo
dall’altra. Le polizie delle potenze occupanti maltrattavano i patrioti
che insorgevano, considerandoli ribelli, banditi, terroristi: molti scelsero la via dell’emigrazione e, assieme a quanti erano stati esiliati, si
raccolsero soprattutto in Francia dove continuarono a svolgere un’atti14
vità politica di propaganda per mantenere viva fra i rifugiati la speranza di una Polonia libera.
Fra mille problemi, fu necessario attendere la pace di Versailles: era
il 1919. Un secolo era trascorso fra rivolte, congiure, attentati e repressioni violente prima che fosse riconosciuto il diritto dei Polacchi di veder rispettata la loro lingua e la loro religione in uno Stato indipendente.
***
Relativamente più fortunata fu l’Italia: la presenza di uno Stato italiano – il regno di Piemonte - che in qualche modo partecipava al concerto europeo, anche se in secondo piano, favorì un movimento politico
che, pian piano, raccolse attorno ad esso le speranze degli indipendentisti e dei liberali italiani. Il processo fu lungo perché la resistenza non solo dell’Austria ma anche della Francia, che non volevano perdere le loro aree di influenza sui territori italiani, fu tenace e spesso spietata.
L’ultimo colpo di coda della feroce volontà austriaca di non lasciare
l’Italia si ebbe il 24 ottobre 1917: a Caporetto, l’esercito italiano fu messo in rotta non dalla crisi morale dei soldati, come fu sostenuto dai disfattisti del tempo, ma dal bombardamento con gas tossici usato dalle armate austriache e tedesche. La sorpresa per la nuova arma così micidiale e i morti a migliaia travolsero la resistenza italiana. Un anno dopo, il
24 ottobre 1918 gli austriaci furono messi in rotta a Vittorio Veneto: l’indipendenza dell’intera nazione italiana era stata completata.
Non era stato un percorso agevole e il secolo trascorso dal Congresso di Vienna deve essere diviso in due tempi: quarant’anni di lotta
politico-insurrezionale e sessant’anni di guerre militari del piccolo e
improvvisato Stato italiano contro l’ancora solido impero asburgico.
A Vienna, nel 1815, era stato deciso l’ampliamento della presenza
austriaca che, estesa anche alle Venezie, aveva portato alla costituzione del regno lombardo-veneto mentre il regno di Sardegna aveva annesso la Liguria e Genova. I piccoli ducati centro-settentrionali, nominalmente indipendenti, andavano sotto l’influenza austriaca mentre lo
Stato pontificio rimaneva sotto un larvato protettorato francese. Il ricostituito regno di Napoli e Sicilia tornava ai Borbone.
Il Risorgimento italiano fu, per i primi quarant’anni, una lotta politica clandestina contro l’assetto restauratore del Congresso non solo in
15
termini dinastici ma soprattutto in termini liberali: l’annullamento e la
revoca nel Lombardo-Veneto del Codice napoleonico e delle istituzioni
del Regno italico assieme all’arroganza dell’esercito e della burocrazia
asburgica trovarono un catalizzatore del malcontento popolare nella
Carboneria che, con motivazioni diverse, operava in tutta l’Italia.
Il programma della Carboneria non era estremistico ma, soprattutto nelle regioni del centro-nord, assunse uno spiccato carattere patriottico antiaustriaco alimentando la più esasperata repressione da parte
della polizia austriaca. Con ancora una vaga idea d’unità nazionale, i
moti insurrezionali (1820, 1821, 1830, 1831, 1834-1844, 1848, 1849)
infiammarono tutti gli Stati nella speranza di ottenere norme costituzionali più liberali: la repressione dei “ribelli terroristi” (come sosteneva la polizia austriaca) fu cruenta e i morti furono migliaia. Molti i
nomi che l’Italia ha venerato come eroi.
Alla fine del 1849, l’Austria era riuscita a soffocare ovunque ogni attesa sia liberale sia indipendentista ma manteneva il controllo ormai soltanto con la più violenta repressione armata: massacri, incendi, fucilazioni, crudeltà estreme e arbitri giudiziari. Solo dopo seicento morti, il
generale austriaco Haynau riusciva ad avere ragione dell’indomita resistenza casa per casa della rivolta bresciana che aveva resistito per dieci
giorni (È sorprendente oggi, 11 novembre 2004, apprendere dal Capo di
Stato maggiore statunitense che a Falluja, in Iraq, la resistenza casa per
casa dei combattenti iracheni è costata, finora, 600 vittime. Il casuale
uguale numero di morti di Brescia del 1849 fa porre una domanda: perché i bresciani che, dopo la sconfitta di Carlo Alberto, si opposero all’invasore austriaco sono ricordati come martiri ed eroi e gli iracheni che
si oppongono all’invasore americano sarebbero solo “terroristi”?).
Uguale violenza fu spesa per soffocare le rivolte nel resto d’Italia.
Ma la brutale reazione austriaca aveva i giorni contati: la coincidenza
dell’azione spirituale, cospiratrice e insurrezionale di Giuseppe Mazzini con l’estro militare di Giuseppe Garibaldi e con il genio diplomatico di Cavour consentì il raggiungimento dell’unità d’Italia che, dopo
tre guerre d’indipendenza contro l’Austria, fu completata nel 1918.
In pratica, anche per l’Italia fu necessario un secolo per smontare
quanto era stato disposto dal Congresso di Vienna.
***
16
© ARMANDO EDITORE. La fotocopia non autorizzata è reato.
Il problema dell’unificazione della nazione tedesca era diverso perché a questo processo partecipava una delle potenze militari più aggressive del tempo: la Prussia. Il Congresso di Vienna, per superare la
crescente rivalità fra austriaci e prussiani, aveva confermato la piena
sovranità dei principi tedeschi sui loro stati, aveva ampliato le dimensioni della Baviera, del Wurttemberg e dell’Assia, aveva rafforzato la
presenza inglese nel Hannover e quella danese nel Holstein. Il Deutscher Bund esprimeva lo spirito di una restaurazione che era in conflitto con le attese del popolo tedesco che pian piano era coinvolto in
quell’atmosfera anche romantica che – attraverso Lessing, Klopstock,
Herder, Goethe, Schiller, Schlegel, Fichte, Hegel, Novalis, Wagner,
ecc. – andava costruendo quel sentimento esaltato per il quale la nazione tedesca avrebbe creduto di avere la missione di guidare l’umanità.
Anche se Goethe, nella sua visione universale dei problemi del
mondo, aveva sostenuto che il nazionalismo era un ritorno alla barbarie, con Hegel si era affermata ed era prevalsa l’idea della funzione storica dello Stato nazionale. La strada non era agevole perché l’Austria
minava nel Bund di Francoforte ogni proposta unificante mentre Federico Guglielmo lll di Prussia, nel suo esasperato legittimismo, rifiutava qualsiasi iniziativa che fosse contro lo spirito della Santa Alleanza.
In questa situazione, nonostante la progressiva unione doganale (Zollverein), le discordie nel Bund convincevano sempre più il cancelliere
prussiano Ottone di Bismarck che solo la forza delle armi avrebbe consentito quell’unificazione della Germania che era nelle cose.
Con fulminee vittorie dei suoi eserciti, nel 1864 la Prussia batte la
Danimarca assumendo il controllo dello Schleswig-Holstein, nel 1866
attacca l’Austria e ottiene l’annessione del Hannover, dell’Assia e delle città di Francoforte e Nassau, nel 1870 sconfigge la Francia che cede l’Alsazia e la Lorena. Le vittorie militari entusiasmano i tedeschi
che, a furor di popolo, costringono il Baden, il Wurttemberg e la Baviera ad entrare nella Confederazione della Germania: il re di Prussia
assume il titolo d’imperatore della Germania unificata.
Mentre procedeva l’unificazione tedesca, tenace ed insistente era
stata l’opera dei liberali che ripetutamente avevano posto anche il problema di una costituzione democratica. Federico Guglielmo lll di Prussia non aveva mantenuto l’impegno assunto nel 1815 e, attaccato al
17
suo potere assoluto, aveva respinto ogni idea di liberalismo. La diffusa agitazione popolare era tenuta a bada da un’attenta vigilanza poliziesca che anticipava ogni tentativo di sommossa utilizzando i delatori che consentivano l’arresto dei cospiratori. Gli eventi della rivoluzione di Parigi del luglio 1830, però, si ripercuotevano sugli stati tedeschi
dove un’energica e intensa propaganda liberale costringeva i sovrani di
Sassonia, di Hannover e d’Assia a concedere la costituzione. La Prussia riuscì a resistere solo accrescendo la violenza poliziesca e le persecuzioni preventive anche di cospiratori soltanto presunti. La pressione
reazionaria della Prussia preoccupava quei tedeschi che guardavano a
questo paese per l’unificazione della Germania, ed il fermento rivoluzionario del 1848, che vide le barricate anche a Berlino, riuscì a trovare ascolto.
In contrasto con l’Assemblea nazionale riunita a Francoforte per redigere un’unica costituzione per tutti gli stati tedeschi, il 5 dicembre
1848 la Prussia concedeva una sua costituzione che voleva affermare
l’autonoma sovranità prussiana rispetto agli altri stati: il cammino verso un’effettiva democrazia politica, come quello per l’unificazione già
descritto, sarebbe stato ancora lungo. Lo spirito reazionario del Congresso di Vienna era quasi battuto, ma la turbolenta situazione tedesca
avrebbe visto esplodere ancora una reiterata violenza: lo stesso Bismarck riuscì a scampare ad un primo attentato nel 1866 e ad un secondo nel 1875; in questo rimase ferito l’imperatore Guglielmo l. Nonostante la grandiosa legislazione sociale realizzata dal cancelliere tedesco, i moti rivoluzionari continuarono fino alla prima guerra mondiale ed oltre.
***
Seguendola paese per paese - Polonia, Italia, Germania, ecc. –, la
storia del diciannovesimo secolo potrebbe apparire lineare. Ma non fu
così: i rapporti fra i governi dei vari paesi e le attese nazionali, politiche
e democratiche dei popoli europei furono così interdipendenti da aver
creato un’unica tensione su tutto il continente dall’Atlantico agli Urali
e dal mar Baltico a quello Egeo. Fra il Congresso di Vienna e la pace di
Versailles, il diciannovesimo fu uno dei secoli più confusi, drammatici
e violenti della storia d’Europa. Per cento anni – e con ondate rivolu18
zionarie più violente nel 1820-1821, nel 1830-1831 e nel 1848-1849 tutti gli angoli d’Europa pullularono di sette spesso in contrasto d’intenti, cospiratori, servizi segreti camuffati da cospiratori, barricate, attentati, rivoluzioni, briganti senza ideali che ne traevano vantaggi, repressioni, fucilazioni, impiccagioni, torture, esili, vessazioni poliziesche, arbitrii giudiziari: sembrava che l’Europa avesse perduto ogni riferimento alla sua cultura e, soprattutto, ogni riferimento a quei valori
umani che bene o male erano già nel suo patrimonio civile.
Per una maggiore completezza del quadro è utile una breve attenzione alle società segrete. Il sistema di potere nato dal Congresso di
Vienna impediva ogni forma d’opposizione a quell’equilibrio politico
che riteneva di aver dato alla situazione europea: era stato il primo dei
tentativi di realizzare “un ordine mondiale”. La solidarietà fra trono e
altare, sancita dalla Santa Alleanza, non ammetteva alcun pluralismo e
il diffuso spirito nazionalistico rompeva quell’unità ideologica che la
Restaurazione aveva disegnato.
In questo clima, l’opposizione non poteva che essere clandestina. Si
diffusero le società segrete e le sette che, nelle loro impostazioni organizzative, guardavano alla Massoneria francese ispirata da principi illuministici. In Italia agiva la Carboneria, in Germania operava la Jugendbund che contava soprattutto sulle associazioni universitarie, in
Spagna era diffusa la società segreta dei Comuneros, in Grecia era attiva l’Eteria e così in Russia, in Polonia, in Belgio, in Portogallo e in
tutto il continente europeo: all’Europa degli equilibri era opposta l’Europa dei popoli, che anche nei paesi slavi non diedero tregua all’Austria e alla Russia. Le varie organizzazioni clandestine, anche se diverse nel tipo di proselitismo – universitario, militare, aristocratico, borghese - e nelle finalità che cercavano di perseguire – nazional-indipendentistica, politico-liberale o politico-anarchica - instaurarono una
rete di collegamenti e una solidarietà reciproca che, pur nell’essenza
nazionalistica di ognuna di esse, si contrapponeva all’aiuto reciproco
fra le potenze negli interventi militari e polizieschi a difesa dell’ordine
sociale e politico imposto.
Indicativo della solidarietà fra i cospiratori fu lo spirito con il
quale, per la prima volta, si espresse la partecipazione di volontari
internazionali a fianco dell’insurrezione del popolo greco, che lottava per la sua indipendenza: le feroci repressioni operate dai Turchi
19
e i reciproci massacri avevano eccitato la commozione di tutta l’Europa e i poeti romantici avevano colto nella lotta della Grecia, culla
della cultura europea, ulteriori entusiasmi per stimolare i valori della nazione e l’organica unicità degli intenti dei popoli.
I collegamenti fra le società segrete, inoltre, consentivano di trovare ospitalità agli esiliati di tutti i paesi che vagavano soprattutto fra la
Svizzera, l’Inghilterra e la Francia alimentando il rancore verso i governi autoritari. L’odio per l’Austria, che era vista come la potenza
protagonista di ogni reazione repressiva, era diffuso ed unanime ma la
divisione interna del fronte rivoluzionario impediva ogni successo.
Nella società civile era diffusa la paura che nasceva dalla demonizzazione dei “ribelli”, dei “briganti” e degli “anarchici”, dall’incertezza
della situazione economico-sociale e dalla precaria sicurezza fisica.
In quel tempo, l’establishment culturale esprimeva la più ferma riprovazione per la violenza delle iniziative e per l’insicurezza fisica e sociale. Dopo - pur persistendo letture storiografiche che continuarono a
parlare di sfruttamento ipocrita dell’ingenuità popolare, di gretta cupidigia delle classi abbienti, d’infantili romanticherie - quando gli avvenimenti persero la loro contingenza e consentirono di costatare gli obiettivi raggiunti, gli storici adeguarono le loro analisi che furono reimpostate guardando ai fatti in funzione dei grandi eventi e delle nuove realtà
politico-sociali: le cause e gli effetti furono rovesciati e scomparvero le
previsioni che le violente rivoluzioni avrebbero potuto determinare disastri sociali. Oggi, sia i morti delle barricate e degli attentati come le uccisioni di regnanti e di capi di governo di quel tempo, sono tutti ricordati con sereno distacco storico, ignorando il raccapriccio e l’esecrazione
morale che avevano suscitato: è la storia con i suoi morti.
C’erano, come sempre e com’è ovvio, i profittatori e solo chi riusciva ad intravedere la luce oltre la tempesta aveva mantenuto un costruttivo impegno coerente.
Pur fra mille crimini, reciproche efferatezze, uccisioni proditorie,
massacri e nefandezze umane, infatti, il diciannovesimo secolo fu fecondo e costruttivo: il passaggio dal principio di legittimità al principio di nazionalità fece affermare definitivamente il diritto all’indipendenza politica delle nazioni; fu affermato anche il diritto costituzionale dei popoli ad una gestione democratica e liberale del potere
politico.
20
Non furono conquiste facili: l’Europa era stata squassata nelle sue
strutture sociali e messa a ferro e a fuoco. E non tutto era stato risolto:
per il riassetto nazionale dei popoli dei Balcani dovrà trascorrere anche
il ventesimo secolo per superare interamente le conseguenze dello
smembramento degli imperi asburgico e ottomano e le conseguenze
della seconda guerra mondiale.
3. 1919-1920: il Trattato di Versailles e le sue conseguenze
È nella tradizione del racconto storico citare il Trattato di Versailles
come fatto conclusivo della prima guerra mondiale. In effetti, a Versailles fu firmato soltanto il trattato di pace fra le potenze vincitrici e
la Germania, mentre gli accordi con gli altri paesi che avevano perduto la guerra furono firmati in varie località. Poiché, ai fini di queste pagine, interessano le conseguenze che gli accordi di pace ebbero sul
Medio Oriente, sarà utile guardare al trattato di pace firmato con la
Turchia, alleata della Germania, a Sèvres il 10 agosto 1920.
Le gravosissime condizioni imposte con questo trattato al governo
di Costantinopoli, in pratica prigioniero degli inglesi, non furono accettate da un altro governo nazionalista turco costituito ad Ankara.
Questo governo, dopo aver condotto una campagna militare vittoriosa
contro la Grecia, stipulò un nuovo Trattato di pace a Losanna il 24 luglio1923: furono cassate le condizioni più mortificanti e quelle che ledevano l’unità del popolo turco, ma furono mantenute le pesanti rinunzie a tutti i possedimenti che ancora residuavano dal vecchio impero ottomano. La Turchia dovette cedere: l’Egitto e Cipro passarono
all’Inghilterra; la Siria andò sotto mandato francese; l’Iraq, la Palestina e l’Arabia (indipendente dal 1926) andarono sotto mandato britannico; il Dodecaneso sotto il controllo dell’Italia; gli Stretti dei Dardanelli furono internazionalizzati. La Turchia, inoltre, riconosceva l’indipendenza dell’Armenia e rinunziava definitivamente ad ogni diritto
su Marocco, Tunisia, Libia e Sudan.
Questi accordi di pace non espressero un nuovo tentativo di concertare il dialogo internazionale come quello che era stato messo in atto dal Congresso di Vienna. Le impostazioni del 1815, condivise o no,
esprimevano ben precisi indirizzi di gestione del dialogo fra le grandi
21
potenze che dovevano essere rispettati anche dalle potenze minori. Un
secolo dopo, invece, queste impostazioni erano saltate e si era consolidato il rapace espansionismo imperialistico delle potenze coloniali
europee: gli accordi di Sèvres e di Losanna ne furono una conferma.
Francia e Inghilterra si divisero i paesi dell’impero ottomano usando la
riga sulla cartina geografica senza tenere in alcun conto i limiti dei territori effettivamente occupati dai vari popoli e, soprattutto, senza tenere in alcun conto le loro attese nazionali e culturali.
Qualcuno ripete che l’odio islamico non ha altre motivazioni che la
barbara volontà di un radicalismo religioso medievale aizzato contro la
civiltà occidentale per spirito di rivincita culturale o nella presunzione
di potere islamizzare i paesi dell’Occidente. È un’affermazione che eufemisticamente si può definire superficiale ma che soprattutto è pericolosa perché sollecita iniziative isteriche. Le ragioni storiche sono più
serie anche se ricordarle è banale perché sono risapute.
Altri, volendo risalire a cause remote, indicano nelle violenze dei
crociati del basso medioevo l’avvio di un risentimento storico al quale
farebbe capo l’odio attuale verso l’Occidente. Non è così: le violenze
degli scontri di quel tempo, iniziati dagli arabi che nelle loro guerre di
espansione erano arrivati fino alla Spagna, erano violenze ‘’normali’’
nel costume della guerra di quel tempo ed erano state reciproche. Inoltre, le conseguenze di quelle guerre, gestite con accordi diplomatici di
tutti i tipi, erano state ampiamente assorbite nei secoli. Per circa seicento anni, infatti, i paesi del nord Africa e del vicino Oriente sono stati amministrati dall’impero ottomano che ha avuto modo di attirare su
di sè l’ostilità degli Arabi e degli islamici soggetti, stimolando le prime attese del loro nazionalismo indipendentista. L’uso dell’espressione “crociati”, per indicare gli eserciti occidentali occupanti, da parte
dei nazionalisti arabi è solo un’allusione storica.
Fu alla fine della prima guerra mondiale che gli Arabi si resero conto della malafede con la quale le potenze occidentali gestivano i rapporti con gli altri popoli. Gli accordi di pace di Losanna mortificavano
le speranze degli Arabi che vedevano tradito l’entusiasmo con il quale
avevano affiancato la guerra di Francia e Inghilterra contro l’impero
ottomano: la resistenza dell’esercito turco nei deserti arabo, siriaco e
palestinese era stata fiaccata grazie alle agili iniziative della cavalleria
araba guidata dal leggendario Lawrence d’Arabia.
22
Affrontando i problemi del Medio Oriente, in un interessante articolo nel primo numero de Il Mondo di Pannunzio del 12 marzo 1949, Augusto Guerriero cita il carteggio fra l’inglese McMahon e gli Arabi e ricorda come l’ostilità araba sia iniziata con il tradimento degli impegni
assunti dall’Inghilterra fin dal 1914. Per l’indignazione per il mancato
rispetto di questi impegni, il delegato presso gli Arabi, colonnello Lawrence si dimise dall’esercito inglese denunciando la vergogna dell’indecoroso inganno: la Siria con il Libano fu mantenuta sotto il controllo
coloniale della Francia mentre l’Inghilterra mantenne il controllo sull’Egitto, l’Arabia, la Palestina e l’Iraq. La frustrazione araba accese i
primi risentimenti verso l’Occidente la cui scorrettezza diventò argomento d’accanito dibattito clandestino nelle università arabe e denuncia
palese nelle piazze del Cairo, di Damasco, di Bagdad: iniziò la repressione delle potenze coloniali con bombardamenti ed eccidi.
Il dibattito culturale islamico - che molti occidentali nella loro disinformazione non ritengono neanche pensabile - nei contatti con la
cultura europea aveva colto e assorbito gli aspetti positivi del nazionalismo che aiutava a superare i limiti del panislamismo e del panarabismo. Ma la conclusione della guerra aveva determinato una particolare condizione che non c’era sotto l’impero ottomano e che per i princìpi dell’Islam era inaccettabile: la subordinazione di musulmani agli infedeli.
La reazione antieuropea, che oggi è genericamente confusa sempre
con l’estremismo wahhabita, fu quindi fin dall’inizio anche d’ispirazione religiosa ma solo in quanto determinata da una situazione lesiva
della dignità dell’Islam. Dopo, per superare le inconciliabili e anarchiche frammentazioni dei popoli arabi in sette, etnie e tribù, il motivo religioso fu colto e stimolato dagli agitatori politici come elemento coagulante in funzione degli obiettivi nazionali da raggiungere, favorendo
così la mistificante attribuzione di ogni opposizione islamica all’estremismo wahhabita.
Contemporaneamente era stato ovvio in quelle Università avviare il
recupero anche dei più antichi retaggi culturali che, con riferimento alle civiltà mesopotamiche e dell’antico Egitto, contribuirono a ricostruire intero l’orgoglio di quei popoli.
L’esplosiva miscela religiosa, storico-culturale e politico-nazionalistica non poteva non deflagrare.
23
Ma, prima di esaminare le particolari ragioni di delusione dei singoli paesi, è necessario ricordare qual è la realtà sociale, politica, religiosa e culturale di un contesto umano che solo la presuntuosa superficialità europea ed occidentale può continuare a giudicare utilizzando concetti come nazione, sovranità, confine, Stato, ecc. che nel
mondo islamico hanno un valore quanto mai impreciso. La sopravvivenza dell’idea califfale nelle entità imperiali ottomane che avevano
governato il mondo islamico aveva mantenuto una struttura sopranazionale la quale permetteva alle varie etnie e ai gruppi religiosi di
conservare un margine di azione autonoma. Il rapporto fra potere
centrale e gruppi sociali era mediato dal reciproco riconoscimento di
prerogative che favoriva la conservazione di specifici patrimoni culturali riferiti alla lingua, alla particolarità religiosa, all’etnia. Le unità
amministrative, in altre parole, erano congrue ed omogenee in una
prospettiva protonazionale che non trascurava di rispettare la presenza di realtà beduine e nomadi che complicavano qualunque divisione
territoriale netta. Questa considerazione chiarisce come le categorie
che in Occidente definiscono il concetto di nazione – lingua, cultura,
territorio, ecc. – nel mondo islamico siano inadeguate o diventino
mistificanti. Non deve essere trascurato, inoltre, che il contenuto legale dell’Islam, oltre quello religioso, è stato un aspetto unificante
del mondo islamico che ha consentito la molteplicità delle situazioni
politiche mantenendo l’unità culturale dei singoli e dei gruppi. Queste caratteristiche dovrebbero far comprendere come la coscienza
collettiva musulmana abbia una dimensione sopranazionale che trova riscontro in un diritto, d’origine divina, che è collante storico di
una civiltà e di un mondo culturalmente compatto. In questo mondo,
infine, un ulteriore profondo, autonomo valore ha il concetto, meglio
il sentimento, di “nazione araba”: questo sentimento fa comprendere
perché il problema che affligge un popolo arabo coinvolge tutto il
mondo arabo nel suo insieme.
La complessità politico-culturale descritta chiarisce quanto gravide di conseguenze negative siano state le linee dei confini fra gli stati tracciate arbitrariamente con la riga sulle carte geografiche dalle
potenze occidentali vincitrici della prima guerra mondiale. La molteplicità degli aspetti socio-politico-culturali, inoltre, deve essere tenuta presente quando, nelle pagine che seguono, per comodità espositi24
va si fa riferimento, in modo secco, alle istanze nazionalistiche delle
entità sociali arabe mediorientali. E, soprattutto, deve essere ricordata quando le iniziative di singoli musulmani o di interi gruppi sociali sono prese nel nome della comunità islamica o della “nazione araba” che, alla cultura occidentale meno attenta, possono sembrare entità astratte.
La consapevolezza di questo radicato patrimonio culturale, infine,
deve aiutare a non trarre errate considerazioni dal successo che, nonostante il wahhabismo e il fondamentalismo sciita, ha la diffusione della tecnologia occidentale: sotto, rimane l’orgoglio di una non scalfibile identità islamica.
***
Nei decenni a cavallo fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo,
l’Egitto era ancora nominalmente una provincia vassalla dell’impero
ottomano. Nei fatti, la larga autonomia goduta aveva favorito una progressiva assunzione di diretti rapporti con le potenze europee. Già nel
1869, infatti, i finanziamenti internazionali avevano consentito l’apertura del Canale di Suez che, per le conseguenze sul traffico marittimo
da e per le Indie, aveva attirato l’interesse dell’Inghilterra.
Le difficoltà egiziane a rimborsare il debito finanziario assunto costituirono l’appiglio inglese per interferire sempre più pesantemente
nelle questioni interne egiziane fino all’occupazione militare del paese sotto un regime imposto di protettorato. Il regime di protettorato,
legalizzato(?) internazionalmente da un accordo con la Francia firmato nel 1904, fu dichiarato provvisorio dalla stessa Inghilterra. L’interferenza inglese nella gestione del paese arrivò fino all’organizzazione
del sistema doganale e giudiziario suscitando la sempre più violenta
reazione dei nazionalisti egiziani che si andavano organizzando in
partiti politici.
Nel 1917, con la fine della guerra mondiale che aveva visto il crollo dell’impero ottomano, avrebbe dovuto cessare il regime di protettorato che l’Inghilterra aveva dichiarato provvisorio: il partito nazionalista, appellandosi al diritto di autodeterminazione dei popoli affermato
dal presidente statunitense Wilson, chiese la cessazione dell’illegale
occupazione dell’Egitto da parte inglese. Fra mille cavilli, incontri di-
25
plomatici, accordi non rispettati e prepotenze palesi, la presenza militare inglese lungo “la valle del Nilo” fu mantenuta fino alla nazionalizzazione del Canale di Suez, nel 1956, da parte del colonnello Nasser, capo dei liberi ufficiali che, con un colpo di stato, avevano proclamato la repubblica.
Vanificata la reazione anglo-francese per l’intervento degli Stati
Uniti, la questione fra l’Egitto e l’Inghilterra poteva ritenersi chiusa
ma, durante gli anni dell’occupazione britannica, l’ostilità antinglese
era diventata ostilità antioccidentale perché gli arabi si erano resi conto che le potenze europee si legalizzavano reciprocamente i comportamenti più arbitrari con Conferenze nelle quali si concedevano reciproche autorizzazioni a prevaricare sui popoli extraeuropei: nel 1928 era
sorto il movimento politico e religioso Fratelli musulmani che, contestando la corruzione dei politici, si andava affermando fra le masse popolari sostenendo un integralismo religioso ritenuto necessario per opporre unitariamente il mondo islamico alle iniziative solidali che le potenze occidentali (cristiane) hanno sempre assunto e continuano ad assumere contro gli arabi e i paesi musulmani.
La diffusa ostilità antioccidentale è continuata a crescere fino a diventare odio per l’appoggio che l’Occidente dà ad Israele nella sua politica di progressiva occupazione della vicina Palestina araba. Il movimento Fratelli musulmani, così, si è diffuso anche in Siria, nel Libano,
in Giordania, in Arabia Saudita provocando più di un eccidio antioccidentale. Chi mistifica le ragioni di quanto accade nel mondo descrive
l’operato di questo movimento come jihaidismo che nasce da un integralismo religioso medievale: dimentica che per il Corano lo jihad, come vedremo meglio più oltre, è una reazione ai torti subiti.
***
In Siria fu recitato dalla Francia lo stesso copione recitato in Egitto
dall’Inghilterra. L’idea di poter o dover abbandonare ogni velleità imperiale non è stata accettata molto volentieri da nessuna potenza europea. Dopo gli accordi di Sèvres del 1920, la Francia aveva tessuto gli
opportuni accordi diplomatici per giungere alla decisione della Società
delle Nazioni che, nel 1922, le affidava il mandato della Siria: nel modo più plateale era mortificato l’entusiasmo con il quale la cavalleria
26
araba siriana al comando dell’inglese Lawrence era entrata per prima
in Damasco liberata dai Turchi.
L’opposizione dei nazionalisti siriani alla successiva decisione
francese di dividere la Siria in quattro stati, fu duramente repressa dalla Francia con il bombardamento di Damasco (1925) e il massacro di
centinaia di civili inermi. La resistenza non fu fiaccata e dopo dieci
anni di guerriglia nazionalista, nel 1936, fu stipulato un accordo franco-siriano che sanciva l’indipendenza della Siria. Ma, come gli inglesi in Egitto, anche i francesi non erano disponibili a rispettare gli impegni che assumevano con gli arabi: i presidi militari e le ingerenze
amministrative francesi continuarono a non tener in alcun conto né gli
impegni assunti né le aspirazioni indipendentiste siriane per altri dieci anni. Nel 1945, l’insurrezione armata congiunta della Siria e del Libano contro le basi militari francesi provocò una violenta reazione che
portò ancora una volta al bombardamento aereo di Damasco: ancora
una volta, centinaia di civili inermi furono massacrati solo per sostenere l’arrogante volontà di un paese occidentale a mantenere soggetto un altro popolo.
L’anno successivo, per l’intervento diplomatico anglo-statunitense
e per la pressione della Lega Araba, costituita da poco, la Siria realizzava il suo sogno di piena sovranità che era costata migliaia di morti
immolati dall’incapacità occidentale di ammettere che i fra popoli arabi correvano gli stessi fremiti d’indipendenza nazionale che, un secolo
prima, avevano attraversato l’Europa.
Ma le motivazioni del rancore antioccidentale degli arabi siriani
non erano terminate: dopo la guerra dei sei giorni perduta contro Israele nel 1967, la Siria non è ancora riuscita a recuperare le alture del Golan, occupate dall’esercito israeliano e successivamente da colonie
ebraiche, nonostante le decisioni dell’ONU vanificate dal veto degli
Stati Uniti che, nell’area mediorientale, hanno assunto il ruolo antiarabo che prima era svolto da Francia e Inghilterra.
L’arrogante scarsa considerazione, con la quale i governi israeliani
trattano la rivendicazione siriana del Golan, completa il quadro delle
ragioni che anche in Siria hanno trasformato l’ostilità antioccidentale
in odio.
***
27
In Iraq, dopo la decisione dell’Inghilterra di non mantenere gli impegni assunti con la mediazione del colonnello Lawremce, l’Università
di Bagdad diventò il centro di un’accanita protesta che si diffuse all’intero paese coinvolgendo lo spirito di autonomia tribale delle varie
etnie e le attese nazionalistiche dei curdi.
Gli anni dagli accordi di Losanna del 1923, che prevedevano il
mandato all’Inghilterra, fino alla definitiva cacciata degli inglesi nel
1958, sono anni di violente proteste popolari, di attentati e di guerriglia. Sono anni che testimoniano la decisa volontà del popolo iracheno
di non subire l’ottusa pretesa britannica di mantenere il controllo strategico-militare dell’area e di non mollare lo sfruttamento delle ricchezze petrolifere, che avevano determinato l’affiancamento degli
americani agli inglesi. Quest’esperienza d’indomita guerriglia irachena durata trent’anni dovrebbe far riflettere quanti affermano che l’attuale (2004) guerriglia antiamericana sia alimentata solo da un fanatico “terrorismo” integralista.
La violenza e la continuità delle proteste, che non erano sedate nonostante la brutale repressione esercitata dalle truppe britanniche, aveva
determinato i tentativi di ipocriti trattati che riconoscevano l’autonomia
irachena ma mantenevano il diritto dell’esercito inglese di presidiare il
paese e gestire il petrolio: nel 1922, 1926,1927, 1930, ad ogni firma di
accordo fra il governo di Londra e i governi fantoccio iracheni imposti,
il popolo insorgeva con le più violente manifestazioni anche contro gli
stessi iracheni che si accordavano con gli inglesi. È quanto sta accadendo anche in questi primi anni duemila e solo un Governo in mala fede e
fondamentalista come quello di George W. Bush può far finta di non
comprendere che un popolo con una cultura non inferiore a quella occidentale (il numero di analfabeti in Iraq è inferiore a quello di molti paesi occidentali) non accetterà mai una condizione di subalternità.
Nei primi decenni del ventesimo secolo fino alla proclamazione
della repubblica con il colpo di stato del generale al-Kassem, nel 1958,
l’Iraq fu espressione di un indomito spirito nazionalistico ad ondate
sempre più violente. Il massimo della brutalità fu espresso nel 1952
quando nella rabbia contro gli inglesi furono accomunati gli americani presenti nel paese, che ormai avevano gettato la maschera: dietro l’ipocrita spirito wilsoniano, l’avida volontà di mettere le mani sul petrolio iracheno era chiara a tutti.
28
La storia più recente non è che una prosecuzione delle conseguenze determinate dalla contraddizione occidentale di tentare di coprire
con l’ostentazione di valori democratici i più materiali interessi economici. Fra guerre con i curdi, nazionalizzazioni e colpi di stato appoggiati dagli americani che avevano portato al potere Saddam Hussein, certamente un autocrate criminale ma costruito dalla CIA. Siamo
arrivati, così, alla guerra dell’Iraq all’Iran, che gli Stati Uniti hanno stimolato e armato per tentare di recuperare il controllo dei pozzi petroliferi che l’Iran di Mossadeq aveva nazionalizzato. Nella successiva
guerra al Kuwait, invece, gli americani si sono schierati contro l’Iraq
perché i pozzi petroliferi kuwaitiani sono già sotto il controllo loro e
degli inglesi.
Oggi, è chiaro a tutto il mondo non prono che l’attuale occupazione statunitense, come tutti gli altri movimenti diplomatici e militari
nell’area mediorientale, è determinata dalla necessità dell’economia
occidentale di accedere con regolare sicurezza alle fonti di petrolio:
ogni altro argomento morale, democratico-liberale e religioso-culturale è soltanto un’ipocrita mistificazione.
Consapevoli di essere nella bufera per l’interesse degli americani
per il loro petrolio, gli iracheni esprimono il più brutale degli odi antioccidentali e non si placheranno fino a quando non saranno liberi di
decidere come mettersi d’accordo a casa loro nel rispetto delle loro tradizioni culturali, politiche e sociali, che si possono anche non condividere ma che devono essere rispettate.
Nella gravità di quanto accade in Iraq, molti occidentali richiamano
con insistenza l’attenzione sulla brutalità della “resistenza” antiamericana irachena, che viene chiamata “terrorismo”, e ne addebitano le efferatezze alla “barbarie” di quella cultura e all’estremismo del fondamentalismo islamico. Come sempre, la storia tenta di scriverla chi crede di aver vinto: forse, ricordando gli eccidi e i crimini commessi in tutta Europa negli anni quaranta del secolo scorso dalla “resistenza” antitedesca anche contro connazionali che collaboravano con il nemico, la
situazione irachena potrebbe essere guardata con maggiore distacco.
In questo senso, per ricordare qualcosa, potrebbe essere utile leggere Il sangue dei vinti di Gianpaolo Pansa nel quale sono descritti decine di eccidi e centinaia di omicidi, stupri, torture e violenze compiuti durante la resistenza e nel dopoguerra dai “partigiani” (se fossero
29
stati iracheni si direbbe “terroristi”) italiani contro altri italiani per punizione, per vendetta, per fanatismo politico e per odio di classe. Un passo (pag. 300) è significativo per tutti: «Il 10 giugno, due partigiani, Tarzan e Bega, entrarono nella canonica e intimarono al sacerdote di consegnare centomila lire… Don Guicciardi obbedì. Ma, mentre voltava le
spalle ai due, Tarzan gli sparò a bruciapelo un colpo alla testa…».
E questo non è il più macabro degli orrori descritti da Pansa e commessi dai “cattolici” partigiani italiani.
Gli episodi simili del confuso dopoguerra iracheno suscitano il raccapriccio e la condanna degli occidentali: è giusto.
Ma, chi si permette di parlare di barbarie “islamica” deve chiarire:
cosa c’è di nuovo sotto il sole? E a quale latitudine?
***
Anche la più breve analisi dei fatti della Palestina impone una premessa che eviti ogni possibile equivoco.
La dimensione dell’orrore di quanto è stato fatto agli Ebrei nella
prima metà del secolo scorso ne impone la più rispettosa memoria e
impone la decisa affermazione che è sacrosanto il diritto degli Ebrei ad
avere una terra e uno Stato propri.
Questo rispetto, però, non deve consentire che un tabù impedisca
sempre e a chiunque di esprimere una qualche valutazione non solo sul
comportamento degli israeliani ma anche degli ebrei che nel mondo ne
difendono sempre e comunque anche i comportamenti più discutibili:
il diritto dei Palestinesi di avere una terra propria non è meno sacrosanto ed è fuori da ogni legge morale chi ritiene di potergliela rubare a
poco a poco.
I diplomatici, probabilmente, possono usare espressioni più moderate, ma la realtà dei fatti storici non può essere mistificata: un furto
lento, violento, progressivo e calcolato è quanto è accaduto ed accade
in Palestina.
La Palestina, soggetta prima ai califfati arabi e poi all’impero ottomano, dal 635 d.C. in poi, è stata patria indisturbata degli arabi mentre
oggi è contesa fra Palestinesi ed Ebrei che, sostenuti dai Paesi occidentali e dai grandi mezzi finanziari delle banche ebree, negli ultimi
cento anni vi si sono trasferiti in massa.
30
«Nel 1881, alla vigilia dell’immigrazione ebraico-sionista, la popolazione palestinese era di circa 457.000 persone: 400.000 arabi musulmani, 13.000-20.000 ebrei e 42.000 cristiani (in gran parte greco-ortodossi). Qualche altro migliaio di ebrei risiedeva stabilmente in Palestina senza possedere la cittadinanza ottomana» si legge nella storia moderna di questa terra scritta dallo storico ebreo Benny Morris (Vittime,
BUR) con apprezzabile equilibrio ed utilizzata per scrivere queste note. Ad essa è rimandato chi voglia conoscere nei particolari le vicende
e i contrasti fra ebrei e palestinesi che hanno portato all’attuale drammatica situazione.
È stato citato uno storico ebreo accreditato per evitare che i rabbini
più scorretti lancino subito l’accusa calunniosa di antisemitismo come
fanno sempre quando è data una notizia di qualsiasi tipo che non ritengono nell’interesse del “popolo ebraico”. Nel capitolo finale di questo saggio saranno esaminati i limiti e la fondatezza di questa espressione; qui interessa aver stabilito il punto di partenza demografico in
quella terra all’inizio dell’incontro-scontro fra arabi ed ebrei.
Nel 1896, Theodor Herzl pubblicava Lo Stato ebraico e nel 1897
fondava l’Organizzazione sionistica mondiale: furono i punti di partenza di un’intensa attività anche diplomatica per fondare uno Stato
ebraico. Il luogo da scegliere inizialmente fu incerto e si riteneva possibile fondare il nuovo Stato nelle grandi praterie fertili ma non popolate dell’Argentina. Pian piano si fece strada e prevalse l’idea di un ritorno in Palestina. “Una terra senza popolo per un popolo senza terra” fu lo slogan che accompagnò la sollecitazione del ritorno degli
ebrei, dimostrando fin dall’inizio non solo quanto fosse sottovalutato
il diritto degli arabi che occupavano quella terra da mille e trecento anni ma anche come volutamente non fosse presa in attenta valutazione
la consistenza numerica del popolo già presente nel territorio.
Il 26 aprile 1916 Francia e Inghilterra si accordano segretamente
per dividersi il controllo dell’impero ottomano contro il quale era in
corso la Grande Guerra: il controllo della Palestina dovrà andare all’Inghilterra. Il 2 novembre 1917 il ministro degli esteri inglese
Balfour, ignorando ogni rispetto degli arabi, dichiara la volontà di “favorire l’instaurazione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico”. È l’inizio di un sempre più massiccio trasferimento verso quella terra di ebrei che, con il sostegno dei grandi mezzi finanzia-
31
ri delle istituzioni ebraiche, acquistano dagli arabi estensioni sempre
più vaste di terreno.
Finita la guerra e, dopo la pace di Sèvres, assegnata la Palestina al
controllo dell’Inghilterra, questa continuò ad ignorare le possibili reazioni arabe e continuò a favorire il trasferimento di ebrei il cui afflusso sempre più massiccio, però, diede l’inizio alle proteste degli arabi:
iniziarono scontri armati fra le due comunità che la polizia britannica
non era in grado di tenere sotto controllo. Il malcontento anche dei
paesi arabi vicini cominciò a preoccupare l’Inghilterra che, resasi conto degli errori politico-diplomatici commessi, fece il tentativo di trovare un accordo fra i Palestinesi e gli Ebrei: iniziò l’iter che pian piano ha costruito il dramma attuale dei Palestinesi che tutto il mondo
arabo sente come oltraggio alla sua dignità e come costante vulnus ai
suoi diritti politici. Il punto di partenza fu, nel 1936, la nomina della
Commissione Peel che avrebbe dovuto dividere la Palestina fra Arabi
ed Ebrei.
La Commissione propose una divisione del territorio per un 80% ai
Palestinesi e per un 20% agli Ebrei: si richiama l’attenzione sul rapporto fra queste porzioni perché in esso è tutta la storia della violenta
truffa storica perpetrata progressivamente in danno degli Arabi. Le
proteste dei Palestinesi, che si vedevano sottratte molte terre, fecero
scattare una serie di attentati organizzati da una banda di terroristi
ebrei, l’Irgun Zwai Leumi, già fondata nel 1931 con il dichiarato scopo di intimidire e cacciare i palestinesi. La storia ufficiale e non contestata di questa banda di terroristi documenta la malafede di tutti i successivi governi israeliani che hanno avuto come primi ministri anche
ex capi di questa organizzazione che si sono macchiati di crimini efferati di cui si sono anche vantati (Begin e Shamir). Fu l’inizio di violenze feroci in luoghi affollati e mezzi di trasporto contro civili arabi
inermi e guarnizioni militari inglesi: i crimini del nazismo verranno
poco dopo e questa scala dei tempi documenta come quello che oggi
gli Ebrei denunciano come terrorismo abbia una culturale primogenitura ebraica nonostante ogni successivo tentativo di mistificazione
suggerita dal fatto che anche i palestinesi si organizzarono in bande
terroristiche. Lo storico ebreo Benny Morris scrive ‘’siamo stati noi
ebrei a dimostrare ai palestinesi quanto sia efficace il terrorismo (Vittime, BUR).
32
© ARMANDO EDITORE. La fotocopia non autorizzata è reato.
Possiamo e dobbiamo tutti condannare la violenza. Ma, se un popolo ha rubato la terra ad un altro popolo con azioni terroristiche, non
ha alcuna patente morale per condannare le azioni terroristiche del popolo derubato che tenta di sopravvivere: anche in questo caso, la violenza di risposta, lo jihad come dice il Corano, è la reazione ad un torto ricevuto.
Incapace di risolvere la complessa situazione determinata dalla reciproca violenza dei contendenti e non volendo prendere iniziative
contro il più feroce terrorismo ebraico, l’Inghilterra affidò il problema
all’ONU che, nel 1947, decise di dividere la Palestina attribuendo ad
Israele il 55% del territorio e ai Palestinesi il restante 45%. Nonostante l’evidente torto agli Arabi (scesi dall’80% al 45%), le bande terroristiche di ebrei - Irgun e banda Stern - iniziarono una serie di massacri
di palestinesi inermi (a Deir Yassin l’eccidio di circa 200 palestinesi
suscitò perfino la protesta di tutto il mondo ebraico pacifista, che è una
maggioranza vasta ma impotentemente imbelle) per farli fuggire e
aprire la strada ai ‘’coloni’’ (integralisti ebrei fanatici quanto e più dei
peggiori fondamentalisti islamici).
La difesa delle posizioni israeliane fu assunta dagli Stati Uniti e da
buona parte dell’Occidente, memore dei torti fatti agli ebrei dal nazismo
e da secoli di assurde persecuzioni promosse dalla Chiesa cattolica e dalle Confessioni protestanti: fu posto e continua ad essere posto il ‘’veto’’
ad ogni decisione dell’Onu volta a ristabilire la verità dei fatti di Palestina e, soprattutto, volta a fermare lo strapotere militare israeliano che, approfittando delle azioni terroristiche palestinesi, anch’esse riprovevoli
per le vittime che provocano, sta conducendo un lento genocidio del popolo palestinese e una lenta erosione dei suoi territori che, depurati delle ‘’colonie’’ e delle vie di comunicazione fra le stesse riservate agli
ebrei, sono ridotti a meno del 20% della Palestina originaria.
Lo stato di fatto è quello che emerge dalla cartina riportata nella
fig.1 che riproduce anche un Muro che gli Israeliani hanno in costruzione con l’intento di chiudere i palestinesi dentro un ghetto invalicabile. I ricordi storici evocano fatti umanamente indecorosi: il muro di
Varsavia dentro il quale i nazisti tedeschi avevano chiuso gli ebrei polacchi e le circoscrizioni dell’apartheid nelle quali i sudafricani “bianchi” chiudevano le popolazioni africane. La storia si ripete: i perseguitati hanno subito, hanno imparato e sono diventati aguzzini.
33
Fig.1 Carta della Cisgiordania palestinese con evidenza
degli insediamenti ebraici e del Muro in costruzione
Pur in questa drammatica situazione che danneggia i Palestinesi, la
pace fra i due popoli sarebbe facilmente raggiungibile con lo sgombero di tutti gli insediamenti colonici da Gaza e dalla Cisgiordania: è
un’ipotesi che i rabbini ebraici estremisti e i loro fanatici seguaci non
34
accetteranno mai perché, pur di non cedere, sono dichiaratamente disponibili anche alla più cruenta guerra civile con gli altri israeliani di
buon senso che sono una maggioranza purtroppo impotente. Lamenta
David Grossmann, uno degli scrittori ebraici più illuminati: “È possibile che il fondamentalismo di poche decine di migliaia di irresponsabili fanatici, che pretendono di occupare questo o quel luogo mitico
della Bibbia, debba impedire a milioni di Ebrei di vivere in pace?”
Purtroppo, non c’è alcuna speranza che questa tragedia possa terminare fino a quando non sarà rispettata la dignità del popolo palestinese e fino a quando questo popolo non avrà una sua terra libera e continua e non quel territorio frammentato da colonie e intersecato da vie
riservate alle forze armate israeliane che la figura 1 evidenzia.
Oggi, 12 novembre 2004, i solenni funerali del Cairo ad Arafat,
trentennale simbolo della resistenza palestinese, con l’omaggio delle
delegazioni ufficiali di tutti gli Stati europei, di tutti gli Stati africani,
di tutti i paesi islamici e della più gran parte del mondo ha chiarito da
quale parte stia la ragione morale, anche sesolo un intervento energico
degli Stati Uniti potrebbe risolvere il problema. Purtroppo, un loro intervento efficace è escluso da due ragioni: i presidenti statunitensi sono condizionati dal voto degli elettori ebrei americani e Israele è l’unico alleato sicuro degli Stati Uniti nello scacchiere mediorientale. Gli
Arabi ne pagano le conseguenze e, ad ogni veto all’ONU che impedisce decisioni contro Israele, il loro rancore verso l’America e verso il
sionismo cresce.
Nel prendere atto di questo rancore si ricordi che gli Arabi, semitici, erano l’unico popolo presso il quale gli Ebrei non avevano subito le
persecuzioni feroci e continue subite presso gli europei cristiani: l’odio
arabo antiebraico è il risultato odierno della stupidità della real politic
occidentale.
***
Le vicende dei paesi arabi mediorientali hanno mostrato le specifiche ragioni che hanno motivato ed alimentato un rancore che è ormai
odio profondo. I popoli mediorientali costatano giorno dopo giorno
quanto la loro apparente e formale indipendenza politica sia nei fatti
condizionata dalla rilevanza strategica che le ricchezze petrolifere di
35
quest’area hanno per l’economia occidentale. Permane, infatti, uno stato effettivo di dipendenza dall’Occidente (leggi Stati Uniti) che, con le
buone o con le cattive, continua a controllarne ogni iniziativa.
Nel 1956, è fallito il tentativo di Francia e Inghilterra di riaffermarsi potenze imperiali occupando il canale di Suez con la collaborazione
militare d’Israele, interessato a rovesciare il governo rivoluzionario
egiziano del colonnello Nasser. L’operazione, che aveva rasentato il ridicolo, fu revocata su pressione degli Stati Uniti: fu sancita la fine del
“momento inglese nel Medio Oriente”, iniziato nel 1918.
Nel 1957, l’epopea d’Algeri concluse la guerra d’Algeria e poco
dopo chiuse la presenza coloniale francese nel Nord Africa. L’immagine della Francia fu umiliata dalla denuncia degli efferati sistemi di
tortura applicati sulla popolazione indigena dall’esercito e dai servizi
segreti di un paese ritenuto civile.
Ma entrambi gli apparenti successi degli Arabi sono stati vanificati
nella loro speranza di completa autonomia dalle numerose basi militari che gli Stati Uniti, sostituendosi a francesi ed inglesi e proprio in
conseguenza dei fatti del 1956-57, hanno progressivamente installato
dal Mediterraneo all’Oceano Indiano e dal mar Nero al Golfo Persico.
La difesa degli interessi petroliferi americani è realizzata non solo pretendendo di mantenere le basi militari perfino in zone sacre all’Islam
come quelle arabo-saudite ma anche con le iniziative della CIA che ordisce complotti in ogni paese per mantenere governi “amici” (il massimo del peggio è stato espresso nell’Iran di Mossadeq). Il sistema di
controllo di quest’area strategica è completato con i metodi delle multinazionali del petrolio che mantengono i governi in posizione filo occidentale corrompendoli. È bloccata, infine, qualsiasi decisione ostile
della Lega Araba con la corruzione dei delegati di questo o quel paese.
Purtroppo, a queste sufficienti ragioni se non per giustificare almeno per capire l’attuale violenza islamica, si devono aggiungere motivazioni religiose e culturali.
È opinione diffusa in alcuni ambienti culturali islamici, soprattutto
ambienti religiosi wahhabiti già ostili da tempi più remoti e ambienti integralisti sciiti, che la modernizzazione tecnologica, con la penetrazione di automobili, televisori e computers, sia il cavallo di troia utilizzato dalla civiltà occidentale per scardinare i valori della cultura e della
religione musulmana. La modernizzazione di tipo occidentale, anche
36
per la volgarità degli spettacoli televisivi e l’incontrollabile possibile
dialogo planetario che Internet consente, alterando i modi di vivere delle popolazioni, corromperebbe non solo la sobrietà dei costumi tradizionali ma anche la compostezza virtuosa delle donne. La consapevolezza di non poter opporre nulla a questa modernizzazione tecnologica
alimenta la rabbia di fanatici religiosi che non trovano di meglio che dare letture mistificate del Corano per aizzare l’odio dei fedeli contro un
Occidente Satana: chi condivide le interpretazioni forzate del Corano,
somma l’ostilità religiosa all’odio politico già sufficiente ed il risultato
è la schiera di giovani esaltati pronti al suicido per l’Islam.
L’esasperazione politico-religiosa è contestata dai più attenti studiosi arabi che tentano di chiarire come le contraddizioni della loro civiltà siano state determinate da una visione immanente del Corano che
ha mantenuto indistinte le esigenze laiche dei popoli dalle impostazioni religiose.
Purtroppo, quest’interpretazione culturalmente più fondata è ancora minoritaria e l’ostilità verso la civiltà occidentale non tende a diminuire: il risultato è anche una sempre latente guerra civile fra opposte
fazioni pro o contro le varie ipotesi di rinnovamento di una società piena di mille attese e di mille contraddizioni.
In questa situazione attutire l’ostilità araba e sostenerne la modernizzazione anche politica sarebbe quasi facile: sarebbe “sufficiente”
evacuare le abusive colonie israeliane in Cisgiordania, eliminare le basi militari americane dai paesi arabi, bloccare le iniziative di corruzione e condizionamento dei governi arabi da parte della CIA e pagare un
prezzo equo per il petrolio mediorientale. Non accadrà niente del genere: gli ebrei più fanatici non vogliono ritirarsi dai luoghi delle loro
idolatrie, gli americani vogliono mantenere il controllo militare del
Medio Oriente e la CIA continua a trafficare per difendere gli interessi petroliferi delle multinazionali.
Il risultato è di favorire quanti, con l’obiettivo della più completa
indipendenza politica, sfruttano il fanatismo religioso come collante
nazionalistico non solo contro gli occidentali ma anche contro i governi islamici filo-occidentali: i kamikaze esplodono sempre più numerosi, assieme alle vittime ignare, e consentono all’Occidente più ipocrita
di affermare che con l’integralismo islamico non c’è alcuna possibilità
di dialogo.
37
4. Considerazioni conclusive
Ripercorrendo i due secoli trascorsi dalla fine delle guerre napoleoniche, è stato rilevato come i popoli occidentali abbiano concluso le loro rivoluzioni nazionali nell’arco di circa cento anni dal Congresso di
Vienna. Sono stati necessari, inoltre, quasi altri cento anni per il definitivo assetto di tutti i suoi popoli, anche quelli slavi, in Stati nazionali.
Per i popoli arabi e del Medio Oriente, invece, mancano pochi anni al secolo dalla pace di Versailles senza che nessuno di essi abbia ancora raggiunto una piena dignità di paese indipendente: ovunque la dignità nazionale è condizionata da interferenze esterne e alcuni popoli
– soprattutto palestinesi e curdi – sono lontani anche dall’avere un loro ben definito e certo territorio.
In Europa, nel diciannovesimo secolo, il compito di frenare le attese politiche e le speranze nazionalistiche era stato svolto dall’Austria
con la Russia accanto e l’Inghilterra che trescava nel suo esclusivo interesse.
In Medio Oriente, nel ventesimo secolo, lo stesso compito è stato
assunto dagli Stati Uniti con l’Inghilterra accanto e la Francia che cerca di trescare in modo autonomo.
La prima considerazione che deve esser fatta è che dovrebbe ormai
essere evidente come non sia possibile programmare assetti di “un ordine mondiale” di qualsiasi tipo ignorando le attese dei popoli: le armi, anche le più potenti, sono state sempre e sempre saranno travolte
dai sentimenti delle masse
La seconda considerazione è che appare incredibile come gli occidentali siano incapaci di rendersi conto che i popoli arabi sono attraversati dagli stessi indomabili fremiti che, negli ultimi scorci del diciottesimo e per tutto il diciannovesimo secolo, animarono le rivoluzioni degli americani e degli europei con la conquista finale della loro
indipendenza nazionale e il rispetto dei valori politici liberali.
Soprattutto è incredibile l’incapacità di rendersi conto del fatto che
l’intensità di questi fermenti non consente di prevedere per l’Occidente nessuna vittoria possibile e nessuna pace fino a quando anche tutti i
popoli del Medio Oriente non avranno la più completa autonomia nazionale nel più pieno rispetto dei loro valori culturali e delle loro risorse economiche.
38
La differenza fra i due periodi sta nel fatto che, mentre l’Austria più
che interessi effettivi difendeva posizioni di principio – il prestigio, la
legittimità e l’ordine –, oggi gli Stati Uniti e tutto l’Occidente difendono corposi interessi che coinvolgono non solo le multinazionali del
petrolio ma anche il benessere materiale delle popolazioni occidentali:
la difesa di interessi economici vitali, sollecitata dal più ancestrale
istinto di conservazione, ottunde la capacità di analisi obiettive e rende quasi obbligate le scelte.
Questa situazione è andata determinandosi lungo due linee: il tipo
di sviluppo economico-tecnologico e l’imperialismo.
Lo sviluppo economico non è argomento di queste pagine, ma è risaputo che, per la complessità dei problemi legati alla produzione di
energia atomica, per l’inquinamento determinato dal carbone e per
l’ancora modesta quantità d’energia prodotta da fonti alternative, l’energia da fonti petrolifere è ancora l’energia fondamentale per l’economia dell’Occidente: non solo per il mantenimento del livello della
produzione industriale ma anche per conservare il livello dei consumi
civili che è sostenuto da un’automazione tecnologica che consuma ancora più energia dell’industria.
La sempre crescente quantità di petrolio richiesta dall’esponenziale sviluppo del suo consumo, anche per l’ingresso nel mercato di paesi sempre più aggressivi come la Cina, ha posto la necessità del controllo politico delle aree del pianeta nelle quali si trovano i giacimenti
petroliferi che, per la maggior parte, sono concentrati in Medio Oriente. Il controllo, però, è stato reso problematico dal fatto che la straordinaria crescita dei consumi petroliferi è coincisa, a metà del secolo
ventesimo, con il momento nel quale si concludeva la decadenza della
potenza imperialistica dell’Occidente europeo.
L’imperialismo era stato espressione della cultura socio-economico-religiosa europea degli ultimi decenni del diciannovesimo secolo ed
aveva raggiunto la sua massima espansione nei primi decenni del secolo successivo. Le interpretazioni di questo fenomeno storico sono
state numerose ma nessuna da sola basta per spiegare il suo diverso
sviluppo nelle differenti parti del pianeta. Le considerazioni economiche hanno alimentato una critica dell’imperialismo che ha visto la sua
più organica esposizione nel saggio di Lenin Imperialismo, fase estrema del capitalismo. Secondo Lenin, lo sviluppo industriale europeo e
39
la concentrazione del capitale in mani sempre meno numerose rendeva sempre più difficile investirlo con profitto creando la necessità di
trovare sbocchi d’investimento all’estero. Questa necessità imponeva
ai più potenti stati europei di entrare in conflitto per dividersi ed occupare i mercati e le nuove aree nelle quali investire. Anche se è vero che
le ragioni economiche da sole non spiegano tutto il fenomeno dell’imperialismo, rimane certo che i grandi gruppi finanziari operanti in Europa spinsero i loro governi a sempre più aggressive avventure coloniali.
Agli stimoli economici si erano aggiunti quelli religiosi a sostegno
della volontà di diffondere i principi cristiani e quelli scientifici che
avevano trovato in Charles Darwin l’espressione massima della necessità di conoscere il mondo. Si aggiungevano questioni di prestigio delle nazioni europee nella gara imperiale e, avviato il processo imperialistico, si erano sommati problemi di difesa ed espansione strategica
delle colonie già conquistate.
La civiltà europea si era avventata sul mondo, come ha scritto qualcuno. Ma, con la sua presenza in paesi e presso civiltà diverse, non poteva non esportare elementi della sua cultura: se nel suo momento di
massima espansione avevano preso il sopravvento le idee razziste che
affermavano l’inferiorità genetica delle razze non “bianche”, pian piano le idee europee di uguaglianza, libertà, autodeterminazione nazionale, patriottismo e identità culturale erano entrate nel profondo anche
dei popoli soggetti. Andavano costruendosi, così, le ragioni della loro
rivolta e, pian piano, le ragioni della sconfitta dell’imperialismo.
Le genti europee, che all’inizio del ventesimo secolo ritenevano ovvio e scontato per l’Europa dominare il mondo, dopo la fine della seconda guerra mondiale hanno dovuto imparare quanto fosse umanamente presuntuosa la sua potenza imperiale.
Nel 1815, il Congresso di Vienna aveva alimentato la speranza che
l’ordine disposto potesse contribuire alla stabilità dell’Europa: nei fatti, aveva portato ad un secolo di rivolte dei popoli europei. Così, dopo
la guerra 1914-1918, l’equilibrio fra le potenze ricercato con gli accordi del 1919 in Africa, in Medio Oriente e nei Balcani, si è dimostrato irrealistico: i fatti hanno chiarito ancora che è presuntuoso pensare di poter disporre dei comportamenti degli altri popoli anche se, e
forse soprattutto se, di cultura diversa.
40
Nella consapevolezza degli errori commessi dall’Europa, gli Stati
Uniti hanno tentato metodi più raffinati e moralmente più scorretti per
mantenere il controllo dei paesi nei quali erano subentrati alle potenze
europee. È superfluo entrare nell’analisi di questi metodi che sono stati ampiamente descritti nelle critiche al “neocolonialismo”. Ma alcuni
aspetti sfacciati delle politiche statunitensi – il sostegno a dittature anticomuniste, il sostegno incondizionato ad Israele, i colpi di stato orditi dalla CIA nel Centro Sud dell’America e in altre parti del mondo, la
protezione anche militare delle iniziative delle multinazionali e il sostegno alle esportazioni statunitensi con la dittatoriale gestione del
Fondo Monetario Internazionale – hanno trasformato l’ostilità antieuropea in un antiamericanismo diretto e viscerale che compromette gli
aspetti positivi della globalizzazione e che è diventato il fondamento
traslato dell’odio verso l’Occidente.
La complessità della situazione che si è venuta a creare dovrebbe
suggerire che non è più possibile limitarsi ad affermare che le responsabilità sono dell’estremismo implicito nell’ostilità antioccidentale che
è stata sempre espressa dal fondamentalismo islamico.
Questa tesi è comoda, ma non è produttiva perché storicamente non
è così. Alle pagine 208 e 209 del suo Il secolo breve, Eric Hobsbawm
descrive i movimenti anticoloniali dei paesi arabi nei primi decenni del
ventesimo secolo e ne documenta gli stimoli dovuti ad influenze o liberali o comuniste di derivazione europea. E, mentre per i Fratelli musulmani egiziani (1928) il riferimento islamico è ricordato soltanto in
chiave nazionalistica antisionistica, per il movimento algerino degli
anni cinquanta viene riportata l’affermazione dei suoi capi che “la loro non era una guerra di religione ma la lotta per distruggere un colonialismo anacronistico”. Anche in Siria, in Iraq, in Iran fino a tutti
gli anni sessanta “non era attivo alcun motivo religioso e solo più tardi le voci laiche e modernizzatici della classe politica furono soffocate e spente dalla rinascita di massa del fondamentalismo”.
Hobsbawm, alle pagine 528-531 della sua storia del mondo, chiarisce ancora come il recupero di un medievale fondamentalismo islamico sia stato la conseguenza della rivoluzione contro lo Scià la cui autocrazia era stata imposta dalla CIA statunitense all’Iran nel 1953,
soffocando brutalmente ogni opposizione nazionale, liberale e marxista (cacciata di Mossadeq). È soltanto nel 1979 che l’ayatollah sciita
41
Khomeini, che a lungo aveva predicato che solo una forma di governo
completamente islamica poteva opporsi validamente alla prepotente
ingordigia americana e all’arroganza occidentale, riesce a far trionfare
in Iran la sua rivoluzione. Dopo questo avvenimento, il suo successo
alimenta il fondamentalismo che risorge progressivamente nel mondo
islamico: la responsabilità è per molta parte degli Stati Uniti. Oggi, solo la consolidata autorità di uomini forti riesce a tenere a freno l’irrequietezza fondamentalista.
Ma, anche non trascurando l’integralismo islamico, l’aspetto grave
nel dialogo mondiale successivo alla crisi dell’imperialismo è che l’invadenza dell’Occidente, con la sua cultura, l’avidità economica e la
potenza militare, ha fatto emergere ovunque un’ostilità assoluta ed irrazionale: si è diffuso un “antioccidentalismo” che “vede” una civiltà
occidentale senz’anima, senza radici morali e senza fede, avida e parassita del mondo, in balia di uomini menomati nella loro sensibilità e
ridotti ad automi incapaci di ritrovare un equilibrio naturale. È una visione pregiudiziale fatta di stereotipi che si contrappone alla presunzione storica degli occidentali sempre pregiudizialmente convinti dell’inferiorità umana e culturale dei non europei.
È una visione la cui gravità sta nel fatto che è diventata lo stimolo
rivoluzionario contro un’invadenza che non si è mai resa conto della
sua arroganza (qualche aspetto sarà accennato nelle Considerazioni finali di questo saggio). Non comprendere che è questo lo stimolo primo d’ogni rivolta antioccidentale è assurdo perché continuare a contestare soltanto il possibile fanatismo religioso altrui, che è stimolato
strumentalmente da politici abili, impedisce agli occidentali di reimpostare radicalmente il dialogo fra le genti del mondo con la consapevolezza che nessuno può pretendere di dettare “un ordine planetario”.
In questa situazione, la novità sta nel fatto che gli islamici si sono resi conto che la potenza militare degli Stati Uniti, la capacità della CIA
di far cadere i governi non filo occidentali e la corruzione che assoggetta i governanti, impediscono qualsiasi tipo d’opposizione palese.
Come al tempo della Restaurazione in Europa si comprese che solo le società segrete avevano una possibilità operativa, così oggi anche
nei paesi arabi le organizzazioni segrete hanno assunto il controllo di
ogni forma di revanscismo nazionale, religioso, culturale e politico,
decidendo di colpire ovunque possibile. L’aspetto preoccupante per
42
l’Occidente è che la diffusa presenza di musulmani nei paesi europei e
negli Stati Uniti ne facilita la possibilità di operare con la copertura di
attività formalmente incontestabili e di colpire qualsiasi obiettivo anche delicato.
Un breve inciso è necessario. In queste pagine si mette a fuoco soprattutto il rapporto degli americani con il mondo islamico perché è a
loro che bin Laden ha dichiarato la guerra. Ma non si deve dimenticare che, ormai, quando si dice Occidente per i musulmani s’intende anche Russia: la solidarietà, almeno silenziosa, che questo paese riceve
nella sua guerra di massacro plurisecolare del popolo ceceno, è messa
dagli islamici nello stesso conto da pagare.
Nella consapevolezza della fragilità d’ogni ipotesi difensiva, molte
iniziative degli occidentali sono oramai manifestamente isteriche. Forse, mai la situazione di tutti i paesi del mondo è stata a questo livello
di insicurezza diffusa e neppure una non immaginabile armonia di un
organismo come l’ONU potrebbe impostare con successo “un ordine
mondiale”. Sarebbe già tanto se riuscisse a risolvere con efficacia qualche specifico problema locale.
La lezione degli ultimi due secoli imporrebbe di prendere atto del
fatto che gli unici veri protagonisti della storia sono le imprevedibili
masse umane, con i loro movimenti migratori, con la forza dei loro
sentimenti e la disperazione dei loro bisogni.
Nonostante la complessità della situazione e il marasma anche delle emozioni che attraversano i popoli, il neo-conservatore americano
Robert Kagan, in un recente saggio (Mondadori, 2004), continua a sostenere il diritto degli Stati Uniti di fare la guerra preventiva e il dovere della Comunità Europea di schierarsi al suo fianco, senza pretendere un’aprioristica difesa legale di un qualche ordine ipotizzabile, per
contrastare la forza di quelli che chiama nemici dell’ordine mondiale.
Non è detto in chiaro, ma è implicitamente sostenuto che l’importanza del petrolio per l’economia occidentale è così rilevante che la sua
gestione in ogni caso non può essere lasciata agli Arabi.
Sarebbe bene che Kagan, con tutti i neoconservatori, si rendesse
conto che, fin quando non sarà rilevata l’arroganza di questa pretesa,
non ci sarà alcuna speranza che gli Arabi in particolare e gli islamici in
generale, rispettosi della loro dignità, possano essere disponibili a lasciar vivere in pace l’Occidente.
43
44
Capitolo secondo
Due protagonisti
1. I protagonisti
Spesso i fatti della storia sono determinati dal caso. Talvolta sono
determinati da necessità che impongono agli uomini comportamenti
obbligati. Talaltra, infine, gli eventi sono determinati dalle iniziative
specificatamente volute da uomini particolari. Di questi uomini può essere utile ripercorrere la vita per cogliere le ragioni fondanti delle loro
scelte. Le notizie biografiche aiutano la comprensione degli stimoli religiosi o politici o economici o sociali che ne hanno sostenuto o ne sostengono l’azione.
Nelle pagine che precedono è stato possibile costatare come, da alcuni punti di vista, le conseguenze che il Congresso di Vienna ha avuto per
l’Europa siano state molto simili a quelle che le paci di Sèvres e di Losanna hanno determinato nei paesi del Medio Oriente. Questa relativa
coincidenza suggerisce di approfondire la comprensione delle più recenti violenze belliche mettendo brevemente a fuoco le vite dei due personaggi che più significativamente si sono impegnati per dare precisi obiettivi alla reazione dei popoli contro le conseguenze delle soluzioni imposte da quegli accordi di pace: Giuseppe Mazzini e Osama bin Laden.
È tanto ovvio che non è neanche da esaminare quanto siano distanti Mazzini e bin Laden non solo in termini di tempo ma anche per diversità religiose e culturali, per differenze socio-ambientali e risorse
economiche e tecnologie disponibili per operare. E tuttavia, pur non
dimenticando le differenze, il confronto fra le vite di questi due protagonisti può disporre ad una più attenta valutazione di quanto accade
nei nostri giorni
45
2. La giovinezza di Giuseppe Mazzini
Giuseppe Mazzini è nato a Genova nel 1805. La cultura liberale del
padre e il giansenismo della madre ne formano fin dall’infanzia un
temperamento rigoroso con spiccati interessi letterari e con un’immediata attenzione alle problematiche sociali e politiche.
A questa formazione collaborano due severi abati giansenisti che ne
guidano le aspirazioni al culto della libertà e al rispetto dei valori democratici di uguaglianza che presto saprà esprimere all’Università
conquistando un certo ascendente sui suoi condiscepoli. Partecipando
con ingenuo entusiasmo giovanile alle manifestazioni del 1821, rimane impressionato dall’incontro con un gruppo di esuli che s’imbarcavano per la Spagna. Scrisse nelle Note biografiche: “Quel giorno fu il
primo in cui s’affacciasse confusamente nell’anima mia, non dirò un
pensiero di Patria e di libertà, ma un pensiero che si poteva e quindi
si doveva lottare per la libertà della Patria”.
Ma Mazzini non era colpito solo da quanto gli accadeva attorno. La
sua curiosità letteraria lo faceva partecipare a quell’atmosfera romantica per la quale la vita non ha quel senso ottimista e positivo dell’illuminismo ma è lotta fra dovere e potere e tende al recupero di un originario ordine armonico. Per questa visione della vita, compito dell’individuo è cogliere nel reale i segni del divenire cosmico nel quale la libertà dell’individuo è legata alla sua volontà di realizzare ideali che
non possono essere circoscritti dalla razionalità meccanicista dell’illuminismo. La diversità nazionale delle culture, il mondo delle sensibilità, il fascino dell’inesprimibile, il gusto del sublime, il senso di quanto c’è di divino nell’uomo, sono motivi che alimentano la formazione
del giovane Mazzini e lo proiettano in una personale dimensione spirituale che lo accompagnerà lungo i quarant’anni del suo impegno politico.
Conclusi gli studi giuridici nel 1827, a ventidue anni si affiliò alla
Carboneria e cominciò a collaborare come pubblicista scrivendo di critica letteraria nell’Indicatore genovese, poi nell’Indicatore livornese di
Guerrazzi e nell’Antologia di Vieusseux. La sua formazione culturale
gli faceva concepire la rivoluzione non come rivendicazione di diritti
individuali ma come dovere religioso al quale rispondere in favore del
popolo. Nel 1830, cominciò a viaggiare per l’Italia per trovare nuovi
46
adepti per la Carboneria. Tradito e denunciato alla polizia quale carbonaro, è arrestato il 13 novembre e rinchiuso nella fortezza di Savona.
Il 28 gennaio, prosciolto per mancanza di prove, è liberato e gli viene
imposto di scegliere tra il confino, sotto la sorveglianza della polizia,
o l’esilio. Sceglie la via dell’esilio ed esce dal Regno Sardo il 10 febbraio. Si reca a Ginevra, dove incontra altri esuli; passa a Lione e vi
trova alcuni proscritti italiani con i quali parte per la Corsica, sperando di portare aiuto agli insorti dell’Italia centrale.
Gli eventi gli fanno comprendere che la Carboneria era soffocata
dalla sua angustia socio-culturale che ne limitava le iniziative a ristretti ambiti locali e a chiuse cerchie sociali: erano i limiti che avevano determinato il fallimento delle rivoluzioni del 1820-1821 e del 1831.
Rientrato in Francia fonda a Marsiglia la Giovine Italia e fa stampare una lettera aperta a Carlo Alberto, appena salito al trono per esortarlo a prendere l’iniziativa della riscossa italiana. La Giovine Italia,
che dichiarava apertamente il suo programma di voler educare il popolo alla fratellanza e all’idea dell’unità nazionale, nasceva dalla constatazione del fallimento della dolorosa esperienza degli insorti del
1831 di Emilia e Romagna: il 26 maggio era stato impiccato Ciro Menotti. Mazzini, riflettendo sulle possibili cause di questa sconfitta, tentava di cogliere vie nuove per inseguire la libertà della Patria.
La giovinezza di Giuseppe Mazzini era terminata. Aveva ventisei
anni: iniziava la vita dell’esule che dedicherà quarant’anni alla sua
speranza di vedere l’Italia indipendente ed unita dalle Alpi alla Sicilia.
3. La giovinezza di Osama bin Laden
Osama bin Laden è diventato un personaggio noto in tutto il mondo dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 alle Twin Towers di New
York. La clamorosa spettacolarità dell’avvenimento ha suggerito l’immediata proliferazione di biografie che hanno voluto creare un alone di
mistero attorno al nostro protagonista ed hanno fantasticato sulle origini della favolosa ricchezza della famiglia.
La realtà, come sempre, è molto più banale e la vita di Osama bin
Laden, fino al 1979, rimase nei termini normali delle vite dei giovani
figli di famiglie molto facoltose.
47
È nato Jiddah per alcuni, per altri a Riyadh, il 10 marzo 1957. Volendo dare una mano a chi ama fantasticare, si rileva che il 10 marzo è
il giorno nel quale è morto Giuseppe Mazzini: è il segno del passaggio
di un testimone?
Del padre è stato scritto che era un ingegnere yemenita o un muratore o un contadino o un facchino. Non è rilevante. Conta che, giunto
in Arabia negli anni ‘30, lavorando sodo era riuscito ad avviare una
piccola impresa edile con la quale pian piano aveva consolidato una discreta disponibilità finanziaria. Forte di questa disponibilità, in un momento di particolare difficoltà della famiglia regnante, aveva colto
l’opportunità per finanziare il re Faysal che, riconoscente, aveva deciso di affidare a bin Laden padre, con uno specifico decreto, la gestione di tutti gli appalti edilizi dell’Arabia Saudita.
Fra gli anni ’50 e ’60, l’eccezionale crescita del consumo di petrolio e il conseguente boom finanziario e edilizio del paese sviluppano
l’impresa bin Laden che monopolizza la costruzione di autostrade, aeroporti, palazzi reali e moschee. Da questo momento, l’effettiva dimensione della straordinaria ricchezza finanziaria ed immobiliare dei
bin Laden è affidata alla fantasia degli agiografi o dei denigratori.
A Jiddah, Osama cresce nel lusso fra 52 o 54 o 57 fratelli e sorelle.
Il rigido maschilismo arabo non consente alcun rilevante ruolo alla
madre, di origini siriane. Alto, esile, mite e riservato, riceve un’educazione raffinata in centri d’élite, come il Vittoria College di Alessandria,
in Egitto, e gode dei lussi dei giovani delle sue condizioni. Quando ancora non ha tredici anni, la perdita del padre lo priva del fondamentale punto di riferimento e chiude ancora più il suo carattere già introverso.
In compagnia dei suoi numerosi fratelli e sorelle e fratellastri compie parecchi viaggi in diversi luoghi d’Europa per raffinare i modi e
apprendere la lingua inglese. Anche per divertirsi. Dopo l’11 settembre
del 2001 i mezzi di comunicazione di tutto il mondo si sono affannati
a cercare avvenimenti intorno alla sua giovinezza. Così sono apparse
testimonianze fotografiche e racconti sulle sue permanenze in Svezia,
Svizzera, Oxford e Marbella, lungo gli anni settanta.
Non attirato dalla vita libertina che conducevano e della quale si
vantavano molti notabili sauditi, cominciò a studiare i testi sacri in una
madrasa (seminario coranico) di Jiddah. A 22 anni si laurea in inge48
gneria e tecniche di gestione d’impresa nell’università Re Abdul Aziz
di Jiddah. Comincia a partecipare all’attività imprenditoriale della sua
famiglia e alla vita della capitale nella quale, accanto al mondo tradizionalista dell’ortodossia islamica, celebra la sua ricchezza miliardaria
un’élite sempre musulmana ma filoamericana che ama le comodità occidentali nel fasto orientale.
La somma delle esperienze comincia a farne un uomo particolare
perché aggiunge le sue spiccate attitudini a servirsi delle tecnologie
mediatiche e delle tecniche finanziarie di Borsa che gli consentono anche di consolidare il già cospicuo patrimonio ereditato dal padre. Sposa una ragazza siriana, come la madre.
È il 1979: nonostante gli appena 22 anni, l’uomo è pronto per la sua
battaglia. Somma un che d’antico e molto di moderno, di elitario e di
popolare, di orientale e di occidentale: è un ibrido esistenziale capace
di muoversi con autorità a tutti i livelli sociali.
Però, prima di seguire le iniziative di Osama bin Laden adulto è utile conoscere il background politico-culturale di cui è portatore.
© ARMANDO EDITORE. La fotocopia non autorizzata è reato.
***
Nel prossimo paragrafo saranno rivisti gli aspetti salienti del
wahhabismo, l’estremismo integralista islamico di cui bin Laden certamente conosce le posizioni anche se, fino a questo punto della nostra
analisi, non possiamo dire quanto e se ne sia sostenitore.
È anche certo che bin Laden non ha ignorato il dibattito politico che
nelle università arabe, come in tutte le università del mondo, è vivace:
è necessario averne un’idea anche minima. Lasciando da parte il complicato problema posto dall’incertezza su quale valore prevalga nel
rapporto fra la singola unità politica statale, la nazione araba e la comunità islamica, ai fini di queste pagine, è utile fermarsi a due argomenti fondamentali: lo jihad e la democrazia politica.
1 – Lo jihad viene continuamente ricordato dalla stampa occidentale come la perenne minaccia dell’Islam, anche non integralista, verso l’Occidente: la “guerra santa”, come viene tradotta la parola, obbligherebbe i credenti a rispondere alla chiamata alle armi per combattere gli infedeli e far trionfare la religione di Allah.
Nel dibattito universitario si ricorda, invece, che la parola «jihad»
49
significa letteralmente «sforzarsi» ed è seguita in genere dall’espressione «fì sabìli ‘llah» valere a dire «sulla via di Dio»: indica, cioè, l’invito ad uno sforzo di miglioramento etico e morale. Nel Corano, le prescrizioni di jihad vanno da un’ampia tolleranza non-violenta (Cor. L,
45; ClX, 1-6; ecc) a una guerra puramente difensiva (Cor. XXll, 39-40)
fino a prescrizioni molto più generali (Cor. lX, 29).
Certo, i pareri sono discordi anche all’interno del dibattito islamista perché i fautori dell’ecumenismo ne danno una lettura pacifica e
morale mentre i fondamentalisti cercano in tutti i modi di accentuarne
il senso aggressivo.
Secondo il diritto islamico, lo jihad diventa obbligo di tutti i credenti solo in caso di aggressione. Nella sura Cor. ll, 191 è detto: “Uccidete dunque chi vi combatte, dovunque vi troviate e scacciateli da
dove hanno scacciato voi”. La lettura non consente interpretazioni illecite: è evidente che si tratta di un invito a reagire e non ad aggredire
in prima battuta.
Ciò che è scritto nel Corano è sempre leggibile e non è contestabile: la contraddizione, quindi, è nei fondamentalisti che sostengono una
lettura rigida del loro libro sacro ma poi danno un’interpretazione
estensiva della parola jihad, ben oltre il significato intrinseco della parola e il contenuto letterale delle sure nelle quali è impiegata.
2 – Anche la gestione del potere politico è un argomento molto dibattuto per la complessa successione storica delle forme di governo
utilizzate dagli arabi. Non si dimentica, infatti, che all’inizio dell’avventura araba, l’istituto del califfo (capo della comunità musulmana),
che assicurava il carattere unitario dell’Islam, si fondava sulla consensualità. Tenendo presente che per i musulmani i comportamenti di
Maometto sono esempi da rispettare come legge, si ricorda che già con
Maometto il suo potere - personale, assoluto, religioso, teocratico e
unitario - nasceva dagli accordi di al-Aqaba del 621 con i membri di
diverse tribù che avevano aderito alle sue idee religiose e dagli accordi con i Medinesi che si erano impegnati a dare anche aiuto militare.
È con gli Omayyadi, dopo il 656, che il potere si trasmette per via
dinastica. Decade l’origine contrattualistica della sovranità e si consolida la tradizione della nomina del successore, che viene accettata per
evitare i pericoli non rari dell’anarchia. La sovranità mantiene il suo
carattere personale ed assoluto ma, contemporaneamente, si affina la
50
costruzione dottrinale ortodossa che pone dei limiti al potere del sovrano stabilendo il suo obbligo di non esercitare un’autorità dispotica
ma nell’interesse di Dio, della religione islamica e dei musulmani. Il
sovrano ha il dovere di rispettare la shari’a come ogni altro credente.
A questi due modi di acquistare la sovranità - elezione consensuale
da parte del consiglio dei rappresentanti della comunità musulmana e
successione - statuiti dalla dottrina ortodossa, l’adeguamento alla
realtà storica dei popoli islamici, ne ha fatto aggiungere un terzo: l’occupazione del potere. L’obbedienza a chi occupa il potere è giustificata dalla necessità di evitare i mali dell’anarchia.L’obbligo dell’obbedienza per il popolo nasce solo dalla corretta gestione del potere da
parte del sovrano che, se sbaglia, può essere dichiarato decaduto.
Gli studiosi di diritto pubblico islamico, quando non sono pregiudizialmente ostili, definiscono l’Islam una “teocrazia laica egalitaria”
con carattere contrattualistico e democratico.
Il fondamento dell’accettazione anche del potere di un autocrate
nasce dall’esperienza secolare dei popoli islamici della loro realtà sociale: una congerie di tribù etnicamente diverse, clan anche molto piccoli e sette religiose ed esoteriche, i cui capi, devotamente seguiti, confliggono bellicosamente fra di loro per non perdere la loro autonomia
amministrativa ed economica.
L’esperienza dei guasti di ogni tipo che i contrasti fra i capi delle
tribù causano in mancanza di un capo assoluto ha fatto statuire alla dottrina che anche un autocrate che sappia imporsi facendosi rispettare e
che rispetti la shari’a, è meglio dell’anarchia: l’accettazione dell’autocrate è considerata una scelta utile per l’armonia sociale.
Nel dibattito culturale musulmano si afferma che la validità di questa scelta della dottrina politica islamica per i suoi popoli è stata dimostrata dagli eventi degli ultimi vent’anni in Medio Oriente dove solo la rozza presunzione degli occidentali disinformati poteva far pensare che fosse sufficiente bombardare le città per imporre dopo la cosiddetta democrazia occidentale: ovunque riprendono i contrasti fra i
gruppi armati delle varie etnie che non cesseranno se non saranno lasciati liberi di mettersi d’accordo fra di loro. Gli occidentali affermano
che questa conflittualità sociale è barbara; gli arabi sostengono che è
barbara l’incapacità degli occidentali di rendersi conto della storica
tradizione di autonomia delle piccole comunità arabe.
51
Per la cultura islamica, la democrazia delegata di tipo occidentale è
un’ipocrisia che legalizza il prevalere degli interessi delle parti sociali
meglio organizzate per condizionare e sopraffare le altre.
Per il diritto pubblico islamico, i conflitti degli interessi che si scontrano nella società umana non sono risolvibili in modo equo se non da
un capo carismatico al di sopra delle parti che, con il consiglio dei saggi, abbia la gestione dell’ultima parola su qualsiasi questione: l’equilibrio del capo è soggetto al giudizio del popolo con le forme della democrazia diretta (plebiscito, referendum, ecc.); il popolo ha anche il diritto di abbattere l’eventuale tiranno dispotico.
Certamente è vero che l’effettiva equità della gestione del potere in
un paese musulmano è affidata all’equilibrio del capo, all’armonia dei
rapporti fra il capo e il suo popolo e alla capacità o meno del popolo di
sostituire quel capo che si comportasse in modo tirannico. In molti casi è stato dimostrato quanto sia difficile.
Ma in quale misura, nelle democrazie delegate occidentali, la manipolazione del consenso, anche in forza del potere condizionante dei
mezzi d’informazione, lede la consapevolezza delle scelte elettorali? E
quanto il potere finanziario, senza alcuna possibilità di controllo, condiziona anche con metodi al limite del codice penale la gestione del potere politico e l’equilibrio delle consultazioni elettorali?
Al dibattito su questi argomenti partecipa l’egiziano Naguib
Mahfouz, premio Nobel per la letteratura 1988, che è uno dei tanti studiosi musulmani che contrastano il fondamentalismo con la forza della cultura e della pazienza. «Dubito che il fondamentalismo sia una
forza autenticamente rivoluzionaria. La pace sociale è una conquista di
lungo respiro... Una vera democrazia convive benissimo con l’Islam
che non è in contraddizione con razionalismo e laicismo... La libertà
d’interpretazione del Corano è intrinseca al testo che è rivolto, piaccia
o no ai fondamentalisti, alla comprensione di tutti gli uomini per metterli in grado di trovare da soli la giusta via fra il bene e il male…» afferma nei suoi lavori e, con impegno, cerca di sostenere questa posizione nei dibattiti ai quali partecipa.
Dai molteplici aspetti di questa cultura politica ha tratto la sua formazione Osama bin Laden prima di scoprire, nel 1979, quella che ha
ritenuto essere la sua missione.
52
4. le teorie estremistiche del loro tempo: anarchismo, wahhabismo
Spesso, quando ci si trova di fronte a problemi dei quali non s’intravedono le soluzioni, accade di etichettare gli eventi con riferimenti
noti: anche se il quadro che ne risulta può non essere confortante, almeno rassicura il fatto di ritenere di conoscerlo nelle sue linee ispiratrici.
Questa situazione si è avuta quando Giuseppe Mazzini portava
avanti la sua missione rivoluzionaria da un paese all’altro di un’Europa nella quale le più contraddittorie atmosfere culturali inseguivano
obiettivi politici che erano suggeriti da una varietà d’ispirazioni: si andava da atteggiamenti mistico-religiosi via via fino a comportamenti di
un estremismo criminale. La difficoltà delle polizie di accettarne le
motivazioni, aveva fatto etichettare Giuseppe Mazzini non tanto come
un agitatore politico nazionalista quanto come un pericoloso estremista sovversivo, rivoluzionario, anarchico.
Anche oggi, la complessità della situazione planetaria tende ad essere semplificata da parte delle polizie di tutto il mondo che, senza indugi, inquadrano come integralismo wahhabita tutte le manifestazioni
non sole dell’estremismo religioso islamico ma anche del revanscismo
arabo, dell’attivismo per un ipotetico califfato panislamico, del nazionalismo culturale e politico dei paesi musulmani e, spesso, pure della
lotta per sopravvivere del popolo palestinese. Così anche l’aggressiva
intraprendenza di Osama bin Laden è privata di ogni autonoma motivazione politica ed è sbrigativamente condannata come espressione del
più barbaro wahhabismo.
È conveniente, allora, rivedere brevemente i contenuti degli estremismi in questione, per poi valutare quanto e come vi possano rientrare o meno le iniziative dei nostri protagonisti.
***
– L’anarchismo. In Europa, nella seconda metà del diciannovesimo secolo, più o meno fondate speculazioni filosofiche avevano affermato, con motivazioni diverse, il diritto dell’individuo alla sua più piena libertà. Non era proposta una semplice libertà di coscienza ma la più
53
completa libertà di esprimersi e di operare in assenza di una qualsiasi
autorità superiore: in assenza, cioè, di una qualunque forma di governo.
Le prime idee su prospettive libertarie, fra il diciottesimo secolo e
il diciannovesimo secolo, erano state formulate nelle opere di JeanJacques Rousseau, in quelle della sinistra hegeliana e nelle iniziative
del Saint-Simon e del Fourier. Ma, è con Pierre Joseph Proudhon che
viene espressa una teoria dell’anarchismo come libero riconoscimento
degli interessi individuali in conflitto in una società non governata né
da leggi né da magistrati. Contemporaneo di Proudhon, Max Stirner
espone un’organica teoria anarchica che rivendica l’assolutezza dell’egoismo dell’individuo che è Unico in una realtà sociale che non può e
non deve limitare il suo più pieno istintivismo. La radice dell’anarchismo era nella negazione del principio d’autorità – umano o divino, civile o ecclesiastico – sul quale sarebbero fondate le istituzioni che hanno costruito le disuguaglianze: solo l’uguaglianza economica e sociale
di tutti potrà costruire un’umanità solidale.
Queste idee trovarono fertile terreno nella situazione sociale russa
che alimentò l’anarchismo politico di Michail Bakunin, l’anarchismo
scientifico di Petr Kropotkin e l’anarchismo mistico-morale di Lev
Tolstoj. La diffusione di queste idee fu il punto di partenza d’esaltati
moti rivoluzionari in molti stati europei e anche d’America: un’attiva
propaganda mirava a rovesciare i governi e a sopprimere i capi di stato. Gli ultimi decenni del diciannovesimo secolo furono espressione di
drammatici eccidi d’origine anarchica: fu ucciso a Lione il presidente
della repubblica francese Carnot, fu ucciso il presidente spagnolo Canovas del Castillo, fu assassinata l’imperatrice d’Austria Elisabetta, fu
assassinato il re d’Italia Umberto l, fu assassinato il presidente degli
Stati Uniti Mc Kinley. Ma le vittime non erano soltanto capi di Stato:
gli anarchici facevano esplodere le loro bombe anche dentro i caffè e i
cittadini dilaniati furono numerosi.
Per l’Europa, furono anni d’insensata violenza da dimenticare: anche per la strumentale accusa d’anarchismo utilizzata dalle polizie e
dai governi per reprimere con le drastiche leggi emanate e con mezzi
brutali pure le manifestazioni politiche non anarchiche.
***
54
– Il wahhabismo. È opinione diffusa che l’Islamismo sia e sia sempre stato una religione con rigide impostazioni che non possono essere contraddette. Non è così. I dettati del Corano e gli esempi dati personalmente da Maometto – che l’Islamismo rispetta come norme di
precetto - non costituiscono un corpo dottrinale organico privo di incertezze. Le attuali norme, inoltre, non sono il risultato di concili dei
dottori della “chiesa” perché l’Islamismo non ha una gerarchia ecclesiastica: sono il risultato di elaborazioni di scuole che, nel tempo, hanno affrontato le varie questioni con vivaci dibattiti.
Mentre il rituale elaborato nei primi due secoli dall’egira non ha subito più variazioni rilevanti, la dogmatica positiva elaborata nello stesso periodo, pur considerata definitiva, è stata nei fatti al centro di un
continuo dibattito sulla possibilità che il ragionamento filosofico abbia
la facoltà o meno di approfondirne e aggiornarne i princìpi. Si è posta
così la distinzione fra una teologia positiva tradizionale (hanbalita) e
una teologia speculativa che addirittura sostiene la necessità di una
speculazione razionale per ogni singolo fedele senza la quale non esisterebbe in lui la vera fede.
Nella prima metà del diciottesimo secolo, alle conseguenze di una
posizione così aperta si è opposto con irruente rigore Muhammad ibn
Abd al-Wahhab (1703–1792). Il giovane al-Wahhab, educato agli studi teologici e giuridici dal padre, qadì di scuola hanbalita, aggredì con
violenza tutto ciò che ritenne essere una deviazione dalle norme del
buon islamismo antico. Fra mille ostilità ambientali e umane, scrisse
opuscoli di carattere catechistico e sostenne un’intransigente riprovazione d’ogni forma di paganesimo con un’accanita propaganda orale.
Il suo rigorismo era un recupero del fanatismo di un vecchio e notissimo hanbalita del primo secolo, Ibn Taimiyyah, che aveva respinto con
fermezza ogni ipotesi d’elaborazione degli insegnamenti iniziali dell’islamismo.
Costretto a fuggire dalla sua città per la reazione popolare alla violenza da lui espressa anche fisicamente contro persone, sepolcri e monumenti, al-Wahhab si rifugiò presso l’emiro Muhammad ibn Sa’ùd
che sposò la sua causa. Quest’avvenimento trasformò il wahhabismo
da semplice movimento religioso puritano in una corrente religiosa,
politica e militare che, per le ambizioni territoriali di Muhammad ibn
Sa’ùd, diventò il motivo ispiratore di una guerra a sfondo religioso che
55
portò alla conquista di buona parte della penisola arabica. Da quel
tempo, la dinastia saudita ha assunto come religione ufficiale dello
stato il wahhabismo e la sua interpretazione soprattutto violenta dello jihad che, da concetto che indica lo sforzo o lotta personale per diventare un buon imam musulmano, diventa ricorso alla spada non più
per difendere la propria fede ma per imporla a chiunque abbia un altro culto. Su questa posizione, dopo alterne vicende, militari e religiose, il wahhabismo si affermò definitivamente con il suo implacabile rigore nel Neged, nell’Higiaz e nella più gran parte dei territori
circostanti.
Oggi, l’integralismo wahhabita afferma che i contenuti della civiltà
moderna d’origine occidentale corrompono la società e devono essere
condannati. Non sono tollerati la musica e il fumare tabacco; sono vietate le case di tolleranza; non sono ammesse espressioni di culto non
wahhabita nemmeno delle confraternite dei sufi musulmani; è applicato il più integro diritto penale islamico, compreso il taglio della mano
e la lapidazione delle donne adultere.
La più rigida e tradizionale delle interpretazioni storiche della sharia, o canone della legge islamica, è difesa dal wahhabismo che si oppone non solo ad ogni innovazione razionalista o laica, presente in altre scuole giuridiche, ma anche a tutta la giurisprudenza d’origine non
coranica.
Seguono, ovviamente, tutte le rigidità di dialogo sociale e politico
collegate a tanta intransigenza religiosa.
L’attuale monarchia saudita, nonostante gli apparenti buoni rapporti con gli Stati Uniti e con l’Occidente, sostiene e difende quest’integralismo religioso che, direttamente o indirettamente, è un accanito nemico di tutto ciò che c’è d’occidentale non solo nei paesi islamici ma,
considerata la diffusione dei musulmani, anche nel mondo.
Siamo, cioè, di fronte ad un diffuso fanatismo non costruttivo, ottusamente fermo ad un’idea di religione e di società umana vecchia di
mille e quattrocento anni con la quale non è possibile alcun dialogo e
per la quale si può solo sperare in un lento mutamento per opera delle
altre scuole islamiche e dello scambio culturale che accompagna l’evoluzione dei mezzi di comunicazione (televisione e Internet).
56
5. Considerazioni conclusive
Il breve cenno alle teorie estremiste che hanno seminato lutti in Europa nel diciannovesimo secolo e stragi per il mondo nei tempi recenti, non ha accertato quanto questi estremismi possano avere condizionato la formazione e la giovinezza di Giuseppe Mazzini e Osama bin
Laden.
Oggi, dopo oltre un secolo, sappiamo perfettamente che nessuno
potrebbe suggerire di inquadrare l’azione rivoluzionaria di Giuseppe
Mazzini in una qualche forma di sovversivismo anarchico. Non è la
violenza espressa nelle insurrezioni e nei tentativi di rivolta organizzati da Mazzini che può essere il metro per giudicarne l’impegno umano:
il suo esemplare, quasi mistico rispetto di un possibile ordine democratico e i suoi precisi intenti politico-nazionali sono stati ampiamente
chiariti dalla Storia.
Non è possibile, invece, sapere quanto tempo dovrà trascorrere prima che possa esser chiaro se l’azione di Osama bin Laden possa essere riferita ad esasperazioni wahhabite o se sia determinata da una legittima esigenza di veder rispettate le attese nazionalistiche e la dignità
dei paesi arabi.
Poiché per tentare di capire non possiamo attendere gli sviluppi finali della diffusa violenza che tiene in ansia il mondo, è necessario
guardare da vicino il succedersi delle dichiarazioni politiche e delle
iniziative di bin Laden per cogliere quegli aspetti che possano aiutarci
a sciogliere i nostri dubbi.
In questa prospettiva, è utile continuare a seguire anche il peregrinare e le iniziative di Giuseppe Mazzini nella sua età adulta per verificare se e quanto sia lecito approfondire un confronto che, nell’attuale
stato di emotività e di paura, appare improponibile alla maggior parte
dell’opinione pubblica occidentale.
57
58
Capitolo terzo
Due società segrete (ma non troppo)
1. Giuseppe Mazzini: la Giovine Italia e la Giovine Europa
Nel 1831, Giuseppe Mazzini aveva appena ventisei anni, ma la
fondatezza delle riflessioni e la tensione morale gli davano una maturità da uomo ben più adulto. Il colore sempre nero che usava per vestire e il tono pacato e sicuro con il quale parlava gli conferivano un
ascendente carismatico che gli altri esuli rispettavano immediatamente. L’analisi delle ragioni delle sconfitte dei moti carbonari del 1831 lo
aveva spinto a costituire un’associazione che si rivolgeva a tutte le
componenti sociali con un programma chiaro e ben determinato: “Fare l’Italia Una, Indipendente, Libera, Repubblicana».
La Giovine Italia, costituita a Marsiglia, si diffuse rapidamente in
Italia e specialmente in Piemonte e in Liguria. Ogni iniziato doveva fare il seguente giuramento solenne:
“Io cittadino italiano
– davanti a Dio, padre della libertà, davanti agli uomini nati a gioirne, davanti a me e alla mia coscienza, specchio delle leggi della natura – pei diritti individuali e sociali che costituiscono l’Uomo – per l’amore che mi lega alla mia patria infelice – pei secoli di servaggio che
la contristano – pei tormenti sofferti da’ miei Italiani fratelli – per le lagrime sparse dalle madri sui figli, spenti o cattivi – pel fremito dell’anima mia nel vedermi solo, inerte e impotente nell’azione – pel sangue
dei martiri della patri – per le memorie de’ padri – per le catene che mi
circondano:
59
giuro di consacrarmi tutto e per sempre con tutte le mie potenze
morali o fisiche alla Patria e alla sua rigenerazione; di consacrare il
pensiero, la parola e l’azione a conquistare indipendenza, unione, libertà all’Italia; di spegnere col braccio e infamar con la voce i tiranni
e la tirannide politica, civile o morale, cittadina o straniera; di combattere in ogni modo le ineguaglianze fra gli uomini di una stessa terra; di
promuovere con ogni mezzo l’educazione degli Italiani alla libertà e
alla virtù che la fanno eterna; di soccorrere coll’opera e col consiglio
qualunque m’invocasse fratello; di cercare per ogni via che gli uomini
della Giovine Italia ottengano la direzione della cosa pubblica; di propagare con prudenza operosa la Federazione di cui fo parte da questo
momento; di ubbidire agli ordini e alle istruzioni che mi verranno trasmesse da chi rappresenta con me l’unione de’ miei fratelli; di non rivelare, per seduzione o tormenti, l’esistenza, le leggi, lo scopo della federazione, e di distruggere, potendo, il rivelatore.
Così giuro, rinnegando ogni mio interesse particolare pel vantaggio
della mia Patria e, invocando sulla mia testa l’ira di Dio e l’abbandono degli uomini, l’infamia e la morte dello spergiuro, s’io mancassi al
mio giuramento”.
Nella formula del giuramento, l’invocazione di Dio e la ripetizione
del verbo consacrare esprimono con chiarezza il sentimento religioso
della formazione mazziniana che è messo al servizio dello scopo politico nazionale. Altre espressioni – spegnere col braccio i tiranni, combattere in ogni modo le ineguaglianze, ubbidire agli ordini, distruggere il delatore – documentano la decisa volontà di operare anche con la
violenza per raggiungere l’obiettivo politico unitario. Il tutto, ovviamente, entro il quadro del rigore morale giansenista e della cultura romantica che Mazzini aveva elaborato con la sua sensibile attenzione al
patrimonio letterario, artistico e storico italiano.
A Marsiglia, nel marzo 1831, inizia la pubblicazione della rivista
«La Giovine Italia», che ha come sottotitolo «Serie di scritti intorno
alla condizione politica, morale e letteraria dell’Italia, tendenti alla
sua rigenerazione». Il periodico diventa strumento di diffusione dell’Associazione. Pian piano, la Giovine Italia si estende anche nell’ambito militare. Il 1833 è un anno duro: nel Regno Sardo gli atti insurrezionali sono soffocati nel sangue: sono condannati a morte vari affiliati. È fucilato ad Alessandria Andrea Vochieri; Jacopo Ruffini, amico
fraterno di Mazzini, si uccide nella notte tra il 10 e l’11 giugno, nel ti60
more di non saper resistere alle torture che si esercitano sui detenuti.
Per la sua attività sovversiva, Mazzini è condannato a morte in contumacia il 26 ottobre dal Consiglio Divisionale di Guerra di Alessandria.
Il 2 febbraio 1835 fallisce il tentativo d’invasione della Savoia e
Mazzini è costretto a rifugiarsi in Svizzera, dove s’incontra con patrioti
esuli di tutte le nazionalità europee oppresse. Favorisce la costituzione
delle società, più o meno segrete, Giovine Polonia, Giovine Germania,
che, collegate con la Giovine Italia, formano la Giovine Europa con lo
scopo di sostenere la creazione di libere nazioni europee affratellate. Il
Gran Consiglio di Berna lo espelle perché aveva promosso anche la costituzione della Giovine Svizzera. Nell’ottobre, con i fratelli Ruffini, è
a Grenchen. Seguono numerosi spostamenti. Nel maggio 1836 è arrestato nel Cantone svizzero di Soletta e poco dopo la Dieta svizzera lo
esilia in perpetuo. La fama di sovversivo lo segue in Francia dove è arrestato a Parigi e rilasciato alla condizione che parta per l’Inghilterra.
Giunge a Londra in miseria e riesce a sopravvivere collaborando a riviste e giornali.
Nel 1840 s’impegna per il rilancio della Giovine Italia e pubblica a
Londra “Apostolato popolare” con il sottotitolo «Libertà, Eguaglianza, Umanità, Indipendenza, Unità - Dio e il popolo - Lavoro e frutto
proporzionato»: le espressioni Apostolato e Dio e popolo confermano
l’aspetto religioso che Mazzini vede nel suo impegno e al quale richiama le masse alle quali si rivolge.
La repressione, che ha preso il sopravvento, lo costringe a trascorrere sette lunghi, difficili anni a Londra dove ha fondato una scuola
gratuita per bambini poveri e da dove cerca di sconsigliare la tragica
spedizione dei fratelli Bandiera. Scrive a Pio lX per indicargli cosa fare per l’Italia e nel 1848 torna a Parigi e poi a Milano che è insorta contro gli austriaci. Ripara in Svizzera al ritorno degli austriaci. Il 9 febbraio 1849 è proclamata la Repubblica Romana. Goffredo Mameli telegrafa a Mazzini: «Roma Repubblica, venite!». Il 5 marzo arriva a Roma, «trepidante e quasi adorando», ed è nominato triumviro. A fine
giugno, non potendo difendere Roma, poiché è respinta la sua proposta di portar fuori l’esercito e combattere altrove, si dimette con gli altri triumviri. Parte per Marsiglia e ricomincia il suo peregrinare prima
a Ginevra poi a Losanna e, sempre nascostamente per sfuggire alla
caccia poliziesca e alle condanne, a Londra dove vivrà per diciotto an-
61
ni con più o meno lunghe puntate nel continente. A Londra non trascura di prendere tutte le iniziative possibili per estendere le simpatie
per il suo paese.
Il 6 febbraio 1853 organizza a Milano un tentativo insurrezionale
contro gli austriaci che è subito represso. Nel 1857 si reca a Genova
per preparare la sommossa della città e la spedizione nel Mezzogiorno
affidata al comando di Carlo Pisacane. La tragica fine di Pisacane fa
fallire anche l’insurrezione che doveva scoppiare nel capoluogo ligure: Mazzini riesce a sfuggire all’arresto e, per la seconda volta, sarà
condannato a morte in contumacia (28 marzo 1858). In quell’inizio del
1858, le ripetute sconfitte delle insurrezioni organizzate gli alienano la
fiducia di molti mazziniani che aderiscono alla causa sabauda che appare sempre più concretamente sostenibile. L’abbandono da parte di
molti amici delude Mazzini e i giudizi negativi espressi dal Cavour alla Camera, sull’irresponsabile violenza e sui rischi delle cospirazioni
mazziniane, lo spingono a scrivergli una dura lettera di protesta.
Nel settembre, tornato a Londra, fonda il periodico « Pensiero e
Azione» che fino al 22 maggio del 1860 è totalmente dedicato alla
propaganda repubblicana.
In Italia Mazzini non è ben accetto e viene escluso dall’amnistia
concessa all’inizio della guerra con l’Austria: è il 1859, si reca clandestinamente a Firenze e la sua presenza è tollerata.
Nel maggio 1860 parte da Londra per l’Italia con la speranza di
raggiungere Garibaldi per l’impresa dei Mille. Arriva a Genova due
giorni dopo la partenza di Garibaldi ma si ferma per collaborare alla
preparazione dell’insurrezione della Toscana.
Con la falsa indicazione di Londra, fa stampare a Lugano Doveri
dell’uomo, sintesi del suo pensiero e della sua concezione etico-religiosa della vita che era il punto di forza del suo impegno attivo: una
fede incrollabile in un chiaro ideale politico animava la sua speranza
di rinnovare l’Italia con il suo impegno rivoluzionario.
A settembre si reca a Napoli dove il prodittatore Giorgio Pallavicino lo invita a lasciare la città anche per le dimostrazioni popolari a lui
ostili. Non riesce nemmeno a convincere Garibaldi a non cedere alla
lusinga sabauda e a proseguire nella sua marcia verso il nord del paese. Comincia a rendersi conto che il suo ideale repubblicano non raccoglie più il seguito degli anni precedenti e, deluso, torna a Londra.
62
Nel 1863 organizza un tentativo insurrezionale in Friuli e richiama
l’attenzione di Vittorio Emanuele ll su Venezia e sul Veneto. Ma la
guerra del 1866 per la liberazione del Veneto lo delude ancora e ritorna all’impegno politico di organizzatore del partito repubblicano: la
Camera dei Deputati annulla la sua elezione nel collegio di Messina, a
causa della condanna a morte del 1858 per i moti genovesi. L’anno
successivo è Mazzini a rinunziare all’elezione a deputato. La sua salute comincia a cedere ma continua a tessere rapporti e a lanciare iniziative: si sposta fra Lugano e Genova e, nel 1870, va in Sicilia dove spera di organizzare un movimento insurrezionale. A Palermo, prima di
scendere dalla nave, è arrestato e trasferito al carcere di Gaeta: poco
dopo è liberato, in virtù dell’amnistia concessa ai condannati politici
per la presa di Roma.
Dopo brevi soste a Roma, Livorno, Genova, deluso dall’atmosfera
che regna in un’Italia unita ma non come aveva sperato, riprende la via
dell’esilio. È a Lugano alla fine di ottobre; ritorna a Londra alla metà
di dicembre.Trascorre a Lugano il 1871 e, il 6 febbraio 1872, giunge
in incognito a Pisa, ospite dei Nathan-Rosselli: muore il 10 marzo. Il
17 successivo si svolgono a Genova i funerali solenni: secondo i calcoli della polizia, partecipano circa centomila persone
Si concludeva la vita di un esule che aveva speso la vita per un
ideale: l’Italia unita, indipendente, democratica e repubblicana. Aveva
tentato anche di sostenere le uguali attese di tutti i popoli europei. Le
sue fughe, gli esili, gli arresti e le condanne a morte non erano stati casuali: sempre dove arrivava salivano i toni delle cospirazioni e gli
eventi sovversivi che le polizie e i governi di tutta l’Europa temevano
e braccavano.
Condannato da molti contemporanei che lo avversarono, oggi, giustamente, Giuseppe Mazzini è ricordato come l’Apostolo dell’unità
d’Italia.
2. Osama bin Laden: al Qaeda (la Base)
Il 1979 è l’anno cruciale della vita di Osama bin Laden: si è appena laureato e ad est dell’Iraq il mondo islamico assiste a due avvenimenti che ne cambiano radicalmente la situazione politica.
63
In febbraio trionfa la rivoluzione komeinista sciita nell’Iran: si risvegliano i movimenti fondamentalisti di molti paesi arabi. In dicembre, la Russia sovietica invade l’Afghanistan per sostenere il regime
marxista contro la ribellione dei mujahiddin locali: si solleva un’ondata di solidarietà in tutto il mondo islamico.
A 22 anni bin Laden, con l’appoggio entusiasta della sua famiglia e
con l’avallo della Casa reale, decide di entrare nelle brigate internazionali musulmane contro il comunismo, sostenute dalle risorse finanziarie e dalle armi che il governo degli Stati Uniti e la CIA profondono per fermare l’espansionismo sovietico.
Il giovane bin Laden, inesperto di guerra e caratterialmente poco incline ad esporsi pubblicamente, in effetti, esordiva sulla scena afghana
sostenuto da una serie di fattori strategico-politici e religiosi che non
possono essere ignorati: era sostenuto dai servizi segreti di Arabia saudita (el Istaybarat), Pakistan (el Isi) e Stati Uniti d’America (CIA), tre
paesi interessati per ragioni diverse ad aiutare la guerriglia afghana e
cacciare i sovietici dall’Afghanistan. Con il riacutizzarsi della guerra
fredda, l’amministrazione statunitense finanziava generosamente
ovunque e qualificava come “combattenti della libertà” le forze ribelli
utili nel confronto globale con l’URSS. Il dittatore pakistano del tempo perseguiva una politica di prestigio e di leadership del suo paese nel
mondo musulmano e aspirava ad includere l’Afghanistan nell’area
d’influenza del Pakistan. L’Arabia Saudita voleva dimostrare ai suoi
critici interni ed esterni che il paese in cui era nato Maometto era un
fermo difensore della fede. I tre stati, inoltre, avevano anche un interesse comune sull’Afghanistan: impedire che l’Iran soppiantasse la
Russia come potenza tutelare. Gli Stati Uniti, per fermare l’avanzata
del fondamentalismo sciita antiamericano; il Pakistan, per una questione di rivalità strategica nella regione; l’Arabia Saudita, per antagonismo religioso del wahhabismo verso l’integralismo sciita.
Forte di questi appoggi e con i consigli del giordano palestinese Abdullah Yusuf Azzam, intellettuale islamista che aveva conosciuto come
docente all’Università di Jiddah, bin Laden avvia l’organizzazione di
campi d’addestramento dei guerriglieri, ne sollecita il reclutamento e
inizia la raccolta di donazioni e finanziamenti per lo jihad afghano: l’espressione jihad è qui nei precisi termini coranici perché si tratta di
reazione all’invasione russa.
64
© ARMANDO EDITORE. La fotocopia non autorizzata è reato.
Per raccogliere fondi, comincia a fare frequenti viaggi nel suo paese e, probabilmente, incrementa i mezzi finanziari con proventi del lucroso traffico d’oppio e di morfina che in Afganistan è fiorente per le
estese coltivazioni di papavero.
Dal 1982 si stabilisce a Peshawar e per agevolare le iniziative avviate contribuisce di tasca propria all’armamento delle migliaia di volontari arabi – come furono chiamati tutti i volontari musulmani non
afghani, sia arabi propriamente detti sia d’altre nazionalità, uzbeki,
africani neri, filippini e cinesi. Comincia a prendere parte egli stesso ai
combattimenti e, ferito in una battaglia per il controllo dell’aeroporto
di Jalalabad, riceve il titolo di mujahid (cioè combattente sacro o colui
che fa lo jihad).
Nell’area operavano già gruppi di guerriglieri locali pasthùn, etnia
maggioritaria in Afghanistan e dominante nelle regioni annesse al
Pakistan dov’è, a sua volta, la terza etnia più popolosa: bin Laden prende contatti con i capi per coordinare e finanziare le azioni di guerriglia.
Questi contatti, che consentono rapporti con i centri di indottrinamento politico e di studi religiosi a Peshawar, permettono a bin Laden
di stabilire nuove relazioni con vari gruppi islamisti nazionali, come la
Jihad islamica egiziana, e con organizzazioni di dimensioni internazionali, come “I fratelli musulmani”, lo storico movimento islamista
fondato in Egitto nel 1928, e la Lega islamica Mondiale, creata in Arabia Saudita nel 1962. Tutte queste associazioni, segrete e non segrete,
erano interessate alla sorte dei loro fratelli di fede afghani. I contatti
con questi centri religiosi, inoltre, fanno fermare la sua attenzione sulla multinazionalità dei combattenti islamici e sul sentimento sopranazionale che li unisce: si ripetono le stesse emozioni che avevano spinto Giuseppe Mazzini, in Svizzera fra gli esuli, alla costituzione della
Giovine Europa.
Nel 1986, cura la realizzazione di un centro operativo in un tunnel,
scavato a Khost nelle montagne a Sud-est di Jalalabad con l’aiuto di
ingegneri e operai pagati da lui, provvisto di moderne tecnologie di
comunicazione fornite dagli Stati Uniti: bin Laden ottiene un controllo più stretto della sua rete di combattenti che istruisce personalmente
dando un’approfondita formazione informatica.
Dal prestigio e dalla forza del mini esercito al suo comando, fra
12.000 e 20.000 uomini, e dall’insieme dei contatti con gruppi inte-
65
gralisti esterni nasce nel 1988 al-Qaeda (La base) con il preciso obiettivo di lottare per il riscatto della dignità di tutta la comunità islamica
(Ummah).
Nel febbraio del 1989 l’esercito sovietico, su decisione di Michail
Gorbaciov, si ritira dall’Afghanistan. Lo jihad, che era inteso nel suo
senso corretto, termina e Bin Laden che, come afferma lo storico francese Gilles Kepel, aveva già una fama leggendaria grazie al buon carattere, alla generosità in danaro, al coraggio di combattente e alla dedizione alla causa, torna in Arabia Saudita. Entra nel circuito degli alleati del re Fahd e riprende con lena la gestione di un complesso d’imprese e di affari che solo in parte corrispondevano all’eredità familiare.
Abbandonato al suo destino dai russi, il regime comunista afghano
di Mohammed Najibullah sembrava avere i giorni contati ma resiste
inopinatamente fino ad Aprile 1992 grazie alle croniche lotte intestine
delle varie tribù e agli antagonismi fra i capi delle diverse fazioni etniche e religiose.
Osama bin Laden dimostra il senso della sua partecipazione ai problemi islamici non dimenticando i suoi afgani: con mezzi propri crea
istituzioni per assisterli economicamente e aiuta le famiglie dei morti
in combattimento.
Nell’agosto del 1990 un’altra scossa sommuove il vicino Oriente:
l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam Hussein. Come bin
Laden, anche il dittatore di Bagdad era stato appoggiato dagli Stati Uniti nella dura guerra contro l’Iran dell’ayatollah Komeini (1980-1988).
Hussein commette l’errore di invadere il ricco emirato petrolifero nell’illusione che gli americani non avrebbero reagito militarmente. Gli
Stati Uniti, invece, organizzano una vasta alleanza militare internazionale perché non vogliono che terzi incomodi interferiscano sul petrolio
kuwaitiano che già controllano: devono cacciare indietro l’Iraq.
Il regno saudita si unisce alla coalizione e consente agli Stati Uniti
di impiantare nel paese una base aerea. L’arrivo di migliaia di soldati
statunitensi e di altre nazioni occidentali ha un impatto senza precedenti nell’ultra conservatrice società saudita che dalla cacciata dei turchi alla fine della guerra mondiale non aveva conosciuto un esercito di
occupazione e mai aveva visto sul suo suolo un esercito costituito da
cristiani infedeli. Bin Laden si erge a pubblico portavoce di molti sauditi che considerano umiliante e sacrilega questa massiccia presenza
66
militare, anche se limitata alla città di Dhahràn e altri punti vicini al
Golfo Persico. La sua città Jiddah, vicina al Mar Rosso e molto vicina
alla Mecca, inoltre, è uno scalo logistico essenziale nelle operazioni
aeree del contingente internazionale.
La rottura definitiva col re avviene quando questi, essendo stata
l’Arabia attaccata dai missili iracheni, preferisce la protezione statunitense a quella offerta da un suo suddito che gli aveva proposto di opporre agli iracheni un esercito esclusivamente musulmano composto
dai suoi ex combattenti afghani. Nel 1990, quindi, sono contro gli Stati Uniti d’America due antichi protetti: Osama bin Laden e Saddam
Hussein.
La lineare consecutio degli avvenimenti documenta come l’iniziativa di bin Laden sia una specifica, diretta reazione all’intollerata presenza degli americani nel suo paese: chi sostiene che nasca da stimoli
wahhabiti è in malafede.
Tanto Saddam che bin Laden allargano il loro discorso rivolgendo
la loro solidarietà al popolo palestinese: sollecitano con il linguaggio
coranico lo jihad della comunità araba contro Israele, alleato degli Stati Uniti nella zona e occupante arbitrario della Cisgiordania palestinese. La situazione per i palestinesi, senza che nessuno possa permettersi di parlare d’integralismo religioso, rientra specificatamente nella coranica reazione al nemico che ha occupato la loro terra.
L’Iraq è obbligato a ritirarsi dal Kuwait per l’attacco militare americano del gennaio 1991, ma le truppe statunitensi rimangono in Arabia
Saudita. Gli americani non intendono lasciare le basi e, corrompendo il
governo, ignorano le proteste dei sauditi, suscitando la reazione ostile
dei vari capi tribù e degli ulema (dottori della legge islamica) che cominciano a simpatizzare con le posizioni contestatrici di Osama bin Laden. Anche in questo caso lo jihad è una reazione all’arbitraria volontà
americana di mantenere abusivamente le basi nel paese sacro all’Islam:
fatto considerato dai musulmani una violenza doppia.
Comincia il peregrinare di Osama bin Laden per i paesi islamici inseguito dalle condanne del suo paese e dai servizi segreti americani e
israeliani. I suoi mezzi, però, sono molto più potenti di quelli che aveva a disposizione Giuseppe Mazzini. Utilizzando i numerosi ex combattenti afghani che teneva segretamente a sua disposizione a Medina
e alla Mecca, bin Laden organizza una serie di attentati contro gli in-
67
teressi degli Stati Uniti, cominciando a pensare ad uno Jihad globale
per combattere gli occupanti del suo paese e, per estensione, nemici di
tutto il mondo arabo e musulmano. Per comprendere la legittimità politica di questa posizione, è necessario ricordare lo stretto legame culturale e religioso che in Medio Oriente c’è nei concetti di Stato, nazione araba e comunità islamica. Purtroppo, la politica occidentale ha
sempre fatto finta d’ignorare questa complessità culturale e, utilizzando i propri parametri, ha creato mille contraddizioni.
Le attività sovversive di bin Laden appaiono intollerabili al regime
saudita che lo costringe ad abbandonare il paese. Dopo un controllo alle installazioni logistico-militari di al-Qaeda che teneva in Afghanistan, bin Laden si rifugia in Sudan, governato con mano di ferro da un
regime militare islamista. Nel paese africano bin Laden continua a far
crescere al-Qaeda con i mezzi finanziari delle sue aziende e società che
operano legalmente e che crescono pure in Sudan dove il governo lo
autorizza a partecipare a parecchie gare per una serie di importanti
opere pubbliche.
Inizialmente, l’organizzazione sovversiva ha una portata potenziale
contenuta perché bin Laden limita lo Jihad all’azione puramente militare e non ritiene di estenderla alla propaganda politica e alla mobilitazione civile: l’obiettivo era buttar fuori i nordamericani dal suo paese.
Pian piano, però, al-Qaeda assume una dimensione complessa ed
imponente dopo aver integrato all’apparato militare una struttura diplomatica, denominata Fronte islamico internazionale, che assume il
compito di coordinare i rapporti con i leaders delle varie organizzazioni estremiste di oltre 40 paesi islamici. Aderiscono anche molti capi dei
gruppi veterani della guerra dell’Afghanistan risentiti contro gli Stati
Uniti perché, conseguito l’obiettivo di mandare a casa i sovietici, si
erano disinteressati del loro paese.
Questo coordinamento senza precedenti di cospiratori politici e di
martiri d’Allah, che comprende anche gruppi di fanatici che violentano i precetti dell’Islam per adeguarli al proprio estremismo, si consolida lungo gli anni novanta, pur se molti gruppi radicali islamici e molte organizzazioni indipendentistiche (Palestina, Cecenia, Kurdistan,
ecc.) mantengono i propri obiettivi nazionali che raccolgono maggiore
partecipazione popolare.
Nel 1992 al-Qaeda è pronta per attaccare obiettivi statunitensi. Il 29
68
dicembre un lavoratore yemenita ed un turista austriaco muoiono in un
attentato contro un albergo di Aden usato da militari statunitensi. Il 26
febbraio del 1993 a New York, un’autobomba posteggiata nel parcheggio sotterraneo delle Torri Gemelle del complesso Word Trade
Center uccide sei persone e ne ferisce molte di più. L’FBI cattura e
condanna gli esecutori materiali ed il presunto organizzatore dell’attentato, un predicatore abituale nella Moschea del New Jersey, ma non
fa ancora alcun riferimento ad un possibile collegamento con al-Qaeda. Le Agenzie di sicurezza degli Stati Uniti cominciano a tener d’occhio l’onnipresente attivista saudita e lo scrivono nella loro lista nera.
La CIA apre un dossier a luglio del 1993. A bin Laden è attribuito anche un intervento indiretto nell’abbattimento di due elicotteri e la morte di una decina di soldati dell’esercito degli Stati Uniti il 4 ottobre del
1993 a Mogadiscio nel corso di un intervento militare in Somalia: si
sospetta che siano stati utilizzati missili Stinger terra-aria (un’altra
conseguenza indesiderata dell’armamento massiccio dei mujahiddin
afghani da parte degli Stati Uniti) forniti da al-Qaeda.
Nel 1994 bin Laden è privato della nazionalità saudita, diventa un
apolide ma non si ferma: al-Qaeda assume il dichiarato obiettivo di
colpire i militari statunitensi in qualunque luogo del mondo e punire il
filoamericanismo della Casa saudita. Il 13 novembre 1995 un’autobomba esplode a Rijadh di fronte alla sede dei consiglieri militari americani della guardia nazionale saudita ed uccide cinque statunitensi. Il
25 giugno 1996 lo scoppio di un camion cisterna carico con una tonnellata di dinamite, vicino all’edificio al-Khobar di Dhahràn, causa la
morte di 19 statunitensi e parecchi feriti. Il regime saudita reagisce con
arresti massicci e con l’esecuzione dei colpevoli. Bin Laden raccoglie
la solidarietà alle sue iniziative fra gli Ulema e i capi religiosi critici
nei confronti della politica interna e diplomatica del re Fahd.
Negli Stati Uniti, Clinton firma una nuova legge antiterrorismo per
bloccare i conti bancari di persone e organizzazioni sospette di terrorismo. Il primo obiettivo di questa disposizione è il multimilionario saudita; la Corte federale di New York istituisce uno specifico ufficio investigativo contro bin Laden.
Settimane prima dell’attentato di Dhahràn, bin Laden abbandona il
Sudan per le pressioni del governo sudanese. Poco prima del suo trasferimento, come racconta Simon Reeve nel suo libro I nuovi sciacalli,
69
bin Laden è vittima di un attentato organizzato dal Mossad israeliano.
È curato sotto falso nome in un ospedale privato di Londra e, nell’agosto del 1996, ritorna in Afghanistan che, dalla caduta di Najibullah nel
1992, è un caotico campo di battaglia e di saccheggio nel quale comandanti mujahiddin e capi tribali lottano per il controllo del paese.
Si stabilisce a Jalalabad, da dove il 23 agosto 1996 lancia la sua dichiarazione di guerra agli Stati Uniti; il titolo completo è: Dichiarazione di guerra contro gli americani che occupano la terra dei due
luoghi santi. Per espellere gli infedeli dalla penisola araba.
La Dichiarazione inizia con una dettagliata elencazione dei massacri subiti dalle popolazioni islamiche in Iraq, Palestina, Libano, Tajikistan, Birmania, Kashmir, Assam, Filippine, Fatani, Ogadèn, Somalia,
Eritrea, Cecenia e Bosnia-Erzegovina. Protesta per l’arbitraria occupazione della “terra dei due luoghi santi” da parte delle truppe americane. Contesta il fatto che i “diritti umani” non siano rispettati dall’alleanza “sionista-crociata” nel trattamento dei musulmani: sono falsi
principi, afferma, che servono a coprire ipocritamente la prepotenza
dell’Occidente. Sollecita la comunità islamica – la Ummah – ad agire
unita contro questi nemici. Contesta i danni che l’aggressione continua
ha arrecato all’industria e all’agricoltura dei paesi islamici oltre al tentativo continuo di appropriarsi delle ricchezze petrolifere i cui prezzi
sono fissati nell’interesse dell’economia americana. Protesta per le
frontiere arbitrarie che le potenze imperiali europee hanno tracciato
per i paesi del Medio Oriente dividendo in piccoli stati senza precisa
determinazione nazionale creando un’enorme confusione che divide
l’Ummah. Invita i musulmani a non combattersi fra di loro per evitare
le conseguenze negative che elenca. Indica nello squilibrio del rapporto fra le forze armate la necessità della guerriglia veloce, segreta e a
sorpresa. Indica l’obiettivo di liberare i luoghi santi. Invita i giovani a
combattere fidando in Dio che premia chi muore per una giusta causa.
Il tutto con la continua invocazione di Allah, com’è normale nella cultura islamica, ricordando sempre che la Ummah per i musulmani ha lo
stesso valore che l’espressione “popolo ebraico” ha per gli ebrei o l’espressione “cristianità” ha per i cristiani, con l’aggiunta di un contenuto anche politico.
Firma la Dichiarazione con il suo nome completo e con l’indicazione della località dove si trova per esprimere la grave importanza
70
dell’avvenimento: OSAMA BIN MOHAMMED BIN LADEN, montagne dell’Hindukush, Khurasan, Afghanistan.
Nessuno, dopo averla letta, può affermare che sia la dichiarazione
di guerra di un fanatico esaltato. È una circostanziata denunzia delle
responsabilità occidentali e una precisa indicazione di obiettivi concreti: liberare i luoghi santi e recuperare serenità politica ed economica per i musulmani. Chi afferma che in questa dichiarazione di guerra
ci sia il fanatismo barbaro dell’“integralismo islamico” o non ha letto
la dichiarazione o è in malafede.
In quel frangente, Osama bin Laden è ospite del noto comandante
militare Ahmed Sheh Masud che, poco dopo, diventa suo nemico. Le
turbolente fazioni del nord, oltre a combattere fra di loro, da due anni
sono aggredite dalle province del sud, di maggioranza pasthun, da dove arriva un nuovo attore del conflitto, i Talebani. Questo movimento,
fondamentalista religioso e militare di base etnica quasi esclusivamente pasthun, è nato nelle scuole islamiche (talib significa studente) che
sostengono una rigida dottrina sunnita.
Tributaria ideologica ed economica del wahabbismo saudita, la rivoluzione talebana, con la sua predicazione ultrarigorosa contro la corruzione, l’arbitrarietà, e la secolarizzazione dei costumi, irrompe in Afghanistan e, nel settembre 1996, ne raggiunge il controllo militare con
i consensi di una popolazione nauseata dalle faide e dalle risse interminabili dei signori della guerra. Sono poste le fondamenta di uno Stato teocratico che diventa alleato naturale di bin Laden di cui condivide
l’odio per l’Occidente. L’alleanza è solida anche se per i Talebani l’antioccidentalismo nasce dall’integralismo religioso mentre per bin Laden è un fatto politico ed economico. L’ospite saudita riceve un trattamento da ospite speciale: i Talebani sono consapevoli dei possibili benefici reciproci non solo per le ricchezze e i sofisticati sistemi di comunicazione e di elaborazione di cui bin Laden dispone ma anche per
le sue relazioni internazionali.
In questa situazione ambientale favorevole, bin Laden organizza
campi di addestramento di guerriglieri, si dota di una guardia del corpo speciale selezionata fra gli uomini migliori e consolida un rapporto
personale con Mohammed Omar Akhmed, leader spirituale, e quindi
anche politico, del movimento talebano.
Nel maggio del 1997 concede un’intervista alla CNN nella quale
71
espone le ragioni politiche, culturali ed economiche che hanno determinato la sua dichiarazione di jihad contro gli statunitensi per le truppe ancora dislocate nel suo paese. Nella stessa intervista accusa la dinastia saudita di tradimento degli interessi del paese e della comunità
islamica: ancora una volta, esprime precise posizioni politiche senza
alcun riferimento integralista.
Nel febbraio del 1998, a Khost, bin Laden organizza un vertice
dei leaders di alcuni gruppi nazionalisti segreti, qualificato dai commentatori occidentali una vera “internazionale terrorista”. In questa
occasione, conosce il leader della jihad islamica egiziana, Ayman alZawahiri, con il quale stabilisce un fermo rapporto di collaborazione. È costituito il Fronte Internazionale Islamico di cui al-Qaeda è
parte. Benché bin Laden non sia un alim (singolare di ulema), assieme agli altri capi emette la famosa fatua la cui lettura può confermare o smentire la convinzione diffusa che il più fanatico integralismo
religioso guidi la sua attività. Questo riscontro del senso letterale delle sue dichiarazioni e dei suoi documenti scritti dovrebbe esser fatto
sempre direttamente per evitare di affidarsi alle più o meno interessate affermazioni di mistificatori o di ingenui che, in un senso o in un
altro, parlano per sentito dire.
Nella fatwa, emessa “contro gli ebrei e i crociati”, è possibile rilevare in quali termini sono precisati i motivi che impongono ai musulmani di agire.
Sia lodato Allah, che rivelò il Libro, che controlla le nuvole,
sconfigge il settarismo e dice nel Libro: “Ma quando sono passati i
mesi proibiti, allora combattete e uccidete i pagani dovunque li trovate, catturateli e assediateli e fate loro agguati con ogni stratagemma”; e la pace si posi sul Profeta, Mohammed bin-Abdallah, che disse: “Io sono stato mandato con la spada fra le mie mani per far sì che
nessuno venga adorato tranne Dio, Dio che ha fatto della mia lancia
il motivo della mia vita e che infligge umiliazione e disprezzo su coloro che disobbediscono ai miei ordini”. La penisola arabica, da
quando Dio l’ha fatta pianeggiante, vi ha creato il deserto e l’ha circondata con il mare, non è mai stata presa d’assalto da forze simili
agli eserciti di crociati che ora vi si diffondono come locuste, divorando le sue ricchezze e distruggendo le sue coltivazioni. E questo
succede in un tempo in cui le nazioni attaccano i musulmani come
72
persone che litigano per un piatto di cibo.Alla luce della grave situazione e della carenza di aiuti, noi tutti siamo costretti a discutere degli eventi attuali e dovremmo tutti metterci d’accordo sulla soluzione delle questioni.
Nessuno può negare, oggi, tre fatti che sono noti a chiunque: li
elencheremo, così da ricordarli a tutti.
In primo luogo, da oltre sette anni gli Stati Uniti occupano la terra
dell’Islam nel più sacro dei luoghi, la penisola arabica, saccheggiandola e dando ordini ai suoi governanti, umiliando il suo popolo, terrorizzando i suoi vicini e trasformando le proprie basi nella penisola in
avanguardie per l’attacco ai vicini popoli musulmani.
Alcuni in passato hanno obiettato che quella americana non è
un’occupazione, ma oramai tutto il popolo della penisola è d’accordo
su questo.
La migliore prova è la continua aggressione degli americani contro
il popolo iracheno, aggressione che utilizza la penisola come scalo, nonostante i suoi governanti siano contrari a che i loro territori vengano
utilizzati a tale scopo; ma essi non possono nulla.
In secondo luogo, nonostante la grande devastazione inflitta al popolo iracheno dall’alleanza crociato-sionista e nonostante l’enorme numero delle persone uccise, che ha superato il milione, nonostante tutto
questo, gli americani stanno tentando ancora una volta di ripetere i loro orribili massacri, come se non si accontentassero del lunghissimo
embargo imposto dopo quella guerra feroce, o della frammentazione e
della devastazione. Vengono per annichilire ciò che rimane di quel popolo e per umiliare i loro vicini musulmani.
Terzo, che lo scopo degli americani sia in queste guerre religioso o
invece economico, il loro scopo è anche di servire gli interessi dell’insignificante stato ebraico e di distrarre l’attenzione dalla loro occupazione di Gerusalemme e dallo sterminio degli arabi della Palestina.
Le migliori prove di questo sono la loro brama di distruggere l’Iraq, lo stato arabo vicino più forte, e i loro sforzi di frammentare tutti
gli stati della regione come l’Iraq, l’Arabia Saudita, l’Egitto e il Sudan
in staterelli di cartapesta, e di garantire, attraverso la loro divisione e
debolezza, la sopravvivenza d’Israele e la continuazione della brutale
crociata di occupazione della penisola.
Tutti questi crimini e peccati commessi dagli americani sono una
chiara dichiarazione di guerra contro Dio, contro il suo Messaggero e
contro i musulmani. E, in tutta la storia islamica, gli Ulema si sono dichiarati d’accordo sul fatto che lo jihad è un dovere individuale, se i
73
nemici distruggono i paesi musulmani. Questo è stato rivelato dall’imam bin-Qamadah nell’Al-Mughni, dall’imam Al-Kisa’i nell’Al-bada’i,da Al-Qurtubi nei suoi commenti e dallo sceicco di Al-Islam nei
suoi libri, dove dice: “Per quanto riguarda la lotta per cacciare [un nemico], essa ha lo scopo di difendere la santità e la religione, ed è un
dovere, come sostengono [tutti gli Ulema]. Niente è più sacro della fede tranne cacciare un nemico che danneggia la religione e la vita”.
Sulla base di tutto questo, e in osservanza degli ordini di Allah,
proclamiamo la seguente fatwa per tutti i musulmani:
La risoluzione di uccidere gli americani e i loro alleati, civili e
militari, è un dovere individuale per ogni musulmano, che può
espletarlo in ogni paese in cui è possibile farlo, allo scopo di liberare la moschea di Al-Aqsa e la Moschea Sacra [della Mecca] dalla loro presa e allo scopo di scacciare i loro eserciti da tutti i paesi dell’Islam, sconfiggendoli e rendendoli incapaci di minacciare anche
un solo musulmano. Questo in accordo con le parole di Dio Onnipotente: “E combattete uniti i pagani come loro combattono uniti
tutti voi”, e: “Combatteteli fino a che non vi sia più turbamento e
oppressione, e fino a che prevalgano la giustizia e la fede in Dio”.
A questo si aggiungano le parole di Dio Onnipotente: “E perché
non dovreste combattere, per la causa di Dio e di coloro che, essendo deboli, sono umiliati e oppressi: le donne e i bambini che gridano: “Signore Dio, portaci in salvo via da questa città, popolata da tiranni, e manda qualcuno che ci aiuti”?”
Noi, con l’aiuto di Dio, facciamo appello ad ogni musulmano
che creda in Dio e desideri la sua ricompensa affinché si conformi
all’ordine di Dio di uccidere gli americani e di spogliarli del loro denaro ovunque e in qualunque momento essi li trovino. Facciamo appello anche agli Ulema, ai governanti,ai giovani e ai soldati musulmani affinché scatenino la lotta contro Satana – le truppe americane
– e contro i loro diabolici alleati e sostenitori, e destituiscano coloro che li governano, così che abbiano la loro lezione.
Dio Onnipotente dice: “O voi che credete, rispondete a Dio e al
Suo Apostolo, quando Lui vi chiama a ciò che vi darà la vita. E sappiate che Dio viene tra un uomo e il suo cuore, e che sarà in Lui che
voi tutti sarete riuniti”.
Dio Onnipotente dice anche:”O voi che credete, che vi succede?
Quando vi si chiede di procedere nella causa di Dio, vi aggrappate
così saldamente alla terra! Preferite la vita di questo mondo o la vita dell’altro? Ma piccolo è il conforto di questa vita, se paragonato
74
con l’altra. Se non procederete, Lui vi punirà con pene severe, e
metterà altri al vostro posto; ma voi non vorrete nuocere a Lui, che
detiene il potere sopra tutte le cose”.
Dio Onnipotente dice anche: “Non perdetevi d’animo, non cadete
nella disperazione. Perché se la vostra fede è pura otterrete il dominio”.
Osama bin Mohammed bin Laden
Ayman Al-Zawahari
Abu Yassir rifa’i Ahmed Taha
Mir Hamzah
Fazlur Rehman
La considerazione che è doveroso fare immediatamente è che una
lettura serena della fatwa, come anche della dichiarazione di guerra del
1996 e di tutti i successivi appelli e dichiarazioni di bin Laden, non
consente di rilevare nessuna espressione che possa esser fatta risalire
al wahhabismo. C’è, ed ovvio, la retorica invocazione di Dio che è tradizionale nella cultura araba. Ma non c’è nessun invito al recupero della rigidità medievale dei principi islamici e non c’è nessuna condanna
della modernità civile e tecnologica dell’Occidente. C’è la condanna
morale del comportamento occidentale nei confronti del mondo islamico: è ovvio; è la ragione della guerra. Creare confusione in Occidente fra la guerra di bin Laden e le iniziative wahhabiste, espresse
dentro e fuori i paesi musulmani, è una pratica scorretta che impedisce
di affidare alla ragione la soluzione dei problemi posti dalla reciproca
violenza. È una mistificazione che vuole coprire la volontà di non risolvere i problemi denunziati: gli ingenui disinformati abboccano.
La fatwa ha, invece, un efficace riscontro positivo nel mondo islamico nel quale crescono i sostenitori di bin Laden.
Nell’agosto 1998, nell’anniversario dell’arrivo delle prime truppe
statunitensi in Arabia Saudita, sono fatti esplodere micidiali ordigni
contro le ambasciate americane di Nairobi e di Dar el Salam, capitali
del Kenia e Tanzania. I morti sono 224, dodici dei quali di nazionalità
americana, parecchie centinaia i feriti. Uno sconosciuto Esercito Islamico di Liberazione dei luoghi Santi rivendica gli attentati. Però, è
convinzione generale che dietro la sigla ci siano gli uomini di bin Laden e Zawahiri.
75
Gli Stati Uniti minacciano di rappresaglia tutti i paesi che possano
dare rifugio o tollerano nel loro territorio le attività cospirative di bin
Laden, che diventa l’uomo più ricercato del mondo: Afghanistan e Sudan capeggiano la lista nera dei paesi sotto minaccia.
Il 20 agosto 1998 navi da guerra degli Stati Uniti dall’Oceano Indiano lanciano missili di crociera contro presunti obiettivi terroristi vicino Khartum e Khost, dove si sospettava che si trovasse bin Laden: i
morti sono una trentina.
La rappresaglia statunitense provoca la protesta del governo sudanese: era stata distrutta l’industria chimica di ash-Shifa che produceva
non componenti per armi chimiche, come sostenuto dagli americani,
ma medicinali. Dato confermato dall’ONU che aveva contattato la fabbrica per produrre medicine destinate all’Iraq.
I danni nell’area di Khost non danneggiano le strutture di al-Qaeda
e non intimidiscono bin Laden che riceve ulteriori attestazioni di appoggio ma anche l’invito dei Talebani ad astenersi da altre pubbliche
dichiarazioni.
Il 4 novembre 1998 la Corte federale statunitense dichiara formalmente bin Laden e il suo luogotenente Mohammmed Atef – un ex poliziotto egiziano descritto dagli esperti come lo stratega militare di Al
Qaeda – responsabili degli attacchi alle ambasciate di Nairobi e Dar el
Salam. L’FBI offre una taglia di cinque milioni di dollari a chi possa
dare notizie utili per l’aresto di bin Laden e ne chiede l’estradizione all’Afghanistan. Il Tribunale supremo dei Talibani respinge la richiesta
perché non esiste un trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti che non hanno neppure riconosciuto il governo afghano: bin Laden
è libero di svolgere in Afghanistan tutte le attività che ritiene opportune. Si rafforza la solidarietà fra bin Laden e il mullah Omar del quale
probabilmente il saudita è il più ascoltato consigliere nella gestione del
potere.
È rifiutato agli Stati Uniti il passaggio attraverso l’Afghanistan di
un oleodotto dal Turkmenistan verso il Pakistan: la famiglia Bush è interessata a questo oleodotto. Il Governo Clinton ottiene la condanna
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU degli attentati di Nairobi e Dar es
Salam. La risoluzione condanna anche la violazione dei diritti umani
da parte dei Talebani soprattutto verso le donne. Sono poste così le premesse per consentire agli Stati Uniti di invadere l’Afghanistan.
76
Dopo il bombardamento di Khost, bin Laden si rende conto del fatto che la tecnologia satellitare americana è in grado di captare e localizzare le sue telefonate e adotta trasmissioni mobili via Internet: la tecnologia aiuta la sua attività di cospirazione contro gli statunitensi.
Anche nell’ottobre 2000: un ordigno telecomandato distrugge la
nave da guerra americana Cole di stanza nello Yemen: muoiono 17 marinai. Per l’audacia tecnologica dell’attentato, la Casa Bianca ritiene
bin Laden responsabile.
Agosto 2001: bin Laden segnala al giornale pubblicato a Londra Al
Quds al-Arabi un imminente attacco agli Stati Uniti “molto, molto
grande, senza precedenti”. I servizi di sicurezza americani si mettono
in allarme, ma non riescono ad immaginare cosa si prepara.
11 settembre 2001. Alle ore 9 del mattino le torri del World Trade
Center, le Twuin Towers di New York, sono colpite da due aerei di linea dirottati e, dopo qualche minuto, collassano. È una catastrofe che
supera qualsiasi immaginazione: per arditezza di progettazione e di
realizzazione; per la spettacolarità dell’impatto mediatico; per l’efferatezza delle conseguenze. I morti sono quasi tremila; le vittime appartengono a ben 62 paesi: il mondo è stupefatto ed inorridito.
Un’ora dopo l’attacco, mentre tutta l’attenzione è concentrata su
New York, un terzo aereo è dirottato e proiettato in picchiata contro il
Pentagono, sede del Ministero della difesa statunitense, considerato il
luogo più vigilato del mondo. I danni sono rilevanti. Un quarto aereo
dirottato, per la reazione di alcuni passeggeri, non riesce a raggiungere il suo obiettivo e precipita: l’obiettivo probabile era la Casa Bianca
o il Campidoglio di Washington.
L’impatto emotivo sull’opinione pubblica mondiale, anche per la
varietà delle reazioni, è oltre ogni possibile descrizione. La massima
allerta disposta dalle Forze armate navali ed aere disposte dai Comandi americani è rimasta senz’alcuna iniziativa utile possibile. Il 12 settembre il Consiglio di Sicurezza dell’ONU approva la risoluzione
1.368 che condanna l’attacco. La Nato attiva il dispositivo di difesa
collettiva previsto dal Trattato. Quasi tutti i paesi del mondo esprimono solidarietà agli Stati Uniti.
Dopo l’undici settembre nessun avvenimento appare più eccezionale. La guerra all’Afghanistan con decine di migliaia di morti civili,
l’embargo all’Iraq con la conseguente crisi alimentare e sanitaria, gli
77
attentati vari per il mondo con decine di morti civili, i conflitti etnici in
Africa con milioni di morti, la guerra americana all’Iraq con decine di
migliaia di civili massacrati, l’attentato alle stazioni ferroviarie spagnole con numerosi civili dilaniati: la dimensione assurda della violenza, che sembra voglia travolgere il mondo, è ormai accettata come
normale.
Solo la tragedia di Beslan, nel 2004, con i bambini che tentano di
fuggire fra due fuochi, riesce a scuotere nuovamente le coscienze.
Il mondo è ormai diviso pro o contro bin Laden: contro il terrorismo, dicono da una parte; in difesa dei popoli emarginati, rispondono
dall’altra parte.
Dall’undici settembre 2001, i servizi segreti di tutto il mondo cercano di far luce sulla ragnatela dei rapporti instaurati da bin Laden attraverso al-Qaeda. Nell’incertezza più grande, è diffuso un elenco di
organizzazioni con dati imprecisi sugli obiettivi, sulla forza organizzativa e sugli effettivi rapporti con bin Laden e al-Qaeda. Sarebbero alleati di al-Qaeda la Jihad islámica egiziana, il Gruppo Islámico Armato (GIA) in Algeria, in Palestina il Movimento Hamás, la Jihad Islamica, le Armate di al-Acsa; in Libano il Partito di Dio Hezbollah, in
Pakistan l’Esercito del Profeta, in Kashmir il gruppo Jamiat Ulema-eIslam (JUI), in Bangladesh il Movimento della Jihad Islámica. Al Qaeda ha certamente contatti con il gruppo filippino di separatismo musulmano Abú Sayyaf, in Cecenia con il comandante Shamil Basáyev y
Omar ibn al-Khattab (probabilmente veterano dell’Afganistan con bin
Laden), in Uzbekistán con il Movimento Islamico Uzbeko. È certo, in
ogni caso, che bin Laden ha avuto ripetuti contatti con tutti i gruppi
sovversivi anche non islamici del mondo. Europa compresa.
La prudenza sulla fondatezza delle informazioni è doverosa. Rimane il fatto che, per il “successo” dell’undici settembre e per le tecnologie e i mezzi finanziari di cui dispone, al-Qaeda è diventata un’organizzazione presente in tutto il pianeta. Probabilmente non come centro di una struttura organica ma come punto di riferimento delle simpatie del mondo “altro” e delle sue organizzazioni sovversive. Quando
si parla di organizzazioni “sovversive”, si ricordi che, nel diciannovesimo secolo, Giuseppe Mazzini era considerato da tutte le polizie
d’Europa come il “sovversivo” più pericoloso.
È possibile che uno degli innumerevoli killers professionali messi
78
sulle orme di bin Laden dalla CIA statunitense e dal Mossad israeliano possa riuscire ad ucciderlo: non cambierebbe nulla, perché bin Laden è ormai riuscito a far assumere a tutto il mondo islamico la consapevolezza delle ragioni di una lotta radicalmente necessaria. La violenza potrà essere fermata solo da una capacità di dialogo che all’orizzonte ancora non s’intravede.
Nella confusione delle notizie che vengono diffuse, la pubblicistica
occidentale meno obiettiva attribuisce a tutte le iniziative nazionalistiche musulmane e a tutte le posizioni panarabe o panislamiche un totalizzante e generico contenuto di terrorismo criminale che è assolutamente ingiustificato ed arbitrario. La violenza di un integralismo religioso, nella confusione degli avvenimenti, è certamente presente. Ma
la generalizzazione che qualifica tutto come terrorismo integralista è
un’impostazione che rischia di avviare una pericolosa caccia alle streghe: i criminali irrazionalmente estremisti sono presenti in questo momento d’irresponsabile violenza planetaria; ma non si trovano sempre
e tutti da una sola parte.
Ancora oggi, nella storia che s’insegna in Austria, Giuseppe Mazzini non è indicato come una figura positiva: per l’Italia, è l’apostolo
della sua unità. Fra qualche decina di anni e dopo che sarà morto, non
è difficile pensare che Osama bin Laden, che ha rinunziato agli agi della vita comoda di un multimiliardario per andare esule e battersi per
cacciare gli americani dal suo paese, per l’indipendenza nazionale effettiva dei paesi arabi e il rispetto del mondo islamico, possa essere ricordato dai musulmani come l’apostolo del riscatto della loro dignità
Il problema è cercare di comprendere fino a che punto possano avere ragione o torto.
3. Considerazioni conclusive
Nessun confronto è possibile fra l’attività di Giuseppe Mazzini e
quella di Osama bin Laden se non si tiene conto dei seguenti fattori:
– il diverso temperamento dei due uomini con la conseguente maggiore o minore enfasi espressiva e la diversa capacità d’iniziativa;
– la diversa cultura generale con la conseguente diversità di argomenti;
79
– il normale, continuo riferimento a Dio di ogni azione umana nell’islamismo;
– il diverso contesto ambientale e il sentimento di vicinanza etnicoreligiosa fra i popoli arabi che non c’è fra i popoli europei;
– la distanza di oltre un secolo fra le due vicende con tutte le conseguenze sull’ampiezza dei movimenti e delle relazioni possibili, determinate dai differenti mezzi di comunicazione;
– la differenza conseguente al fatto che: Mazzini lottava contro nemici che usavano armi tradizionali; bin Laden deve adeguarsi non
solo alla violenza della guerra moderna ma anche ai sistemi di sovversione, corruzione e condizionamento dei governi che usa la CIA;
– la differenza, infine, fra le tecnologie disponibili che oggi consentono iniziative anche spettacolari oltre che sorprendentemente violente.
E, tuttavia, pur poste queste differenze, rimane ferma da parte di
molti la contestazione di questo confronto fondata sulla considerazione che Giuseppe Mazzini non organizzava i suoi tentativi insurrezionali uccidendo e terrorizzando civili inermi.
È un fatto inoppugnabile. Ma, non può essere ignorato di contro l’aspetto fondamentale che caratterizza la violenza nei due diversi secoli.
Al tempo di Mazzini, nel diciannovesimo secolo, la parola “guerra”
presupponeva ancora specifiche premesse formali diplomatiche e precisi limiti determinati dalla dislocazione fisica certa degli eserciti: i
fronti erano ben definiti e la violenza coinvolgeva soltanto i militari e
le popolazioni che abitavano nelle aree delle battaglie e nei territori
lungo i quali si muovevano le forze armate.
Con l’avvento dell’aereo, già da oltre settant’anni, la “guerra” è radicalmente cambiata: l’attacco di sorpresa si è affermato e il fronte è
diventato qualsiasi luogo nel quale ci siano interessi umani, economici, politici e culturali dei contendenti. Nelle scuole militari aeronautiche dei paesi “cristiani” dell’Occidente si apprende che «i bombardamenti aerei notturni hanno l’obiettivo di cogliere di sorpresa nel sonno
le popolazioni civili per atterrirle e fiaccarne la resistenza fisica distruggendo gli acquedotti, le centrali elettriche, le stazioni ferroviarie
e tutte le strutture civili per impedirne anche ogni resistenza morale».
Questo criminale postulato della strategia militare, che l’Occidente ha
80
© ARMANDO EDITORE. La fotocopia non autorizzata è reato.
messo a punto e che viene regolarmente applicato, ha travolto ogni
ideale affermazione che esistano “regole d’onore” oltre le quali ci sarebbe l’infamia.
Giusto o sbagliato che sia, dopo le città inglesi, italiane e tedesche
rase al suolo nella seconda guerra mondiale con centinaia di migliaia
di civili inermi massacrati, dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki dove i civili sono morti a milioni, immediatamente o a
seguito delle radiazioni, dopo la deforestazione e la distruzione dei villaggi del Vietnam con il napalm incendiario e dopo i massacri che in
tutti i continenti hanno accompagnato lo svolgersi degli ultimi cinquant’anni, nessun belligerante nel mondo ha l’autorità morale per sostenere quali siano i principi morali invalicabili di una guerra. Non ci
sono più fronti definiti, non ci sono più “civili” che possano essere ritenuti al sicuro da ogni forma d’aggressione.
Qualsiasi iniziativa anche proditoria è consentita dal fatto che niente è più proditorio del bombardamento improvviso e notturno delle
città con centinaia di migliaia di civili inermi e con decine di migliaia
di morti certi. Oggi, poi, il bombardamento di obiettivi civili è quanto
di più efferato si possa immaginare perché è effettuato con bombe all’uranio impoverito le cui radiazioni aggrediscono la popolazione civile oltre ogni ipocrita assicurazione di bombardamenti mirati.
Tutte le forme d’aggressione sono entrate in una spirale di violenza
che nessun belligerante può permettersi di contestare con un qualche
argomento che voglia riferirsi a principi di umanità.
Quando un paese potentemente armato impone obblighi ad un paese debole con il ricatto costituito dalla minaccia di massacrarlo nelle
sue strutture civili con la sua potenza militare ed aerea, quali limiti
possono essere posti alle più varie ipotesi di reazioni alternative che il
paese debole può tentare di mettere in atto? È doloroso doverlo costatare, ma nessun limite morale è più accettato: chi non ha aerei – in questa feroce realtà che è il mondo di cui solo gli ipocriti fanno finta di
non rendersi conto – sceglie legittimamente la guerriglia, gli attentati,
i sequestri umani, gli scudi umani e ogni altra iniziativa che possa mettere in difficoltà il nemico militarmente più potente. Chi conduce la
sua guerra con questi mezzi – e bin Laden ha ufficialmente dichiarato
guerra agli USA e ai loro alleati – è meno immorale di chi fa la guerra con gli aerei: i morti da guerriglia e da attentato sono un numero
81
quasi sempre “insignificante” rispetto alle migliaia di morti dei bombardamenti aerei.
Esprimere giudizi morali, che non tengano conto di queste considerazioni su ciò che oggi è la guerra, è da presuntuosi: chi considera
legittimo massacrare gli avversari con i più proditori bombardamenti
aerei e ritiene di poter condannare moralmente soltanto le ugualmente
proditorie iniziative altrui è o un ingenuo che si è fatto convincere da
una qualche pressione mediatica o un ipocrita moralmente confuso che
sostiene interessi indifendibili.
Prendere atto che questa è l’attuale realtà umana è amaro. La dettagliata elencazione dei massacri subiti dalle popolazioni islamiche, che
bin Laden fa nella sua dichiarazione di guerra agli Stati Uniti, con la
denuncia di centinaia di migliaia di vittime civili inermi, gli fa affermare che l’Occidente non ha l’autorità morale per condannare le sue
rappresaglie. I “diritti umani”, dice e scrive bin Laden, sono un inganno ipocrita se hanno valore solo per gli occidentali.
Assunta la consapevolezza della gravità delle contestazioni che bin
Laden muove agli Stati Uniti e all’Occidente in termini di massacri civili, è meno difficile rendersi conto delle ragioni che hanno determinato in Mazzini e bin Laden una violenza a prima vista così macroscopicamente diversa: Mazzini sosteneva diritti; bin Laden sostiene diritti e contesta massacri.
La verifica di una certa coincidenza intellettuale fra i due, dopo, è
facilitata da un attento confronto dei contenuti del giuramento dei militanti della Giovine Italia con i contenuti della fatwa posta a fondamento delle iniziative di al-Qaeda:
1 – L’invocazione a Dio, il ricordo della penisola arabica, l’attacco
delle locuste al piatto di cibo dei musulmani, l’umiliazione dell’Arabia
sacra da parte delle basi militari americane, le aggressioni agli altri popoli arabi, il diritto-dovere del musulmano di opporsi a chi distrugge i
paesi musulmani – che sono l’oggetto del prologo della fatwa non sono che l’esposizione, nell’ampollosità araba, degli uguali, corrispondenti, letterali argomenti della premessa al giuramento della Giovine
Italia: “Dio padre della libertà, la patria infelice, i secoli di servaggio
che la contristano e le catene che mi circondano, i tormenti sofferti dai
fratelli italiani, i diritti individuali e sociali che costituiscono l’Uomo,
le memorie dei padri”.
82
Entrando nel corpo dei due documenti e citando per primo il testo
della fatwa, possiamo verificare che:
2 – “uccidere gli americani e i loro alleati, civili e militari, è un dovere individuale per ogni musulmano, che può espletarlo in ogni paese in cui è possibile farlo” corrisponde quasi alla lettera a: “giuro di
spegnere col braccio e infamar con la voce i tiranni e la tirannide politica, civile o morale, cittadina o straniera”;
3 – “liberare la moschea di Al-Aqsa e la Moschea Sacra (della Mecca) dalla loro presa” corrisponde a: “consacrare il pensiero, la parola e
l’azione per conquistare indipendenza, unione, libertà all’Italia”;
4 – “combattere uniti i pagani come loro combattono uniti tutti voi”
può corrispondere a: “combattere in ogni modo le ineguaglianze fra gli
uomini”;
5 – “combatteteli fino a che vi sia turbamento e oppressione, e fino
a che prevalgano la giustizia e la fede in Dio” corrisponde a “(giuro di)
promuovere con ogni mezzo l’educazione degli italiani alla libertà e
alla virtù che la fanno eterna”;
6 – “combattere per la causa di Dio e di coloro che, essendo deboli, sono umiliati ed oppressi” corrisponde a: “soccorrere con l’opera e
col consiglio qualunque m’invocasse fratello”;
7 – “facciamo appello ad ogni musulmano che creda in Dio e desideri la sua ricompensa affinché si conformi all’ordine di Dio di uccidere gli americani” corrisponde a “(giuro) di ubbidire agli ordini e alle istruzioni che mi verranno trasmesse”;
8 – “non perdetevi d’animo, non cadete nella disperazione” corrisponde a: “ non rivelare, per seduzione o per tormenti, l’esistenza, le
leggi, lo scopo della federazione”
9 – “se la vostra fede è pura otterrete il dominio” conclude la fatwa
mentre il giuramento mazziniano conclude: “sulla mia testa l’ira di Dio
e l’abbandono degli uomini, l’infamia e la morte dello spergiuro, s’io
mancassi al mio giuramento”.
Forse, la frase finale della fatwa è più sobria della frase finale del
giuramento mazziniano che conclude con un’espressione enfatica per
scacciare il timore della sconfitta. La fatwa, però, prima della conclusione comprende anche il ricordo ai giovani islamici che morire in
guerra vuol dire entrare nella grazia di Allah.
Molti, la più gran parte degli occidentali, accusano di fanatico iste-
83
rismo integralista la fatwa appello del “terrorista” bin Laden. Confermano il giudizio? E, sono disposti a considerare anche Giuseppe Mazzini un fanatico “terrorista”? O si può convenire su un’evidente coincidenza di toni e d’intenti?
Accantonando il giudizio sulla violenza, che è da condannare da
qualunque parte venga espressa, è possibile limitarsi a valutare la legittimità delle attese e la dedizione alla causa?
Le vite dei due esuli e cospiratori hanno molti aspetti in comune: la
rinunzia ad una vita normale per una vita difficile, fatta di esili e di peregrinazioni da un paese all’altro per sfuggire alle condanne a morte;
fatta di rischi, di cospirazioni e di atti sovversivi; ma, soprattutto, vissuta con identica intensità religiosa per la speranza nazionale, con l’identico fervore di una decisa volontà di spegnere col braccio i tiranni,
come giura ogni neofita della Giovine Italia.
È fuori d’ogni dubbio che gli attentati attribuiti ad Osama bin Laden
siano di una violenza cento volte maggiore di quella dei patrioti italiani. Ma, a parte la differenza delle tecnologie disponibili, nessuno può
negare che questa violenza che uccide “pochi” civili inermi è niente rispetto alla violenza dei bombardamenti aerei che uccidono decine di
migliaia di civili inermi; è niente di fronte all’arroganza dei colpi di stato condotti dalla CIA con omicidi, sabotaggi e corruzione che distruggono democrazie politiche ancora incerte e fanno fare salti indietro alla maturità civile di paesi in via di sviluppo; è niente davanti alle guerre economiche condotte con gli strumenti del Fondo Monetario Internazionale, con le tariffe doganali e le fittizie norme di tutela igienica
che mettono nella miseria le popolazioni contadine di interi paesi cui
viene impedita l’esportazione dei manufatti mentre vengono derubati
dei prodotti agricoli e delle materie prime con prezzi stracciati imposti.
Certamente le iniziative di bin Laden sono esecrande. Ma chi le ritiene più gravi delle iniziative militari statunitensi, dei sistemi sovversivi della CIA e dei comportamenti economici di tutto l’Occidente o ha
un’informazione superficiale o è moralmente confuso.
Non manca, infatti, di portare un contributo alla chiarezza delle ragioni dell’una e dell’altra parte, la dichiarazione ufficiale di guerra di
Osama bin Laden del venerdì 23 agosto 1996 dalle montagne dell’Hindukush, Khurasan, Afghanistan. Da quella data, per chi voglia essere informato, alle pagine web <http://msanews.mynet.net//MSA84
NEWS/199610/19961012.3.html> e collegate, può trovare l’intera dichiarazione di bin Laden: può leggere e capire con la propria testa.
Si tratta di una pignola elencazione delle ragioni umane, politiche,
morali ed economiche per le quali è dichiarata la guerra agli Stati Uniti e ai suoi alleati in nome degli islamici di tutto il mondo.
Qualcuno, appigliandosi al fatto che in questa dichiarazione di
guerra è ripetuta l’invocazione ad Allah (che è nella normale tradizione arabo-islamica), ne contesta il presunto integralismo religioso: sarebbe istigazione allo jihad nel senso estremistico di “guerra santa”
integralista. Non è così: è certamente un invito allo jihad, ma nel senso di reazione all’aggressione come suggerisce il Corano ai musulmani che vogliano il rispetto della loro dignità. Le accuse elencate
nella dichiarazione di guerra sono assolutamente ragionevoli e laicamente fondate: decine di guerre si sono combattute in Europa per
molto meno.
Chi ha letto la dichiarazione di guerra del 1996 e la fatwa del 1998
ha potuto costatare che non riportano nessuna espressione che possa
essere considerata di ispirazione wahhabita: in bin Laden non c’è fanatismo integralista religioso; c’è vibrata indignazione contro i soprusi, gli arbitrii, le sopraffazioni e i massacri subiti dal mondo islamico.
Molti non sono d’accordo con una legittimazione delle ragioni di
bin Laden e devono essere ascoltati: la violenza, affermano, deve essere condannata. È incontestabile. Ma la condanna deve essere rivolta
verso tutte le violenze: chi finge di ignorare i violenti massacri di civili inermi dei bombardamenti aerei perde la dignità morale e non ha più
il diritto di esprimere condanne.
Vogliamo, allora, tentare di valutare i problemi sollevati da Osama
bin Laden e le sue iniziative con distacco storico?
Vogliamo avviare l’analisi distinguendo gli interessi economici,
culturali e demografici dell’Occidente dall’interesse morale di tutti ad
avere idee chiare su ciò che accade nel mondo?
Se non per impegnarci per un’improbabile pacifica convivenza
umana, almeno per avere un quadro della possibile prospettiva prossima ventura.
È necessario, allora, assumere il dubbio come guida della nostra ragione e costruirlo con argomenti opposti a quelli di chi è sicuro di avere certezze.
85
86
Capitolo quarto
Considerazioni conclusive
1. Argomenti controversi
Le note con le quali è stata brevemente ripercorsa la vita di Giuseppe Mazzini hanno mostrato quanto fosse inadeguato il senso degli avvenimenti in chi, in quel tempo, ne condannava le iniziative
sovversive.
Oggi, di fronte alla violenza degli attentati attribuiti a bin Laden
non si può che condannarne l’efferatezza. Ma, guardando la violenza con distacco scevro da paure e interessi, si deve approfondire la
legittimità o meno delle ragioni che purtroppo la stimolano.
L’inconciliabile contraddizione fra efferatezza e legittimità impone di essere prudenti.
Il tentativo di assumere una posizione distaccata ha qualche esitazione davanti alla drasticità dei giudizi morali a senso unico contro la violenza: la storia ha successivamente giustificato, e in qualche caso espressamente approvato, le violenze dell’Ottocento che,
andate a buon fine, hanno realizzato l’indipendenza nazionale dei
popoli europei e quella forma di democrazia politica che la cultura
europea ha elaborato.
Le violenze del nostro tempo sono uguali a quelle di quel secolo
dal punto di vista del danno alla serenità e alla sicurezza umana. La
differenza è nei modi della loro realizzazione tecnologica. Il problema storico è valutare la legittimità o meno che sta alla base delle iniziative.
Davanti alla confusione di giudizi e di posizioni sui fatti attuali,
può essere utile chiedersi come sia possibile che, nonostante il pres87
sante invito di Papa Giovanni Paolo ll ad impegnarsi per la pace e
per la solidarietà, una buona parte dei cattolici sia sulle posizioni irrazionali di una donna frustrata che, credendo di essere la giovanna
d’arco del ventunesimo secolo, incita alla guerra contro l’Islam.
Se le radici della violenza affondassero veramente e soltanto in
un humus culturale e religioso, nonostante la mistificante campagna
mediatica, la sensibilizzazione delle masse sarebbe rimasta più in
superficie e la partecipazione sarebbe stata meno attenta. La realtà è
che i più si sono resi conto del fatto che, in prospettiva, quanto sta
accadendo mette in gioco in modo preoccupante gli interessi economici, il benessere e la stessa prospettiva demografica dell’Occidente attuale e, soprattutto, quello delle prossime generazioni.
L’ancestrale istinto di conservazione ha preso il sopravvento e
l’analisi razionale è passata in second’ordine. Con il futuro dei figli
non si scherza: l’uomo regredisce ai suoi più brutali, egoistici, istintivi comportamenti animaleschi.
La gravità del momento ne impone una valutazione anche cinica
ma non inutilmente ipocrita o political correct. Per farlo, è preliminarmente utile chiarire, in un’analisi di argomenti controversi, il significato o il contenuto che queste pagine attribuiscono alle parole
d’uso più frequente nel confuso dialogo planetario nel quale nessuno sembra ascoltare nessuno: tutti abbiamo la verità su tutto.
L’analisi vuole suggerire di essere prudenti nel giudicare l’azione di Osama Bin Laden ed è fondata sul recupero di alcuni argomenti già ampiamente trattati dalla saggistica più informata che ha
posto in evidenza molte contraddizioni che da sempre l’Occidente
tenta di rimuovere.
All’inizio del glossario sono prese in considerazione anche
espressioni della cultura occidentale così radicate da apparire innocue mentre sono fra le cause non ultime dell’incomprensione con gli
“altri”, del loro odio e della loro reazione.
***
Tolleranza. Fin dai primi viaggi di Colombo, la derisione e la
sottovalutazione del modo d’essere delle altrui culture hanno fatto
crescere negli europei convinzioni molto superficiali che si sono co88
sì radicate da non essere più rilevate: pian piano la dignità umiliata
ha stimolato negli “altri” un rancore sordo e profondo.
La leggerezza etnologica occidentale ha continuato ad aggravare
l’incomprensione fino ai nostri giorni malgrado già nella prima metà
del secolo scorso gli studi di Levi-Strauss, compendiati nel suo relativismo culturale, cercassero di spiegare come ogni cultura sia un
‘’insieme’’ che non può essere valutato enucleando questo o quell’elemento, magari aberrante agli occhi di una cultura diversa, senza collegarlo a tutti gli altri che lo compensano e giustificano. È assurdo fare scale gerarchiche fra le culture, sostiene Levi-Strauss,
perché ognuna trova le proprie compensazioni al suo interno e tutte,
quindi, hanno pari dignità. È assurdo, anche, forzare l’immissione di
elementi di culture diverse che, non trovando un sistema di equilibrate compensazioni, potrebbero essere rigettati o potrebbero creare
le più imprevedibili disarmonie.
Però, nonostante l’impegno degli etnologi e degli antropologi, il
comportamento migliore, che la parte più sensibile della comunità
occidentale ha espresso per gestire i rapporti con le comunità con
valori e costumi diversi, è stato la ‘’tolleranza’’.
Anche se questa espressione è usata con la più assoluta buona fede ed ha assunto un valore positivo, in effetti letteralmente indica
‘’la capacità di tollerare, senza subire danni, quanto è o può essere
pericoloso o spiacevole”. La negatività dell’espressione, nel dialogo
con gli “altri”, sta nell’implicita presunzione di superiorità della cultura occidentale: i valori e i comportamenti delle altrui culture sono
“in ritardo” ma io, uomo occidentale, sono comprensivo e li “tollero’’.
Per reimpostare radicalmente il modo di rapportarsi degli occidentali con gli altri popoli del mondo, occorre ben altro: «Il rispetto
e l’amore deve estendersi a coloro che pensano ed operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche e persino religiose, poiché
con quanta maggiore umanità e amore penetreremo nei loro modi di
sentire, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un colloquio», dice la Gaudium et Spes (ll,28), Costituzione pastorale del
Concilio Vaticano ll, che dovrebbe essere continuamente ricordata
anche a molti cardinali della Curia di Roma.
Non serve la “tolleranza’’; è necessario il “rispetto’’: rispettare la
89
pari dignità delle idee e dei comportamenti altrui, comprendere che
la varietà delle culture è il contributo più costruttivo al patrimonio
umano e rieducare in profondità anche il linguaggio sono le conquiste che l’Occidente deve fare per recuperare quella correttezza umana, anche formale, che è urgente per affrontare quel dialogo che, prima o poi, dovrà far accantonare l’odio. Forse.
***
Uomo di colore. Per avere più chiare le ragioni che rendono difficile ogni dialogo, occorre ricordare i comportamenti determinati
dalla convinzione occidentale ancora molto diffusa secondo la quale la razza “bianca” europea sarebbe una razza “pura” superiore.
Questo pregiudizio resiste malgrado anche lo studio delle affinità
linguistiche, andando indietro nel tempo, abbia consentito alle
scienze antropologiche di dimostrare come le differenze umane nel
mondo siano il risultato di migrazioni complesse che già in tempi
non storici avevano determinato un’ibridazione reciproca vasta e
profonda: pur accettando la parola “razza”, ma soltanto in senso etnologico, dovrebbe essere definitivo per tutti che non esiste una razza umana biologicamente “pura».
In questo senso, oggi, la genetica e la microbiologia molecolare,
con lo studio del genoma umano, hanno dimostrato come fra i vari
tipi etnici umani, che appartengono tutti all’unico ceppo homo sapiens, non esistano differenze genetiche radicali ma soltanto differenze determinate nei millenni da fattori climatici, ambientali e culturali. Gli studi di Luca Cavalli Sforza sul cromosoma Y hanno consentito addirittura di ricostruire la genealogia dell’homo sapiens e
stabilire con certezza scientifica che tutti gli uomini viventi oggi nel
mondo hanno avuto origine da un iniziale piccolo gruppo che si è
espanso dall’Africa Orientale fra 100.000 e 50.000 anni fa: parlare
ancora di razze in senso biologico è soltanto una grave disinformazione.
Ferme queste considerazioni, è evidente quanto sia stato e sia ancora controproducente continuare a fermare l’attenzione sul colore
della pelle degli europei che, essendo ‘’bianco’’ indicherebbe un’implicita ‘’purezza’’. La biologia ha dimostrato come la diversa pig90
mentazione della pelle sia stata la conseguenza di mutazioni che
hanno accompagnato il diffondersi dell’uomo sulla terra per favorire l’assorbimento dei benefici arrecati dai raggi del sole o per opporre adeguata resistenza ai possibili danni.
In origine, l’affermazione che la nostra pelle fosse bianca, suggerita dal confronto con quella degli africani neri, è stata fatta certamente senza intenti discriminatori e con spontanea immediatezza.
Dopo, andando per i continenti, gli europei hanno attribuito alla pelle delle genti che incontravano i colori più vari: gialli, rossi, bruni,
olivastri, neri. Pian piano, convinti della superiorità della loro civiltà, hanno cominciato a ritenere di essere una razza superiore ed il
colore bianco della pelle è stato considerato un elemento di distinzione che confermava questa presunta superiorità: la «razza bianca»
sarebbe stata l’unica razza «pura», che non doveva mischiarsi alle
altre per non contaminarsi. Il bianco, infatti, nell’inconscio collettivo occidentale è anche il colore della purezza e della sacralità religiosa.
Così oggi i bianchi meno avveduti non vogliono ancora accettare che è finito il tempo dei paesi a popolazione esclusivamente bianca anche per l’Europa, dove si prevede che, mantenendo le attuali
tendenze, entro cento anni i cittadini di origine extraeuropea supereranno la percentuale degli abitanti autoctoni come già è accaduto
a New York dove, con il censimento del 2001, i cittadini di origine
africana, cinese, asiatica in genere, misto-ispanica e amerinda hanno complessivamente superato per numero i cittadini di origine europea
Nonostante l’ineluttabilità di questo processo, la tenace linea di
difesa della razza “bianca” da parte di molti mi ha suggerito di rendermi conto a livello empirico della fondatezza di questo preteso
candore.
Ho guardato con specifica attenzione il colore della pelle di mia
madre e di mio padre: la prima, nei momenti di migliore salute, aveva una pelle di colore bruno-rosato chiaro mentre il secondo aveva
una pelle di colore bruno-rossastro scuro. Senza curarsi dell’evidenza dei colori, molti, culturalmente confusi, continuerebbero a giurare che erano di pelle, e quindi di razza, “bianca”.
Ho cercato senza successo, dalla Norvegia alla Sicilia, uomini di
91
pelle «bianca» e, al meglio ho trovato un rosato chiaro. Senza possibilità di essere smentiti, si può affermare che non esiste una comunità umana il cui colore della pelle sia «bianco»: la pelle degli
uomini di origine europea esprime tutta una variegata gamma di colori che cambiano in funzione della zona climatica abitata e dello
stato emotivo, igienico e sanitario di ogni singolo individuo. L a
presunzione di essere una razza superiore perché ‘’bianca’’ è ormai
un inconsapevole razzismo antropologico che si esaspera nei razzisti del Ku Klux Klan che fondano sulla Bibbia la loro posizione:
«Dio disse a Jafet: egli abiti nelle tende di Sem, e Canaan sia suo
servo» (Genesi, lX, 27) Canaan, con il padre Cam, fu, com’è noto,
capostipite delle genti africane.
Le conseguenze della convinzione di essere ‘’bianchi’’ nel dialogo fra europei e non europei sono ancora devastanti. È quotidiano
leggere sulla stampa o udire espressioni come «un uomo di colore»,
«un lavoratore di colore”, «un giocatore di colore»: quale colore? E
quale sarebbe l’uomo “non di colore” o “senza colore”? Sono
espressioni che documentano il razzismo di chi parla e di chi scrive,
anche se, quasi sempre, questo razzismo è così culturalmente radicato da essere diventato inconscio. Quello che è grave è che l’espressione “uomo di colore” è usata anche dai giornalisti più liberali e dagli uomini di cultura più civilmente impegnati.
Nel mondo siamo europei, asiatici, africani, afro-americani, euro-africani o, se vogliamo, cinesi, indiani, slavi, arabi, germani e così via: non servono altre distinzioni. Dopo tanti secoli di acritica presunzione di superiorità, questa è la più urgente conquista culturale
che gli uomini di origine europea dovrebbero fare. Quando questa
consapevolezza sarà arrivata fino alla base profonda della cultura
delle masse europee, allora finalmente smetteremo quell’arrogante
sufficienza con la quale la più gran parte di noi continua a guardare
gli altri «di colore» senza rendersi conto di suscitare negli altri disprezzo per la nostra presuntuosa stupidità e odio per la continuata
lesione della loro dignità.
***
92
Democrazia. Un chiarimento sul senso di questo termine è reso
necessario non solo perché oggi si vuole “esportare” la democrazia
con le armi ma anche perché, nel dialogo parlato e spesso in quello
scritto, si ritiene che “democrazia” sia sinonimo di “democrazia liberale” e che questa equivalga a “democrazia elettorale”. Non è così: è ovvio per molti e sarebbe quasi banale parlarne se per molti altri non fosse un’espressione ancora indistinta.
“Democrazia”, infatti, senza un attributo qualificante significa
tutto e niente: si ricordi che il totalitarismo comunista sovietico si
autoappellava “democrazia popolare”. È necessario ricordare, quindi, che “democrazia elettorale” indica soltanto un metodo pratico
per affidare il governo della cosa pubblica a delegati di un elettorato, che può coincidere o no con l’intero popolo: siamo, cioè, di fronte ad una “tecnica variabile” di delega del potere politico.
Ben altro è il senso di “democrazia liberale” che vuole indicare i
principi socio-politico-morali, cioè i contenuti, ai quali si deve attenere la gestione del potere politico, in qualunque modo sia espresso
e rappresentato.
Fatta questa premessa e dati per scontati i dubbi sull’effettiva applicazione dei principi liberali all’interno dello stesso Occidente dove potere economico e potere mediatico condizionano ogni scelta
elettorale, è utile ricordare anche che solo una serie di superficialità
culturali - il corto respiro dell’eurocentrismo della storia, la grave
leggerezza dell’eurocentrismo della storia della filosofia, ecc. - ha radicato la convinzione che la “scoperta” del diritto alla libertà sia stata una sensibilità esclusivamente occidentale e così raffinata da avere consentito di porre valori “universali”, ignoti alle altre culture.
Amartya Sen, nobel per l’economia nel 2000, ha documentato nel
suo Lo sviluppo è libertà, con una pacata citazione di fonti asiatiche,
quanto sia ingiustificata e presuntuosa la convinzione degli occidentali che i diritti umani, intesi come libertà piena dell’individuo,
siano una conquista esclusiva della loro cultura. La questione, sostiene Sen, non si può concludere facendo rilevare come nel sistema
dei ‘’valori asiatici’’ prevalgano l’ordine e la disciplina confuciani:
si deve accertare se in Oriente mancano idee, dottrine e proposte
culturali che abbiano sostenuto il valore della libertà, lasciandone
così la paternità esclusiva all’Occidente.
93
Se è vero che l’ordine e la disciplina sono gli aspetti sui quali
mette l’accento il confucianesimo, non è meno vero che per il buddismo, fin dal sesto secolo a.C., è la libertà a dare nobiltà alla condotta umana. Allo stesso modo in Occidente, se è vero che Aristotele parla di libertà, anche se poi difende la schiavitù, non è meno vero che Platone o Agostino sono autoritari almeno quanto Confucio.
Per documentare la pratica antica della libertà, del rispetto della
diversità religiosa e dell’uguaglianza, Amartya Sen cita gli scritti e
la pratica dell’imperatore indiano Ashoka del terzo secolo a.C., sostenitore di un rispetto egualitario e universale, e gli editti sulla libertà religiosa del sovrano musulmano Mobol Akbar che, durante il
suo regno dal 1556 al 1605, sostenne la neutralità religiosa dello
Stato compresa l’uguaglianza fra i sessi e quella fra vecchi e giovani. Inoltre, ricordando certe esaltazioni delle presunte tradizioni antiche del “liberalismo occidentale”, Amartya Sen fa notare che,
quando Akbar proclamava questi principi, in Europa dominava l’Inquisizione e Giordano Bruno era arso vivo per eresia).
Dopo altre citazioni di trascorse situazioni liberali turche e arabe, Sen ribadisce come non sia la sola cultura occidentale ad aver
colto il valore della libertà e come anche le idee di Confucio siano
molto più complesse e raffinate delle massime che spesso vengono
rappresentate come statica espressione del suo pensiero.
Che gli eventi della storia abbiano portato le genti in tempi alterni verso una o un’altra direzione non vuol dire che la conquista di
certi valori sia stata esclusiva di una cultura e non vuol dire nemmeno né che questa conquista sia definitiva nei suoi contenuti né
che sia certa la convenienza di tutti i popoli di applicarli nella loro
attuale formulazione.
Amartya Sen, cioè, contesta l’asserita primogenitura occidentale
dei principi liberali ma ne conferma la validità per lo sviluppo di
qualsiasi paese alla condizione di un opportuno adeguamento al
contesto culturale nel quale applicarli: la democrazia può essere liberale soltanto vivendola in coerenza con il proprio patrimonio culturale.
È qui che scatta l’arroganza occidentale e l’aggressività verso le
altre culture, determinandone la reazione ostile. L’Occidente, infatti, ritiene che la libertà politica sarebbe assicurata solo dalla sua
94
forma di “democrazia elettorale” che dovrebbe essere imposta a tutti anche con i carri armati: è questo un fondamentalismo ideologico
la cui arbitrarietà, in Occidente, sfugge ai più.
Nell’attuale sua situazione socio-economico-culturale, la democrazia elettorale per l’Occidente è probabilmente la migliore forma
d’organizzazione politica possibile. Non si può ignorare, però, che
studiosi americani come Shmuel Eisenstadt, Robert Putnam e Noam
Chomsky hanno dimostrato che la democrazia statunitense è ormai
soltanto una “gerontocrazia plutocratica” burocraticamente sclerotizzata: l’Occidente europeo dovrebbe mettersi in guardia perché i
fenomeni evolutivi della società americana si riproducono in Europa entro l’arco di vent’anni.
La volontà occidentale di imporre a tutti i paesi del mondo questa forma di democrazia politica preoccupa: per molti non è la prospettiva migliore. Le masse umane della più gran parte del mondo
esprimono antichi e profondi radicamenti culturali assolutamente diversi. Spesso queste masse hanno una cultura nella quale i legami
religiosi o tribali o di casta prevalgono ancora sulle attese individuali: a fondamento dei rapporti sociali, vigono sistemi di valori
umani e politici assai diversi da quelli della cultura occidentale.
Confucio, per esempio, ha insegnato che l’ordine e la disciplina sociale, mantenuti con equilibrata saggezza, sono gli strumenti più validi per frenare le contraddizioni della natura umana.
Fare guerre preventive e aggredire gli altri popoli per imporre
presunti valori ‘’universali’’ di libertà e di tutela dei diritti umani,
come molti in Occidente ritengono che sia necessario fare, è una
contraddizione in termini che offende l’intelligenza di chi ha un’autonoma capacità di giudizio.
Poi, quando l’imposizione di valori “universali” vuole coprire indifendibili interessi economici, le ritorsioni più violente degli “altri”
diventano legittime.
***
Il mondo “altro”, infatti, è ormai consapevole che, dietro l’ipocrita bandiera della libertà e dei diritti umani, l’Occidente, in realtà,
porta avanti soltanto i suoi più brutali interessi economici.
95
Nel 1944, quando gli imperi coloniali già vacillavano e la seconda guerra mondiale volgeva verso la sua conclusione, a Bretton
Woods si definivano gli accordi che dovevano servire a realizzare
gli obiettivi che Franklin Delano Roosevelt aveva imposto a Churchill in occasione dell’incontro a bordo di una nave al largo di Terranova nell’agosto del 1941: gli Stati Uniti accettavano di entrare in
guerra contro la Germania a condizione che l’Inghilterra avesse rinunziato al “blocco Sterling’’, con il quale gli inglesi si erano riservati l’accesso alle materie prime dei paesi dell’impero britannico, e
si fosse stabilita la più assoluta libertà mondiale per gli scambi
commerciali, gli investimenti privati e l’accesso alle materie prime.
La certezza storica di queste notizie è testimoniata da Churchill nella sua Storia della Seconda guerra mondiale. L’interesse economico
che sta dietro ad ogni più apparentemente ideale iniziativa bellica
degli Stati Uniti è ormai documentalmente provato. Henry Kissinger, famoso sottosegretario di stato americano, ha sostenuto: “la globalizzazione è soltanto il nuovo modo di esprimersi dell’imperialismo economico degli Stati Uniti”.
Anche se a Bretton Woods, con la creazione della Banca Mondiale (BIRS e IDA) e del Fondo Monetario Internazionale, John
Maynard Keynes e Harry Dexter White avevano posto le premesse
per una gestione espansiva di tutta la politica economico-finanziaria
mondiale, i due istituti sono stati progressivamente deviati dagli
americani verso la tutela dei loro interessi con un’aberrante ideologia: l’assoluta centralità del mercato capace di risolvere, con la sua
più libera gestione, tutti i problemi non soltanto economico-commerciali ma anche sociali di qualsiasi paese, anche il più arretrato.
In effetti, al di là di ogni affermata questione di principio, i crediti erogati ai paesi meno sviluppati sono stati e sono gestiti in modo da assicurare la subalternità dei loro governi.
È utile ascoltare Joseph E. Stiglitz, professore di Economia alla
Columbia University, consigliere economico di Bill Clinton e, dal
1997 al 2000, senior vice president e chief economist della Banca
Mondiale che, nel suo La globalizzazione e i suoi oppositori alle pagine 4-7, scrive: «Il cambiamento più importante in queste istituzioni si è verificato negli anni Ottanta, quando Ronald Reagan e Margaret Thatcher predicavano l’ideologia del libero mercato negli Sta96
© ARMANDO EDITORE. La fotocopia non autorizzata è reato.
ti Uniti e nel Regno Unito. L’FMI e la Banca Mondiale divennero gli
istituti missionari preposti a diffondere queste idee in paesi poveri
riluttanti che spesso avevano un disperato bisogno di prestiti e concessioni. … L’Occidente ha persuaso questi paesi che il nuovo sistema economico li avrebbe portato ad una prosperità senza precedenti. In effetti, sotto molti aspetti, per gran parte della popolazione
l’economia di mercato si è dimostrata addirittura peggiore di quanto avessero previsto i leaders comunisti… Non a torto, i critici accusano i paesi occidentali di ipocrisia. Questi ultimi hanno spinto i
paesi poveri ad eliminare le barriere commerciali, ma hanno mantenuto le proprie, impedendo così ai paesi in via di sviluppo di esportare i loro prodotti e privandoli, di fatto, del reddito delle esportazioni di cui hanno invece disperato bisogno. Gli Stati Uniti, naturalmente, sono tra i principali colpevoli e la questione mi ha toccato
profondamente. Quando ero presidente del Consiglio dei consulenti
economici, ho combattuto strenuamente contro questa ipocrisia che
ha danneggiato i paesi in via di sviluppo… Non vi è stato soltanto il
rifiuto da parte dei paesi più avanzati di aprire i propri mercati alle
merci provenienti dai paesi in via di sviluppo, ma anche il fatto che
i paesi industrializzati hanno continuato da una parte a sovvenzionare l’agricoltura, mettendo così in difficoltà i paesi emergenti che
non riescono ad essere competitivi, e dall’altra a insistere che questi
abolissero i sussidi sui prodotti industriali».
L’autorità accademica di Stiglitz e il livello delle responsabilità
politico-economiche da lui ricoperte esonerano da qualsiasi considerazione ulteriore e non lasciano dubbi sulle effettive ragioni per le
quali l’Occidente cerca di portare ovunque la sua “democrazia”. Se
al popolo, al quale “si vuole portare la libertà”, mancano i prerequisiti socio-culturali funzionali alle impostazioni “democratiche” occidentali, non è rilevante: gli s’impongono con i massacri aerei e i
carri armati e i mercati sono aperti alla rapacità delle multinazionali.
Antisemitismo. Non si possono affrontare i problemi del dialogo fra i popoli del nostro pianeta senza toccare quest’argomento.
La parola “antisemitismo” impone un’analisi attenta non solo
perché i fatti che richiama coinvolgono la pace del mondo ma anche
97
perché ricorda un crimine che macchia la storia umana del più efferato genocidio mai posto in essere. Il ricordo del crimine del nazismo è sempre necessario non solo perché i giovani sappiano, ma anche per mantenere vivi quegli anticorpi morali che devono far sperare che tanta sciagura non si ripeta mai più: occorrerà insistere finché il rifiuto d’ogni odio razzista non sarà entrato nel dna culturale
di tutti i popoli.
Quest’irrinunciabile posizione non deve consentire, però, che il
rispetto dovuto alla Shoah possa essere strumentalizzato dai rabbini
più scorretti fino a permettere loro di lanciare l’accusa di “antisemitismo” contro chiunque si permetta anche soltanto di contestare le
violenze dei governi israeliani nella repressione del popolo palestinese.
Per una valutazione attenta di questa locuzione, occorre ricordare, prima di tutto, che la parola «ebreo» ha solo un contenuto religioso-culturale e indica sempre un praticante la religione ebraica e/o
un portatore della cultura ebraica. Cioè, ed è necessario ripeterlo, alla parola «ebreo» non può essere collegato nessun contenuto politico, civile e, soprattutto etnico, come dimostra il fatto che se un
ebreo si converte ad un’altra religione o dichiara semplicemente di
non sentirsi più ebreo, non è più considerato ebreo nemmeno dagli
altri ebrei e non fa più parte del «popolo ebraico». La coscienza nazionale ebraica si affermò e sfidò i millenni come coscienza religiosa: la storia degli Ebrei è stata la storia del loro rapporto con Dio e
con la sua «Legge».
Questa cultura è sopravvissuta nei millenni perché le sue idee
non rimasero staticamente legate al tempo in cui furono abbozzate
ma si sono evolute fino a diventare non solo patrimonio spirituale
degli Ebrei ma anche patrimonio culturale di tutta l’umanità. Eppure, nonostante la dimensione universale della sensibilità umana
espressa dalla religione ebraica, nel corso dei secoli gli Ebrei hanno
subito una somma d’aggressioni che, dalla fine del diciannovesimo
secolo, sono state ritenute manifestazioni di «antisemitismo».
Per tentare di capire perché sia accaduto, occorre prima rivedere
le cause di quelle aggressioni e, dopo, accertare se l’espressione
«antisemitismo» – che letteralmente ha il significato di ostilità razzista contro uomini di razza semita – sia la più pertinente non solo
98
per indicare le motivazioni e il contenuto di quegli eventi ma anche
per qualificare le attuali espressioni di ostilità antisraeliana.
Chi abbia avuto nella sua infanzia una formazione cattolica o comunque cristiana, sa che fin da quell’età porta dentro l’informazione che il popolo ebraico è un popolo ingiustificatamente sopravvissuto al “superamento” della sua religione con l’avvento e il trionfo
di Cristo. Le intuizioni religiose e la profondità etica della cultura
ebraica erano state assunte dal Cristianesimo che, raccolta quella
che considerava un’eredità, aveva ritenuto subito che il suo affermarsi nel mondo doveva essere accompagnato dall’eliminazione di
quel «ramo secco» che ormai erano i portatori della vecchia religione dei profeti.
È questa la causa di fondo delle persecuzioni che per secoli hanno segnato la storia degli Ebrei in Europa e la responsabilità è tutta,
per intero e senza alibi alcuno, della Chiesa cattolica e delle confessioni protestanti: per giustificarla, fu coniata a carico del popolo
ebraico l’accusa di deicidio, cui diedero un contributo con i loro
scritti anche Agostino e Tommaso d’Aquino.
Sfruttando questa radice religiosa ed emotiva, interessi economici e motivazioni politiche hanno aizzato nei secoli, qua e là per l’Europa, l’odio popolare contro le comunità ebraiche, responsabili soltanto dell’arroccamento nella loro specificità culturale e religiosa.
Nei secoli scorsi, inoltre, le particolari condizioni di inferiorità
sociale, nella quale erano tenuti gli Ebrei, non avevano consentito
loro la proprietà di beni immobili con la conseguenza che la disponibilità di denaro liquido li aveva portati verso quell’attività bancaria non gestita dai cattolici perché condannata dalla loro religione:
la filosofia del lavoro dell’ebreo aveva determinato spesso l’accumulo di fortune finanziarie contro le quali era facile aizzare la furia
popolare in occasione di carestie o di crisi economiche.
Così, fino a tutta la prima metà del secolo diciannovesimo, l’ostilità verso gli Ebrei fu «soltanto» religiosa, culturale (vedi anche
Voltaire), politica ed economica: mai razzista.
La fondatezza di quest’affermazione si dimostra fermando l’attenzione su alcune fra le più drammatiche persecuzioni subite nei
secoli recenti dalle comunità ebraiche in Europa, mentre si possono
trascurare le vicende e gli esili degli antichi Ebrei perché a quei tem-
99
pi non erano nemmeno immaginate le discriminazioni su base razziale.
Già durante gli ultimi secoli dell’impero romano, il progressivo
diffondersi del cristianesimo aveva portato i primi imperatori cristiani ad occuparsi in modo ostile degli Ebrei anche se ancora nell’ambito di quella tolleranza religiosa assai diffusa nell’antichità.
Questa situazione complessivamente accettabile continuò per gli
Ebrei per tutto l’alto medioevo, pur se non mancarono anche in quel
tempo forme di discriminazione sociale ed economica.
Fu con l’inizio delle crociate che la condizione degli Ebrei in Europa andò progressivamente aggravandosi fino alle statuizioni restrittive del Concilio Lateranense (Innocenzo lll, 1215) che impose
agli Ebrei l’obbligo di portare sugli abiti un segno che li distinguesse dai cristiani. Ma, già in Francia e in Germania, i crociati della
prima crociata (1097), sfruttando il fanatismo religioso del tempo,
avevano preso ad aggredire e sterminare gli Ebrei per liberarsi dei
debiti che avevano contratto e per impadronirsi dei loro beni: aggressione con scopo di rapina, si direbbe oggi, ma niente razzismo.
E, quando Luigi lX ordinò la distruzione di tutte le pubblicazioni ebraiche e l’espulsione degli Ebrei dalla Francia (1254) con la
confisca di tutti i beni, il motivo ispiratore era stato il fanatismo religioso di quel re, ma niente razzismo. Così pure nel 1492, l’anno
simbolo dell’espulsione degli Ebrei dalla Spagna, i motivi scatenanti dell’evento furono l’ambizione dei sovrani di cristianizzare totalmente il regno unificato e l’avidità della borghesia castigliana che
voleva impadronirsi delle lucrose attività commerciali degli Ebrei.
Ma niente antisemitismo razzista, come dimostra che lo stesso accanimento non fu speso in quel tempo per espellere anche gli Arabi,
che vivevano ancora numerosi in Spagna e che erano sicuramente di
stirpe semita e non cristiani.
Una ragione assurda, infine, sta dietro le periodiche aggressioni
subite dagli Ebrei in Polonia e in Russia: era sfogo della violenza
brutale delle masse popolari aizzate dalla miseria, dalla fame e dalla più distruttiva insoddisfazione sociale. Il potere costituito lasciava sfogare in direzione delle comunità ebraiche gli istinti aggressivi
delle masse in occasione di carestie o di crisi economiche o politiche, ma niente razzismo.
100
Non c’era razzismo nell’odio antiebraico che macchiava l’Europa ed è necessario avere ben chiare queste motivazioni non razziste
che hanno determinato le persecuzioni subite dagli Ebrei nel Medio
Evo e nella prima Età moderna per comprendere il salto di qualità
compiuto dall’aberrante cultura politico-sociale tedesca fra il sedicesimo e il ventesimo secolo.
Se intorno alla metà del diciannovesimo secolo a partire dalla
Germania, la violenza culturale e fisica contro gli Ebrei si scatena
anche in senso razziale, il fatto non è casuale: fu in quel tempo che
il fanatismo nazionalistico pangermanico, alimentato anche dai successi militari della Prussia, cominciò a guardare alle comunità ebraiche, non integrabili né dal punto di vista religioso né da quello culturale, come a realtà disgreganti di quel mito superiore che la cultura tedesca, da Martin Lutero a Wagner, aveva costruito con inusitato furore: la nazione germanica.
Da Lutero a Nietzsche non fu soltanto un arricchimento culturale: fu, attraverso Lessing, Klopstock, Herder, Goethe (anche lui,
purtroppo), Schiller, Humboldt, Schlegel, Fichte, Hegel, Novalis,
Grimm, Wagner, ecc., un crescendo di autocelebrazione del genio
tedesco e di antiebraismo con una progressiva esaltazione tale da
non sorprendere che il diapason finale sia stato raggiunto da un politico probabilmente uscito di senno (Hitler).
La comunità ebraica, che già da millenni e per prima nella storia
dell’umanità aveva coscienza di sé come di un popolo-nazione, non
si sarebbe fatta fagocitare neppure da quella nazione che riteneva di
avere il destino di guidare il mondo. Si era ancora lontani dalla disumana «soluzione finale» di Hitler, ma il problema - che era religioso, culturale, politico ed economico - con grossolana malafede
culturale, cominciò ad essere progressivamente trasformato in problema razziale: gli Ebrei, in quanto di origine semitica, non erano
ariani e, quindi, erano una razza inferiore alla quale dovevano essere poste tutte le difficoltà possibili per convincerla ad abbandonare
il sacro suolo germanico.
Al nascere di quest’impostura, che è uno degli aspetti più mortificanti della per altri versi geniale cultura tedesca, avevano dato il
loro contributo le teorie esposte dal francese de Gobineau che nel
1855 aveva pubblicato il «Saggio sulle disuguaglianze delle razze
101
umane». Sulla base di queste teorie, alla fine dell’Ottocento, lo storico tedesco Chamberlain, posta la grandezza ineguagliabile della
stirpe germanica, afferma la necessità per i Tedeschi di eliminare
ogni rapporto con gli Ebrei, miscuglio di razze inferiori.
Durante i cinquant’anni che corrono fra i saggi di questi due storici la letteratura tedesca impegnata in senso antisemita si era arricchita di mille contributi. Professori di teologia, di storia, di filosofia
e di antropologia, fra i quali uno dei più noti fu lo storico von Treitschke, fecero quasi a gara con le loro pubblicazioni per costruire un
castello d’insinuazioni sull’incapacità degli Ebrei, in quanto semiti,
a dare contributi positivi al costruendo impero tedesco, alla sua economia e alla sua cultura.
Fu durante questo periodo di farneticante antiebraismo che, nel
1880, Wilhelm Marr usò per primo l’espressione «antisemitismo».
Scriveva Richard Wagner in una lettera al re di Baviera nel 1881:
«Considero la razza ebraica il nemico giurato dell’umanità pura e di
tutto ciò che in essa v’è di nobile…». Se questa era la posizione di
un tedesco al livello culturale di Wagner, non è difficile immaginare quale fosse l’animo e il comportamento della feccia sociale sobillata dalla malafede politica. Gli ultimi decenni del diciannovesimo secolo e i primi del ventesimo furono un crescendo di aggressioni agli Ebrei che, dopo la sconfitta del 1918, furono quasi il naturale capro espiatorio per le tensioni economiche, politiche e sociali che travolsero la Germania democratica.
Giustamente, Abba Eban, nel suo Eredità (pag. 280), con riferimento all’espressione usata da Wagner nella lettera al re di Baviera,
pone un interrogativo: «Wagner fa ricorso ad una locuzione che in
precedenza non è dato di incontrare: la razza ebraica. Ora il giudaismo è la religione ebraica, coloro che sono nati da genitori ebrei
costituiscono il popolo ebraico e l’odierno Israele è lo Stato ebraico. Ma in che cosa consiste la razza ebraica?
E, in effetti, la domanda non è ingiustificata perché tutto l’impegno razzista e pseudoculturale dei tedeschi non aveva e non ha alcun fondamento scientifico.
A parte l’odierna certezza della scienza che il concetto di razza
in senso biologico è senza alcun fondamento, per le implicazioni politiche e sociali legate a questo problema, gli antropologi hanno stu102
diato a fondo l’esistenza o meno di una presunta razza ebraica e il
risultato di questi studi è stata l’affermazione certa e incontrovertibile che non esistono caratteri corporei che possano dirsi esclusivi
del popolo ebraico. Tutte le comunità ebraiche, nei loro componenti, presentano elementi e caratteristiche propri di mescolanze somatiche, presenti anche in altri gruppi etnici europei ed extra-europei.
Così, gli studi dell’altezza, della forma della testa, del colore degli
occhi, della forma del naso, della pelosità corporea, ecc, hanno potuto solo confermare la maggiore o minore incidenza dei caratteri
delle popolazioni delle zone nelle quali le varie comunità ebraiche
si erano fermate più o meno a lungo.
Theodosius Dobzhansky, uno dei più attenti studiosi dell’evoluzione umana, scrive: «Il nostro problema è stabilire fino a qual punto, nei diversi paesi, gli ebrei siano rimasti geneticamente distinti
dalle popolazioni vicine... Gli ebrei evidentemente non sono una
razza omogenea o unica: le popolazioni ebraiche che vivevano come caste in paesi diversi hanno subito una considerevole divergenza genetica e generalmente – cosa che non sorprende – nella direzione delle popolazioni non ebraiche fra cui vivevano».
E, infatti, già nel secondo millennio a.C. le migrazioni degli Ebrei
assieme a quelle degli Aramei, degli Ammoniti, degli Edomiti si erano
sovrapposte nella zona siro-palestinese a quelle dei semiti immigrati
prima (Cananei) e a quelle presemitiche per mescolarsi poi con stirpi
sopravvenute di origine egea e indoeuropea (Filistei, Hittiti, ecc.).
Così, in tempi storici, negli oltre tremila anni di peregrinazioni,
le genti portatrici della religione ebraica hanno continuato a ricevere i più ampi contributi genetici in Asia mediorientale, nell’Africa
centrosettentrionale e nell’Europa tutta. Questo spostarsi per il mondo non fu mai una passiva fuga: l’attività commerciale e la difesa
dell’autonomia religiosa e culturale furono accompagnate sempre da
un discreto proselitismo sulle popolazioni dei paesi che venivano
raggiunti, rinnovando e accrescendo le comunità ebraiche ben oltre
il loro possibile incremento naturale.
Agli Ebrei in esilio a Babilonia, com’è risaputo, Geremia aveva
suggerito anche i matrimoni misti «per non ridurvi a pochi di numero» (Geremia, 29, 6).
Il conseguente caleidoscopio etnico ebraico è documentato oggi
103
nello Stato di Israele i cui cittadini ebrei (cioè di religione e/o di cultura ebraica), provenienti da tutto il mondo, vanno dal biondo di tipo slavo al nero di tipo etiopico, passando per tutta la gamma dei colori e dei caratteri somatici che è possibile riscontrare nelle popolazioni mediorientali, europee e africane.
L’obiettivo di queste considerazioni è concludere che, certamente, tre mila anni fa c’è stato un popolo ebreo di stirpe semitica, cioè
appartenente al gruppo di popoli di lingua semitica, comprendente
anche gli Arabi, per il quale la genetica non ha potuto accertare alcun criterio distintivo rispetto ai popoli del gruppo indoeuropeo.
Oggi, dopo tre millenni di incroci con i popoli dei paesi raggiunti dalla diaspora, non esiste un qualche riferimento biologico della
specificità ebraica, neppure linguistico, che possa consentire di rappresentare unitariamente le comunità ebraiche del mondo. (Per evitare equivoci, sia chiaro che lo stesso discorso sull’ibridismo dei
gruppi umani può essere fatto, più o meno, anche per tutti i popoli
della presuntuosa Europa).
Soltanto l’ignoranza, la stupidità e la malafede, prima di alcuni
uomini di cultura e dopo di uomini politici, dalla metà del diciannovesimo secolo in poi, ha fatto diventare di natura «genetica» quel fenomeno di ostilità ideologica verso gli Ebrei che aveva avuto sempre un fondamento a volte religioso, a volte socio-culturale, a volte
economico: trovare poi masse istericamente emotive da aizzare contro non è stato mai un problema e mai lo sarà.
L’“antisemitismo” della prima metà del XX secolo fu un’impostura prima culturale e poi politica pagata a caro prezzo: il massacro
di 6 milioni e mezzo di Ebrei.
***
Fatte queste premesse, necessarie per ricordare il problema e condannare senza mezzi termini tutte le violenze inflitte agli Ebrei nei
secoli, oggi occorre chiedersi se sia giustificato continuare ad utilizzare ancora l’espressione «antisemitismo» per qualificare sempre
qualsiasi forma di ostilità verso aspetti della realtà ebraica e, soprattutto, per contestare quanti riprovano la violenza aggressiva dello
Stato di Israele.
104
Purtroppo, l’antiebraismo - o antigiudaismo, che è la stessa cosa –
esiste ancora per quella ostilità originaria instillata dal cristianesimo
nella subcultura europea e si esprime con atti alimentati da emotiva disinformazione, da stupida violenza fine a stessa, da interessi economici
e socio-politici. Né si può ignorare che esiste anche, purtroppo, un antiebraismo ideologico di origine laico-culturale dovuto ad una superficiale conoscenza dei contenuti ideali della cultura ebraica. Esistono, infine, anche posizioni antisraeliane per scelta morale di fronte al lento
genocidio dei Palestinesi o per documentata informazione storica di chi
ricorda i crimini del terrorismo dell’Irgun e della ‘’banda Stern’’, con il
cui contributo di violenza gli Ebrei fondarono lo Stato d’Israele.
In questi casi usare ancora l’espressione “antisemitismo” è assolutamente fuorviante.
L’espressione è usata erroneamente, anche in buona fede, nel
senso generico di antiebraismo senza tener conto del suo significato
letterale: non esistendo una razza ebreo-semitica, non può essere denunziata un’ostilità razzista se non fondandola sull’ignoranza.
Pur non dimenticando, quindi, che nella maggior parte dei casi
l’espressione è usata con superficiale buona fede, si deve contestare
chi, da parte ebraica, muove oggi ad altri ancora l’accusa di «antisemitismo» per evocare l’emozione suscitata dal non dimenticabile
sterminio nazista. Quest’uso non è corretto: a nessuno è consentito
brandire l’accusa di “antisemitismo’’ come un insormontabile muro
per chiunque non sia filoisraeliano.
Questa considerazione è tanto più fondata quando, paradossalmente, viene accusato di «antisemitismo» chi, in difesa di posizioni
arabe, contesta comportamenti o argomentazioni di Ebrei: se c’è ancora una specificità semitica, infatti, questa potrebbe essere accreditata quasi soltanto agli Arabi. Questo paradosso è una contraddizione in termini che dimostra quanto l’uso della parola ‘’antisemitismo’’ sia ormai un’impostura semantico-filologica (sarebbe interessante un parere di Umberto Eco).
Per una stortura culturale affermatasi centocinquant’anni fa e assunta per fini politici dal nazismo settant’anni fa, l’espressione “antisemitismo” continua ad essere utilizzata perché contiene un’implicita condanna morale e perché l’irrazionalità che vuole rappresentare non consente a chi ne subisce l’accusa una difesa razionale.
105
Contestare la fondatezza dell’uso della parola «antisemitismo»
non è un cavillo formale: è una scelta di correttezza culturale per rettificare affermazioni suggerite da un’inadeguata informazione. Diventa poi una scelta di correttezza morale quando non vuole consentire più il ricatto di chi usa in malafede l’espressione «antisemitismo» per difendere posizioni ebraico-israeliane errate e insostenibili.
La malafede sta nel sapere che il contenuto apodittico dell’espressione “antisemitismo’’ esprime un’accusa morale con il suo valore semantico di razzismo irrazionale.
«Antisemitismo» non è più un’espressione razionalmente utilizzabile con un fondamento culturale.
Se l’espressione è usata da una persona disinformata è utile chiarirgliene il senso. Ma, se continua ad essere utilizzata da un ebreo
colto o da un rabbino - soprattutto se è il capo della comunità ebraica di un paese - è necessario contestargli la scorrettezza umana e la
malafede che lo ispirano perché lui sa che, accusando un interlocutore di antisemitismo - cioè presunto razzismo - lo sposta di obiettivo e gli impedisce ogni argomentazione razionale con la quale possa eventualmente dimostrare la fondatezza del suo disaccordo.
Qualsiasi forma di ostilità o d’infondata diffidenza verso gli
Ebrei deve essere definita semplicemente «antiebraismo» o, ed è la
stessa cosa, «antigiudaismo»; la riprovazione del comportamento
dei governi israeliani può essere considerata “antisraeliana”: non è
“antisemitismo”.
La fondatezza di queste considerazioni è stata dimostrata dal
comportamento dei capi del Congresso ebraico europeo e mondiale
che, con il massimo dell’arroganza estremista possibile, hanno accusato di ‘’antisemitismo’’ la Commissione Europea per il sondaggio che ha mostrato come lo Stato di Israele sia considerato dalla
maggioranza degli Europei il peggior ostacolo alla pace nel mondo:
non si può accusare di ‘’antisemitismo’’ chi non approva quella politica israeliana che è contestata anche da milioni e milioni di Ebrei
nel mondo fino a quei giovani israeliani che si rifiutano di prestare
il servizio militare.
L’espressione”antisemitismo” da impostura pagata a caro prezzo
dagli Ebrei è diventata un’impostura opposta: oggi, è utilizzata da106
gli ebrei più scorretti che, aggredendo chi condanna la brutale oppressione del popolo palestinese, impediscono ogni dialogo che possa portare un contributo alla pace del mondo.
***
Terrorismo. La parola “terrorismo”, qui, non è presa in considerazione per giudicare i fatti di chi causa la morte di civili inermi con
un comportamento efferato e proditorio simile al comportamento efferato e proditorio di chi effettua bombardamenti aerei su migliaia
di civili ignari. L’analisi vuole costatare quanto storicamente ne sia
stato discrezionale l’uso.
Un preliminare ricordo dell’avvenimento “terroristico” più clamoroso mai accaduto può essere utile per porre qualche punto di riferimento fondamentale.
Gli attentati alle torri di New York e al Pentagono di Washington,
con i loro duemila e ottocento morti civili, sono l’evento che ha
aperto il terzo millennio lasciando attonito il mondo: scioccati, i più
ne hanno dato un giudizio condizionato dalla propria posizione socio-culturale e da quella economico-politica del proprio Paese.
Ho assistito alla televisione a quella che, emotivamente e a livello epidermico, mi è apparsa come una delle iniziative più efferate
mai intraprese dagli uomini, esecranda nella concezione realizzatrice e nel dolore provocato. Questa, però, è un’emozione personale
senza alcun valore generale.
La rapida, schematica essenzialità dell’evento 11 settembre
2001, figlia della tecnologia e della velocità del nostro tempo, non
ha consentito di vederne con chiarezza la dimensione.
Ci sono nella storia degli uomini eventi che stabiliscono valori
nuovi, positivi o negativi secondo i punti d’osservazione, che sono
pietre miliari della cultura umana, al di là dei costi che possano essere stati pagati. La rivoluzione americana, la rivoluzione francese e
la rivoluzione russa hanno imposto valori che riscattano ampiamente le decine o centinaia di migliaia di morti che sono costate: il diritto dei popoli all’autodeterminazione, il diritto alla più piena libertà dell’individuo umano, il diritto alla giustizia sociale per chi lavora. Nel tempo in cui queste rivoluzioni avvennero, la potenza co-
107
loniale inglese, l’aristocrazia francese, la nobiltà russa, gli industriali meno avvertiti e buona parte dell’establishment culturale
hanno espresso un giudizio molto negativo contestando la crudeltà
di quanto accadeva ma guardando, in effetti, ad interessi propri o a
proprie visioni del mondo.
Chi guardasse oggi alla rivoluzione francese fermando l’attenzione sulle miserie umane, sui crimini e sui massacri che ne hanno
accompagnato il corso, dimostrerebbe la sua sensibilità ma anche la
sprovveduta ingenuità: tutta la storia delle conquiste ideali umane è
accompagnata da una storia di nefandezze.
La violenza “spettacolare” dell’11 settembre 2001, per l’eccezionalità del suo svolgimento, ha avuto un’incidenza storica non inferiore a quella di ognuna delle tre rivoluzioni ricordate: ha chiarito la
dimensione dell’odio del mondo verso l’Occidente. Per la sua rilevanza, l’avvenimento si porta fuori dal contesto quotidiano e pone il
problema di capire se i suoi morti abbiano aperto una prospettiva
positiva per la società umana o ne abbiano annebbiato il futuro.
L’analisi, invece, è stata affrontata in condizioni di estrema emotività e il massimo, forse, è stato raggiunto dall’ingenua reazione di uno
dei più esperti ed apprezzati giornalisti italiani che, sul Corriere della
Sera, ha affermato che stava dalla parte degli americani perché nel 1914
erano corsi in aiuto di suo padre e nel 1941 erano corsi in suo aiuto.
Certamente l’Europa è debitrice verso gli Stati Uniti per il contributo che hanno dato per sconfiggere le dittature fasciste e i giovani americani caduti sulle spiagge di Normandia hanno conquistato un rispetto imperituro per la bandiera a stelle e strisce.
Per la pulizia morale che ha sempre distinto il suo lavoro, da questo giornalista si accetta tutto, ma la posizione, che decontestualizza l’avvenimento da quello che è accaduto negli ultimi sessant’anni,
non può essere condivisa perché la dimensione del problema creato
dal crollo delle Twin Towers non consente di affrontarlo con una
semplice scelta di campo.
Sicuramente, Enzo Biagi negli anni quaranta abitava in campagna, altrimenti non avrebbe dimenticato la paura dei bombardamenti con i quali gli americani, prima e dopo lo sbarco del 1943, hanno
raso al suolo le città italiane senza preoccuparsi delle decine di migliaia di «civili» che massacravano per «liberarli».
108
Chi fra il gennaio e il luglio 1943 abitava a Palermo non potrà più
dimenticare il terrore per i quotidiani bombardamenti “a tappeto”
che gli aerei americani effettuavano sulla città a tutte le ore lanciando volantini che dicevano: “Se non volete essere ‘’coventrizzati’’ ribellatevi alle autorità”. La città era stata bombardata in precedenza
dai francesi che provenivano dalla Tunisia e dagli inglesi che provenivano da Malta; sia gli uni che gli altri si erano limitati a bombardare la zona portuale della città e solo con gli americani la città
fu rasa al suolo e i morti e i feriti furono decine di migliaia: a quei
tempi non si era ancora parlato di terrorismo, ma i palermitani vecchi ricordano che si distinse fra i bombardamenti ‘’civili’’ dei francesi e degli inglesi e i bombardamenti ‘’terroristici’’ degli americani: la storia la fanno i fatti e non le emozioni o le gratitudini di Biagi.
Un’analisi realistica dell’attentato di New York non consente posizioni pregiudiziali e aprioristiche scelte di campo: a Biagi che dichiara il suo orrore per i morti “civili’’, si deve suggerire di provare
a contare i milioni di morti “civili’’ di cui, negli ultimi sessant’anni
del ventesimo secolo (dal 1941 ad oggi), gli statunitensi, dietro la
bandiera della libertà, hanno seminato il mondo con i bombardamenti a tappeto sulle città italiane e tedesche, le bombe atomiche sul
Giappone, i massacri in Corea, la devastazione del Vietnam, il colpo di stato nel Cile, la repressione dei sandinisti in Nicaragua, la
guerra del 1991 all’Iraq e poi l’embargo, il bombardamento dei villaggi indifesi dell’Afganistan, i raids aerei su Grenada, Panama, Somalia, Sudan e ancora Iraq nel 2003-2004.
Com’è stato già detto nel capitolo precedente parlando della
“guerra”, quando si parla di morti civili non si può dimenticare che
l’impiego dell’aereo ha radicalmente modificato negli ultimi sessant’anni i concetti di ‘’guerra’’, di ‘’fronte’’ e di ‘’civili’’ e si deve
cercare di capire se l’attentato alle due torri debba essere considerato un atto di guerra o un atto ingiustificatamente criminale: per l’Occidente è un atto di “terrorismo”; per il mondo islamico è un atto di
guerra nei termini possibili per paesi che non hanno la potenza militare e tecnologica dell’Occidente.
Questa premessa non ha ancora chiarito quali comportamenti
possano essere considerati atti di terrorismo. Ha voluto ribadire, mo-
109
mentaneamente, che né la violenza né la morte di civili inermi sono
aspetti che, oggi, possono far qualificare un’aggressione come fatto
terroristico: per valutare si deve guardare soltanto alla legittimità o
meno delle ragioni che l’hanno determinato. Purtroppo, però, anche
i fondamenti di ciò che può essere considerato legittimo oggi sono
posti in discussione e un’analisi completa richiederebbe di portare
l’attenzione pure sul contenuto di altre parole altrettanto abusate:
uguaglianza, libertà e democrazia. Ma, poiché il discorso richiederebbe un saggio a parte, l’analisi deve limitarsi ad uno sguardo ai
fatti.
È facile, allora, constatare come l’espressione “terrorismo” sia
stata sempre utilizzata con grande elasticità di significato: Napoleone chiamava terrorismo la guerriglia spagnola e quella russa: Goya
ha documentato come fosse terroristico il comportamento degli
eserciti napoleonici. Durante la seconda guerra mondiale, in tutta
l’Europa, le iniziative violente dei movimenti di resistenza all’occupazione tedesca erano considerate “terrorismo” dalle autorità del loro tempo per essere poi apprezzate come attività lecite di ‘’movimenti di liberazione’’ a guerra finita.
L’esempio più clamoroso l’ha dato Israele che ha la primogenitura assoluta del terrorismo moderno. Israele, che oggi ipocritamente si scandalizza moralmente per il terrorismo arabo bollandolo d’infamia, non potrà mai far dimenticare che è nato sul sangue e sull’odio seminati dalle sue bande di criminali che, nella prima metà del
secolo ventesimo, seminavano la morte più crudele anche per l’Europa, facendo saltare in aria alberghi, caserme e ambasciate inglesi
(come hanno fatto anche a Roma): una buona parte dei leaders che
Israele ha avuto fin’ora sono stati acclarati terroristi, come per
esempio il primo ministro Menachem Begin o il primo ministro
Yitzhak Shamir: a loro, se la storia non la scrivesse sempre e soltanto chi vince, per gli attentati portati anche in Occidente, avrebbe
dovuto essere riservato lo stesso trattamento di criminali che viene
promesso a Bin Laden e ai suoi gruppi. Invece, sono stati ricevuti e
trattati come normali capi di Stato da tutti i governi dei paesi occidentali: dove finisce il rispetto della propria dignità ed inizia l’ipocrisia politica?
Quanto è accaduto per i sionistici in Palestina, è accaduto anche
110
per l’African National Congress di Mandela in Sudafrica: il ricorso
ad atti di terrorismo viene retrospettivamente giustificato quando gli
irredentismi nazionali o politici o culturali raggiungono lo scopo e
ottengono il riconoscimento internazionale.
Anche per la particolare violenza espressa in Irlanda del Nord,
nei Paesi Baschi e in Corsica, si conferma l’ambiguità d’uso della
parola “terrorismo”: i resistenti sono chiamati “terroristi” dai governi inglesi, spagnolo e francese mentre sono chiamati ‘’partigiani’’
dai connazionali che ne condividono la causa.
Oggi, nel mondo occidentale, genericamente, sono sempre qualificati come ‘’terrorismo’’ gli atti di chi, con azione violenta, improvvisa e inattesa, voglia affermare un suo diritto - fondato o presunto che sia - o una sua visione ideologica della società umana e
dei rapporti fra i popoli. Salvo a riconoscere la validità dell’azione
violenta e a riqualificarla positivamente quando essa riesca a raggiungere i suoi obiettivi.
Quest’impostazione concettuale già quasi sancisce come, accanto agli utopisti frettolosi ed irresponsabili, “terroristi” sono considerati soltanto i prevaricati, gli scontenti e i disperati del mondo che,
non disponendo della forza militare o sociale per recuperare dialetticamente migliori posizioni politiche o economiche, risolvono la
loro impotenza affidando alla violenza le loro speranze.
Forse, possiamo distinguere: l’accusa di “terrorismo” è fondata
per le iniziative violente degli utopisti occidentali, che nei loro paesi sono incapaci di trovare spazio alle loro idee politiche in modo
dialettico e, anarchicamente, scelgono la via della violenza irresponsabile. Diversa deve essere l’attenzione per le iniziative anche
violente di quanti operano in clandestinità per difendere diritti negati o interessi sopraffatti di paesi che non dispongono della forza
politica e militare adeguata per ottenerne il riconoscimento nel contesto internazionale.
Nel primo caso, siamo di fronte all’impotente ed irresponsabile
immaturità politica di fanatici che non riescono ad affermare in modo democratico-liberale le loro idee e pretendono di imporle con la
violenza: la condanna di questo terrorismo tout court non può che
essere la più severa e la risposta la più dura.
Nel secondo caso, la valutazione deve essere più articolata e sic
111
et simpliciter non può essere considerato “terrorismo” la reazione
anche violenta alla violenza di tirannici governi locali o all’aggressione manifesta o subdola di governi stranieri che condizionano la
vita di un popolo per perseguire i loro interessi: questo era il comportamento di Giuseppe Mazzini contro l’Austria e la storia l’ha
successivamente ampiamente giustificato (il problema della dimensione della violenza utilizzata è stato già esaminato).
In questo secondo caso si può affermare che nel mondo occidentale soltanto una pubblicistica faziosa, eccitando il raccapriccio che
suscita la morte di civili, considera «terrorista» sempre e soltanto il
prevaricato che si ribella.
Nonostante la pressione mediatica, che tenta di imporre una visione mistificata della realtà del mondo, sono certamente atti di terrorismo quelli di un Governo legittimo di uno Stato che impiega i suoi
servizi segreti per abbattere il Governo anch’esso legittimo di altri
Stati, spesso facendone assassinare i responsabili politici liberamente
eletti. Sono atti di terrorismo quelli di un Governo che fomenta rivolte, organizzando gruppi di ribelli armati, in quei Paesi i cui governi
siano ostili ai suoi interessi. Sono atti di terrorismo le iniziative delle
multinazionali occidentali, come è acclarato che fanno, quando finanziano e armano i guerriglieri, per esempio, in Sierra Leone per i diamanti o nel Congo per le immense risorse minerarie.
I fatti del Nicaragua accaduti dopo l’abbattimento della dittatura
di Somoza, che era stato imposto dagli USA, hanno dimostrato come nel mondo dove è espresso il terrorismo di stato statunitense non
c’è alternativa alla lotta clandestina per chi si ribella. Dopo la libera elezione di un governo nicaraguegno non favorevole all’invadenza degli americani, costoro organizzano la guerriglia dei contras e,
dopo aver bombardato il paese con 29.000 morti civili e 57.0000
mutilati, impongono un governo amico. Il successivo governo liberamente eletto non fa esplodere bombe a New York: chiede il rimborso dei danni dei bombardamenti alla Corte di Giustizia Internazionale di Giustizia. La Corte il 27 giugno 1986 condanna gli Usa a
pagare i danni commessi con “l’uso terrorista della forza”. Gli Stati
Uniti, unico paese condannato dalla Corte per terrorismo di Stato, si
oppongono sostenendo che non accettano giudicati internazionali
sul loro operato. Dopo, hanno posto il veto ad una condanna del
112
© ARMANDO EDITORE. La fotocopia non autorizzata è reato.
Consiglio di sicurezza dell’ONU e hanno dichiarato di non volersi
attenere alla decisione dell’Assemblea dell’ONU che ingiungeva di
rispettare la condanna delle Corte di Giustizia. Di fronte a tanta tracotante arroganza degli Stati Uniti, chi, in buona fede, sostiene ancora che la protesta violenta dei popoli prevaricati è moralmente
condannabile, ha bisogno di un controllo della sua capacità di intendere e di volere.
“Terroristi” non sono sempre e soltanto i disperati che non hanno altro mezzo, oltre la violenza pure su se stessi, per attirare l’attenzione del mondo. Terrorismo non è solo ciò che gli occidentali
pretendono che sia considerato “terrorismo”.
L’attentato alla Twin Towersper la maggior parte degli occidentali, colpiti in una delle certezze che avevano più salda - la sicurezza, fondata sull’inviolabilità degli Stati Uniti - è stato uno dei crimini più freddamente efferati della storia del mondo; senza alcuna
discussione possibile.
Per i nazionalisti arabi, è stata un’impresa che ha esaltato la capacità di sacrificio e d’eroismo dei loro giovani. È stato, anche, un
nuovo punto di partenza per il riscatto della dignità dei loro popoli
e per la liberazione delle loro terre dall’occupazione militare o politica o economica dell’Occidente.
Per i fondamentalisti islamici, è stata una lezione all’Occidente
presuntuoso e corrotto ed un monito pesante per i governi islamici
filo-occidentali.
Per i poveri del mondo e per tutti i popoli che hanno subito e subiscono l’aggressività culturale ed economica occidentale, compresi i settantacinque milioni d’individui che costituiscono le minoranze afroamericane, ispaniche ed asiatiche degli stessi Stati Uniti, è
stata una lezione che l’Occidente s’è cercata. Se non hanno gioito,
non hanno neppure provato alcun particolare sentimento di partecipazione al dolore americano: sia i giovani come i vecchi di queste
minoranze statunitensi, dopo l’attentato, hanno mostrato alle televisioni che li intervistavano la più fredda indifferenza per la menomazione subita dal «loro» Paese.
Su sei miliardi di uomini nel mondo, scontate tutte le ufficiali
ipocrisie di facciata, almeno quattro miliardi nel loro cuore non hanno sentito alcuna ragione di solidarietà verso gli americani.
113
Può non piacere, ma l’odio, che il mondo esprime verso gli statunitensi, è il sentimento più compatto che l’umanità - al di là di razze, di culture e di condizioni economiche - abbia mai espresso in
modo così profondo e diffuso: chi non riconosce che questa è la
realtà del mondo, rifiuta di comprenderne gli eventi e mantiene la
testa sotto la sabbia.
Messa da parte l’ipocrita solidarietà ufficiale del Giappone, chi
pensa che anche i giapponesi, memori di Hiroshima e Nagasaki, non
abbiano visto con soddisfazione che finalmente era mortificata anche l’arroganza americana? Duemila e ottocento morti sono un numero insignificante di fronte al milione e più di vittime “civili”
giapponesi fatte dai bombardamenti atomici americani e dalle successive radiazioni.
Le reazioni all’attentato hanno fatto rilevare come gli occidentali valutino i morti del mondo ricco cento volte di più di quelli delle
tragedie dei paesi meno sviluppati, i cui morti rimangono insignificanti cifre statistiche: queste note chiariscono quanto profonde siano le distanze nel dialogo mondiale, quanto sia difficile capirsi e
quanto gravi le possibili conseguenze.
C’è da parte occidentale il tentativo di esorcizzare quanto accade
assumendo un atteggiamento di pregiudiziale ripulsa morale e fisica
verso i kamikaze: gli attentati sarebbero un orrore prodotto dalla più
barbara e fanatica violenza al valore della vita umana. Questi occidentali rifiutano di ammettere che, per miliardi di uomini del mondo, i kamikaze che sacrificano la loro vita sono eroi: eroi che, fedeli alla più antica tradizione islamica, s’immolano per riscattare la dignità di popoli sopraffatti. La ripulsa occidentale è razionalmente
inutile ed ingenua: è umano difendersi; ma è necessario prendere atto della violenza per capire fin dove si può e si vuole spingerla.
Per circa tre quarti del secolo ventesimo, l’Occidente è stato impegnato a contrastare l’espandersi di quel tentativo sclerotico di comunismo che si era affermato nell’Unione sovietica. Preoccupava
non solo per la gestione illiberale del potere politico ma anche per
le esasperate violenze fisiche ai civili di cui il comunismo si era reso protagonista prima in Russia, poi in Cina, in Cambogia con le
stragi di Pol Pot e ovunque era riuscito ad assumere il potere. Per ottant’anni, la straordinaria dimensione di questo tentativo fallito di
114
gestire il cammino dell’uomo verso una meta data, ha assorbito l’attenzione dell’Occidente. Salvo la parentesi della contestazione giovanile del “sessantotto” e la contemporanea protesta per la guerra
nel Vietnam, la società civile occidentale ha trascurato di preoccuparsi di quanto avveniva nel resto del mondo dove il neocolonialismo faceva crescere l’ostilità per il suo incombere rapace.
Il risveglio imposto dall’11 settembre 2001, pur nella crudezza dell’evento e al di là di ogni raccapriccio possibile, chiede realisticamente
di ammettere che i fatti non hanno un loro valore accertabile fermando
l’attenzione sui morti, numerosi o no, occidentali o no, civili o no.
La storia dimostrerà che le iniziative di bin Laden, degli islamici e dei sopraffatti del mondo, fondate su ragioni politico-nazionalistiche ed economico-culturali, non possono essere considerate “terrorismo”: saranno riqualificate come l’unica legittima possibilità di
operare per i popoli impotenti di fronte alla potenza tecnologico-militare occidentale.
Tuttavia, nella situazione attuale, è naturale che la paura di un pericolo incontrollabile crei in Occidente una ripulsa ostile ed è doveroso che i governi dei paesi occidentali difendano la sicurezza fisica dei loro paesi. È senza alternative anche il fatto che i Governi ufficiali di tutti i paesi condannino gli attentati di un “terrorismo” che
non può entrare nel bagaglio riconosciuto degli strumenti di guerra.
L’invito all’uso della ragione è un dovere per tutti: molto spesso, è
un dovere manifestamente ipocrita e senza alcun altro comportamento palese possibile.
Ma l’ipocrisia dei più non farà uscire dalla spirale di violenza
con le condanne morali. La violenza che è stata innescata persisterà
fino a quando la soluzione dei problemi non sarà individuata da una
ragione che riesca a ricordare che le armi sono spuntate quando si
scontrano con i fremiti ideali dei popoli e con le contraddizioni della loro realtà economica.
***
La violenza. Mettendo da parte ogni giudizio morale molto spesso fazioso, guardando al bisogno di serenità di ogni uomo, qualsiasi manifestazione di violenza è sempre da condannare: senza se e
senza ma, da qualunque parte provenga.
115
Le considerazioni sulla guerra e sul terrorismo” hanno chiarito
come sia stato travolto ogni limite morale e come la gravità di quest’aspetto non consenta di giustificare nessuno. Ma il raccapriccio e
molte condanne morali espresse con sbalordito sgomento davanti alla violenza della resistenza irachena e degli attentati islamici sono
soltanto espressione della più scandalosa ipocrisia.
Non è il caso di ricordare quando e perché qualcuno ha sostenuto che la violenza è la levatrice della storia. È certo, però, che questa povera storia umana è così piena di feroci eccidi da quasi non
credere che sia la nostra storia: le orde di uomini in movimento hanno seminato sempre stupri, violenze e massacri di tutti i tipi. Nessuno può sorprendersi. Ma solo l’Europa ‘’civile’’ ha ritenuto di poter
“rimuovere” i suoi genocidi. Non sono quindi inutili i libri come Le
livre noir du colonialisme nel quale lo storico Marc Ferro ci ricorda
i milioni di morti costati ai paesi che l’Europa ha ‘’colonizzato’’ per
‘’portare loro la civiltà e i valori spirituali del cristianesimo”: per
non consentire un’ipocrita visione morale della violenza, all’Europa
è necessario ricordare la sua millenaria efferatezza.
Gli stermini e i saccheggi, che accompagnarono le conquiste di
Cortes e Pizarro nel Centro e nel Centro-Sud America con la distruzione di civiltà raffinate come quelle degli Atzechi, dei Maia e degli
Incas, sono noti perché spesso sono citati come esempio della crudeltà dei ‘’colonizzatori’’ europei. Ma pochi sanno che l’invasione
dell’America del nord da parte di inglesi e francesi fu un genocidio
che ridusse le tribù indigene da oltre sei milioni di indiani a circa
370.000 superstiti: gli americani raccontano sempre come un’epopea eroica questo lungo massacro che nei numeri è vicino al genocidio degli ebrei da parte del nazismo tedesco. C’è una differenza: i
tedeschi non hanno vinto la guerra e la storia è scritta sempre da chi
vince. Non possono esserci genocidi buoni e genocidi cattivi.
Del colonialismo spietato e razzista, Ferro ricorda anche il milione di morti nelle isole caraibiche, l’eliminazione quasi totale degli aborigeni dell’Australia, i due milioni di africani morti nel trasportare tredici milioni di schiavi dall’Africa all’America. Ricorda
come, in mezzo secolo, fra la seconda metà del XlX e l’inizio del
XX secolo, il violento espansionismo coloniale degli imperi europei
abbia fatto diminuire la popolazione africana di oltre cinquanta mi116
lioni di persone: nell’entusiasmo nazionalistico di chi, in ogni paese
d’Europa, acclamava i successi del ‘’suo’’ impero.
Nonostante il loro numero, i morti non sono stati il danno più
grave arrecato dalla violenza dell’aggressione occidentale. Questa
considerazione, che sembra sottovalutare il valore della vita umana,
nasce dalla necessità di guardare con realismo agli effetti lunghi degli eventi e alle conseguenze che incidono sulla prospettiva più o
meno lontana di chi ne è rimasto vittima: i danni più gravi sono stati arrecati squassando l’equilibrio di quelle culture soverchiate con
l’introduzione di elementi culturali ed istituti socio-politici che non
trovavano compensazione nel complesso delle tradizioni locali.
Questi danni sono stati aggravati attizzando le ostilità fra le etnie dei
paesi occupati: il principio del divide et impera ne ha sconvolto le
elementari strutture politiche e distrutto ogni ordine sociale.
Il risultato di tanta violenza è stato un radicale odio che si è
iscritto nel profondo del dna culturale delle residue entità originarie
di quei popoli che oggi guardano agli europei e agli americani come
alla causa di tutti i mali del mondo.
Ma la brutalità della violenza della “cristiana” civiltà occidentale non si è espressa solo con il colonialismo perché la violenza è endemica nella sua come in ogni cultura umana ed ha colpito sempre
in tutte le direzioni. Per fermarci ai tempi più recenti e aver chiara
la dimensione della violenza è utile ricordare il massacro degli Ugonotti e le stragi delle guerre di religione in Europa (secolo XVll), i
giudizi sommari e gli eccidi perpetrati dall’Inquisizione cattolica
anche con le cacce alle streghe di masse isteriche (lungo i secoli del
medioevo e della prima età moderna), i massacri e le esecuzioni
sommarie della Rivoluzione francese in Francia e in Europa anche
al seguito degli eserciti di Napoleone (fine XVlll e XlX secolo), i
continui reciproci massacri fra le popolazioni slave cattoliche, ortodosse e musulmane nei Balcani (lungo i secoli), i raccapriccianti eccidi in Europa nella guerra di trincea del primo conflitto mondiale
(XX secolo), le esecuzioni di massa e gli sradicamenti umani verso
i gulag siberiani nella Russia comunista (XX secolo), il genocidio
degli Ebrei in tutta Europa da parte dei nazisti tedeschi e dei loro
complici europei (XX secolo), le città tedesche ed italiane rase al
suolo dai bombardamenti anglo-americani con centinaia di migliaia
117
di morti civili inermi (XX secolo), i bombardamenti americani con
bombe atomiche delle città giapponesi di Hiroshima secolo e Nagasaki con milioni di civili morti o deformati (XX secolo), la decimazione e deportazione in massa della popolazione cecena da parte
della Russia (XlX e XX secolo), la desertificazione del Vietnam da
parte degli Stati Uniti con bombe al napalm con tre milioni e mezzo
di morti civili (XX).
Com’è facile costatare, il civilissimo Occidente ancora nel XX
secolo, cioè nei nostri giorni, si è distinto per i milioni di uomini
massacrati da una violenza così disumana da aver fatto esprimere a
molti il timore della fine della sua civiltà. E quelli indicati sono solo gli eventi più gravi della ferocia espressa dai “valori” della civiltà
“cristiana” euro-americana che, nell’assumere il controllo del mondo, si è macchiata anche di mille altre risapute criminali crudeltà.
Ma attribuire ai valori e ai principi della civiltà europea la responsabilità di questi comportamenti è assolutamente ingiustificato:
sarebbe un giudizio sommario che non terrebbe conto che questi
eventi sono da addebitare a specifiche ingordigie di avventurieri, a
deviazioni ideologiche, a esasperazioni religiose, a lesioni cerebrali
di qualcuno, a isterie di masse sobillate. Meno che mai è possibile
coinvolgere nella responsabilità delle violenze il Cristianesimo come religione perché questa fede è espressione di amore, di pietà e di
speranza.
È l’uomo che, quando è in balia degli istinti più egoistici, talvolta stimolati anche da fanatismi ideali, ritorna alla sua radice belluina e accantona i freni che i valori della sua civiltà hanno posto. Su
questa realtà è inutile spendere parole: non riescono mai ad essere
adeguate ai fatti.
Per le stesse ragioni, solo chi è totalmente disinformato o chi è in
malafede può sostenere che responsabili della violenza degli attentati degli islamici siano la loro religione e la loro civiltà. Soltanto
chi non conosce la religione musulmana o la vuole presentare in modo artato può citare lo jihad a conferma delle sue affermazioni. Il
Corano parla esclusivamente di jihad difensivo: la responsabilità del
significato aggressivo è di qualche ayatollah integralista che ne ha
elaborato un’interpretazione forzata per specifici obiettivi politici
(fra tutti i libri sacri del mondo, solo la Bibbia, nel Vecchio Testa118
mento, incita gli Ebrei ad una guerra feroce e a non lasciare vivi né
donne, né bambini né vecchi, dopo gli scontri con il nemico)
La violenza non è nella religione – islamismo, cristianesimo,
ebraismo o induismo che sia – è nella natura degli uomini. È naturale guardare alla violenza con repulsione; ma non sono accettabili
le ipocrite condanne morali solo quando è espressa dai musulmani.
Per accantonare il moralismo a senso unico che condanna solo la
violenza degli altri, può essere utile ricordare anche le recenti disumane torture americane ai prigionieri di Abu Graib e di Guantanamo o ricordare i palestinesi decapitati dai soldati israeliani che ne
mostrano entusiasti le teste infilzate su picche di ferro. È stata già ricordata l’efferata violenza “cristiana” della guerra partigiana italiana degli anni Quaranta.
Non possiamo arrenderci. Ma è stato già detto: chi è senza peccato lanci la prima pietra.
***
L’analisi di argomenti controversi potrebbe continuare. Chi ha
onestà intellettuale ha già chiare le ragioni per le quali si deve essere prudenti nel giudicare gli avvenimenti dei nostri giorni che non
consentono moralismi di parte e che sono stati fatti degenerare dalle più infide ipocrisie.
2. Uno sguardo avanti
Chi ferma l’attenzione soltanto sull’integralismo religioso e sul
presunto scontro di civiltà fa un torto alla sua intelligenza e non dà
un sostegno alla società occidentale nella quale si diffondono paure
ed arroganze che sollecitano irrazionali iniziative aggressive per difendere posizioni che i processi economico-demografici in corso
stanno già travolgendo.
È necessario, invece, tentare di rendersi conto di quanto sta accadendo nel mondo a prescindere dai venti di guerra che lo agitano.
Chi non vuole avere idee chiare si distragga: Oriana Fallaci vada in
vacanza.
119
Nella storia dell’uomo ci sono eventi scelti come simboli di svolte epocali: la caduta dell’impero romano nel 476 d.C., la scoperta
dell’America nel 1492, la Rivoluzione francese nel 1789 e altri
eventi ancora che gli storici possono aver scelto in funzione del loro modo di raccontare la storia. È risaputo che questi simboli e queste date sono solo convenzionali perché il processo evolutivo della
realtà socio-culturale umana è un continuum lungo il quale le conquiste sociali, politiche, economiche, scientifiche e culturali in genere sono il risultato di un lento accumulo di tentativi, di fallimenti
e di rari successi.
Nei nostri giorni da più parti è stata avvertita l’eccezionalità della situazione i cui eventi simbolo possono essere indicati nella caduta del Muro di Berlino nel 1989 e nella contemporanea definitiva
affermazione della rete Internet nel mondo.
La rilevanza di questi riferimenti è ovviamente nel loro valore
simbolico particolare e, a chi cita l’11 settembre 2001 e le Twin
Towers, è sufficiente ricordare che, a parte la spettacolarità dell’evento, chi non fosse stato distratto avrebbe potuto cogliere uguale
significato nella caduta di Dien Bien Phu del 1954, nella nazionalizzazione del canale di Suez del 1956, nella battaglia di Algeri del
1957 e, soprattutto, nella disfatta dell’esercito americano nel ‘’pantano’’ del Vietnam (1973).
Da troppo tempo ormai i gioghi coloniali stanno stretti a tutti i
popoli e questi avvenimenti esprimono anche simbolicamente il rifiuto di quel colonialismo che tenta di sopravvivere con mille trucchi. Pur se in molti non sono d’accordo nel considerare l’attacco alle Twin Towers l’espressione di un revanscismo nazionalistico, anche costoro non possono ignorare le precise dichiarazioni in questo
senso di bin Laden e dei suoi “complici”.
La caduta del Muro di Berlino e la diffusione di Internet, invece,
sono eventi nuovi che proiettano concettualmente avanti. Il valore
della caduta del Muro di Berlino, che era stato il simbolo della separazione di due mondi antagonistici, è in primo luogo nell’essere
stato il momento della conquista della definitiva consapevolezza su
tutta la Terra che la più casuale libertà è la condizione per la migliore espressione delle attese umane. In secondo luogo, il suo valore è anche nell’aver rappresentato la fine del contrasto fra due modi
120
alternativi di concepire la prospettiva dell’operare dei popoli: sono
state queste le premesse che hanno favorito l’esponenziale diffondersi di un globale interscambio umano non solo in termini economici ma anche culturali, etnici e demografici. Nonostante le attuali
gravi contraddizioni della globalizzazione economica di cui certamente non sono responsabili i principi di libertà che la ispirano,
quell’attimo ideale del 1989, dopo il quale è radicalmente mutato il
modo di farsi della politica mondiale, rimane un punto di riferimento simbolico universalmente riconosciuto.
Negli stessi anni durante i quali maturava la caduta del Muro di
Berlino, la messa a punto delle più opportune procedure tecniche
consentiva la realizzazione di un sistema di comunicazioni e trasmissione dati attraverso una rete di computer sparsi in tutto il mondo: nasceva Internet. L’efficace semplicità realizzata nei modi di utilizzare questa rete mondiale ne ha consentito la diffusione a centinaia di milioni di utilizzatori che in tutti i continenti hanno imparato a ‘’navigare’’: giovani ed anziani, uomini e donne, persone della
più varia cultura e a tutti i livelli, da tutti i paesi del mondo, che abbiano un computer o utilizzino le postazioni offerte nei Net Point o
nei Cyber Cafè, quotidianamente entrano (‘’navigano’’) attraverso
una quantità impressionante di canali nazionali e internazionali in
un arcipelago infinito di interessi e informazioni culturali di ogni tipo. Il desiderio di conoscere il mondo, che è stato messo “a portata
di mouse”, si accompagna alla volontà di aprire i propri orizzonti
con un’informazione sempre più autonoma. Con Internet è possibile anche discutere di problemi culturali, religiosi, politici, ecc. collegandosi attraverso una “chat line” con chiunque in qualsiasi angolo di tutti i continenti. Le centinaia di milioni di computer collegati
in un crescendo esponenziale, con l’ovvia differenza attuale di una
maggiore diffusione nei paesi più sviluppati, sono il punto di riferimento certo, al di là di qualsiasi politica statale di controllo delle linee telefoniche, della prospettiva di una inarrestabile circolazione
delle idee che, accanto alla diffusione delle immagini consentita dalla televisione, consente già un dialogo mondiale di una intensità e
con effetti oggi non definibili.
Inoltre, un’ulteriore rilevanza della diffusione di Internet sta nella tendenza all’unicità della lingua utilizzata da tutti gli utenti di
121
questo mezzo di comunicazione. È risaputa l’importanza che la lingua ha avuto fin dall’inizio del dialogo umano e la coesione o la diffidenza determinate dalla condivisione o meno dello stesso linguaggio. Quando attraverso Internet, anche fra un secolo, tutto il mondo
sarà in grado di capirsi con un’unica lingua, mille barriere saranno
state abbattute.
Caduta del Muro di Berlino e Internet sono i simboli più emblematici del processo rivoluzionario nascente dal dialogo planetario in
atto che, per la novità del suo raggio totale, sta generando le più radicali reimpostazioni economiche e le più violente manifestazioni di
insoddisfazione locale e generale con un numero incredibile di guerre e di guerriglie in tutti i continenti con esclusione della sola Europa, che però deve fare i conti con la protesta islamica e con focolai
di irredentismo regionale che non mancano di aggiungere preoccupazioni non meno gravi.
Può anche essere un caso che l’avvio di questo incontro-scontro
abbia trovato pronto un sistema di trasmissione delle informazioni
della potenza totale che ha Internet; ma il caso è stato sempre uno
dei protagonisti fondamentali del processo evolutivo che si esprime
nella storia umana: rimane il fatto che la potenza di Internet e la radicalità dell’attesa di tutti i popoli di potersi esprimere in piena libertà e nel più pieno rispetto dei propri diritti e della propria dignità
stanno sommuovendo il mondo oltre ogni allarmata previsione e
molto oltre quanto si ha il coraggio di ammettere.
Di questa sommossa uno degli strumenti più violentemente ineluttabili è la reimpostazione totale della situazione demografica
mondiale.
Già oltre dieci anni fa, al Convegno mondiale di genetica del
Cairo nel 1993, i biologi hanno sostenuto, con ampie e documentate analisi, le conseguenze, nel lungo termine, dell’interscambio biologico determinato dai movimenti delle masse umane nel mondo:
entro 500 anni sulla terra la “razza” indoeuropea sarà estinta. La sfida biologica alla “razza bianca” è assoluta e totale: la sua sopravvivenza futura non è soltanto posta in discussione; è radicalmente pronosticata come impossibile.
Che gli uomini fra cinque secoli possano esser tutti neri o tutti
gialli non è una disputa che possa interessarci più di tanto. L’infor122
mazione serve per richiamare la nostra attenzione sul fatto che siamo di fronte ad una sfida senza alternative che coinvolge tutte le etnie del mondo in uno scambio di rapporti sempre più frequenti e
sempre più ampi. Chi non vuole guardare alla prospettiva futura dell’uomo e rimane istericamente a difesa delle sue radici etno-culturali, non si rende conto di essere vittima di antichi e recenti tabù e di
una radicata diffidenza alimentata dall’ignoranza e dalla paura.
La sfida demografica dei popoli africani e asiatici ai popoli europei è assoluta e, purtuttavia, non è un evento «voluto». È, infatti,
il risultato del trasferimento spontaneo e non gestito di uomini in
esubero nelle loro terre dove il comportamento procreativo, anche se
condizionato da informazioni religiose, morali, politiche, economiche e sociali, rimane affidato ai naturali e liberi impulsi degli individui. Cioè, pur non trascurando le politiche di contenimento delle
nascite, attuate o proposte in tutti i paesi ad esuberante crescita, non
trascurando le politiche di stimolo allo sviluppo economico e non
trascurando le iniziative di controllo e di contenimento delle masse
emigranti, questo fenomeno deve essere guardato per quello che è:
un grandioso processo naturale con un suo «progetto» ecologico che
tende prima a far crescere e a far incontrare e poi a fondere tutte le
genti del mondo.
Il movimento non è, come dice qualcuno, soltanto un fenomeno
epocale: è un evento inarrestabile, progressivamente crescente, definitivo. Non si muovono soltanto le masse umane dai paesi poveri
verso quelli ricchi o i profughi, che pure nei cinque continenti sono
milioni e milioni. Si muovono anche le masse rurali verso le città
che stanno diventando megalopoli incontrollabili e si muovono da
un paese all’altro flussi crescenti di lavoratori specializzati, dirigenti di aziende, uomini d’affari, sportivi e artisti in un interscambio
economico, culturale ed umano che tende a costruire un’unica civiltà di cui non è possibile prevedere il modo d’essere.
Nei secoli a venire la tendenza appare essere verso un unico ecosistema umano che, nell’incontro di mille diversità, dovrebbe riuscire a trovare i modi per un meno conflittuale dialogo fra le genti.
Negli immediati decenni, invece, la sfida demografica determinerà
un radicale mutamento del panorama umano soprattutto nell’Occidente “bianco”, dove le conseguenze sono ancora tutte da accertare.
123
La popolazione mondiale è cresciuta dai 2,5 miliardi del 1950 ai
circa 6,2 miliardi del 2002: questa crescita nasconde, ma non tanto,
la sfida per il predominio del mondo. Nell’arco dei quarant’anni indicati, la popolazione dei paesi più sviluppati è passata da 830 milioni a 1.232 milioni con una crescita del 48% mentre quella dei paesi meno sviluppati è passata da 1,7 a quasi 5 miliardi con un aumento oltre il 150%. Le proiezioni recenti effettuate dagli uffici studi delle Nazioni Unite, per il prossimo futuro, prevedono le seguenti ipotesi medie di modificazione della situazione:
– nel 2025, la popolazione dei paesi più sviluppati passerà a 1.415
milioni mentre quella dei paesi meno sviluppati passerà 7.056
milioni;
– 2050, la popolazione dei paesi più sviluppati tornerà indietro a
1.232 milioni mentre quella dei paesi meno sviluppati continuerà
a crescere a 7.886 milioni.
Le proiezioni esprimono con estrema “gravità” la prospettiva
della “razza bianca” quando dal computo dei paesi più sviluppati si
tolgono i dati del Giappone e si rimane alla popolazione dell’Europa e dell’America settentrionale. La prospettiva per l’Europa, senza
eventi che facciano radicalmente mutare i tassi di fecondità e di
mortalità, è in primo luogo l’invecchiamento della popolazione cui
seguirà la progressiva diminuzione con gravi conseguenze per la
struttura produttiva e per l’equilibrio degli istituti di «welfare».
Ma queste proiezioni sintetiche redatte dagli uffici studi delle
Nazioni Unite specializzati nelle analisi dei processi evolutivi delle
popolazioni, non dicono nulla su quale sarà l’effettiva proiezione,
complessiva e nel dettaglio, della popolazione dei vari paesi europei
perché non analizzano i fenomeni immigrativi e non chiariscono
l’incidenza che avranno sulle prospettive demografiche di questi
paesi. Cioè, per i paesi europei, le prospettive d’incremento o di diminuzione delle popolazioni sono state calcolate tenendo conto delle tendenze che si sono espresse negli ultimi decenni, analizzando i
fattori che influenzano tali tendenze: età del matrimonio, invecchiamento della popolazione, alfabetizzazione, posizione sociale della
donna, ecc. ed immigrazione nel suo insieme.
Ma quale sarà il contributo quantitativo degli immigrati e il com124
portamento delle masse asiatiche ed africane immigrate nei paesi
europei non appena avranno consolidato a tutti gli effetti il loro status di cittadini regolari dei paesi che li ospitano?
Per la sola Italia, per esempio, le proiezioni ufficiali (ISTAT, INPS) affermano che gli italiani autoctoni saranno circa 44 milioni nel
2025 e circa 38 milioni nel 2050: poiché è anche previsto che la popolazione complessiva rimarrà intorno a 56-57 milioni, questo vuol
dire che nel 2050 in Italia ogni due italiani autoctoni ci sarà un «italiano» non autoctono.
Considerato che le popolazioni immigrate hanno un’elevata fertilità alla quale si oppone la crescita zero delle popolazioni autoctone, è evidente come la sfida alla “razza bianca” fin dentro il cuore
dell’Europa, via via che il rapporto dei numeri cambierà, diventerà
progressivamente un problema sempre più difficile da tenere sotto
controllo: accanto agli arabi e agli islamici in genere, africani, caraibici, indiani, cinesi, filippini, indonesiani e malesi stanno portando alla “razza bianca” una sfida ultimativa. Si può anche tentare di
frenare con le armi i flussi d’immigrati in arrivo come già si fa, ma
è impossibile svuotare il mare con un bicchiere. Alla legge dei numeri non si può opporre nulla: i popoli europei, dove non sono in diminuzione, sono a crescita zero; le popolazioni africane ed asiatiche
hanno trends di crescita esplosivi: è solo questione di tempo.
L’unica speranza degli europei è affidata al caso: i fattori che
hanno influenzato e possono influenzare le tendenze demografiche
sono così vari, numerosi e imponderabili da non consentire nessuna
previsione che possa dirci con certezza quale sarà il futuro demografico degli uomini. Il progressivo superamento del concetto ottocentesco di nazione potrà portare a minori conflitti ideologico-culturali fra paesi vicini. Ma il livello di tensione, che i vari gruppi etnici potranno esprimere fra di loro all’interno di ogni paese, dipenderà dall’intelligenza o meno dei governi e delle popolazioni autoctone.
La presenza nel mondo di milioni di oriane fallaci, con la loro ottusa difesa di un mondo superato dagli eventi della storia, non promette nulla di buono.
Fra le ragioni delle tensioni potranno anche esserci molte espressioni di estremismo fondamentalista - islamico, ebraico, cristiano e
125
induista - ma gli obiettivi della più gran parte delle violenze saranno economici e politici. Le religioni continueranno ad essere utilizzate come collante delle masse per sostenere princìpi ed interessi.
Insieme agli scontri civili interni e ai conflitti apparentemente
ideali di tutti gli integralismi, la guerra mondiale, nel suo modo nuovo, violento ed informale di essere combattuta, continuerà fino al
paritario accesso di tutti i popoli alle limitate risorse del pianeta. Il
problema si può anche ipocritamente rimuovere, come si continua a
fare, ma se non cambierà la realtà etico-economica del mondo, questa guerra squasserà il pianeta fino a quando i paesi più industrializzati non saranno riusciti, se non a sradicare, almeno a mitigare il loro opprimente incombere.
La fame, nei millenni, è stata accettata dall’uomo come una condizione naturale della vita. Oggi non è più così: attraverso la televisione tutti nel mondo constatano il benessere dell’Occidente e,
quando apprendono che le risorse che consentono un benessere così
smodato sono prodotte anche nel loro paese, l’invidia, la rabbia e
l’odio sono le reazioni più spontanee e naturali. È un fatto così noto e logoro che ormai è ritenuto superfluo parlarne. Ma questa supponenza sarà castigata: qualsiasi cosa possa accadere, la violenza
farà pagare in un modo o in un altro questo conto ai paesi occidentali.
Il nocciolo del problema economico è un aspetto risaputo della
realtà mondiale: secondo le statistiche del M.I.T. (Massachussets Institute of Technology) e del WWF, gli Stati Uniti, con una popolazione che non raggiunge il 5% della popolazione mondiale, consumano da soli circa il 30% delle principali risorse del pianeta. Il resto del mondo più sviluppato e occidentalizzato, con una popolazione intorno al 20% della popolazione mondiale, consuma un altro
34% di queste risorse. Al rimanente 75% circa degli abitanti della
Terra ne rimane appena un 36%, con oltre due miliardi di indigenti
assoluti. Senza fare valutazioni morali che lasciano immodificata la
situazione, si deve aver chiaro prima di tutto che si parla delle risorse - materie prime e prodotti agricoli - e non dei prodotti industriali che dipendono dal grado di sviluppo tecnologico dei paesi.
Sulla base della percentuale dei consumi dei soli Stati Uniti, secondo il M.I.T., se la Cina, il cui sviluppo è sempre più impetuoso, vo126
lesse raggiungere lo stesso livello di consumi, sarebbero necessarie
le risorse di almeno altri tre pianeti grandi come la Terra.
Questa situazione fa comprendere che ciò che è stato definito come l’Impero statunitense non è che il risultato della pretesa americana di garantirsi fonti di accesso alle materie prime adeguate ai livelli dei suoi consumi. Presto le esigenze della Cina e, dopo, quelle
dell’India imporranno una revisione di questi livelli, con le buone o
con le cattive: sono i bisogni di quasi due miliardi e mezzo di persone contro i risaputi sprechi di appena trecento milioni. Davanti a
quest’enorme problema, è sorprendente constatare come i più siano
pregiudizialmente divisi pro o contro gli Stati Uniti e, assunta questa posizione, non riescano a riflettere sulle ragioni delle contraddizioni americane. È superficiale ritenere che questo Paese esprima
solo il meglio della modernità politica, economica e scientifica o solo il massimo della violenza e della rapacità sul mondo: probabilmente, esprime l’uno e l’altro.
Anche non dimenticando che nei millenni l’idea di impero è stata riferita a periodi di pace (imposta), di benessere e di diffusione
della cultura, oggi è mutata non solo la coscienza etico-politica dei
popoli ma anche la consapevolezza che ognuno di essi ha del proprio valore culturale: l’impero viene percepito come l’espressione
del più egoistico interesse nazionalistico in un mondo che tenta di
avere un respiro planetario, anche se ancora a fatica e fra mille contrasti.
Nella realtà mondiale moderna, l’Impero statunitense, con la sua
pretesa di imporre un “ordine mondiale” con la guerra preventiva,
esprime soltanto il rantolo di un’agonia che può durare anche qualche generazione ma che ha il suo cancro inguaribile nella percezione che la difesa del livello dei consumi del popolo americano può
contare solo sulla sopraffazione armata del resto del mondo. La morale internazionale che è stata costruita nell’ultimo secolo non consente più un impero, qualunque ne sia il suo modo d’essere: nella
non procrastinabile prospettiva di una crescita dei consumi dei paesi meno sviluppati, è evidente come il problema della redistribuzione del potere di accesso alle risorse del pianeta sia scottante nell’immediato e deflagrante nel prossimo futuro.
Se i paesi più industrializzati, forti della loro potenza militare,
127
continueranno a ritenere di poter rimuovere questo problema coprendo la malafede con la solita affermazione della necessità di difendere i ‘’valori’’ ideali di libertà, in tutto il pianeta una legittima
guerriglia improvvisa, violenta e continua esprimerà una ferocia di
cui i soliti ‘’ingenui’’ diranno di non spiegarsene l’efferatezza, che
continueranno a condannare con la più faziosa, scandalizzata morale.
Questa violenza si esprimerà ovunque nel mondo: perché accanto al problema delle risorse, l’Occidente ha anche la necessità di
mantenere il più attento controllo strategico delle vie d’accesso ad
esse e il controllo della situazione geopolitica generale.
Finché persisterà così diffusa presenza rapace, la rabbia del
mondo, che è già espressa nei modi più irrazionali anche con scontri autodistruttivi fra comunità religiose ed etnie, non è la manifestazione di una pazzia collettiva. La situazione ha coinvolto radicalmente la persona umana con la sua necessità di soddisfare i bisogni
primari e di veder rispettata la dignità politica e culturale. Tutti - popoli meno sviluppati, nazioni mortificate, gruppi di interessi economici, aree culturali e comunità religiose - in modo più o meno violento, sono in campo in uno scontro che sembra diviso in tanti scontri locali ma che sono legati dall’insoddisfazione generale.
Molti hanno già descritto la situazione parlando di Quarta Guerra Mondiale (la Terza sarebbe stata la Guerra Fredda). L’espressione può essere accettata, anche se questa è la Prima vera guerra mondiale.
Occorre aggiungere, però, che gli avvenimenti di questa guerra
senza regole non dovranno mai sorprendere: siamo di fronte ad un
“normale” conflitto la cui apparente eccezionalità è determinata dal
fatto che la società umana ha raggiunto solo adesso un confuso dialogo globale nel quale mille egoismi si scontrano per i più imprevedibili motivi.
Non sorprenda, allora, che la violenza più improvvisa possa
esplodere nei luoghi più impensati e anche, forse soprattutto, dove
sembra sia stata raggiunta un’illusoria pacificazione. Non sorprenda
neppure che la violenza si alterni a periodi di apparente tranquillità.
La rivolta – individuale, di gruppi o di masse – sarà sempre più disorganica e spontanea.
128
Dovremo imparare a convivere con la violenza anche perché è irrealistico pensare che il mondo occidentale possa recitare il mea culpa e rinunziare alle posizioni di vantaggio raggiunte. Non solo perché nessun uomo ha mai rinunciato a quanto già ha conquistato ma
anche perché una rapida riduzione dei consumi del mondo più sviluppato sarebbe un’iniziativa controproducente anche per il benessere dell’intera comunità umana mondiale. Si avviterebbe un ciclo
regressivo: minori consumi di prodotti finiti, minori consumi di materie prime, disoccupazione, ulteriori minori consumi e così via fino
a conflitti armati e conseguenze globali inimmaginabili.
Il mondo è ad un’impasse ben più grave di quel che si dica: in
molti pensano che siamo in un tunnel in fondo al quale non ci sia
una luce ma un treno che marcia in senso contrario al nostro.
© ARMANDO EDITORE. La fotocopia non autorizzata è reato.
3. Una prospettiva probabile
La presenza dell’Occidente con le sue attività economiche e i
suoi interessi strategici, anche su quei paesi caratterizzati da lento
sviluppo economico e da vivacità demografica, ha stimolato un dialogo mondiale che tende verso una globalizzazione dei problemi.
Questo processo ha posto in evidenza una serie di differenze fra le
quali la più rilevante è la diversa visione della vita di quei popoli la
cui cultura non ha preso in considerazione l’idea ebraica per la quale solo il successo pratico confermerebbe ad ogni uomo la benevolenza di Dio. Questi popoli guardano con mille riserve allo stile di
vita esasperato e dilaniante degli occidentali e non accettano che il
loro modo di vivere sia considerato un ritardo civile.
La visione della vita radicalmente diversa, che comincia ad essere parzialmente mitigata dalla generale accettazione dei benefici
della tecnologia occidentale, ha tracciato una linea discriminante assoluta che mette in evidenza le effettive cause dei problemi umani:
la fame, la sete, le malattie, il bisogno di energia e il bisogno di rispetto della propria dignità.
Questa linea divide i popoli ponendoli su due opposte sponde: da
una parte, la necessità di difendere il livello dei consumi raggiunto;
dall’altra parte, la necessità di riequilibrarlo. Com’è stato già ricor-
129
dato, non è facile per il mondo tollerare ancora che un solo paese con
circa il 5% della popolazione mondiale, gli Stati Uniti, consumi oltre
il 30% delle principali risorse del pianeta mentre altri tre paesi che
rappresentano circa il 50% della popolazione mondiale - Brasile, Cina e India - ne consumino insieme appena il 10% (dati M.I.T. e
WWF). Questo problema è complicato anche dalla necessità di riequilibrare il rapporto fra l’uomo e la natura: molti aspetti dell’industrializzazione di tipo occidentale e della trascuratezza dei popoli
meno sviluppati hanno compromesso l’equilibrio ecologico della
Terra e aggravano le ragioni dello scontro fra le due parti del mondo.
Problemi tanto complessi sono difficili da risolvere e non si deve
volgere lo sguardo ad altre ragioni per ricercare il perché della contestazione dell’avidità dell’Occidente che ha radicato negli altri un
odio profondo. Quest’odio c’è e non è soltanto islamico. Può non
piacere, ma l’odio, che il mondo esprime verso gli occidentali, è il
sentimento più compatto che mai l’umanità abbia espresso in modo
così profondo e diffuso: chi non ammette e non riconosce che questa
è la realtà del mondo, non è in grado di comprenderne gli eventi.
E l’“altro” mondo vuole recuperare anche la sua dignità. La sua
attuale condizione non è un’emozione suscitata da questa o da quella guerra più o meno ingiustificata, non è invidia della ricchezza dell’Occidente, non è conseguenza della costante sottovalutazione culturale: è tutte queste cose assieme. È il risultato della rozza insensibilità con la quale l’Occidente ha sempre umiliato la dignità degli altri popoli cui è aggiunta la rabbia per la secolare rapina: l’Occidente
è chiamato a rispondere della sua avidità, dell’arroganza culturale,
del razzismo antropologico, del fondamentalismo politico e dell’ipocrisia di valori sbandierati per mascherare gli interessi economici
La profondità dell’odierno sentimento d’odio antioccidentale impone di superare la tendenza ad etichettare le posizioni altrui per poterle rifiutare in blocco. In politica, nel secolo scorso, i maestri di
questa tecnica sono stati i peggiori comunisti. Ma anche nel campo
liberal-democratico non sono mancati i cultori di questa pratica assai
poco intelligente. Chi s’interessava di politica negli anni Settanta del
secolo scorso ricorderà come le considerazioni sulla povertà dei paesi meno sviluppati erano liquidate con apodittiche espressioni come
‘’rozzo antimperialismo’’ e ‘’pietismo terzomondista’’. Oggi è rite130
nuta più pertinente quella di “antiamericanismo’’ che pretende di includere anche un’accusa di razzismo socio-economico-culturale. Le
etichette, in effetti, esprimono soltanto il rifiuto di discutere di chi le
utilizza e la sua presuntuosa inadeguatezza culturale.
Quest’incapacità di dialogo è determinata dal fatto che per la più
gran parte degli occidentali è difficile ammettere o anche soltanto
pensare che il modo d’essere della civiltà occidentale possa ledere
la serenità dell’intero pianeta. È utile leggere Il vizio occulto dell’Occidente di Massimo Fini: «Nel Rapporto che recentemente
George W. Bush ha inviato al Congresso, dov’è teorizzata la “guerra preventiva”, dove si afferma che l’America “non intende minimamente consentire ad alcuna potenza straniera di colmare l’enorme divario apertosi negli armamenti”, ed è la prima volta che uno
Stato pretende il disarmo di tutti gli altri, postulando, in un delirio
di onnipotenza, un’egemonia non solo attuale ma eterna, qualcosa di
molto simile al “Reich dei mille anni” di Adolf Hitler, si dice anche
che l’America userà la sua potenza, divenuta unica, per il “bene delle società libere”.
Quali sono le società libere? Ed esistono società libere, libere di
essere se stesse, come la storia le ha fatte, secondo le proprie tradizioni, i propri costumi, la propria vocazione, secondo la volontà e il
consenso dei propri membri, quando sono sottoposte ad un simile
diktat? La domanda è tanto più legittima perché il documento Bush
aggiunge: “C’è un solo modello possibile: la libertà, la democrazia
e l’impresa, valori che devono essere protetti ovunque”.
Non c’è posto per valori diversi. Che il modello ha da essere unico e che dev’essere quello occidentale, non è più una tendenza di
fatto, ora è un atto costitutivo, quasi giuridico, che sta scritto sulla
carta. È la nuova Costituzione Mondiale… L’Islam, come qualsiasi
altra diversità culturale, sarà accettato, e potrà continuare ad esistere nel nuovo ordine mondiale, solo nella misura in cui si omologherà
all’Occidente.
Vale per tutti… A colonizzare l’intero pianeta non siamo spinti
solo dai nostri interessi, crediamo sul serio – questo è il vizio oscuro dell’Occidente – di avere “il migliore dei modelli possibili”. E
quando qualcuno, qui in Occidente, osa avanzare dubbi sulla bontà
del modello, quasi subito si alza in piedi un cretino che con gli oc-
131
chi iniettati di sangue illuminista urla: «ma indietro non si torna!”
Bravo. La tragedia è proprio questa. Idiota.».
Questa conclusiva, energica contestazione di Massimo Fini della
volontà dell’Occidente di omologare il mondo sul suo modello, segue una vivace esposizione delle ragioni filosofico-economico-sociali che spingono lo scrittore a indicare il modello di vita occidentale come la causa evidente di una ‘’follia’’ che c’impedisce di renderci conto che siamo prigionieri di un meccanismo economico-industriale che pretende la nostra costante insoddisfazione per non
collassare, fino alla nostra morte. Ho esposto in altro saggio le ragioni per le quali non condivido il giudizio radicalmente e definitivamente negativo della realtà occidentale. Tuttavia è stato riportato
perché esprime con efficacia significativa una delle ragioni per le
quali l’Occidente a guida statunitense è un problema planetario: ritiene di non dover rispettare più nulla che sia culturalmente diverso.
***
L’intricata complessità dei problemi ricordati ha determinato uno
stato confusionale del mondo di cui la prima vittima è l’Occidente.
Qui, nonostante il livello di benessere raggiunto, il sentimento più
diffuso è un’angoscia alimentata dalla paura di pericoli che si temono sempre nell’aria. Le raccapriccianti notizie sui morti straziati dagli attentati islamici, hanno convinto i più che questa paura sia dovuta all’orrore suscitato dalla violenza. Purtroppo non è solo così:
l’ansia ha anche altre motivazioni. La preoccupazione per gli attentati c’è, ma concentrare l’attenzione solo su questa rischia di provocare iniziative inadeguate e conseguenze ancora più dannose.
L’incerta definibilità di tutti i motivi dell’apprensione delle popolazioni occidentali fa tornare psicologicamente comodo metterla
interamente a carico della violenza islamica. Serve a rimuovere
l’impotenza di fronte a ben più gravi problemi che, da tempo,
un’ampia saggistica ha affrontato nel dettaglio in termini economici, socio-politici, psicoanalitici, etno-antropologici e semplicemente
demografici. La diffusa conoscenza di questi argomenti che riempiono centinaia e centinaia di studi, di cui nel 1972 il saggio “I limiti dello sviluppo” del M.I.T fu uno dei primi impegni, esonera da
132
un’approfondita ripresa in queste pagine nelle quali sono sufficienti
brevi cenni.
In modo essenziale si ricorda che la sicurezza psicologica degli
occidentali, conquistata con la vittoria sulla fame che ha afflitto per
millenni tutti gli uomini del pianeta, in effetti è minata da almeno altre quattro ragioni certe che determinano un generale stato di fragilità emotiva.
La prima ragione dell’ansia è una conseguenza indesiderata della mobilità consentita agli uomini, alle merci e ai mezzi finanziari
dalla nuova realtà tecnologica del mondo: la rapidità dei mezzi di
trasporto, la potenza dei mezzi di comunicazione e la globalizzazione dei mercati hanno posto le condizioni favorevoli per la delocalizzazione delle attività con grande impiego di mano d’opera verso i
paesi a bassi salari. Anche rimanendo nella stessa Europa, il costo
orario di un operaio, che nei paesi più ricchi va dai 20 ai 27 euro, già
nei paesi europei ex comunisti scende a meno di 2 euro e ancora più
scende nei paesi asiatici, sudamericani e africani: sono evidenti i benefici che ricavano le aziende che vi trasferiscono i loro stabilimenti anche in considerazione dell’assoluta flessibilità dei locali rapporti di lavoro. La conseguente sempre più preoccupante precarietà
del lavoro dipendente, aggravata dalla crisi del welfare state, sta
diffondendo anche nel mondo occidentale in centinaia di milioni di
lavoratori e di giovani, un’ansia per il presente e ancor più per il futuro che era assolutamente sconosciuta fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. La prospettiva non può che essere un livellamento dei salari dei lavoratori di tutto il mondo: a quale livello?
La mondializzazione immaginata come produttrice di benessere per
tutti, è vissuta oggi dai lavoratori occidentali come una grave minaccia: non solo per il danno diretto della diminuzione della domanda di lavoro ma anche per l’impotenza delle organizzazioni sindacali che vedono spuntata l’arma dello sciopero: le aziende reagiscono trasferendosi interamente nei paesi dove trovano lavoro flessibile e a buon mercato.
Una seconda ragione d’ansia è nella consapevolezza che la concorrenza dei manufatti prodotti nei paesi di nuovo sviluppo industriale - paesi del sud-est asiatico ma soprattutto Cina - aggrava la
situazione d’insicurezza delle aziende e dei lavoratori occidentali
133
che sempre più insistentemente chiedono ai governi iniziative di
blocco doganale per le merci provenienti da quei paesi: la fiducia in
una crescita degli scambi internazionali di beni e servizi con espansione dello sviluppo e della produttività generale è considerata sempre più irrealistica. La globalizzazione è diventata una prospettiva
dalla quale difendersi. La gravità della situazione che si teme si prepari sul piano economico, tende a far dimenticare che le guerre doganali sono il preludio di più cruente guerre militari. Tenendo conto
delle dimensioni della Cina, fra la paura dell’incertezza economica
e la paura della guerra non è certo di quale paura si terrà più conto:
l’insicurezza cresce.
Un’altra inquietudine inconscia è suscitata dalla pressione mediatica che enfatizza i problemi ecologici: anche le notizie scientificamente più serie sono date in un modo che sollecita la più vasta eco
di scandalo e di paura. Il panorama della precarietà del presente e
dell’incertezza del futuro è reso più fosco dal modo esasperato ed
ultimativo con il quale sono date le notizie sull’inquinamento dell’atmosfera, sulla progressiva inadeguatezza delle risorse idriche
della Terra, sull’avvelenamento chimico dei terreni agricoli, sulle
calamità climatiche e sugli altri problemi globali che affliggono il
nostro pianeta. Questo terrorismo mediatico alimenta un’angoscia
ancora più profonda di quella suscitata dal terrorismo effettivo perché, dando una responsabilità ultimativa all’uomo, esaspera per il
senso d’impotenza che incute di fronte ai disastri della natura.
Titolano i giornali a tutta pagina: “La situazione è apocalittica:
per poter sopravvivere l’umanità dovrebbe spostarsi verso altri mondi’’… Il WWF: “Record di sprechi: fra 50 anni la Terra morirà”…
“’il 35% delle specie marine estinto fra il1970 e il 1999’’… “il 12%
delle foreste primarie è scomparso fra il 1970 ed oggi”… “Acqua, la
grande sete si avvicina: aiuto! Ce la siamo bevuta tutta’’… “Mediterraneo, ultimo avviso: rischia di spegnersi con il suo mondo sommerso”… “Effetto serra, guardate la cartina: il polo si stringe, la
Groenlandia si scioglie, New York allagata, l’Italia un deserto, 5 miliardi di persone senz’acqua: entro cento anni’’ E così via.
Siamo di fronte ad un’esasperazione delle notizie proveniente
quasi sempre da fonti scientifiche o da organizzazioni di volontariato senza potere politico: al di là della smania di protagonismo di
134
qualcuno, sembra che molti, ognuno dietro i suoi idoli, non si accorgano della tempesta di violenta confusione con la quale le informazioni più strumentali flagellano il mondo.
I conflitti d’interessi che nascono fra gli Stati evidenziano la fondatezza delle preoccupazioni: già la Conferenza di Stoccolma del
1972 – pur nella relativa moderazione delle prime analisi sulla gravità e sulle cause dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo – aveva messo in evidenza la differenza di opinioni fra i rappresentanti dei Paesi ricchi e quelli dei Paesi poveri. Ma è nel 1992, alla Conferenza di Rio de Janeiro, che emergono le posizioni divergenti fra i Paesi tecnologicamente avanzati, responsabili dell’elevato tasso dell’inquinamento atmosferico determinato dallo sviluppo
industriale e dal consumo di idrocarburi, e i Paesi in via di sviluppo
che non ritengono di dover fare loro dei sacrifici per la salvaguardia
dell’ambiente del cui inquinamento non sono responsabili. La Conferenza ONU del 1997, con il “Protocollo di Kyoto’’, ha tentato di
definire, in funzione dei valori di inquinamento addotto da ogni singolo Paese, gli impegni per la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica, il cui accumulo nella troposfera è una delle cause dell’aumento della temperatura della Terra. Hanno sottoscritto il Protocollo i Paesi dell’UE, la Cina e qualche altro piccolo Paese: tutti assieme contribuiscono per circa il 37% delle emissioni di anidride
carbonica; ha successivamente accettato di rispettare gli impegni anche la Russia che contribuisce con un valore di circa il 18%. Gli Stati Uniti, che contribuiscono da soli per un valore pari al 23% all’inquinamento del pianeta, non hanno firmato il Protocollo: gli egoismi
in gioco aumentano i problemi.
Questi brevi cenni chiariscono come gli interessi economici, gli
interessi sanitari e i risvolti morali, connessi anche se taciuti, facciano diventare il problema ecologico uno degli aspetti più delicati
del dialogo planetario: alle paure emotive delle masse si somma, infatti, la consapevolezza dei danni economico-sociali che potrebbero
essere determinati da eventuali troppo rapide riconversioni industriali nei Paesi occidentali.
Chi ”sente” le minacce che vengono dal tono ultimativo con il
quale apprende della gravità dei problemi climatici ed ecologici,
guarda preoccupato alle prospettive possibili e alla sua impotenza.
135
Ma, forse, la ragione più profonda dell’inquietudine occidentale
è radicalmente esistenziale: la costante, inarrestabile immigrazione
nell’Occidente ‘’bianco’’ di gente di tutte le culture, le etnie e i ‘’colori’’, che è stata già ricordata, fa costatare quotidianamente la progressiva erosione di quella condizione di ‘’purezza’’ biologica e culturale di cui i paesi europei ritenevano di essere depositari. Forse,
dovrebbe essere ragionevole rendersi conto che la ‘’mutazione’’ biologica, culturale e ambientale sarà un processo lento e progressivamente assorbibile dalla grande attitudine dell’uomo ad adeguarsi alle situazioni nuove. Invece, l’incapacità degli europei d’oggi di rimuovere questa prospettiva futura, la fa già vivere con ansia: non si
riesce ad immaginare quale possa essere la situazione demograficoeconomico-culturale nella quale vivrà la propria progenie. Ferme le
tendenze demografiche in atto, sarà molto difficile nel breve periodo prendere iniziative adeguate senza rischiare contraccolpi pericolosi.
Gli uomini sono animali ipersensibili. Intuiscono o almeno “sentono nell’aria’’ qualcosa di non controllabile e temono a fermare
l’attenzione su un futuro così pieno d’incognite: hanno fiutato una
somma di pericoli e, non avendo chiaro come poterli evitare, sono
inquieti. La reazione è emotiva: si cercano di nuovo le antiche appartenenze, si riscoprono le differenze dagli “altri”, si sollecitano
politiche di chiusura verso l’immigrazione; il “vicino” è sempre più
un nemico che vuole portare via il lavoro, la serenità, la vita.
Quest’angosciosa dimensione alimenta il nichilismo di gran parte dei giovani occidentali che con gli sport estremi, la musica esasperata, la droga e i suicidi sembra vogliano esprimere un rifiuto
della vita che è soprattutto un rifiuto di responsabilità che appaiono
insostenibili.
Megafono di quest’incapacità a trovare risposte adeguate, oltre
che di un razzismo biologico-culturale, sono stati “La rabbia e l’orgoglio’’ e “La forza della ragione” sfoghi esasperati di una donna
che non si rende conto che il suo è il grido disperato di un animale
che “sente’’ che la propria specie tende ad estinguersi: lo rifiuta. Il
successo di questi saggi dimostra come un’irrazionale emotività stia
emergendo dal mondo che fu di Socrate, di Cartesio, di Galilei e di
Einstein.
136
Questa condizione irrazionale rende sempre più difficile in Occidente trovare il bandolo della matassa delle iniziative possibili per
superare le contraddizioni che incombono.
***
Tante paure messe assieme e la sensibilità per la condizione altrui hanno sollecitato un movimento per la pace che è riuscito ad
esprimere nel mondo momenti di entusiasmo. La mancanza di una
riflessione concreta su cosa e come possa essere la pace ha progressivamente affievolito il movimento. Impegnarsi per la pace non è
inutile solo se si è consapevoli che si tratta di una resistenza all’irrazionale e di una semina per un raccolto ancora lontano. La pace
non deve essere una speranza. La pace può essere soltanto partecipazione attiva ad un processo lungo, fatto di tanti no e molti sì. No
al razzismo, sì al multiculturalismo; no alla tolleranza, sì al rispetto;
no al benessere smodato, sì all’equilibrio dei consumi; no al settarismo religioso, sì al rispetto della fede di ognuno; no all’integralismo
religioso, sì al laicismo civile; e così via, lungo il processo evolutivo della cultura umana nel tempo e nello spazio. Per superare le resistenze, sarà necessario un tempo indefinibile; si verseranno lacrime e sangue.
Consapevoli della dimensione dei problemi, noi occidentali potremmo cominciare a frenare il nostro egoismo primario per riprendere i contatti con il nostro razionale egoismo-altruismo che da tempo ha segnalato i pericoli ecologici, economici e culturali verso i
quali corriamo. Ma la convenienza e la presunzione tecnologica non
hanno ancora fatto scattare l’allarme biologico di una maggioranza
che abbia chiaro il carattere ultimativo della violenza che si sta impadronendo del mondo.
Se è stato possibile lanciare aerei contro il Pentagono, non sarà difficile mandare aerei su obiettivi devastanti come le centrali nucleari
od obiettivi sensibili come i luoghi affollati da migliaia di persone.
Fatti così enormi, quali conseguenze psicologiche possono determinare? Quali disastrose scelte possono suggerire? Quanto il nichilismo
morale dell’economia di mercato, con tutte le conseguenti ferocie, è
penetrato nell’anima di chi combatte le guerre contro i poveri?
137
Il mondo è prigioniero di un nichilismo globale nel quale al nichilismo attivo di chi costruisce le ragioni dell’odio si somma il nichilismo passivo di chi finge di non rendersi conto di quanto accade: a tanto nichilismo si oppone un nichilismo al di là del bene e del
male, di nietzschiana memoria, che invasa sempre più chi si ribella.
Finché la dimensione della violenza non sarà tale da minacciare
la sua stessa sopravvivenza, sarà molto difficile che nel mondo occidentale riesca a coagularsi una prevalente consapevolezza che voglia prendere in mano il timone di una sua riconversione morale.
Morale non nel significato convenzionale di etico ma nel senso secondo il quale conveniente, razionale e morale sono soltanto sinonimi consequenziali.
Ancora per qualche tempo, l’impotenza e la mortificazione dell’ONU, le guerre più arbitrarie, le pretese del WTO, del FMI e della Banca Mondiale, gli inascoltati appelli alla pace del Pontefice cattolico, le ‘’inutili’’ proposte - in mille saggi di scienziati, di filosofi
e di studiosi di tutti i paesi - di come sarebbe possibile costruire un
mondo migliore, saranno la conferma della paradossale ipocrisia dei
potenti di cui l’espressione più drammaticamente lampante è la
mancata ratifica del Protocollo di Kyoto da parte degli Stati Uniti e
di altri stati, con il contemporaneo progressivo svuotamento delle
leggi di salvaguardia ambientale in molti Paesi.
Fino a quando la violenza degli “altri” non farà rientrare la nostra violenza culturale, prima che economico-militare, e non ci farà
recuperare la consapevolezza di quale sia la nostra convenienza più
equilibrata, potremo continuare a portare la guerra ovunque, combattendola direttamente o facendola combattere ad altri, organizzando colpi di stato in America meridionale, istigando guerre tribali in
Africa (per portare via da quei paesi i minerali, l’oro e le pietre preziose), corrompendo i fantocci politici nei paesi islamici, minando il
potere dell’ONU e così via. Potremo inseguire, rintracciare ed uccidere ad uno ad uno i vari bin Laden o Saddam o Yassin e tutti i capi di governi non filo-occidentali.
Potremo, soprattutto, proseguire verso la meta che sembra essere
stata definita: trasformare i nostri paesi in campi di concentramento
di cittadini che credono di essere ancora liberi; costruire nei porti,
negli aeroporti e nelle stazioni i più fortificati bunker contro fanta138
smi che non si sa da dove possano arrivare; raccogliere immense
fortune finanziarie nelle mani di chi ha il potere di ridurre tutti noi
in miseria morale prima che economica; far diventare le nostre città
come luoghi spettrali attraversati da ‘’nemici’’ sempre più numerosi
che ci sorridono impauriti più di noi.
Saremo riusciti a far diventare la nostra vita un incubo oltre ogni
immaginazione kafkiana: le Olimpiadi barricate d’Atene 2004 sono
state un accenno ancora mite di come saranno blindati gli svaghi, lo
sport e tutti i luoghi dove possa raccogliersi una folla.
Purtroppo, l’”ingenuo” impegno dei numerosi gruppi di volenterosi “terzomondisti” e di medici che dedicano la loro vita per combattere i flagelli del mondo non è compreso: la difesa degli egoismi
e degli interessi connessi - economici, sociali, religiosi e culturali ottunde la maggioranza di quella minoranza che è l’Occidente. Questa gretta maggioranza, lusingata dai consumi e memore di una fame antica, non sa che la sua cultura è un patrimonio di cui è debitrice anche al resto del mondo e non vuole nemmeno prendere in
considerazione l’idea che possiamo aver sbagliato in qualcosa.
Leggendo la storia dei secoli trascorsi, è naturale che questa
maggioranza continui a camminare per una strada impervia lungo la
quale sperimenteremo il terrore come companatico quotidiano: per
un tempo non definito e non definibile continueremo ad essere irresponsabilmente fedeli al progetto di arrivare alla meta-incubo che
stiamo costruendo giorno dopo giorno.
E, senza intravedere nessuno che tenti vie alternative, verso questa direzione va l’attuale riarmo missilistico della Russia che, consapevole del peggio che si prepara, ha deciso di recuperare il suo ruolo di grande potenza; va la Cina con il suo esercito sempre attivo di
oltre due milioni di soldati pronti a sostenere i crescenti interessi del
paese per le fonti delle materie prime; va l’ingresso di Pakistan e India nel club delle potenze atomiche; vanno Corea del Nord ed Iran
con la ferma decisione di entrare anche loro in questo club; vanno i
paesi caucasici e dell’Asia centrale insofferenti al lento diffondersi
delle basi militari americane e alla volontà russa di continuare a sostenere i suoi interessi nell’area; va la sempre più chiara volontà del
Brasile di alzare il tono della sua voce per far rispettare i suoi bisogni; vanno i fremiti dell’Africa equatoriale, le contraddizioni del
139
Sud-Est asiatico e il violento revanscismo arabo-islamico: la Comunità Europea è un’oasi impotente con la testa sotto la sabbia.
I simboli che denunciano la follia nichilista che progressivamente si è impadronita di questo mondo – il bimbo ebreo che esce dal
ghetto di Varsavia, lo scheletro metallico di una torre di Hiroshima,
la bimba nuda che cammina sotto il napalm in Vietnam e i bambini
coperti di sangue che corrono qua e là fra due fuochi a Beslan – sono rimossi dall’incapacità a dialogare.
Solo dopo che tutti avremo sperimentato la violenza con quotidiana sofferenza, dopo aver tentato mille ipocriti palliativi per cedere quanto meno è possibile, recupereremo forse quella capacità egoistica ma razionale dell’uomo che fa comprendere come il nostro miglior benessere sia costretto a tener conto anche del benessere altrui.
La pace e la serenità nel mondo saranno per tutti o non saranno
più per nessuno.
L’evoluzione umana è stata sempre lenta: le fasi del processo
evolutivo culturale umano ricordano quanti secoli siano occorsi per
ogni adeguamento della società a nuove situazioni determinate da
vecchi bisogni e nuovi valori che, condivisi, hanno fatto avanzare
quella storia ‘’carsica’’ degli uomini che ne accumula il patrimonio
più vero.
Nessuna civiltà è stata mai disponibile a cedere anche una piccola parte del benessere conquistato se non costretta dalle più imponderabili ragioni. Oggi, quando lo scontro generale è appena iniziato,
parlare di una possibile, spontanea solidarietà umana che raggiunga
a breve termine un equilibrio dei consumi, è una fantasia da visionari: per qualche generazione, la violenza degli eventi confinerà ai
margini i suoi valori ideali, rendendo evidente l’ipocrisia della “melina” dell’Occidente.
In questa situazione, la violenza che ci aggredisce non può essere storicizzata da noi che ne siamo coinvolti. In sé, la violenza non
è né morale né immorale: è uno degli strumenti che la Natura ha
messo a disposizione dei protagonisti del suo processo evolutivo,
nel mondo fisico come in quello animale. In quest’eterno processo
evolutivo dell’universo, la violenza ha dimostrato di avere avuto
sempre il suo obiettivo in un equilibrio più avanzato. Nell’unicità
della storia umana, che non consente preventive verifiche galileiane,
140
non è dato di sapere in anticipo e con certezza né quale sia l’equilibrio da raggiungere né quale sia la violenza costruttiva e quale quella nefasta.
Comunque e purtroppo, buona o cattiva, la violenza dei paria della Terra sembra essere oggi l’unico strumento al quale rimanga affidato il progetto evolutivo razionale di camminare verso un equilibrio in grado di costruire nel tempo un mondo planetariamente morale.
La violenza ci costringerà. E, dimenticando la costrizione, molti
puri godranno dei progressivi compromessi che accrediteranno all’efficacia del loro impegno per un dialogo solidale di tutte le genti.
Saremo costretti.
E la storia dell’uomo, passo dopo passo, andrà avanti.
Nel tempo.
Come vuole una lettura distaccata della storia che ha tempi molto più lunghi di quanto si vorrebbe, che non ha un progetto certo, ma
ha una sua insondabile, costruttiva coerenza.
141
142
NELLA STESSA COLLANA
BORSELLINO P. Prevenzione e territorio. Le tossicodipendenze, 1998, pp.
200
CARLEVARIS P. E-mail dalla Lapponia. Tra i ghiacci con il Servizio Volontario
Europeo, 2003, pp. 96
CATALDI R. Il fascino del potere, pref. di A. Carotenuto, 1999, pp. 160
CINTURA M. La sociologia per l’operatore sociale. Manuale di formazione,
20032, pp. 128
COMUNE DI ROMA (Assessorato alle Politiche per la Promozione della Salute)
Storie di barboni rasati a zero. Vite di strada. Dall’assistenza alle politiche di inclusione, 2000, pp. 160
DEBRAY R. La repubblica spiegata a mia figlia, trad. di F. Baglivo, 2002, pp. 96
EBHARDT F. L’arte di vivere, trad. di A. Lucchiari, postfazione di M. Baldini,
2000, pp. 144
FALBO E. Servizi sociali oggi, 2002, pp. 224
FARINA M. Una modesta proposta per rivoluzionare le tasse, 1999, pp. 72
FAVRETTO A.R. (a cura di) La terra di mezzo. Le attività in ‘Luogo neutro dei
Servizi sociali’, 2003, pp. 288
FORLENZA F. Il diritto penale nella Divina Commedia, 2003, pp. 112
FREUND J. La fine dello spirito europeo, trad. di F. Ravaglioli, 1983, pp. 136
IORIO G. La povertà. Analisi storico-sociologica dei processi di deprivazione, 2001, pp. 224
LAZZARI C. Psicologia ed etica del lavoro e delle organizzazioni. Dal mobbing all’etica aziendale, 2004, pp. 144 (in corso di stampa)
LELLI G. L’identità rimossa. Gli Italiani e l’Italia: profilo di una dialettica
complessa, 2000, pp. 288
LÊ THÀNH KHÔI Islam. La storia, le istituzioni, le differenze culturali, trad. di
G. Pampanini, 2002, pp.160
MANCINI U. Lotte contadine e avvento del fascismo nei Castelli Romani,
2002, pp. 404
MANCO A. La donna nella società e nella famiglia. Risposte a 100 quesiti
inerenti il Diritto di Famiglia, 2003, pp.160
MARSELLA A. Pianificare valutare comunicare. Metodi e strumenti del lavoro sociale, 2004, pp. 144
MASTROENI G., Aggresività e homo sociologicus, 1997, pp. 208
MINC A. La nuova trinità. I giudici, i media, l’opinione pubblica, 1997, pp.
160
MONCADA DI MONFORTE M. Israel: fine della speranza?, 2002, pp. 96
RIZZUTO A. L’Europa monetaria. Dall’età dell’oro all’età dell’euro, 2003, pp.
288
SASSONE A. Villa Falconieri dalla borghesia nobiliare alla periferia del
sapere. Nobili e ignobili, 2002, pp. 208
SASSONE A. Villa Falconieri dalla borghesia nobiliare alla periferia del
sapere. Effetto Tantalo. La politica della ricerca educativa, 2002, pp.
224
TIRALOSI S. La prospettiva dell’euro, 1999, pp. 128
TIRALOSI S. Genesi dell’industria e delle multinazionali in Italia. La scelta
etico-produttiva, 2003, pp. 96
VIOLA F. Ragazzi di scuola tra rapporti e valori, 1998, pp. 192