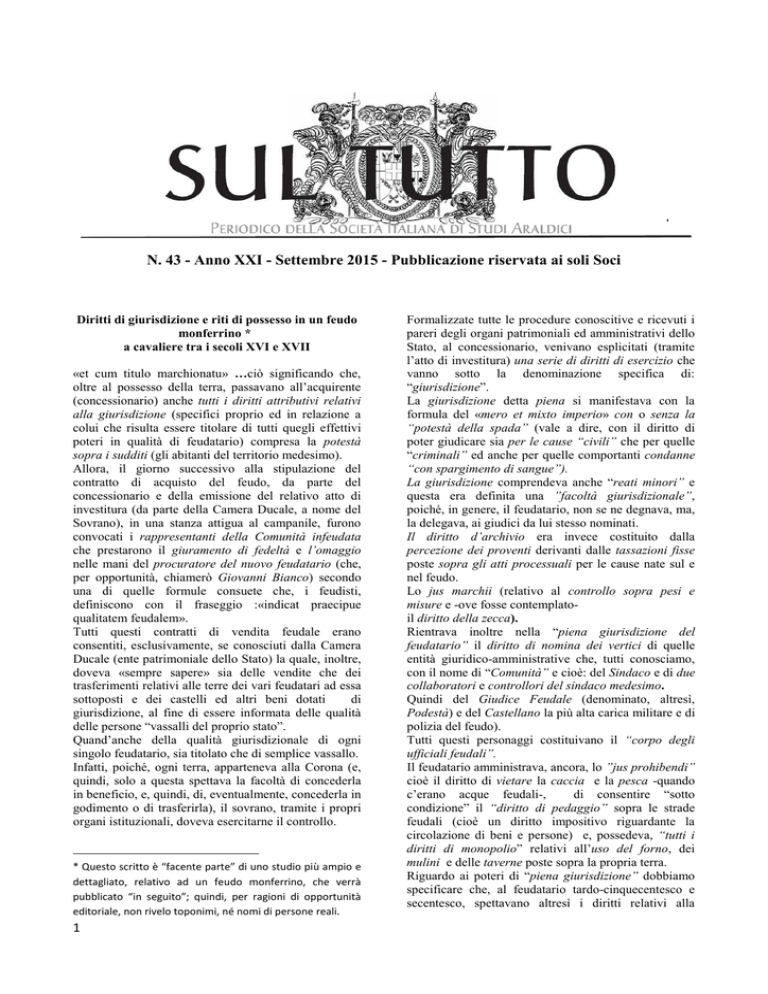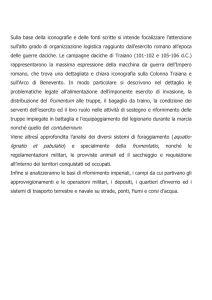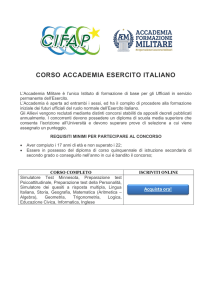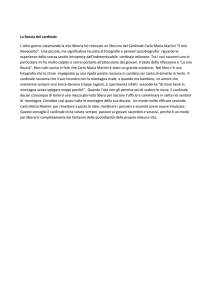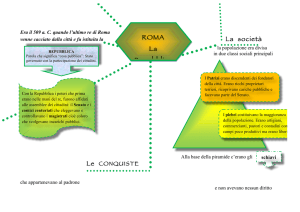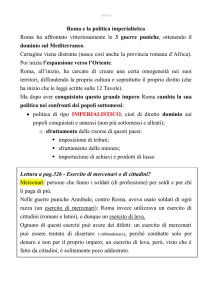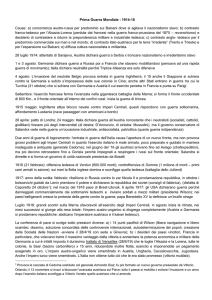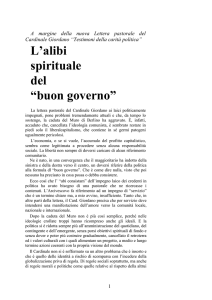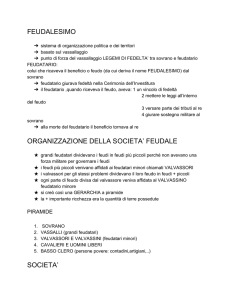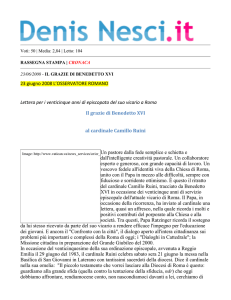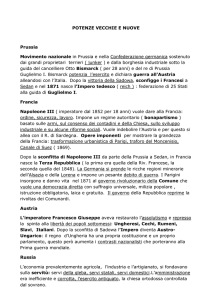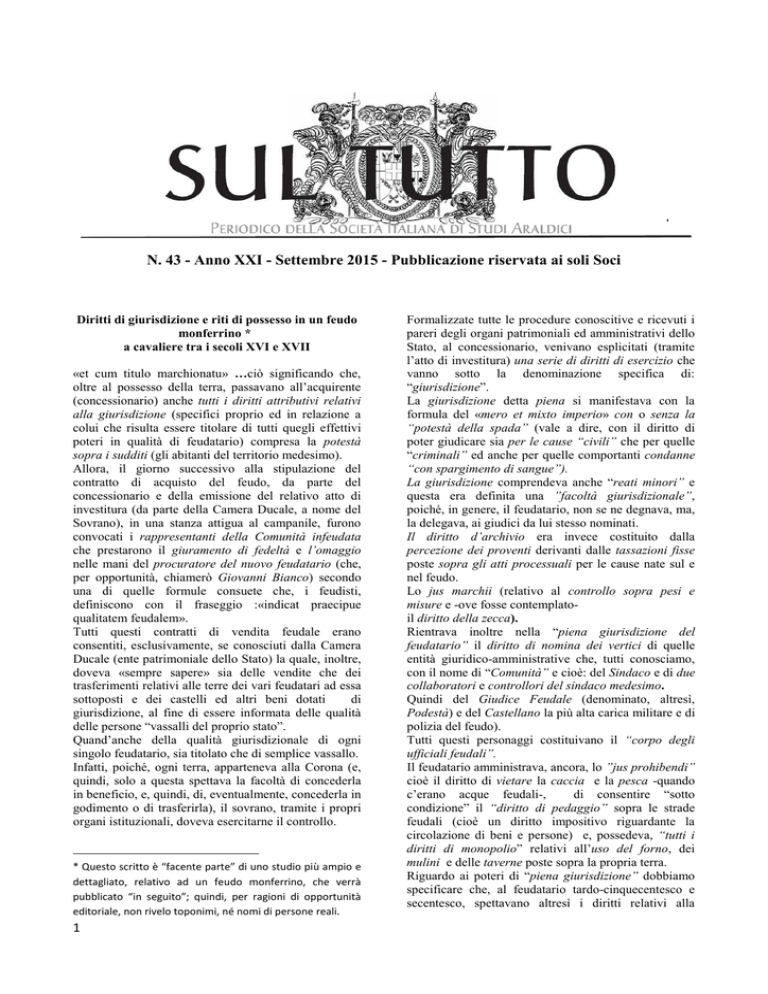
N. 43 - Anno XXI - Settembre 2015 - Pubblicazione riservata ai soli Soci
Diritti di giurisdizione e riti di possesso in un feudo
monferrino *1
a cavaliere tra i secoli XVI e XVII
«et cum titulo marchionatu» …ciò significando che,
oltre al possesso della terra, passavano all’acquirente
(concessionario) anche tutti i diritti attributivi relativi
alla giurisdizione (specifici proprio ed in relazione a
colui che risulta essere titolare di tutti quegli effettivi
poteri in qualità di feudatario) compresa la potestà
sopra i sudditi (gli abitanti del territorio medesimo).
Allora, il giorno successivo alla stipulazione del
contratto di acquisto del feudo, da parte del
concessionario e della emissione del relativo atto di
investitura (da parte della Camera Ducale, a nome del
Sovrano), in una stanza attigua al campanile, furono
convocati i rappresentanti della Comunità infeudata
che prestarono il giuramento di fedeltà e l’omaggio
nelle mani del procuratore del nuovo feudatario (che,
per opportunità, chiamerò Giovanni Bianco) secondo
una di quelle formule consuete che, i feudisti,
definiscono con il fraseggio :«indicat praecipue
qualitatem feudalem».
Tutti questi contratti di vendita feudale erano
consentiti, esclusivamente, se conosciuti dalla Camera
Ducale (ente patrimoniale dello Stato) la quale, inoltre,
doveva «sempre sapere» sia delle vendite che dei
trasferimenti relativi alle terre dei vari feudatari ad essa
sottoposti e dei castelli ed altri beni dotati
di
giurisdizione, al fine di essere informata delle qualità
delle persone “vassalli del proprio stato”.
Quand’anche della qualità giurisdizionale di ogni
singolo feudatario, sia titolato che di semplice vassallo.
Infatti, poiché, ogni terra, apparteneva alla Corona (e,
quindi, solo a questa spettava la facoltà di concederla
in beneficio, e, quindi, di, eventualmente, concederla in
godimento o di trasferirla), il sovrano, tramite i propri
organi istituzionali, doveva esercitarne il controllo.
* Questo scritto è “facente parte” di uno studio più ampio e
dettagliato, relativo ad un feudo monferrino, che verrà
pubblicato “in seguito”; quindi, per ragioni di opportunità
editoriale, non rivelo toponimi, né nomi di persone reali.
1
Formalizzate tutte le procedure conoscitive e ricevuti i
pareri degli organi patrimoniali ed amministrativi dello
Stato, al concessionario, venivano esplicitati (tramite
l’atto di investitura) una serie di diritti di esercizio che
vanno sotto la denominazione specifica di:
“giurisdizione”.
La giurisdizione detta piena si manifestava con la
formula del «mero et mixto imperio» con o senza la
“potestà della spada” (vale a dire, con il diritto di
poter giudicare sia per le cause “civili” che per quelle
“criminali” ed anche per quelle comportanti condanne
“con spargimento di sangue”).
La giurisdizione comprendeva anche “reati minori” e
questa era definita una ”facoltà giurisdizionale”,
poiché, in genere, il feudatario, non se ne degnava, ma,
la delegava, ai giudici da lui stesso nominati.
Il diritto d’archivio era invece costituito dalla
percezione dei proventi derivanti dalle tassazioni fisse
poste sopra gli atti processuali per le cause nate sul e
nel feudo.
Lo jus marchii (relativo al controllo sopra pesi e
misure e -ove fosse contemplatoil diritto della zecca).
Rientrava inoltre nella “piena giurisdizione del
feudatario” il diritto di nomina dei vertici di quelle
entità giuridico-amministrative che, tutti conosciamo,
con il nome di “Comunità” e cioè: del Sindaco e di due
collaboratori e controllori del sindaco medesimo.
Quindi del Giudice Feudale (denominato, altresì,
Podestà) e del Castellano la più alta carica militare e di
polizia del feudo).
Tutti questi personaggi costituivano il “corpo degli
ufficiali feudali”.
Il feudatario amministrava, ancora, lo ”jus prohibendi”
cioè il diritto di vietare la caccia e la pesca -quando
c’erano acque feudali-,
di consentire “sotto
condizione” il “diritto di pedaggio” sopra le strade
feudali (cioè un diritto impositivo riguardante la
circolazione di beni e persone) e, possedeva, “tutti i
diritti di monopolio” relativi all’uso del forno, dei
mulini e delle taverne poste sopra la propria terra.
Riguardo ai poteri di “piena giurisdizione” dobbiamo
specificare che, al feudatario tardo-cinquecentesco e
secentesco, spettavano altresì i diritti relativi alla
possibilità di ridurre le pene corporali o pecuniarie, di
remissione dei delitti in primo e secondo grado di
giudizio (qualche volta, dietro delega sovrana, anche in
terzo grado); del diritto di confisca dei beni del
condannato o di persone contumaci o bandite, dopo un
anno di assenza.
A tutta questa serie di diritti si sommavano quelli di
natura economica relativi allo sfruttamento diretto
delle terre del feudo, degli erbaggi e dei canoni attivi
relativi alle concessioni enfiteutiche (affitto di
fabbricati, concessioni dirette o indirette di impianti di
trasformazione di prodotti agricoli.
Le attività agricole di sfruttamento terriero,
costituirono, tuttavia, la fonte principale della
ricchezza feudale.
Quella ricchezza, che variava da terra a terra, e che, lo
stato, in parte, già si mangiava “in erba”, nel momento
in cui chiedeva, al nuovo infeudato, l’esborso della
tassa patrimoniale di infeudazione.
Nulla di nuovo, dunque, sotto il sole…!
I rituali di realizzazione del possesso feudale
Sappiamo molto bene quanto importante fosse stata la
“ritualizzazione” quale linguaggio preminente per la
società di Ancien Régime.
Ciò che “si vedeva”, infatti, simbolicamente, dichiarava, all’osservatore, molto di più che “mille scritti”..!!
Ecco dunque che, sia il potere civile, che, a maggior
ragione, quello religioso (tramite la liturgia), si
esprimevano, essenzialmente, “per rituali” (veri e
propri linguaggi estetico-materiali espressivi di un ceto
dominante.
Seguire, pertanto, “la cerimonia di passaggio” di un
possesso feudale tra un antico detentore (il venditore
autorizzato) ed un nuovo investito (l’acquirente
autorizzato) può essere, oltre che “affascinante”, per il
valore simbolico manifesto, anche utile, al fine di poter
comprendere, i ruoli sociali intercorrenti tra i due ceti:
quello dominante e quello dominato.
Tutta la comunità feudale, partecipava, infatti, a
quell’evento rituale che era stato stabilito,
meticolosamente, dal nuovo feudatario e che veniva
esplicitato tramite un atto notarile pubblico.
Il feudatario antico e quello subentrante erano sempre
rappresentati “coram populo” da loro procuratori di
fiducia che, per essi, cedevano e ricevevano la
“pienezza dei poteri feudali”.
Dopo un anno solare, infatti, dalla definizione degli
accordi contrattuali ed ottenute le relative sovrane
autorizzazioni, il procuratore del cedente feudatario
(che, per opportunità, chiamerò Giuseppe Rosso) e
quello del subentrante (che chiamerò, Giovanni
Bianco), si prepararono ad espletare tutte le formalità
della cessione e del nuovo possesso del feudo di fronte
al notaio ed ai testimoni.
Fu convocato, quindi il giorno..X.. il Consiglio della
Comunità e tutti i capifamiglia del feudo, i quali dichiararono di essere “a piena conoscenza” della avvenuta cessione del Castello del feudo in questione con
tutta la sua giurisdizione (così come risultava dall’atto
notarile pubblico, letto dal notaio, in presenza di tutti i
summenzionati organi comunitari).
2
Quindi il procuratore del nuovo feudatario, dichiarò di
accettare ed il procuratore del vecchio feudatario
effettuò la consegna del Castello.
Terminato il Consiglio, gli uomini rappresentanti la
Comunità, “giurarono fedeltà ed obbedienza” al nuovo
signore secondo un antico rituale, cioè: «toccando
ciascuno, con le proprie mani, il libro dei Vangeli e,
inginocchiati a terra, a capo scoperto, facendo una
riverenza, riconobbero i nuovi ufficiali feudali», quindi
furono licenziati ed invitati a presentarsi presso la porta
principale del castello.
Da questo momento ebbe inizio la vera e propria
liturgia della presa di possesso del feudo:
Alla presenza del procuratore dell’antico feudatario
(Giuseppe Rossi), furono consegnate le chiavi del
Castello al procuratore del nuovo feudatario (Giovanni
Bianco) il quale, ricevuta, in questo modo, la piena
potestà, entrò dalla porta del castello, in segno di vero
possesso; indi chiuse la predetta porta con le relative
chiavi per riaprirla subito dopo.
Il giorno successivo il procuratore del novo
acquirente, il (m.se. B.), con il notaio e con il
procuratore del venditore, (il m.se. P.), presente e
consenziente, si recò presso tutti i poderi esistenti nel
feudo e camminando e tirando zolle, estirpando l’erba
e rompendo rami degli alberi, chiudendo ed aprendo
cancelletti e cancellate, dimostrò di aver preso reale
possesso dei poderi feudali.
Il terzo giorno il procuratore del m.se. B. fece la stessa
cosa, cavalcando ed attraversando tutto il territorio del
feudo, toccò i confini di tutti i poderi.
Quindi “finse”, in piazza, davanti al Castello, di
“amministrare la giustizia”, confermando, così, anche
la potestà del giudicare del suo signore.
Sempre seguito dal notaio e dal procuratore dell’antico
feudatario, entrò, di poi, nel borgo e visitò la taverna, il
macello ed il forno e, fuori dal borgo, i due mulini.
Il Castello, costituiva, in verità, simbolicamente, il
bene principale del possesso feudale.
In ragione di ciò il procuratore del marchese B.
entrando in tutte le stanze, ai diversi piani del Castello
medesimo, aprendo e chiudendo finestre e porte,
dimostrò, a tutti, che, il suo signore, deteneva anche
quello.
Successivamente, affacciatosi ad una finestra, rivolse
lo sguardo per ogni dove comprendendo, in questo
modo, visivamente, tutto il paese (con gli edifici interni
ed esterni).
Per mezzo di tutte queste “ritualità” egli prendeva,
così, il totale reale ed attuale possesso di tutto il feudo,
sopra ogni cosa e luogo e camminando, ancora, in
lungo ed in largo, sulla piazza, dichiarò: «di voler
conservare il territorio intiero nel migliore dei modi».
Il percorso ritualistico del possesso feudale, poteva
dunque, considerarsi concluso ed, in questo modo,
risultò a tutti manifesto che, il nuovo signore, poteva
considerarsi legittimato, pienamente, al fine di poter
esercitare, la propria futura e piena giurisdizione.
Alberto Gamaleri Calleri Gamondi
Duecento anni fa
Sono passati 200 anni dagli eventi che scossero
l’Europa che si stava appena rimettendo dalle ferite
della lunga guerra che l’aveva sconvolta da quando
prima la repubblica poi l’impero francese aveva cercato
di assoggettarla ed è ora il tempo di liberarsi dai veli
con cui gli storici del Risorgimento hanno coperto i
fatti di quel periodo.
Il ritorno di Napoleone dall’Elba riaprì il conflitto che
si credeva concluso e del quale si cercava la composizione nel Congresso di Vienna e nel marzo al giugno
del 1815 tutto tornò in discussione. Di quel breve
periodo gli storici in Italia ricordano le vicende di
Murat, che ingenuamente pensava col suo malandato
esercito di poter aver ragione dell’Impero Austriaco. In
genere la storiografia italiana è piuttosto generosa con
questo generale e con il suo tentativo, spesso dandogli
una connotazione patriottica che non aveva. Si
nasconde in genere che il suo esercito era assolutamente modesto, che i suoi generali erano ancor meno
capaci di lui, che quale unica qualità aveva il coraggio,
ma quasi nessuna delle caratteristiche del condottiero,
nessuna visione strategica o almeno tattica. Così il suo
esercito senza nerbo e mal comandato dopo il primo
scontro si dissolse. Su ipotetiche glorie e la resistenza
che alcuni reparti fecero a Tolentino o in altre zone gli
storici risorgimentali han scritto pagine e pagine, ma
sono in genere pura fantasia, dovevano pure inventare
degli eroi che si immolassero per l’Italia unita, cui
nella realtà nessuno pensava.
Quello che la storiografia italiana ignora totalmente e
sulla quale non ha volutamente fatto mai neanche una
parola è stato l’intervento del Regno di Sardegna a
fianco degli Alleati contro il rinato esercito di
Napoleone durante i cosiddetti 100 giorni. Il perché
non ha nulla a che vedere con la storia, ma
semplicemente con la politica, con la necessità di
creare l’immagine di una Francia amica e di un Austria
che voleva opprimere gli stati della penisola. Non si
poteva così dire che nel 1815 il rinato Regno di
Sardegna aveva partecipato alla guerra contro la
Francia a fianco dell’Austria, per riprendersi la Savoia
che l’esercito napoleonico aveva invaso nuovamente, e
che le sue truppe avevano partecipato all’occupazione
del Lionese e di Marsiglia. A maggior ragione neanche
un cenno poteva citarsi sul fatto che anche le truppe dei
ducati di Modena e Parma avevano partecipato a questa
spedizione Tutto questo doveva essere semplicemente
cancellato. Che orrore scrivere di essere stati alleati
dell’Austria contro la Francia. Come se per i secoli
precedenti l’alleanza con l’Austria non avesse
salvaguardato il Piemonte dall’essere assogget-tato dal
potente vicino d’oltralpe.
Ripreso il potere in Francia dopo un ritorno che era
stata un sorta di marcia semi trionfale, senza che
nessuno vi si opponesse, Napoleone forse pensava che
le grandi potenze avrebbero accettato lo stato di fatto,
quando si rese conto che non era così, si organizzò a
difesa. Per quel che interessa questa nota, basta
ricordare che costituì la cosiddetta Armata delle Alpi
3
che dopo aver vinto, agli ordini del maresciallo Grouchy, la resistenza del duca d’Angouleme, affidò al
maresciallo Suchet col compito di proteggere le provenienze dalla Svizzera e portarsi sulla cresta della catena
montana per meglio assicurare la difesa. In sostanza,
per quel che riguardava il Regno di Sardegna, occupare
quella parte della Savoia che, dopo la pace di Parigi
dell’anno prima, gli era stata restituita in modo da dare
continuità allo schieramento difensivo
Da parte piemontese, al comando del generale Nicolis
di Robilant, presidiavano la Savoia circa 2000 uomini
dei reggimenti Savoia, Piemonte, Monferrato, Ivrea ed
il battaglione Cacciatori Italiani, privi di artiglieria e di
cavalleria.
Ama del generale Giovanbattista Nicolis di Robilant:
Troncato nel 1° d’oro sparso di moscature d’ermellino di
nero, all’aquila bicipite dello stesso, membrata, rostrata e
coronata di rosso, al 2°d’azzurro a duefoglie di sega
d’argento
Nella notte fra il 14 ed il 15 giugno 12000 Francesi,
senza alcuna dichiarazione di guerra invasero la regione, cogliendo del tutto impreparato lo schieramento
avversario, con una colonna conquistarono Montmellian e risalendo la valle dell’Arc presero Aiguebelle, con una seconda colonna seguendo il corso
dell’Isere si diressero verso Conflans, allora capitale
della parte di Savoia restituita al Piemonte e con una
terza muovendo lungo le rive del lago di Ginevra
puntarono alla confluenza del Rodano nel lago per
raggiungere il confine con la Svizzera.
A contrastare i Francesi a Montmellian e Aiguebelle
c’erano 400 uomini del reggimento di Savoia agli
ordini del tenente colonnello Gaspare Marechal de
Somont,
Arma del cav. Gaspare Marechal de Saumont: D’oro
alla banda di rosso carica di tre conchiglie d’argento
ufficiale che si era distinto nella guerra delle Alpi e che
durante l’occupazione francese si era ritirato a vita
privata. La quasi totalità del reggimento venne sorpresa
nella notte e fece una scarsa resistenza, solo la
compagnia che presidiava Maltaverne,, comandata dal
capitano Maurizio di Charboneau,
neau, già decorato quando
era tenente nel 1796 della croce dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro, avvertita per tempo imbastì una
forte resistenza, sino a quando non fu sopraffatta da un
nemico che era 6 o 7 volte
lte superiore di numero.
I Cacciatori Italiani, comandati dal tenente colonnello
Emilio Roberti di Castelvero, si scontrarono con la
colonna diretta a Conflans e malgrado la sproporzione
di forze in campo guadagnarono il tempo necessario a
far sgomberare laa città e contrastarono efficacemente
l’avanzata francese nell’alta valle dell’Isere,
costringendolo a non andare molto oltre Conflans.
Emilio Roberti di Castelvero, troppo giovane per
essere arruolato nell’esercito sabaudo nel 1796, rifiutò
di servire nell’esercito
ell’esercito francese e considerando questo
il nemico della sua patria si arruolò nell’esercito
austriaco. Nel 1812, a seguito degli accordi fra
Napoleone e l’Imperatore austriaco, venne però
congedato, ma anche questa volta non si arruolò nell’
esercito francese
rancese ove avrebbe conservato il suo grado
di maggiore, preferì rimanere privato cittadino. Nel
1814 però fu richiamato dagli Austriaci per costituire e
comandare un battaglione formato con italiani che presi
prigionieri che avevano però espresso il desiderio
desid
di
combattere contro la Francia. Questo battaglione
quando l’Austria riconsegnò il Piemonte a Vittorio
Emanuele I divenne l’unica forza militare che il
sovrano sabaudo avesse in terraferma.
Arma del generale Gabaleone Salmour d’Andezeno: D’
azzurro al leone d’oro, con il capo d’argento carico di un
gallo di rosso accompagnato sui fianchi da una rosa di
rosso a destra e a sinistra da un cardo di verde.
Il suo reggimento era su due battaglioni, uno si trovava
con lui, l’altro al comando del tenente colonnello
c
Giovanni Luigi Massel di Caresana era schierato sul
lago di Ginevra. Combatté per contrastare gli invasori
ed ebbe la fortuna quando stava per essere schiacciato
dalla superiorità numerica del suo avversario di
ricevere il rinforzo dell’avanguardia
dell’avanguard austriaca, con la
quale partecipò a respingere le truppe francesi
rioccupando Evian e Thonon.
Arma del cav. Gio. Luigi Massel (Macello) di Caresana:
Caresana
Di rosso a tre magli d’oro
Arma del conte Emilio Roberti di Castelvero:Di
Castelvero
rosso con
la corona all’antica d’oro con due rami di palma di verde
intrecciati alla corona, la corona accompagnata in punta
da un bordone da pellegrino, con il capo d’oro carico di
un’aquila coronata di nero.
A Conflans il battaglione sii batté con straordinario
coraggio
oraggio e le sue perdite furono notevoli, oltre 300 fra
morti e feriti, e fra i primi anche un comandante di
compagnia.
Aveva il comando delle truppe nell’alta Valle dell’Isere
il generale
ale Luigi Amedeo Gabaleone Salmour
Salm
d’Andezeno, comandante del reggimento
to Monferrato già
ufficiale durantee la guerra delle Alpi, che dopo il 1798
si era ritirato a vita privata.
Quando a Torino giunse la notizia dell’attacco francese
alcune unità, peraltro ancora in via di costituzione si
mossero per andare ad occupare le posizioni del
Monginevro, del Moncenisio e del Grande e Piccolo
San Bernardo ed iniziò la formazione di un Corpo
Cor
d’Armata da affidare al generale Vittorio Amedeo
Sallier de la Tour.. Era questi un ufficiale che, col
permesso del suo sovrano aveva servito Austria ed
Inghilterra per continuare a battersi contro la Francia,
uomo di assoluta fedeltà, di grande capacità e di
provata esperienza, dava garanzia, pur nella difficile
situazione del momento, con l’esercito in via di
ricostituzione, di operare al meglio e contribuire
efficacemente allo sforzo per ripristinare la pace in
Europa.
Generale Vittorio Amedeo Sallier
Sal
de la Tour
4
Arma: Partito di verde e di nero, al cavallo d’argento
spaventato
Il Corpo d’Armata piemontese si sarebbe dovuto
affiancare all’Armata austriaca d’Italia
Italia per riconquistare la Savoia e contribuire ad occupare il Lionese.
L’armata austriaca si stava muovendo, con un contincontin
gente di circa 50000 uomini agli ordini diretti del barobaro
ne Frimont, per la strada del Sempione per raggiungere
il Giura, e con un contingente
ngente di 25000 uomini agli
ordini del generale Bubna per entrare nel Delfinato
transitando per Torino, Susa e con un’aliquota per il
Moncenisio e la Val Moriana e con altra aliquota per il
Piccolo San Bernardo e la Val d’Isere.
Quest’ultima aliquota, già il 22 giugno si congiunse
con le forze del generale d’Andezeno nell’alta valle
dell’Isere e il 28 giugno riprese Conflans. Nel combatcombat
timento ebbero a distinguersi sia i Cacciatori Italiani,
sia il I/Monferrato ed il reggimento di Piemonte.
Il Corpo d’Armata
ta del generale de la Tour iniziò a
muoversi il 25 giugno ed il 29 era già a Montmellian,
fra gli altri componevano questa grande unità un
battaglione per ciascuno del reggimenti delle Guardie,
di Genova, di Saluzzo, della Legione Reale Piemontese
e il battaglione
taglione dei Cacciatori Piemontesi. Facevano
parte di questa grande unità anche i reggimenti dei
Cavalleggeri del Re e dei Cavalleggeri di Piemonte,
costituenti una brigata di cavalleria al comando del
maggior generale Ettore Veuilliet de la Saunière
d’Yenne
ne che nella fase iniziale del conflitto venne
assegnato al Corpo d’Armata Austriaco, che cedette in
cambio alcuni squadroni di ussari.
Generale Ettore Veuilliet de la Saunière di Yenne.
Arma: Troncato al 1° d’oro al levriere d’azzurro nascente
dalla partizione,
artizione, collarinato d’argento, bordato e chiodato
di nero; nel 2° di rosso.
Ufficiale di grande capacità ed esperienza che fu poi
Viceré di Sardegna
Quale Capo di Stato Maggiore il generale de la Tour si
avvaleva di Giovanni Battista Nicolis di Robilant,
Robila quali
generali alle sue dipendenze aveva oltre Gabaleone
d’Andezeno, il de Rege di Gifflenga, unico generale
già al servizio della Francia che aveva chiesto di
prendere servizio nel rinato esercito piemontese, a lui
era stata affidato la responsabilità della marcia di avviavvi
cinamento.
5
Generale Alessandro de Rege di Gifflenga.
Arma: Scaccato d’argento e d’azzurro, con il capo del
primo carico di un ramoscello di rosaio al naturale, fiorito
di un pezzo.
Il Corpo d’Armata piemontese raggiunse quindi gli
Austriaci sull’Isere il 29 giugno, quando era stato
dichiarato un armistizio ed allo scadere di questo, il 3
luglio si mosse per andare conquistare la piazza di
Grenoble, mentre il Corpo d’Armata Austriaco avrebbe
investito le posizioni francesi sul Giura
Gi
per puntare poi
su Lione.
Il 6 luglio venne investita Grenoble e dopo un duro
combattimento i Piemontesi conquistarono i sobborghi
della città che il giorno 8 si arrese.
Nel frattempo da parte francese era cessata ogni
resistenza e al Corpo d’Armata del
de generale de la Tour
venne affidato il compito di occupare una larga
porzione del Delfinato, sino al fiume Rodano nel tratto
fra Lione e Valence.
Sul fronte della Contea di Nizza, i Francesi non
tentarono attacchi di sorta, malgrado le forze a
disposizione del generale d’Osasco fossero assai
modeste, ma egli benché non compreso da Torino,
dove doveva regnare la più grande confusione per
mancanza di notizie su quali fossero le vere intenzioni
degli Alleati, riuscì ad ottenere, agendo d’astuzia di
salvare la Contea da conflitti, ed ebbe la possibilità di
occupare una fascia di territorio sino ad Antibes, dove
venne accettata una guarnigione piemontese.
Un battaglione del reggimento di Asti prese parte,
unitamente ad un contingente britannico alla conquista
di Marsiglia.
L’appena rinato esercito sardo-piemontese
sardo
in una
circostanza assai grave come quella provocata dal
ritorno di Napoleone in Francia, diede una buona
dimostrazione di sé, merito di ciò va ai comandanti di
allora, che riuscirono a superare
perare un mare di difficoltà,
dovute al fatto che era la macchina dello stato che
ancora non girava a dovere:
dove
mancava il denaro,
scarseggiavano le munizioni, i rifornimenti erano irregolari, da Torino giungevano ordini contrastanti o
inattuabili, tanto da far pensare che la Corte e di
ministri non fossero al corrente di ciò che stava
avvenendo. Fortuna volle che comandasse le truppe sul
campo uno dei migliori generali che il Piemonte abbia
mai avuto, il Sallier de la Tour, che seppe sempre
rimettere al loro
ro posto ministri e sovrano, chiarendo
perché agiva in un certo modo e perché erano
inattuabili o già superate dagli eventi alcune delle
disposizioni che gli venivano impartite.
Per motivi di politica di questi avvenimenti non si fa
quasi mai cenno nella storia. Aver combattuto contro la
Francia a fianco degli Austriaci dava l’orticaria agli
storici risorgimentali, allora niente di meglio che
ignorare. Tanto più che Austriaci non erano così cattivi
come venivano descritti, se si pensa che nel momento
che stavano per rioccupare Chambery, sgombrata dai
Francesi, il generale Bubna chiese al de la Tour di
assegnarli un reparto piemontese in modo che fosse
esso il primo ad entrare nella storica capitale del
ducato, e così fu un battaglione del reggimento di Piemonte di entrare nella città che tornava a vedere, dopo
23 anni, la bandiera sabauda.
ALFS
GESTA, APOTEOSI E INSEGNE
ARALDICHE DI UN “BRIGANTE”
LEGITTIMISTA
Il mio primo incontro con D. Josè Borjes avvenne
quando ero ancora un bambino, negli anni della guerra.
Eravamo andati a trovare certi parenti, anche loro
‘sfollati’ in case di campagna sulle rive della Calabria
jonica e i loro figli, decisamente più spigliati e
disinvolti di quanto mi sognassi di essere io, mi
condussero un giorno in un luogo proibito, un vecchio
cimitero abbandonato. Erano le rovine del secentesco
convento del Crocifisso, negli immediati dintorni di
Bianco, le cui mura per oltre due secoli avevano ricetto
alle sepolture del luogo, sino a quando – nell’autunno
1861 – aveva subito un rovinoso incendio.
6
Da allora era divenuto una cava di materiale edilizio e
le sistematiche devastazioni non avevano rispettato le
tombe e il materiale lapideo. Resti umani, talora
parzialmente mummificati, erano sparsi un po’
dappertutto (si diceva, da sacrileghi incettatori di fedi
nuziali) e il macabro contesto esercitava ovvia
attrazione su sprovveduti ragazzetti. Davanti alla
spoglia cavità dell’ingresso, che presentava ancora
tracce fuligginose, sedeva su un masso un vecchio,
vestito di un saio bisunto e dalla incolta barba
imbiancata, preceduto da un cesto, dal quale
occhieggiavano alcune gualcite immaginette sacre e
delle cartoline in stato non migliore. Gli demmo
qualcosa e riportammo a casa una campionatura delle
sue merci. Dopo l’onda dei rimproveri, l’attenzione
degli adulti si portò sulle cartoline. Una di esse
rappresentava dei ceffi sinistri, col cappello a pan di
zucchero (“alla calabrese”, si diceva un tempo), armati
di ‘tromboni’ e circondati da scenari selvaggi. Non ci
furono fornite grosse spiegazioni sui come e i perché,
ma ci fu detto che il convento era andato in fumo a
causa dei briganti. Beh, come quasi sempre accade,
qualcosa di vero c’era.
Un’attendibile
analisi
storica
del
fenomeno
“brigantaggio” è ancora al di là di venire, benché il
saggio di Franco Molfese, mezzo secolo fa, abbia
aperto il solco alla ricerca documentata, che – è vero –
ha prodotto una apprezzabile serie di risultati, i quali,
però, riflettono troppo sovente episodi locali, non
organizzati in una visione di ampio raggio e, con non
minore frequenza, indulgono a interpretazioni più
passionali che rispettose della realtà storica e, talora,
della ragione elementare.
Può tranquillamente affermarsi, ormai, che dal 1861 al
1866, nelle regioni continentali del già regno delle Due
Sicilie imperversò un’autentica guerra civile, che vide
confusamente allineati e contrapposti malviventi,
militari o civili fedeli all’antica dinastia, esercito
italiano e guardia nazionale, popolazioni atterrite e
affamate da entrambi. I ‘briganti’ appartennero alle due
prime categorie. La legge Pica, istitutrice di consigli di
guerra e di tribunali militari, finì con l’avere la meglio,
ma quei metodi, che la stampa estera (francese, in
particolare) definì ‘da guerra coloniale’, portarono (la
stima sembra peccare per notevole difetto) a quasi
diecimila fucilati, poco più gravemente feriti, quaranta
donne e sessanta bambini uccisi, quattordicimila
detenuti, mille abitazioni distrutte, sei paesi e dodici
chiese o conventi dati alle fiamme e al sacco, oltre
quattordicimila comuni insorti in armi. Secondo i
calcoli del colonnello Cesari, solo tra la fine del 1862 e
i primi del 1863, il neonato stato italiano impiegò nella
repressione dei moti circa 120.000 uomini, vale a dire
quasi la metà degli organici delle forze armate. Come
in tutte le guerre civili, odi personali sfociarono in
sanguinose vendette e il risultato globale fu l’ulteriore
immiserimento del Mezzogiorno e, forse ancora più
grave, un precario senso dii unità nazionale, diffuso in
tutta la penisola, malgrado la retorica risorgimentale.
Tra gli insorgenti occupa un posto di spicco José
Borjes, non soltanto per il suo valore, ma per quella
purezza di ideali che lo contraddistinse e che i suoi
stessi avversari gli riconobbero.
José Miguel Francisco Borjes (il suo autentico
cognome, che d’ora in poi gli daremo, era Borgès) era
nato a Vernet, presso Lérida, nell’ovest della
Catalogna, dai coniugi Antonio Borgès e Antonia
Grenulles il 28 novembre 1813. La famiglia, pur di
antica nobiltà
biltà e di tradizione militare, non doveva
godere di cospicuo censo, visto che Antonio ricopriva
originariamente il grado di sottufficiale. S’era però
assai distinto nella guerriglia del 1808 contro le armate
di Giuseppe Bonaparte e nel 1826, combattendo contro
c
i rivoltosi di Cadice. I Borgès, di convinta fede
cattolica, vantavano attaccamento alla legittimità
dinastica e Antonio, alla scomparsa di Ferdinando VII,
si schierò per Don Carlos, che – dopo numerosi fatti
d’armi – lo volle tra i suoi principali condottieri.
c
Nel
1835, fu costretto ad arrendersi al colonnello regio
Antonio Niubo, che, dopo avere accettato la spada
portagli dallo sfortunato cabecilla,, lo fece fucilare a
Cervera qualche giorno più tardi. Il suo posto sarà
preso tra breve da José, che diciassettenne, era entrato
nella Scuola Sottufficiali di Lérida. Si unì all’armata
carlista e fece prodigi di valore, attirando su di sé
l’interesse ammirato del Pretendente. Nel 1837, agli
ordini del conterraneo Tristany (anche lui si arruolerà,
a suo tempo,
mpo, tra gli insorgenti filoborbonici
meridionali), avrà la soddisfazione di sconfiggere
Niubo, che resterà morto sul campo e tre anni più tardi,
nel 1840, mentre il proprio fratello Miguel,
comandante di battaglione, cadeva in combattimento,
Don Carlos premierà
emierà il sacrificio e il coraggio dei
Borgès, promuovendo José al grado di generale di
brigata.
Alla prima disfatta carlista, riparerà in Francia,
assicurandosi la sopravvivenza con l’attività di
rilegatore di libri prima e, più tardi, di commerciante di
vini, ma sempre pronto a rispondere all’appello del rey
Don Carlos, come farà nel 1846 e nel 1855. Era un
uomo di bell’aspetto e di notevole prestanza fisica, con
la statura (allora) ragguardevole di m. 1,72. A Lione
venne contattato da emissari del ‘comitato
‘comi
borbonico’
di Marsiglia e si recà in quella città marinara, dove, il 5
luglio 1865, incontrò due personaggi di rilievo: il
7
maresciallo di campo Tommaso Clary e il principe di
Scilla, Fulco Salvatore Ruffo.
Il primo, malgrado avesse dato sui campi di battaglia
pessime prove di competenza militare (tanto
da essere accusato di tradimento da Giacinto de Sivo),
godeva tuttavia dell’appoggio del conte di Trapani,
fratello del re; il secondo, alto funzionario di corte di
fede immacolata, nutriva
iva la innocente presunzione di
essere fine politico. A nome di Francesco II, gli
chiesero, in certo senso, di ripetere l’impresa che il
cardinale Fabrizio Ruffo di Bagnara aveva
vittoriosamente portato a termine nel 1799:
riconquistare la porzione continentale
contine
del reame delle
Due Sicilie, partendo dalla Calabria. Gli consegnarono
un brevetto di maresciallo di campo, la gran croce
dell’ordine di Francesco I, una somma di denaro e gli
ordini regi, consistenti, in buona sostanza, di riportare
l’ordine e la tranquillità
anquillità nell’ex regno di Napoli,
restituito al sovrano legittimo e al più assoluto rispetto
della religione cattolica e dei rappresentanti del vicario
di Cristo. Si poneva l’accento sul divieto tassativo di
avallare o consentire vendette e di rispettare le
proprietà dei privati, pena la morte per i trasgressori.
Certamente il principe di Scilla, che riteneva tale punto
altamente premiante, non avrà perduto l’occasione per
raccomandare al Borgès di fare uso, non del ‘bianco
vessillo’ dei Borbone, ma del tricolore
t
con la grande
arme degli eredi di Carlo III, che re Francesco aveva
adottato il 21 giugno 1860, al momento di concedere la
costituzione, e che aveva sventolato sugli spalti di
Gaeta e di Civitella del Tronto. Clary assicurò che
l’insurrezione generale era un dato di fatto e che in
tutte le province erano in corso di avanzata
riorganizzazione dei reparti regolari dei ‘Reali
Eserciti’, impeccabilmente equipaggiati e con gli
organici della ufficialità al completo. Tanto per
cominciare, al suo sbarco avrebbe potuto contare su
duemila uomini in perfetto assetto di guerra, in attesa
dei suoi ordini. Avrebbe dovuto prima passare da
Malta, a ritirare un carico di armi e prelevare un
battaglione napoletano, che gli avrebbe fatto da scorta
Borgès fu il primo di quella ‘legione straniera’ di
legittimisti, che combatterono per la causa borbonica,
sacrificando non di rado la propria vita. Tra essi non
mancarono esponenti della migliore aristocrazia
europea, spinti talora da autentico lealismo verso il
discendente di San Luigi, altre volte da spleen
byroniano o da semplice spirito d’avventura. Per fare
dei nomi: il non più giovane Freiherr prussiano
Theodor Klitsche de La Grange; il sassone Edwin Graf
von Kalkreuth (sarà fucilato nel 1862); il visconte
Henri de Cathelinau, discendente del celebre capomassa vandeano; l’alsaziano conte Émile Théodule de
Christen (sconterà dieci anni di carcere duro); il belga
marchese Albert de Trazegnies de Namur, imparentato
con mezzo Gotha (e fucilato pochi giorni prima del
nostro eroe).
Borgès non dubitò di nulla e accettò l’alto incarico,
consentendo a un giovane reduce di Gaeta che l’aveva
supplicato in tal senso, il tenente Achille Caracciolo dei
duchi di Girifalco, di seguirlo nella impresa. Fece vela
su Malta e alla Valletta la prima sorpresa: del
battaglione neppure l’ombra e, quanto alle armi, stentò
a rimediare venti fucili. Meno male che il neomaresciallo di campo si era fatto raggiungere da un
pugno di suoi fedelissimi compagni d’armi, tutti
catalani o spagnoli (16 in tutto), in compagnia dei quali
e del Caracciolo prese terra sul lido della Locride, nei
pressi di Brancaleone (la speronara avrebbe dovuto
raggiungere Bovalino, ma una totale caduta dei venti lo
impedì), nella tarda serata del 13 settembre 1865. La
spiaggia era deserta, ma presto apparve un lume: era un
pastore, un’anima generosa, che trovò loro un luogo di
bivacco all’aperto e, il giorno dopo, li guidò a
Precacore (oggi Samo), dove furono accolti dal fuoco
di fucileria di un reparto della ‘Guardia Mobile’, che fu
presto messo in fuga, ma con esso si dileguò anche la
ventina di contadini, arruolatasi sotto le bandiere di
Borgès. Si recò quindi proprio al convento del
Crocifisso dei PP. Riformati di Bianco, il cui superiore,
P. Samuele da Siderno, lo mise in contatto con il
notaio Sculli di Natile e Francesco Violi da Platì, il
quale guidò gli ‘spagnoli’ (così erano noti) al campo di
Ferdinando Mittica (Mittiga sembra la forma corretta),
un presunto combattente per la restaurazione di casa
Borbone. Frattanto la prossima S. Agata era insorta,
ma – sembra – senza versare una sola goccia di sangue:
i borbonici si erano limitati a sostituire il sindaco
Rossi, liberale, con il giovane barone Giuseppe Franco,
8
a sventolare drappi gigliati e a intonare il Te Deum. Il
20 settembre sopraggiungerà un forte contingente di
bersaglieri, che il generale De Gori aveva condotto da
Reggio. Al capitano Rossi, cugino del deposto sindaco
di S. Agata, fu affidata la rappresaglia, che fu quanto
mai spietata: fu dato alle fiamme il convento del
Crocifisso e ucciso il superiore, mentre finirono al
muro due fratelli Franco con un buon numero di
trabanti e domestici, il notaio Sculli, il Violi e almeno
un’altra dozzina di nostalgici dei Borbone.
Abbiamo lasciato gli ‘spagnoli’ al campo di
Ferdinando Mittiga. Era questi, all’origine, un violento,
che la rivoluzione del 1848 aveva liberato dalla
prigione, ov’era stato rinchiuso per una certa faccenda
di coltellate. Godeva del soprannome di ‘Caci’ (dal
greco cacòs = malvagio). Almeno dai disordini del
1860, si era dato alla macchia, radunando un numeroso
gruppo (circa 200) di malavitosi e di renitenti alla leva.
Era stato forse un graduato nell’esercito delle Due
Sicilie, ma ora si autointitolava generale. Accolse
freddamente Borgès e. lette le sue credenziali, dichiarò
che si sarebbe posto ai suoi ordini solo dopo avere
visto il suo comportamento in un’azione militare.
Borgès e suoi erano divenuti di fatto prigionieri del
Mittiga, con l’eccezione del Caracciolo di Girifalco,
che, ottenuti da Borgès 200 franchi, s’era eclissato
assieme alla sua ordinanza, il soldato napoletano
Marra. S’è detto che fosse un delatore: in ogni caso era
un vile. Il capo-brigante aveva già pronta la sua azione:
l’attacco alla sua patria, Platì, dove intendeva compiere
una sua antica vendetta nei confronti di un possidente
del luogo, Rosario Oliva. Non fu un attacco, neppure
un’assedio, ma una serie di scaramucce inconcludenti,
se non per l’uccisione del povero Oliva, che s’era
rinserrato nel suo palazzo e si difendeva, sparando
dalle finestre. Mittiga attese il momento giusto e fece
fuoco contro il lampo del fucile del suo nemico,
stendendolo morto. Appagato, lasciò il paese, ma i
bersaglieri di De Gori erano già alle loro calcagna. La
banda si sfaldò ben presto e Mittiga, rimasto con un
solo seguace, fu ucciso dalla Guardia Nazionale il 30
settembre, presso Natile. Gli ‘spagnoli’ di Borgès
approfittarono della confusione per prendere le
distanze da bersaglieri e da briganti e da qui in poi ebbe
inizio la loro epopea, che doveva concludersi a
Tagliacozzo, davanti al plotone d’esecuzione, l’8
dicembre 1865.
Su di essa e sulla figura di José Borgès vale quanto
insospettabilmente scrisse, quasi nell’immediatezza dei
fatti, un suo cavalleresco nemico, il conte Alessandro
Bianco di Saint-Jorioz, capitano di S.M. del R. Esercito
italiano, che, peraltro, dedicò il suo lavoro al generale
Govone:
Fu un illuso e un tradito, un capo partigiano convinto e
di buona fede, non un brigante nello stretto e brutto
significato della parola! … Con un pugno di spagnuoli
attraversò la Calabria, la Basilicata, il Molise,
l’Abruzzo,
circondato
ovunque
da
truppe,
continuamente combattendo, sfuggendo al nemico,
ritirandosi, nascondendosi, ed or mostrandosi ed
audacemente marciando al nemico per poi deluderlo
ancora con marcie, contromarcie, ritirate, falsi assalti
e stratagemmi; compì una marcia meravigliosa, e
sfuggì con singolare fortuna e talento a tutte le
persecuzioni di sette Corpi, comandati da sette
generali italiani espertissimi, attivi e infaticabili:
Brunetta, Della Chiesa, Mazé, Villarey, Cadorna,
Govone e Chiabrera, e uscì vittorioso dalle prove le
più terribili e le più penose. Soffrì impavidamente la
fame, la sete, il freddo, il caldo, la pioggia, tutti gli
stenti, tutte le fatiche, tutte le disillusioni le più amare.
… Borjès era un uomo di cuore e d’onore, aveva tutti i
requisiti per fare uno dei più distinti capi partigiani:
attività, perspicacia, tenacità, sodezza, valore, calma
nel disordine, rassegnazione nei disastri, impavidezza
nei maggiori pericoli e nelle peggiori sventure.
Fu un tradito e un illuso. Tradito dalle promesse della
Camarilla reazionaria di Roma. – Illuso dalla fede nel
principio di legittimità. Egli vedeva nel suo operare e
persistere un’azione grande e generosa ed a questa
nobilmente si sacrificò.
Egli fu il don Chisciotte di una causa perduta e
screditata, combattè i molini al vento, ma li combattè
con la fede del soldato d’onore e di convinzione,
combattè da cieco e da pazzo sì, ma da generoso e da
valente qual era, da vero discendente del gran
cavaliere della Mancia, di Avalos, il famoso marchese
di Pescara, d’el Pastor, d’el Capucino, d’el Trapisto,
d’el Empecinado e di Castagnos (i quattro ultimi, noti
comandanti di insorti nelle guerre napoleoniche e
carliste)..
La cattura e l’esecuzione avvennero a opera del
maggiore Enrico Franchini, al comando di un
distaccamento di 1° reggimento bersaglieri, che era
stato informato da un delatore (un amministratore del
principe Torlonia) che gli ‘spagnoli’ (poco più di una
ventina) stavano bivaccando in una cascina di Luppa, a
qualche chilometro dal confine pontificio. Non è il caso
di soffermarci sulle tante incongruenze del rapporto
ufficiale, ma, rifacendosi tanto ad esso, che alle
(poche) fonti degne di considerazione, emerge che
Borgès, quando le fiamme, appiccate dai bersaglieri al
casolare in cui si era asserragliato con il suo pugno di
uomini, lo costrinsero alla resa ‘a condizione’ (oggi
diremmo incondizionata) si vide respingere con sgarbo
e sdegno la spada offerta dal Franchini (Giacinto de
Sivo affermò che l’ufficiale italiano dette uno schiaffo
al prigioniero e aggiunse che la pronta esecuzione si
dovette al fatto che il maggiore si era impadronito della
pingue ‘cassa’ del cabecilla e avrebbe avuto, quindi,
interesse a fare sparire i testimoni, ma lo storico di
Maddaloni è troppo di parte per essere preso come oro
colato), che delegò al disarmo un suo bersagliere.
Sempre Franchini dichiarò che Borgès, alla sua
proposta di rendere dichiarazioni, che, ove ritenute
importanti, gli avrebbero salvata la vita, rispose,
sogghignando, che le peggiori torture non gli avrebbero
estorto una sola parola. Disse male di Crocco, forse
fedele al Borbone, ma anche sanguinario indulgente a
ruberie, e dell’equivoco de Langlois, ma era il meno
che potesse proferire. Condotti a Tagliacozzo, furono
fucilati alla schiena in diciotto (tredici tra catalani e
9
spagnoli e cinque napoletani), di cui sedici ufficiali.
Affrontarono il plotone con eroica devozione, recitando
i salmi in castigliano. Il giorno dopo, le salme dei
giustiziati vennero incenerite tutte, a eccezione di
quella di Borgés, nel probabile timore che i borbonici
lo facessero ‘risuscitare’ o, addirittura, negarne
l’avvenuto decesso. Due mesi dopo, su richiesta del
principe di Scilla e del visconte de Saint-Priest, il
generale Alfonso Ferrero della Marmora disporrà
l’esumazione della salma del generale Borgès, che sarà
consegnata a un medico, inviato dalla legazione
francese presso la S. Sede. Condotta a Roma, funerali
solenni furono celebrati nella chiesa del Gesù, ma
ignoro il luogo della sepoltura definitiva.
ASCO
Notizie librarie
È da poco uscito un libro illustrato intitolato Ordine di
Malta, di due dei più autorevoli membri del Sovrano
Ordine di Malta, il Balí Fra' Elie de Comminges e dil
Balí Jean-Pierre Mazery, edito da Gangemi di Roma. Il
libro di 216 pagine, consta di 200 fotografie su
personaggi e la vita melitense dal 1880 al 1960. Sono
riprodotte fotografie di cavalieri e dame ma anche di
medici, infermieri e volontari. Ogni immagine è
accompagnata da didascalie e testi esplicative.
Il libro è in italiano e francese: peccato non sia anche in
inglese dato la nazionalità degli ultimi due Gran
Maestri.
È disponibile sia in forma cartacea sia in format pdf
(ISBN 13: 9788849230154 e ISBN 10: 884923015X)
al costo rispettivamente di € 30.00 e € 25.00.
(AMG-MDB)
Attività dei soci
Il nostro Presidente Emerito Carlo Gustavo di
Gropello è stato insignito, il girono 26 settembre 2014,
della Medaglia di Benerenza del Principe della Reale e
Ducale Casa di Parma e Piacenza da parte di SAR il
Principe Carlo Saverio di Borbone Parma, Duca di
Parma Piacenza.
Il giorno successivo, anche il nostro consigliere
Maurizio Bettoja ha ricevuto la Medaglia di Benerenza.
Complimenti ad entrambi! (AMG)
Sul Giornale Araldico Genealogico Diplomatico
Italiano Anno 1 N.1 Dicembre 2014 e apparso un interessante contributo araldico del nostro consocio
Vincenzo Amorosi intitolato “Gli stemmi dei re Filippo II, Filippo III e Filippo IV di Spagna”. L’articolo
è
visibile
online:
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sit
es&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjbHViYW5ub2
JpdHxneDo3ZmY5ZmFjZjBiOTM1NWQ
Si segnala che l’intero Giornale Araldico
Genealogico Diplomatico Italiano in format pdf è
scaricabile. (AMG)
Il Premio alla Cultura “l’Arcangelo” al
10
Consocio Roberto Nasi
Il nostro consocio Roberto Nasi ha ricevuto il
XX edizione del prestigioso premio alla cultura
“l’Aracangelo” che viene conferito dall’Associazione
Immagine per il Piemonte.
La motivazione per il conferimento è la
seguente:
come alto riconoscimento per l'attività di
tutela e di valorizzazione dei valori della cultura e
della storia del Piemonte sabaudo svolte da un maestro
di tradizioni piemontesi, storia risorgimentale e gran
Cavaliere oltreché di straordinaria umanità, negli
ultimi decenni a favore dell'immagine del Piemonte in
Italia e nel mondo
Il Premio consiste in una Targa bronzea fusa
appositamente per l'Associazione Immagine per il
Piemonte (onlus) da Johnson (Milano).
La cerimonia di premiazione, moderata dal
Presidente di “Immagine per il Piemonte”, Vittorio G.
Cardinali, si è tenuta al Circolo dell’Unione Industriale,
ha visto la partecipazione di folto pubblico.
Tra i vincitori delle edizioni precedenti del
premio l’Arcangelo vi sono la Casa Editrice Andrea
Viglongo,
il
Centro
Nazionale
di
Studi
Alfieriani (Asti), Segusium - Società di ricerche e studi
valsusini (Susa), S.E.R. Mons. Germano Zaccheo
(+) Vescovo di Casale Monferrato, il Generale Guido
Amoretti (+), direttore del Museo Pietro Micca, Cav.
del
Lavoro Alberto
Bolaffi,
Presidente
dell’omonima Casa Filatelica torinese.
Complimenti e vivissime congratulazioni al
consocio Nasi!
(AMG)
Il nostro vice-presidente Roberto SandriGiachino (assieme Ugo Grosso) ha dato alle stampe
nel febbraio 2015 il libro Tavigliano e l’antica
comunità di Andorno. Storia, famiglie, avvenimenti
(pubblicato dal Comune di Tavigliano – ISBN
8897616011), il libro (di 432 pagine) è in grande
formato ed ha più di 250 fotografie e cartine. Il volume
è diviso in due parti: la prima narra le vicende
dell'antica comunità di Andorno, la seconda quella di
Tavigliano dal 1699, quando ebbe una propria
amministrazione autonoma. Vi sono anche degli
appendici ben documentati e ricci che elencano i nomi
degli abitanti, dei chiavari e consoli di Andorno, dei
sindaci di Tavigliano e dei proprietari censiti negli
antichi catasti.
Nuovo Cardinale Patrono del Sovrano Militare
Ordine di Malta
Il Sovrano Militare Ordine di Malta ha un nuovo
Cardinale Patrono. L’8 novembre scorso, S.S. Papa
Francesco ha nominato il Cardinale statunitense
Raymond Leo Burke che in precedenza aveva rivestito
il ruolo di Prefetto della Segnatura Apostolica, cioè il
massimo tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
Il Cardinale Burke subentra a Sua Eminenza il
Cardinale Paolo Sardi, nominato Patrono nel 2009 da
S.S. Papa Benedetto XVI.
Negli Stati Uniti d’America il cardinale è stato vescovo
di La Crosse (1994–2003) nello stato di Wisconsin e
arcivescovo di St. Louis (2004–2008) nello stato di
Missouri.
Il Cardinale Patrono è il rappresentante del Pontefice
presso il Sovrano Ordine e ha il compito di promuovere
gli interessi spirituali dello stesso e dei suoi 13.500
membri, oltre ad essere responsabile delle relazioni con
la Santa Sede. È elemento di forti legami che uniscono
il Vaticano e il Santo Padre all’Ordine gerosolimitano.
Lo stemma del Cardinal Burke è: d’oro alla croce di
rosso con nel quarto destro un leone rampante di nero.
Il motto è: secundum cor tuum. Gli ornamenti esterni
sono quelli di un cardinale di Santa Romana Chiesa,
ossia il galero rosso (che corrisponde alla dignità
cardinalizia) con cinque ordini di fiochi. (Lo stemma
qui illustrato è quando il Cardinale Burke era ancora il
Prefetto della Segnatura Apostolica. Non abbiamo
potuto reperire suo stemma come cardinale patrono,
che dovrebbe avere il capo dell’Ordine [di rosso alla
croce d’argento] con aggiunto dietro allo stemma la
croce ad otto punte) è opera di Marco Foppoli, nostro
consocio e uno dei più bravi disegnatori araldici
contemporanei che sa cogliere e giustapporre l’antico
col nuovo e, pensiamo con questo disegno abbia
suscitato un senso di piacere al Cardinale Burke,
(consigliamo una visita al sito: http:/ /www .marco
foppoli.com/).
11
Armi di Francia
Sul tutto periodico della SISA riservato ai Soci
Direttore
Alberico Lo Faso di Serradifalco
Comitato redazionale
Marco Di Bartolo, Andrew Martin Garvey,
Vincenzo Pruiti, Angelo Scordo
Testata del periodico
di † Salvatorangelo Palmerio Spanu
Indirizzi postali
Direttore: Piazza Vittorio Veneto n. 12 10123 Torino
Redattore: Marco Di Bartolo, via IV novembre n. 16 10092
Beinasco (Torino)
Sito Internet
www.socistara.it
Posta elettronica
[email protected]
[email protected]
Segreteria della Società
Arch. Gianfranco Rocculi. Via S. Marco 28 20121 Milano
I contributi saranno pubblicati se inviati su supporto magnetico in formato word o via e-mail ai sopraccitati indirizzi.
Quanto pubblicato è responsabilità esclusiva dell’autore e
non riflette il punto di vista della Società o della redazione.
Gli scritti verranno pubblicati compatibilmente con le
esigenze redazionali ed even-tualmente anche in due o più
numeri secondo la loro lunghezza. La redazione si riserva la
possibilità di apportare qualche modifica ai testi per renderli
conformi allo stile del periodico.
12