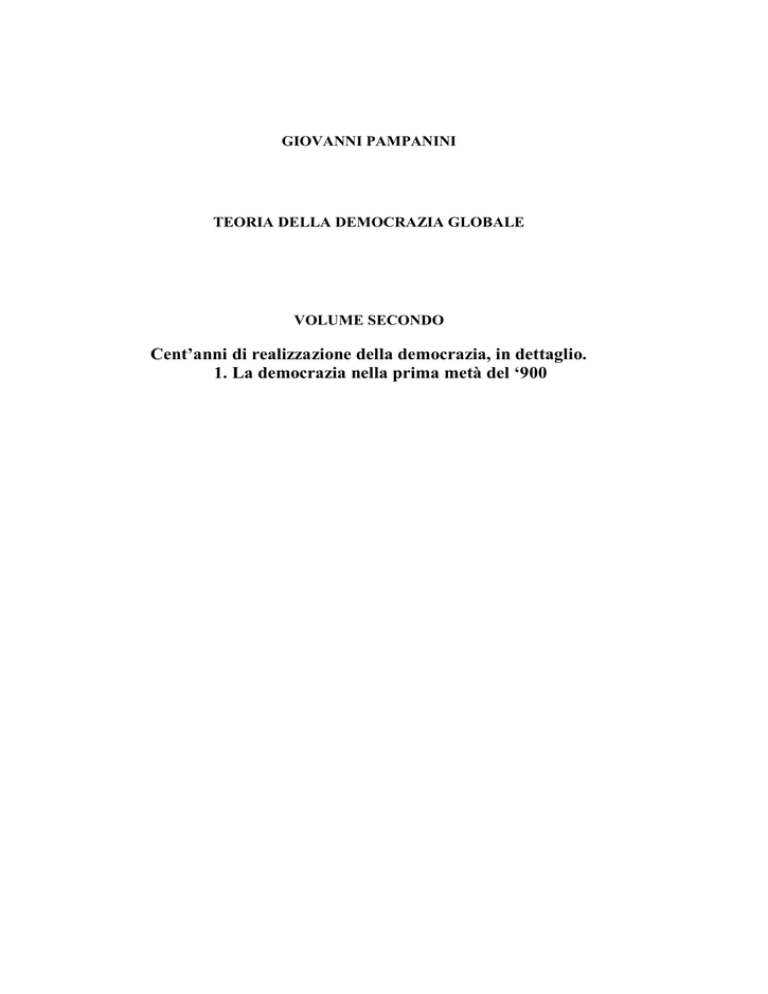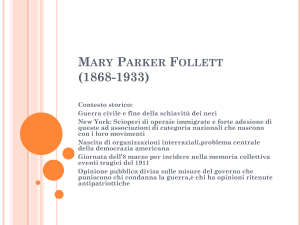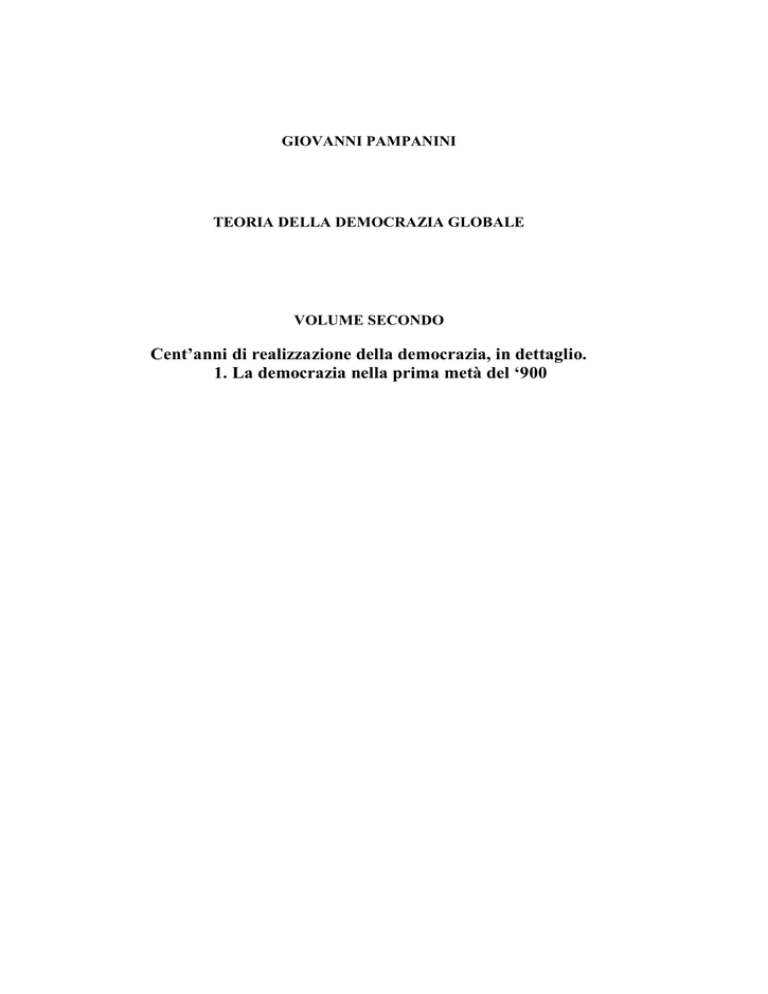
GIOVANNI PAMPANINI
TEORIA DELLA DEMOCRAZIA GLOBALE
VOLUME SECONDO
Cent’anni di realizzazione della democrazia, in dettaglio.
1. La democrazia nella prima metà del ‘900
Secondo volume: Cent’anni di realizzazione della democrazia, in dettaglio. 1. La democrazia
nella prima metà del ‘900.
Indice
Introduzione
Capitolo I. Dalla vittoria del Giappone sulla Russia alla Repubblica di Weimer.
Paragrafo 1: Storia
Paragrafo 2: Politica
Capitolo II. Dalla Grande Crisi alla Seconda guerra mondiale
Paragrafo 1: Storia
Paragrafo 2: Politica
Capitolo III. Attorno alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Paragrafo 1: Storia
Paragrafo 2: Politica
Conclusioni
Bibliografia
Introduzione
Questo secondo volume della Teoria della democrazia globale estende la ricerca alla
prima metà del XX secolo, fino all’insorgere della Guerra Fredda, che diventa subito
schema di riferimento delle Relazioni Internazionali.
1. Nella sezione storica (che sarà divisa, per comodità di esposizione, in otto macroregioni: Est Asia, Asia Centrale, Asia Meridionale, Asia Occidentale, Europa, Africa,
America del Nord e America del Sud – divisione che sarà mantenuta nei successivi
volumi, fino al quinto) cercherò di identificare le maniere in cui tutti i processi di
democratizzazione di cui abbiamo sufficiente informazione abbiano avuto successo o
insuccesso (come, cioè, siano stati bloccati da “passaggi irreversibili”); 2. dal punto di
vista politologico, studieremo gli attori e gli autori di azione e pensiero politico che
hanno fissato le caratteristiche della politica interna ed estera della democrazia
moderna.
Capitolo I
Dalla vittoria del Giappone sulla Russia alla
Repubblica di Weimer.
1900-1928
Paragrafo 1
Storia
1900-1928
All’inizio del XX secolo il Giappone era ancora un paese in corsa verso la
modernizzazione, soprattutto militare e tecnologica (riforma Meiji, a partire dal 1866),
sicché la guerra mossa nel 1904 contro la Russia, ritenuta una potenza, malgrado i
conflitti sociali interni, sembrò all’opinione pubblica mondiale un azzardo. Ad opera di
Ito Hirobumi, importante uomo politico attivo a cavallo fra Ottocento e Novecento, più
volte ministro e anche primo ministro, la riforma costituzionale aveva posto accanto al
governo una Dieta composta da due camere, una bassa, eletta con suffragio molto
ristretto e censitario, e una alta, formata da statisti anziani. Benché il potere della Dieta
sul governo fosse piuttosto limitato, fu grazie ad essa che i liberali poterono entrare per
la prima volta sulla scena politica nazionale, il che obbligò i ministri che volevano
raggiungere comunque i loro scopi a compiere delle operazioni corruttivo-simili,
politicamente più complesse e sofisticate di prima (Collotti Pischel, 1999, p. 63). Al
contrario di Ito, il suo avversario politico principale, Yamagata, usava mezzi di
convincimento dei parlamentari dichiaratamente non legali, come la corruzione o
addirittura gesti di forza.
Dopo il 1900 i continuatori della politica dell’uno e dell’altro uomo politico al vertice
del governo giapponese, come Saionji Kimnochi e Katsura Taro, proseguirono la loro
azione in un contesto in cui “il potere dei governanti non veniva sostanzialmente
intaccato dalla politica riottosa e turbolenta dei partiti presto ridotti anch’essi a
consorterie di gruppi e di interessi”. D’altra parte, le alternative erano scarse: “È
significativo che il Partito socialdemocratico nel 1901 venisse sciolto l’indomani della
sua nascita in base a una nuova, dura legge di polizia ‘per l’ordine pubblico’; la
mancanza di una rappresentanza privò la classe operaia giapponese di quella tutela
legislativa che in Occidente veniva introdotta in quei medesimi anni” (idem, p. 63).
Soltanto nel 1906, quando il Partito socialdemocratico si ricostituì, Saionji non lo
sciolse. Ancora più straordinario può sembrare il fatto che, a promuovere la politica di
espansione del Giappone in Asia fossero proprio i nazionalisti democratici, sulla base
della convinzione, peraltro plausibile, che anche i Giapponesi, a loro volta, si potevano
considerare vittime dell’aggressione colonialista dell’Europa (idem, p. 64). Malgrado (o
forse, grazie a) questa convinzione, il Giappone strinse uno strategico patto di alleanza
con l’Inghilterra nel 1902. Peraltro, la recente vittoria sulla Cina nel 1894-95 aveva
permesso, grazie al risarcimento ricevuto, di promuovere l’industria siderurgica, ciò che
aveva reso il paese in poco tempo indipendente dall’estero quanto a fornitura di armi
(Collotti Pischel, 1982, p. 85).
Nella Russia sconfitta dal “nano giapponese”, lo zar si rifiuta di fare le opportune
riforme, mentre l’opposizione liberale incalza e si ramifica. Nicola II fu così costretto a
promulgare una costituzione riconoscendo ampi poteri legislativi alla Duma, il
parlamento (con membri eletti tramite elezioni a suffragio universale maschile), ma
lasciando a se stesso il grosso del potere esecutivo, soprattutto in politica estera. Il
desiderio di Nicola II, infatti, era quello di disporre di una Duma docile,
“addomesticata”, piuttosto che di un parlamento davanti al quale il suo governo dovesse
sentirsi responsabile. Nel 1907 Nicola II ottenne un risultato diplomatico notevole a
proposito del “Grande Gioco”, cioè, la lotta con la Gran Bretagna per la supremazia in
Asia centrale, spartendosi con questa l’influenza sulla Persia (idem, p. 418). Da qui la
nascita della Triplice Intesa, con Francia, Gran Bretagna e Russia, contrapposta alla
Triplice Alleanza di Germania, Austria-Ungheria e Italia (ibidem). Nel 1912-13 le
successive guerre balcaniche dovevano lasciare sul terreno una situazione tutt’altro che
pacificata, sicché quando i patrioti serbi uccisero, il 28 giugno 1914, l’erede al trono
asburgico, l’arciduca Francesco Ferdinando, scattò automaticamente il sistema delle
alleanze europee e si ebbe praticamente la Prima guerra mondiale, a cui la Russia
partecipò senza esserne la maggiore responsabile, dato che non aveva partecipato alla
“corsa alle colonie” che tanta parte ebbe nello scatenare il terribile evento.
Se l’impero ottomano era il “grande malato” dell’Europa, l’impero cinese era la stessa
cosa in Asia (vedi Collotti Pischel, 1982, p. 86 sul “protocollo” del 1901). I tentativi
dell’imperatrice Cixi di rammodernare lo stato (un rimodernamento che, secondo lei,
sarebbe dovuto passare attraverso la repressione dei movimenti riformatori dal basso) si
dimostrarono inefficaci (Collotti Pischel, 1999, p. 115). Fra riformatori e rivoluzionari
si distingue Sun Yat-sen, sostenitore della necessità della modernizzazione
all’occidentale del suo paese. Nel 1905 Sun riunì un assembramento (più che un partito
vero e proprio) che prese il nome di Tongmenghui (o T’ung Meng-hui, Lega giurata),
col quale manifestò la piattaforma del suo programma politico, basato sui “tre principi
del popolo”: la sua sopravvivenza fisica, la sua identità, i suoi diritti. Attorno a questo
programma si organizzò un vasto movimento che, tramite società segrete, portò Sun al
successo, nell’ottobre 1911, a Nanchino dove dichiarò nata la Repubblica cinese da lui
presieduta (Collotti Pischel, 1982, pp. 108-111). Tuttavia, per effetto dell’accordo
siglato nel 1916 fra il militare Yuan, emissario dell’imperatrice, ancora riconosciuta
internazionalmente, e i Giapponesi, la Cina fu completamente sottomessa al Giappone
(idem, p. 121).
Nel disegno imperiale della Gran Bretagna (la regina Vittoria assunse il titolo di
imperatrice nel 1877), l’India era destinata a svolgere un ruolo centrale. Dal punto di
vista economico, l’India era concepita come il sostegno alla Gran Bretagna, e col tempo
doveva quindi impoverirsi sempre di più a vantaggio della madrepatria (Collotti
Pischel, 1999, pp. 93-94). Nel contesto della ribellione del 1905 (anche questa suscitata
dall’entusiasmo per la vittoria del Giappone sulla Russia), emersero nuovi leader e
nuovi concetti, agitati dai militanti nazionalisti indiani, fra cui l’ideale dello swaraj,
autonomia e autogoverno, o indipendenza, e lo swadeshi, autosufficienza, in pratica, il
boicottaggio delle merci inglesi e, al contempo, l’invito al consumo esclusivo delle
merci indiane. La reazione del Raj britannico fu violenta, da un lato, ma anche di tipo
riformistico (le riforme più importanti sono quelle Morley-Minto, del 1909, e
Chelmsford-Montagu, del 1919: idem, p. 95).
In Africa, fino alla Prima guerra mondiale è l’impero tedesco che la fa da padrone.
Terribile rimane la repressione tedesca della rivolta degli Herere in Namibia nel 190405, che assunse le proporzioni di un vero e proprio genocidio. Inoltre, la Francia
controllava ora buona parte dell’Africa equatoriale e orientale; la Gran Bretagna,
l’Africa orientale; il Belgio controllava il Ruanda, il Burundi e il Congo. Fuori
dall’Africa nasce e cresce intanto un movimento panafricano di emancipazione, che ha
il suo primo rappresentante nell’intellettuale afro-americano William Edward
Burghardt Du Bois, ispiratore della National Association for the Advancement of
Coloured People nel 1909. Sotto la sua leadership si organizza il primo Congresso
panafricano, a Parigi nel 1919, a cui poi seguiranno, fino al 1929, altre tre Congressi:
1921 a Londra, Bruxelles e Parigi, in contemporaneità; 1923, a Londra e a Lisbona; e
1927 a New York (Speitkamp, 2010, p. 158).
Con Theodore Roosevelt nel 1901 gli USA avevano inaugurato la cosiddetta politica
della “porta aperta”, cioè, la fine dell’isolazionismo e l’interesse al mondo da parte
della nascente potenza del Nuovo Continente, che in pratica si traduceva in una politica
di tipo colonialistico nei confronti dell’America Latina consona agli interessi del grande
capitale statunitense (Rockfeller, “il re del petrolio”, Carnegie, “il re dell’acciaio”,
Morgan, il potente magnate della finanza, sono tra i nomi che cominciano a spiccare a
partire da questa epoca), il “che poteva essere interpretato come uno svolgimento della
dottrina di Monroe, e nel senso dell’espansione nel Pacifico, che, con un certo sforzo
d’immaginazione, poteva apparire come un prolungamento ed una ripresa dell’avanzata
dei pionieri verso Ovest” (Villari, 1971, p. 394). Nel 1901-02, al fine di costringere il
governo venezuelano a onorare i contratti sottoscritti con gli imprenditori europei e
statunitensi, gli USA, la Germania, l’Italia e la Gran Bretagna praticarono il blocco
navale. In quell’occasione, il ministro degli Esteri argentino Luis Drago, recuperando
l’elaborazione dell’internazionalista liberale Carlos Calvo (anch’egli Argentino) degli
anni Sessanta dell’Ottocento, inviò un memorandum al presidente USA, facendo
presente “che il debito pubblico non poteva essere occasione di interventi armati e
nemmeno di occupazione territoriale delle nazioni americane” (Carmagnani, 2003, p.
309). Questa dottrina, chiamata da allora Calvo-Drago, venne sposata da tutti i paesi
latino-americani e recepita dalla Conferenza dell’Aja del 1907.
Il Messico, sotto la lunga presidenza di Porfirio Diaz (in carica dal 1877), aveva
conosciuto un periodo di stabilità e modernizzazione, ma anche di inserimento del
capitale esterno e di aumento della distanza fra ricchi e poveri. Malgrado il presidente
stesso non fosse un semplice spettatore imparziale di questi processi, rimase famosa la
sua caustica frase: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”
(Speckman Guerra, 2007, pp. 203-205). La situazione nel paese precipita nel 1911,
dopo la lotta fra Diaz e il suo avversario Francisco Madero, in cui gli USA esercitarono
un ruolo ambiguo a sostegno delle forze reazionarie di Victoriano Huerta (Garciadiego,
2007, p. 241. Successivamente, Wilson, divenuto nel frattempo presidente USA, inviò i
Marines a Haiti nel 1915 per “esportarvi” la sua democrazia). A partire da questi
eventi, come si disse allora, “l’America Latina si apprestava a diventare il giardino di
casa degli USA”. Tuttavia, i paesi latino-americani reagirono a questa interpretazione di
comodo della dottrina Monroe data da Roosevelt, e in varie conferenze (Città del
Messico, 1901, Rio de Janeiro, 1906, Buenos Aires, 1910, Santiago del Cile, 1923 e La
Havana, 1928) presero l’abitudine a consultarsi fra loro (anche per quanto riguardava i
confini territoriali), limitando così lo strapotere nord-americano, almeno per quel che
riguardava il loro sub-continente (Carmagnani, 2003, p. 218).
Dal punto di vista internazionale, fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, il Brasile
(presidente Rodrigues Alves dal 1902) “mantinha uma estrutura economica agrarioexportadora que o situava, na divisao internacional do trabalho, em uma posiçao
periferica” (Aquino et al., 2000, p. 112). Anche l’economia dell’Argentina (sotto la
presidenza di José Figueroa Alcorta) si andò integrando col capitalismo internazionale
all’inizio del XX secolo – e anche qui gli immigrati europei giocarono un ruolo
decisivo. Carmagnani nota: “Il passaggio dal concerto europeo a quello internazionale
amplia la partecipazione europea nelle aree extraeuropee. Infatti, le principali potenze
dell’Europa si trovano ad affrontare una crescente competizione da parte delle medie
potenze e cercano di contrastarle aumentando il proprio potere militare e navale ed
espandendo le spese statali ai fini militari, tanto da trasformarle in un propulsore della
crescita dei cantieri navali, delle fabbriche di armi e, più in generale, dell’industria
metalmeccanica ed elettrica” (Carmagnani, 2003, p. 208). In poche parole: più potere =
più esercito.
La presenza USA era destinata ad aumentare, soprattutto da dopo la Prima guerra
mondiale e fino agli anni Trenta, con forme non dissimili da quelle utilizzate dagli stati
europei nei confronti del resto del mondo: occupazioni militari (Nicaragua, Haiti),
annessioni e protettorati (Panama, Cuba, Repubblica Dominicana), e pressioni
economiche. Le aziende statunitensi, operanti soprattutto nei settori dell’agricoltura
tropicale e delle miniere, presero l’abitudine di anticipare la presenza militare (idem, p.
222). Durante la Prima guerra mondiale, tutti i paesi latino-americani rimasero neutrali.
Per quanto riguarda l’impero ottomano, malgrado l’imperatore al-Hamid II si sentisse
risollevato dalla modesta vittoria contro gli insorti cretesi, il suo impero si era
effettivamente alquanto indebolito (Schulze, 2004, p. 35). In realtà, l’Europa procedeva
velocemente alla colonizzazione dell’Africa e dell’Asia, anche vincendo tante
resistenze. Infatti, Schulze nota: “Per quanto non esista un nesso causale tra la
rivoluzione russa del gennaio 1905, il movimento costituzionalista persiano del 1906, la
propaganda nazionalista egiziana dello stesso anno e il colpo di stato di luglio dei
Giovani turchi a Istanbul del 1908, tuttavia il clima politico del periodo prebellico nei
paesi islamici non differiva granché da quello degli stati europei. L’espansione
coloniale, che dal 1878 al 1896 aveva saputo mantenere un ordine relativo nella
maggioranza dei paesi islamici, appariva palesemente prossima alla fine. Stava
volgendo al termine la ‘decade aurea’ del colonialismo (1896-1906)” (idem, p. 44).
Segretamente, infatti, le potenze europee avevano già provveduto alla spartizione anche
dell’impero turco e della Persia. La Prima guerra mondiale doveva non solo mettere
fine al plurisecolare impero ottomano, ma avrebbe anche accentuato l’opposizione fra
le due culture e società, la turco-ottomana e l’araba (idem, p. 56).
Dopo la Prima guerra mondiale, che non fu affatto rapida come Guglielmo II aveva
pensato, la fine degli imperi centrali europei e la rivoluzione bolscevica, Wilson, che
pure in quel periodo stava contribuendo a soffocare le proteste democratiche in
Messico, si sentì di affermare che l’intervento militare USA a fianco delle potenze
“liberali”, Inghilterra e Francia, libere ora da quell’impresentabile Intesa che le aveva
tenute unite alla Russia zarista (ma non sapeva degli accordi segreti, e cinici, che queste
stesse potenze “liberali” avevano già sottoscritto con la Russia zarista per spartirsi il
Medio Oriente …), avrebbe difeso nientedimeno che la stessa democrazia, i diritti e le
libertà delle piccole nazioni (Villari, 1971, p. 452; Jones, 2000, pp. 379-381: gli accordi
segreti sono quelli divenuti successivamente famosi come Sykes-Picot, in quanto
negoziati dai mediatori Mark Sykes e George Picot a Sèvres nel maggio 1915, resi
pubblici solo il 22 novembre 1917, appunto, da Lenin una volta giunto al potere e
scoperte le carte dello zar). Peraltro, già durante la guerra mondiale gli alleati
dell’Intesa avevano più volte proclamato il diritto dei popoli all’auto-determinazione
(più o meno sinceramente); lo stesso principio era stato ribadito da Lenin una volta
giunto al potere nel 1917; e dunque il presidente USA Wilson, nella sua dichiarazione
in 14 punti dell’8 gennaio 1918, non faceva che mettere in forma schematica una
concettualizzazione relativa alla democrazia internazionale che era già stata paventata
da ben altre parti. Certo, riaffermata da un capo di stato tanto importante e vincitore
quanto erano gli USA, quest’affermazione di diritto fu presa dappertutto come
l’assenso alla richiesta degli indipendentisti di tutto il mondo. Ben presto, però, i diversi
delegati dei paesi colonizzati, venuti a Versailles per partecipare alle conferenze di pace
e per chiedere l’indipendenza dei loro paesi natii, dovevano comprendere che la
dichiarazione di Wilson andava intesa in senso ristretto, cioè europeo (Schulze, 1994,
p. 59. Peraltro, i paesi latino-americani non vi erano stati nemmeno invitati, a
Versailles) (Villari, 1971, p. 460). Ecco, dunque, un altro importante “passaggio
irreversibile” al livello di non-democratizzazione delle Relazioni Internazionali.
Per quanto riguarda la politica estera, al fine di coordinare l’insieme dei partiti
comunisti europei ed asiatici con quello sovietico, Lenin e gli altri capi comunisti
europei decisero di formare un ufficio apposito, il Komintern, costituito a Mosca nel
marzo 1919. Tuttavia, Lenin decise di abbandonare la prospettiva rivoluzionaria
europea, rendendosi conto che le prospettive rivoluzionarie più serie si trovavano in
Asia.
In Cina (dove intanto, nel 1912, il T’ung Meng-hui si trasformava in partito politico, il
Kuomintang capeggiato dal militare Chiang Kai-shek), nacque il Partito comunista
cinese (1921) rimpiazzando le vecchie e superate società segrete, con l’aiuto del Soviet;
la Mongolia si separava dalla Cina, e i due partiti vissero alleandosi ma anche
scontrandosi (feroci gli episodi del dicembre 1927 a Shanghai: Collotti Pischel, 1999, p.
183).
Da parte sua, alla fine della guerra, l’impero ottomano veniva occupato a chiazze di
leopardo dalle forze alleate, in seguito all’armistizio di Mudros del 30 ottobre 1918. Nel
1920 ad Ankara Kemal convocò un’assemblea nazionale turca per procedere alla
ricostituzione della nuova Turchia e per liberarla dalle potenze europee che
l’occupavano (in questo contesto Kemal invitò perfino i bolscevichi a fare fronte
comune – un fronte turco-sovietico – contro il resto dell’Europa – una prospettiva, però,
che i sovietici, favorevoli agli Armeni e ai Curdi, lasciarono cadere: idem, p. 68). La
nuova costituzione turca (e non più ottomana) venne pubblicata il primo marzo 1921,
ma la vittoria definitiva sui Greci, ancora operanti a Izmir, venne solo nel 1922. Con
essa si ultimò la ricostituzione definitiva del territorio nazionale turco, con capitale
Ankara, che fu riconosciuto come tale dal Trattato di Losanna. Kemal, nuova stella del
nazionalismo repubblicano, fu nominato presidente della nuova Turchia il 29 ottobre
1923 come Ataturk, padre della Turchia.
La Persia, in seguito alla revoca del Trattato anglo-persiano del 1919, che assicurava
alla Gran Bretagna il monopolio economico del paese (erano stati trovati giacimenti
petroliferi nel sud del paese), si era stabilizzata nel 1921 sotto la guida militare di Rida
Han (o Reza Khan) che, poco per volta, aveva ripreso il controllo sull’intero territorio
dell’ex-impero persiano (la “liberazione nazionale”). Dopo una fase in cui ci fu la
possibilità di istituire una repubblica, proprio come stava facendo contemporaneamente
Mustafa Kemal in Turchia, Rida Han, forte del potere militare, depose l’ultimo scià
cagiaro, Ahmad Sciah, nel 1925, e si fece eleggere scià a sua volta, instaurando la
dinastia dei Pahlavi, praticamente una dittatura militare, che sarebbe durata fino al
1979.
Data la crisi post-bellica della Gran Bretagna, e in un mutato clima internazionale (la
Rivoluzione bolscevica andava avanti e si cominciavano a vedere i primi risultati grazie
al miglioramento dell’economia pianificata), entra attivamente nella lotta per
l’indipendenza dell’India Nehru, a fianco di Gandhi, che ormai godeva di larga
popolarità fra le masse indiane per via delle sue varie iniziative di non-violenza. Dopo
la grande depressione del ’29 la lotta per l’indipendenza dell’India si sarebbe inasprita.
Negli anni Venti, si attua quella che Carmagnani, fra gli altri, chiama la traslatio
imperii, il trasferimento del centro della civiltà occidentale dalla vecchia Europa
all’America settentrionale (Carmagnani, 2003, p. 304). Tuttavia, l’America non era
affatto unita da nord a sud, anzi: le terribili esperienze di sopraffazione della parte nord
yankee sul sud del Continente spiegano abbondantemente la tiepidità con cui l’America
Latina accettò di far parte della Lega delle Nazioni e accolse la dottrina di Wilson
(idem, p. 308). Peraltro, grazie anche all’appoggio democratico dell’opinione pubblica
statunitense, opposto alle mire espansionistiche del proprio governo, i paesi caraibici e
centro-americani riebbero la loro indipendenza negli anni Venti.
Tra il 1870 e il 1929 “l’economia latino-americana triplicò il proprio prodotto interno
lordo, duplicò il reddito procapite, triplicò la popolazione e quintuplicò la propria
partecipazione al commercio internazionale” (idem, p. 226).
Dopo la guerra mondiale gli USA, delusi dagli esiti della pace di Versailles, tornarono
alla politica dell’isolazionismo e non aderirono alla Società delle Nazioni, malgrado il
parere positivo dei presidenti repubblicani susseguitisi dopo il promotore Wilson
(Jones, 2000, pp. 432-452). Vale la pena di ricordare l’iniziativa Briand-Kellogg dal
nome dei due uomini, il primo, ministro degli esteri francese e il secondo, degli USA,
che nel 1928 sottoscrissero un accordo teso a “mettere la guerra fuori legge”, come si
disse allora. – Un “monumento all’utopia”, dal momento che non erano previste
sanzioni per quello stato che l’avrebbe trasgredito, ma che valse il Premio Nobel per la
Pace ai due uomini politici (Jones, 2000, p. 435).
Il Partito repubblicano, forte del favore che si era conquistato abbassando ulteriormente
le tasse, ottenne la presidenza in quello stesso 1928, con Herbert Hoover, il presidente
“ottimista” che doveva farsi cogliere impreparato dal crollo di Wall Street.
Paragrafo 2
Politica
1900-1928
Ecco una selezione delle opere maggiori di filosofia politica, o comunque di interesse
per la filosofia politica, del periodo 1900-1929, elencate in ordine cronologico:
1902: Ostrogorski, La democrazia ed i partiti politici: studi sulle tendenze oligarchiche
degli aggregati politici.
1902: Muhammad ‘Abduh, Apologia dell'Islam contro il Cristianesimo.
1902: J.A. Hobson, Imperialism.
1902: Joseph Conrad, Cuore di tenebra.
1902-1910: Liang Ch’i-ch’ao, Hsin-min Ts’ung-pao – Miscellanea del popolo nuovo.
1905: Sun Yat-sen, Min Pao (Giornale del Popolo).
1905: Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo.
1906: Pareto, Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza sociale.
1907: Henri Bergson, L’evoluzione creatrice.
1908: Meinecke, Weltburgentum und Nationalstaat.
1908: Georges Sorel, Réflexions sur la violence.
1909: Gandhi, Hind Swaraj.
1909: Lenin, Materialismo e empiriocriticismo.
W.E.B. DuBois, autore dal 1909 dei primi summit anti-colonizzazione a favore
dell’Africa.
1910: Michels, La democrazia e la legge ferrea dell'oligarchia: saggio sociologico.
1910: Unamuno, La mia religione.
1911: Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie.
Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens.
1911: Kitaro Nishida, Uno studio sul bene.
1912: Corrado Gini, pubblica il suo Indice.
1912: Emile Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa.
1913: Premio Nobel per la Letteratura a Rabindranath Tagore.
1913: Edmund Husserl, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia
fenomenologica.
1913: Unamuno, Del sentimento tragico della vita.
1915: (a partire dal) il giornale Xin Qingnian (Gioventù nuova), con articoli di Hu Shi,
Li Dazhao e Lu Xun.
1916: Dewey, Democracy and Education.
1916: Pareto, Trattato di sociologia generale.
1917: Lenin, L’imperialismo come fase suprema del capitalismo (scritto nel 1916)
1917-18: Lenin, Stato e rivoluzione.
1918: Karl Jaspers, Psicologia delle concezioni del mondo.
1919: Henri Bergson, L’energia spirituale.
1919: Keynes, Le conseguenze economiche della pace.
1919: von Mises, Nation, Staat und Wirtschaft.
1920: Keynes, Treatise on Probability.
1920: Lenin, L’estremismo, malattia infantile del comunismo.
1920: (fino al 1940) la Scuola di Chicago fondata da C.E. Merriam.
1920: Von Mises “manifesto liberale”.
1920: Pareto, Fatti e teorie.
1921: Pareto, Trasformazione della democrazia.
1921: Weber, Economia e società.
1921: Max Scheler, L’eterno nell’uomo.
1921: Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus.
1922: Surendranath Dasgupta (1885-1952), Storia della filosofia indiana.
1922: Servapalli Radhakrishnan, Storia della filosofia indiana.
1922: Tagore istituisce a Santiniketan l’Università internazionale.
1923: Pollock, Introduzione allo studio della scienza politica.
1923: Keynes, Trattato sulla riforma monetaria.
1924: Lukacs, Lotta e coscienza di classe.
1924: Kelsen, Il problema del parlamentarismo.
1924: Oswaldo de Andrade (già famoso per lo slogan parodia: “Tupy or not tupy, that
is the question”), Mario de Andrade e Tarsila do Amaral, costituiscono la tendenza di
sinistra del movimento modernista, Manifesto Pau-Brasil, in cui criticano il
nazionalismo di destra. Più oltre Oswaldo de Andrade estremizzò questo approccio
arrivando a rifiutare qualsiasi influenza culturale proveniente dall’Occidente, e
promuovendo una ricerca all’interno della cultura brasiliana soltanto.
1925: ‘Ali ‘Abd al-Raziq, al-Islam wa-usul al-hukm (L’Islam e i fondamenti del potere.
1925: Benedetto Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti.
1925: De Ruggiero, Storia del liberalismo europeo.
1925: Unamuno, L’agonia del cristianesimo.
1926: Taha Hussein, La poesia pre-islamica.
1926: Stalin, Questioni del leninismo.
1926: André Gide, Viaggio in Congo.
1926: Keynes, The End of Laissez-Faire.
Piero Sraffa
1927: Julien Benda, La Trahison des clercs.
1927: Spengler, Il tramonto dell’Occidente.
1927: Heidegger, Essere e tempo.
1927: Heisenberg, teoria dell’indeterminazione.
1927: Lasswell, Propaganda Technique in First World War.
1927: Mosca, Saggi di storia delle dottrine politiche.
1928: Carl Schmitt, Verfassungslehre.
1928: José M. Mariateguí, 7 esayos de interpretacion de la realidad peruana.
1928: el-Banna: creazione dell’associazione dei Fratelli musulmani.
1929: Hotelling, Teoria economica della democrazia.
1929: Kelsen, Essenza e valore della democrazia.
Jabran Khalil Jabran (1883-1931), I detti del profeta.
Mantenendo lo stesso ordine solare – da Est a Ovest – dell’esposizione storica del
primo capitolo, inquadreremo adesso le opere indicate nel loro contesto geo-storico.
Nel 1911, anno in cui il Giappone si annette la Corea, il quarantenne Kitaro Nishida
(1870-1945), successivamente riconosciuto come l’iniziatore della controversa Scuola
di Kyoto, pubblica il suo primo grande libro: Uno studio sul bene (Nishida, 2007), nel
quale, a colloquio con la tradizione filosofica e psicologica europea e statunitense, la
politica fa solo capolino. In un passaggio sul legame fra etica e politica, relativamente
all’autorità, Nishida scrive: “Considerando la storia delle dottrine etiche si possono
rinvenire due tipi di teorie dell’autorità: quelle dispotiche, incentrate sulla figura di un
sovrano, e quelle teocratiche basate su Dio” (idem, p. 116). Da qui discende che mai
l’uomo fa del bene perché lo sente, ma solo per paura delle punizioni, sicché il
paradosso finale (che sa di Nietzsche) è che quando un uomo fa del bene, non fa un atto
buono: “A partire dal punto di vista delle teorie dell’autorità non solo non si può
spiegare l’impulso morale, ma anche la cosiddetta ‘legge morale’ diventa qualcosa di
pressoché insensato e di conseguenza viene meno anche il criterio della distinzione tra
bene e male” (idem, p. 117). L’intenzione di Nishida è mostrare la necessità di una
morale-stato in direzione di quell’autentico bene che solo può sgorgare dal profondo
dell’uomo: “A tutt’oggi lo stato è l’espressione più grande della coscienza comunitaria
unificata, ma l’espressione della nostra persona non può arrestarsi qui, abbisogna di
qualcosa di ancora più grande. Si tratta cioè di un’unione sociale solidale di tutti gli
uomini che abbia abolito ogni differenza generica e creato un unico gruppo. Un simile
ideale è già comparso nel cristianesimo di Paolo e presso gli stoici. Ma un tale ideale
non è facile da realizzare. Oggi il nostro tempo è ancora un’epoca di pace armata”
(idem, p. 149).
In Cina, Liang Ch’i-ch’ao, liberale riformista, a 25 anni ministro dell’effimero regime
creato dal suo maestro K’ang Yu-wei nel 1898, come tutti i liberali del tempo, “non
credette mai che nel determinare il destino del paese potessero intervenire con efficacia,
preparazione e legittimità forze nuove operanti dal basso, estranee per origini e
qualificazione culturale alla classe dirigente” (Collotti Pischel, 1982, p. 90). Riparato a
Tokyo, da lì continuò alacremente la sua azione culturale e politica (diffuse i suoi scritti
Hsin-min Ts’ung-pao – Miscellanea del popolo nuovo, 1902-1910, che furono molto
letti benché messi al bando). Liang era fermamente convinto che la Cina dovesse fare
esattamente ciò che l’Europa era stata capace di fare “dal Rinascimento in poi”:
liberarsi dai ceppi dell’ideologia. Liang vide nettamente in Montesquieu colui che più
di ogni altro autore europeo aveva saputo trovare, nell’idea di separazione dei poteri, il
modo per rammodernare lo stato. Nel giornale Xin Qingnian (Gioventù nuova),
pubblicato a partire dal 1915, venivano agitati i motivi anti-tradizionalisti, contro
l’eredità di Confucio, assunto come bastione della superstizione, e a vantaggio del
rinnovamento (idem, p. 123). Il giornale pubblicava scritti innovativi di intellettuali
come il filosofo Hu Shi, formatosi con Dewey, Li Dazhao, sociologo ed economista, e
Lu Xun, famosissimo scrittore.
Anche se non più giovane (era nato nel 1866) troviamo tra coloro che “passano
all’azione” il futuro primo presidente della Repubblica cinese, Sun Yat-sen, che mise in
essere società segrete dedite alla cospirazione. Fra i suoi riferimenti, a Mazzini affiancò
Lincoln, gli anarchici agli comunisti russi (e forse conobbe Plechanov in persona). Dal
Giappone, da dove operava dall’interno di una società segreta (la T’ung Meng-hui),
pubblicava il giornale Min Pao (Giornale del Popolo), che ben presto soppiantò gli
scritti di Liang nelle preferenze dei giovani rivoluzionari. Da questo pulpito Sun lanciò
nel 1905 la sua dottrina nazionalista fondata sui tre principi democratico-borghesi, di
cui si è detto nel paragrafo precedente.
In questo periodo appaiono i primi scritti di Mao Tze-Tung – scritti soprattutto tattici di
organizzazione del movimento rivoluzionario contadino in varie province (Hunan e
altrove) (Mao, 1977, pp. 3-89).
In India la reazione all’aggressione dell’Occidente fu facilitata dal risveglio della
tradizione vedica dell’Ottocento a cura di uomini di varia formazione come Keshav
Chandra Sen, Ramakrishna, Aurobindo Ghose e Vivekananda. Quest’ultimo, in
particolare, si incaricò perfino di “esportare” i valori spirituali prettamente indiani negli
USA, dove vi svolse nei primi decenni del XX secolo un’opera di tipo missionario. Dal
punto di vista culturale e letterario immenso fu l’apporto di Rabindranath Tagore, che si
adoperò per instaurare un dialogo permanente fra la civiltà occidentale e quella
orientale, l’indiana in particolare, istituendo (a sue spese) un’Università del dialogo a
Santiniketan, nel Bengala, ancor oggi esistente (fu insignito del Premio Nobel per la
Letteratura nel 1913). In questo panorama indiano di attori e pensatori democratici il
posto centrale è occupato da Mohandas K. Gandhi (1869-1948). Nel 1909 pubblica
Hind Swaraj, dove, proponendo agli Indiani una forma di vita più semplice e
onesta,contestava la validità della civiltà moderna nel suo insieme – la crescita
materiale e le continue trasformazioni tecnologiche, insieme alle istituzioni politiche
occidentali. Sulla spinta dell’orgoglio recuperato con il movimento culturale di Gandhi,
Tagore e Aurobindo Gosh, anche la Filosofia indiana trova il coraggio per riproporsi a
livello mondiale, con le opere di Surendranath Dasgupta (1885-1952), celebrato
professore di Filosofia di Calcutta, ospite negli anni ’30 in molte università europee e
autore di una storia della filosofia indiana in cinque volumi, pubblicata nel 1922. Un
altro autore importante, futuro primo presidente dell’India libera, è Servapalli
Radhakrishnan, che chiudendo la sua Storia della filosofia indiana si lamentava di
come i pensatori indiani abbiano smarrito l’originalità della loro iniziativa di pensiero,
che fu forte fino alle soglie dell’Età moderna, quando l’India cadeva sotto il dominio
prima musulmano e poi inglese. Si lamentava anche che l’educazione religiosa indù
non ci fosse più e che il sistema indiano fosse talmente mutato da far diventare gli
Indiani più Inglesi degli Inglesi stessi (“Il desiderio di Macaulay è stato soddisfatto”,
scriveva sarcasticamente nel 1922: idem, p. 827). E spera in una ripresa dell’originalità
indiana, fautrice di libertà per tutti i popoli asiatici rispetto all’invadente Occidente,
senza estremismi ma con equilibrio (idem, pp. 820-829).
Moisei Ostrogorski (1854-1921), bielorusso, è considerato insieme a Max Weber e
Robert Michels uno dei fondatori della sociologia politica, in particolare, dello studio
dei partiti politici. Nel 1902 pubblicò la sua opera maggiore La democrazia ed i partiti
politici (originariamente in francese), focalizzato soprattutto su USA e UK. Le sue
osservazioni hanno fatto scuola: 1. la fedeltà ai partiti è spesso paragonabile alla fedeltà
ad una religione; 2. non appena un partito viene creato, anche se è motivato dai più
nobili intenti, si sforza in primo luogo di perpetuare se stesso, tendendo alla
degenerazione oligarchica – probabilmente, questo tratto comune a tutti i partiti e
contesti democratici di competizione, è anche frutto della concorrenza e della
competizione elettorale democratica – e a questo scopo esso è capace anche di
utilizzare gli strumenti del potere pubblico e le ricchezze sociali; 3. questo fa sì che nei
partiti presto o tardi si riducano la democrazia interna e l’autonomia dei rappresentanti
eletti, i quali da portatori del proprio autonomo pensiero o convinzioni, oppure da
rappresentanti dei cittadini, sono come forzati a divenire funzionari dei partiti (queste
osservazioni sono state studiate e usate da successivi attori e autori politici – per tutti
basti citare Lipset – per vedere come accade che i partiti politici finiscano per
“occupare” lo stato e le sue istituzioni); 4. il potere finisce prima o poi nelle mani di
pochi per servire interessi particolare contro l’interesse generale – addirittura, le attività
legislative e amministrativa si possono vendere e comprare, insieme alle cariche
pubbliche (virtualmente, messe all’asta: capitolo XII, par. I).
I difetti dei sistemi democratici e dei partiti politici, tuttavia, sono visti da Ostrogorski
come suscettibili di correzione con l’introduzione di misure anti-corruzione e limitative
dello strapotere dei partiti, oppure facendo ricorso all’eliminazione del monopolio del
potere legislativo, come accadeva nella forma svizzera o in alcuni stati USA dell’Ovest,
dove vigeva la democrazia diretta. Questa convinzione differenzia Ostrogorski da altri
autori contemporanei, come Weber o Michels, che invece ne traevano una conclusione
come di una legge tendente all’elitismo. Fra tutti i rimedi ideati da Ostrogorski quello
forse più famoso consiste della temporaneità dei partiti stessi, i quali, una volta
dichiarati e raggiunti gli scopi del proprio esistere, dovrebbero semplicemente
sciogliersi (capitoli XI e XII, e Conclusioni).
Lenin Vladimir Ilijc Uljanov (1870-1924) condivide con Hobson l’ipotesi dell’origine
economica dell’imperialismo dovuta alla nascita degli aggressivi monopoli, ma non
concorda con l’ipotesi che il capitalismo possa essere riformato, e parteggia
apertamente per la rivoluzione mondiale, evitando tuttavia le “fughe in avanti” (Villari,
1971, p. 482; Riasanovsky, 2003, p. 468). Per quanto riguarda la politica interna, Lenin
ribadisce la necessità dell’estinzione dello stato e della rivoluzione violenta, la critica
del parlamento, organo vuoto e formale, dunque l’estinzione economica dello stato
parassita, l’unità nazionale, l’idea di una nuova società e la critica dell’“opportunismo”
di Plekhanov e Kautsky (“cambiare affinché nulla cambi”, e l’alleanza col nemico di
classe: Lenin, 1948, pp. 126-209). Il partito è per Lenin quella macchina capace di
pensare continuamente a come portare avanti la rivoluzione (Lenin, 1948, p. 321).
Lenin distingue democrazia borghese da democrazia proletaria: “La democrazia
proletaria, una forma della quale è il potere dei Soviet, ha dato appunto alla stragrande
maggioranza della popolazione, agli sfruttati e ai lavoratori, uno sviluppo e una
estensione della democrazia finora mai visti al mondo” – a questo serve la dittatura del
proletariato via partito bolscevico (idem, p. 353). Tutto questo perché non ci può essere
eguaglianza fra sfruttatori e sfruttati (idem, p. 356).
Quando Lenin muore, 1924, Stalin, in un’introduzione al volume Sulla via dell’Ottobre,
attacca la concezione di Trotski (“una varietà del menscevismo”: Stalin, 1952, p. 105) e
ribadisce la necessità dell’istituzionalizzazione del partito bolscevico come autentico
interprete della volontà rivoluzionaria e guida del proletariato in un solo paese, anche
se la Rivoluzione d’Ottobre rimane “l’inizio e la premessa della rivoluzione mondiale”
(idem, p. 125; tutte queste questioni saranno riprese nello scritto del 1926 intitolato
Questioni del leninismo: idem, pp. 130-188; sul “socialismo in un solo paese”, vedi pp.
166-177).
Al contrario delle aspirazioni califfali dell’imperatore turco, i costituzionalisti, come il
turco Ziya Goekalp, volevano che fossero i cittadini musulmani stessi ad erigersi a
“difensori dell’islam”. Vicino a queste idee il mufti egiziano Muhammad ‘Abduh
(1849-1905) fonda la scuola salafiyya. A questo indirizzo di pensiero si
contrapponevano i liberali, fra i quali primeggiava l’egiziano Ahmad Lutfi al-Sayyd
(1872-1963), i quali erano più legati all’entroterra agrario e volevano per questo che
l’indipendenza non alterasse i rapporti economici con le ex-madrepatrie (Schulze, 2004,
pp. 60-61). Al repubblicano Rida, salafita che concepiva lo stato nazionale pervaso
dallo spirito religioso islamico (e per il quale l’ideale europeo di libertà corrispondeva a
quello musulmano di giustizia), faceva opposizione un altro liberale, l’indiano Sayyd
Ahmad Han, che invece concepiva un ordinamento costituzionale laico all’inglese. In
questa concezione, stato e religione andavano chiaramente separati: mentre con questa
l’uomo coltiva il proprio legame con Dio, grazie a quello l’uomo può prosperare sulla
terra accedendo al mercato mondiale (idem, p. 62).
Quando la storia dell’impero ottomano giunse a capolinea (con la fuga del sultano
Wahid al-Din a Malta e poi a Sanremo, nel 1922), anche se la nuova Turchia ebbe un
nuovo sultano (nella persona di ‘Abd al-Magid II, 1868-1944, figlio del sultano ‘Abd
al-Aziz), Mustafa Kemal dichiarò solennemente che la sovranità era ormai
incondizionatamente nelle mani del popolo turco. Il “padre della nuova Turchia”,
infatti, voleva che si compissero tre passaggi fondamentali: l’indipendenza politica
dagli stranieri, la sovranità popolare e l’indipendenza economica (Schulze, 2004, p. 69).
– Tanto queste idee islamiche potevano coniugarsi con quelle di sinistra che ci fu
perfino chi sospettò che perfino Lenin aveva ricavato le sue idee comuniste dall’islam
(idem, p. 68).
Il liberalismo si afferma in Europa e negli USA con alcuni importanti autori. Qui di
seguito do uno schizzo veloce di alcuni tra gli autori più rappresentativi (Weber, von
Mises, Schumpeter, Kelsen, Pareto, Croce, Michels, Mosca, Hobson, Keynes, Wilson,
Dewey, la Scuola di Chicago, e Hotelling), cercando di evidenziare gli aspetti più
interessanti per la Teoria della democrazia globale. Questa breve rassegna si chiude con
due autori particolari, Schmitt e Mariategui.
Max Weber (1864-1920) pubblica L’etica protestante e lo spirito del capitalismo nel
1905, dove cerca di comprendere perché le accumulazioni di denaro e l’uso del denaro,
pur essendoci sempre state in tutte le civiltà, soltanto in Occidente diventarono
capitalismo come regime economico-finanziario di tipo razionale (Weber, 1994.
Naturalmente, questo aspetto doveva poi coniugarsi con gli altri studi sulla nazionalità,
comunità, etc., in cui si risentiva anche la lezione del Meinecke di Weltburgentum und
Nationalstaat pubblicato nel 1908).
Ludwig von Mises (1881-1973), nelle sue opere di questo periodo (1912: Theorie des
Geldes und der Umlaufsmittel; 1919: Nation, Staat und Wirtschaft; 1922: Die
Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus; 1927: Liberalismus; 1928:
Geldwertstabilisierung und Konjunturpolitik; 1929: Kritik des Interventionismus)
critica la pretesa del socialismo di poter calcolare la totalità della vita economica –
secondo lui, sono solo i prezzi che guidano le scelte razionali degli individui (von
Mises si spinse fino a sostenere l’ineluttabilità della caduta dell’URSS proprio per
questo motivo).
Joseph Schumpeter (1883-1950), in L'essenza e i contenuti fondamentali dell'economia
teorica (1908), aveva sostenuto l’affinità dell’economia alle scienze naturali, ma in
Teoria dello sviluppo economico (1912), cominciò ad occuparsi in particolare dello
sviluppo e di ciclo economico, basati sulle innovazioni.
Hans Kelsen, nei due saggi del 1924 (Il problema del parlamentarismo) e del 1929
(Essenza e valore della democrazia), tenta sostanzialmente di difendere la democrazia
(il principio maggioritario) criticando gli aspetti deteriori del parlamentarismo
imprigionato dai “professionisti della politica” e dai gruppi di pressione, vedendo il
parlamento come la sede del contratto sociale à la Rousseau, e finendo per coincidere
con Schumpeter secondo cui, sostanzialmente, democrazia è procedura.
Vilfredo Pareto, amico di Mussolini, Luigi Einaudi, Napoleone Colajanni, Gaetano
Salvemini e Corrado Gini (autore, nel 1912, dell’indice che porta il suo nome utile per
misurare la povertà). In economia, il suo contributo è stato alla teoria marginalistica o
neo-classica di Carl Menger, William Jevons e Léon Walras (questa teoria si
contrappone a quella, classica, di Adam Smith e David Ricardo – rispetto a questa la
neo-classica cerca di introdurre in economia il metodo sperimentale delle scienze
fisiche, con il conseguente uso della matematica). L’ottimo paretiano è il concetto
operativo più noto di Pareto, incastonato nella cosiddetta “legge di Pareto”: si tratta
dell’estrapolazione statistica del fatto che, non solo il numero di percettori di reddito
medio è più elevato del numero di coloro che percepiscono redditi molto sopra e molto
sotto la media, ma anche del fatto che, man mano che si considerano livelli di reddito
sempre più alti, il numero dei percettori diminuisce in un modo che è all’incirca uguale
in tutti i paesi e in tutte le epoche. Tale “legge” è stata poi variamente affinata e
modificata sia nella sua base empirica che nella formalizzazione matematica, ma è
rimasto il problema di sapere se la distribuzione dei redditi è probabilistica, e dunque
risultante dalle abilità naturali umane distribuite casualmente in una popolazione,
oppure influenzata da fattori ambientali, che quindi generano ingiustizie (Buchanan,
Tullock, 1998, pp. 243-244. Nel 1970 Sen criticò a fondo questa teoria, basandosi sugli
studi di Arrow, obiettando che non sempre ciò che l’agente sceglie è ciò che egli
preferisce, nel senso che l’agente economico non è quell’attore perfettamente razionale
che l’approccio marginalista vorrebbe. I neo-classici rispondono che il loro modello
non si applica ad ogni individuo, ma solo al consumatore rappresentativo o medio). Per
Pareto i rapporti fra individui sono regolati da leggi di natura, dunque, i rapporti fra
governanti e governati non cambiano mai: questa è la base dell’idea di equilibrio
sociale (di cui egli stesso ha tentato un’improbabile formalizzazione matematica):
quando si “rompe”, l’elite al governo tramonta (“la storia è un cimitero di elite”).
Benedetto Croce militò per il partito liberale aderando inizialmente al fascismo, da cui
dopo il delitto Matteotti prese le distanze, redigendo perfino un Manifesto degli
intellettuali antifascisti nel 1925. Nelle sue opere (che spaziano dall’estetica
all’economia, dalla filosofia alla storia) i suoi maggiori saggi sono su Vico e Hegel,
mentre del marxismo apprezza l’aver sostenuto l’importanza del momento economico
nella vita dell’uomo, non come legge generale, ma come una funzione dello sviluppo
storico concreto. Roberto Michels, allievo di Max Weber, pubblica nel 1910 La
democrazia e la legge ferrea dell’oligarchia: saggio sociologico, e nel 1911 La
sociologia del partito politico nella democrazia moderna (Michels, 1910 e 1911). Tutti
i partiti, inclusi quelli più rivoluzionari, hanno la tendenza a trasformarsi in burocrazie
oligarchiche – non dissimilmente da come avviene nello stato (egli stesso fu membro
convinto del partito socialista). Con una base sociale così concreta, Michels, pur
continuando ad aderire agli ideali del socialismo, abbandonò l’aspetto millenaristico
che è presente nella dottrina marxista. Fu vicino al liberale Luigi Einaudi, futuro
presidente dell’Italia post-fascista, e poi a Benito Mussolini del quale apprezzava la
capacità di governare facendo a meno del sistema farraginoso dei (e degli accordi sottobanco fra i) partiti (aspetto già evidenziato da Ostrogorski) – e pertanto aderì al
fascismo, di cui difese una versione pacifista e antirazzista. Le sue frasi famose sono:
“Io di rivoluzioni ne ho viste tante, di democrazie mai”; “L’organizzazione è la madre
della signoria degli eletti sugli elettori”; “Sulla base democratica si innalza,
nascondendola, la struttura oligarchica dell’edificio”. Al contrario da Ostrogorski,
Michels aderì all’elitismo, ritenendo che solo un eroe carismatico, dotato di un rapporto
diretto col popolo, avrebbe potuto risolvere gli aspetti negativi del parlamento. A
differenza di Weber, che non smise di credere nel parlamento, se non altro come luogo
dove si forma un eventuale eroe carismatico, Michels ritenne che proprio il parlamento
fosse quel luogo negativo dove maggioranza e opposizione fanno finta di lottare,
instaurando una finta democrazia e agendo in realtà come un’oligarchia unicamente
interessata a perpetuare se stessa. Michels riteneva che il parlamentarismo fosse una
leggenda, e in La democrazia e la legge ferrea dell’oligarchia sosterrà che è un
compito della scienza politica quello di smascherare questo falso mito: non siamo noi
che votiamo i rappresentanti, ma sono i rappresentanti che si fanno scegliere da noi; lo
stato non importa alla maggior parte delle persone, soprattutto per ciò che attiene le
vicende prettamente istituzionali, e pertanto non si può sperare che la partecipazione
parta dal basso; le classi politiche non si sostituiscono, come riteneva Pareto, ma
puntano, invece, all’amalgama, servendosi della cooptazione per non perdere il potere
(anche nel partito le decisioni, pure quelle relative alle casse del partito stesso, vengono
sempre prese da pochissimi); l’opposizione parlamentare mira all’unico scopo, in
teoria, di sostituire la classe dirigente avversaria, finendo per amalgamarsi con essa;
anche gli eventuali leader dei movimenti popolari, una volta giunti al potere,
abbandonano le masse (il leader “parte incendiario e arriva pompiere”). In pratica, la
democrazia stessa è un mito: tutto viene scelto dal vertice, la base non ha alcun potere
reale.
Gaetano Mosca, palermitano, deputato per la Destra al parlamento dal 1909 al 1917,
sottosegretario di stato per le colonie dal 1914 al 1916, dal 1923 al 1933 professore di
Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche alla facoltà di scienze politiche
dell’Università di Roma, smise anche lui di aderire al fascismo dopo il delitto Matteotti
del 1924 e firmò l’anno dopo il Manifesto di Benedetto Croce. Con Pareto, Michels e
Weber, fa parte dell’elitismo, a cui può essere accostato anche Thorstein Veblen (18571929), autore di La teoria della classe agiata del 1899. I contributo più specifico di
Mosca è la teoria delle classi politiche (“classe politica è l’insieme delle gerarchie che
materialmente e moralmente dirigono una società”). Il parlamentarismo e il socialismo
non sono che delle utopie che coprono la realtà manipolativa dei pochi capaci di
reggere il destino di una nazione. La realtà è, per Mosca, che il potere riproduce se
stesso cooptando al suo interno nuovi membri quando questi si rivelino atti a riprodurre
l’oligarchia al governo, dotata di una propria “formula politica” – a meno che questa,
incapace, non si faccia scalzare dalle masse scontente (Mosca, 1933).
John Atkinson Hobson (1858–1940), fabiano, nell’opera Imperialism (1902), sostiene
che l’imperialismo statunitense è il prodotto naturale della pressione economica di un
improvviso incremento del capitale, che non può trovare impiego in patria e ha bisogno
di mercati stranieri per i beni e gli investimenti, ed è per questo che il popolo americano
si muove alla conquista di nuovi territori con lo “spirito d'avventura”.
John Maynard Keynes (1883-1946), allievo a Cambridge di Alfred Marshall e Arthur
Cecile Pigou, partecipò da consigliere del Ministero del Tesoro dell’UK al trattato di
Versailles del 1919 – da qui il saggio Le conseguenze economiche della pace
azzeccando le pessimistiche previsioni sulla non-capacità della Germania di onorare i
debiti di guerra colà stabiliti, da cui poi si sviluppò il nazismo. Nel 1920 pubblica il
Treatise on Probability (Trattato sulla probabilità), contributo di notevole spessore per
il sostegno filosofico e matematico alla teoria della probabilità, e nel 1923 il Trattato
sulla riforma monetaria dove attacca le politiche deflazioniste britanniche degli anni
Venti, sostenendo l’obiettivo della stabilità dei prezzi interni e proponendo i tassi di
cambio flessibili. È considerato il padre della macro-economia, contrapposta alla teoria
neo-classica o marginalista. Secondo quest’ultima teoria i prezzi, la produzione e il
reddito sono determinati attraverso il modello di domanda e offerta; gli individui, in
questo sistema, massimizzano una funzione di utilità vincolata dal reddito, mentre le
imprese massimizzano i profitti essendo vincolate dalle informazioni e dai fattori della
produzione. Secondo questo approccio lo stato deve intervenire con misure di politica
di bilancio e monetarie qualora un’insufficiente domanda aggregata non riesca a
garantire la piena occupazione.
Woodrow Wilson, in un suo discorso del 1904 (ancora non era presidente degli USA),
denunciava la potenza manipolatrice della maggioranza ad opera dell’elite del mondo
economico, col rischio di stravolgimento della democrazia (Salvadori, 2011, p. 72).
Questo monito ritornerà in successivi presidenti USA, come T. Roosevelt e F.D.
Roosevelt (Carmagnani, 2003, p. 208). In effetti, mentre la Prima guerra mondiale
prosegue, i diversi stati coinvolti, da una parte e dall’altra, cominciano ad aver bisogno
di risorse aggiuntive, ciò che pone le basi per farli diventare tutti clienti degli USA. Nel
suo discorso dell’8 gennaio 1918 al Congresso, Wilson, adesso Presidente, enuclea i
suoi “quattordici punti”, i primi otto dei quali erano legati a questioni territoriali,
europee, specifiche, gli altri cinque punti fissavano principi generali delle Relazioni
Internazionali (libertà di navigazione, trattati e negoziati diplomatici pubblici,
uguaglianza delle possibilità economiche, riduzione degli armamenti, sistemazione
delle rivendicazioni coloniali), mentre l’ultimo, il quattordicesimo, “prevedeva la
creazione di una Società delle Nazioni col compito di garantire la pace intervenendo
con funzioni di arbitrato nelle controversie internazionali e assicurando reciproche
garanzie di indipendenza politica e d’integrità territoriale a tutti gli stati membri”
(Jones, 2000, p. 386. Come abbiamo già visto, gli stessi USA non vi aderirono).
Nel 1916 John Dewey pubblica Democracy and Education dove afferma l’indissolubile
legame fra democrazia e educazione, un’educazione che ovviamente non deve essere la
stessa di quella degli ancien régime europei.
Nel 1920 Charles E. Merriam fonda la Scuola di Chicago, introducendo “i programmi
organizzati di ricerca empirica, ponendo l’accento sull’interpretazione psicologica e
sociologica della politica, e dimostrando il valore della quantificazione” (Almond,
2005, p. 45).
Infine, Hotelling pubblica la Teoria economica della democrazia, che verrà ripresa nel
1957 da Anthony Downs (De Sio, 2011), in cui pone la legge secondo cui alle elezioni
hanno maggiori possibilità di vittoria i partiti che si collocano al centro – da qui la
“corsa” dei partiti estremi a convergere verso posizioni centriste e moderate.
In questo panorama un posto a parte va riservato a Carl Schmitt, che avversò il
liberalismo e il parlamentarismo, tentando di andare dritto all’essenza del diritto
inVerfassungslehre, pubblicato nel 1928, il riferimento di base è il concetto di
“politico”, reso oggetto di una specifica pubblicazione successiva al 1933, appunto Der
Begriff des Politischen (Il concetto di “politico”), in cui Schmitt afferma che la base
della vita politica è la dialettica amico-nemico, nel senso che questa dinamica sta alla
base della vita, che poi si regola con il diritto, che si svolge all’interno di un contesto
territoriale politicamente identificato come uno stato. In tale stato vige una
pacificazione garantita dal monopolio della forza detenuto dallo stato, ma tutte le regole
giurisprudenziali sono il frutto di un continuo compromesso fra queste due figure, in un
certo senso astratte, dell’amico e del nemico. Da questo punto di vista, la politica che si
svolge dentro i confini territoriali di uno stato è politica di secondo livello, rispetto
cioè, a quella, di primo livello, che si svolge fra gli stati, in quanto dentro lo stato tutto
lo scopo della vita istituzionale è regolare i conflitti e le tensioni in maniera pacifica per
giungere ad una decisione quale che sia (in questo senso, precisava Schmitt, la politica
nazionale è più polizia che politica vera e propria). Da questo punto di vista, le
discussioni interne ad uno stato restano sempre una forma di razionalizzazione di una
tensione, un conflitto, una contrapposizione potenzialmente armata e violenta (forse
anche Croce pensava questo quando diceva che la parola stato sembra statica, ma
invece è dinamica). Questo equilibrio non è mai dato una volta per tutta, ma richiede un
lavorio costante. La guerra civile è, dunque, l’esito di un lavoro politico fatto male, una
mediazione che il politico non ha ben saputo svolgere nella comunità che gode di
un’omogeneità socio-culturale (e anche etnica). Pertanto, secondo Schmitt, il diritto
pubblico è la parte non-politica della Costituzione. Infatti, “sovrano è colui che decide
sullo stato di eccezione” – questa è la sua tesi principale. In altri termine, presupposto
della pacificazione dello stato è che questi abbia comunque il potere di troncare,
quando lo ritiene opportuno, le discussioni e di prendere una decisione. Di
conseguenza, lo stato precede la Costituzione, e non viceversa. La Costituzione, dice
Schmitt, non è un contratto, ma una decisione (naturalmente, qui tutto questo andava a
vantaggio di Hitler, che decideva, interrompendo l’inutile ciarla della repubblica di
Weimer). La conclusione di Schmitt è che anche le libertà individuali sono da
incardinare in una unità e forma politica esistente, cioè, ci deve essere la volontà
politica di farle rispettare contro le eventuali violazioni da parte del prossimo
(altrimenti restano carta) – e ciò è vero anche rispetto agli stati.
Di segno totalmente opposto a Schmitt, una figura di eccellente intellettuale José Carlos
Mariategui (1895-1934) si trova in Perù; pubblica nel 1928 un accurato volume, fatto
da sette saggi, sulla realtà peruviana con focus sull’evoluzione economica: lo
sfruttamento delle risorse naturali, i cui proventi vanno ai latifondisti, con uno schema
di proprietà di tipo feudale, alleati del grande capitale straniero; la questione dell’Indio,
l’educazione, soprattutto la riforma dell’Università di Lima, la cui cultura dell’epoca
era molto distante dai bisogni del paese; la religione, l’amministrazione delle regioni, la
cultura letteraria (Mariategui, 1928). Colpisce la sensibilità, tipica anche di altri scrittori
sud-americani che, come l’“apostolo” José Marti, non staccano i piedi dalla loro terra,
che Mariategui mostra nei confronti della popolazione india nativa, a cui la terra è stata
letteralmente strappata dai colonizzatori europei fin dall’inizio dell’Età moderna. Senza
assumere una posizione di difesa ad oltranza della loro cultura, ma al contrario con
occhio aperto alla modernità, Mariategui propone una sintesi fra le diverse civiltà
compresenti nella realtà peruviana (così come in altre parti del Sud America) che
rispetti l’anima di ciascuna cultura. Questa preoccupazione per il dialogo fra culture
non gli fa comunque mai velo rispetto alla posta in gioco economica che è fortemente
condizionante lo sviluppo sociale. Per questo Mariategui conduce un’analisi sociopolitica ed economica del latifondo peruviano, con le sue connessioni con il capitale
straniero. La lotta di classe fra possidenti e loro eventuali alleati stranieri e poveri, sia
della propria nazionalità che Indios viene analizzata nelle sue componenti politicopartitiche e socio-culturali: “La cuestion indigena arranca de nuestra economia. Tiene
sus raices en el regimen de propriedad de la tierra. Cualquier intento de risolverla con
medidas de administracion o policia, con metodo de ensenanza o con obras de vialidad,
constituye un trabajo superficial o adjetivo, rientra subsista la feudalidad de los
‘gamonales’” – i latifondisti (idem, p. 35).
Capitolo II
Dalla Grande Crisi alla Seconda guerra mondiale
Paragrafo 1
Storia
1929-1945
Il Giappone degli anni Venti e Trenta sviluppa una politica estera “su due direttrici,
fortemente contraddittorie: da una parte tendeva ad occupare le posizioni
definitivamente o
temporaneamente abbandonate dalle potenze imperialistiche
occidentali (il caso più evidente è nei rapporti con la Cina), dall’altra tendeva a
presentarsi come rappresentante degli stati asiatici nelle loro aspirazione di
indipendenza e di riscatto verso le potenze imperialistiche. Nel lungo periodo,
nonostante il programma di ‘coprosperità asiatica’ agitato dalla propaganda, le
contraddizioni sarebbero esplose e sarebbe divenuto sempre più evidente il carattere di
espansionismo militare e brutalmente sfruttatore della politica nipponica” (Villani,
1993, p. 503).
Al crollo della borsa di New York e al conseguente aumento dei dazi da parte USA fino
al 23% sulle merci giapponesi nel 1930, il Giappone reagì con la svalutazione della
moneta (yen) e il potenziamento delle esportazioni dell’industria leggera (tessuti,
biciclette, orologi), a prezzi concorrenziali; ma l’agricoltura fu il settore che risentì
maggiormente della nuova situazione (idem, p. 221). Grazie alla forte disciplina di
fabbrica, la crisi economica globale della fine degli anni Venti (che tra l’altro comportò
la caduta del prezzo della seta giapponese, fondamentale per l’economia dei contadini
giapponesi) ebbe in Giappone degli effetti tutto sommato limitati. Quattro famiglie,
soprannominate le “cricche del denaro” (zaibatsu), emergono da questo contesto come
detentrici delle leve del potere economico-finanziario in Giappone: i Mitsui (mercanti,
fin dai tempi dei Tokugawa), Mitsubishi (industria pesante), Sumitomo (estrazione del
rame) e Yasuda (banchieri). Sono loro che fanno il bello e il cattivo tempo
nell’economia giapponese, e che si arricchiscono anche quando attorno si diffonde la
preoccupazione, se non la povertà (come, appunto, negli anni Venti), rilevando le
aziende e le piccole banche in fallimento.
Proprio in Cina l’ambiguità della politica estera giapponese, fra il dominio e la
protezione, doveva risaltare al massimo grado, quando, all’inizio degli anni Trenta, il
governo giapponese cominciò senza mezzi termini la conquista della Manciuria manu
militari (Villani, 1993, p. 506). L’occupazione diventò veramente pesante nel 1937.
Entrato, il Giappone, in guerra a fianco dell’Asse nel giugno ’41, il nuovo premier Tojo
Hideki, constatando le difficoltà del fronte europeo e russo, tentò decisamente la carta
della “marcia verso il Sud”, cioè, verso il sud-est asiatico e il Pacifico. L’attacco agli
USA a Pearl Harbour, il 7 dicembre 1941, segnò l’apice della strategia del “nuovo
ordine dell’Asia” che il Giappone intendeva perseguire (e che era già stato delucidato
pubblicamente dal precedente premier Konoe nel 1938); ma, al di là dei primi
incoraggianti successi nel Pacifico, questo fu, invece, per il Giappone solo l’inizio della
fine.
In Cina Chiang Kai-shek, dopo aver decimato gli elementi del Partito comunista (il che
evidenziò che, praticamente, in Cina si stavano combattendo ben due guerre
contemporaneamente, quella contro i Giapponesi così come quella fra nazionalisti
borghesi e comunisti), era riuscito nel 1927 ad impiantare un governo del Kuomintang a
Nanchino, con l’appoggio dei “signori della guerra” del Nord a lui alleati.
Contemporaneamente Mao proclamò a Ruijing, nel Sud, la Repubblica cinese degli
operai con l’appoggio del Soviet russo, una realtà politica che riuscì ad interessare fino
a nove milioni di persone. Accerchiato dalle forze di Chiang, Mao riuscì ad iniziare una
marcia che con 100.000 uomini al suo seguito spostò il suo governo dal Sud al Nord
(nel periodo fra la fine del 1934 e la fine del 1935), rinforzando la presenza del
movimento comunista al Nord, e acquisendo così la statura di leader nazionale. Ma in
questi stessi anni il Kuomintang accresceva il suo controllo politico ed economico sullo
stato (sulle orme dei dibattiti correnti sul potere dello stato fascista nell’economia): la
famiglia Soong, una rampolla della quale andò in moglie allo stesso Chiang, godeva di
un’enorme potenza finanziaria sia in Cina che negli USA (acquisita anche con metodi
mafiosi) e controllava il ministero cinese delle Finanze. La situazione rimase di stallo
durante gli anni della seconda guerra mondiale.
Dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbour, Chiang, che aveva già ricevuto aiuto da
parte di Stalin più di quanto questi ne avesse dato a Mao, ottenne anche dagli USA di
Roosevelt l’appoggio tanto sperato, soprattutto finanziario, malgrado presso l’opinione
pubblica statunitense si fosse diffusa l’immagine del regime di Chiang come di un
regime corrotto e crudele (peraltro, proprio per questo l’opinione pubblica statunitense
era a favore più di Mao che di Chiang).
La resa del Giappone, il 15 agosto 1945, ebbe un risvolto in Vietnam, in quanto fornì a
Ho Chi Minh l’occasione per l’insurrezione dei Vietminh che presero il potere nella
parte nord del paese, entrando un mese dopo a Hanoi. Da lì, il leader vietnamita, con
una dichiarazione pubblica in cui utilizzò sapientemente la retorica democratica ed
internazionalista, e richiamandosi perfino ai tre principi della Rivoluzione francese –
Libertà, Eguaglianza e Fraternità – proclamò l’indipendenza del Vietnam, chiedendone
contestualmente il riconoscimento agli Alleati. A dispetto di quel che è ragionevole
aspettarsi, questo riconoscimento non arrivò mai, anzi – il che costituisce senz’altro un
altro importante “passaggio irreversibile” verso la non-democratizzazione. Come
vedremo nel prossimo capitolo, le potenze “democratiche” vincitrici del conflitto
mondiale, segnatamente Francia e USA, si orientarono in senso diametralmente
opposto alla democrazia, favorendo il fronte conservatore e colonialistico (idem, pp.
10-12).
Un altro caso di “passaggio irreversibile” anti-democratico è costituito dalle Filippine,
tolte dagli USA alla Spagna alla fine del XIX secolo, dove si era installato un governo
statunitense-simile ispirato alle idee di Wilson. Nel 1934 Roosevelt favorì
l’approvazione della legge Tydings-McDuffie che prevedeva un Commonwealth
statunitense-filippino, preludio di un’indipendenza piena, che effettivamente giunse
dopo la guerra, il 4 luglio 1946 (idem, p. 164). Prima di questo riconoscimento, le elite
locali (composte dagli ilustrados di sangue misto spagnolo-malese-cinese) si
dividevano fra i due gruppi di favoriti, da un lato, coloro che si rifacevano al presidente
dell’assemblea nazionale, Sergio Osmena, dall’altro, coloro che invece riconoscevano il
loro capo nel rappresentante filippino a Washington, Manuel Quezon. Questa
condivisione del potere era congeniale agli interessi statunitensi, benché localmente il
potere, soprattutto nella produzione agricola, si applicasse e gestisse con modalità
prettamente feudali. La riforma agraria, complici gli Statunitensi, fu rinviata, così, alle
calende greche. Le prime elezioni videro la partecipazione di una moltitudine di partiti,
tra cui il più importante era quello nazionalista, guidato dal leader indipendentista
Aguinaldo (idem, p. 165).
Malgrado le infinite resistenze del governo britannico, Gandhi costituisce un esempio
più unico che raro di superamento dei “passaggi irreversibili”. Arrestato più volte per le
sue campagne di disobbedienza civile (clamorosa la marcia per estrarre il sale dal mare
per protestare contro la nuova tassa britannica sul sale nel 1931), Gandhi fu capace di
portare pian piano l’Inghilterra ad avvolgersi in spirali sempre più auto-contraddittorie,
fra preteso liberalismo e concreta sopraffazione (Collotti Pischel, 1999, pp. 94-95).
Quando si trattò di aderire o meno alla Seconda guerra mondiale a fianco della madrepatria contro il nazi-fascismo, Gandhi, al contrario della contingenza della Prima guerra
mondiale, si oppose.
Sotto la guida di Stalin, l’URSS procedette alla realizzazione dei piani quinquennali di
sviluppo, la cui enfasi era sull’industria pesante e la collettivizzazione dell’agricoltura
(ciò che si poté fare solo con molte forzature e costrizioni nei confronti dei contadini,
alquanto restii ad aderire al nuovo indirizzo politico-economico: Riasanovsky, 2003, p.
496) e i cui risultati furono comunque notevoli, ma i cui costi in termini di democrazia
furono altrettanto notevoli: al di là delle dolorosissime purghe e i processi-farsa, si può
prendere il fatto che fra il 1939 e il 1952 non ci fu più nessun congresso del Partito
comunista come il miglior indice rivelatore della fine del cosiddetto “centralismo
democratico” di leniniana memoria. Secondo Riasanovsky, tutta la politica estera
sovietica può essere vista come una normale politica estera, uguale, cioè, a quella di
tutti gli altri stati e ispirata agli stessi problemi di sicurezza di un qualsiasi altro stato –
senza che si notasse, in altri termini, alcun “criterio marxista” all’opera (Riasanovsky,
2003, p. 510).
Quando Hitler sferrò il suo attacco alla Cecoslovacchia (1939), Francia, Gran Bretagna
e URSS furono colte alla sprovvista. L’URSS, la cui politica estera era ora passata nelle
mani di Molotov, continuava a nutrire diffidenza nei confronti delle due potenze
europee (diffidenza motivata anche dalla loro politica di appeasement nei confronti del
fascismo), sicché strinse un accordo di neutralità con Hitler (rappresentato per
l’occasione da Ribbentrop), il che diede alla Germania il feu vert per l’assalto alla
Polonia e all’URSS e l’annessione dei paesi baltici. La risposta francese e inglese, in
pratica, la dichiarazione di guerra alla Germania, diede l’inizio vero e proprio alla
Seconda guerra mondiale.
Per quanto riguarda l’Asia occidentale, ovvero il mondo arabo-islamico, in questi anni
rivestì molta importanza la questione sionista e palestinese – si diffuse un movimento
nazionalista arabo che intendeva bloccare la svendita che gli stessi Palestinesi stavano
facendo della loro terra ai potentati ebraici, e che era motivata, fra l’altro, proprio dalla
crisi del ’29 (Schultze, 1994, p. 124). Intanto, in Iraq Faysal era stato incoronato re
dalla Gran Bretagna nel 1921 ma non esercitò realmente il potere fino all’indipendenza,
nel 1932. Dal suo lato aveva le famiglie latifondiste e con queste governò, sostenuto
dall’ex-madrepatria, interessata allo sfruttamento del petrolio (soprattutto a partire dal
1925). Dal 1933 al 1939 il potere fu esercitato dal figlio di Faysal, Gazi, che rinforzò
l’esercito. Primo ministro fu un militare legato alla famiglia hascemita governante, Nuri
al-Said (1888-1959), che esercitò il potere in maniera dittatoriale, fino al 1958. In
Egitto nel 1938, un anno dopo che prendesse il trono il re Faruq (destinato a restarvi
fino al 1952), che aveva ricevuto un’educazione sensibile alle ragioni della salafiyya, il
movimento dei Fratelli musulmani, guidato da al-Banna, si trasformò in partito politico
“con l’obiettivo di imporre, sulla base dei propri principi islamici, la sovranità
dell’Egitto. […] I Fratelli musulmani erano [già] scesi in campo con un programma
articolato in cinquanta punti, in cui si insisteva soprattutto sull’applicazione del nuovo
codice islamico, si richiedeva il controllo della fiorente industria cinematografica
egiziana, una più rigorosa separazione tra i sessi e la possibilità di usare i caffè come
centri di formazione islamica. Le dichiarazioni politiche si esaurivano in una lista di
richieste, tra cui la ‘condanna del sistema partitico’, il ‘rafforzamento dell’esercito’,
l’incoraggiamento alla costituzione di gruppi giovanili e all’esortazione del loro zelo
sulla base dello sforzo morale islamico (gihad) o della ‘diffusione dello spirito islamico
negli uffici governativi’” (Schultze, 1994, p. 127). L’avvicinamento che si era creato,
dopo le proteste della seconda metà degli anni ’30, fra le posizioni neosalafite e i
Fratelli musulmani era, dunque, nei fatti. Sono questi gli anni in cui sale agli allori della
cronaca il leader indipendentista tunisino Habib Bourghiba, guida del partito
costituzionale Destour (idem, p. 138). Sia il movimento nazionalista sia quello
neosalafita si mostrarono ambivalenti rispetto alla polarizzazione europea fra fascismo
e comunismo durante la Seconda guerra mondiale: infatti, sia in Iran sia in Egitto, i
governi spinsero per un’alleanza con il fronte nazi-fascista, pur presentando molte
istanze che potevano ben essere considerate di sinistra (basti citare, per tutti, il caso
dell’intellettuale musulmano pakistano al-Mawdudi).
Vale qui la pena finire questa sezione storica ricordando che quando nel 1941 gli USA
e l’Inghilterra proclamarono la Carta atlantica (in cui si diceva, sostanzialmente, che
ogni popolo doveva essere rispettato nelle proprie decisioni), tale dichiarazione venne
interpretata dai paesi arabi e islamici colonizzati come un implicito incoraggiamento a
procedere verso l’indipendenza – proprio così la lessero, infatti, sia l’hindu Nehru, sia il
musulmano Jinnah (idem, p. 143).
In Africa le potenze europee “liberali” vincitrici della Prima guerra mondiale si erano
divise i possedimenti già tedeschi, organizzandovi una pluralità di forme di governo.
(Speitkamp, p. 2010, p. 172). Anche su questo continente – già colpito duramente dalla
diffusione da epidemie mortali all’inizio del ‘900 – si riverberò la grande depressione
degli USA, ma la maniera in cui le potenze coloniali cercarono di porre rimedio
all’enorme miseria che si generò in Africa non fu che di scarso aiuto (CoqueryVidrovitch, Moniot, 1977, p. 137; Speitkamp, 2010, p. 203). In realtà, soprattutto per
quanto riguarda la Francia, la colonizzazione, almeno fino alla Prima guerra mondiale,
era
stata
considerata
come
un’impresa
fondamentalmente
giusta,
finanche
religiosamente giustificabile (la missione civilizzatrice). “Non furono mai presa in seria
considerazione i finanziamenti perché, secondo le idee di allora, che ignoravano la
nozione di ‘aiuto al sottosviluppo’ (idea nata soltanto dopo la seconda guerra
mondiale), era l’oltremare a dover essere redditizio per la madrepatria, e non il
contrario: è in questo spirito che nel 1900 fu votata a Parigi la cosiddetta legge
dell’‘autonomia finanziaria’ delle colonie, rimasta in vigore fino al 1946. Ogni colonia
aveva il suo budget, alimentato dall’imposta diretta pro capite, difficile da realizzare in
società poco o per nulla monetarizzate, e le tasse doganali, da cui la necessità di
un’economia estrovertita che privilegiava il commercio internazionale. Questo magro
gruzzolo
doveva
coprire
tutte
le
spese,
inclusi
i
salari
dell’esercito
e
dell’amministrazione. Il che equivale a dire che le colonie si sostennero solo grazie ai
debiti contratti con la madrepatria, cosa che accrebbe ulteriormente le spese. Un caso
sfortunato volle che i cospicui prestiti coloniali, già previsti dalla Francia prima dello
scoppio della Grande guerra ma ritardati dal contesto politico, non potessero essere
avallati che nel 1931: essi si limitarono perciò a tappare le falle aperte dalla Grande
depressione. Rimborsabili in cinquant’anni, i prestiti misero in moto il ciclo infernale
dell’aiuto e dell’indebitamento” (Coquery-Vidrovitch, 2012, p. 121). La mise en valeur
delle colonie (come recitava il titolo del libro dell’ex-ministro delle Colonie francesi
Albert Sarrault) restava assai deficitaria (idem, p. 127).
In generale, per quanto riguarda la Francia colonialista, i riflessi degli scandali degli
abusi in Africa furono delle importanti reazioni nell’opinione pubblica, innescati anche
da opere letterarie come quella di André Gide (Voyage au Congo, del 1927). “Coscienti
degli abusi e intenzionato a porvi rimedio, il governo francese del Fronte popolare
raccomandò un ‘colonialismo umanitario’. Ma, al momento dell’indipendenza, era
ancora in vigore la riscossione autoritaria dell’imposta di capitazione” (CoqueryVidrovitch, 2012, p. 123). Ambiguo fu anche l’atteggiamento della Francia di sinistra
rispetto al movimento sindacale che tentò di svilupparsi nelle colonie nel 1937, un
movimento che fu appena tollerato. Il lavoro forzato veniva, peraltro, abbondantemente
praticato e considerato legale nelle colonie del Belgio, e, in maniera non ufficiale,
anche nelle stesse colonie francesi (i principi della Dichiarazione dei diritti dell’uomo
ne vietavano la legalizzazione): esso, infatti, “fu comunque abitualmente sfruttato,
soprattutto durante le due guerre mondiali, al punto da dover essere soppresso nel 1947
dalla legge Houphouet-Boigny. A questi mezzi di pressione si aggiunse, nei paesi con
importanti colonie bianche, l’espropriazione delle terre (Sudafrica, Highlands del
Kenya) mediante l’odiosa politica delle ‘riserve’” (idem, p. 125; Speitkamp, 2010, p.
192). Quando Roosevelt e Churchill, nel 1941, diffusero la Carta atlantica,
proclamando il diritto dei popoli all’autodeterminazione, gli Algerini, come tanti altri,
la fecero propria e l’utilizzarono come loro nuovo cavallo di battaglia indipendentista.
Ma sia la Gran Bretagna, sia la Francia si affrettarono a precisare che tale diritto valeva
solo per quei popoli che erano stati occupati dal nazi-fascismo. Nella conferenza di
Brazzaville del 1944 la Francia, che non aveva voluto capire la nuova aria che tirava in
fatto di colonialismo, dovette ridefinire il proprio piano per l’Africa, ma ancora una
volta – sotto De Gaulle – si trattò di una politica dalle vedute corte: l’assimilazionismo.
Tuttavia, furono approvate anche le riforme della decentralizzazione amministrativa e
politica (Coquery-Vidrovitch, 2012, p. 136).
In generale, l’atteggiamento europeo nei confronti del colonialismo in Africa fu
ambivalente, e segna un terribile “passaggio irreversibile” di non-democratizzazione –
tanto che giustamente il quinto Congresso panafricano, che si svolse a Manchester nel
1945, richiese la sostanziale rinuncia al sistema coloniale (Speitkamp, 2010, p. 249). Il
motivo era fondamentale: “La garanzia per la madrepatria di prezzi d’acquisto inferiori;
mercati di sbocco protetti da politiche doganali e un prelievo fiscale pressoché rapace
sui guadagni derivanti dal commercio internazionale per le colonie – [tutto questo]
faceva sì che qualsiasi sviluppo andasse soprattutto a vantaggio della madrepatria”
(idem, p. 260). Fra le altre cose, lo stesso Congresso richiese l’istruzione pubblica e
gratuita e l’applicazione della Carta atlantica a tutti i popoli africani.
Negli USA, il 24 ottobre 1929 (il famoso “giovedì nero”), presi dal panico, i possessori
di azioni cercarono di venderle a qualsiasi condizione; dopo qualche giorno la
situazione divenne incontrollabile: “I guadagni di mesi svanirono in poche ore,
portando alla rovina centinaia di risparmiatori, grandi e piccoli” (ibidem). I prezzi
continuarono a scendere nei mesi successivi e, con esso, l’indice industriale della borsa,
che nel 1932 toccò il minimo storico, 58, crollando da 452! Svanì la fiducia negli affari
e il mondo sembrò fermarsi: fallirono banche e industrie, i prezzi cominciarono a
calare, le famiglie persero i loro risparmi, lavoro e casa; i contadini furono alla miseria.
Un quarto della popolazione attiva si era fermata nel 1932. Poveri si raccoglievano
dappertutto in settori di baracche nelle grandi città, ribattezzati con ironia
“Hooverville” (idem, p. 412).
Con ogni evidenza Hoover non fu capace di gestire la situazione. Alle elezioni di fine
1932 gli succedette Franklin Delano Roosevelt, della famiglia dell’ex-presidente
Roosevelt, e anche lui democratico. Questi seppe ispirare nel popolo americano,
abbattuto dalla crisi, la fiducia necessaria alla ripresa (il New Deal), e applicò
suggerimenti che gli venivano dall’economista britannico John M. Keynes (anche se
non in modo pedissequo): energico intervento dello stato nell’economia e nella società,
investimenti
pubblici
nelle
opere
pubbliche
(riassorbendo
così
parte
della
disoccupazione), svalutazione del dollaro (abbandono della parità aurea e meno enfasi
sulla parità di bilancio), aumento dei prezzi ma anche dei salari; diminuzione delle ore
di lavoro nelle fabbriche; aumento della produzione di energia elettrica (il Tennessee
Valley Authority); infine, controllo statale del sistema bancario e commerciale (Jones,
2000, p. 416). In totale, si ritiene che gli effetti negativi della Grande depressione
sull’economia statunitense siano durati dieci anni, 1929-1939. Essa fu più pesante per i
poveri (peraltro, provocò l’arresto dell’immigrazione di massa), i Nativi e i Neri. I
Nativi erano già stati aiutati, prima della Grande depressione, dal presidente Hoover
con dei finanziamenti specifici. Questa politica venne continuata anche durante gli anni
difficili della Grande depressione, quando Roosevelt diede l’incarico specifico per gli
affari indiani a John Collier, un abile riformatore, che fu capace di far passare nel 1934
il Wheeler-Howard (Indian Reorganization) Act: “Ma il ‘New Deal indiano’ fu un
successo solo in parte: anche se vennero messe a coltura milioni di ettari di terreni, la
produttività ebbe un incremento notevole, il tasso di mortalità diminuì e per la prima
volta da secoli la popolazione indiana aumentò di numero, ciononostante il processo di
disgregazione delle tribù non si interruppe e gli indiani d’America, indecisi tra due
culture e minacciati dall’alcoolismo, rimasero in condizioni pietose” (idem, p. 424). Per
quanto riguarda i Neri, malgrado non stessero particolarmente a cuore a Roosevelt, essi
tuttavia apprezzarono il suo New Deal. Questo provocò un loro ri-orientamento
elettorale (essi erano più vicini ai repubblicani fin dai tempi di Lincoln), e ciò fu dovuto
anche alle prese di posizione della moglie di Roosevelt contro il razzismo bigotto
(idem, p. 423).
Quando giunse la guerra, il numero di disoccupati si ridusse enormemente per
soddisfare i bisogni bellici: “Dai nove milioni del giugno 1940 i disoccupati scesero ai
780.000 del settembre 1943” (Jones, 2000, p. 458). Anche Neri, donne e handicappati
furono chiamati a dare il loro contributo, malgrado permanesse un atteggiamento
svalutativo sia nei confronti del lavoro delle donne (pagate molto meno degli uomini),
sia dei Neri (discriminati in qualunque ambito lavorativo).
In politica estera, Roosevelt migliorò i rapporti con l’America Latina (nel 1934, per la
prima volta, ritirati i Marines da Haiti, non ci furono militari USA in tutto il sudcontinente, anche se, bisogna aggiungere che subito dopo dittature repressive
s’installarono in Nicaragua, Repubblica Dominicana, Haiti e Cuba con l’appoggio degli
USA). La “diplomazia del dollaro”, tuttavia, rimase operativa, anche se il governo fu
duttile abbastanza nell’accettare le politiche nazionalistiche della Bolivia (1937:
confisca delle proprietà della Standard Oil Company), del Messico (1938: esproprio
delle compagnie petrolifere straniere) e del Venezuela (1939: aumento delle percentuali
nazionali degli utili per lo sfruttamento dei pozzi). Per Jones, questo comportamento
accomodante fu dovuto al timore degli USA che la politica estera della Germania e
dell’Italia prendesse piede nell’America del Sud (idem, p. 441).
Prima e durante la Seconda guerra mondiale ci fu una corsa agli armamenti che fu un
fenomeno che interessò tutti i paesi latino-americani; questi, infatti, “si sentirono
minacciati dal disordine determinato dalla scomparsa dei meccanismi naturali di
regolazione ottocenteschi e dal fallimento della nuova istituzione della Società delle
Nazioni. La risposta del sottocontinente americano al disordine internazionale e alla
nuova aggressività europea e americana è da ricercarsi nello sviluppo di un
nazionalismo estremista, che influenza pesantemente le politiche dei governi portandoli
ad adottare condotte da libero battitore, ovvero cercando di ottenere le migliori
condizioni possibili nella conflittualità tra gli Stati Uniti e la Germania” (Carmagnani,
2003, p. 216). Da questo punto di vista, la tradizione politica tipicamente latinoamericana di concepire il presidente della repubblica come un quasi-re (il caudillo) può
essere considerata come una naturale difesa contro le politiche economiche e militari
aggressive sia dell’Europa, sia del Nord America nei confronti del sub-continente sudamericano. Non desta, dunque, meraviglia che a quei tempi la centralità dello stato si
traducesse “in una crescita smisurata delle facoltà e delle competenze della presidenza
della repubblica che permetterà ai governi di corporativizzare i gruppi d’interesse e di
trasformarli in organizzazioni che sostengono e dialogano direttamente con il potere
esecutivo” (idem, p. 311).
Nel 1938 si estingue in Messico il Partito Nazionale Rivoluzionario e al suo posto
nasce il Partito della Rivoluzione Messicana che, al contrario del precedente, non ha
una base di tipo regionale, ma di tipo lavorativo – vi si identificavano le quattro sezioni
corrispondenti agli operai, contadini, popolo e esercito. Nel 1939, grazie a Manuel
Gomez Morin, nasce il Partito di Azione Nazionale, con un’impronta conservatrice, che
raccoglie il favore sia dei cattolici, sia degli investitori statunitensi, feriti dalla scelta di
nazionalizzare l’industria del petrolio. Le elezioni del 1940 furono vinte da Manuel
Avila Camacho, che governò per tutto il periodo della guerra mondiale, nella quale il
Messico si schierò dalla parte degli Alleati. Al contrario degli altri paesi impegnati
nello sforzo bellico, il Messico, adottando un’ottica keynesiana, diminuì la spesa
militare e investì in strade, industrie, elettricità, ospedali, scuole e servizi pubblici
(Aboites Aguilar, 2007, p. 272).
Al contrario del Messico, il Brasile era stato da sempre su posizioni più filostatunitensi. Tuttavia, nel 1930 prese il potere un esponente dell’oligarchia gaucha,
Getulio Vargas, dopo che gli accordi che avevano consentito la cosiddetta “politica del
caffè-latte” erano cessati in seguito alla Grande depressione del 1929. Approfittando
dello scontento dell’esercito (il cosiddetto movimento del tenentismo, teso a migliorare
le condizioni dell’esercito e ad aumentarne il potere, e che fu espressione della piccola
borghesia, esclusa in quel momento dal potere delle oligarchie) e della fine
dell’egemonia oligarchica paulista, Vargas, a capo del nuovo Partito democratico e
dell’Alleanza liberale, mantenne il potere fino alla fine della Seconda guerra mondiale,
assumendo via via toni sempre più autoritari. Sotto la presidenza di Vargas (che
sopravvisse ad un tentativo di golpe nel 1932, che emanò una costituzione nel 1934,
che dava maggiore protezione sociale e istituiva l’istruzione elementare pubblica e
gratuita: Aquino et al., 2000, p. 339), la vita politica si polarizzò attorno ai due
schieramenti: quello della sinistra, rappresentata dalla Aliança Nacional Libertadora e
dal Partido Comunista do Brasil, e quello della destra, con un movimento di ispirazione
fascista l’Açao Integralista Brasileira. Proprio con la scusa di evitare uno
“smascherato” golpe comunista (il cosiddetto Plano Cohen, che si scoprì poi essere una
montatura ad hoc), Vargas, un anno prima delle elezioni del 1937, operò lui stesso un
golpe appoggiato dalla destra, annunciando la creazione dello Estado Novo, ispirato al
fascismo europeo contemporaneo. Seguì un triste periodo di repressione poliziesca, che
si esercitò non solo sul dissenso politico, ma anche sull’arte e la scienza (Filinto Muller,
capo della polizia, acquisì una sinistra fama, e a lui la fortuna arrise ancora durante la
successiva dittatura militare, quando venne eletto al parlamento). Tuttavia, dopo che
scoppiò la guerra mondiale, il Brasile, come il Messico, si schierò dalla parte degli
Alleati. La contraddizione insita fra la politica estera filo-Alleati e la politica interna
ispirata al fascismo, portò Vargas alle dimissioni alla fine stessa della guerra, nel 1945.
Alle elezioni di ottobre vinse il Partito social-democratico, guidato da Enrico Gaspar
Dutra, che l’anno dopo approvò una nuova costituzione democratica e federalista.
Al contrario del Messico e del Brasile, l’Argentina si schierò dalla parte dell’Asse
Germania-Italia-Giappone. Indebolito sul fronte interno dalla crisi succeduta al crollo
della Borsa di New York, il governo di Yrigoyen cadde nel 1930 in seguito ad un golpe
(che fu motivato anche come una reazione alla decisione del presidente di fissare il
prezzo del petrolio con una legge dello stato). Si susseguirono al governo vari militari
(José Félix Uriburu, quindi Agustin Pedro Justo) fino al 1937. Roberto Ortiz, radicale,
era presidente quando scoppiò la guerra mondiale. In questi anni l’Argentina tentava di
darsi una propria politica industriale autonoma. Castillo, un altro militare, prese il
potere nel 1943, schierando l’Argentina con l’Asse; solo quando fu chiaro che tutto era
perduto, alla fine del 1945, l’Argentina cambiò nuovamente orientamento e si schierò
dalla parte degli Alleati (Albonico, 1982, p. 18).
Fra le cause della Seconda guerra mondiale dobbiamo ascrivere senza dubbio
l’incapacità (prevista, fra gli altri, da Keynes) della Germania di pagare il debito
contratto a causa della Prima guerra mondiale e il clima di allarme per la Grande
depressione proveniente dagli USA – due fattori che diedero la forza politica decisiva al
movimento nazista di Adolf Hitler (Villari, 1971, p. 556). – Inoltre, non dobbiamo
dimenticare che anche per le potenze “democratiche” europee, per esempio, per
Churchill, si trattava semplicemente della “difesa e la salvaguardia dell’Impero
britannico” (Schulze, 1994, p. 138; sulla Francia, “repubblica coloniale”: Lemaire,
Blanchard, Bancel, 2001). Giustamente, leader e pensatori come Gandhi, Césaire o
Mariateguí si rifiutavano di vedere, sia nell’Europa, sia negli USA, dei “baluardi della
democrazia” da difendere contro il nazismo tedesco, e non piuttosto come dei partner,
anche se sotterranei, delle potenze occidentali più retrive nello stesso impegno di
dominio mondiale. Qui si manifesta un punto centrale della Teoria della democrazia
globale: la formazione delle due grandi macro-regioni – i colonizzatori e i colonizzati –
determina il modo di sentire degli abitanti dell’una come dell’altra. Infatti, che le
preoccupazioni degli Europei fossero rivolte solo alla loro condizione particulare,
senza alcuna consapevolezza della, o preoccupazione per la condizione degli altri, è un
fatto storico. Villari, rispetto ai sindacati inglesi, ricorda che essi, dopo il fallito
sciopero del 1926, si misero a collaborare con il governo e la classe padronale per
favorire la loro ripresa industriale (Villari, 1971, p. 557). I sindacati e il Partito
laburista compresero quanto la classe operaia fosse poco propensa ad adire una via
veramente rivoluzionaria (il che non vietava, d’altra parte, che la tradizione del
riformismo sociale e dell’impegno pubblico di assistenza fosse molto forte). Le
politiche economiche dei governi laburisti del 1924-1929 e del 1929-1931 (guidati da
Ramsay Mac Donald) si indirizzarono più nel senso del governo tedesco di Bruening
che in quello statunitense di Roosevelt, praticamente assecondando i conservatori:
deflazione, mantenimento del valore della sterlina, riduzione delle spese pubbliche,
tagli ai sussidi di disoccupazione – tutt’un insieme di misure che, col primo governo
Mac Donald, finì per provocare la spaccatura del Partito laburista e la caduta stessa del
governo (idem, p. 558). Il successivo governo Mac Donald, non riuscì, come voleva, a
salvare il valore della sterlina; ma proprio questo fu la fortuna della ripresa
dell’Inghilterra a discapito delle colonie: infatti, il deprezzamento di un terzo della
sterlina favorì la ripresa delle esportazioni, mentre gli accordi commerciali del 1932
proprio con i dominions crearono una sorta di area di mercato privilegiata. Un’altra
buona notizia per l’economia inglese, ma non per le altre, fu la caduta dei prezzi
alimentari sul mercato mondiale – anche di quelli prodotti dai paesi extra-europei
(ibidem. Notiamo qui, per inciso, che, quando Villari parla di politica estera del Regno
Unito, si riferisce esclusivamente alla politica europea, e non a quella dei paesi exraeuropei; vedi, per esempio, idem, p. 559).
A seguito dei fallimenti delle politiche economiche del governo inglese, anche nel
Regno Unito nacque un partito fascista, incoraggiato direttamente da Mussolini. Sotto
queste influenze, il governo di Neville Chamberlain, 1935-1939, poté ritenere che, in
fondo, la Germania nazista non svolgesse che un buon servizio a difesa dall’URSS,
verso la quale sperò di poter indirizzare l’aggressività insita nel movimento hitleriano.
Da qui, la scelta per una politica di attesa, appunto, l’appeasement. Anche in Francia,
malgrado il governo fosse nelle mani del socialista Léon Blum (vincitore delle elezioni
del 1936), l’atteggiamento nei confronti del nazismo fu lo stesso – il che ebbe un effetto
disastroso per la contemporanea vicenda repubblicana spagnola – ma non fu affatto di
attesa quando si trattò di appoggiare l’Italia fascista di Mussolini nell’aggressione
all’Etiopia (ottobre 1935-maggio 1936), un’operazione che, contrastata poco più che
simbolicamente dalla Società delle Nazioni, era destinata in realtà ad aumentare
l’ammirazione, il consenso e perfino l’emulazione da parte degli altri fascisti sparsi per
l’Europa (come gli ustascia jugoslavi e le Guardie di ferro rumene) nei confronti
dell’Italia (idem, p. 564).
La guerra mondiale di Hitler, Mussolini e Hirohito, dopo i primi immediati successi,
cominciò ad inclinarsi nel ’41 con il “piano Barbarossa” di Hitler (il tentativo di
conquistare la Russia) e il raid aereo nel porto di Pearl Harbour, nelle isole Hawaii
(dicembre 1941) dei Giapponesi – due mosse decisamente perdenti. Nel corso del 1942
sia gli Statunitensi, sia i Russi presero il sopravvento sui Tedeschi sia in Russia
(battaglia di Stalingrado), sia nel Pacifico (con le battaglie navali condotte dal generale
USA Douglas MacArthur contro i Giapponesi), ed anche in Africa gli Inglesi, guidati
da Montgomery, ebbero la meglio sui Tedeschi di Rommel (battaglia di el-Alamain,
dove forze indiane combatterono a fianco degli Inglesi). Durante l’epilogo della guerra,
nell’agosto del 1944 a Dumbarton Oaks (USA) le Nazioni Unite vennero trasformate in
un’organizzazione internazionale permanente – alla Cina di Chiang venne riconosciuto
lo status di grande potenza con un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza,
insieme a USA, URSS, Francia e Inghilterra. Dopo gli sbarchi in Normandia e in Sicilia
e le bombe atomiche sul Giappone, i tre paesi fascisti furono costretti (tra maggio e
settembre 1945) a firmare la resa senza condizioni. Ma quando i vincitori si ritrovarono
a Potsdam negli stessi mesi per spartirsi il “dividendo della pace”, si evidenziarono
subito i motivi di disaccordo fra di loro (a cominciare dalla questione polacca: il
massacro, effettuato dai Sovietici, di migliaia di ufficiali polacchi nella foresta di Katin
nei pressi di Smolensk, avvenuto prima che la zona fosse occupata dalle truppe
tedesche. La notizia, in effetti choccante, confermata da successive indagini,
manifestava gli antichi dissapori esistenti fra Russi e Polacchi. In altre parole, i
Sovietici assistettero senza colpo ferire all’annientamento delle forze clandestine
polacche antitedesche ma anche antisovietiche. Così, il “caso” Polonia doveva diventò
l’inizio ufficiale della Guerra Fredda).
Per Arrighi, sulla scorta di Braudel, la fine della Seconda guerra mondiale segna
l’avvento del potere capitalistico USA su quello del Regno Unito: inizia ora, e per tutta
la durata del XX secolo, la fase attuale, caratterizzata dal caos causato dalle lotte fra
“egemonie occidentali” (Arrighi, 2010, p. 220).
Paragrafo 2
Politica
1929-1945
La “co-prosperità asiatica” era stata il vessillo della politica estera nipponica ambigua
(Villani, 1993, p. 503). All’indomani della crisi di Wall Street nel Giappone si
chiudono le già poche prospettive di democratizzazione. Operano molti gruppi e società
segrete, spesso alimentate da ambienti ufficiali e militari. “Comune a tutti questi gruppi,
che ebbero sempre carattere elitario, fondato sull’ideale dell’eroismo personale, era la
ripresa della mistica politica – nata dalla scuola di Mito e presente nel movimento dei
samurai a metà dell’Ottocento – della sacralità del Giappone, in particolare del suo
imperatore, e della sua missione egemonica in tutta l’Asia orientale. Altro elemento
comune era un atteggiamento di protesta nei confronti dell’ordine sociale esistente in
Giappone: esso non si esprimeva in un ideale di uguaglianza o in lotte per migliorare le
condizioni dei ceti subalterni, bensì in una sistematica denuncia delle conseguenze della
modernizzazione e quindi del potere della grande finanza, dei suoi legami con i partiti
politici (e quindi con il sistema parlamentare) e con gli stranieri, per non dimenticare il
mutamento ritenuto ‘perverso’ dei costumi della popolazione urbana e in particolare
degli intellettuali. In parallelo vi era una sistematica ‘sacralizzazione’ del Giappone
rurale tradizionale e il rifiuto delle misere condizioni dei contadini, ritenuti depositari
della vera cultura del paese e base vitale del suo esercito. Né mancava
un’idealizzazione della tradizione dei samurai e della loro dedizione totale, fino e oltre
la morte, al loro ‘signore’, trasferita ora al sacro imperatore, personificazione del
carattere divino del suolo e del popolo del Giappone” (Collotti Pischel, 1999, p. 224).
Nel 1938 muore Edmund Husserl, il filosofo europeo con cui Nishida ebbe più modo di
entrare in contatto. Un anno prima il Giappone invade la Cina e, in questa nuova
avventura bellica Nishida, già ritiratosi (da dopo il 1928) dalla vita accademica attiva
all’Università di Kyoto, viene tirato dentro il dibattito politico pro- o control’imperialismo nipponico (in particolare, in questo orizzonte della “co-prosperità”). La
posizione del filosofo rimane a tutt’oggi oggetto del contendere (in generale, in
Giappone la Scuola di Kyoto rimase associata, nel comune sentire, all’autoritarismo.
Nello stesso anno Nishida pubblica, in effetti, un saggio filosofico, in cui c’è poco l’eco
degli eventi correnti, ma solo una visione critica molto generica (Nishida, 2001; ed or.
1937), che sarà ripresa da Nishida più tardi, nell’ultimo dei suoi scritti, La logica del
luogo – ormai anche l’Università di Kyoto è sottoposta al controllo della polizia
fascista. In quest’ultimo saggio troviamo qualcosa di più sull’aspetto della filosofia
mondiale (il contesto è la religione, la filosofia buddhista del vuoto, Amida, e
l’incitazione che Nishida fa ai buddhisti di impegnarsi di più per la pace): “Lo spirito
dell’epoca
odierna
non
richiede
forse
una
religione
dell’assoluto
Vuoto
compassionevole di Amida piuttosto che una religione del Signore degli Eserciti?
Vorrei chiedere ai buddhisti di riflettere criticamente su questo punto. Una guerra
mondiale deve essere una guerra in cui tutto il mondo neghi la guerra, in vista di una
pace eterna” (Nishida, 2005, p. 193). E termina con pagine in cui cerca di combinare
religione e politica superando ogni prospettiva nazionalistica nella direzione di
un’unificazione di un’unica cultura mondiale pacificata – aderendo alle coeve proposte
di Berdjaev e Tillich (“Sono fondamentalmente in sintonia con la proposta di Berdjaev
esposta ne Il significato della storia, sebbene la sua filosofia non si sia discostata dal
misticismo di Boehme. La nuova era deve innanzitutto essere scientifica. Il libro di
Tillich, Kairos e logos, ha qualcosa in comune con la mia epistemologia, ma la sua
logica non è chiara. Oggi queste nuove tendenze devono sempre essere logicamente
fondate”: idem, pp. 229-230).
L’altro filosofo di Kyoto Tanabe partecipa in un primo momento all’euforia per la
guerra, salvo poi a pentirsene amaramente e, già prima della disfatta del 1945, pubblica
la sua opera maggiore, Philosophy as Metanoetics, chiedendo perdono per il suo errore.
Nel “decennio di Nanchino” Chiang tentò di realizzare una costituzione che rispondesse
al pensiero di Sun con una costituzione provvisoria elaborata nel 1931 e una definitiva,
del 1936. “Sun Yat-sen aveva previsto un meccanismo costituzionale di ‘cinque poteri’
aggiungendo a esecutivo, legislativo e giudiziario il potere dello Stato di reclutare il
personale per pubblico concorso e di controllare il comportamento dei funzionari”
(idem, p. 239). Fu negli anni Trenta, nel periodo dell’ambigua lotta del Kuomintang
contro l’invasione della Cina, che si sprigionò la resistenza e la produttività degli
intellettuali cinesi, come Lu Xsun e Mao Dun: “Tutti scesero in campo per denunciare
la politica di resa a un Giappone percepito come l’incarnazione delle posizioni fasciste
in Asia: soprattutto a Shanghai questa campagna di mobilitazione culturale che presto
divenne politica aprì una grande stagione di creatività intellettuale, di apertura verso il
mondo esterno, in nome di ideali, allora comuni a uomini diversi in paesi lontani,
ovunque vissuti con drammatica intensità” (idem, p. 255). Da parte sua Mao affronta la
situazione creata dall’invasione del Giappone nel 1937 con una serie di scritti tecnici
che orientano il Partito comunista cinese nella guerra di resistenza al Giappone (Mao,
1937, pp. 193-204), senza tralasciare alcuni problemi di carattere più filosofico, con
degli scritti che affontano la contraddizione (1937: pp. 219-244), il liberalismo (1937:
pp. 245-250) e la democrazia (1940: pp. 323-354).
Negli anni Trenta si andavano diffondendo la filosofia e l’azione di Gandhi, sia
all’interno dell’India, sia nel mondo. In una conversazione con un amico nordamericano, nel 1940, Gandhi afferma che “la democrazia può essere garantita soltanto
attraverso la non-violenza”; e spiega: “La democrazia occidentale, nelle sue attuali
caratteristiche, è una forma diluita di nazismo o di fascismo. Al più è un paravento per
mascherare le tendenze naziste e fasciste dell’imperialismo. Perché oggi vi è la guerra,
se non per la brama della spartizione delle spoglie del mondo? Non è stato con metodi
democratici che l’Inghilterra si è impadronita dell’India. Che cosa è la democrazia del
Sud Africa? La costituzione di quel paese è stata fatta appositamente per assicurare la
supremazia dell’uomo bianco sul negro, il naturale abitante di quella terra. La storia del
vostro paese è segnata da ingiustizie ancora peggiori, malgrado ciò che gli stati del
Nord hanno fatto per l’abolizione della schiavitù. Il modo in cui avete trattato gli
schiavi costituisce una grande macchia nella storia americana. Ed è per salvare queste
democrazie che oggi la guerra viene combattuta. Vi è una grande ipocrisia circa la
guerra […]. L’India sta cercando di sviluppare una vera democrazia, ossia libera dalla
violenza” (Gandhi, 1996, pp. 140-141). E poco prima aveva scritto: “Sto lottando per il
Regno dei Cieli, che è libertà spirituale. Per me la strada della salvezza risiede
nell’incessante e duro lavoro al servizio del mio paese e dell’umanità. Voglio
identificarmi con tutto ciò che vive. Per usare il linguaggio del Gita, voglio vivere in
pace con gli amici e i nemici. Il mio patriottismo è per me una tappa del mio viaggio
nella terra dell’Eterna Libertà e Pace. Perciò risulta evidente che per me non c’è politica
senza religione. La politica è subordinata alla religione. La politica spogliata della
religione è una trappola mortale, perché uccide l’Anima” (Gandhi, 2006, p. 46).
Queste dichiarazioni di Gandhi sono di due anni successive alla famosa dichiarazione
del Presidente USA Franklin D. Roosevelt al Congresso degli Stati Uniti, che contiene
la seguente frase: “La prima verità è che la libertà di una democrazia non è salda se il
popolo tollera la crescita d’un potere privato al punto che esso diventa più forte dello
stesso stato democratico. Questo, in essenza, è fascismo – un governo posseduto da un
individuo, un gruppo, o qualsiasi altro potere privato capace di controllarlo. La seconda
verità è che la libertà di una democrazia non è salda se il suo sistema economico non
fornisce occupazione e non produce e distribuisce beni in modo da sostenere un livello
di vita accettabile”. Roosevelet continua affermando che in quegli anni negli USA si
stavano creando proprio le condizioni minacciose prima enucleate (riportato in Gallino,
2009, p. 3; vedi anche Salvadori, 2011). Non c’è dubbio che questi due punti si sono
veramente trasformati in due croci per la democrazia occidentale post-bellum, dato che
effettivamente nelle società affluenti la ricchezza si è accumulata sempre di più nelle
mani di pochi, soprattutto da dopo gli ultimi due decenni di fine XX secolo, mentre
l’occupazione è andata sempre più scemando (crescita senza lavoro: Piketty, 2012).
Successivamente alla prima fase della Rivoluzione, una ‘camicia di forza’ intellettuale
si impose sugli intellettuali russi (Majakovskij morì suicida nel 1930, seguendo Esenin,
scomparso allo stesso modo cinque anni prima di lui; altri si chiusero nel silenzio, come
la poetessa Anna Achmatova, espulsa dall’Unione degli scrittori sovietici nel 1946, e
Sergey Pasternak) (Riasanovsky, 2003, p. 587. Maksim Gorki muore nel 1936 in
circostanze a cui lo stesso Stalin non sarebbe stato del tutto estraneo: idem, p. 588).
Stalin festeggia, ovviamente, la crisi di Wall Street del 1929, estesasi rapidamente a
tutti i paesi capitalistici (Stalin, 1952, pp. 520-592). In Sul progetto di costituzione
dell’URSS (1936), Stalin, basandosi sui successi della politica perseguita nel campo
della produzione (NEP), dell’istruzione e della sanità, approfondisce e delinea il profilo
della democrazia proletaria, in pratica il dominio assoluto del Partito comunista
bolscevico, tramite i soviet, su tutta la società – la produzione industriale e agricola, i
sindacati, la vita politica, intellettuale, educativa ed economica – nel nome della classe
lavoratrice (idem, pp. 614-644). Una visione totalmente opposta della Russia – del tutto
in continuità con la tradizione slavofila, la diede, invece, il filosofo Nicholaj Berdjaev
che pubblica in questi anni il saggio sul Senso della storia, poi sviluppato in L’idea
russa.
Nel mondo arabo continua negli anni Trenta l’“onda lunga” della Nahda. Negli anni
Trenta “in varie occasioni si era manifestata una controversia sui valori assoluti
dell’occidentalismo e la ricerca dell’autenticità e dell’ancestralità (asala) araboislamica” (Arkoun, 1995, p. 98). Fra questi autori un peso notevole ebbe Taha Hussein,
professore di Letteratura alla Università Al-Azhar del Cairo, già autore di una
controversa opera negli anni Venti sulla poesia pre-islamica, e ora dello scritto
programmatico su L’avvenire della cultura in Egitto (1938), per il quale Arkoun
sostiene: “Gli animatori della Nahda fanno pensare ai filosofi illuministi, che essi del
resto ammiravano. Pur rimanendo fedeli al gusto classico, essi cercavano di rendere
accessibili al maggior numero di persone le nuove conquiste dello spirito” (idem, p.
99). La scuola salafita di Rida viene ora rilanciata, a ridosso dei danni prodotti dalla
Grande depressione, dalla neosalafiyya di cui fecero parte l’indipendentista marocchino
‘Allal al-Fasi (1919-1974) e il giornalista indiano Abu al-Ala al-Mawdudi (1903/41979) (Schulze, 2004, p. 119). Questi si dà interamente al compito di islamizzare il
discorso politico del nazionalismo: “Per al-Mawdudi lo stato era concepibile solo in
quanto espressione della sovranità divina, e andava organizzato dai musulmani sulla
base di queste premesse ideologiche. A partire dal 1939 al-Mawdudi rimproverò ai
nazionalisti indiani della Muslim League di non avere una ‘mentalità o abitudini di
pensiero islamiche e di non analizzare da un punto di vista islamico i problemi politici e
sociali’. […]. Al-Mawdudi riassunse il suo pensiero nell’inquietante formula: ‘Iddio è
colui che tutto conosce, non vogliamo un governo islamico, al potere vogliamo l’Islam
e non i musulmani’. E altrove specificò: ‘Come vero musulmano non ho motivo di
rallegrarmi che i turchi siamo al potere in Turchia, gli iraniani in Iran e gli afghani in
Afghanistan. Come musulmano non credo all’idea di un governo del popolo, attraverso
il popolo e per il popolo. Credo invece nella sovranità divina’. […]. A detta di alMawdudi, lo ‘stato islamico’ doveva essere un’unità di etica, diritto e politica,
l’incarnazione terrena di Dio” (Schulze, 2004, pp. 144-145). Non desta meraviglia che
questi pensieri si prestassero all’epoca ad interpretazioni di destra come di sinistra, e
dovessero servire poi come base per il fondamentalismo islamico di fine secolo.
Un caso a parte, “particolarissimo” (idem, p. 147) è costituito dall’indonesiano Sukarto,
il leader liberato dai Giapponesi nel 1942 e divenuto presto l’organizzatore
dell’indipendenza dell’Indonesia nel 1945. La sua dottrina (ispirata al pensiero di
Muhammad Yamin) si raccoglieva in cinque punti:
“1. Kebangsaan (nazionalismo) – principio che, a detta di Sukarno, non era espressione
di un nazionalismo sciovinista, ma di un sentimento di solidarietà nazionale di stampo
difensivo.
2. Perikemanusiaan (umanesimo) – quella indonesiana doveva essere una cultura
internazionalista, ma non cosmopolita, cioè suscettibile di contraddire il carattere
nazionale dello stato.
3.
Permusyawaratan
(consultazione),
perwakilan
(rappresentanza)
e
mufakat
(deliberazione comune) – secondo l’adat, per pervenire a una posizione unitaria e
vincolante, le decisioni politiche e sociali, espresse da un sistema rappresentativo,
andavano prese attraverso consultazioni permanenti.
4. Kesejahteraan (assistenza sociale).
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (fede nell’Uno e unico Dio) – in un secondo tempo
questo principio fu anteposto a tutti gli altri” (Schulze, 2004, pp. 147-148).
Le potenze colonizzatrici svilupparono anche un approccio conoscitivo delle
consuetudini di diritto civile dell’Africa, basato sull’antropologia (il tedesco Leo
Frobenius fu un autore importante in questo contesto; anche l’Inghilterra e la Francia
ebbero i loro antropologi al lavoro sulla ricerca e la catalogazione del diritto
tradizionale). Gli intellettuali africani di quest’epoca, così come i movimenti politici
critici e sindacali, hanno poco spazio, invece, nei loro stessi paesi di origine: “L’élite
intellettuale, in cerca della propria identità, tradusse le sue aspirazioni sotto forma
letteraria (la rivista L’Etudiant Noir escì a Parigi nel 1934), che doveva dare vita al
tema della négritude, proposto nel 1939 dal poeta antillano Aimé Césaire e da Senghor”
(Coquery-Vidrovitch, Moniot, 1977, p. 176). Proprio di Senghor va qui citato l’articolo
del 1939 sul mancato rendez-vous fra le culture, che costituisce un punto di riferimento
della Teoria della democrazia globale.
In Germania, gli autori più noti sembrano preoccuparsi poco del pericolo degli eventi
mondiali correnti – da Jaspers a Rudolf Bultmann, da Hermann Cohen a Heidegger, da
Spengler a Ernst Junger –, mentre più focalizzati appaiono il Karl Mannheim di
Ideologia e utopia e, soprattutto, il Carl Schmitt degli articoli raccolti, a guerra finita, in
Il nomos della terra (1950). La maggior parte degli autori europei più noti ebbero a
temere il fascismo, lo combatterono, furono esiliati o perseguitati (Benjamin, Bergson,
Thomas Mann, Toynbee, Unamuno, Ortega y Gasset, Valéry, Malraux, Sartre,
impegnato in questi anni nella stesura di Essere e nulla, Russell, Wittgenstein, Arendt,
Popper, Berlin, Horkheimer, Adorno e Marcuse). Altri, come André Gide, furono ben
presto delusi dall’URSS. Dopo la guerra, uno dei maggiori punti di riferimento teorico
anti-fascista fu Antonio Gramsci (i cui Quaderni dal carcere contengono importanti
critiche a Mosca, Croce ed altri liberali) e Georg Lukacs. Qui di seguito do alcune
sintesi da autori europei utili per la costruzione della Teoria della democrazia globale.
José Ortega y Gasset in La rivolta delle masse espone il concetto di uno stato che, come
quello odierno, è capace di provvedere a tutto ciò che serve alle masse, sicché queste
sono ben contente di diventare passive e di lasciarsi guidare dal potere. Da questo punto
di vista, il saggio contiene un’azzeccata diagnosi del tempo – l’avvento della “società
di massa”.
Jacques Maritain detta nel 1934 sei lezioni all’Università di Santander raccolte sotto il
titolo Umanesimo integrale (Maritain, 1980), dove, sulla base di Aristotele e San
Tommaso, preme per un nuovo cristianesimo impegnato nel sociale e nella politica, a
favore della democrazia. Con Thomas Mann, Maritain ritiene che la democrazia, qua
rispetto della libertà del cittadino, sia una conseguenza del Vangelo (Maritain, in linea
con Bergson, lo afferma nel suo scritto Democrazia e Cristianesimo). Ma, rispetto al
liberalismo Maritain è critico, perché compito dello stato non può essere solo quello di
garantire la libertà, senza poi occuparsi del fine per cui tale libertà è salvaguardata: il
bene comune (Da Bergson a Tommaso d’Aquino). Ci vuole la libertà di autonomia,
mediante la giustizia e l’educazione – altrimenti, per Maritain, abbiamo una democrazia
personalistica, e non una democrazia liberale. Il filosofo francese non vuole la
separazione fra chiesa e stato, perché teme che gli uomini perdano così, la libertà di
seguire Dio, cadendo vittime del proprio egoismo (il principio di Péguy: “La
rivoluzione sociale sarà morale o non sarà”). Tuttavia, Maritain desidera che il
principio del pluralismo venga inserito nella costituzione e protetto legalmente,
plaudendo ad una filosofia politica democratica e pluralistica. Contro l’economia
dell’abbondanza della sua epoca, Maritain sostiene che il dilemma – o l’individualismo
dell’Occidente o la burocrazia dell’Est – sia falso, poiché entrambi perseguono quel
tipo di economia che causa sempre maggiore insoddisfazione.
Nel 1930 Keynes pubblica il Trattato sulla moneta, in due volumi, in cui sviluppa
ulteriormente la sua teoria del ciclo del credito di stampo wickselliano e anticipa la sua
opera principale, che è la Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della
moneta (The general theory of employment, interest and money del 1936), che
costituisce la base della moderna macro-economia. In esso Keynes afferma che sono
giustificabili le politiche destinate a stimolare la domanda in periodi di disoccupazione
tramite un incremento della spesa pubblica. Poiché Keynes non ha piena fiducia nella
capacità del mercato lasciato a se stesso di esprimere una domanda di piena
occupazione, ritiene necessario che in talune circostanze sia lo Stato a stimolare la
domanda (furono queste le argomentazioni a base del New Deal). Verso la fine della
guerra mondiale, essendo ormai vicina la vittoria degli Alleati, Keynes si fa promotore
nel 1944 degli accordi di Bretton Woods, negli USA, per far nascere la Banca Mondiale
(di cui non sarà soddisfatto, per via del sistema dei cambi fissi che non riuscì a fare
abolire, temendo che favorissero la speculazione e battendosi contro gli USA stessi; in
effetti, dopo la crisi della guerra del Vietnam e quella del petrolio la sua diagnosi
economica doveva dimostrarsi azzeccata – infatti, nel 1971 Nixon dovette abbandonare
i cambi fissi e passare a quelli flessibili).
Negli USA, intanto, Addio alle armi (1929) di Ernest Hemingway suscitava
l’attenzione del grande pubblico: “Nel 1934 un sensazionale articolo, ‘Le armi e il
fuoco’, pubblicato da molte riviste periodiche, e il libro Mercanti di morte attribuirono
alle macchinazioni delle industrie belliche internazionali lo scoppio delle guerre
moderne. Organizzazioni pacifiste come il National Council for the Prevention of War
e la Women’s International League for Peace and Freedom sfruttarono l’occasione per
chiedere un’inchiesta del congresso sul commercio delle armi e nell’aprile 1934 il
senato nominò una speciale commissione investigativa presieduta da un isolazionista
convinto, Gerald P. Nye, un repubblicano del North Dakota. La commissione
d’inchiesta mise in luce le manovre di corridoio e le dubbie attività dei fabbricanti
d’armi e accertò che nel corso della prima guerra mondiale industriali e affaristi
avevano realizzato enormi profitti con la vendita di armi agli Alleati. Per di più le
conclusioni della commissione, pur non essendo corredate da prove concrete,
adombrarono l’ipotesi che nel 1917 gli Stati Uniti fossero entrati in guerra per le
pressioni dei banchieri di Wall Street e dei magnati dell’industria bellica. Un libro di
Walter Millis, La strada per la guerra. 1914-1917, coronato da grande successo di
pubblico, sostenne la stessa tesi. Gli Stati Uniti, a giudizio dello scrittore, non erano
entrati in guerra per difendere ideali o interessi nazionali, ma solo per gli stretti legami
economici che li univano agli Alleati: una tesi che sembrava plausibile agli esponenti di
una generazione pesantemente condizionati dai problemi economici” (idem, p. 442).
Sono anni, dunque, di grande vivacità culturale, in cui i sociologi e gli psicologi hanno
un’ottima possibilità di studiare da vicino i modi in cui mutano gli umori delle masse
(Talcott Parsons pubblica La struttura dell’azione sociale nel 1937 e Fromm Fuga
dalla libertà nel 1941). Sarà stato forse anche per la facile maniera con cui le masse
cambiano orientamento che Joseph Schumpeter definì la democrazia come una
procedura, dunque formale: la democrazia è quel meccanismo grazie al quale i
cittadini, organizzati in partiti, hanno il potere di votare liberamente scegliendo i loro
rappresentanti in parlamento (Schumpeter, 1943).
Le opere economiche liberiste di questi anni, come Human Action di von Mises (in cui
l’autore rigetta il concetto positivista di causalità e ribadisce la superiorità del libero
mercato sulla pianificazione economica statale), o La via della schiavitù, dove Friedrich
August von Hayek sostiene la sostanziale continuità tra socialismo e nazismo, si
comprendono meglio se viste alla luce delle paure generate in questi anni dai
totalitarismi avanzanti.
Un posto a parte spetta all’opera di Karl Polanyi, che scrive La grande trasformazione
proprio in questi anni, mentre si trova negli USA (Polanyi, 2000). La tesi centrale qui è
che il fascismo sia una “mossa sempre possibile” dato il sistema economico liberale
basato sul mercato capitalistico – il che vale come un’ampia confutazione
dell’economia politica classica o neoclassica basata sull’homo oeconomicus. – La tesi,
certamente importante per la Teoria della democrazia globale, passò all’epoca alquanto
inosservata (non se ne trova traccia nei nuovi studi intrapresi da Arrow), anzi, proprio il
1944 è l’anno di fondazione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca
Mondiale. Il punto che Polanyi conquista in modo convincente è che è lo stesso
liberalismo di mercato a rendere sempre possibile un approdo “naturale” al fascismo,
perché l’economia si sottrae al controllo sociale.
In Brasile, quando negli anni Trenta si forma il movimento integralista, emerse
l’intellettuale Plinio Salgado, che operò una sintesi fra istanze di sinistra e di destra,
così come di spiritualismo e di materialismo: “No pensamento integralista o conceito de
revoluçao assumia a proposta – origalmente ligida a astronomia – de retorno a um
ponto preestabelicido, representando para Plinio Salgado a volta do Brasilao passado
colonial onde, nas suas palavras, o Brasil fore realmente brasileiro. Caberia a
Revoluçao Integralista anunciar a restauraçao nacional a partir da revoluçao spiritual,
conduzida por um numero de homens que Plinio chamava de apostoles. A perspectiva
nazionalista
de
Plinio,
portanto,
mantinha
uma
aproximaçao
com
postura
antiimperialista de setores da esquerda, mas estava marcada por um aspecto
conservador, no sentido de defender a pureza nacional do Periodo Colonial. Plinio,
influenciado pela intelectualidade da decada de 1930, era partitario da ideia de
democrazia racial da colonia, considerando o caboclo a sintese de tres raças e simbolo
da unidade nacional brasileira” (Aquino et al., 2000, p. 346). Il tutto stava in sintonia e
simpatia con il fascismo europeo contemporaneo. Altri nomi importanti del movimento
furono quelli di Gustavo Barroso (detto il Führer brasileiro, filo-nazista), Gerardo Melo
Mourao e Miguel Reale (più filo-fascisti).
Capitolo III
Intorno alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
1945-1950
Paragrafo 1
Storia
1945-1950
Il quinquennio 1945-1950 è particolarmente importante per le Relazioni Internazionali,
in quanto è durante questi cinque anni che si verificarono i seguenti atti e fatti di
rilevanza internazionale: gli accordi di pace successivi alla guerra mondiale, la
continuazione e l’instaurarsi di altri conflitti, l’inizio della Guerra Fredda, il
rinnovamento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, l’entrata in regime delle nuove istituzioni finanziarie ed economiche
mondiali (FMI, Banca Mondiale, GATT), la “dottrina Truman”, il Piano Marshall per
l’Europa occidentale, la creazione della NATO, del Consiglio d’Europa e della Lega
Araba, la nascita dello stato di Israele, i primi successi del movimento anti-colonialista
e la vittoria di Mao su Chiang – praticamente tutto il nuovo assetto della politica
internazionale, durato fino al 1989.
Mentre gli stati fascisti, Italia, Germania e Giappone, dichiaravano la loro sconfitta, gli
Alleati (Stalin, Chiang, De Gaulle, Churchill, sostituito subito dopo da Attlee, e
Truman, subentrato a Roosevelt) si riunivano a Potsdam, presso Berlino, continuando il
discorso già aperto a Teheran e a Yalta e procedendo a ridisegnare il nuovo ordine
mondiale (luglio-agosto 1945). In quest’occasione si cominciò a discutere anche
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e del meccanismo del Consiglio di sicurezza.
In politica estera, infatti, l’URSS cercò sempre più di consolidare la propria influenza
sui paesi dell’Europa dell’Est che voleva fossero considerati come suoi satelliti,
soprattutto a partire dal 1947. Se nel 1946 gli alleati e l’URSS erano ancora abbastanza
uniti da portare i gerarchi nazi-fascisti davanti al tribunale internazionale di
Norimberga, subito dopo questo buon inizio di collaborazione post-bellica l’URSS si
rifiutò di far parte della commissione istituita dalle Nazioni Unite per il controllo
dell’energia atomica e, cosa ancora più grave, al contrario di Gran Bretagna e USA, non
ritirò, come avrebbe dovuto, le sue truppe dall’Iran, e fu costretta solo dall’ONU a
rispettare i patti (Riasanovsky, 2003, p. 535). Ci fu anche una maggiore pressione anti-
comunista esercitata in Europa dagli USA in quell’anno. La sfiducia reciproca, infatti,
fra USA e URSS cresceva contemporaneamente da ambo le parti. Il 1947 è l’anno in
cui si costituisce il General Agreement on Tariffs and Trade, organismo internazionale
per il regolamento del commercio mondiale, ma è anche l’anno in cui si prepara il
Piano Marshall, varato l’anno successivo, col suo strascico di condizionamenti politici
che avrebbe comportato su tutta l’Europa, subito denunciato da Molotov alla prima
conferenza di pace come un nuovo tentativo di colonizzazione e imperialismo. – Logica
conseguenza di questo Piano, infatti, era anche l’estromissione dei partiti comunisti
dalle coalizioni di governo nei paesi dell’Europa occidentale. L’URSS represse quei
dirigenti comunisti che volevano seguire le orme di Tito in altri paesi satelliti (ne
patirono le conseguenze soprattutto gli Ungheresi e i Cecoslovacchi). Detto questo,
bisogna anche dire che tutto ciò corrispondeva alla contemporanea offensiva, e non solo
ideologica, degli USA: ben oltre la questione greca, nell’aprile del 1949 i paesi
dell’Europa occidentale firmavano con gli USA il patto militare nord-atlantico NATO.
Da lì a poco l’URSS avrebbe risposto con l’instaurazione del Patto di Varsavia (1955).
Praticamente, già nei prima anni del dopo-guerra, siamo nella Guerra Fredda.
Nel 1949 il Partito comunista di Mao riuscì a prendere Pechino e poi Shanghai. Chiang
fu costretto a riparare a Formosa (Taiwan), dove Mao desisterà dal portare la battaglia.
Su Taiwan Chiang installa, così, quel che rimaneva della Repubblica cinese fondata da
Sun nel 1911, mentre sul Continente asiatico Mao creava la Repubblica Popolare
Cinese su una base dichiaratamente comunista, e con una forte intesa con l’URSS
guidata da Stalin. Anche in Indonesia, Malesia e Birmania i partiti comunisti lottarono
con fortune alterne, riuscendo alla fine a conquistare l’indipendenza per le loro
rispettive nazioni.
Gli USA intervennero energicamente sul Giappone, privandolo delle sue colonie e
conquiste; sei milioni di soldati giapponesi furono disarmati e smobilitati, fu compiuta
una radicale riforma agraria e la pubblica istruzione fu completamente rinnovata. Con
la nuova costituzione democratica il Giappone rinunciava alla guerra, l’esercito doveva
essere drasticamente ridotto e la posizione dell’imperatore ridotta a quella di un
semplice monarca costituzionale (Jonas, 2000, p. 475).
Gli Inglesi operarono con distinguo nelle loro colonie asiatiche, reprimendo nel sangue
le rivendicazione indipendentistiche della Malesia nel 1947, ma riconoscendo
l’indipendenza dell’India e di Ceylon, che accettarono di far parte del Commonwealth,
al contrario della Birmania, che ottenne l’indipendenza (l’anno successivo), rimanendo
però estranea alla comunità britannica (Villari, 1971, pp. 604-605). In Corea, la parte
sud posta sotto l’amministrazione fiduciaria degli USA venne ricostituita come
repubblica, con presidente provvisorio Syngman Rhee, ma il suo programma politico,
di tipo democratico (nazionalizzazione dell’industria, riforma della terra, suffragio
universale, condizioni di lavoro migliori, fine del lavoro minorile e salario minimo
garantito), era portato avanti da una leadership interessata esattamente all’opposto:
uomini d’affari e proprietari terrieri che avevano già fatto parte della polizia coloniale,
coadiuvati dalle forze USA rappresentate dal tenente generale John Hodge, uomo poco
esperto di Asia, con opinioni di tipo quasi-razzista (Lee, 2003, p. 37) – un altro
“passaggio irreversibile” della non-democratizzazione particolarmente interessante per i
successivi sviluppi sia nella Corea (la guerra 1950-1955), sia nel resto dell’Asia.
La sorte del Vietnam fu diversa e, sotto molti aspetti, peggiore di quella della Corea.
Malgrado l’appello al riconoscimento internazionale di Ho Chi Minh fosse impeccabile,
e dopo un primo timido atteggiamento positivo da parte di Roosevelt, nel passaggio di
potere a Truman l’approccio USA cambiò radicalmente. Peraltro, la Cina (ancora
governata da Chiang) e la Gran Bretagna, incaricati di sovrintendere alla situazione
indocinese dopo la sconfitta del Giappone, si mostrarono inclini a riconoscere le ragioni
della Francia piuttosto che quelle del Vietnam. Gli USA stessi si mostrarono molto più
propensi a ripristinare il comando coloniale francese, avallandone le iniziative
provocatorie della Francia come il bombardamento di Hanoi nel 1946, piuttosto che a
sostenere la nuova repubblica indipendente – altro grande “passaggio irreversibile”
della non-democrazia.
Nell’estate del 1947 arriva l’indipendenza per l’India e il Pakistan – ma con la partition
(non voluta da Gandhi, ma sì da al-Mawdudi e Jinnah, seguaci di Muhammad Iqbal; il
primo, soprattutto, fu l’artefice della nuova costituzione islamica pakistana), che
indebolì molto il fronte democratico-culturale dell’operazione indipendentista – come
tale, dunque, anche questo momento va considerato come un altro “passaggio
irreversibile” della non-democratizzazione internazionale.
Nel 1949 l’Indonesia si stacca dall’Olanda. Per gli Olandesi, questo fu uno chock: “Ne
nacque una grossa crisi di fiducia, data la convinzione diffusa nel paese che l’Olanda
non potesse sopravvivere senza il contributo dei possedimenti d’oltremare”
(Mammarella, 1992, p. 84). Come in India e in Pakistan, si installa in Birmania una
democrazia orientata verso il soddisfacimento dei bisogni dei meno abbienti, dunque ad
orientamento sociale (se non socialista). Accaddero però, dei fatti delittuosi che
modificarono il corso degli eventi: il leader democratico birmano Aung Sun viene
ucciso nel 1947, la sua famiglia smembrata e costretta all’esilio. Un assassinio
eccellente – come, se non di più fu l’omicidio di Gandhi, per mano di un
fondamentalista indù, nel 1948. Questo delitto in Birmania spianò la strada alla
dittatura militare, che si proclamò ispirata al comunismo – al contrario dell’India, che,
invece, rimase fermamente democratica, sotto la guida di Nehru, e che avrà nel 1950
una costituzione apertamente liberal-democratica, redatta dal giurista Ambedkar,
proveniente dalla casta dei dalit, musulmano convertito al buddhismo, amico di
Gandhi.
In Russia, la politica interna di ricostruzione fu affidata da Stalin e dal politbjuro ai
piani quinquennali, di già sperimentata efficacia (si stima che il tasso di crescita
industriale dell’epoca sia stato attorno al 12-14%: Riasanovski, p. 531). Le popolazioni
che avevano simpatizzato per i nazisti furono punite con trasferimenti di massa, dal
Volga, Crimea e Caucaso in remote zone orientali – sotto il controllo dell’efficacissima
polizia guidata da Berija. Le elezioni vennero tenute, dopo quelle del 1937, nel 1946 e
nel 1950, in tutta l’URSS, ma il nuovo Soviet supremo non era che la cassa di risonanza
delle decisioni di Stalin: “Gli anni post-bellici furono anche di decisa riaffermazione
dell’ortodossia comunista in campo ideologico e culturale”, opera nella quale si distinse
Andrej Zdanov, particolarmente solerte nel debellare ogni fermento di critica (idem, p.
533).
Un episodio analogo a quello della Persia, smobilitata dall’URSS solo dopo forti
pressioni dell’ONU, da prodromi di Guerra Fredda, si ebbe contemporaneamente anche
in Turchia, a cui l’URSS propose di condividere lo stretto dei Dardanelli, cosa che il
governo di Ankara rifiutò decisamente, anche qui con il supporto militare degli USA
(Mammarella, 1992, p. 104). Prendeva corpo la metafora di Churchill della “cortina di
ferro”, che divideva in due parti la Germania e, di più, l’Europa intera, occidentale e
orientale. Il presidente degli USA Truman e il dittatore russo Stalin si trovarono così a
fronteggiarsi, immediatamente dopo la guerra, in una serie di luoghi diversi, e l’uno e
l’altro preparavano le proprie strategie di attacco-difesa, ben al di là degli accordi di
pace che furono conseguiti in seguito alle riunioni diplomatiche di Potsdam, Londra,
Mosca, Parigi e New York, fra il 1945 e il 1947.
Per quanto riguarda la Francia e la Gran Bretagna relativamente al potenziale di
sfruttamento delle risorse petrolifere e all’equilibrio in Medio Oriente, la bilancia
pendeva ora a netto vantaggio della Gran Bretagna (Villari, 1971, p. 609).
Durante gli anni della guerra, facendo seguito alla dichiarazione della Carta atlantica da
parte di Roosevelt, i paesi del Maghreb cercarono di cogliere l’occasione per
proclamarsi indipendenti dalla madrepatria francese. In questa direzione operò sia il re
marocchino Muhammad V, sia il bey tunisino Muhammad al-Moncef, sia i membri
della leadership del partito dell’indipendenza algerino, come Allal al-Fasi, e del partito
nazionalista borghese, come Farhat ‘Abbas – i cui sforzi, però, rimasero per il momento
senza esito. La nascita della Lega Araba (22 marzo 1945) aumentò le speranze di
maggiore indipendenza, e anche l’Associazione degli ulama algerina fece causa
comune con gli altri partiti anti-colonialisti. Tuttavia, malgrado Hitler fosse capitolato,
la Francia si oppose fieramente alle richieste di indipendenza degli Algerini (Schulze,
1994, p. 150). Il fatto è che a quell’epoca l’Occidente colonialista adottò nei confronti
dell’islam un’ottica fondamentalista, nel senso che tutto quello che veniva dall’islam
doveva essere rifiutato a priori, vuoi perché all’islam tutt’intero si affibbiava il concetto
di non-separazione fra stato e religione, vuoi perché si nutriva una paura generalizzata
rispetto alla sharia. D’altra parte, l’islam condivideva con il resto del mondo le stesse
esperienze, le stesse speranze e delusioni: “Fame, devastazione, sradicamento, famiglie
distrutte, impoverimento psichico e fuga avevano segnato la coscienza di numerose
comunità. Tuttavia, diversamente che nell’Occidente vittorioso, nell’Unione sovietica
trionfante e perfino nei paesi europei sconfitti, per il mondo islamico l’orrore, quello
vero, lungi dall’essere un ricordo, stava per cominciare proprio in quel momento. La
restaurazione coloniale, anch’essa conseguenza della Seconda guerra mondiale, non
tardò a mostrare i propri effetti: in Marocco, Algeria, Tunisia, Iugoslavia, Palestina,
India e Indonesia la guerra cominciava ora, al termine del secondo conflitto mondiale”
(idem, p. 152). L’Algeria perse nella sua lotta per l’indipendenza un decimo della sua
intera popolazione, mentre, a confronto la Germania aveva perso l’8,5% della sua
durante la guerra mondiale, il Giappone il 3% e la Francia il 2%.
In Africa, nel periodo che stiamo considerando ci sono degli importanti cambiamenti
demografici positivi – la popolazione totale del 1935 era intorno ai 165 milioni, dopo la
Seconda guerra mondiale arriva a 200 milioni e nel 1956, alla vigilia dell’indipendenza
degli stati sub-sahariani, 220 milioni (Speitkamp, 2010, p. 205). Dopo la fine del
commercio oltreoceano di schiavi, l’emigrazione di Africani dal Continente si era
fermata – e riprenderà solo alla fine del XX secolo. Invece, il colonialismo, da parte
sua, ha comportato l’afflusso di immigrati europei, che andò accompagnata anche ad
una discreta immigrazione dall’Asia. Questi rimescolamenti sociali ebbero degli
importanti riflessi sulla cultura e la società tradizionale africana. Le nuove opportunità
offerte dai lavori creati dal modo di produrre occidentale spostavano il baricentro della
vita dalla campagna alla città. Qui i giovani africani acquisivano nuove prospettive
culturali e sociali, talvolta anche sindacali e politiche, rendendosi autonomi dai
tradizionali vincoli di potere gerarchico tipici del villaggio. Alcuni di loro
semplicemente aspirarono a diventare dei big men e a tornare indietro nel villaggio col
nuovo status acquisito. Altri, invece, approfittarono della nuova situazione per formare
relazioni familiari di tipo nuovo, al di fuori del monopolio esercitato dagli anziani sulla
terra, che era stato proprio della campagna. Si andarono affermando le famiglie nucleari
e non allargate e, in generale, si modificarono i rapporti fra i sessi anche negli ambienti
rurali più tradizionali.
Per quanto riguarda l’aspetto politico, in generale bisogna dire che malgrado le buone
intenzioni, il bilancio della politica coloniale che si deve fare per il periodo 1945-1955
rimane magro, anzi, pessimo, dato che le potenze europee tesero ad aumentare lo
sfruttamento (Coquery-Vidrovitch, Moniot, 1977, p. 178; Coquery-Vidrovitch, 2012, p.
127). Proprio la Carta atlantica del 1941 aveva ispirato l’azione anti-colonialista di
uomini come Kwame N’Krumah (Ghana) e Namdi Azikiwe (Nigeria) che avevano
studiato negli USA. Proteste, scioperi e disordini dovevano susseguirsi in questi anni in
Nigeria, Ghana, Uganda, Kenya e Madagascar. Nel 1946 in Congo si fondava il
Rassemblement démocratique africain (RDA), guidato da Félix Houphouet-Boigny, un
movimento di coalizione di partiti. In tutto questo processo non mancarono ambiguità:
mentre si formava questo Rassemblement (1946), lo stesso Houphouet-Boigny, che
entrava a far parte del governo francese, votava a favore della repressione armata in
Indocina – al contrario del suo compagno di partito dell’RDA, il leader camerunense
Ruben Um Nyobé (1913-1958), che invece non era d’accordo a rompere con i
comunisti e sosteneva la lotta per l’indipendenza sia dell’Algeria, sia del Vietnam.
A San Francisco nei mesi di giugno e luglio del 1945 (ancora a guerra non finita) si
ritrovano i delegati di cinquanta paesi per discutere e sottoscrivere la carta istitutiva
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Jones, 2000, p. 468). Questa volta, grazie
all’abile regia di Roosevelt che aveva fatto partecipare, al contrario del suo
predecessore democratico Wilson, entrambi i due maggiori partiti statunitensi ai lavori
diplomatici preliminari, gli USA accettarono fin da subito di farne parte (la firma, per
gli USA, la mise Truman). Con quest’istituzione, che faceva seguito a quella delle
organizzazioni internazionali finanziarie – Banca Mondiale e Fondo Monetario
Internazionale – messe a battesimo l’anno prima a Bretton Woods, si può dire che si era
creato, per la prima volta in modo stabile, un assetto istituzionale dalla base molto larga
delle Relazioni Internazionali post-bellum. La Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo (10 dicembre 1948) venne a porsi come la cornice di pensiero, al tempo
stesso costituzionale e politica, delle nuove Relazioni Internazionali.
Il punto di maggior discordia fu la gestione post-bellum della Germania, ma un punto di
discordia di non minor importanza fu il disarmo atomico. Nel 1946 gli USA
sottoposero un progetto alle Nazioni Unite per l’eliminazione di queste armi da parte di
un ente internazionale, idea che l’URSS rifiutò. A partire da questo momento, ispirata
da un documento diplomatico steso da George Kennan, la politica degli USA nei
confronti dell’URSS fu quella del “contenimento”, cioè, di misure politico-strategiche
per limitare l’influenza sovietica nel mondo (idem, p. 473). Il primo passo concreto fu
fatto da Truman nel Mediterraneo orientale, dove la Gran Bretagna aveva aiutato i
movimenti di destra nella lotta partigiana, sostenuta dall’URSS. Quando Churchill
comunicò a Truman di non essere più in grado di continuare questo sostegno
(soprattutto per le difficoltà economiche e finanziarie post-bellum), Truman scese in
campo per sostenere sia la destra greca, sia quella turca (ibidem). La “dottrina
Truman”, come fu chiamata questa “discesa in campo” ad aiuto della destra in Europa,
s’inserì così in quella politica di “contenimento” che il presidente USA presentò al
Congresso e che, anche con l’aiuto di repubblicani internazionalisti come Vandenberg,
fece passare come linea ufficiale statuntense. Nel 1949 John Foster Dull, segretario di
stato, formulò la “teoria” di politica internazionale denominata roll back nei confronti
dell’URSS, che si spingeva un passo oltre quella del “contenimento” di Kennan: in
breve, si affermava che la politica del “contenimento” non fosse più sufficiente ad
affrontare la superpotenza avversaria, ma che bisognasse correre dietro all’URSS,
recuperando con forza il terreno perduto – tanto più che, come già detto, l’URSS aveva
ottenuto la propria bomba atomica nel 1949, seguita da quella all’idrogeno nel 1953.
Tanto per complicare questo quadro di acuta concorrenza, proprio nel 1949, come
abbiamo visto, il Partito comunista cinese, guidato da Mao, riusciva a prendere il potere
su tutta la Cina, sconfiggendo il vecchio alleato Chiang. Quest’ultimo fatto convinse gli
USA che bisognava cambiare strategia in Asia, ciò che cominciò a fare a partire dalla
Corea (Jonas, 2000, p. 475).
In Messico nel 1946 il Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) governò il paese in
chiave nazionalista (talvolta, con prese di posizione anti-statunitensi) senza interruzioni,
fino al 2000, con politiche il più delle volte a vantaggio della parte padronale con
l’acquiscienza dei sindacati (Aboites Aguilar, 2007, p. 279). Nel febbraio 1945 Città
del Messico ospitò la “Conferenza interamericana sui problemi della guerra e della
pace”, meglio nota come Conferenza di Chapultepec. Ai lavori parteciparono tutte le
repubbliche americane salvo l’Argentina: nell’atto finale, del 4 aprile, i delegati
riaffermarono i principi democratici di convivenza internazionale e sollecitarono la
stipulazione di un trattato capace di garantire ogni repubblica dalle minacce che
eventualmente le provenissero da Stati diversi, anche dello stesso continente americano
(Albonico, 1982, p. 19).
In Brasile, dopo la rinuncia forzata di Vargas nell’ottobre del 1945, s’inaugura il
periodo che viene conosciuto come quello della Nova Republica, durato fino al 1961
(col nuovo presidente, il generale Dutra, si ebbe una nuova costituzione, la quarta, e si
instaurò una commissione per verificare i delitti compiuti durante il periodo dittatoriale
dello Estado Novo – denunce e pubblicazioni in proposito non ne mancarono, come
quella del 1946 del giornalista David Nasser contro l’ex-capo di polizia Filinto Müller,
che, paradossalmente fu eletto nello stesso anno senatore per lo stato del Mato Grosso:
Aquino et al., 2000, p. 469). In questo periodo furono attivi nuovi partiti, alcuni nati
durante gli ultimi anni del precedente mandato di Vargas, tra cui il Partido Trabalhista
Brasileiro (fondato dallo stesso Vargas) e la Uniao Democratica Nacional, a cui
parteciparono esponenti dell’alta borghesia, banchieri e industriali, favorevoli alla
crescita del paese e all’ingresso del capitale straniero; il Partido Socialista Brasileiro fu
fondato nel 1947 (Aquino et al., 2000, p. 458). Il periodo della presidenza Dutra fu
quello in cui di più si evidenziò la differenza fra il partito di chi voleva mantenere in
patria le ricchezze nazionali (il petrolio in testa, con lo slogan O petroleo é nosso!) e chi
era invece favorevole a fare entrare in patria il capitale straniero.
In Argentina nel 1944, il nuovo presidente Pedro Pablo Ramirez ruppe le relazioni
diplomatiche con le potenze dell’Asse e nel 1945, addirittura, dichiarò guerra alla
Germania – il che non impedì, tuttavia, ad una serie di gerarchi fascisti di trovare riparo
in Argentina (fra questi Adolf Eichmann, catturato nel 1960, Josef Mengele, che però
non venne mai trovato, e morì in Brasile, e Erich Priebke, arrestato a San Carlos de
Bariloche nel 1995). L’Argentina entrò a far parte della nuova ONU; ma gli USA, che
non avevano ben visto questi mutamenti di fronte, operarono in modo tale da isolarla
diplomaticamente. Artefice di questo isolamento internazionale fu l’ambasciatore
statunitense a Buenos Aires Spruille Braden (sostenuto dallo stesso Truman). Alle
elezioni del 1946, tuttavia, vinse la coalizione avversaria al fronte guidato da Braden (e
che comprendeva l’Unión Democratica, i conservatori della Provincia di Buenos Aires,
l’Unión Cívica Radical e i partiti socialista e democratico-progressista, e che aveva
perfino l’appoggio del Partito comunista), e il popolo argentino si espresse ampiamente
a favore del colonnello Juan Domingo Perón, il cui movimento comprendeva il Partido
Laborista, i sindacati (CGT), i gruppi yrigoyenisti, ma anche i conservatori delle
province dell’interno del paese. Dopo le elezioni, Perón organizzò un nuovo partito
peronista, il Partido Único de la Revolución, inglobando il Partido Laborista, elaborò
una nuova costituzione e promosse una politica repressiva contro la dissidenza. La
situazione economica, tuttavia, andò peggiorando e da paese creditore (anche verso
potenze di primo livello come la Gran Bretagna), il paese cominciò a diventare debitore
(l’economista Raul Prebish cominciò, infatti, in questi anni le sue ricerche su quella che
poi verrà diventerà famosa come la “teoria della dipendenza”). In Bolivia, Paraguay e
Uruguay Perón fu capace di condizionare la politica interna tramite esponenti politici
che si identificavano con le sue posizioni.
Per quanto riguarda il Guatemala, infine, va ricordata la presidenza di Juan José
Arévalo (1944-1951), che riuscì ad abolire le servitù legali a cui erano ancora sottoposti
gli Indios non ispanizzati, che costituivano la maggioranza della popolazione (idem, p.
34).
L’Inghilterra che, grazie all’economista keynesiano William Beveridge, inventa il
modello di Welfare State e si impegna in un ampio programma di democratizzazione
(sussidi alla disoccupazione, edilizia pubblica, nazionalizzazione della Banca
d’Inghilterra, dei servizi di telegrafi e radiocomunicazioni, delle miniere di carbone,
dell’industria siderurgica, dell’energia elettrica, e dei trasporti terrestri ed aerei: Villari,
1971, p. 592), accompagna tutte queste politiche di ridistribuzione della ricchezza con
una forte politica di austerità (portata avanti dal ministro laburista Stafford Cripps).
Non solo, in questo modo, i costi del Welfare State non scalfivano l’organizzazione del
potere, né la sostanza del capitale (in termini di proprietà delle industrie e di
introduzione di una qualche forma di controllo dal basso o di partecipazione operaia:
Mammarella, 1992, p. 58), ma addirittura si riversavano sulle popolazioni colonizzate,
ripentendo lo schema della democrazia etnica che abbiamo già visto all’opera altre
volte, con la chiara “contraddizione fra la volontà di mantenimento di un regime
coloniale nei territori d’oltremare e l’instaurazione di una democrazia sociale nel
territorio metropolitano” (Villari, 1971, p. 592. Per l’Italia, visto che il suo dominio
coloniale era terminato con la sconfitta in guerra, il problema non si poneva più – se
non residualmente, per quanto riguardava la Somalia). D’altra parte, Churchill, anche se
aveva già abbandonato il potere, intendeva passare la mano agli USA di Truman per
quanto concerneva la gestione del potere conservatore diffuso in Europa. L’Inghilterra
non riusciva più a supportare i suoi 40.000 soldati impegnati a sostegno della
monarchia greca, la stessa che nel 1936 aveva favorito la dittatura fascista del generale
Metaxas contro il movimento di liberazione, e che adesso, grazie alla Gran Bretagna,
era tornata in sella. Fu a partire da queste logiche che gli USA formularono, altogether,
il Piano Marshall per il sostegno alla ricostruzione europea post-bellica e l’aiuto al
contenimento del movimento democratico in Europa: “La ‘dottrina Truman’, basata
sulla combinazione della guerra fredda e dell’aiuto alla ripresa economica, fu l’inizio di
una svolta nella storia europea del dopoguerra” (Villari, 1971, p. 595; Riasanovsky,
2003, p. 536). In pratica, l’aiuto statunitense alla ricostruzione dell’Europa implicava
non solo il controllo finanziario degli USA sull’Europa, beneficiaria dei suoi prestiti,
ma anche una politica di freno allo sviluppo della democrazia nel Vecchio Continente
(Mammarella, 1992, p. 112). Questo quadro dà ragione di come i fatti più specifici in
ogni singolo paese europeo abbiano avuto il significato di “passaggi irreversibili” di
non-democratizzazione (pensiamo alla strage mafiosa del primo maggio 1947 di
Portella della Ginestra in Sicilia, rimasta impunita, etc.). A completare l’opera antidemocratica, non solo i partiti comunisti furono ben presto estromessi dai nuovi governi
europei (soprattutto, in Italia, Belgio e Francia), ma “cominciò anche ad attenuarsi
l’intransigenza antifascista che era stata imposta dai movimenti della Resistenza e
furono recuperati nelle organizzazioni politiche, nella burocrazia, nella polizia ecc. i
gruppi ed i partiti più conservatori, gli ex-fascisti e gli ex-collaboratori del nazismo”
(Villari, 1971, p. 596).
La creazione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, avvenuta a
Bretton Woods nel 1944, veniva a costituire lo sfondo più consono in cui la
restaurazione capitalistica in Europa doveva avverarsi.
Il Piano Marshall fu, dunque, un do ut des nei confronti dell’Europa – infatti, l’URSS
smascherò quest’operazione e rifiutò l’aiuto, denunciando l’insieme di queste politiche
USA “a favore” dell’Europa come una nuova forma di imperialismo (Jones, 2000, p.
473). Nel gennaio del ’49, inoltre, l’URSS creerà una propria politica di aiuti (o di
“aiuti”), il COMECON, nei confronti dei suoi paesi satelliti (Mammarella, 1992, p.
137). Negli USA, inizialmente, il Piano Marshall fu osteggiato nel Congresso sia dalla
destra sia dalla sinistra, ma poi, il colpo di stato comunista in Cecoslovacchia nel
febbraio 1948 convinse il parlamento USA ad approvarlo rapidamente. La creazione
del Consiglio d’Europa (5 maggio 1948), in seguito all’accordo fra Francia, Gran
Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo (firmatari del trattato di Bruxelles), più
Danimarca, Irlanda, Italia, Norvegia e Svezia, si inserisce anch’essa nella strategia più
generale di difesa nei confronti del pericolo, piuttosto sopravvalutato, dell’URSS. Così,
gli USA, Canada, Gran Bretagna, Francia, Italia, Portogallo, Belgio, Olanda,
Lussemburgo, Norvegia, Danimarca e Islanda firmarono, il 4 aprile 1949, il Patto
atlantico denominato North Atlantic Treaty Organization (NATO) inteso a proteggersi
vicendevolmente in caso di eventuali aggressioni – dall’URSS – “conclusione logica
della politica del ‘contenimento’” (Jones, 2000, p. 474).
Paragrafo 2
Politica
1945-1950
Sembra dunque, che si possa dire che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sia
nata insieme alla Guerra Fredda. È lo stesso contesto in cui in Cina Mao ha ragione di
Chiang: due scritti della seconda metà dell’anno fatidico, il 1949, esplicitano la
differenza fra la concezione della storia della democrazia popolare e quella,
fallimentare, idealistica e borghese, attribuita a Chiang (1949: pp. 593-604, e pp. 605614).
L’avvento del comunismo in Cina fu vissuto dagli USA come una catastrofe, la perdita
di un partner, Chiang, corrotto ma affidabile. Gli anti-comunisti statunitensi,
preoccupandosi che la Corea e il Vietnam fossero “contaminati” dagli eventi in Cina,
elaborarono la “teoria del domino”, “secondo la quale la presa di potere dei comunisti
in un paese avrebbe innescato una reazione a catena nei paesi vicini; tale teoria fu un
elemento importante nell’elaborazione della politica del contenimento” (Hall, 2003, p.
16).
In India, a seguito dell’indipendenza e la morte di Gandhi, il potere passa a Nehru. La
Costituzione preparata da Ambedkar, molto liberale e democratica, viene approvata nel
1950.
L’avvento del comunismo aveva prodotto anche in Russia una destabilizzazione fra gli
intellettuali, pochi di essi accettarono tranquillamente di portare acqua al mulino di
Stalin entrando a far parte delle nuove strutture per il loro inquadramento (associazioni
di scrittori sovietici, e simili), soprattutto gli slavofili, la cui tradizione rimonta a
Dostoevsky, Leont’ev e Solov’ov, rifiutarono il nuovo ordine bolscevico. Il filosofo più
rappresentativo, Nikolaj Berdjaev, che pure aveva un passato da rivoluzionario, va in
esilio a Parigi nel 1922 e vi resta fino alla morte (1948). È qui che scrive l’Idea russa
dove riprende il classico tema del confronto con l’Occidente per fare emergere lo
specifico proprio della cultura slava – e per questo fu stimato da Nishida e da altri
filosofi non occidentali (Berdjaev, 1992).
“Dopo la Seconda guerra mondiale l’idea di giustizia sociale diventò il motivo
ideologico predominante della neosalafiyya. A fronte del boom della politica
nazionalista, l’opinione pubblica islamica non tardò a considerarsi la ‘coscienza
sociale’ del mondo islamico. La neosalafiyya paragonò il concetto di libertà dei
nazionalisti a un particolarissimo concetto di giustizia. Una delle formule più spesso
invocate recitava: libertà equivale a giustizia, in un contesto islamico libertà non può
che significare giustizia” (Schulze, 2004, p. 157). Il “contesto islamico” diventò, input
inconsapevole forse della nascita della Lega Araba, un contesto di significazione
originale, per cui l’irakeno ‘Abd al-Rahman al-Bazzaz provocò l’opinione pubblica
islamica con la tesi secondo la quale l’Islam, come l’ebraismo, era una religione
nazionale araba, e poteva servire solo come un marker dell’identità del popolo arabo
solamente – concezione che più tardi avrebbe influenzato il partito Ba’at. Si videro
anche importanti programmi politici socialisti e comunisti emersi nel dibattito arabo a
partire dal 1947 – per esempio, in Egitto, dove Mustafa al-Siba, un capo dei Fratelli
musulmani, si proclamò “socialista islamico”; un altro, Muhammad al-Gazzali,
neosalafita, propose lo slogan: “Fratellanza nella religione, socialismo in terra!”
(Schulze chiama il periodo fra il 1942 e il 1952 il “decennio liberale”, perché in questi
anni fu concesso agli Arabi di esprimere le loro posizioni nazionaliste, repubblicane e
socialiste: Schulze, 2004, p. 176). Un evento culturale di particolare importanza è la
pubblicazione nel 1949 al Cairo di La giustizia sociale e l’Islam di Sayyid Qutb,
giornalista egiziano, uno dei fondatori dei Fratelli musulmani. In questo libro l’autore
“prendeva le distanze dal discorso ‘europeo’ del socialismo e optava per
un’interpretazione islamica delle tradizioni socialiste. Questo testo spianò la strada a un
rafforzamento delle tendenze isolazionistiche all’interno dell’opinione pubblica
islamica, cui si unirono anche Muhammad al-Gazzali e il mordace critico ‘Abd al-Qadir
‘Awda (giustiziato nel 1954). Gli isolazionisti individuarono il loro avversario politico
nei fautori della monarchia egiziana come pure in tutti gli ordinamenti monarchici e nei
loro rappresentnti. Al-Gazzali si scagliò contro la monarchia saudita, contro i wahhabiti
che ‘come pecore’ si erano ‘sottomessi ai tiranni e despoti’ e contro gli ulama ‘che
davano un sostegno morale ai tiranni’. ‘Awda si spinse oltre, affermando che i dottori
della Legge andavano privati di qualsiasi potere” (Schulze, 2004, p. 168). Ma il
movimento fondamentalista islamico doveva trovare le sue basi teoriche in un altro
scritto dello stesso, irriducibile oppositore politico Sayyid Qutb, Pietre miliari: “Nelle
opere di Qutb di questo periodo si rinvengono tre temi conduttori. Qutb avvertì, in
primo luogo, il bisogno di distinguere, e di classificare secondo uno schema polare, ciò
che nelle società islamiche era giusto da ciò che era sbagliato, e voleva forgiare parole
incisive come armi, in grado, cioè, di restituire al musulmano e alla musulmana la
facoltà di decidere della propria vita. Criticò, in secondo luogo, la realtà musulmana a
lui contemporanea tacciandola di ‘mondo dell’ignoranza’ (gahiliyya) e identificandola
simbolicamente con l’età preislamica, conosciuta appunto sotto questo epiteto. Divulgò
infine, attraverso i suoi scritti, l’idea della sovranità assoluta di Dio, attribuendole però
un significato diverso da al-Mawdudi: ‘Un musulmano non crede che si debba adorare
un altro essere, all’infuori di lui; e non crede che la sovranità spetti a uno dei suoi
servitori’. Attraverso la ‘appropriazione creativa dell’immagine’ (tasawwur), la
sovranità divina poteva trovare realizzazione nell’uomo stesso. In Qutb, reggente della
sovranità divina non è lo stato, come in al-Mawdudi, bensì l’uomo in quanto individuo.
Attraverso il lavoro artistico e intellettuale l’uomo doveva ritornare all’‘immaginario
islamico’, di cui il Corano è la massima espressione” (Schulze, 2004, p. 212; su alMawdudi, vedi Palou, 1996). Non è un caso se il pensiero di Qutb sia stato avvicinato a
quello anarchico, la concezione di una società senza sovrano.
Nel 1947 a Parigi Alioune Diop, senegalese, fonda Présence africaine, attorno a cui si
riunisce la militanza africana anti-colonialista e a cui collabora anche Jean-Paul Sartre.
Il pensiero liberale del secondo dopoguerra trova i suoi pilastri in Karl R. Popper
(autore di Miseria dello storicismo e di La società aperta e i suoi nemici, feroce critica
contro la “società chiusa” di Platone), Isaiah Berlin, Norberto Bobbio, Ortega y Gasset,
Miguel de Unamuno, Maurice Blondel e Gabriel Marcel – e naturalmente, nella stessa
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. I più operativi fra di loro cominciarono da
subito a cercare dei rimedi permanenti alla pericolosa bellicosità dell’Europa – fra
questi Jean Monnet e Winston Churchill, che immaginarono una partnership FranciaGermania e gli Stati Uniti d’Europa. Il primo vide nell’unificazione delle risorse
minerarie (la regione della Ruhr in Germania) il primo passo per procedere
concretamente verso l’unificazione continentale, soprattutto nell’immediatamente rinata
divaricazione Est-Ovest, URSS vs. USA. Queste idee furono condivise dal gruppo di
dirigenti politici del dopoguerra: Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De
Gasperi. Infatti, la CECA, per regolamentare e “comunitarizzare” sia il carbone, sia
l’acciaio, nasce da questa preliminare intesa.
Jean-Paul Sartre pubblica nel 1946 L’esistenzialismo è un umanesimo, con cui separa la
sua linea esistenzialistica da quella di Martin Heidegger. Contemporaneamente
pubblica su Les Temps moderns i saggi, pubblicati in due volumi l’anno dopo da
Gallimard, con cui praticamente inizia il suo rapporto con il marxismo. In Materialismo
e rivoluzione attacca gli ideologi del materialismo dialettico istituzionalizzato nel
Partito comunista francese, di osservanza staliniana (Sartre, 1977: entrando in polemica
con Roger Garaudy, ma anche con Lukacs, Althusser e Merleau-Ponty). I temi
fondamentali di Sartre sono: il bisogno, la penuria, la rivolta, la corporeità vissuta e la
prassi. Praticamente, Sartre inserisce nel marxismo le categorie del probabile, di crisi,
di soggetto. Ovviamente, Sartre riconosce al materialismo di avere ben lavorato contro
la falsità dei modelli di libertà proposti dallo stoicismo, dal cristianesimo e dal
bergsonismo – una libertà interiore che lascia mano libera ai padroni e ai poteri. Sono
illuminant alcuni suoi passaggi: “Non è dato a tutti diventare rivoluzionario. […]. In
altri termini, il rivoluzionario è in situazione. È chiaro che lo si incontra solo fra gli
oppressi, ma non basta essere oppresso per volersi rivoluzionario. Gli israeliti si
possono catalogare fra gli opprressi [lo stato di Israele non esisteva ancora: nota di GP]
– e altrettanto dicasi delle minoranze etniche di certi paesi – eppure molti di essi sono
oppressi in seno alla classe borghese e, partecipando dei privilegi della classe che li
opprime, non possono preparare senza contraddirsi la distruzione di questi privilegi.
Allo stesso modo noi non chiameremo rivoluzionari i nazionalisti feudali delle Colonie
o i negri d’America, anche se i loro interessi possono coincidere con quelli del partito
che prapara la rivoluzione; infatti la loro integrazione nella società non è completa. I
primi chiedono il ritorno a uno stato di cose anteriore, vogliono rirovare la loro
supremazia e spezzare i vincoli che li tengono legati alla società colonizzatrice. Quanto
ai negri americani e agli ebrei borghesi, essi desiderano un’eguaglianza di diritti che
non implica affatto un mutamento di struttura nel regime di proprietà; voglio
semplicemente diventare partecipi dei privilegi dei loro oppressori, cioè, in fondo,
perseguono un’integrazione più completa” (Sartre, 1977, p. 86). Al contrario, il
rivoluzionario nega la nozione stessa di diritti, perché – e qui è d’aiuto il materialismo –
è consapevole del fatto che tale sistema di diritti è solo una costruzione arbitraria e
storica, che ha garantito dei vantaggi ad alcuni e oppressione e dolore ad altri.
Da questo punto di vista la filosofia rivoluzionaria deve aiutare il rivoluzionario ad
avere coscienza della sua libertà, che va oltre anche il “compito” di essere
rivoluzionari: “Questa possibilità di prendere le distanze da una situazione per assumere
si di essa un punto di vista (punto di vista che non è conoscenza pura, ma unità
indissolubile di comprensione e azione), è precisamente ciò che si chiama libertà”
(idem, p. 100).
Nella presentazione della rivista Les Temps modernes (raccolto nell’altro volume del
1947) Sartre precisa cià che intende per “responsabilità dello scrittore”: “Qualcuno
potrebbe consacrare la vita a scrivere romanzi sugli Ittiti; ma la sua astensione sarebbe
di per sé una presa di posizione. Lo scrittore è ‘in situazione’ nella sua epoca: ogni
parola ha i suoi echi. Ogni silenzio anche. Io ritengo Flaubert e Goncourt responsabili
della repressione che seguì la Comune perché non hanno scritto una riga per impedirla.
Non era affar loro, si dirà. Ma il processo di Calas era affare di Voltaire? La condanna
di Dreyfus era affare di Zola? L’amministrazione del Congo era affare di Gide?
Ciascuno di questi autori, in una circostanza particolare della vita, ha misurato la
propria responsabilità di scrittore. L’occupazione [nazista] ci ha insegnato la nostra”
(Sartre, 1976, p. 200).
Per quanto riguarda la situazione mondiale attuale Sartre scrive: “Il prossimo conflitto
richiederà un’attrezzatura industriale che il vecchio mondo nel suo insieme non è in
grado di fornire; due potenze mondiali, che non sono né l’una né l’altra borghesi, né
l’una né l’altra europee, si disputano il possesso dell’universo [questo è scritto un anno
prima che Aldous Huxley scrivesse 1984]; il trionfo dell’una significherebbe l’avvento
del socialismo di stato e della burocrazia internazionale; dell’altra, l’avvento del
capitalismo astratto. Tutti funzionari? Tutti impiegati?” (idem, p. 226). Per questo,
scrivendo, Sartre si dà questo compito, apparentemente paradossale: “In una parola,
dobbiamo nei nostri scritti militare a favore della libertà dell’individuo e della
rivoluzione socialista” (idem, p. 246; sottolineatura di Sartre). E conclude: “In
particolare, tutto è perduto se vogliamo scegliere tra le potenze che preparano la
guerra”. La scelta, in altre parole, si deve costruire – si noti che qui siamo ancora sette
anni prima della costituzione del Fronte dei Non-Allineati a Bandung nel 1955.
A ridosso della Dichiarazione universale dei diritti umani, Jacques Maritain pubblica
nel 1951 le lezioni del 1949 a Chicago (Maritain, 1992), in cui affronta una serie di
questioni filosofiche, giuridiche e politiche al luce del tomismo democratico e postmoderno, contro il nazionalismo e per un’autorità politica mondiale, al cui centro stia il
diritto naturale (i diritti umani si scoprono nel farsi della storia). A livello
internazionale, nella filosofia politica sul diritto internazionale il problema di a chi
spetti la sovranità è stato posto da Edmunds, Jellinek e altri – e qui Maritain tenta di
smascherare lo stato che esercita il potere assoluto in nome del popolo, con tutte le
distorsioni e i vizi che questo comporta, mostrando la contraddittorietà soprattutto per
gli stati democratici, dove si presume che sì, lo stato governi nel nome del popolo, ma
che dovrebbe anche essere, ma il più delle volte concretamente non è, soggetto al
controllo del popolo: “Ma se lo Stato è responsabile e sottoposto al controllo del
popolo, come può essere sovrano?” (idem, p. 61, e poi di nuovo a p. 76, le elezioni,
etc.). E propone di buttar via insieme i concetti di sovranità e di assolutismo “forgiati
sulla stessa incudine” (idem, p. 62). Tanto la democrazia può essere contraddittoria da
rischiare di essere perfino inutile, sottolinea Maritain citando Emile Giraud: “La
democrazia può essere impacciata, inetta, incoerente, esposta a tradirsi da sola cedendo
all’istinto della fiacchezza o a quello della violenza oppressiva. Può meritare il severo
giudizio che sulle sue capacità in materia di politica estera fu pronunciato dal giurista
francese Emile Giraud, già consigliere giuridico alla Società delle Nazioni, il quale
scrisse sul periodo 1919-1939 un libro intitolato La nullità della politica internazionale
delle grandi democrazie” (idem, p. 70). E cita Gandhi (che riconnette a S. Tommaso),
per la “guerra spirituale” la Satyagraha, la difesa della verità, che va al di là degli altri
mezzi che il popolo ha per controllare lo stato, come la libertà di stampa, di
associazione, etc. (idem, p. 80). In questo volume Maritain affronta anche il tema
dell’unificazione politica del mondo (pp. 222 e ss.) – l’idea di World Government che
nasce dalla Scuola di Chicago, per garantire la pace. Maritain considera che il mondo di
oggi è interdipendente, economicamente prima che politicamente – ma da queste
interdipendenza può scaturire sia più riavvicinamento nella famiglia umana, sia una
nuova stagione di lotte (accenna alla questione della bomba atomica). Maritain cita poi
il giurista belga Fernand de Visscher, che si preoccupa dalla amoralità dello stato
moderno, e ne teme le mosse in un ambiente internazionale anarchico – Maritain
approfitta per risalire fino a Hegel in questa concezione, che sostiene essere errata,
dello stato-individuo sovrano. Uno stato, nell’ambito internazionale, trova il limite nella
forza bruta degli altri stati – è poca cosa quel che può fare l’ONU: “In pratica gli Stati
moderni, per quanto attiene alle relazioni intenazionali, agiscono in una sorta di spazio
vuoto, come delle entità supreme e adamantine, trascendenti e assolute” (idem, p. 228).
Dunque, Maritain è a favore della creazione di un’autorità politica mondiale, fonte di
pace e di giustizia, dotato di una costituzione mondiale (fa riferimento al Piano
Hutchins, o Piano di Chicago, a cui collaborarono anche Giuseppe Borgese e Ch.
McIlwain: idem, p. 235). Ma più che un super-impero, Maritain immagina
un’organizzazione politica di tipo federale degli stati, che ha più chance di essere
democratico (idem, p. 241).
Nel 1947 mentre Horkheimer scrive Eclissi della ragione, Heidegger torna a farsi
sentire con la Lettera sull’umanesimo – in cui dichiara che il suo esistenzialismo non è
un umanesimo – e prosegue la sua Kehre verso il linguaggio con Sentieri interrotti del
1950. Al contrario, impegnatissimi nell’agone culturale sono Adorno e Horkheimer
che, con Dialettica dell’Illuminismo, finito a Los Angeles nel 1944, ma pubblicato da
Querido ad Amsterdam nel 1947, pubbliccano il libro manifesto della Scuola di
Francoforte (l’Institut fur Sozialforschung) che i due autori, insieme a Friedrick
Pollock, avevano già creato prima della Seconda guerra mondiale a Francoforte e che
adesso rimettono in piedi. Il programma è immediatamente legato alla situazione del
dopo-guerra e l’inizio della guerra fredda, cioè, la logica dei due schieramenti
contrapposti e pronti a rinnovare il conflitto su scala mondiale. La teoria critica è a
favore dei “residui di libertà, delle tendenze verso un umanesimo, anche se questi
sembrano impotenti di fronte alla grande dinamica storica” (così i due autori nella
prefazione all’edizione tedesca del 1969). La critica all’intelligentzia è totale,
equiparata alla “ostilità allo spirito”; il tentativo è esplicito: mantenersi fedeli allo
spirito critico e di emancipazione dell’Illuminismo, senza avanzare verso il positivismo,
cioè, “il mito della pura fattualità”; la paura è che tutto il mondo si integri in modo
totale, come nell’utopia catastrofica di 1984 di Aldous Huxley. Peraltro, il mondo
tecnologicamente avanzato, l’“apparato” e l’industria culturale sono una trappola
eccellente: “Il singolo, di fronte alle potenze economiche, è ridotto a zero. Queste, nello
stesso tempo, portano a un livello finora mai raggiunto il dominio della società sulla
natura. Mentre il singolo sparisce davanti all’apparato che serve, è rifornito da esso
meglio di quanto non sia mai stato” (idem, p. 7; pur nella grande diversità di ispirazione
e di tendenze, analoghi pensieri si ritrovano sia in Ortega y Gasset, sia in Heidegger).
Nel ’49 il sociologo Thomas H. Marshall tiene un ciclo di conferenze all’Università di
Cambridge facendo focus su questioni che diventeranno caratterizzanti la nuova
concezione del Welfare State, e cioè quelle legate alla concezione dei diritti civili,
politici e sociali in regime democratico (i diritti umani erano stati appena ri-affermati
nella Dichiarazione universale del ’48). La riflessione di Marshall sulla povertà come
negazione dei diritti sociali è fondamentale per allargare la comprensione della
democrazia nella nuova epoca subentrante, caratterizzata dalla Guerra Fredda.
L’educazione, come la salute, oltre al lavoro e alla casa, viene ora concepita come un
diritto, alla stessa stregua della libertà di movimento, di riunione, di espressione e di
voto politico (Marshall, 2002).
George Kennan, conoscitore di cose sovietiche, aveva diffuso negli USA la
convinzione che “il Cremlino fosse ormai impegnato nella realizzazione di un disegno
di dominazione mondiale” che andasse al di là della comunistizzazione dei soli paesi
dell’Est europeo (Mammarella, 1992, pp. 113-114). Tuttavia, la visione di Kennan non
era che l’URSS si stesse già dirigendo alla conquista militare dell’Europa, ma che
fossero piuttosto i partiti comunisti dell’Europa che si stessero mobilitando per
l’avvento del dominio comunista, e pertanto suggeriva agli USA la politica del
“contenimento” di qualsiasi tentativo, diretto o indiretto, di sovietizzazione
dell’Europa.
Questa concezione si dimostrerà molto produttiva, perché innescherà nuove riflessioni
sui diritti e i doveri, la cittadinanza e lo stato, la fruizione di un servizio e il suo
fornitore. Nella nuova ottica del Welfare State, l’educazione diventa un diritto, ovvero
un bene che è dovere dello stato fornire e diritto del cittadino fruire. Il Welfare State è il
nuovo paradigma, derivante in parte dall’approccio paternalistico di Bismarck, in parte
dal New Deal post-crisi del ’29, con cui gli stati occidentali tentano di modulare e
mitigare il capitalismo; pertanto, esso si sposa bene con gli ideali post-bellici di
democrazia parlamentare. Non solo l’educazione, ma anche la salute, la casa e perfino
il lavoro diventano diritti del cittadino, insieme alla libertà politica e di opinione; lo
stato viene ritenuto depositario del potere di soddisfare tali diritti. Lo sviluppo diventa
l’idea-chiave, insieme a quella di benessere (welfare) per inquadrare i processi di
riproduzione della vita materiale; esso può essere garantito solo attraverso la crescita
economica, a sua volta frutto ed effetto della costituzione di un “capitale umano”
appositamente formato per rispondere alle necessità dell’economia. In questo
framework l’educazione è un ingranaggio con una funzione specifica: quella di creare il
“capitale umano”, risultato e premessa del nuovo giro di sviluppo/benessere, in cui
includere, pian piano, tutti gli strati sociali. È con questa concezione che le
Organizzazioni internazionali, dalla Banca mondiale all’UNESCO all’UNDP, si sono
avviate a realizzare, stimolando e coadiuvando i vari governi, il piano di sviluppo
mondiale del Dopoguerra, e fino ad oggi.
Ai problemi della democrazia Hans Kelsen tornerà negli anni dell’esilio, negli USA
dalla cattedra della Harvard, e precisamente nella Parte Seconda della sua Teoria
generale del diritto, dedicata appunto allo Stato. In questa Parte, un intero capitolo, il
IV, è dedicato a Le forme di governo: democrazia ed autocrazia. Qui Kelsen nutre una
tripletta di obiettivi fondamentale: la ‘purezza’ del diritto rispetto alla sociologia, da un
lato, e all’etica, dall’altro; la supremazia, e al tempo stesso la neutralità, del diritto
rispetto allo Stato; e l’idea, veramente cardine, della sistematicità di ogni singola norma
rispetto all’ordinamento a cui appartiene (e questo sarà il punto più sottolineato da
Bobbio. In quanto tecnica sociale specifica, per Kelsen il diritto ha un suo modo
proprio ed autonomo di funzionare: esistono delle norme primarie e norme secondarie,
il tutto ruotando attorno al concetto di monopolizzazione dell’uso della forza da parte
dello Stato, forza che viene usata erogando, nei modi previsti, una sanzione; decisivo,
però, è il passaggio nel quale si afferma che il funzionario statale nel momento e nella
misura in cui questo funzionario conosce un illecito ha l’obbligo di porvi riparo. In
breve: “Il diritto è un’organizzazione della forza”: idem, p. 21). L’intento dell’opera,
all’indomani dell’immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale e del nazi-fascismo
(si noti che la prefazione è datata aprile 1944, quindi, ancora le bombe atomiche USA
non erano state sganciate Hiroshima e Nagasaki), è quella di porre le basi per
l’impossibilità futura di trasformare nuovamente una democrazia in una dittatura. Il
riferimento teorico principale di Kelsen rimane il positivismo giuridico insieme
all’approccio comparativo, mentre l’interlocutore privilegiato è la tradizione
giurisprudenziale analitica (John Austin; ma anche i ‘continentali’ come Eugen
Ehrlich). Di pieno spirito è la seguente affermazione di Kelsen, che troviamo nella
Parte Prima, dedicata al diritto: “Se possono qualificare come ‘comandi’ le leggi
democratiche, soltanto se si ignora il rapporto fra gli individui che emanano il comando
e quelli ai quali tali comandi sono diretti, se si assume soltanto un rapporto fra questi ed
il ‘comando’, considerato come una autorità impersonale ed autonoma. Questa è
l’autorità della legge, al di sopra delle persone singole che sono comandate o che
comandano. L’idea che la forza vincolante promana non già da un qualche essere
umano che comanda, ma dal ‘comando’ impersonale e anonimo. In quanto tale, è
espressa nelle famose parole non sub homine, sed sub lege. Se si include nel concetto di
comando una relazione di superiorità e inferiorità, allora le regole di diritto sono dei
comandi soltanto se si considera l’individuo da esse vincolante come soggetto alla
regola. La norma è un ‘comando’ impersonale ed anonimo” (idem, p. 36).
La parte relativa alla democrazia si trova nella Parte Seconda, dove si parla dello Stato
(che può avere una costituzione rigida o flessibile: idem, pp. 264-265, differenza
fondamentale, approfondita ai nostri giorni da Luigi Ferrajoli). Per Kelsen, la divisione
dei poteri non è un tratto per essenza democratico, l’unico vero tratto essenzialmente
democratico essendo che tutto il potere resta concentrato nelle mani del popolo, sia
nella versione diretta di tale affidamento, sia nella versione indiretta (qualora quella
diretta non fosse attuabile) (idem, pp. 287-288).
In questa Parte Seconda, Kelsen entra nel cuore della teoria politica, costituito dalla
classificazione dei governi. A seconda delle costituzione, i governi possono essere
essenzialmente di due tipi: monarchia o repubblica, dato che l’aristocrazia, annoverata
da Aristotele come una terza possibilità, è fondamentalmente una repubblica. Ora, una
repubblica può essere democratica. Infine, uno Stato può essere autocratico se in esso
prevale il potere di un solo individuo, il dittatore (a me pare che Kelsen non faccia
differenza fra Stato e governo). I tratti caratteristici della democrazia sono per Kelsen il
rispetto della liberà dell’individuo; l’idea di libertà, riconosce però Kelsen, si è evoluta
nel tempo, e si è andata affinando per sempre meglio confacersi con le varie e mutevoli
esigenza della vita democratica; infatti, il vivere insieme comporta comunque una
limitazione della libertà individuale – il problema diventando come conciliare il
massimo di auto-determinazione con la stessa convivenza sociale (idem, p. 291). Il
primo problema che ci viene incontro, infatti, è quello della necessaria limitazione della
libertà per mezzo del principio di maggioranza, l’altro principio che anima il governo
democratico. Questo principio porta con sé l’idea di eguaglianza, così come, anche,
quello di rispetto dei diritti della minoranza: così, qui si fanno avanti gli stessi problemi
che Kelsen aveva già affrontato nei saggi precedenti che abbiamo già visto: il nesso
strettissimo fra democrazia e liberalismo, l’arte del compromesso in democrazia e,
infine, la dicotomia fra democrazia diretta e democrazia indiretta (o rappresentativa),
che per Kelsen è più o meno una finzione (idem, p. 294). Infatti, il sistema della
rappresentatività passa attraverso tutto il meccanismo delle votazioni, e quindi dei vari
sistemi elettorali (proporzionale o maggioritario, e varie varianti), i sistemi uni- o bicamerali, il funzionamento delle iniziative popolari, come il referendum, infine, il
sistema dei partiti (idem, pp. 295-304). Poi con Oppenheim e Nussbaum, Kelsen tratta i
vari aspetti del diritto internazionale (incluso il commercio e la guerra).
Nell’opera capo-fila della scuola del realismo delle Relazioni Internazionali, Politics
Among Nations, del 1948, Hans Morgenthau pone i suoi sei princìpi secondo i quali si
svolge la vita politica internazionale: 1. la politica è governata da leggi oggettive, che
derivano dall’immutabile natura umana; 2. il concetto di interesse, definito in termini di
potere, permette una comprensione razionale della politica (senza, tuttavia, escludere
gli aspetti irrazionali); 3. l’interesse-potere varia nel tempo, in quanto dipende dalle
circostanze; 4. i principi morali non possono essere applicati astrattamente alle relazioni
fra gli stati, dove vige una razionalità assolutamente concreta e circostanziale: un
governo non può concedersi di disapprovare o evitare la violazione di qualche principio
morale astratto, pena il rischio di mettere a repentaglio la sua stessa sopravvivenza; 5.
le aspirazioni morali di uno stato (pace, giustizia) non possono essere identificate con il
bene universale, ma solo con il perseguimento dell’interesse di quello stesso stato,
sempr definito in termini di potere; 6. al di là delle pluralità delle dimensioni
dell’uomo, il realismo politico privilegia la sfera politica come la principale tra le
molteplici sfere di interesse umano, e la distingue in special modo da quella morale per
riuscire a studiare in termini oggettivi, scientifici la politica.
Lo stesso tipo di studi internazionali, di diritto, economia e politica, ma dal punto di
vista dell’America Latina, sono al centro dell’interesse scientifico dell’economista
argentino Paul Prebish. L’Argentina, che da paese creditore, anche di potenze come la
Gran Bretagna, comincia a diventare debitore nel dopo-guerra, lo porta ad ipotizzare
quella che poi diventerà la “teoria della dipendenza”, ovvero la teoria centro-periferia
(Wallerstein, Amin, Arrighi, Franck). Con le sue osservazioni sul commercio mondiale
Prebish cominciò a porre in relazione l’arricchimento
delle aree mondiali
maggiormente sviluppate con il sotto-sviluppo delle aree mondiali sfruttate, che
diventavano come “la grande periferia” del mondo.
Conclusioni
Parte II:
De esta parte se deriva el conocimiento de que:
-
en las primeras tres décadas del siglo XX el mundo se divide en tres
categorías: los países fuertes y libres (imperios - y luego estados - en Europa,
los EE.UU., y Japón), los países formalmente independientes pero débiles
(China, Tailandia y América del Sur) y los colonizados (todos los de Asia,
excepto China y Tailandia, y el conjunto de África);
-
en los primeros países se forman, junto con los partidos liberales y los
monárquicos, los partidos socialdemócratas, socialistas y comunistas, pero son
saboteados en muchos aspectos, legales o ilegales (Japón, Italia, Alemania, en
particular);
-
quién coloniza, de un modo u otro, son los países formalmente democráticos y
liberales: Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Portugal y
España - en orden de poder - y los EE.UU., el poder etno-democratico por
excelencia. Ellos hacen su aparición en la escena internacional como una
potencia de primer orden, por primera vez en el sistema interamericano, a
continuación, sobre todo después de la primera guerra mundial, en todo el
mundo;
-
comienza en los EE.UU. (con W.E.B. DuBois en 1909) un gran movimiento
de redención cultural y política de la población africana, que tendrá un
significado importante para el desarrollo de la democracia global en las
próximas décadas; a partir de aquí empezan movimientos políticos que traen
la independencia de los países africanos después de la Segunda Guerra
Mundial;
-
con la Revolución de Octubre, Lenin hace viver la esperanza de los partidos
socialistas y comunistas de ver elevarse a un nuevo modelo de Estado, a la
redención y la emancipación de la clase obrera, pero esta esperanza pronto se
verá frustrada por la política de “socialismo en un solo país” posteriormente
presentada por Stalin;
-
incluso el mundo árabe-musulmán, aplastado por el colonialismo europeo,
trata de levantarse, por una parte, emulando a los más poderosos paises del
“West” (como lo hizo el Japón de la era Meiji), por otro lado, tratando de
seguir su propio camino a la modernidad originales (como ya había tratado de
hacer, pero sin éxito, China); esta oscilación es típica, sin embargo, de todo el
“Rest”: el mundo árabe-musulmán, el mundo africano al sur del Sahara, el
subcontinente indio, el mundo chino, el mundo japonés, y el mundo
latinoamericano;
-
después de la primera guerra mundial los imperios europeos y el imperio
Otomano terminan a sus vidas, pero se mantiene en pie su colonialismo;
-
la democracia EE.UU. se estabiliza con el bi-polarismo (el Partido
Republicano, de centro-derecha, y el Partido Democrático, de centroizquierda), un patrón que persiste hasta nuestros días. En las décadas
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, asistimos no sólo a una marginación
de los partidos políticos de menor importancia y de los sindicatos, sino
también el florecimiento de las actividades políticas y sociales no oficial (no
partidista) y una creciente no-participación electoral;
-
importantes conceptualizaciones emergen, con definidos partidos políticos
como los de Lenin, Stalin y Mao, por una parte, y Roosevelt y Churchill
(Kennan y Morgenthau), por el otro; hay también una orientacion pacifista de
Gandhi, y una tendencia más doctrinal de la teoría política: la de Schumpeter,
Kelsen, Karl Polanyi, Raúl Prebisch, Adorno y Horkheimer, Popper, Gramsci,
Mariateguí, Berdjaev, Nishida, Croce, Maritain, Carl Schmitt, Sartre, Keynes,
Wittgenstein, Sraffa, Gini, Ortega Y Gasset, Russell, Weber, Hotelling, Taha
Hussein, Rashid Rida, Gorki, Senghor, Porfirio Díaz, Cárdenas, Getulio
Vargas, Perón, De Gaulle, al- Mawdudi;
-
la educación, que había alcanzado en la Segunda Guerra Mundial su apogeo
como la “educación de la nación”, se invierte, inmediatamente después de la
guerra, con la misión internacional de paz por el renacer de las Naciones
Unidas (UNESCO).
Bibliografia
Aboites Aguilar L. (2007). El ultimo trano, 1929-2000. In Nueva historia minima de
México. México: El Colegio de México, pp. 262-302.
Albonico A. (1982). America Latina. Tra nazionalismo, socialismo e imperialismo.
Milano: Marzorati.
Almond G. (2005). Cultura civica e sviluppo politico. Trad. it. Bologna: Il Mulino.
Aquino R.S.L. et al. (2000). Sociedade brasileira: uma historia atraves dos
movimentos sociais. Da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo. Rio de
Janeiro, Sao Paulo: Record.
Arkoun M. (1995). La filosofia araba. Trad. it. Milano: Xenia.
Berdjaev N. (1992; ed or 1946). L’idea russa. I problemi fondamentali del pensiero
russo (XIX e inizio XX secolo). Trad. it. Milano: Mursia.
Buchanan J.M., Tullock G. (1998; ed. or. 1962). Il calcolo del consenso. Fondamenti
logici della democrazia costituzionale. Trad. it. Bologna: Il Mulino.
Carmagnani M. (2003). L’altro Occidente. L’America Latina dall’invasione europea al
nuovo millennio. Torino: Einaudi.
Coquery-Vidrovitch C. (2012). Breve storia dell’Africa. Trad. it. Bologna: Il Mulino.
Coquery-Vidrovitch C., Moniot H. (1977; ed. or. 1974). L’Africa Nera dal 1800 ai
nostri giorni. Trad. it. Milano: Mursia.
Collotti Pischel E. (1982; ed. or. 1972). Storia della rivoluzione cinese. Roma: Editori
Riuniti.
Collotti Pischel E. (1999, 2a ed.). Storia dell’Asia orientale. 1850-1949. Roma:
Carocci.
Dasgupta S. (2006; ed or 1922). A History of Indian Philosophy. Delhi: Motilal
Banarsidass.
Fromm E. (1963; ed or 1941). Fuga dalla libertà. trad. it. Milano: Edizioni di
Comunità.
Gallino L. (2009). Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procura contro l’economia.
Torino: Einaudi.
Gandhi M. (1996). Teoria e pratica della non-violenza. Trad. it. Torino: Einaudi.
Gandhi M. (2006). Antiche come le montagne. Trad. it. Milano: Mondadori.
Garciadiego J. (2008). La revolucion. In Nueva historia minima de México. México: El
Colegio de México, pp. 225-261.
Gramsci A. (1979). Quaderni dal carcere. Vol. I: Il materialismo storico. Roma:
Editori Riuniti.
Gramsci A. (1979). Quaderni dal carcere. Vol. II: Gli intellettuali. Roma: Editori
Riuniti.
Gramsci A. (1979). Quaderni dal carcere. Vol. III, Note sul Machiavelli. Roma: Editori
Riuniti.
Hall M.K. (2003). La guerra del Vietnam. Trad. it. Bologna: Il Mulino.
Von Hayek F. 1944 (tr. it. La via della schiavitù, Liberilibri, Macerata, 2011, The Use
of Knowledge in Society, 1945.
Von Hayek F. Individualism: True and False, 1949 (tr. it. Individualismo: quello vero e
quello falso, Rubbettino Editore, 1997)
Hobson J.A. (1974; ed or 1902). L'imperialismo. Trad. it. Milano.
Horkheimer M., Adorno T.W. (1974). Dialettica dell’illuminismo. Trad. it. Torino:
Einaudi.
Jones M.A. (2000; ed. or. 1982). Storia degli Stati Uniti d’America. Dalle prime
colonie inglesi ai giorni nostri. Nuova edizione aggiornata. Trad. it. Milano: Bompiani.
Kelsen H. (2004), La democrazia. Trad. it. Bologna : Il Mulino.
Kelsen H. (1994; ed or 1945). Teoria generale del diritto e dello Stato. Trad. it. Milano:
Etas Kompass.
Keynes J.M. (2006; ed or 1936). Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della
moneta. Trad. it. Torino, UTET.
Lee S.H. (2003). La guerra di Corea. Trad. it. Bologna: Il Mulino.
Lenin (1948). Opere scelte. 2 voll. Mosca.
Mammarella G. (1992). Storia d’Europa dal 1945 a oggi. Bari-Roma: Laterza.
Mao Tse Tung (1977). Opere. Trad. it. Milano: Newton Compton.
Maritain J. (1980; ed or 1934). Umanesimo integrale. Trad. it. Roma: Borla.
Maritain J. (1992; ed or 1951). L’uomo e lo Stato. Trad. it. Milano: Massimo-Vita e
Pensiero.
McIlwain C.H. (1990; ed or 1947). Costituzionalismo antico e moderno. Trad. it.
Bologna: Il Mulino.
Von Mises F. (1912). Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel.
Von Mises F. (1919). Nation, Staat und Wirtschaft (trad. it. Stato, nazione ed economia,
Bollati e Boringhieri, Torino 1994).
Von Mises F. (1922). Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus
(trad. it. Socialismo, Rusconi, Milano 1990).
Von Mises F. (1927). Liberalismus (trad. it. Liberalismo, Soveria Mannelli: Rubbettino,
1997).
Von Mises F. (1928). Geldwertstabilisierung und Konjunturpolitik (trad. it. La
stabilizzazione del potere di acquisto della moneta e la politica della congiuntura,
UTET, Torino 1935).
Von Mises F. (1929) Kritik des Interventionismus (trad. it. I fallimenti dello stato
interventista, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 1997).
Von Mises L. (1995; ed or 1944). Lo Stato onnipotente. Trad. it. Milano: Rusconi.
Von Mises L. (1946). Pianificazione economica collettivistica. A cura di F. Hayek.
Trad. it. Torino: Einaudi.
Von Mises L. (1959; ed or 1949). L'azione umana. Trad. it. Torino: UTET.
Mosca G. (1965; ed or 1933). Storia delle dottrine politiche. Bari: Laterza.
Nishida K. (2001, ed or 1937). Il corpo e la conoscenza. Trad. it. Venezia: Libreria
Editrice Cafoscarina.
Nishida K. (2007; ed or 1911). Uno studio sul bene. Trad. it. Torino: Bollati
Boringhieri.
Nishida K. (2005; ed or 1945). La logica del luogo e la visione religiosa del mondo.
Trad. it. Palermo: L’Epos.
Palou R. (1996). Abul a’la Mawdudi, penseur de l’Islam politique. Etudes, Juillet 1996.
Piketty T. (2012). Il capitale nel XXI secolo. Trad. it. Milano: Bompiani.
Polanyi K. (2000; ed or 1944). La grande trasformazione. Le origini economiche e
politiche della nostra epoca. Trad. it. Torino: Einaudi.
Riasanovsky N.V. (2003; ed. or. 1984). Storia della Russia dalle origini ai giorni
nostri. Nuova edizione aggiornata a cura di Sergio Romano. Trad. it. Milano:
Bompiani.
Salvadori, M. (2011). Democrazie senza democrazia. Bari-Roma: Laterza.
Sartre J.-P. (1976; ed or 1947). Che cos’è la letteratura? Trad. it. Milano: Il Saggiatore.
Sartre J.-P. (1977; ed or. 1947). Materialismo e rivoluzione. Trad. it Milano: Il
Saggiatore.
Schmitt C. (1998; ed or 1950). Il nomos della terra nel diritto internazionale dello ‘Jus
publicum europaeum’. Trad. it. Milano: Adelphi.
Schulze R. (1994). Il mondo islamico nel XX secolo. Politica e società civile. Trad. it.
Milano: Feltrinelli.
Schumpeter J. (2011). Passato e futuro delle scienze sociali. Trad. it. Macerata:
Liberilibri.
Schumpeter J. (2010). Il capitalismo può sopravvivere? La distruzione creatrice e il
futuro dell'economia globale. Trad. it. Milano: ETAS.
Schumpeter J. (2002). Teoria dello sviluppo economico. Trad. it. Milano: ETAS.
Schumpeter J. (2001). Capitalismo, socialismo e democrazia,. Trad. it. Milano: ETAS.
Speitkamp W. (2010). Breve storia dell’Africa. Trad. it. Torino: Einaudi.
Stalin J. (1952). Questioni del leninismo. Traduzione di Palmiro Togliatti. Roma:
Rinascita.
Villani P. (1993). L’età contemporanea. Bologna: Il Mulino.
Villari R. (1971). Storia dell’Europa contemporanea. Bari: Laterza.
Weber M. (1994). L’etica protestante e lo spirito del capitalismo. Trad. it. Milano:
Rizzoli.
Weber M. (1999). Economia e società. Trad. it. Milano: Comunità.