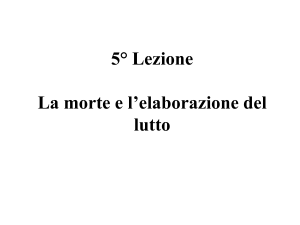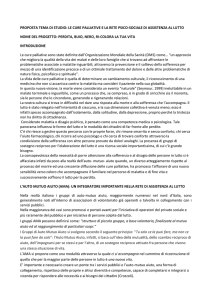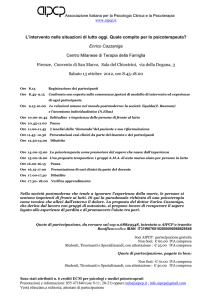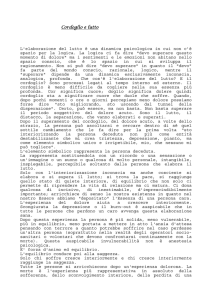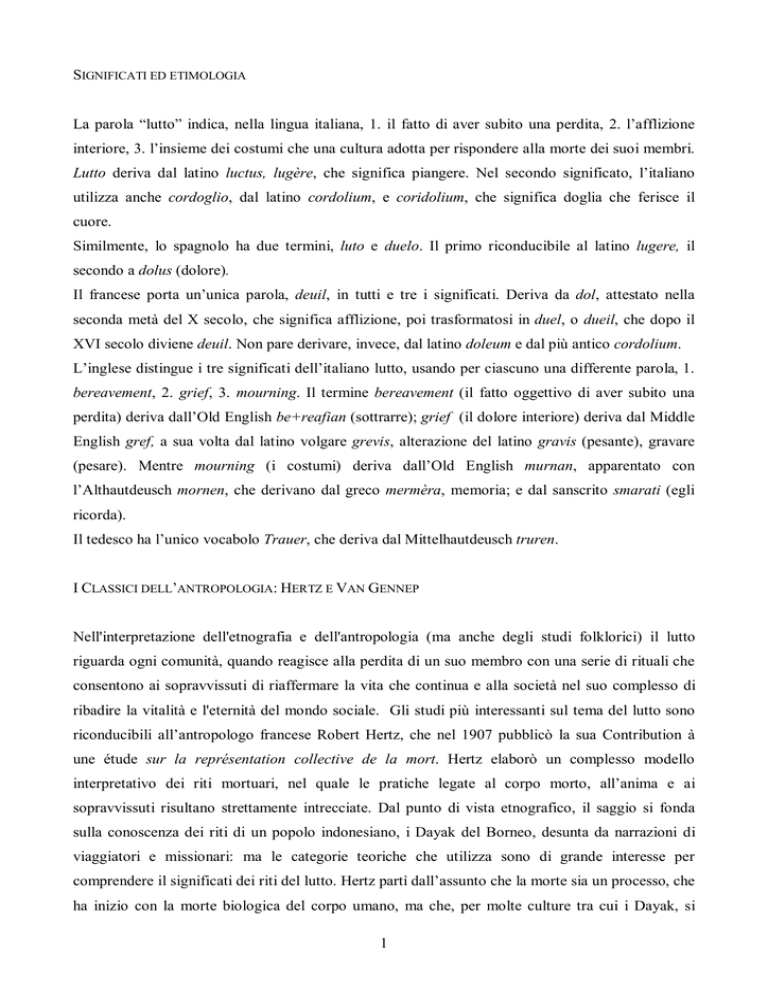
SIGNIFICATI ED ETIMOLOGIA
La parola “lutto” indica, nella lingua italiana, 1. il fatto di aver subito una perdita, 2. l’afflizione
interiore, 3. l’insieme dei costumi che una cultura adotta per rispondere alla morte dei suoi membri.
Lutto deriva dal latino luctus, lugère, che significa piangere. Nel secondo significato, l’italiano
utilizza anche cordoglio, dal latino cordolium, e coridolium, che significa doglia che ferisce il
cuore.
Similmente, lo spagnolo ha due termini, luto e duelo. Il primo riconducibile al latino lugere, il
secondo a dolus (dolore).
Il francese porta un’unica parola, deuil, in tutti e tre i significati. Deriva da dol, attestato nella
seconda metà del X secolo, che significa afflizione, poi trasformatosi in duel, o dueil, che dopo il
XVI secolo diviene deuil. Non pare derivare, invece, dal latino doleum e dal più antico cordolium.
L’inglese distingue i tre significati dell’italiano lutto, usando per ciascuno una differente parola, 1.
bereavement, 2. grief, 3. mourning. Il termine bereavement (il fatto oggettivo di aver subito una
perdita) deriva dall’Old English be+reafian (sottrarre); grief (il dolore interiore) deriva dal Middle
English gref, a sua volta dal latino volgare grevis, alterazione del latino gravis (pesante), gravare
(pesare). Mentre mourning (i costumi) deriva dall’Old English murnan, apparentato con
l’Althautdeusch mornen, che derivano dal greco mermèra, memoria; e dal sanscrito smarati (egli
ricorda).
Il tedesco ha l’unico vocabolo Trauer, che deriva dal Mittelhautdeusch truren.
I CLASSICI DELL’ANTROPOLOGIA: HERTZ E VAN GENNEP
Nell'interpretazione dell'etnografia e dell'antropologia (ma anche degli studi folklorici) il lutto
riguarda ogni comunità, quando reagisce alla perdita di un suo membro con una serie di rituali che
consentono ai sopravvissuti di riaffermare la vita che continua e alla società nel suo complesso di
ribadire la vitalità e l'eternità del mondo sociale. Gli studi più interessanti sul tema del lutto sono
riconducibili all’antropologo francese Robert Hertz, che nel 1907 pubblicò la sua Contribution à
une étude sur la représentation collective de la mort. Hertz elaborò un complesso modello
interpretativo dei riti mortuari, nel quale le pratiche legate al corpo morto, all’anima e ai
sopravvissuti risultano strettamente intrecciate. Dal punto di vista etnografico, il saggio si fonda
sulla conoscenza dei riti di un popolo indonesiano, i Dayak del Borneo, desunta da narrazioni di
viaggiatori e missionari: ma le categorie teoriche che utilizza sono di grande interesse per
comprendere il significati dei riti del lutto. Hertz partì dall’assunto che la morte sia un processo, che
ha inizio con la morte biologica del corpo umano, ma che, per molte culture tra cui i Dayak, si
1
protrae fino alla scheletrizzazione di quest’ultimo (o essiccazione, esposizione o anche cremazione):
fino a che, in altri termini, la parte «umida», putrescibile del corpo si sia consumata e abbia dato
luogo a resti «secchi», integri, immutabili. La progressiva metamorfosi del corpo putrescente
giustifica, in svariate culture, il ricorso alla «doppia sepoltura»: una prima collocazione provvisoria
viene assegnata al corpo in decomposizione, una seconda sistemazione definitiva ai resti. Un tempo
variabile trascorre tra la prima e la seconda sepoltura, ciascuna delle quali richiede una cerimonia. Il
tempo è, appunto, elemento indispensabile per poter metabolizzare la morte in una cultura umana:
esiste infatti, per Hertz, un parallelismo tra le vicende del corpo, quelle dell’anima del defunto, e
quelle dei sopravvissuti, o dolenti. Mentre il corpo completa la sua trasformazione per divenire
resto immutabile, l’anima compie il suo viaggio verso la sua destinazione finale, dove acquisirà un
nuovo status (presso i Dayak, quello di antenato e spirito protettore); nel frattempo, i fluttuanti si
trovano in una condizione di impurità, che deriva dal fatto che i parenti sopravvissuti del defunto,
soprattutto la vedova, sono indissolubilmente uniti al destino del morto. La cerimonia finale, infatti,
ha tre funzioni: dare ai resti la sepoltura definitiva, assicurare all’anima il riposo e l’accesso ai paesi
dei morti e infine sollevare i sopravvissuti dall’obbligo del lutto, liberarli dall’impurità e dai divieti
e reintegrarli pienamente nel mondo dei vivi.
Questa triplice correlazione tuttavia, affermò Hertz, non è sempre presente in modo completo: in
alcune culture (viene in mente quella vittoriana, se volessimo fare un esempio europeo), è previsto
un lungo periodo di lutto senza che vi sia l’usanza della doppia sepoltura.
Due anni dopo, nel 1909, Van Gennep diede alle stampe il suo libro Riti di passaggio. Van Gennep
considerò i funerali come una tipologia della più vasta categoria dei riti di passaggio, tra i quali va
annoverato anche il matrimonio o l’iniziazione alla vita adulta. Nel rito funebre si possono
individuare tre fasi: alla necessaria separazione dei vivi dal morto segue lo stadio di margine o
liminarità (tempo di lutto per i dolenti e tempo del viaggio dell’anima per il defunto). Infine, la fase
conclusiva è caratterizzata dall’aggregazione del defunto al mondo dei morti e dalla rinnovata
accoglienza dei dolenti nel contesto dei vivi. Il lungo processo di metamorfosi del morto verso la
condizione di antenato, cioè (e il corrispondente stato del dolente in attesa di essere riaggregato al
mondo dei vivi), viene concepito da Van Gennep come un periodo liminare (dal latino limen,
soglia), di sospensione. Anche per Van Gennep, dunque, la dimensione sociale del rito su cui gli
antropologi insistono è dunque indissolubilmente legata all’esigenza condivisa di lasciare passare
un certo tempo tra la morte e il ritorno alla normale quotidianità, affinché dolenti e comunità
possano affrontare nuovamente il mondo con fiducia dopo una perdita.
In questi “classici” dell’antropologia del lutto si parla, a proposito dei sopravvissuti dopo una
morte, di riti funebri, e non di “elaborazione del lutto”, concetto costruito dalla psicoanalisi e con
una connotazione prettamente occidentale, che ci apprestiamo a descrivere.
2
LA PSICOANALISI E LA PSICOLOGIA
La visione del lutto come processo di «guarigione psicologica», che si compie nell’interiorità
dell’uomo, non poteva avere altra culla che l’Occidente, che fin dal XIX secolo ha puntato a
valorizzare l’autonomia dell’individuo, la sua unicità, la sua creatività.
Alle origini ci fu l’opera di Sigmund Freud: nel 1917, nel breve saggio Lutto e melanconia, pur
distinguendo il lutto dalla depressione, egli pose al contempo in luce i punti comuni tra i due stati
psichici. Enucleò i sintomi di un lutto profondo, specificò in cosa consiste il «lavoro» o
«elaborazione» del lutto e contemplò la possibilità che il lutto divenga, in alcuni casi, patologico. Il
lutto comporta la «perdita di interesse per il mondo esterno», la «perdita della capacità di scegliere
un qualsiasi nuovo oggetto d’amore (che significherebbe rimpiazzare il caro defunto)»,
«l’avversione per ogni attività che non si ponga in rapporto con la sua memoria».
Il lavoro del lutto richiede, anche per Freud, tempo e dispendio di energia, ma nella sua ottica si
tratta del tempo e dell’economia psichica dell’individuo, e non è in gioco la collettività: è
necessario infatti un «esame di realtà», che dimostri al dolente «che l’oggetto amato non c’è più»,
affinché, lentamente, egli si convinca dell’esigenza «che tutta la libido sia ritirata da ciò che è
connesso con tale oggetto». Poiché «gli uomini non abbandonano volentieri una posizione libidica»,
può manifestarsi un’avversione per la realtà, un ripiegamento del dolente su se stesso:
l’elaborazione del lutto, in tal caso, si prolunga, fino a che non sia stipulato un doloroso
compromesso tra il riconoscimento della realtà della perdita e la necessità di ritornare alla vita
normale. Infatti, scrisse Freud, «la normalità è che il rispetto della realtà prenda il sopravvento».
Un lutto normale si risolve spontaneamente, secondo l’iniziatore della psicoanalisi, a patto che ci
siano il tempo e l’energia necessari per portare a termine il lavoro del lutto, che ha come esito lo
scioglimento del «proprio legame con l’oggetto annientato», ossia con il defunto.
Il lutto patologico, invece, può insediarsi nella psiche quando la relazione con il deceduto era
particolarmente ambivalente, intrisa d’odio inconscio: l’ambivalenza amore/odio, infatti, genera
senso di colpa nei confronti del morto, «conferisce al lutto una configurazione patologica e lo
costringe a manifestarsi sotto forma di autorimproveri secondo i quali il soggetto è responsabile –
ossia ha voluto – la perdita dell’oggetto d’amore».
Le successive parziali correzioni della teoria del 1917, operate da Freud e da Abraham, i quali
sottolinearono l’esistenza di un’identificazione e di un’introiezione del morto (il mettere i nostri
morti all’interno del nostro Io), accentuavano, se vogliamo, proprio la dimensione privata e
interiore del cordoglio. Altri psicoanalisti, come Melanie Klein, insisterono sull’interpretazione del
lutto come malattia della psiche, e del suo superamento come processo di faticosa ricostruzione del
3
mondo interiore, che richiede anche un riesame delle esperienze infantili, e il cui successo, in
sovrappiù, dipende dalla costituzione del soggetto.
La riflessione contemporanea, tuttavia, si fonda non tanto sulle teorie psicoanalitiche, quanto
sull’opera di
John Bowlby,
uno
psichiatra che
negli
anni
Cinquanta,
su
incarico
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, condusse una ricerca sulle condizioni psichiche dei
bambini costretti a vivere lontani dalla famiglia che lo portò a riflettere sulla perdita e sul lutto.
Il paradigma di Bowlby si differenzia da quello psicoanalitico, poiché contamina l’argomentazione
clinica di quest’ultimo con altri saperi: l’etologia, la biologia, la teoria dei sistemi e la psicologia
cognitiva. Egli intende descrivere gli elementi di un processo di lutto «normale».
Si tratta di una teoria molto nota, di uno schema studiato e utilizzato da tutti coloro che, oggi, si
occupano di sostegno al lutto e di counseling. Partendo dai dati di una ricerca sociale condotta dal
collega e amico Colin Murray Parkes, Bowlby individuò quattro fasi psichiche che caratterizzano la
risposta a una perdita importante:
a) la prima fase è di stordimento, di incredulità di fronte alla notizia della morte. b) segue la fase di
ricerca e struggimento per la persona perduta, che si accompagna alla presa d’atto episodica, non
ancora definitiva, della realtà della morte. Dolore e pianto caratterizzano questo stadio, insieme a
insonnia e preoccupazione. c) la fase di disorganizzazione e disperazione è quella nella quale si
attraversa l’insieme delle emozioni violente e dolorose in parte già ricordate e si comincia a
tollerarle, a riconoscere che la perdita è definitiva e che non si può far altro che lasciare alle spalle
gli stili precedenti di pensiero e azione per inventarne altri, e riformare e adattare la propria vita alla
nuova situazione. Poiché tale compito è arduo, e prima di trovare un nuovo adattamento il dolente
deve abbandonare quello passato, non è inconsueto che egli si senta solo, privo di punti di
riferimento e che sprofondi nella depressione. d) infine, se il lutto imbocca la strada giusta, segue la
fase della riorganizzazione, nella quale, appunto, il dolente compie quei cambiamenti che lo
conducono a un nuovo adattamento all’esistenza.
Le fasi del lutto individuate da Bowlby non si susseguono sempre cronologicamente e non sempre
tutte le manifestazioni sono presenti: tuttavia, il loro apparire segnala che il lutto si sta svolgendo in
modo normale. Pertanto, egli ritiene che siano in errore coloro che, di fronte ai sintomi da lui
individuati, li interpretino come patologici, immaginando che il lutto normale debba essere breve e
indolore. Il principale limite della teoria delle fasi di Bowlby consiste nel fatto che, immaginando di
descrivere un processo «naturale», che trova il suo fondamento nella biologia e nella teoria
evoluzionista, egli non si rende conto che il lutto «normale» è tale – forse – solo nel contesto della
cultura da lui analizzata. Egli restò, così come il collega Parkes, sempre convinto che, malgrado le
enormi differenze riscontrabili nei costumi sociali del lutto, le reazioni individuali dell’uomo alla
perdita siano le stesse, naturali, universali e originarie.
4
PSICOLOGI E ANTROPOLOGI: RIPENSAMENTI
Più recentemente, psicologi più attenti all'antropologia, come Paul Rosenblatt, hanno dimostrato
che non solo variano le manifestazioni delle emozioni, ma differiscono le stesse emozioni, le quali
sorgono all'interno di un contesto culturale, e non prima e indipendentemente da questo. Rosenblatt
ha voluto studiare le reazioni delle altre culture di fronte alla perdita, sia al fine speculativo di
sottoporre a vaglio critico le teorie occidentali sul lutto, sia con lo scopo pratico di dare indicazioni
ai counsellor che operano nella società multiculturale.
Secondo Rosenblatt, gli studiosi che enfatizzano le similitudini tra tutti gli esseri umani si
riferiscono al fatto, indiscutibile, che la morte di un congiunto porta con sé un forte impatto
emotivo, tristezza e sconvolgimento. Tuttavia, non ci sono prove che l’umanità affronti la morte
nello stesso modo in culture differenti: pertanto, è più corretto partire dal presupposto della
diversità. Dai resoconti degli antropologi, infatti, si possono desumere comportamenti dissimili, che
riguardano svariati aspetti della reazione alla perdita. In primo luogo, non tutte le culture ritengono
adeguata l’estrinsecazione delle medesime emozioni di fronte alla morte. Vi sono culture che
privilegiano l’espressione del dolore e altre che ritengono appropriata la manifestazione di rabbia,
così come ve ne sono che richiedono ai propri membri di piangere e altre di avere un saldo controllo
delle proprie emozioni. Per esempio, l’antropologa Unni Wikan, che ha paragonato le reazioni al
lutto in due comunità musulmane, Bali e gli slum del Cairo, in Egitto, ha affermato che a Bali
l’espressione di emozioni forti è considerata pericolosa per la salute individuale e collettiva, poiché
rende l’intera comunità vulnerabile di fronte ai malefici; viceversa, nella cultura cairota, di fronte a
una perdita importante, è considerato normale restare immersi, anche per anni, in una profonda
depressione. L’idea che le emozioni siano culturalmente condizionate è condivisa dalla maggior
parte degli antropologi, da Clifford Geertz a David Le Breton.
Anche i sociologi Clive Seale e Tony Walter affermano che non esistono culture ove le emozioni
del lutto siano naturali e naturalmente espresse: ogni società costruisce socialmente le emozioni dei
propri membri, stabilendo il campo delle possibilità più o meno rigidamente.
L’antropologia, dunque, ha fornito importanti stimoli per ripensare sia la tesi dell’unità psichica
dell’uomo, sia il modello culturale del lutto come processo di elaborazione e come «lavoro»
individuale. In particolare, come afferma Dennis Klass, l’antropologia contemporanea ha superato
la netta dicotomia universalismo/relativismo psichico, mediante la tesi secondo cui la mente umana
si sviluppa all’interno di ricche interazioni, in una complessa dialettica e scambio tra esperienza
umana e formazione di modelli culturali.
5
Vi è stato dunque un ripensamento all'interno della psicologia, che ha smesso di guardare alle
proprie categorie come a degli assoluti, ma le ha problematizzate. In particolare, in un numero
dell’American Behavioral Scientist, del 2001, interamente dedicato al lutto, si sono confrontati i più
importanti ricercatori europei ed americani, mettendo in discussione le nozioni più radicate della
psicologia del lutto, a partire da quella, criticata da George Bonanno, di «elaborazione del lutto». La
critica di Bonanno si appunta inoltre alla distinzione tra lutto normale e lutto patologico, al ruolo
dell’espressione delle emozioni nella risoluzione del lutto, alla visione del legame con il morto (è
sempre progressivo rompere i legami con il defunto o è meglio piuttosto continuare a tenerli vivi?).
Il saggio conclusivo, della studiosa olandese Margaret Stroebe, tenta di sintetizzare le osservazioni
di tutti e di fissare alcuni punti fermi, che possano servire per un ulteriore approfondimento della
ricerca. Qualche riferimento ci permetterà di esemplificare la direzione dei ripensamenti.
In primo luogo, Stroebe riafferma l’efficacia del concetto di elaborazione del lutto. Le critiche, per
esempio quella che deriva dalla prospettiva interculturale, non vanno sottovalutate, anzi devono
essere assorbite dalla riflessione. Tuttavia, ella afferma, il concetto di elaborazione va difeso perché
utile dal punto di vista operativo. Ma una seria ricerca è ancora da fare, soprattutto per quanto
riguarda la separazione che va operata tra i processi che si rivelano costruttivi all’interno del
processo di elaborazione del lutto e quelli non costruttivi. Quando Stroebe dice «costruttivo»
intende dire latore di benessere fisico e mentale per il dolente. E, certamente, costruttivo è ciò che
contribuisce a uno scioglimento del dolore della perdita, come richiesto dalla nostra società: Stroebe
si colloca all’interno del paradigma occidentale. Tuttavia, ella sostiene l’utilità di avviare ricerche
che permettano di andare oltre gli stereotipi teorici della psicoanalisi, per comprendere meglio le
esigenze dei dolenti. In sintesi, la nozione di «elaborazione del lutto» deve trasformarsi da concetto
generale ad analisi particolareggiata del processo, valutandone le componenti cognitive ed emotive
e facendo tesoro, al contempo, dell’esperienza clinica e dei risultati della ricerca sociale.
Per esempio, è auspicabile esprimere il dolore, la rabbia e la disperazione nel lutto? Bonanno e
Field hanno mostrato che spesso il fatto che il dolente palesi le emozioni negative è sintomo di una
difficoltà di adattamento, che può manifestarsi anche nel lungo periodo (5 anni): la loro ricerca può
servire come richiamo alla prudenza per coloro che tendono a considerare sempre positivamente
l’espressione di sentimenti.
Che dire poi del frequente tentativo delle persone in lutto di sfuggire al dolore, di sottrarsi al
pensiero della morte? Se il diniego estremo della perdita è nocivo, perché ritarda la presa di
coscienza dell’accaduto, talvolta un parziale evitamento, o una distrazione dal lutto, possono essere
funzionali al riadattamento. Riprendere il lavoro o riallacciare relazioni sociali possono essere
momenti utili. Questa riflessione invita a non schematizzare i comportamenti e a cogliere le
differenze tra il diniego patologico e un normale desiderio di evitare la sofferenza.
6
Anche la discussione sull’opportunità di mantenere o meno un legame con il defunto, su cui Walter
aveva riflettuto nel suo libro On Bereavement, può essere ricomposta, secondo Stroebe, con
un’analisi più dettagliata: un attaccamento complicato e patologico al defunto è cosa diversa dal
trovare un posto per il morto nella vita che continua. È necessario cioè esplicitare la natura del
legame che si prolunga: per esempio, costruttive possono essere la ricollocazione del defunto nella
vita e il culto della memoria, mentre non costruttive l’identificazione con il morto e la dipendenza.
Anche la più recente riflessione sociologica (ad esempio il già citato Clive Seale) ha messo in luce
come le categorie psicologiche possono essere utili per fornire un contesto interpretativo del lutto
nella società occidentale, purché sia presente la consapevolezza della relatività di tali categorie.
IL LUTTO NELLA STORIA CULTURALE
E’ un aspetto che le grandi sintesi di storia della morte di Ariès e Vovelle trattano marginalmente.
Ariès si limita a qualche pennellata qua e là sul tema del lutto: afferma che la ritualizzazione e la
socializzazione del lutto, riscontrabili nelle classi aristocratiche a partire dal Sei-Settecento,
finiscono per bloccare l’espressione del rimpianto, per paralizzare il dolente, per fungere da
diaframma tra l’uomo e la morte. A proposito dell’Ottocento, ritiene che la diffusione dei costumi
del lutto e del culto dei defunti indichi lo spostamento d’attenzione, a suo parere molto rilevante,
dalla “morte del sé” alla morte dell’altro: ma non spiega il passaggio dalla cultura romantica e
vittoriana del lutto alla situazione novecentesca sua contemporanea, peraltro stigmatizzata da Ariès
sulle orme dell’antropologo Geoffrey Gorer. Gorer, infatti, condusse una ricerca sociale sulla
percezione e i riti del lutto all’inizio degli anni Sessanta in Inghilterra, e concluse che ci si trovava
di fronte ad una grave crisi culturale, che comportava l’abbandono dei dolenti; la società
contemporanea chiedeva infatti all’individuo, anche se implicitamente, che il lavoro del lutto e il
superamento della perdita si compissero in privato, senza rattristare i propri simili. Secondo Gorer,
perduti i riti sociali del lutto, si era smarrita anche la solidarietà elementare tra le persone.
Vovelle, più sistematicamente di Ariès, tentò di tracciare una storia del lutto nelle pagine del suo La
morte e l’Occidente dal 1300 ai giorni nostri, in particolare a partire dall’età barocca, quando il
costume del lutto emerge in ambiente di corte e aristocratico. Narrò inoltre, seppure brevemente,
della rivendicazione del “diritto alle lacrime” avanzata da alcuni correnti settecentesche, della
maggiore diffusione e enfatizzazione del lutto nell’Ottocento, utilizzando come fonti le incisioni
d’epoca, i livres de raison, le cronache, oltre che i giornali e le riviste di moda; descrisse le
prescrizioni borghesi ottocentesche, gli abiti di lana e crespo nero delle vedove, i cappelli e il crespo
al braccio degli uomini, la durata del lutto a seconda del sesso e della parentela, le visite di
condoglianze, la frequentazione del cimitero. Sempre nel noto volume La morte e l’Occidente,
7
Vovelle mise in luce il parziale declino di questi costumi già alla fine del secolo XIX, citando la
fondazione, nel 1875, in Inghilterra, della National Funeral and Mourning Association, che
predicava il ritorno ad una maggiore semplicità rituale; e collocò cronologicamente negli anni Venti
e Trenta, con la modernizzazione e dopo la Prima Guerra Mondiale, il loro definitivo affossamento.
Sulla Prima Guerra Mondiale, talora intesa come potente cesura tra un prima (romantico, borghese
e vittoriano dei costumi del lutto, fortemente normati e condivisi socialmente) e un dopo
(l’azzeramento dei costumi precedenti e la privatizzazione e individualizzazione del lutto) esiste una
discussione tra gli storici. Molti, e in primo luogo Gorer, hanno fatto risalire alla Prima guerra
mondiale la decadenza della cultura borghese e romantica della morte, che incoraggiava soprattutto
le donne a mantenere solidi legami con i defunti e a dedicare loro un importante culto familiare e
sociale. L’Ottocento manifestava una preoccupazione condivisa per i morti e per coloro che
restavano, un forte culto delle tombe, un’educazione, fino dall’infanzia, a convenzioni sociali
radicate, e in sostanza a costumi collettivi funzionali a far fronte alla morte. Il conflitto del 1914-18
rappresenterebbe una frattura epocale, che ha provocato i primi cambiamenti dei costumi relativi al
lutto nel corso del Novecento: la morte di massa, il lavoro delle donne durante la guerra, l’esigenza
di non piangere per non deprimere il morale della nazione, e l’eccessiva quantità delle vedove
avrebbero infatti contribuito a far cadere in desuetudine i costumi mortuari tradizionali. Tuttavia,
non mancano le fonti che paiono contraddire questa interpretazione, forse non falsa, ma riduttiva e
troppo schematica: sia descrivendo scenografie brulicanti di donne in nero, anche dopo la fine della
Prima guerra mondiale, sia narrando l’importanza della solidarietà sociale e dei rituali di lutto e di
commemorazione, come fanno, per citare i più grandi, Jay Winter, Stéphan Audoin-Rouzeau,
Annette Becker e George Mosse.
A questo proposito, un’utile fonte per individuare il momento del regresso della cultura romantica,
che aveva diffuso i propri costumi del lutto in buona parte dell’Europa, è rappresentata dai galatei:
rivolti soprattutto alle donne, che di quella cultura erano le vestali, si preoccupavano di fornire
indicazioni di saper vivere a proposito di occasioni luttuose, accanto a quelle dedicate a matrimoni e
battesimi. Vero è che il galateo indica un dover essere e non rispecchia esattamente le usanze,
tuttavia tende a seguire e esplicitare la moda e i criteri correnti di buona educazione. I galatei ci
dicono che l’acme delle usanze della morte borghese, tra cui il lutto esteriore di lunga durata, si ha
nella seconda metà dell’Ottocento, mentre il regresso è collocabile in parte dopo la Prima, e in
modo più definitivo dopo la Seconda guerra mondiale.
In modo simile a Vovelle, Pat Jalland ridimensionò il ruolo della guerra mondiale, sostenendo che
alcune tendenze centrifughe, rispetto alla cultura vittoriana del lutto, esistevano già prima del 1914.
La studiosa affermò che tali usanze erano fondate soprattutto sulla fede (sottovalutando forse il
ruolo che ebbe la borghesia, ispirata a valori soprattutto terreni, nel radicamento di tali costumi), e
8
aggiunse che questi ultimi erano già stati incrinati dalle teorie di Darwin sull’origine della specie,
dall’esplosione della moda dello spiritismo e dalla nascita della cremazione. La guerra, che aveva
l’esigenza di semplificare i riti per non abbattere il morale della nazione, non aveva fatto altro che
accelerare un processo già in corso.
Naturalmente, nel venir meno della cultura vittoriana della morte non vi sono solo aspetti deteriori,
non solo una perdita di ritualità valutabile negativamente. Questo è un aspetto che David Cannadine
volle mettere in luce, ritenendo che la guerra abbia condotto a una cultura della morte più semplice
ed egualitaria. In modo analogo, Ernesto de Martino diede un giudizio positivo sull’essenzialità e
sobrietà dei costumi funebri della fine degli anni Cinquanta, e sull’espressione sommessa del dolore
in Italia –perlomeno nell’Italia settentrionale.
La storia culturale, cioè, ha cominciato ad interrogarsi sul passaggio, in Europa, dalla cultura
ottocentesca del lutto, romantica, comunitaria e borghese, a quella odierna, essenziale, poco cogente
ma impoverita, che delega agli individui il superamento del dolore: la cesura su cui si è
maggiormente elaborato è quella della Prima guerra mondiale. Da questo punto di vista, molto
lavoro resta da fare, ed è necessario osservare dal punto di vista del lutto gli anni tra le due guerre, il
secondo Conflitto mondiale, l’effetto devastante del genocidio degli ebrei, e il secondo dopoguerra,
fino ai giorni nostri; tenendo conto dei grandi mutamenti dell’occidente, quali l’individualizzazione
estrema e il prolungamento dell’aspettativa di vita media, le modalità assunte dall’urbanizzazione e
l’obbligo, per gli individui, di essere “autonomi” e autosufficienti in tutto, anche e soprattutto nel
dolore.
In prima approssimazione, si può comunque dire che la mancanza di riti condivisi si fa sentire,
emerge come forte disagio sociale, sensazione di solitudine e isolamento di fronte alla morte e al
dolore della perdita. Apparentemente, è lasciata ad ogni individuo un’ampia libertà di scelta di
comportamenti: piangere o non piangere, commemorare o meno, esprimere il dolore o continuare la
propria vita normalmente. In realtà, questa libertà e quest’autonomia sono per lo più estremamente
gravosi: lasciano i dolenti in balia di se stessi, senza guida, senza punti di riferimento, senza
abitudini collettive, costretti a interrogarsi su quali azioni sia opportuno compiere e quali sentimenti
sia lecito esprimere.
Tuttavia, anche questa faticosa libertà è apparente. Poiché ogni società non può esimersi dal
regolamentare la morte e gli eventi che la circondano, la nostra, che attraversa una seria crisi rituale,
ha trovato due solidi sostituti della dimensione impoverita della cultura della morte: la psicologia e
la medicina, aree del sapere potenti, e investite di un prestigio condiviso.
Non a caso, le proposte per fronteggiare il problema sociale del lutto provengono oggi proprio
dall'area della medicina e della psicologia, i gruppi di auto mutuo aiuto (che l'Organizzazione
9
Mondiale della Sanità valuta positivamente per la risoluzione di molti problemi che hanno a che
fare con la salute pubblica), il counselling (psicologico e filosofico), le psicoterapie.
Marina Sozzi, Fondazione Fabretti
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Antropologia
Bloch M. e Parry J. (a cura di), Death & the regeneration of life, Cambridge University Press,
Cambrdge, 1982.
De Martino E., Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Bollati
Boringhieri, Torino, 2000.
Di Nola A. M., La nera signora. Antropologia della morte e del lutto, Newton Compton, Roma
2006.
Hertz R., Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort, «Studi
Tanatologici», n. 2, 2006, pp. 27-107.
Hertz, R., La preminenza della destra (a cura di A. Prosperi), Einaudi, Torino, 1994.
Van Gennep A., I riti di passaggio (introduzione di F. Remotti), Bollati Boringhieri, Torino, 2007.
Van Gennep A., Manuel de Folklore français contemporain (1939) tome I, vol. 2, Picard, Paris,
1980.
Psicologia
Bacqué, M.-F., Le deuil à vivre, Odile Jacob, Paris, 2000.
Bowlby J., Attaccamento e perdita, vol 3 : la perdita della madre (1980), Bollati Boringhieri,
Torino, 1983.
Freud S., Opere, vol. 8, Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti, 1915-1917, Bollati Boringhieri,
Torino, 1989.
Freud S., Opere, vol. 9, L’Io e l’Es e altri scritti, 1917-1923, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
Freud S., Scritti sulla guerra e la morte (a cura di L. Marchetti), Palomar, Bari,1997.
Klein M., Il lutto e la sua connessione con gli stati maniaco-depressivi, in Scritti, 1921-1958,
Boringhieri, Torino, 1978.
Parkes C. M. e Weiss R. S., Recovery from bereavement, Basic Books Publishers, New York,
1983.
Parkes C. M., Il lutto. Studi sul cordoglio negli adulti (1972), Feltrinelli, Milano,1980.
Parkes C. M., Laungani P., Young B. (a cura di), Death and Bereavement across Cultures,
Routledge 1997.
Rando Th. A., Treatment of complicated Mourning, Paperback 1993.
Rosenblatt P.C., Walsh R.P., Jackson D.A., Grief and Mourning in Cross-Cultural Perspective,
Paperback, 1976.
Rosenblatt P.C., Parent grief: Narratives of Loss and Relationships, Routledge, 2000
Rosenblatt P.C., B. R. Wallace, African-American Grief, Routledge 2005.
Stroebe M., Bereavement Research and Theory: Retrospective and Prospective, «American
Behavioral Scientist», vol. 44, n. 5, gennaio 2001, pp. 854-865.
Sociologia
Gorer G., Death, Grief and Mourning. A study of contemporary society, (1965), 2° ed., Anchor
Books, New York 1967.
10
Seale C., Constructing Death. The sociology of Dying and bereavement, Cambridge University
Press, Cambridge, 1998.
Walter T., On bereavement. The culture of grief, Open University Press, Buckingham-Philadelphia,
1999.
Storia
Audoin-Rouzeau S., Becker A., La violenza, la crociata, il lutto. La Grande Guerra e la storia del
Novecento (2000), Einaudi, Torino, 2002.
Cannadine D., War and Death, Grief and Mourning in Modern Britain, in J. Whaley (a cura di),
Mirrors of Mortality: Studies in the Social History of Death, Europa, London,1981, pp.187-242.
Gibelli A., L’officina della Guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale
(1991), Bollati Boringhieri, Torino 2007.
Jalland P., Death in the Victorian Family, Oxford University Press, Oxford, 2006.
Janz O., Klinkammer L., La morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla
Repubblica, Donzelli, Roma 2008.
Molinari, A., Donne e ruoli femminili nell’Italia della Grande Guerra, Selene Edizioni, Milano,
2008.
Mosse G.L., Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti (1990), Laterza, Roma-Bari,
2005.
Nonnis Vigilante S., Le corps en deuil: la mise en scène de la mémoire dans les traités de savoirvivre. France-Italie XIXe et XXe siècles, in R. Bertrand, A. Carol, J-N. Pelen, Les narrations de la
mort, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 2005.
Winter J., Il lutto e la memoria. La grande guerra nella storia culturale europea (1995), Il Mulino,
Bologna, 1998.
Associazione
Maria Bianchi
11
Firmato digitalmente da
Associazione Maria Bianchi
ND: CN = Associazione Maria
Bianchi, C = IT
Motivo: Dichiaro l'accuratezza e
l'integrità di questo documento
Data: 2010.10.04 19:59:29 +02'00'
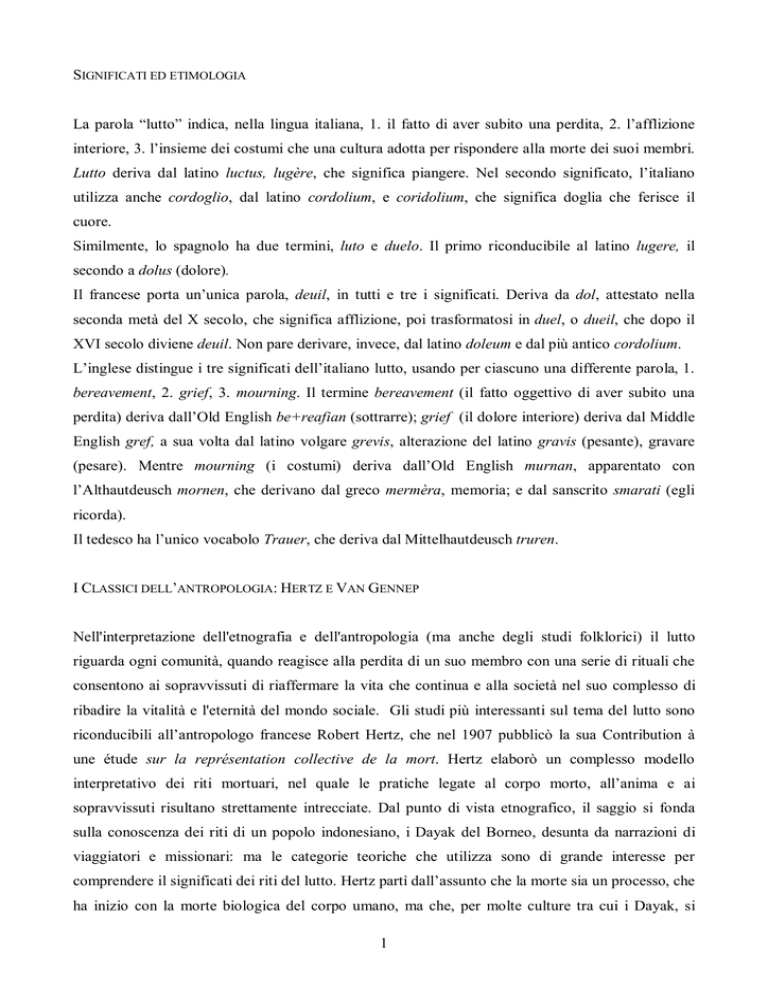
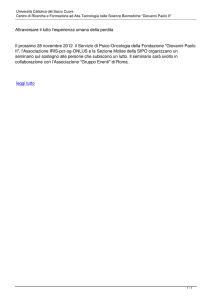

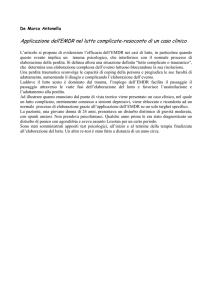
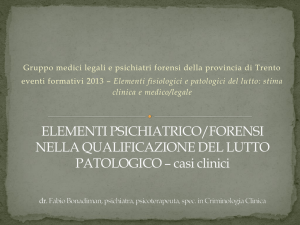


![Sportello di Elaborazione del lutto [file]](http://s1.studylibit.com/store/data/003962216_1-463249f52e113059237ad893cd7ffd2f-300x300.png)