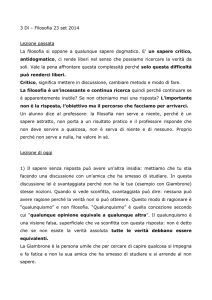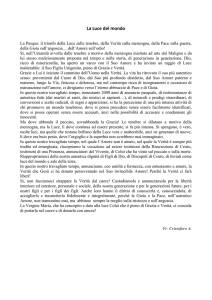Philosophical News, rivista semestrale di filosofia, nasce dalla collaborazione di più
studiosi a livello internazionale e da un intenso lavoro di redazione. Obiettivo della
rivista è di favorire la ricerca e la riflessione con particolare attenzione al dibattito
contemporaneo, in tutte le sue diverse manifestazioni culturali. Per questo, la
redazione sollecita in modo particolare contributi attinenti al dibattito attuale, siano
essi di carattere teorico o storico. I numeri, oltre ad essere composti da articoli e
recensioni, ospitano anche interviste e resoconti di works in progress: con ciò si vuole
ribadire l’attenzione per gli sviluppi recenti che contraddistingue questo progetto
editoriale. Al tempo stesso si è scelto di privilegiare grandi temi, conferendo a ciascun
numero un taglio monografico: è soltanto a partire dall’unità di cui il pensiero consiste
nella sua origine, da un pensiero radicato nel terreno dell’esperienza e conscio della
sua provenienza, che è infatti possibile uno sviluppo, un progresso, un lavoro capace
di portar frutto con quella pacatezza poi assolta e trasformata dal ‘nuovo’. Così,
l’armonia che talvolta trapela tra le pagine dei classici sembra poter divenire cardine
di un lavoro sempre più proficuo: Come un contadino ara la terra per la messe che
ad-est, il filosofo ara il visibile per l’Invisibile che in esso traluce. Egli fende il visibile
tracciandovi dei solchi ordinati non secondo i principi della geometria ma secondo
l’Unum invisibile che integra i suoi pensieri e le sue azioni, gli uni e le altre filo-sofici
(Stanislaw Grygiel).
Philosophical News is a semi-annual journal of philosophy born from the collaboration
of a number of international scholars as well as an intense editorial effort. The
aim of our journal is to promote research and reflection with special regard to the
contemporary debate in all its different cultural manifestations. Our editorial office
therefore especially welcomes contributions pertaining to current debates, both
of theorical and historical nature. In addition to including articles and reviews, the
issues also feature interviews and reports on works in progress: this choice is aimed
at further reinforcing the attention on current developments, which is the distinctive
feature of this editorial project. Another choice that was made was that of privileging
major themes, developing each issue in a monographic form: only from the unity that
belongs to thought in its origin, thought that is rooted in the grounds of experience
and aware of its provenance, is it possible to move forward, to progress, to bear fruit
with that calm that is then absolved and transformed by the ‘new’. Likewise, the
harmony that occasionally transpires from the pages of classics appears as a potential
cornerstone for a new, enriched study: As a farmer ploughs the earth for the harvest
that ad-est, the philosopher ploughs the visible for the invisible that shines through
it. He cuts through the visible, digging furrows that are not ordered according to the
principles of geometry but according to the invisible Unum that integrates his thoughts
and his actions, which are both philo-sophical (Stanislaw Grygiel).
Philosophical News
NUMERO 2 – MARZO 2011
La rivista sottopone gli articoli a blind peer review
Direttore responsabile: Elisa Grimi
Redazione: Antonio Allegra, Marco Damonte, Alessandro Gamba, Alessandra Gerolin, Maria
Silvia Vaccarezza, Matteo Zoppi
Comitato scientifico: Francesca Bonicalzi, Evandro Botto, Francesco Botturi, Rémi Brague,
Angelo Campodonico, Timothy Chappell, Vincenzo Costa, Gianfranco Dalmasso, Alessandro
Ghisalberti, John Haldane, Claudio La Rocca, Michele Lenoci, Danielle Lories, Massimo
Marassi, Margarita Mauri Alvarez, Letterio Mauro, Matteo Negro, John O’Callaghan, Robert
Spaemann
Rivista in formato elettronico (ISSN 2037-6707) e cartaceo (ISSN 2039-7194).
Dati per l’abbonamento annuale, 2 numeri:
ASSOCIAZIONE CULTURALE PHILOSOPHICAL NEWS
[CF 97578590156; P.IVA 07339530961]
ABBONAMENTO ANNUALE: 50,00 EURO (Italia; studente 25,00 EURO); 60,00 EURO
(Estero)
Per abbonarsi:
Tramite bonifico bancario intestato ad
“Associazione Culturale Philosophical News”
Causale: “abbonamento annuale”
pagamento: Banca Intesa Sanpaolo, via E. Ponti 55, 20143, Milano - Italy
BIC/SWIFT: BCITITMMXXX
IBAN IT27J0306909540100000008168
-mandare email con conferma avvenuto pagamento e indirizzo per la spedizione a
[email protected], specificando “Abbonamento Philosophical News” e indicando i numeri
desiderati.
Autorizzazione Tribunale di Milano n.127 – 12 marzo 2010
Copyright 2010 - All rights reserved
© 2011 – MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it / www.mimesisbookshop. com
Via Risorgimento, 33 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono e fax: +39 02 89403935
Via Chiamparis, 94 – 33013 Gemona del Friuli (UD)
E-mail: [email protected]
Indice
Editoriale
di Elisa Grimi
p. 11
Intervista a Bernhard Waldenfels
a cura di Ezio Gamba
p. 19
In esclusiva:
Hans-Herbert Kögler
Essere in quanto dialogo,
o le conseguenze etiche dell’interpretazione
tr. it. di Andrea Lugoboni
p. 27
Presentazione di Philosophical News
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, 15 ottobre 2010
“Possiamo amare la verità?”
Rémi Brague
p. 48
Michele Lenoci
p. 54
Letterio Mauro
p. 63
Saggi
Emilio Baccarini
Fare la verità
p. 68
Marco Buzzoni
Verità ed epistemologia evoluzionistica
p. 78
Lorenzo Fossati
La verità della parola.
La critica di Ebner all’idealismo e alla filosofia in generale
p. 84
Michael P. Lynch
Thoughts, the World and Everything in Between
p. 95
Marco Santambrogio
Verità e liberalismo politico
p. 102
Recensioni
Convegni
Religion in the Public Sphere,
XVIII European Society of the Philosophy of Religion Conference
Merton College, Oxford – 26-29 Agosto 2010
di Marco Damonte
p. 116
Il dono: valore di legame e valori umani. Un dialogo interdisciplinare
Università degli Studi di Macerata – 16-17 settembre 2010
di Anna Cossetta
p. 121
Erik Peterson. La presenza teologica di un outsider
Simposio internazionale
Roma – 24-26 ottobre 2010
di Isabella Guanzini
p. 124
Libertà e necessità in Al di là di Bene e Male
VII Seminario permanente nietzscheano
Bologna – 16-18 novembre 2010
di Selena Pastorino
p. 129
Il primato di Dio nella vita e negli scritti del beato John Henry Newman
Simposio internazionale
Pontificia Università Gregoriana – 22-23 novembre 2010
di Samuele Busetto
p. 134
Pluralità e interpretazione
Convegno di studi
Università degli Studi di Genova – 22-23 novembre 2010
di Francesco Ferrari e Selena Pastorino
p. 139
Filosofia e Mistica
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – 24-25 novembre 2010
di Luca Vettorello
p. 145
SILFS 2010
International Conference of the Italian Society for Logic and Philosophy of Sciences
Università degli Studi di Bergamo – 15-17 Dicembre 2010
di Stefano Rivara
p. 150
Voegelin. I. Israele e la rivelazione, Vita e Pensiero, Milano 2009
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – 20-21 gennaio 2011
di Alessandra Gerolin
p. 155
Quale esperienza per la filosofia della religione? Due giornate seminariali al Centro
Studi del Fenomeno Religioso di Verona
Fondazione Centro Studi Campostrini – 27-28 gennaio 2011
di Giuseppe di Salvatore
p. 164
Libri
Antonio Allegra,
Metamorfosi.
Enigmi filosofici del cambiamento,
Mimesis, Milano 2010;
di Paolo Monti
p. 174
Giuseppe Bonvegna,
Per una ragione vivente.
Cultura, educazione e politica nel pensiero di John Henry Newman,
Vita e Pensiero, Milano 2008;
di Gianni Bianchi
p. 179
Gabriele De Anna,
Causa, forma, rappresentazione.
Una trattazione a partire da Tommaso d’Aquino,
Franco Angeli, Milano 2010;
di Marco Damonte
p. 184
Massimo Donà,
Il tempo della verità,
Mimesis, Milano 2010;
di Antonio Allegra
p. 187
Roberto Esposito,
Pensiero vivente.
Origini e attualità della filosofia italiana,
Einaudi, Torino 2010;
di Andrea Ciceri
p. 189
Guglielmo Forni Rosa,
L’amore impossibile.
Filosofia e letteratura da Rousseau a Levì-Strauss,
Marietti, Genova-Milano 2010;
di Emanuele Romanini
p. 191
Isabella Guanzini,
Lo spirito è un osso.
Postmodernità, materialismo e teologia in Slavoj Žižek,
Cittadella editrice, Assisi 2010;
di Francesca Mazzini
p. 195
Fabrice Hadjadj – Fabrice Midal,
Qu’est-ce que la vérité?,
Salvator, Parigi 2010;
di Massimo Borghesi
p. 198
Mario Micheletti,
La teologia razionale nella filosofia analitica,
Carocci, Roma 2010;
di Hagar Spano
p. 201
Jan Patočka,
Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo,
Centro Studi Campostrini, Verona 2009;
di Lodovica Maria Zanet
p. 204
Antonio Pavan – Emanuela Magno (a cura di),
Antropogenesi.
Ricerche sull’origine e lo sviluppo del fenomeno umano,
Il Mulino, Bologna 2010;
di Michele Paolini Paoletti
p. 206
Georg Sans,
Al crocevia della filosofia contemporanea,
Gregorian & Biblical Press, Roma 2010;
di Lorenzo Fossati
p. 210
Holger Zaborowski,
Robert Spaemann’s Philosophy of the Human Person:
Nature, Freedom, and the Critique of Modernity,
Oxford University Press, Oxford-New York 2010;
di Matteo Amori
p. 216
Cristina Zaltieri,
L’invenzione del corpo.
Dalle membra disperse all’organismo,
Negretto Editore, Mantova 2010;
di Roberta Sofi
p. 221
Editoriale
Veritas Redarguens
di Elisa Grimi
“Chi può sbagliare la porta?”. Parlando della ricerca della verità Aristotele, nella Metafisica, ricorda questo proverbio. Tutti sono in grado di colpire un bersaglio
grande, quale per l’appunto è una porta, mentre risulta più difficile colpire un
bersaglio piccolo. La ricerca intorno alla verità si presenta dunque per un aspetto
semplice, tutti sono infatti in grado di dire qualche verità in generale, ma per l’altro
difficile, poiché riguarda le verità specifiche. Ciascuno, tuttavia, esprime qualcosa
sulla natura della verità: “come infatti gli occhi delle nottole stanno alla luce del
giorno, così anche l’intelletto della nostra anima sta alle cose che per natura sono
le più note di tutte”.
Sulla scia della definizione aristotelica di filosofia quale scienza della verità, appare dunque sinora chiara la consistenza del tema che contraddistingue questo
secondo numero. La filosofia viene considerata dallo Stagirita quale conoscenza
teoretica della verità e dunque conoscenza teoretica delle cause (principi primi), e
la causa per cui una cosa è vera è più vera di quella cosa, ed è maggiormente ciò che
è quella cosa. In tale prospettiva la verità attinge la sua origine ed è proprio a partire da essa che ogni riflessione trova la sua genesi, il suo sviluppo e la sua fecondità.
Molti sono i saggi che si è scelto di ospitare in questo numero: in primo luogo teniamo a ringraziare il professor Hans-Herbert Kögler per averci concesso di
pubblicare in traduzione italiana il suo saggio ‘’Being as Dialogue or: The Ethical
Consequences of Interpretation”, così come la rispettiva casa editrice Northwestern University Press. Kögler propone una riflessione stilata in occasione del cinquantesimo anniversario dalla prima edizione del celebre testo di Hans-Georg Gadamer Verità e metodo; dopo avere ribadito che il progetto filosofico di Gadamer è
orientato a mostrare come il dialogo teso alla verità possa liberare l’interpretazione
da legami concettuali del discorso trascendentale e storicistico così da ristabilire una comprensione piena dell’esperienza ermeneutica, Kögler avanza dunque
l’ipotesi che al fine di riconoscere pienamente la natura etica dell’altro, occorrano
i metodi che rivelano la piena portata dell’esistenza dell’altro incluse le dimensioni
socio-istituzionali e quelle psicologico-individuali.
Ad aprire il numero è però l’intervista al professor Bernhard Waldenfels, uno
dei massimi esponenti contemporanei della fenomenologia, il quale sottolinea
come la pretesa di verità che si distacchi da situazioni concrete sia in fondo destinata a ricadere in un’ideologia fondamentalistica. Di qui la contrapposizione propria di Edmund Husserl di ‘orizzonti’ di verità ad una assolutizzazione della verità.
Waldenfels tende poi a sottolineare l’importanza di un individuo che risponde
12
ELISA GRIMI
Philosophical News
dinnanzi a ciò che accade, un rispondere che non è né arbitrario né costrittivo ma
inevitabile: non si può che rispondere. La filosofia così, afferma Waldenfels, rimane viva “soltanto finché il lavoro sulle ‘cose stesse’ mantiene il suo peso sufficiente,
e questo in un lavoro comune selettivo con le scienze, non in una sottomissione
ad esse”. Ma quale è la garanzia del sussistere di quella che un tempo si presentava come philosophia perennis? Suggerisce argutamente Waldenfels lo Stachel des
Fremden, vale a dire il ‘pungolo dell’estraneo’.
Seguono a tale intervista i testi della presentazione della rivista avvenuta lo scorso 15 ottobre 2010 presso l’aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. L’incontro dal provocatorio titolo “Possiamo amare la verità?” è stato
guidato in primis dal professor Rémi Brague, dal cui insegnamento deriva il contenuto di questo editoriale. Il prof. Brague, dopo avere delineato un breve profilo
di carattere storico circa il tema in esame, richiama un noto passaggio agostiniano,
seppur raramente messo in evidenza. Si legge nelle Confessioni riguardo alla verità:
amant eam lucentem, oderunt eam reguardentem. La verità, sottolinea Agostino, è
lucens, dacché permette di conoscere le cose come un lume puntato su queste, ma
d’altra parte è anche redarguens, vale a dire che la luce ritorna a ciò che l’ha emessa
rivelando ciò che talvolta è semplice nascondere. Pertanto l’amore che nasce da
una veritas lucens è premessa della conoscenza, consente un controllo sulle cose;
diversamente avviene per la veritas redarguens, più difficile da ammettere, seppur
proprio in essa si riveli il pieno amore alla verità in quanto tale. Ed è per questo che
allora l’onestà intellettuale di fronte anche a una verità brutta, rappresenta l’ultima
traccia dell’amore per la verità bella; e la verità, afferma Brague, per essere amata
deve essere buona e bella.
La veritas redarguens consiste dunque in un secondo livello conoscitivo, che
segue alla veritas lucens, e senza la quale non può darsi una cultura. Infatti una
cultura che affondi le sue radici nella sola veritas lucens sarebbe, seppur forse non
in prima istanza, troppa comoda e a lungo andare vuota. Ma una cultura che consideri la verità per l’unità di questi suoi due aspetti, poiché sì illumina ma anche
riprende (red-arguens), allora è una cultura capace di portar frutto, di offrire un
dialogo, di essere per l’appunto dia-logica, di rapportasi, di render conto di quanto
avviene nel mondo, in una società, nel suo relativo ambito politico ed educativo.
Sempre in occasione della presentazione, all’interrogativo di Brague, al fatto
se sia cioè possibile amare una verità, hanno risposto, i proff. Michele Lenoci e
Letterio Mauro. Lenoci, sulla scia di Max Scheler, ha sottolineato come amore e
conoscenza siano profondamente correlati e come l’incremento del primo renda
possibile un allargamento della seconda. Inoltre il riferimento alla verità si pone
come necessario, in quanto è ciò che consente che l’amore sia completo e integrale,
e allo stesso tempo come portavoce di quello sperare senza il quale non è possibile,
seguendo il motto eracliteo, trovare l’insperabile. Mauro ha invece sottolineato
la tendenza relativistica propria dell’epoca contemporanea di porsi nei confronti
del vero, per cui anche per un povero ingenuo sarebbe facile definire la verità, in
quanto somma di ciò che si legge e si sente dire continuamente. La stampa, i media, sottolinea Mauro, in tale senso si offrono spesse volte come buono strumento
per trasmettere un’unica quanto relativa ed esasperata verità. Diversamente da tale
Philosophical News
VERITAS REDARGUENS
13
atteggiamento si pone quell’umana e autentica ricerca del vero per cui con Edith
Stein la filosofia sembra poter tornare a desiderare, una filosofia questa che “vuole
la verità nella più ampia estensione possibile”, e per cui la sfida che continuamente
si pone per chi è in ricerca non può che divenire passo dopo passo sempre più
interessante, e meritevole di un maggiore approfondimento.
La riflessione prosegue con numerosi contributi che presentano approcci differenti al tema della verità. Il saggio del prof. Emilio Baccarini dal titolo “Fare
la verità” propone un confronto tra due paradigmi che leggono la verità come
totalità riportando risultati contrapposti: Georg Wilhelm Friedrich Hegel e Franz
Rosenzweig; giunge poi ad analizzare un terzo paradigma capace di permettere un
approccio ermeneutico, vale a dire Luigi Pareyson. Sottolinea poi Baccarini come
la verità non possa risultare al di fuori di una umana responsabilità.
Differente invece è l’approccio di Marco Buzzoni, il quale in “Verità ed epistemologia evoluzionistica” tratta della stretta connessione presente nel programma
dell’epistemologia evoluzionistica tra la teoria dell’evoluzione e la teoria della verità; afferma Buzzoni che la pretesa di avere un valore di verità, cosa che l’epistemologia evoluzionistica necessariamente solleva, non può essere spiegata o giustificata
in termini di mera sopravvivenza biologica.
Segue dunque il contributo del prof. Lorenzo Fossati “La verità della parola. La
critica di Ebner all’idealismo e alla filosofia in generale”. In esso vengono prese in
esame le critiche di Ferdinand Ebner all’idealismo hegeliano, ritenuto dal filosofo
austriaco incapace di offrire una spiegazione della dimensione spirituale. L’articolo
dalla spedita e agile scrittura, dopo aver proposto un’analogia tra Ebner e Jof, il
saltimbanco protagonista del celebre film di Ingmar Bergman Il settimo sigillo,
propone uno spunto di riflessione a partire dalla prospettiva di Johann Georg Hamann sui limiti propri della ragione e della parola come qualcosa che non può
essere semplicemente definito come concetto, in modo particolare in una dimensione spirituale e di fede. Fossati conclude quindi il saggio in modo provocatorio
accennando alla possibilità di scoperta di un equilibrio che venga a coniugare il
razionalismo e l’infinitezza della fede. Lasciamo qui però al lettore di valutare se
per una “operatività” reale della fede occorra una qualche iniziativa, per quanto
nobile, o se forse invece già nell’insegnamento di Mia, moglie del citato personaggio Jof, si possa percepire una risposta, più semplice di un’argomentazione pro o
contro Dio. Non c’è qui spazio per tornare al dialogo del Settimo sigillo tra Mia e
il Cavaliere, basti richiamare che l’inquietudine del cuore di chi si trova nel film a
giocare la sua ultima partita, per l’appunto a scacchi con la Morte, sembra per un
attimo quasi risolversi nel profumo delle fragole selvatiche appena colte, in una
ciotola di latte, nel silenzio di un crepuscolo; così anche quella fede, ‘pena così
dolorosa, come amare qualcuno che è lì fuori al buio e che non si mostra mai per
quanto lo si invochi’, pare trovare il suo conforto: il cavaliere, d’un tratto, torna a
credere.
Originale si presenta poi la riflessione di Michal P. Lynch dal titolo “Thoughts,
the World and Everything in Between”. Lynch osserva essere due i grossi problemi
delle teorie deflazioniste della verità: in primo luogo si chiede come tali concezioni, facendo riferimento a un background così esiguo, possano approdare ad
14
ELISA GRIMI
Philosophical News
una definizione significativa e adeguata della verità; in secondo luogo come tali
prospettive possano conciliarsi con la nostra intuizione che la verità implichi una
corrispondenza tra il pensiero e il mondo. A risposta di tali dilemmi si pone il substitutionalism di Christopher Hill: Lynch ne rileva i punti carenti.
A chiudere la sezione dei saggi è il contributo del prof. Marco Santambrogio
“Verità e liberalismo politico”. Egli propone una riflessione sul concetto di verità a
partire dal pensiero di John Rawls. Durante il ventesimo secolo la nozione assoluta
di verità, come anche di verità in quanto tale, è stata spesse volte rifiutata. Si pone
a esempio Hans Kelsen, il quale traccia un parallelo da un lato tra assolutismo
filosofico e autocrazia, dall’altro tra relativismo e democrazia, o ancora Hannah
Arendt, la quale deduce dalla sua concezione democratica che la verità deve essere
respinta. Affini a tali prospettive paiono essere alcune dichiarazioni di John Rawls
riguardo la verità. Sottolinea però in merito Santambrogio come ciò sia vero solo
in apparenza e successivamente discute l’interpretazione del pensiero di Rawls offerta da Joshua Cohen.
Alle sezione dei saggi seguono numerose cronache di recenti convegni e molte
recensioni a nuovi testi. Riteniamo che queste sezioni siano preziose, non soltanto
perché offrono un aggiornamento che è doveroso nel settore della ricerca, ma in
quanto dicono dell’attenzione che tale progetto editoriale ha per il dibattito contemporaneo. È infatti soltanto a partire da una coscienza personale, dall’esser desti
sulle cose, che un lavoro manifesta la sua vera scientificità.
Prima però di lasciare il lettore alla riflessione sul tema proposto, teniamo a fare
una premessa che dice dell’intenzione e della possibilità con cui il presente lavoro
va formandosi. Il tema della verità è certamente un tema arduo, per alcuni versi
fastidioso, ma che tocca in fondo ogni uomo in prima persona, un tema insomma
non facile da scansare. E certo non poca può essere la confusione innanzi ad una
tematica di così vasta portata, come quando capita, aspettando che l’orchestra inzii
a suonare la sua sinfonia, di assistere come a un comizio di accordi tra loro non affini, musicisti intenti ad accordare i propri strumenti, nenie monotone, apparentemente insensate. Ma tale squilibrio d’un tratto cessa, e rievocando una celebre immagine di von Balthasar, questo avviene quando “il pianoforte suona un la, perché
tutt’intorno si stabilisca una certa uniformità di suono: si accorda su qualche cosa
di comune”. Si tratta di una verità sinfonica, così intitola il testo onde prosegue il
teologo: “[...] La scelta degli strumenti presenti non è casuale. Essi costituiscono
già, con la diversità delle loro caratteristiche, qualche cosa come un sistema di
coordinate. L’oboe, aiutato forse dal fagotto, farà da contrappunto alla parte degli
archi; tuttavia non sarebbe sufficientemente efficace, se i corni non svolgessero
il compito di sottofondo unitario per il dialogo dei diversi strumenti. La scelta è
determinata dal disegno che provvisoriamente giace, muto, nella partitura aperta”.
E con tale auspicio che affidiamo ora la lettura.
Editorial
Veritas Redarguens
by Elisa Grimi
“Who will miss the door?”. Aristotle quotes this proverb when discussing the
pursuit of truth. Everyone is capable of hitting a large target, such as a door for
instance, while it is far more difficult to hit a small one. The research of truth seems
simple on the one hand, for anyone can state some general truth, while on the
other hand it is difficult, in particular when it concerns specific truths. However,
everyone expresses something about the nature of truth: “as the eyes of bats are
to the light that follows the dawn of day, so also is the mind of our soul to those
things, which above all, are naturally the most splendid”.
In the wake of the Aristotelian definition of philosophy as the science of truth,
the consistency of the theme of our second issue is immediately revealed. The Stagirite considers philosophy to be the theoretical knowledge of truth and, therefore,
the theoretical knowledge of causes (first principles); the cause for which a thing is
true is more true than the thing itself, and it is what the thing is more than the thing
itself. From this angle truth draws on its origin and starting from this origin every
reflection finds its genesis, its development, and its fruitfulness.
We have chosen to feature numerous essays in this issue. First of all, we would
like to thank Professor Hans-Herbert Kögler for having kindly granted the publication of the Italian translation of his essay ‘’Being as Dialogue or: The Ethical Consequences of Interpretation”, as well as the respective publishing house,
Northwestern University Press. Kögler offers a reflection conceived on the occasion of the fiftieth anniversary of the first edition of Hans-Georg Gadamer’s
renowned work Truth and Method; after having reasserted that Gadamer’s philosophical project is oriented towards revealing how dialogue reaching toward truth
can free interpretation from the conceptual ties of the transcendental and historicist points of view, thus enabling us to restore a full understanding of hermeneutic
experience, Kögler brings forward the hypothesis that in order to fully recognize
the ethical nature of others it is necessary to employ the methods that reveal the
full depth of their existence, including the socio-institutional and psychologicalindividual dimensions.
The opening item of the issue is an interview with Professor Bernhard Waldenfels, one of the leading phenomenological thinkers of our time, who underlines
the consideration that any claim of truth detached from concrete situations is ultimately destined to relapse into a fundamentalist ideology. Hence the contrast,
originally formulated by Edmund Husserl, between ‘horizons’ of truth and an
absolutization of truth. Waldenfels also tends to underline the importance of an
16
ELISA GRIMI
Philosophical News
individual who responds to what is happening, the response being neither arbitrary nor constricting, but rather inevitable: one cannot but respond. Waldenfels
states that philosophy therefore stays alive “only as long as the work on the ‘things
themselves’ maintains its sufficient importance, in a combined, selective effort with
sciences and not in submission to them. But what guarantees the continuation of
what once presented itself as a philosophia perennis? Waldenfels sharply suggests
the Stachel des Fremden, in other words the ‘sting of the alien’.
This interview is followed by the texts of the presentation of the journal that took
place on 15th October 2010 in the Pio XI lecture hall of the Università Cattolica del
Sacro Cuore in Milan. The conference, which presented the provocative title “Can
we love truth?”, was lead in primis by Professor Rémi Brague, whose teachings
gave life to the content of this editorial. After offering a brief historical profile of
the theme in question, Prof. Brague referred to a well-known Augustinian passage
that is, however, rarely spotlighted. One can read in the Confessions about the truth:
amant eam lucentem, oderunt eam reguardentem. Truth, Augustine underlines, is lucens, for it allows things to be known as a light that shines on them, but on the other
hand it is also redarguens, which means that the light returns to that which emitted
it, revealing what is sometimes easily hidden. Therefore the love that originates
from a veritas lucens is a premise of knowledge, and it allows a grasp on things; differently from that the veritas redarguens is more difficult to admit, although within
the latter is where a brimming love for truth is revealed. This is why intellectual
honesty even in the presence of an ugly truth represents the last trace of love for
beautiful truth; according to Brague truth, to be loved, must be good and beautiful.
Veritas redarguens thus consists of a second level of knowledge that follows veritas lucens and without which there cannot be culture. Indeed, a culture that sinks
its roots in veritas lucens alone would be, even if not at first, too convenient and it
would long be sterile. However, a culture that considers truth as the unity of these
two aspects, for truth does illuminate but it also reprimands (red-arguens), is a
culture capable of bearing fruit, of offering a dialogue, of being indeed dia-logic, of
relating to and being aware of what is happening in the world, in society, and in its
relative political and educational fields.
On the occasion of the presentation, professors Michele Lenoci e Letterio Mauro also replied to Brague’s query on the possibility of loving truth. In the wake of
Max Scheler, Lenoci drew attention to the fact that love and knowledge are deeply
correlated, in that an increase of the former enables an amplification of the latter.
Furthermore the reference to truth presents itself as necessary, in that it is what
allows the love to be complete and whole, and at the same time as mouthpiece of
that hope without which, according to Heraclitus, it is impossible to find what is
beyond hope. Mauro, instead, emphasized the relativistic attitude toward truth of
the contemporary age, according to which even a simple-minded man could easily
define truth, it being a sum of things we continuously read and hear about. In this
sense the press and the media, Mauro underlines, often offer themselves as a suitable instrument for transmitting a truth that is one, as well as being relative and
exasperated. Differently from this perspective, with Edith Stein philosophy seems
to be able to start hoping once more for a human and authentic search for truth,
Philosophical News
VERITAS REDARGUENS
17
a philosophy that “desires truth in the greatest possible extension” and for which
the challenge that the seeker constantly faces cannot but become step by step more
interesting and deserving of a more in-depth examination.
The reflection continues with numerous contributions that testify different approaches toward the topic of truth. Prof. Emilio Baccarini’s paper entitled “Fare la
verità” suggests a comparison between two paradigms that read truth as a totality
but reach opposite results: Georg Wilhelm Friedrich Hegel and Franz Rosenzweig; he then analyzes a third paradigm capable of allowing a hermeneutic approach, which belongs to Luigi Pareyson. Baccarini then underlines how truth
cannot find itself outside the boundaries of human responsibility.
Different is the approach of Marco Buzzoni, who, in “Verità ed epistemologia
evoluzionistica” considers the close connection between the theory of evolution
and the theory of truth found in evolutionist epistemology. Buzzoni states that the
claim to a value of truth, which is necessarily brought up by evolutionist epistemology, cannot be explained or justified in terms of mere biological survival.
Prof. Lorenzo Fossati’s “La verità della parola. La critica di Ebner all’idealismo
e alla filosofia in generale” followed. It examines Ferdinand Ebner’s criticisms of
Hegelian idealism, which the Austrian philosopher considers unable to provide
an explanation of the spiritual dimension. The article is written in a quick, agile fashion; after having proposed an analogy between Ebner and Jof, the street
acrobat protagonist of Ingmar Bergman’s famous film The Seventh Seal, it offers
food for thought starting from Johann Georg Hamann’s perspective on the limits
of reason and language as something that cannot simply be defined as a concept,
in particular in a spiritual dimension of faith. Fossati concludes the paper in a
provocatory manner, hinting at the possibility of discovering a balance that could
combine rationalism and the infiniteness of faith. We shall leave it to the reader to
establish whether for a real “operativeness” of faith there needs to be an initiative,
however noble it may be, or whether an answer that is simpler than an argument
for or against God is instead already present in Mia’s teaching (the wife of the
abovementioned Jof). There is no room here to go over the dialogue of the Seventh
Seal between Mia and the Knight; let it be enough to recall that the unease of those
who, in the film, find themselves playing their last match in the form of a chess
game with Death, seems for an instant almost to find a resolution in the scent of
freshly picked wild strawberries, in a bowl of milk, in the silence of dusk. Likewise
that faith, ‘such a painful trial, like loving someone who is out there in the dark and
never shows himself, however many times he is beckoned’, seems to find comfort:
the knight suddenly starts believing again.
Michal P. Lynch’s reflection entitled “Thoughts, the World and Everything in
Between” presents itself as original. Lynch points out that there are two prominent
problems in deflationary theories of truth; first of all, he wonders how such conceptions can come to a significant, adequate definition of truth by basing themselves
on such an exiguous background. Secondly, he asks himself how such perspectives
can be reconciled with our intuition that truth implies a correspondence between
thought and the world. Lynch singles out the weak points of Christopher Hill’s
substitutionalism, which presents itself as an answer to such queries.
18
ELISA GRIMI
Philosophical News
Prof. Marco Santambrogio’s contribution, entitled “Verità e liberalismo politico”, was discussed in the conclusion of the section dedicated to essays. He proposed a reflection on the concept of truth starting from John Rawls’ thought. In
the course of the twentieth century, the absolute notion of truth, as well as the one
of truth as such, was often times refused. Some examples are given; Hans Kelsen,
for instance, suggests a parallelism on the one hand between philosophical absolutism and autocracy, and on the other between relativism and democracy. Hannah Arendt states that truth must be rejected, deducing this conclusion from her
conception of democracy. Some statements of Rawls about truth bear similarities
to these standpoints. In regard to these, however, Santambrogio underlines how
said similarities are only apparently true and goes on to discuss Joshua Cohen’s
interpretation of Rawls.
Following the essay section, there are numerous accounts of recent conferences
as well as reviews of new texts. We feel that these sections are valuable not only because they offer the chance to keep updated, as is advisable in the field of research,
but also because they shine a light on the attention with which our editorial project
tackles the contemporary debate. Only starting from personal conscience, from
being vigilant of things does an effort manifest its true scientific nature.
Before leaving the reader to reflect on the theme we proposed, we would like to
make a premise about the intentions and possibilities with which the present project is being undertaken. The topic of truth is certainly an arduous topic, even irksome under some aspects, but it is a topic that reaches into the depths of everyone
personally and that is therefore not easily dismissed. Indeed there can be no little
confusion when facing a theme so vast; just like when, waiting for the orchestra to
start playing its symphony, one hears an assembly of clashing chords as the musicians are intent on tuning their instruments, a monotonous and seemingly senseless tune. However, such imbalance suddenly ceases, and recalling a well-known
image of von Balthasar, this occurs when “someone has struck an A on the piano,
and a certain unity of atmosphere is established around it: they are tuning up for
some common endeavor”. It is a symphonic truth, so reads the title of the theologian’s text that goes on to state: “Nor is the particular selection of instruments
fortuitous: with their graded differences of qualities, they already form a kind of
system of coordinates. The oboe, perhaps supported by the bassoon, will provide
a foil to the corpus of strings, but could not do so effectively if the horns did not
create a background linking the two sides of this counterpoint. The choice of instruments comes from the unity that, for the moment, lies silent in the open score
on the conductor’s podium”. And with such a wish, we leave you to enjoy the read.
Intervista a Bernhard Waldenfels
a cura di Ezio Gamba
1- Domanda: La intervisto per il secondo numero della rivista “Philosophical
News”. In primo luogo vorrei domandarLe del Suo iter filosofico personale; vorrei
cioè chiederLe quali eventi o quali esperienze L’hanno condotta a porsi quei problemi (in particolare quelli dell’estraneo e della responsività) intorno ai quali si è
sviluppato il Suo pensiero.
Ich interviewe Sie für die zweite Nummer von “Philosophical News”. Zuerst
möchte ich Sie über Ihren philosophischen Weg befragen: Welche Ereignisse und
Erfahrungen haben Sie dazu bewogen, sich die Probleme zu stellen (besonders das
des Fremden und der Responsivität), um die sich dann Ihr Denken entwickelt hat?
Risposta: Il mio interesse giovanile per figure come Socrate o Kierkegaard può
avere a che fare con il fatto che dal principio non mi muovevo nel flusso della comunicazione come un pesce nell’acqua. Però l’idea decisiva era il fra. Ciò che accade fra noi non può essere ricondotto a nessuno di noi esclusivamente. Il saggio di
Kleist Sulla graduale produzione dei pensieri durante il discorso si riferisce anche al
discorso come dialogo (Wechselrede). Occorre allora prendere alla lettera espressioni come “inter-soggettività”, “inter-corporeità” o “inter-culturalità”, come pure
“dia-logo” o l’“entre-tien infini” di Blanchot. Nessun io isolato sta al principio,
ma neppure nessun noi compatto. Così il mio primo libro di ampio respiro, che
si ricollega a Husserl, a Buber e a Merleau-Ponty, ebbe il titolo Das Zwischenreich
des Dialogs.
Mein frühes Interesse an Gestalten wie Sokrates und Kierkegaard mag damit zusammenhängen, daß ich mich von Anfang nicht im Fluß der Kommunikation bewegte wie ein Fisch im Wasser. Doch die zündende Idee war das Zwischen. Was zwischen
uns geschieht, kann auf keinen von uns allein zurückgeführt werden. Kleists Essay
Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden bezieht sich auch auf
die Wechselrede. So gilt es, Ausdrücke wie Inter-subjektivität, Inter-korporeität oder
Inter-kulturalität sowie den Dia-log oder Blanchots entre-tien infini wörtlich zu nehmen. Kein isoliertes Ich steht am Anfang, aber auch kein kompaktes Wir. So bekam
mein erstes großes Buch, das an Husserl, Buber und Merleau-Ponty anknüpft, den
Titel Das Zwischenreich des Dialogs.
20
EZIO GAMBA
Philosophical News
2- Domanda: Rivolgendomi ora maggiormente all’attualità, vorrei domandarLe come ha maturato la decisione di dedicare al tema delle arti il Suo libro più
recente.
Um zur Gegenwart zu kommen, möchte ich Sie jetzt fragen, aus welchen Gründen
Sie sich entschieden haben, Ihr neuestes Buch dem Thema der Künste zu widmen.
Risposta: Il nesso tra aisthesis ed estetica, tra i sensi e le arti, mi interessa da
molto tempo. Già in Sinnenschwellen, e poi naturalmente nel libro più recente
Sinne und Künste im Wechselspiel, sensi e arti sono al plurale. Si tratta di una molteplicità sinestetica con svariate connessioni trasversali. Considerate da un punto
di vista fenomenologico, le arti non sono uno specifico regno della bella apparenza,
bensì una forma di accrescimento del sensibile, un campo di sperimentazione dei
sensi. Esse ci insegnano a vedere diversamente, a udire diversamente, a muoverci
diversamente. Nella mia storia, ciò risale molto indietro. La prima lezione che ho
tenuto dopo la mia abilitazione nell’inquieto 1968 si chiuse con una citazione da
Paul Valéry: “Hercule changé en hirondelle – ce mythe existe-t-il?”.
Der Zusammenhang zwischen Aisthesis und Ästhetik, zwischen den Sinnen und
den Künsten, hat mich seit langem interessiert. Schon in den Sinnesschwellen und
dann natürlich in dem jüngsten Buch Sinne und Künste im Wechselspiel stehen
Sinne und Künste im Plural. Es handelt sich um eine synästhetische Vielheit mit
mannigfachen Querverbindungen. Phänomenologisch betrachtet bilden die Künste
keinen Sonderbereich des schönen Scheins, sondern eine Steigerungsform des Sinnlichen, ein Experimentierfeld der Sinne. Sie lehren uns anders sehen, anders hören,
anders uns bewegen. Das geht bei mir weit zurück. Die erste Vorlesung, die ich nach
meiner Habilitation in dem unruhigen Jahr 1968 hielt, schloß mit einem Zitat von
Paul Valéry: “Hercule changé en hirondelle – ce mythe existe-t-il?”.
3- Domanda: “Philosophical News” è una rivista che, come dice il nome stesso,
intende avere particolare attenzione per l’attualità filosofica; il secondo numero
della rivista è dedicato al tema della verità, un argomento che per certi versi può
quasi sembrare inattuale. Tradizionalmente, infatti, la filosofia si concepisce proprio come la ricerca della verità; oggi però questa immagine tradizionale della filosofia sembra non essere più universalmente condivisa; ma la filosofia deve ancora
interessarsi alla verità? In che modo?
“Philosophical News” ist eine Zeitschrift, die (wie der Name sagt) der philosophischen Aktualität besondere Beachtung schenkt. Die zweite Nummer der Zeitschrift ist
dem Thema Wahrheit gewidmet, ein Thema, das in gewisser Hinsicht fast inaktuell
scheinen kann. Traditionellerweise verstand sich die Philosophie als Suche nach der
Wahrheit, aber heute scheint diese traditionelle Vorstellung der Philosophie nicht
mehr allgemein geteilt zu werden. Soll die Philosophie sich noch für die Wahrheit
interessieren? In welcher Weise?
Risposta: Questa è una domanda enorme. Si può intendere la verità analiticamente o pragmaticamente come verità dell’enunciato. Allora, però, si impone ciò
Philosophical News
INTERVISTA A BERNHARD WALDENFELS
21
che già Husserl e Heidegger indicavano: c’è un’esperienza pre-predicativa, che
precede la distinzione di vero e falso, di sì e no. Qualcosa si mostra come rosa,
come martello, come rovina di tempio o come atto di forza. Noi abbiamo a che
fare, per parlare con Merleau-Ponty, con un senso in statu nascendi. Ciò che io
chiamo Response, cioè il processo del rispondere a ciò che ci accade, non è vero
o falso; vera o falsa è la risposta (Antwort), per esempio l’informazione che io do.
In ciò le condizioni di verità che stanno a fondamento delle nostre affermazioni
quotidiane risalgono a una “genealogia della logica”, similmente a come la morale
risale a una “genealogia della morale”. Su questo punto si incontrano Husserl e
Nietzsche. Questo non ha nulla a che fare con una semplice abolizione o disistima
della verità.
Das ist eine gewaltige Frage. Man kann die Wahrheit analytisch oder pragmatisch
als Aussagewahrheit verstehen. Dann aber gilt, was schon Husserl und Heidegger anvisierten: Es gibt eine vorprädikative Erfahrung, die der Disjunktion von wahr und
falsch, von Ja und Nein vorausgeht. Etwas zeigt sich als Rose, als Hammer, als Tempelruine oder als Gewaltakt. Wir haben es, mit Merleau-Ponty zu reden, mit einem
Sinn in statu nascendi zu tun. Was ich Response nenne, also der Vorgang des Antwortens auf das, was uns widerfährt, ist nicht wahr oder falsch; wahr oder falsch ist die
Antwort, etwa die Auskunft, die ich gebe. Dabei gehen die Wahrheitsbedingungen,
die unseren alltäglichen Behauptungen zugrunde liegen, zurück auf eine “Genealogie
der Logik”, ähnlich wie die Moral auf eine “Genealogie der Moral” zurückgeht. An
dieser Stelle berühren sich Husserl und Nietzsche. Mit einer schlichten Abschaffung
oder Mißachtung der Wahrheit hat dies nichts zu tun.
4- Domanda: La parola “verità”, naturalmente, abbraccia un campo di significati molto ampio, che vanno dalla semplice verità di una proposizione come:
“Piove” a ciò che si intende quando si dice che “Dio è la verità”. Pensa che esista
una ragione per cui tutti questi significati vanno sotto un unico nome di “verità”?
Das Wort “Wahrheit” umfaßt natürlich ein sehr weites Bedeutungsfeld, das sich
von der einfachen Wahrheit des Satzes “Es regnet” bis hin zu dem, was wir meinen,
wenn wir “Gott ist die Wahrheit” sagen, erstreckt. Denken Sie, daß es einen Grund
dafür gibt, um all diese Bedeutungen unter dem einzigen Wort “Wahrheit” zu fassen?
Risposta: La verità quotidiana qui e ora non dovrebbe essere separata dalle
grandi visioni della verità. “Ho visto la verità”, professa Dostoevskij, ma al tempo
stesso egli colloca la questione della verità nella polifonia del dialogo, a cui Bachtin
ha concesso la sua particolare attenzione. Ogni pretesa di verità che si distacchi da
situazioni concrete tende a un’ideologia fondamentalistica. In questo senso Husserl stesso, che per vari aspetti si muove su vie tradizionali della verità, si volge
contro un “essere che si libra al di sopra delle nuvole della conoscenza”; all’assolutizzazione della verità egli contrappone “orizzonti” della verità, che escludono
un saldo possesso della verità. Se si cerca di eliminare completamente qualcosa,
questo ritorna attraverso le porte di servizio, spesso in forma peggiore. Fanatismo
e indifferentismo, assolutismo e relativismo si rafforzano l’un l’altro.
22
EZIO GAMBA
Philosophical News
Die alltägliche Wahrheit hier und jetzt sollte man nicht von den großen Wahrheitsvisionen absondern. “Ich habe die Wahrheit gesehen”, bekennt Dostojewski,
doch gleichzeitig verlegt er die Wahrheitsfrage in die Vielstimmigkeit des Dialogs, der
Bachtin seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Jeder Wahrheitsanspruch,
der sich von konkreten Situationen ablöst, tendiert zu einer fundamentalistischen
Ideologie. In diesem Sinne wendet sich selbst Husserl, der sich in mancherlei Hinsicht auf traditionellen Wahrheitswegen bewegt, gegen ein “über den Wolken der
Erkenntnis schwebendes Sein”; der Verabsolutierung der Wahrheit stellt er “Horizonte” der Wahrheit entgegen, die einen festen Wahrheitsbesitz ausschließen. Sucht
man etwas gänzlich abzuschaffen, so kehrt es durch die Hintertüre zurück, oft in
schlimmerer Gestalt. Fanatismus und Indifferentismus, Absolutismus und Relativismus verstärken einander.
5- Domanda: Il tema della verità ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella filosofia di ispirazione fenomenologica; essa ha spesso ricercato un “fenomeno
originario della verità”, cioè un fondamento della verità di ogni verità che sia esso
stesso fenomeno; le risposte su questo “fenomeno originario della verità”, da quella di Heidegger a quella di Michel Henry, sono molto diverse. Il problema fenomenologico della verità e del “fenomeno più originario della verità” assume una
curvatura particolare nella prospettiva della Sua fenomenologia responsiva?
Das Thema Wahrheit hat in der Philosophie phänomenologischen Ursprungs immer eine grundlegende Rolle gespielt. Diese Philosophie hat oft nach einem “ursprünglichen Phänomen der Wahrheit” gesucht, d.h. nach einem Grund der Wahrheit
jeder Wahrheit, der zugleich Phänomen ist. Die Antworten hinsichtlich dieses “ursprünglichen Phänomens der Wahrheit”, von Heidegger bis zu Michel Henry, sind
sehr verschieden. Nimmt das phänomenologische Problem der Wahrheit und des “ursprünglichen Phänomens der Wahrheit” in der Perspektive Ihrer responsiven Phänomenologie einen besonderen Zuschnitt an?
Risposta: Ho i miei dubbi su tutti i tentativi di ripiegare su un piano della verità
più alto o più profondo. Questo riguarda tanto la distinzione di verità ontica e
ontologica in Heidegger quanto il ricorrere di Michel Henry a una verità che annuncia se stessa come “parole de la vie”. Quest’ultima conduce al pericolo di una
ventriloquia: “La vita dice” – dice Michel Henry. Nel campo sociale e politico si
incontrano sospette frasi retoriche come “il popolo vuole”, “l’umanità vuole” o
“Dio vuole”, che velano il luogo del discorso. Se c’è qualcosa come un “fenomeno
originario della verità”, esso c’è in forma di pretese che procedono dall’altro e
dall’estraneo. Ma la loro “verità” non si mostra direttamente, bensì solo indirettamente nella risposta che noi diamo – o rifiutiamo. Il nostro rispondere non è né
arbitrario né costrittivo, è inevitabile. Noi non possiamo non rispondere. Naturalmente ci sono situazioni normali in cui noi diamo risposte idonee, per esempio
ricambiando un saluto; però persino tali situazioni non sono mai del tutto normali
e quotidiane, finché noi non ci trasformiamo in apparati di reazione. Oltre a ciò ci
sono situazioni che sono così insolite e stupefacenti che noi dobbiamo inventare
Philosophical News
INTERVISTA A BERNHARD WALDENFELS
23
le risposte. Le nostre risposte saranno sempre soltanto più o meno all’altezza di
pretese procedenti da una situazione collettiva o da una richiesta personale. Rispondere significa attivare una storia di risposte o interromperla, per esempio negli
atti del promettere o del perdonare. Questo riguarda tanto storie d’amore quanto
esplosioni di violenza. Per prendere un esempio dalla storia più recente, l’11 settembre 2001 è stato un evento sconcertante, che ha sconvolto un intero popolo.
Come la guerra in Afghanistan, anche Guantanamo appartiene alle risposte a questo atto di violenza; però la realizzazione di un campo di prigionia extraterritoriale
rappresenta una risposta dubbia, poiché in questo modo il governo ha minato i
fondamenti di stato di diritto della propria nazione.
Ich habe meine Zweifel bei allen Versuchen, auf eine höhere oder tiefere Ebene
der Wahrheit auszuweichen. Dies betrifft sowohl die Unterscheidung von ontologischer und ontischer Wahrheit bei Heidegger wie Michel Henrys Inanspruchnahme
einer Wahrheit, die sich als “parole de la vie” selbst ausspricht. Letztere führt zur
Gefahr einer Bauchrednerei: “Das Leben sagt” – sagt Michel Henry. Im sozialen
und politischen Bereich finden sich dubiose Floskeln wie “das Volk will”, “die Menschheit will” oder “Gott will”, die den Ort der Rede verschleiern. Wenn es so etwas
wie ein “originäres Phänomen der Wahrheit” gibt, so in Gestalt von Ansprüchen,
die vom Anderen und vom Fremden ausgehen. Aber deren “Wahrheit” zeigt sich
nicht direkt, sondern nur indirekt in der Antwort, die wir geben – oder verweigern. Unser Antworten ist weder beliebig noch zwingend, es ist unvermeidlich.
Wir können nicht nicht antworten. Natürlich gibt es normale Situationen, in denen
wir passende Antworten geben, indem wir etwa einen Gruß erwidern; doch selbst
solche Situationen sind niemals ganz und gar normal und alltäglich, solange wir
uns nicht in Reaktionsapparate verwandeln. Darüber hinaus gibt es Situationen,
die so ungewohnt und überraschend sind, daß wir die Antworten erfinden müssen.
Ansprüchen, die von einer kollektiven Situation oder von einer persönlichen Bitte
ausgehen, werden unsere Antworten immer nur mehr oder weniger gerecht. Antworten heißt, eine Antwortgeschichte in Gang setzen oder sie unterbrechen, so etwa
in Akten des Versprechens oder Verzeihens. Das betrifft Liebesgeschichten ebenso
wie Einbrüche der Gewalt. Um ein Beispiel aus der jüngsten Geschichte zu nehmen,
der 11. September 2001 war ein bestürzendes Ereignis, das eine ganze Bevölkerung
aufwühlte. Wie der Krieg in Afghanistan so gehört auch Guantanamo zu den Antworten auf diese Gewalttat; doch die Anlage eines exterritorialen Gefangenenlagers
stellt eine fragwürdige Antwort dar, da die Regierung damit die rechtsstaatlichen
Grundlagen der eigenen Nation unterhöhlte.
6- Domanda: Il Suo libro più recente, Sinne und Künste im Wechselspiel
(Suhrkamp, München 2010), è sulle arti; ricorre inoltre quest’anno il cinquantesimo anniversario di Verità e metodo di Gadamer, nel cui pensiero ha una grande
importanza l’attribuzione all’arte di una propria verità. Lei pensa che possiamo
parlare di una verità dell’arte? E in che senso?
Ihr neuestes Buch, Sinne und Künste im Wechselspiel (Suhrkamp, München
2010), ist den Künsten gewidmet. Außerdem feiert man in diesem Jahr das 50 Ju-
24
EZIO GAMBA
Philosophical News
biläum von Wahrheit und Methode von Gadamer. In Gadamers Denken ist das Thema einer Wahrheit der Kunst sehr wichtig; denken Sie, daß wir von einer Wahrheit
der Kunst sprechen können? In welchem Sinn?
Risposta: Sono assolutamente d’accordo con lo sforzo di Gadamer di liberare
l’arte dalle limitazioni di un’estetica soggettivistica e riconquistare a essa una sede
in seno all’esperienza. Di una verità dell’arte non ho mai espressamente parlato,
ma molto delle possibilità di scoprire in modo nuovo il mondo e noi stessi nell’arte.
Mi sembra importante in questo la dimensione patica e responsiva dell’arte, che
conferisce all’arte una particolare profondità. Così, in riferimento all’arte figurativa, non c’è soltanto un eidos della pittura, bensì anche un pathos come un effetto
che passa attraverso il medium dell’immagine, e c’è anche uno sguardo che procede dall’immagine e non si dirige primariamente all’immagine come lo sguardo
dalla finestra nel senso di Alberti. Iconologia e iconografia devono dunque essere
completate con un’iconopatia. Penso qui, tra l’altro, a rappresentazioni della violenza come per esempio nei Desastres de la guerra di Goya. Nel mio nuovo libro
compaiono però anche le arti del movimento della danza, tra le quali la moderna
Körpertanz, così come il teatro, che nella forma di un “teatro postdrammatico”
dà un particolare peso all’accadere scenico. Infine non mancano neanche le arti
della tavola e della convivialità del pasto, che qui in Italia hanno una particolare
tradizione. La classica gerarchia di sensi inferiori e superiori, che si rispecchia in
una gerarchia delle arti, vacilla se si procede dalla totalità di un sensorio corporeo
e di una motricità corporea.
Mit Gadamers Bemühen, die Kunst von den Einschränkungen einer subjektivistischen Ästhetik zu befreien und ihr einen Sitz inmitten der Erfahrung zurückzuerobern, stimme ich durchaus überein. Von einer Wahrheit der Kunst habe ich nie
ausdrücklich gesprochen, sehr wohl aber von Möglichkeiten, in der Kunst die Welt
und uns selbst neu zu entdecken. Wichtig erscheint mir dabei die pathische und responsive Dimension der Kunst, die den Inventionen der Künste einen besonderen
Tiefgang verleihen. So gibt es, auf die bildende Kunst bezogen, nicht nur ein Eidos
der Malerei, sondern auch ein Pathos als eine Wirkung, die durch das Bildmedium
hindurchgeht, und ebenso gibt es einen Blick, der vom Bild ausgeht und nicht primär
auf das Bild zugeht wie der Fensterblick im Sinne von Alberti. Ikonologie und Ikonographie sind also durch eine Ikonopathie zu ergänzen. Ich denke dabei unter anderem
an Darstellungen der Gewalt wie etwa in Goyas Desastres de la guerra. In meinem
neuen Buch kommen aber auch die Bewegungskünste des Tanzes vor, darunter der
moderne Körpertanz, sowie das Theater, das in der Form eines “postdramatischen
Theater” dem Bühnengeschehen ein besonderes Gewicht gibt. Schließlich fehlen
auch die Künste der Tafel und die Geselligkeit des Mahls nicht, die hier in Italien
eine besondere Tradition haben. Die klassische Hierarchie von niederen und höheren
Sinnen, die sich in einer Hierarchie der Künste spiegelt, kommt ins Wanken, wenn
man von der Gesamtheit eines leiblichen Sensoriums und einer leiblichen Motorik
ausgeht.
Philosophical News
INTERVISTA A BERNHARD WALDENFELS
25
7- Domanda: Questa intervista si svolge durante il Suo soggiorno a Torino, dove
Lei si trova per tenere una settimana di seminari presso la Scuola di Alta Formazione Filosofica su invito di Ugo Perone; che cosa pensa in generale della questione
della formazione dei giovani alla filosofia oggi?
Dieses Interview findet während Ihres Aufenthalts in Turin statt, wo Sie auf Einladung von Ugo Perone ein Seminar an der Scuola di Alta Formazione Filosofica
halten. Was denken Sie im Allgemeinen über die Frage der philosophischen Bildung
der Jugend heute?
Risposta: Non ci si dovrebbe fare alcuna illusione, la filosofia non prometteva neanche in passato alcuna normale carriera professionale. Si deve cercare
la propria strada. Da un punto di vista istituzionale, un particolare problema
risiede oggi nell’economizzazione e funzionalizzazione delle università e nella
formalizzazione dei percorsi di studio. Però la nostra settimana seminariale ha
mostrato che anche oggi è ancora possibile filosofare all’università in modo vivace, senza limitarsi al conseguimento di crediti e al disbrigo di un programma
d’esame. A Bochum abbiamo avuto per anni un corso di dottorato in “Fenomenologia ed ermeneutica”, nel quale era possibile un lavoro similmente fecondo.
Altre difficoltà riguardano la strutturazione interna della disciplina filosofica. La
pratica della filosofia richiede acume e dottrina, anche conoscenza delle lingue.
Ma sarebbe grave per la filosofia se essa da una parte si specializzasse in ricerca
e metodica parascientifiche, dall’altra si risolvesse in ricerca testuale storica. La
filosofia rimane viva soltanto finché il lavoro sulle “cose stesse” mantiene il suo
peso sufficiente, e questo in un lavoro comune selettivo con le scienze, non in
una sottomissione a esse. Riguardo a ciò il crescere del patrimonio del sapere
costringe alla fissazione di punti centrali, anche già nello studio universitario.
Inoltre il pensiero filosofico non va separato dalla responsabilità politica, il che
era già ben presente agli antichi Greci. Le università costituiscono un luogo nella
società, ma come luoghi-limite, che si oppongono a una completa integrazione,
finché esse rimangono fedeli a se stesse.
Man sollte sich keine Illusionen machen, die Philosophie versprach auch früher keine normale Berufskarriere. Man muß seinen Weg suchen. Institutionell gesehen liegt
heute ein besonderes Problem in der Ökonomisierung und Funktionalisierung der
Hochschulen und in der Formalisierung der Studiengänge. Doch unsere Seminarwoche hat gezeigt, daß es auch heute noch möglich ist, an der Universität auf lebendige
Weise zu philosophieren, ohne sich auf den Erwerb von Credits und die Bewältigung
eines Prüfungsstoffs zu beschränken. In Bochum hatten wir über Jahre hin ein Graduiertenkolleg “Phänomenologie und Hermeneutik”, in dem eine ähnlich fruchtbare
Arbeit möglich war. Andere Schwierigkeiten betreffen die innere Strukturierung der
philosophischen Disziplin. Zur Ausübung der Philosophie gehören Scharfsinn und
Gelehrsamkeit, auch Sprachkenntnisse. Aber es wäre schlecht um sie bestellt, wenn
sie sich einerseits auf parawissenschaftliche Forschung und Methodik spezialisieren,
andererseits in historische Textforschung auflösen würde. Die Philosophie bleibt nur
lebendig, solange die Arbeit an den “Sachen selbst” ihr hinreichendes Gewicht behält, und dies in selektiver Zusammenarbeit mit den Wissenschaften, nicht in einer
26
EZIO GAMBA
Philosophical News
Unterwerfung unter sie. Dabei zwingt das Anwachsen des Wissensbestandes zur
Schwerpunktbildung, auch schon im Studium. Überdies ist philosophisches Denken
von politischer Verantwortung nicht zu trennen, das war schon den alten Griechen
bewußt. Universitäten bilden einen Ort in der Gesellschaft, aber als Grenzorte, die
sich einer völligen Integration widersetzen, solange sie sich selbst treu bleiben.
8- Domanda: Infine, una domanda sull’attualità filosofica: che cosa trova particolarmente interessante nella filosofia di oggi?
Abschließend eine Frage zur philosophischen Aktualität: Was halten Sie in der
heutigen Philosophie für besonders interessant?
Risposta: Rispondere a questa domanda implica una certa parzialità. Temi che io
considero particolarmente fecondi sono l’alterità e l’estraneità, la carne (Leib) e il
corpo (Körper), il luogo e lo spazio, l’immagine, l’interculturalità, il potere e la violenza. Questa lista si può evidentemente ampliare. Però, se c’è qualcosa che mette
in pericolo il pensiero, è l’inclinazione alla normalizzazione e al conformismo di un
mainstream. Già Nietzsche, che a Torino non è uno sconosciuto, mette in guardia
dall’autolimitazione di un “uomo normale”, che si limita ormai a funzionare. Il
risultato sarebbe una cultura normale, che sopravvive a se stessa. Di fronte a ciò io
parlo di un “pungolo dell’estraneo”.
Die Beantwortung dieser Frage schließt eine gewisse Parteilichkeit ein. Themen,
die ich selbst für besonders ertragreich halte, sind Andersheit und Fremdheit, Leib und
Körper, Ort und Raum, Bild, Interkulturalität, Macht und Gewalt. Diese Liste läßt
sich jederzeit erweitern. Doch wenn etwas das Denken gefährdet, so ist es der Hang
zur Normalisierung und zum Konformismus eines mainstream. Schon Nietzsche, der
in Turin ja kein Unbekannter ist, warnt vor der Selbstbescheidung eines “Normalmenschen”, der nur noch funktioniert. Das Resultat wäre eine Normalkultur, die sich selbst
überlebt. Demgegenüber spreche ich von einem “Stachel des Fremden”
Bernhard Waldenfels, nato nel 1934 a Essen, è uno dei massimi esponenti della fenomenologia oggi in attività. Dopo aver studiato in varie Università tedesche e francesi (in particolare a
Parigi, dove ebbe modo di confrontarsi personalmente con Merleau-Ponty), divenne professore
alla Ludwig-Maximilians-Universität München e raggiunse l’ordinariato nel 1976 presso l’Universität Bochum, di cui è attualmente Professore Emerito (dal 1999).
Le sue ricerche fenomenologiche si concentrano principalmente sul tema dell’estraneità o
dell’estraneo, applicato in particolar modo al corpo, al linguaggio, al concetto della modernità e
alle relazioni interculturali.
Tra le sue numerose opere, sono pubblicate in italiano Fenomenologia dell’estraneità (Vivarium, Napoli 2002), Estraniazione della modernità. Percorsi fenomenologici di confine (Città
Aperta, Troina 2005) e Fenomenologia dell’estraneo (Raffaello Cortina, Milano 2008). È in corso
di pubblicazione per i tipi di Rosenberg & Sellier il volume delle lezioni da lui tenute nel 2010 a
Torino presso la Scuola di Alta Formazione Filosofica, in occasione delle quali è stata realizzata
questa intervista.
Hans-Herbert Kögler
Essere in quanto Dialogo
ovvero le conseguenze etiche dell’interpretazione*
trad. italiana di Andrea Lugoboni
A Verità e metodo di Hans-Georg Gadamer è giustamente riconosciuto di aver
sfidato con successo un concetto d’interpretazione umano-scientifica modellato sulla
base delle scienze naturali1. Una durevole conquista è mostrare che anche le posizioni delle ermeneutiche romantiche o dello storicismo, nonostante la loro opposizione
al modello della scienza esplicativo e basato su leggi, rimangono guidate dall’ideale
della conoscenza oggettiva2. Gadamer si propone di ricostruire una concezione alternativa di comprensione tornando alla radice di quest’ultima: la relazione tra il sé
e l’altro. Il suo maggiore punto di svolta consiste nel concettualizzare la relazione
Io-Tu in quanto esperienza dialogica. Il punto di vista dialogico non solo permette di liberarci dai confini metodologici delle ermeneutiche precedenti, ma connette
inoltre la discussione ermeneutica ad una prospettiva universale che riguarda tutta
l’esperienza. La dimensione dialogica dell’esperienza, infatti, diventa ora la base di
una totale revisione della nostra autocomprensione filosofica3. Essa rende possibile
la duplice negazione sia della filosofia trascendentale, che assume come principio
fondante una prospettiva liberata dalle fonti storico-empiriche, sia dello storicismo,
che obietta, contro il soggetto trascendentale, l’altrettanto universale affermazione
della relatività storica di tutta la conoscenza. In contrasto con entrambi, l’ermeneutica di Gadamer propone un atteggiamento orientato alla verità che evita l’illusione neokantiana di stabilire criteri universali attraverso la riflessione astratta, senza
però accettare le conseguenze relativistiche dello storicismo, con la sua pretesa di
indipendenza dai valori4. Al contrario, si mostra che la natura intenzionale di tut* Trad. it. di “Being as Dialogue, or The Ethical Consequences of Interpretation” in J. Malpas - S. Zabala, Consequences of Hermeneutics: Fifth Years After Gadamer’s Truth and Method,
Northwestern University Press, Evanston, Ill. 2010, pp. 343-368. Ringraziamo l’autore e la casa
editrice Northwestern University Press per la gentile concessione.
1 H.G. Gadamer, Verità e Metodo, a cura di G. Vattimo, Bompiani, Milano 2000.
2 Obiettivi cruciali sono tra gli altri F. Schleiermacher, Hermeneutics: The Handwritten Manuscripts, 1819, tr. di J. Duke e J. Forstman, Scholars Press, Missoula 1977; e W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito: tentativo di fondazione per lo studio della società e della storia, vol.
I, introduzione e apparati di G.B. Demarta, tr. it. di G.A. De Toni, riveduta da G.B. Demarta,
Bompiani, Milano 2007; Id., Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften,
1910. W. Dilthey, La Costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito, in Scritti filosofici, a
cura di P. Rossi, UTET, Torino 2004.
3 H.G. Gadamer, Verità e metodo, spec. parte III, pp. 781 e ss. Cfr. anche M. Heidegger, In
cammino verso il linguaggio, tr. it. di M. Caracciolo, Mursia, Milano 1990; e W. von Humboldt,
La diversità delle lingue, a cura di D. Di Cesare, Laterza, Roma-Bari 20044.
4 Per una classica e influente difesa della ricerca sociale libera da valori, cfr. il saggio di M.
Weber, L’oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica (1904), in M. Weber, Il metodo
28
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
ta la comprensione implica che l’interprete sia costretto a comprendere i fenomeni
culturali e storici in una modalità già “situata” e orientata alla validità. Il progetto
filosofico di Gadamer è quindi guidato da una grande questione: mostrare come il
dialogo orientato alla verità possa liberare l’interpretazione dai vincoli concettuali
del discorso trascendentale e storicistico, così da ristabilire una comprensione piena
dell’esperienza ermeneutica.
In questo saggio siamo interessati alle conseguenze etiche del modello dialogico
di comprensione e interpretazione. L’interpretazione dialogica implica un’idealizzazione normativa in relazione all’altro che è incorporata nel processo di comprensione
stesso. Il progetto di Gadamer perciò prepara il terreno per un riconoscimento
etico dell’altro, che evita l’astratta richiesta di rispettare l’autonomia dell’altro, né
nega tale autonomia riducendo l’altro ai contesti storico-culturali contingenti. Al
contrario, il dialogo genuino riconosce l’altro come soggetto situato, e che pure
dice la verità, come agente in grado di esprimere idee e di mettere in discussione
se stesso, come qualcuno che è radicato totalmente nel contesto culturale, sociale e politico e che tuttavia – o proprio per questo – è in grado di farci vedere in
modo diverso e migliore. Connettendo concettualmente il riconoscimento etico
alla comprensione, l’etica è incorporata nell’autentica condizione di possibilità di
relazionarsi con l’altro, in quanto agente umano5.
Di particolare interesse per il nostro progetto è l’intreccio delle dimensioni normative, ontologiche e metodologiche nell’interpretazione. Ogni accesso interpretativo al senso dell’altro deve essere dialogico. L’interpretazione dialogica implica
un’unica, ma fondamentale forma di riconoscimento, perché esclude ogni oggettivazione dell’altro. Mostreremo come questo equivalga ad una struttura fondamentale per il riconoscimento etico, che precede le teorie etiche articolate. Visto
che il comprendere è una caratteristica essenziale dell’agire umano e l’accesso al
suo significato è per necessità dialogico, l’essere umano è definito come dialogico.
Essendo costretti ad approcciare l’altro in modo dialogico, e vi siamo costretti se
vogliamo davvero comprendere l’altro in quanto essere umano, siamo costretti a un
rispetto per l’altro fondato ontologicamente. L’ulteriore obiettivo che ora emerge è
quello di mostrare come questo riconoscimento ermeneutico possa essere attuato
in pratiche interpretative concrete, cioè come esso riguardi le prospettive metodologiche delle scienze umane e sociali.
La maggior parte di questo saggio tenterà di rendere plausibile la nostra tesi
centrale e di mostrare cosa ne segue per quanto riguarda la comprensione dell’agire umano nelle scienze interpretative. Gli approcci metodologici di queste scienze possono essere esaminati in riguardo alle loro implicazioni etiche. Gadamer
delle scienze storico-sociali, Torino, Einaudi 1958; e l’introduzione a Id., Economia e società, tr. it.
di M. Palma, Donzelli, Roma 2005.
5 Dato che comprendere l’altro è indispensabile quando ci si rapporta ad esso – noi sempre
già comprendiamo l’altro nella luce di alcuni concetti, schemi, assunzioni – fondare il riconoscimento etico sull’esperienza ermeneutica colloca il progetto normativo del rispetto intersoggettivo su un reale processo del mondo. Impianta la pretesa del dovere etico su ciò che possiamo fare,
su reali capacità ermeneutiche che sono attualizzate ogni volta che entriamo in relazioni sociali.
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
29
stesso ricostruisce un’infrastruttura normativa della comprensione intersoggettiva
e la impiega per determinare le conseguenze etiche della comprensione e dell’interpretazione. Noi stessi cominceremo a ricostruire il modo in cui la concezione
di Gadamer della comprensione dialogica implica un’essenziale dimensione etica
(1). In un secondo momento, discuteremo l’argomentazione esplicita di Gadamer sulla natura etica della comprensione, nella quale egli compara l’approccio
socio-scientifico, storico-empatico e dialogico con gli atteggiamenti nei confronti
dell’altro nel mondo della vita. Egli conclude che l’oggettivazione delle prospettive
socio-scientifiche e l’individualizzazione delle prospettive empatiche non riesce a
render giustizia alla sostanza etica del dominio oggettuale, cioè il soggetto umano
(2). Nondimeno, come mostreremo in un terzo momento, Gadamer sopravvaluta il suo caso etico-metodologico. Noi argomenteremo, al contrario, che al fine
di riconoscere pienamente la natura etica dell’altro, metodi che rivelano la piena
portata dell’esistenza dell’altro, incluse le dimensioni socio-istituzionali e quelle
psicologico-individuali, sono necessari. Affermeremo che gli approcci discorsivoanalitici, così come quelli empirici, possono essere giustificati sulla base dell’universale mediazione dell’esperienza attraverso il linguaggio. Di conseguenza, quelle
prospettive, invece di violare il senso etico dell’interpretazione dialogica, completano piuttosto il riconoscimento morale dell’altro.
1. L’ethos implicito dell’interpretazione dialogica
Per preparare il terreno per la nostra ricostruzione della posizione di Gadamer,
dobbiamo mettere in primo piano due aspetti essenziali. Da una parte Gadamer
argomenta contro la considerazione del metodo come via verso la verità nell’interpretazione, enfatizzando il ruolo costitutivo di un’implicita e olistica comprensione di sfondo come condizione dell’interpretazione6. La visione di un interprete che
possa obiettivamente e neutralmente accertare i significati incontrati nei testi o le
espressioni simboliche è difettosa, visto che, per accedere al significato in quanto
tale, esso deve impiegare le sue credenze date per certe e le proprie presupposizioni. Senza esser in grado di connettere un’espressione dotata di significato al contesto di credenze e presupposizioni proprio di qualcuno, l’interprete non potrebbe
mai cominciare a produrre senso. Viceversa, visto che le credenze e le presupposizioni dell’interprete sono necessariamente formate e costituite dal concreto
contesto socio-culturale della sua esistenza, la comprensione del significato sarà
sempre informata da tale sfondo di presupposti. D’altra parte, Gadamer nota che
il compito autentico della comprensione implica necessariamente un orientamento
all’oggetto, die Sache selbst. Questo punto è chiarito argomentando contro ogni
6 H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit., pp. 749 e ss. Per l’importanza delle assunzioni ricavate dal retroterra olistico nell’interpretazione, cfr. H. Dreyfus, Holism and Hermeneutics, in
“Review of Metaphysics”, 1980, 34 (1), pp. 3–24; e J. Searle, Della intenzionalità. Un saggio di
filosofia della conoscenza, Bompiani, Milano 1985.
30
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
concezione di significato, linguistico o meno, che permetterebbe l’astrazione dalla
dimensione del contenuto, dal processo di coglimento dei significati linguistici in
quanto tali7. In altre parole, la conoscenza del contenuto e la comprensione dei
segni linguistici e/o degli atti discorsivi sono due facce delle stessa medaglia: esse
non possono essere separate. Presi insieme, entrambi i punti suggeriscono che la
comprensione interpretativa coinvolge un processo dialogico nel quale le credenze
dell’interprete e le presupposizioni di sfondo sono messe in relazione alle espressioni simboliche dell’altro, cosicché emerge un accesso al significato orientato alla
verità. Ma come dobbiamo concepire la comprensione del testo o l’espressione
simbolica in quanto dialogo orientato alla verità? E cosa rende l’interprete in grado
di svelare adeguatamente, sulla scorta di ciò, il significato del testo, ora compreso
come articolazione di credenze su un certo argomento?
Come abbiamo già visto, per cogliere il significato di un testo o di un’espressione simbolica, noi dobbiamo concentrarci sull’oggetto (die Sache selbst), visto che
un testo esprime il suo significato sempre riguardo a un argomento.
Se ci proponiamo di esaminare il fenomeno ermeneutico sul modello del dialogo che
ha luogo tra le persone, è perché l’analogia decisiva tra queste due situazioni apparentemente così diverse come la comprensione di un testo e l’intendersi nel dialogo consiste
anzitutto nel fatto che ogni comprensione e ogni intendersi hanno di mira un oggetto
l’interprete che sta loro di fronte. Come uno si intende con il suo interlocutore su qualcosa, così l’intreprete comprende ciò che il testo gli dice.8
Per comprendere fino in fondo, dobbiamo comprendere cosa dice il testo su
un certo argomento. Tuttavia per capire cosa dice davvero il testo, ci è richiesto
di relazionare noi stessi all’argomento. L’argomento può essere svelato solo a partire da ciò che noi presupponiamo su di esso. Come Heidegger ha mostrato con la
pre-struttura del comprendere, ogni interpretazione deve relazionare il significato
testuale alle nostre proprie precomprensioni. Allo stesso tempo, è anche vero che
noi non possiamo soltanto imporre le nostre credenze e le nostre presupposizioni
al testo. Se la nostra interpretazione vuole davvero essere adeguata al significato
dell’altro, dobbiamo cercare di comprendere il testo o l’altro in quanto tali, cioè
nella loro diversità da noi. L’interpretazione, perciò, è la continua risoluzione tra
il nostro contesto storico e il contesto di sfondo del significato dell’altro. I presupposti principali di questo modello di dialogo interpretativo possono esser esposti
come segue.
1. L’interpretazione non può esser concepita come un processo di immersione
psicologica nell’altro, o come empatia prelinguistica o Nacherleben (rivivere) degli
stati mentali dell’altro. Visto che necessariamente dobbiamo mettere in gioco le
nostre credenze e le nostre presupposizioni, il processo di interpretazione è sempre tale per cui noi stessi formiamo le nostre credenze proprio perché incontriamo
7 H.G. Gadamer, Verità e metodo, pp. 783 e ss..; per un argomento simile cfr D. Davidson,
Inquiries into Truth and Interpretation, (Second Edition) Clarendon Press, Oxford 2001.
8 H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit., pp. 777-779.
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
31
le credenze e le presupposizioni dell’altro. Questo è un processo fondato sulla
nostra capacità di base di relazionarci cognitivamente alle credenze e alle presupposizioni all’interno della nostra prospettiva e del nostro contesto di vita, e perciò
implica una relazione simbolicamente mediata dalla quale non possiamo astrarre9.
2. Nella misura in cui la comprensione è orientata alla comprensione delle credenze, siamo costretti ad attribuire “ragione” o “verità” alle affermazioni dell’altro.
Questo accade perché noi cerchiamo di comprendere le credenze e, per comprenderle, dobbiamo dargli senso. Ma per avere senso, esse devono essere razionali in
una certa forma (razionale, alla luce delle nostre credenze e presupposizioni ovviamente). Con il dare senso al discorso di qualcuno, noi assumiamo sempre, nel nostro atteggiamento naturale verso persone e testi, che quello che dicono possa essere
vero o almeno plausibile. C’è perciò una profonda connessione tra il comprendere
il significato e cogliere la sua ragionevolezza. Gadamer chiama ciò “anticipazione
di completezza [razionale]” e lo presenta come una condizione generale di tutta la
comprensione. “Avere senso” e “essere plausibile o vero” sono perciò identici.
3. Per svelare cosa dice il testo dobbiamo relazionarlo a qualcosa che condividiamo con l’altro. Alterità e differenza possono esser esperiti solo se il testo e il suo
significato sono relazionati agli interessi e alle presupposizioni comuni. Per cercare
di affrontare la domanda che il testo pone, il testo deve essere rimosso dalla sua
posizione di oggetto di comprensione e gli deve essere permesso di parlarci a proposito dell’interesse condiviso. Intraprendere questa appropriazione riflessiva delle
questioni e degli interessi di fondo, ci permette di svelare il significato del testo come
qualcosa di sensato e significativo. Anche se ciò è esperito in modo paradigmatico
nel caso di testi e di espressioni che sono parte della nostra tradizione, lo stesso metodo si applica anche ai testi che appartengono a culture straniere, giacché dobbiamo anche relazionare i loro interessi e prospettive ai nostri, posto che essi debbano
parlare. Ciò è di buon augurio per le scienze umanistiche, dato che, in ultima analisi,
esse sono mirate a produrre interpretazioni significative e rilevanti per noi.
4. Da ciò segue quindi che l’interpretazione dovrebbe essere concepita come un
dialogo orientato alla verità tra interprete e testo. La “logica” che è in vigore nello
scambio lettore/testo è guidata dal ricostruire la domanda cui il testo vuole dare la
risposta e dal comprendere sia la domanda che le risposte date come rilevanti e importanti, cioè giustificate e plausibili. Questo significa che l’interprete è coinvolto
in un processo di valutazione e stima. Ma valutare e stimare la rilevanza e la signi9 Alla luce della nostra discussione seguente, potremmo già notare che il bersaglio è qui la
concezione prelinguistica dell’empatia che assume un misterioso processo di ri-pensamento o reesperienza dei pensieri dell’altro, in qualche modo penetrando nei suoi stati mentali soggettivi.
Tale critica non esclude un modo di comprensione empatica linguisticamente mediata, in cui un
interprete si ponga in relazione con i racconti e le circostanze biografiche di un altro soggetto
allo scopo di comprendere la sua unica prospettiva soggettiva. Pertanto seguiamo Gadamer nella
sua critica di un modello malposto di empatia, ma non nel rifiuto generalizzato di tale approccio.
Per una nuova valutazione del ruolo dell’empatia, cfr. K. Stueber, Rediscovering Empathy, MIT
Press, Cambridge, Mass. 2006; cfr. anche i saggi compresi in H.H. Kögler – K. Stueber (eds.),
Empathy and Agency: The Problem of Understanding in the Human Sciences, Westview Press,
Boulder, Colo. 2000.
32
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
ficatività di un testo o di un atto simbolico non è qualcosa di estraneo o di inadeguato all’interpretazione. Al contrario, visto che la nostra interpretazione esplicita
è necessariamente connessa ad un intero orizzonte di presupposizioni implicite e
credenze, il significato autentico sarà inevitabilmente connesso alle nostre prospettive di valutazione. Questo non è un difetto dell’interpretazione, ma piuttosto la
sua modalità di default. Si tratta della condizione di possibilità per produrre una
lettura sensata di un testo.
5. Possiamo ora capire come tutta la comprensione sia interpretazione, nella
misura in cui l’orientamento ermeneutico verso l’argomento coinvolge le nostre
credenze e presupposizioni. Visto che queste ultime appartengono al concreto
mondo-della-vita, la comprensione interpretativa di un testo mette in luce aspetti
specifici del significato in questione. Ma ciò non rende l’interpretazione “soggettiva”. L’interpretazione è in grado di conquistare la sua vera e propria “oggettività”
attraverso la sfida che la voce del testo presenta. Ma il significato che così emerge
non può esser separato dall’autentico processo di questo incontro. Esso emerge
come vero “intermezzo” tra il lettore e il testo. E visto che questa fusione di orizzonti è legata al contesto dell’interprete, tutta l’interpretazione è applicazione. Il
significato non è prima compreso e poi relazionato al proprio contesto culturale:
nella misura in cui si comprende davvero, l’applicazione al proprio contesto familiare e significativo ha già sempre avuto luogo.
6. Visto che tutto il significato emerge dai concreti contesti culturali, non c’è un
parametro esterno e obiettivo di valutazione; è il nostro senso della verità e della
razionalità che ci guida nel valutare la verità dell’altro. In accordo con queste premesse, l’interpretazione è una fusione di orizzonti, nella misura in cui le differenti
prospettive dell’interprete e del testo si fondono in un nuovo e coerente punto di
vista e in una nuova prospettiva. Gadamer vede la conquista della verità, compresa
come plausibile ricostruzione delle affermazioni dell’altro, come lo scopo continuo
dell’interpretazione. Comprendere ciò che il testo dice che può esser vero è perciò
il “criterio” finale di un’interpretazione di successo.
La forza di questa assunzione dell’interpretazione consiste nel mostrare che
nessun metodo può astrarre se stesso dalla verità che la nostra tradizione (attraverso i suoi pregiudizi costitutivi) ci conferisce. Siamo destinati ad interpretare
alla luce delle nostre credenze prese per vere e delle nostre presupposizioni, che
noi costantemente applichiamo, trasformiamo e ridefiniamo attraverso l’incontro
orientato alla verità con testi, espressioni e situazioni. Le situazioni ermeneutiche,
infatti, sono già sempre comprese alla luce di valori di base e presupposizioni,
sicché l’interpretazione riflessiva dei testi più rilevanti che esprimono e articolano
tali presupposizioni è una via essenziale per ridefinire il nostro essere. Il processo
di comprensione deve perciò esser concepito alla luce della trasformazione interna
delle nostre identità storiche e culturali. Ma questo processo è decostruito, potenzialmente distrutto, se visto attraverso la prospettiva di una coscienza metodologicamente obiettivante. Se il pregiudizio riguardante il ruolo costitutivo dei
pregiudizi per l’intera comprensione è superato – cioè se è compreso il bisogno di
investire le proprie credenze e presupposizioni al fine di comprendere e giudicare
davvero – la possibilità di uscire, di astrarre da un certo punto di vista, diventa un
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
33
fallimento. Il punto di vista senza punto di vista non esiste. Ma da ciò non segue la
conclusione che tutta la conoscenza è relativa, visto che quest’affermazione richiederebbe un osservatore capace di vedere le cose dall’alto, cioè da nessuna parte.
Al contrario la conoscenza è ora orientata alla verità in una maniera determinata
– ossia possiamo comprendere le questioni in gioco, solo con il dare loro senso in
accordo con le nostre credenze e presupposizioni. Tutta la verità è perciò situata, ma
non relativa. Non è quindi legata a un limite che la costringe, visto che può sempre
essere espansa da qualsiasi incontro o sfida le si presenti.
Siamo in grado ora di esplicitare l’ethos dialogico dell’approccio interpretativo.
Innanzitutto, dovendo ricorrere alle nostre credenze e presupposizioni per comprendere, la nostra sostanza “ontologica” diviene il fondamento sulla base del quale
noi incontriamo l’altro. La proiezione delle nostre esperienze simbolicamente mediate e dei nostri pensieri è il ponte attraverso cui possiamo arrivare all’“altro lato”.
Ma l’altro lato deve essere come noi. Le nostre convinzioni e presupposizioni sono
parte del nostro orientamento nel mondo. In quanto tali, essi costituiscono il nostro
“essere-nel-mondo”, che è un mondo sempre definito da relazioni normative e da
orientamenti di valore. Si tratta, inoltre, di un mondo in cui abitiamo in maniera
intenzionale, cioè esso esprime i progetti che abbiamo riguardo al futuro10. Questi
progetti sono sempre in una certa misura condivisi con altri soggetti umani, sono
localizzati in un mondo sociale eticamente definito11. Da ciò segue che comprendere
un altro soggetto umano attraverso l’interpretazione delle sue espressioni simboliche
è un atto che necessariamente identifica l’altro come agente costituito in modo simile
a noi. Nella misura in cui davvero possiamo dare senso agli atti e alle espressioni
dell’altro, noi lo facciamo in relazione alla nostra esistenza intenzionale. Semplicemente, noi non possiamo avere una relazione interamente obiettivata con le nostre
credenze e presupposizioni. Esse fanno parte del nostro orientamento nel mondo,
che è flessibile, intrinsecamente aperto e interpretativamente definito. Visto che siamo costretti a svelare i significati dell’altro su questa base, noi abbiamo già sempre
attribuito uno status etico all’altro, sia che ne siamo coscienti, sia che non lo siamo.
In aggiunta, assumere un atteggiamento esplicitamente dialogico renderà ancora più ovvio l’implicito potenziale normativo dell’interpretazione. Si noti che, pur
dovendo attingere dalle nostre credenze e presupposizioni, che hanno in quanto
tali un carattere etico, noi possiamo non essere coscienti di questo fatto. Possiamo
“leggere” l’altro secondo un copione che determina, classifica, oggettivizza e riduce
l’altro ad una qualche caratteristica oggettivamente predicabile del mondo. Ma se
noi comprendiamo che un simile processo, nella misura in cui afferma di classificare
così gli atti di un altro uomo, è basato su una attribuzione di significato (sia pure
implicita), possiamo apertamente approvare il movimento oscillante tra le nostre
presupposizioni e quelle dell’altro. Questa modalità di interpretazione dialogico
riflessiva è definita da una caratteristica essenziale: l’apertità. L’apertità è intrinse-
10 M. Heidegger, Essere e tempo; cfr. anche H. Dreyfus, Being-in-the-World: A Commentary
on Heidegger’s Being and Time, MIT Press, Cambridge, Mass. 1991.
11 C. Taylor, Radici dell’io, tr. it. di R. Rini, Feltrinelli, Milano 1993.
34
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
camente etico-ontologica. Questo accade perché l’apertità, in questa sede, nel caso
dell’incontro intersoggettivo tra due agenti umani, significa che l’altro appare come
soggetto capace di sfidare, rifiutare, trasformare – in una parola: mettere in discussione le mie credenze e prospettive riguardo ad un argomento condiviso. Il processo
interpretativo nel quale cerco di comprendere l’altro, che è possibile solo perché relaziono ciò che io leggo e ascolto con le mie credenze prese per vere, diviene un processo espressamente interrogativo, in cui le visioni mie e dell’altro sono acquisibili.
Ma questo definisce la forma ultima per riconoscere l’altro come soggetto razionale,
e perciò per costituire eticamente l’altro come soggetto, cioè su un fondamento reciproco. Il processo dialogico è l’estensione di una modalità generale di esperienza
che è definita da una negatività dialettica. Nel caso dell’esperienza ermeneutica,
però, il feedback negativo che io posso incontrare proviene da un soggetto con il
quale condivido la questione in gioco. Entrare in un simile processo – o piuttosto,
permettere a me stesso e all’altro di entrare in questo scambio dialogico – costituisce l’altro, in primo luogo, come soggetto che può esser eticamente valutato12.
Questa reciprocità dialogica, infine, procura il legame etico che tiene insieme i
nostri mondi-della-vita sociali e culturali. Abbiamo affermato in precedenza che
la proiezione di significato basata su credenze e presupposizioni rivela sempre un
certo contesto etico di sfondo. Ma se noi entriamo in un processo di interpretazione
dialogica riflessivamente assunto, noi ci troviamo di fronte alla sfida potenziale e alla
carica negativa espressa dalla visione di un altro. Ora, suggeriamo che solo interpretando in modo dialogico le credenze e le presupposizioni dell’altro, cioè assumendoli in una modalità caratterizzata dall’apertità e dall’anticipazione razionale delle
vedute dell’altro, possiamo sperare di ricostituire i legami etici che definiscono le
nostre tradizioni. In altre parole, il processo dialogico di interpretazione costituisce
una forma di comprensione che tiene conto del potere di legare normativamente che
i soggetti etici e le norme richiedono. Orientando se stessi verso l’altro in maniera
aperta dialogicamente, le credenze essenziali, le presupposizioni e gli orientamenti
valoriali possono emergere e diventare parte di un discorso condiviso13. Solo se questo accade è possibile ricostituire i legami potenzialmente spezzati tra gli agenti. E se
12 Per Gadamer, l’esperienza è in essenza sempre negativa. Facciamo esperienza quando
incontriamo qualcosa di inaspettato, che ci sfida e resiste: ciò mette in luce l’esistenza di qualcosa
al di là di noi, l’in-sé, che si confronta con noi ed esige una risposta. Quale fenomeno ciò indica
la connessione e apertura del sé ad un mondo che è oltre il suo controllo o costruzione. Tuttavia
è importante notare che l’esperienza significa qualcosa di più che essere sfidati: essa implica una
comprensione, un “fare-esperienza”, che implica che essa muove oltre la sfida, verso una nuova
e migliore comprensione delle cose. Gadamer enfatizza che il vero risultato dell’esperienza è che
la coscienza che esperisce comprende la sua stessa trasformazione cognitiva come qualcosa che
davvero trasforma l’oggetto (H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit., pp. 715 e ss.). La concezione
dialogica dell’interpretazione mira ad applicare questa intuizione generale alla situazione particolare di una comprensione tra due soggetti, in accordo alla quale, in ultima analisi, è modellata
la nostra concezione dell’interpretazione nelle scienze umane.
13 Charles Taylor fa di questa intuizione la pietra d’angolo della sua concezione del riconoscimento etico in ambito multiculturale. Cfr. C. Taylor – J. Habermas, Multiculturalismo. Lotte
per il riconoscimento, tr. di L. Ceppa e G. Rigamonti, Feltrinelli, Milano 1998.
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
35
le cose stanno così, è chiaro che l’atteggiamento dialogico implica un orientamento
interpretativo che è definito da un orientamento etico verso l’altro.
2. Origini normative delle prospettive interpretative
Secondo Gadamer, l’analogia cruciale tra interpretazione e conversazione non
significa ignorare la differenza essenziale che esiste tra queste due situazioni. È
interessante notare che Gadamer non si concentra qui sull’incapacità del testo di
rispondere istantaneamente e correggere le possibili mosse errate dell’interprete,
come un autentico processo di comunicazione intersoggettiva potrebbe permettere. Piuttosto, essendo interessato a una teoria dell’esperienza ermeneutica, Gadamer sottolinea che il dialogo ermeneutico con il testo, pur analogo alla conversazione, non è orientato a comprendere i pensieri e le intenzioni dell’altro concreto,
ma piuttosto si rivolge a quei pensieri come a un’articolazione della tradizione. Perciò, nell’esperienza ermeneutica, il dialogo orientato alla verità non intende entrare nella coscienza dell’autore, ma piuttosto tenta di farsi interrogare e indirizzare
dalle affermazioni di verità del testo, in quanto valida espressione della tradizione.
Ma per esser capace di svelare la tradizione in questo modo, il modello di dialogo
orientato alla verità tra due soggetti deve tuttavia fare da guida:
L’esperienza ermeneutica ha a che fare con la tradizione. È questa che costituisce
l’oggetto di tale esperienza. L’esperienza non è semplicemente un evento che nell’esperienza si impari a conoscere e a padroneggiare, ma è linguaggio, cioè ci parla come un
tu. Il tu non è un oggetto ma si rapporta a noi. Ciò però non va erroneamente inteso
nel senso che, nella tradizione, ciò di cui si fa esperienza sia da comprendere come
l’opinione di un altro, che sarebbe il tu. Noi riteniamo invece che la comprensione di
un dato storico trasmesso non comprende il testo tramandato come l’espressione di un
determinato tu, ma lo intende invece come una struttura significativa sciolta da ogni
legame con il particolare opinare di questo o quell’io o tu. Tuttavia, il rapporto con il tu
e il senso dell’esperienza che in tale rapporto si verifica devono poter servire all’analisi
dell’esperienza ermeneutica. Giacché anche la tradizione storica è qualcosa con cui siamo autenticamente in comunicazione come l’io con il tu.14
La duplice affermazione che il nostro approccio ermeneutico verso il testo è
analogo alla conversazione con un altro agente, e che tuttavia esso non vuole essere
costruito come qualcosa che raggiunge i suoi pensieri concreti, può in un primo
momento confondere. Ma essa ha senso se vista sullo sfondo del dato che i testi
sono momenti della tradizione in cui le credenze essenziali, le presupposizioni e i
valori di un contesto culturale sono espressi. Se riflettiamo sulla presupposizione
generale che tutta la comprensione interpretativa è fondata su una precomprensione olistica e culturalmente determinata, osserviamo che il testo non dovrebbe
essere visto come il prodotto di un ente psicologicamente autonomo, che inventa i
14 H.G. Gadamer, Verità e Metodo, cit., pp. 737-739.
36
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
suoi pensieri, per così dire, nel laboratorio cognitivo isolato di una singola mente.
Piuttosto, le cosiddette “intenzioni dell’autore” sono esse stesse espressioni di un
continuo dialogo situato in una tradizione che si evolve storicamente e specificata
culturalmente. Perciò, l’esperienza ermeneutica con il testo è un dialogo orientato
alla verità che si apre a ciò che il testo (in quanto espressivo della tradizione) ha da
dire, ma senza esplicito riguardo ai pensieri concreti dell’altro15.
Questa identità qualificata del dialogo interpretativo e di quello reale si mostra
cruciale per l’affermazione normativa di Gadamer riguardo all’esperienza ermeneutica. Mantenere questa analogia permette a Gadamer di affermare ancora che
ogni approccio interpretativo alla tradizione – grazie alla sua intrinseca costituzione dialogica – è essenzialmente simile, dal punto di vista etico, ai reali incontri
intersoggettivi. A sua volta, ciò è giustificato dal fatto che, in questo e in quel caso,
l’ultimo “oggetto” di comprensione è un essere umano ed è perciò definito come
un fenomeno morale. Subito dopo aver introdotto l’idea di modellare l’esperienza
ermeneutica sulla scorta della relazione Io-Tu, Gadamer spiega: «Che l’esperienza
del tu sia necessariamente qualcosa di specifico, in quanto il tu non è un oggetto,
è un fatto chiaro […]. Poiché qui l’oggetto dell’esperienza ha esso stesso un carattere personale, tale esperienza è un fenomeno morale, e così pure il sapere che
attraverso l’esperienza si acquisisce, la comprensione dell’altro»16.
Incontriamo qui un’argomentazione esplicita che riguarda l’essenza etica
dell’interpretazione. Gadamer tenta di articolare il momento etico nella comprensione tracciando modalità interpretative di connessione all’altro, al fine di valutare
gli orientamenti delle relazioni intersoggettive. Nel complesso, i tre atteggiamenti
morali verso l’agente sono (a) valutati nei termini della loro dignità morale e (b)
comparati alle prospettive metodologiche nelle scienze umane e sociali. Se un atteggiamento interpretativo può essere connesso ad una relazione morale discutibile, diventa esso stesso moralmente dubbio. Usando questo paragone, la possibilità
di sostenere atteggiamenti interpretativi è, almeno in parte, resa dipendente dalla
possibilità che essi rendano giustizia al loro “oggetto” di comprensione, ossia all’altro agente in quanto agente morale. Se ha successo, il mettere insieme gli atteggiamenti morali con le prospettive metodologiche porta alla luce la dimensione etica
nell’interpretazione. In aggiunta, il momento etico dovrà all’impegno ontologico
dell’interpretazione la comprensione dell’altro come co-soggetto umano. Infine
Gadamer cerca di mostrare che, sulla scorta di questa base, può esser dimostrata la
superiorità dell’approccio dialogico in relazione al testo e al significato culturale17.
15 In ogni caso focalizzare la comprensione di un testo direttamente sull’intenzione dell’autore sarebbe metodologicamente malposto, dato che il pensiero dell’autore può essere ricostruito solo attraverso la comprensione del testo, il che richiede il coinvolgimento delle proprie
credenze e assunzioni e dunque una mediazione tra il proprio e l’altrui contesto (piuttosto che
una trasposizione diretta nella mente altrui). Come vedremo, ciò non esclude un modo di comprensione empatica linguisticamente mediato, che segua le narrazioni degli agenti individuali.
16 H.G. Gadamer, Verità e Metodo, cit., p. 739; il secondo corsivo è mio.
17 Questo approccio è prima facie plausibile dato che applica il fondarsi dell’interprete nel
retroterra storico-culturale al processo dell’interpretazione metodologicamente raffinata che ha
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
37
Ma un conto è mostrare che l’approccio dialogico costituisce la cornice di base
per l’accesso epistemico al significato, un altro conto è scartare del tutto approcci alternativi alla comprensione interpretativa epistemica, basati su una presunta
mancanza di riconoscimento morale. Nondimeno, questa è precisamente la strategia di Gadamer. In prima istanza, egli abbina l’atteggiamento intersoggettivo di
una Menschenkenntnis oggettivante con l’approccio metodologico costitutivo delle scienze sociali. Al livello delle reali relazioni intersoggettive, questo atteggiamento punta a una conoscenza generalizzabile della natura umana, che può esser usata
per prevedere e controllare l’altro agente. Visto che l’altro è svelato in termini di
modelli osservabili e schemi che permettono una predizione controllata dinnanzi
alle azioni dell’altro, l’atteggiamento è di certo strumentale. L’altro è ridotto a divenire: «Il suo comportamento ci serve al pari di qualsiasi altro mezzo in vista dei
nostri scopi. Sotto il profilo morale questo rapporto con il tu significa la pura riduzione degli altri a strumenti e contrasta con la destinazione morale dell’uomo»18.
Secondo Gadamer, questo orientamento verso l’altro è replicato dalle scienze
sociali orientate da leggi. Approcciando l’oggetto culturale e storico dalla prospettiva della terza persona, cercando di identificare leggi generalizzabili per poter
spiegare il rispettivo comportamento, questo atteggiamento interpretativo è il corrispettivo metodologico dell’atteggiamento che oggettiva il mondo della vita, atteggiamento che abbiamo visto contraddire la nostra più profonda intuizione morale: «Chi comprende in tal modo la tradizione storica la tratta come un oggetto, il
che vuol dire però che si pone davanti alla tradizione come libero e disinteressato
[…]. Abbiamo visto che un osservatore di questo tipo si separa dalla vivente tradizione entro al quale egli stesso ha la sua storica concretezza»19. Di conseguenza, la
moralmente sospetta oggettivazione dell’altro nel mondo della vita è replicata da
un atteggiamento che nega all’altro il diritto di sfidarci e di affrontarci, che nega a
sua volta all’altro il riconoscimento della sua piena umanità.
Il difetto normativo dell’oggettivazione sociologica, tuttavia, non deve essere
curato dalla svolta ermeneutica intrapresa dalla coscienza storica (il secondo obiettivo di Gadamer). La coscienza storica si confronta con un orientamento nel mondo-della-vita che riconosce l’altro come una persona pienamente individuale. In
questo atteggiamento empatico e vissuto in prima persona, l’altro non è ridotto nei
termini di leggi generali derivate dalle condizioni sociali, psicologiche e storiche
oggettive. Questo approccio, piuttosto, si vanta di occuparsi attentamente della
costituzione originale del suo oggetto, costituito in quanto co-soggetto umano, per
luogo nelle scienze umane e sociali. Poiché astrarre dalle proprie assunzioni e pratiche ereditate è
un’illusione metodologica, la connessione tra le specifiche prospettive epistemiche sul significato
e le loro implicazioni normative ha senso. L’interpretazione ermeneutica resta collegata all’orizzonte di vita mondana che opera attraverso incontri dialogici, dunque l’interpretazione riflessiva
ha luogo in un continuum con i contesti culturali concreti. Allo stesso tempo, come vedremo, la
discrepanza tra un vero incontro intersoggettivo e l’attitudine interpretativa delle scienze umane
determina una differenza riflessiva che può modificare la nostra valutazione normativa.
18 H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 739.
19 Ivi, p. 739.
38
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
comprendere pienamente l’altro. Gadamer perciò garantisce che questa modalità
di comprensione presenta un vantaggio sulla coscienza sociologica, visto che ora le
circostanze originali e gli stati soggettivi sono almeno presi seriamente come base
per la comprensione. Eppure, riguardo all’implicazione normativa, che chiede che
l’altro sia pienamente riconosciuto come soggetto umano capace di rivolgere affermazioni verso se stesso, quest’atteggiamento si può riassumere brevemente così:
«Un secondo modo dell’esperienza del tu e della comprensione del tu è quello in
cui la persona è bensì riconosciuta come un tu, ma nonostante ciò la comprensione
del tu rimane una forma di riduzione all’io [...]. In tal modo il Tu perde l’immediatezza con cui si rivolge all’altro […]. Nella misura in cui si comprende l’altro e si
pretende di conoscerlo, si toglie ogni fondamento alle sue pretese»20.
Gadamer attribuisce questa “perdita di immediatezza” alla natura riflessiva di
questo approccio, nel quale l’interprete distacca se stesso dalla relazione intersoggettiva, spesso affermando di “comprendere l’altro meglio di quanto egli comprenda se stesso”. Eppure puntare ad una completa comprensione dell’altro non è altro
che “una forma riflessiva di dominazione”21.
Allo stesso modo, il corrispettivo atteggiamento assunto nelle scienze umane è
definito da un ethos del dominio: «In quanto nella condizionatezza di quest’unico,
essa pretende di liberarsi completamente di ogni conoscenza, essa [la coscienza
storica] rimane tuttavia prigioniera di un’apparenza dialettica, giacché in realtà
non fa che cercare di rendersi padrona del passato»22. Così facendo, infatti, essa
distrugge il fondamento autentico sul quale può sorgere il riconoscimento dell’altro, in quanto agente determinato da un orientamento al valore: «Chi non vuol
riconoscere i giudizi che lo determinano, non saprà vedere neanche le cose che
alla luce di questi gli si mostrano»23. La stessa cosa accade con l’oggettivazione
storicistica dei testi e delle azioni in cui il significato è compreso nei termini di circostanze uniche e concrete: «Allo stesso modo chi si ritrae dal rapporto vivente con
la tradizione storica, distrugge il senso vero di questa tradizione»24. In altri termini,
il metodo empatico e individualizzante è, alla fine, solo un approccio oggettivante
al pari di quello sociologico, visto che distacca la capacità di affermare la verità
implicata nella tradizione dagli atti significativi e dalle espressioni dell’altro. Ciò si
compie rendendo l’altro un oggetto di comprensione individualmente compreso.
Il terzo e “più elevato tipo” di esperienza ermeneutica di Gadamer consiste
nell’atteggiamento di apertità dialogica che abbiamo ricostruito nella prima sezione
di questo saggio. In questo contesto è importante notare che tale “coscienza determinata storicamente” fa riferimento anch’essa ad un orientamento nel mondo della
vita. Gadamer indica un ethos dell’apertità come fondamento sul quale solamente
le relazioni mutuamente rispettose e realmente vincolate possono fiorire. Come abbiamo visto, questo ethos dialogico implica che si voglia essere sfidati, aperti alla
20
21
22
23
24
Ivi, pp. 741-742.
Ivi, p. 743.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
39
visione dell’altro e alla critica. Esso implica che si operi con l’altro in uno spirito
che vada oltre l’insistenza dogmatica sulle proprie giuste vedute, così come oltre un
distaccato “lasciare che l’altro sia” ponendosi fuori dalla conversazione. Al contrario, esso solo riconosce pienamente l’altro aprendo se stesso alle sue affermazioni:
Nel rapporto con gli altri, come abbiamo visto, ciò che importa è esperire il tu davvero come tu, cioè sapere ascoltare il suo appello e lasciare che ci parli […]. Senza questa
radicale apertura reciproca non sussiste alcun legame umano. L’essere legati gli uni agli
altri significa sempre, insieme, sapersi ascoltare reciprocamente […]. L’apertura verso
gli altri implica dunque il riconoscimento che io devo lasciare che in me si affermi qualcosa come contrapposto a me, anche quando non ci sia di fatto nessuno che lo sostenga
contro di me.25
Perciò, l’ethos ermeneutico consiste nella creazione dello spazio dialogico oltre
il dogma e la doxa, oltre l’ostinato aggrapparsi ai pregiudizi (più o meno riconosciuti) e l’astenersi dal valutare, che tratta la visione dell’altro come le sue “personali” opinioni tali che a esse non sarà permesso di diventare davvero significative.
Occorre lavorare attraverso conflitto e dissenso, coinvolgendo le proprie visioni e
i propri valori in un’aperta conversazione con l’altro, in modo tale che un nuovo
produttivo consenso possa essere realizzato. Solo ciò può rinnovare la tradizione,
in quanto solo ciò può essere la base di un mutuo impegno per valori ed idee. Visto
che tutti i nostri orientamenti di valore e pensieri provengono dalla pre-comprensione culturalmente determinata, il lavoro interpretativo nelle scienze umane deve
naturalmente apparire guidato dallo stesso ethos: «Io devo riconoscere i diritti
della tradizione storica non nel senso di un puro riconoscimento dell’alterità del
passato, ma accettando che esso abbia qualcosa da dirmi»26. Visto che la nostra esistenza è infine fondata su valori e pensieri che ci sono giunti attraverso la cultura e
la tradizione, è logico che il lavoro riflessivo che punta a ricostruire il loro contenuto sia guidato dallo stesso ideale che viene assunto come necessario per sostenere
un mondo della vita condiviso.
Lo è davvero? Chiaramente l’ethos del rispetto dialogico è cruciale se siamo interessati a comprendere adeguatamente i pensieri intenzionali e valori che la nostra
tradizione ci ha consegnato. Sembra chiaro, inoltre, che Gadamer presenti un forte
argomento in favore di tale approccio, come adatto a rinvigorire i valori condivisi
che definiscono la sostanza della nostra identità culturale. Tuttavia, sembra che la
stretta connessione che Gadamer stabilisce tra, da una parte, l’atteggiamento intersoggettivo del mondo della vita (che potrebbe o non potrebbe meritare la nostra
approvazione morale), e dall’altra gli approcci interpretativi verso la tradizione
(che sono perciò resi oggetto di valutazione morale), lasci inutilizzato l’autentico
obiettivo etico dell’interpretazione riflessiva nelle scienze umane e sociali. Gadamer sembra suggerire che, viste le carenze morali degli approcci socio-scientifici e
storico-empatici, ciò con cui infine rimaniamo è un approccio dialogico orientato
25 Ivi, p. 745.
26 Ivi, p. 745.
40
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
alla verità. La lezione sarebbe che l’inevitabile coinvolgimento dei pregiudizi presi
per veri nell’interpretazione, significa che testi azioni e pratiche culturali devono
in genere essere direttamente coinvolti in una stima del valore di verità. In questo
modo l’interpretazione che ha successo sarebbe quella in cui la verità del suo tema,
emergente da un processo produttivo di condivisione di prospettiva, serve come
“criterio” dell’adeguatezza dell’interpretazione. Solo in casi di fallimento di tale
consenso effettivo siamo costretti a rivolgerci al contesto storico o psicologico per
la “spiegazione”27. L’implicita struttura di tutta la comprensione attraverso assunzioni olistiche, simbolicamente mediate e valorialmente orientate, sarebbe dunque
intesa come se richiedesse l’esplicito orientamento alle specifiche affermazioni di
verità e validità poste dall’altro.
Ma tale conclusione assumerebbe erroneamente che l’ambito del significato intenzionale sia esaurito dagli aspetti che rivelano sé stessi nella modalità orientata
alla verità. Tale assunzione è lontana dall’essere ovvia, se pur non completamente
problematica. Se l’interprete ha a che fare con il fine genuino del comprendere la
tradizione, l’identificazione della tradizione con solo quelle dimensioni che si prestano alla valutazione (e approvazione!) morale in prima o seconda persona sembra una decisione che richiederebbe almeno un argomento addizionale. In effetti
ogni pratica o istituzione può e deve essere fatta oggetto di giudizio normativo,
ossia può e deve essere valutata nella misura in cui la sua realtà incanala o meno i
valori che desidera realizzare e istituzionalizzare, e nella misura in cui può venire
o meno apprezzata su questa base. Ma assumere che la logica attraverso la quale le
pratiche sociali e le istituzioni funzionano, sia pienamente definita e esaurita dagli
orientamenti di valore che definiscono il loro esplicito ambito normativo equivale
a una riduzione idealistica del mondo sociale ai significati intenzionali. In particolare, ridurre simbolicamente l’ambito metodologico degli approcci interpretativi a
un esplicito orientamento alla verità porterebbe ad assumere tre affermazioni che
sembrano insostenibili alla luce della nostra conoscenza del mondo sociale. Primo,
assumerebbe che tutte le pratiche culturali e le istituzioni sono riprodotte attraverso il modello dialogico della ricerca della verità, negando perciò la costruzione
di istituzioni e campi sociali dovuti a modalità operative strategiche e funzionali28.
Secondo, implicherebbe la negazione che gli spazi di esperienza istituzionalmente
stabiliti (che sono dovuti a modalità di interazione definite dal potere) abbiano
la capacità di dischiudere regni di esperienza e “verità” che reintegrano pertanto
27 Cfr. H.H. Kögler, The Power of Dialogue: Critical Hermeneutics after Gadamer and
Foucault, MIT Press, Cambridge, Mass. 1996, pp. 114 e ss.
28 Il dibattito sulla teoria dell’azione comunicativa di J. Habermas, secondo la quale i sottosistemi funzionali dell’economia e della politica sono definiti da efficacia e potere, può esemplificare questa tesi. Mentre anche questi ambiti implicano qualche orientamento normativo, il
loro modus operandi può difficilmente essere compreso in accordo con l’enfatico modello della
ricerca dialogica della verità, che Gadamer individua al centro della nostra tradizione. Cfr. J.
Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, a cura di G.E. Rusconi, tr.it. di P. Rinaudo, Il Mulino,
Bologna 1986; vedi anche la sua esplicita critica dell’idealismo gadameriano in Habermas, Logica
delle scienze sociali, tr. it. di G. Bonazzi, intr. di A. Santucci, Il Mulino, Bologna 1970.
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
41
l’orizzonte della tradizione basato su valori29. Infine, tale approccio assumerebbe
che la precomprensione culturale, in quanto presente sia nell’agente interprete
che nell’agente interpretato, è essa stessa libera da ogni influenza delle pratiche di
potere istituzionali e sociali30.
3. L’ambito riflessivo dell’esperienza ermeneutica
Se accettiamo questa situazione, emerge il compito di rendere giustizia al completo ambito ermeneutico della nostra tradizione. Dobbiamo far ciò senza perder
di vista l’ethos dialogico che Gadamer ha così vigorosamente sostenuto. Il compito
perciò non può significare ridurre l’atteggiamento dialogico alle modalità storicoempatiche e socio-scientifiche dell’interpretazione. Tale riduzione è già esclusa dal
fatto che ogni comprensione – questo il durevole contributo di Gadamer – è fondata
su una precomprensione orientata al valore che deve essere affrontata. Ma dobbiamo
riconsiderare l’inferenza di Gadamer, a partire dagli orientamenti etici del mondo
della vita in direzione delle prospettive metodologiche. Fondare in questo modo il
momento etico dell’interpretazione potrebbe infatti condurre a un impoverimento
del suo pieno potenziale normativo. Senza dubbio, i critici potrebbero osservare che
l’inclusione di prospettive rivolte ai legami di potere o agli stati emozionali-soggettivi
riduce l’agente al rispettivo contesto sociale o storico-vitale. Dato che in ultimo trattano l’altro come un soggetto-oggetto determinato, finiscono con il negarne il modo
fondamentale del riconoscimento dialogico. Ma questa osservazione trascura che
noi non escludiamo l’interpretazione dialogica come una modalità di interpretazione
esplicita; e tuttavia affermiamo che il nostro compito attuale richiede di tenere assoluto conto della determinatezza dell’agente culturale, in modo tale che tutti i fattori
essenziali che entrano a formare la sua identità culturale siano portati alla luce. L’insistenza di Gadamer sulla radicale determinatezza culturale di ogni comprensione,
che è volente o nolente definita come processo influenzato storicamente, ci costringe
ad andare al cuore reale dei significati e delle condizioni degli agenti. Riteniamo
che, visto che i fattori socio-istituzionali così come psicologico-biografici impattano
essenzialmente l’essere dell’agente, dobbiamo assicurarci che l’ambito dell’interpretazione sia abbastanza largo da catturare anche questi fattori determinanti. Il vero
29 Cfr. ad es. lo studio di Foucault sulla clinica, ove la ristrutturazione politica dell’ospedale
conduce ad un nuovo sguardo oggettivante sul corpo, che rende possibile alcune fondamentali
intuizioni della medicina moderna: M. Foucault, Nascita della clinica, tr. it. di A. Fontana, Einaudi, Torino 1969; per la sua prospettiva generale sul potere, cfr. spec. Sorvegliare e punire, tr.
it. di A. Marchetti, Einaudi, Torino 1993; e la Storia della sessualità, a cura di P. Pasquino e G.
Procacci, Feltrinelli, Milano 1978.
30 Cfr. il classico studio di Edward Said sull’orientalismo, nel quale l’autore dimostra come
la visione occidentale del Medio Oriente, per quanto disinteressata, empatica, e perfino simpatetica, resti strutturata dalla realtà soggiacente del colonialismo e postcolonialismo: E. Said,
Orientalismo, tr. it. di S. Galli, Bollati Boringhieri, Torino 1991. Per una discussione critica sul
potenziale di dialogo in tali contesti, cfr. Mandair, Arvind-Zene, Cosimo (eds.), Dialogue as the
Inscription of “the West”, in “Social Identities”, numero speciale, 2005.
42
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
riconoscimento etico non si arresta a ciò che si presta a una pura comprensione simbolica, ma accetta e riconosce ogni agente come definito da condizioni oggettive31.
Di conseguenza proponiamo di rivalutare il ruolo normativo della comprensione socio-scientifica e empatica nell’interpretazione riflessiva. Gadamer ha ragione
a enfatizzare che la ricostruzione dialogico-interpretativa delle credenze e delle
assunzioni di valore definisce un importante atteggiamento interpretativo. Ma dal
fatto che ogni interpretazione procede da una precomprensione linguisticamente mediata, non segue che solo questo modo debba governare le nostre pratiche
scientifiche di interpretazione. Proponiamo al contrario di esplorare il potenziale
di approcci alternativi, che sarebbero analogamente fondati sull’intuizione ermeneutica che tutta la comprensione è culturalmente e storicamente fondata. Perciò
ricostruiremo in maniera differente la relazione tra (a) lo sfondo di comprensione
implicito e olistico, e (b) gli espliciti atteggiamenti metodologici nelle discipline
culturali32. Procederemo con il mostrare la percorribilità di tre prospettive interpretative, includendo l’approccio dialogico (1), quello socio-scientifico (2) e quello
empatico (3). Faremo ciò grazie alla ricostruzione della loro costituzione interna
e produttività, a partire da indicazioni su ciò che sono in grado di dischiudere se
adoperati nell’interpretazione riflessiva.
1. Dovremo anzitutto ancora enfatizzare che l’orientamento dialogico al tema in
una modalità riguardante la verità rimane una essenziale modalità di interpretazione
esplicita, sebbene perda il suo status quale unico canone normativamente legittimo.
La prova della validità di tale approccio quale possibile prospettiva, è fenomenologica. L’esperienza di un testo o di un’espressione simbolica implica un incontro di
significato che può essere adeguatamente caratterizzato quale esame di una tesi o di
una sfida, senza bisogno di invocare alcun soggetto concreto o persona “dietro al
31 Non è sufficiente rispettare l’altro come soggetto morale autonomo; e neanche ridefinire
in qualche modo questa attitudine alla luce di un riconoscimento intersoggettivo delle tesi discorsive dell’altro. Questo è comunque il limite cui si arresta Gadamer. Invece, ciò che occorre
è una prospettiva ermeneutica che richieda non solo la dimensione normativa dell’autonomia
dell’altro riconosciuta intersoggettivamente, ma anche la concreta situazione socio-culturale e
individuale-biografica dell’altro. Nonostante la sua promessa, la gadameriana idealizzazione del
dialogo si prova infine insufficiente a fondare il suo approccio etico. La tesi critica qui non è solo
che Gadamer manca altri fattori essenziali per una concezione etica dell’interpretazione, quali la
“richiesta” originaria posta dalla presenza dell’altro (Levinas), o la costituzione pervasa di potere
dei contesti sociali, che richiede il loro smascheramento e decostruzione (Habermas, Foucault).
Va pertanto avvalorata l’insistenza di Gadamer sul fatto che la mediazione linguistica o simbolica
è cruciale, e che la relazione con l’altro va concepita in termini di un modello dialogico che preserva la capacità altrui di formulare pretese di verità o validità; ma invece di riconciliare questa
dimensione con la contestualità intrinseca di ogni esperienza, che implica contesti di potere
socialmente strutturati così come stati biografici individuali, Gadamer concepisce la comprensione interpretativa come un processo che è in qualche modo sollevato al di sopra della mera
contingenza dei contesti e non prende in considerazione la loro costituzione.
32 Non occorre dire che così facendo non stiamo sostenendo gli orientamenti non-etici del
mondo della vita che Gadamer ha scoperto, replicati nelle prospettive metodologiche del discorso social-scientifico o storico-empatico. Piuttosto, riteniamo che il loro utilizzo in effetti li liberi
da tali parentele, in modo da compiere la promessa etica delle scienze storiche e sociali.
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
43
testo”. In effetti, mentre sto scrivendo/digitando queste righe, io ho direttamente a
che fare con la tesi di Gadamer per cui la comprensione dovrebbe essere modellata
sulla relazione Io-Tu in termini di dialogo orientato alla verità. Con ciò, non ho a che
fare con le disposizioni psicologiche, sociali, culturali o in altro modo oggettivabili di
Gadamer. Non sto ricercando, né ne ho bisogno necessariamente, ciò che lui aveva
in mente al di là di ciò che ha deciso di scrivere. Al contrario, sono coinvolto in un
movimento oscillante tra le mie proprie intuizioni e ciò che il testo dice, nella misura
in cui provo a determinare come capire il testo e come formulare un ragionevole accordo o disaccordo. In questo processo dialogico, io affronto il pensiero del testo, il
Sinngehalt in quanto tale, come Gadamer potrebbe dire. Non ho coscienza di avere
a che fare con i processi mentali o gli effettivi contenuti di pensiero della mente di
Gadamer nel momento della produzione del testo, né vedo come un tale processo
potrebbe aiutarmi a definire la mia propria posizione. Piuttosto, ciò con cui ho a che
fare, e ciò che comprendo come questione e domanda posta dal suo testo, è come
concepire al meglio l’esperienza ermeneutica secondo il dialogo intersoggettivo.
Si dovrebbe immediatamente notare, tuttavia, che il fatto che io sia disinteressato (per ora?) alle prospettive storico-culturali in quanto hanno avuto un influenza sulla mia visione, o inconsapevole di come la mia interpretazione di Gadamer
potrebbe essere inconsciamente informata da fattori simili, non toglie che questi
fattori siano in gioco. Avere una piena comprensione della nostra comprensione
della visione dell’altro – e perciò raggiungere una radicale riflessività riguardo alla
questione così posta – potrebbe ben richiedere prospettive che includano quelle
dimensioni. Se tale approccio possa esser produttivo dipende da cosa siamo in grado di vedere nella sua luce: questa è esattamente la strada che stiamo prendendo
per difendere la sua percorribilità. Perciò, non stiamo sostenendo che una scienza
sociale empatica o critica è ultimamente fondata sugli interessi universali umani di
emancipazione, né suggeriamo che questa forma riflessiva sia necessaria perché la
nostra precomprensione implica diversi strati ontologici, incluso il potere, che richiedono interpretazioni ermeneutiche critiche33. Al contrario, prendiamo spunto
dalla forma cognitiva di pratiche scientifiche prestabilite, e ricostruiamo come esse
aprano in maniera produttiva la realtà in gioco e come siano capaci di comprendere la tradizione, in modo tale che le strutture del potere istituzionale e gli agenti
umani individuali diventano espliciti.
2. Un’analisi socio-scientifica delle pratiche culturali, sebbene necessariamente
collocata in contesti dati per certi e impregnati di valori, è in grado di tematizzare
le configurazioni strutturate dei contesti sociali di sfondo ricorrendo alla natura
riflessiva della comprensione ermeneutica. Visto che ogni prospettiva metodologi-
33 Per la prima opzione cfr. J. Habermas, Conoscenza e interesse, tr. it. di G. E. Rusconi,
Laterza, Bari 1970; la seconda rotta è esplorata in H.-H. Kögler, The Power of Dialogue: Critical
Hermeneutics after Gadamer and Foucault (Studies in Contemporary German Social Thought),
MIT Press, Cambridge 1999, cfr. anche Ricoeur, che intravede un pluralismo metodologico che
include metodi ermeneutici e strutturali: P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, tr. it. di R.
Balzarotti, F. Botturi, G. Colombo, Jaca Book, Milano 1995. Cfr. egualmente il suo più recente e
rilevante saggio Sé come un altro, a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993.
44
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
ca rimane fondata sull’inevitabile mediazione di una precomprensione simbolica
e pratica, la nostra analisi naturalmente si rifà a come tale apertura sia possibile
nel medium del linguaggio. Perciò la dimensione riflessiva (reflexive) dell’interpretazione linguisticamente mediata (che Gadamer cerca di superare tornando
a un’immediatezza riflessa (reflective) riguardo alla verità e al significato) è qui
positivamente valutata, in modo tale che l’altro è intenzionalmente oggettivato.
Questa modalità di oggettivazione non è fondata sull’adattamento malposto di un
modello naturale-scientifico alla comprensione umana, ma emerge dall’esperienza di situazioni e incontri oggettivamente vincolati all’interno dello stesso mondo
socio-culturale. In accordo con questa prospettiva, l’altro agente è visto come un
soggetto parlante e agente coinvolto in relazioni pratiche e discorsive.
Il fine dell’interpretazione è la descrizione empirico-analitica di questi modelli
sociali di base. Perciò, siffatta oggettivazione non è né immorale né motivata da un
puro fine scientifico di creare un ordine scientifico nel suo dominio oggettivo. Piuttosto, l’intento teoretico di scoprire gli schemi, i modelli, le strutture del campo,
è motivato dall’interesse riflessivo di comprendere come le pratiche intenzionali
possano esser formate e strutturate da fattori contestuali finora non riconosciuti,
ed è epistemicamente realizzato e convalidato dai risultati attuali di tali modelli e
strutture. Il movimento oscillante tra le proprie prospettive e quelle dell’altro riguardo al significato del testo, alle pratiche, all’espressione simbolica, punta perciò
a una cristallizzazione discorsiva della prospettiva dell’altro. Una volta che le relazioni e i modelli discorsivi sono descritti, possono essere analizzati in una varietà di
metodi empirici che permette la fondazione delle cornici di significato in un concetto di realtà empirica sociale. La natura linguistica del processo interpretativo è
perciò adoperata per oggettivare riflessivamente le prospettive culturali dell’altro
– e forse infine anche le proprie –, cogliendo le loro strutture interne. Queste cornici discorsive possono essere comparate e poste in relazione a un’analisi delle pratiche sociali e delle istituzioni, inclusi gli aspetti quantitativi rilevanti per la spiegazione. Per esempio la sociologia di Pierre Bourdieu esemplifica quest’approccio
combinando una descrizione etnografica dei particolari schemi interpretativi con
un’analisi quantitativo-empirica dei fattori che causano e mantengono tali schemi nel mondo sociale. La comprensione interpretativa degli agenti determinati è
perciò vista come definita da un habitus pratico-simbolico, il quale (a) serve come
sfondo soggettivo-intenzionale della comprensione di sé degli agenti, e (b) emerge
come categoria oggettivabile della realtà sociale che ancora tale comprensione di sé
in una realtà sociale strutturata e istituzionale34.
3. Tale oggettivazione socio-scientifica dell’agente è solo una prospettiva. Come i
dibattiti nella filosofia delle scienze sociali fanno chiaro, l’ipostatizzazione del metodo
discorsivo-strutturale come il solo e privilegiato accesso al significato sociale esclude
34 P. Bourdieu, Per una teoria della pratica, tr. it. di I. Maffi, Cortina, Milano 2003; Ragioni
pratiche, tr. it. di R. Ferrara, Il Mulino, Bologna 1995. Per una discussione critica di tale approccio cfr. H.H. Kögler, New Directions in the Sociology of Knowledge, numero speciale di “Social
Epistemology”, 1997.
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
45
un altro essenziale componente: la dimensione irriducibile dell’azione esperienziale
individuale, che appare in questo modo come un caso, non come un fattore attivo
nel ricostruire il mondo sociale e il suo significato35. Questa dimensione è aperta attraverso l’atteggiamento empatico. Abbiamo visto che Gadamer l’ha introdotto come
un approccio più adeguato dell’oggettivazione sociale, pur eccependo che fosse in
ultimo un ulteriore (sebbene più individualizzante) modo dell’oggettivazione. E tuttavia, l’inferenza di Gadamer da un atteggiamento intersoggettivo di sopraffazione
grazie ai mezzi della conoscenza è abbastanza differente dall’approccio che punta
a comprendere le specifiche circostanze della vita e della situazione dell’altro. Con
il relazionarsi alla maniera in cui l’altro si trova situato in narrative, storie, concrete
circostanze di vita e eventi, l’interprete articola la dimensione irrevocabile dell’agire
soggettivo che viene perso nella prospettiva sociologica36.
Perciò l’orientamento fenomenologico all’agire individuale dell’altro è nel suo
intento profondamente opposto all’oggettivazione. Invece di evitare, per così dire,
l’agire dell’altro, esso afferma la sua concreta determinatezza biografica e culturale37. Questa interpretazione riflessiva non implica di fermarsi alla comprensione contemplativa dell’altro come oggetto individuale; non vuole quindi assolvere l’altro, considerato come un sé assolutamente unico, da ogni implicazione che
possa avere nei riguardi di noi stessi. Piuttosto, questa prospettiva metodologica
deve garantire che non vengano perse di vista le due dimensioni che intervengono
nell’incontro ermeneutico con l’altro: anzitutto il fatto che l’altro è concretamente
35 G. Delanty (ed.), Handbook of Contemporary European Social Theory, Routledge, London 2006.
36 Per un resoconto di come la comprensione empatica possa essere ricostruita dopo la
svolta linguistica cfr. i capitoli di Stueber, Kögler, e Blackburn in Stueber – Kögler, Empathy and
Agency. Il resoconto di Georg Herbert Mead dell’assunzione di prospettiva come dimensione
nucleare del significato linguistico può aiutare a fondare una concezione dell’interpretazione
empatica orientata alla ricostruzione intenzionale della prospettiva dell’altro grazie all’articolazione delle narrazioni dell’agente: cfr. G.H. Mead, Mente, sé e società, tr. it. di R. Tettucci, Giunti, Firenze 2010. Nel presente contesto l’enfasi maggiore sta nel mostrare che tale prospettiva è
richiesta per rendere giustizia alla promessa etica dell’interpretazione.
37 I sostenitori di tale approccio adoperano l’analisi fenomenologica per ricostruire come le
interazioni sociali e interpretative degli agenti possano essere viste come costruttive del mondo.
Cfr. A. Schutz, La fenomenologia del mondo sociale, a cura di Franco Bassani, Il Mulino, Bologna
1974; H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, N.J. 1967; P. Berger – T.
Luckmann, La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna 1969. Si può raccomandare
che tale approccio venga adoperato per focalizzare la dimensione soggettiva del significato, senza
prenderlo come esaustivo della piena costituzione del mondo sociale. Per un abile utilizzo dell’approccio, che è sempre stato popolare presso gli studi etnografici, cfr. P. Stoller, Money doesn’t smell,
University of Chicago Press, Chicago 2002. Che l’analisi etnografica delle storie di vita sia altamente rilevante per le altre due prospettive, dialogica e socio-scientifica, è esemplificato da Saba
Mahmood nella ricostruzione del modo in cui certe donne comprendano se stesse quali soggetti
riflessivamente collocati nell’Islam; cfr. S. Mahmood, Politics of Piety. The Islamic Revival and
the Feminist Subject, Princeton University Press, Oxford 2005; per una visione più critica, che
colloca tale autocomprensione entro il contesto più ampio di una “sfera pubblica islamica”, cfr.
De Jorio – Rosa, Between Dialogue and Contestation: Gender, Islam, and the Challenges of a Malian Public Sphere, in “Journal of the Royal Anthropological Institute (Man)”, numero speciale
2009, pp. 95–111.
46
HANS-HERBERT KÖGLER
Philosophical News
determinato in un contesto specificamente definito che ha sempre già dato forma
alla sua individualità, e poi che l’altro deve venire considerato come agente riflessivo capace di risposte e decisioni autonome, ossia critico-riflessive, basate sul suo
particolare contesto di vita e sulla sua particolare situazione. In altre parole, la modalità empatica di interpretazione non implica che stiamo oggettivando illegittimamente l’altro, ma piuttosto punta a una comprensione dell’altro come unicamente
definito e tuttavia co-soggetto riflessivamente autonomo con cui noi siamo in una
complessa relazione etica e interpretativa38.
L’orientamento interpretativo verso l’agire individuale dell’altro è perciò cruciale, visto che completa la comprensione scientifico-sociale con l’insormontabile
dimensione dell’agire che previene uno strutturale o sistematico riduzionismo del
significato sociale a forze transoggettive. Questo complemento socio-ontologico si
prova essenziale anche per un adeguato accesso epistemico all’agire umano nella
sua dimensione socio-culturale. Come Peter Winch ha mostrato, il problema della
comprensione degli atti e pratiche sociali differisce in un aspetto importante dalla
comprensione degli eventi naturali39. Mentre tutte le forme di comprensione coinvolgono una comunità di interpreti, che segue certe regole in base alle quali viene
accettato e determinato ciò che deve contare come significato condiviso e come
fatto, lo scienziato sociale si trova di fronte ad una sfida peculiare. Piuttosto che
semplicemente aderire agli standard della propria comunità, fa conoscenza di regole e ragioni dal lato del suo “oggetto”. Ora, come Wittgenstein ha notoriamente
mostrato, una regola in sé stessa non determina la propria applicazione40. Comprendere come (understand how) seguire una regola significa sapere come (know
how) seguirla correttamente, e ciò significa infine sapere come distinguere i casi
adeguati dell’applicazione da quelli inadeguati. Ma questo è possibile solo con l’acquisizione di un senso pratico della correttezza, di una capacità fronetica di leggere
una situazione alla luce di una regola intuitivamente capita – dato che tale regola
non implica le condizioni della sua applicazione. Perciò la regola di comprensione
intuitiva è una capacità ermeneutica che non può essere resa in termini di codice
strutturato o sistematico. È perciò una dimensione della comprensione che richiede un agente situato che dà senso in una modalità strutturata e tuttavia flessibile e
con diversi esiti possibili. Questa concezione di una comprensione di sé ermeneutica, che sfugge a regole esplicite, integra la discussione epistemica e ontologica grazie al requisito interpretativo di riconoscere l’autocomprensione dell’agente. Visto
che gli agenti già comprendono sempre sé stessi sulla base dell’autocomprensione,
38 Cfr. anche G. Warnke, Gadamer. Hermeneutics, Tradition, and Reason, Polity Press, Cambridge 1987.
39 Cfr. P. Winch, Il concetto di scienza sociale e le sue relazioni con la filosofia, tr. it. di M.
Mondadori e M. Terni, Il Saggiatore, Milano 1972. Per una valutazione recente dei temi che il
saggio di Winch aveva posto, cfr. S. Turner – P. Roth (eds.), Philosophy of the Social Sciences,
Blackwell, Oxford 2003.
40 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1967. Cfr.
anche S. Kripke, Wittgenstein su regole e linguaggio privato, a cura di M. Santambrogio, Boringhieri, Torino 1984.
Philosophical News
ESSERE IN QUANTO DIALOGO
47
che definisce socio-ontologicamente il loro agire, l’interprete si deve relazionare a
quella comprensione, se esige di comprendere il proprio obiettivo. Ma questo richiede, e rende totalmente legittimo, che orienti la sua interpretazione a una comprensione empatica dell’agente individuale, per ricostruire come esso concepisca
la propria determinatezza riguardo agli ambienti socio-storici.
Conclusione
Gadamer definisce il fine della comprensione interpretativa come orientato alla
tradizione. Ma riconoscere la tradizione – riconoscere gli agenti determinati che
esprimono sé stessi nelle pratiche culturali – non è esaurito dall’assumere un approccio orientato alla verità. Proprio perché ogni comprensione interpretativa è
fondata su una precomprensione olistica, che implica i campi sociali e le situazioni
individuali come aspetti della nostra tradizione, gli orientamenti metodici vanno
oltre l’assillo filosofico per il discorso veritativo. Nell’interpretazione dialogica,
siamo orientati verso l’argomento in modo tale da affrontare una domanda condivisa per ottenere nuove intuizioni prese per vere. Nell’analisi socio-scientifica,
tematizziamo i campi sociali e le pratiche nel cui contesto gli agenti situati sono
in grado di pensare, percepire, e agire. E nella comprensione empatica, ricostruiamo le concrete prospettive degli agenti individuali in quanto essi esperiscono
soggettivamente sé stessi in una tradizione. I campi sociali e i contesti di vita individuale non sono soggetti a valutazione allo stesso modo di un testo autorevole che
articola una prospettiva fondamentale su una domanda condivisa. Ma essi sono
tuttavia aperti a partire dallo sfondo delle nostre convinzioni prese per vere, cui
rimangono riflessivamente collegati. Ricostruire come le condizioni sociali strutturino e vincolino l’autocomprensione degli agenti, e come gli agenti individuali
soggettivamente costruiscano e narrino le proprie storie di vita entro tali contesti,
rappresentano strumenti indispensabili per riconoscere pienamente la complessità
della tradizioni culturali. Il compito ermeneutico è ormai di affermare come questi
progetti completino l’interesse dialogico per l’altro, invece di essere opposti a esso.
Lavorando per un’integrazione di tali prospettive nella cornice di un’ermeneutica
dialogica, incoraggeremo una comprensione veramente etica dell’altro.
Hans-Herbert Kögler
University of North Florida
[email protected]
Hans-Herbert Kögler è professore e Direttore del Dipartimento di filosofia della University
of North Florida, Jacksonville. Ha tenuto numerosi seminari e conferenze presso la Alpe-Adria
University, Klagenfurt, Austria, e la Czech Academy of Social Sciences, Praga. Tra le sue maggiori pubblicazioni: The Power of Dialogue: Critical Hermeneutics after Gadamer and Foucault,
(1999); Michel Foucault (2nd edition 2004), Kultura, kritika, dialog (Prague 2006), ed è coautore
del volume Empathy and Agency: The Problem of Understanding in the Human Sciences (2000).
Rémi Brague
Possiamo amare la verità?*
The fundamental requisite for loving truth is that truth is good and beauty. In
the classical age and during the Enlightenment truth coincided with beauty. In the
romantic movement and in the reaction to Enlightenment this equation has been reversed. Today the truth coincides with suspicion. After the truth has been despised we
have to remember that the truth is not comparable to something that is superfluous,
as truth is a need. Moreover truth is hated because it is also redarguens. The only
possibility to accept an uncomfortable truth is the hope in God’s forgiveness.
Avete consacrato la presentazione di questa nuova rivista al tema della verità.
Ma questo verbo “consacrare”, è preso sul serio? C’è qualche sacralità nella verità?
Rousseau aveva scelto come massima per il suo secondo discorso sulla disuguaglianza e come simbolo o programma della propria vita una frase latina di Giovenale: vitam impendere vero, «rischiare la vita per la verità»1.
Ogni universitario, che sia scienziato o filosofo, cerca la verità o fa finta di cercarla. Ma la cerca come si cerca la persona amata? La scoperta della verità è sempre,
come tale, piacevole. Ma non è necessario che il contenuto scoperto sia amabile. Il
poliziotto cerca il colpevole, ma non ama il reo come tale; e la verità che scopre è
sempre brutta, spesso orribile.
Quando si parla d’un amore della verità, dobbiamo distinguere. C’è da un lato
la soddisfazione di conoscere, dall’altro lato la gioia della verità, la gioia nella verità
come tale.
La prima può spiegarsi a partire della volontà di potere, del sentimento di avere
vinto. E ciò in funzione della difficoltà da superare, non direttamente della rilevanza per la vita. Il matematico greco Archimede fece incidere sul proprio sepolcro
la dimostrazione geometrica da lui fatta del rapporto tra il volume del cilindro e
quello della sfera inscritta2. Ma il fatto che il volume della sfera sia i due terzi di
quello del cilindro circoscritto, che cosa significa?
* Relazione tenuta in occasione della presentazione della presente rivista presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Milano, 15 ottobre 2010.
1 Giovenale, Satire, IV, 91; Stoici Latini Minori, ed. I. Ramelli, Milano, Bompiani, 2008, pp.
2290-2291.
2 Cicerone, Tusculanae disputationes, V, 64-66; Plutarco, Vita di Marcello, XXII.
Philosophical News
POSSIAMO AMARE LA VERITÀ?
49
La seconda, la gioia della verità, non si lascia spiegare con la stessa facilità e
soprattutto, non si può giustificare. Abbiamo bisogno di una ragione oggettiva.
Allora, la condizione fondamentale d’un amore della verità è che la verità sia degna
d’amore, ovvero bella.
1. La verità bella
Propria degli scolastici è la teoria della cosiddetta convertibilità delle proprietà
trascendentali dell’essere. Sono chiamate trascendentali le proprietà che si trovano
in tutte le categorie, che non si fermano al loro limite e che, per questo motivo, le
“trascendono”. Allora dicevano che tali proprietà possono convertirsi l’una nell’altra. Ciò significa che ciò che è, è anche uno, buono, e vero. C’era gente, un po’ a
margine, come Bonaventura, che aggiungeva il bello. Per gli altri, il bello era soltanto un aspetto inseparabile del bene.
L’amore alla verità suppone che la verità sia qualcosa di buono o che sembri
buono, perché non si può amare quello che non è buono o almeno che non sembra
tale.
Per l’età classica e illuministica, la verità coincideva con la bellezza. Il poeta
francese del seicento Nicolas Boileau ha espresso con chiarezza questa visione classica del mondo: «Niente è bello se non il vero, solo il vero è amabile» (rien n’est
beau que le vrai, le vrai seul est aimable)3.
2. La verità brutta
Questa tranquilla equazione si è rovesciata nel movimento romantico e prima di
questo nella reazione all’Illuminismo. Così Rousseau fa scrivere all’eroina del suo
best-seller, il romanzo Giulia o la nuova Eloisa, una lettera in cui dice, rispondendo
implicitamente a Boileau: «Niente è bello tranne quello che non è» (il n’y a rien de
beau que ce qui n’est pas)4.
Probabilmente lo scrittore che ha approfondito maggiormente questa idea è
Leopardi. Scrive nello Zibaldone nel dicembre del 1822: «Il vero certamente non
è bello»5. Un anno prima troviamo la formula generale: «Tutto il vero è brutto»6.
Contrariamente all’ordine logico, un anno prima si legge: «La felicità consiste
nell’ignoranza del vero»7. La rappresentazione di una natura crudele, cieca, brutta
si trova in tutto l’Ottocento, soprattutto in Schopenhauer, che è stato nella seconda metà del secolo e fino alla Prima Guerra il filosofo più influente su scrittori ed
3 N. Boileau, Epistola IX (Arte poetica).
4 J.J. Rousseau, La nouvelle Héloïse, VI, 8; Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, 1961, p. 693.
5 G. Leopardi, Zibaldone, 2653 (3.12.1822), in Tutte le Poesie, tutte le prose e lo Zibaldone, a
cura di L. Felici, Roma, Newton Compton, 2007, p. 530b.
6 G. Leopardi, Zibaldone, 1522 (18.8.1821), p. 343b.
7 G. Leopardi, Zibaldone, 326 (14.11.1820), p. 106b.
50
RÉMI BRAGUE
Philosophical News
artisti. Questa Stimmung fondamentale la riassume un personaggio di un dialogo
di Ernest Renan: «chissà se la verità non è triste»8?
Oggi, c’è ancora di peggio: il vero è sospetto. Dicono spesso: la credenza in una
verità assoluta produce il fanatismo, l’intolleranza, ed altri spauracchi. Dunque,
occorre eliminarla in favore di un pluralismo delle “verità”.
3. Quello che rimane
Quello che rimane dopo il disprezzo della verità è un paesaggio intellettuale e
spirituale abbastanza variegato. Mi sembrano importanti tre elementi.
1) Prima di tutto c’è l’accontentarsi di una versione debole della verità. I medievali come Mosè Maimonide, e dopo di loro Spinoza, distinguevano credenze
(i’tiqâd, dogma) vere e credenze utili o pie9. Le vere sono riservate all’élite dei filosofi, quelle utili garantiscono l’ordine della società.
I moderni non distinguono più tra verità e opinione. La verità diventa l’utilità,
punto e basta.
Questo l’aveva visto anche Leopardi con perfetta chiarezza: «La verità era necessaria all’uomo, soltanto come unico fondamento di quelle credenze che sono
necessarie alla sua vita. [...] La perfezione della ragione non consiste nella cognizione di questa verità, perché non consiste nella cognizione della verità in quanto
verità, ma in quanto stabile fondamento delle credenze necessarie o utili alla vita»10.
2) Si predica la tolleranza davanti alla diversità delle opinioni di cui nessuna è
l’unica vera. L’atteggiamento presupposto della tolleranza non è l’amore dell’opinione altrui, neanche il rispetto per la persona che difende questa opinione. Tollerare non è autorizzare, dare libero corso a quello che si considera come buono e
che si vuole promuovere. La tolleranza vuol dire che ci si rassegna ad accettare di
mala voglia un male necessario, che non possiamo eliminare.
3) Un vero che non fosse buono e bello, ma piuttosto cattivo e brutto, non potrebbe essere amato. Nonostante questo, può essere l’oggetto di un altro atteggiamento. Si
tratta dell’onestà intellettuale, per cui il tedesco ha una parola che non si lascia tradurre facilmente in italiano, nemmeno in francese o in qualsiasi altra lingua, la Redlichkeit. Nietzsche dice che è la virtù più recente, una virtù che diviene, ed anche l’ultima
8 E. Renan, Dialogues et fragments philosophiques, in Œuvres Complètes, Paris, CalmannLévy, t. 1, p. 614.
9 Mosè Maimonide, Guida dei perplessi, III, 28, ed. I. Joël, Gerusalemme, Junovitch, 1929,
p. 374; Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, c. 14, ed. van Vloten e Land, L’Aia, 1914, t. 2,
p. 246.
10 G. Leopardi, Zibaldone, 414 e 416 (16.11.1820), p. 125ab.
Philosophical News
POSSIAMO AMARE LA VERITÀ?
51
virtù che ci resta11. È una virtù perché è una specie del genere fortezza, che è una delle
quattro virtù cardinali. Occorre essere forti per accettare quello che dispiace.
4. Tre osservazioni sulla situazione presente
Vorrei fare qui tre osservazioni che corrispondono suppergiù ai tre punti che ho
appena delineato.
1) La verità non è qualcosa di superfluo, non è un lusso. È un bisogno. Siamo
bambini viziati, possiamo permetterci di giocare con l’idea di verità perché non
siamo costretti a mentire. È ben chiaro che la menzogna esiste ovunque nella società, come in tutto il genere umano dall’invenzione del linguaggio. Ma da noi non
costituisce la condizione base della sopravvivenza. D’altro canto, ci sono, o forse,
speriamolo, c’erano sistemi politici in cui non si poteva vivere normalmente senza
rendersi complici della menzogna ufficiale dell’ideologia.
Dovremmo ascoltare a questo proposito la testimonianza di Aleksandr
Solženicyn. Nella sua Lettera ai leaders sovietici, pubblicata nel 1974, lo scrittore
russo dedica all’ideologia un capitolo speciale dell’operetta, il sesto. Scrive, parlandone: «questa bugia universale, obbligatoria, che siamo costretti adoperare, è
divenuta l’aspetto più tormentoso dell’esistenza della gente in nostro paese – peggiore di tutte le avversità materiali, peggiore di ogni mancanza di libertà civile»
(Эта всеобщая обязательная, принудительная к употреблению ложь стала самой мучительной стороной существования людей в нашей стране—хуже всех
материальных невзгод, хуже всякой гражданской несвободы)12. La miseria e
l’oppressione non erano da poco nell’Unione Sovietica dell’era Brežnev, quando
scriveva Solženicyn. Nonostante tutto, l’autore ha preferito porre l’accento sulla
sofferenza morale e intellettuale dovuta alla mancanza di verità.
2) Io sospetto il sospetto contro la verità. Mi chiedo se l’autentica ragione sia la
paura dell’intolleranza. C’è un altro motivo per l’odio della verità. Vorrei leggere
qui un brano di Agostino. Nelle Confessioni si domanda perché scrive Terenzio:
veritas parit odium, «la verità partorisce l’odio», d’accordo col Vangelo di Giovanni che parla di quelli che rifiutano la luce (3, 19-21). Perché la verità, di cui tutti
dicono che sia un bene, può diventare oggetto di odio?
Risponde Agostino con una distinzione tra due funzioni possibili della verità. «L’amano quando splende, l’odiano quando riprende (Amant eam lucentem,
oderunt eam redarguentem). [...] L’amano allorché si rivela, e l’odiano allorché li
rivela»13. Amiamo la verità lucens che ci permette di conoscere le cose come un
11 F. Nietzsche, Morgenröte, V, §456; KSA, t. 3, p. 275; Frammento Agosto 1885-Primavera
1886, 1 [145]; KSA, t. 12, p. 44.
12 A. I. Solženicyn, Lettera ai leaders sovietici, cap. 6.
13 Agostino, Confessioni, X, XXIII, 34; a cura di M. Bettetini, Torino, Einaudi, 2000, pp.
370-371.
52
RÉMI BRAGUE
Philosophical News
lume puntato su queste. Per il secondo participio redarguens, la traduzione è corretta, risulta persino elegante grazie al gioco di parole. Eppure, non rende la complessità interna del verbo: redarguere significa, come lucere, “fare la luce”. Si pensi
al metallo bianco che luccica, il cui nome latino, argentum, viene della stessa radice. Ma la luce redarguens ritorna a quello che l’ha emessa, come in un specchio, e
rivela tutto ciò che avremmo preferito nascondere.
La verità lucens, quella che ci fa conoscere le cose, scoprendole, ci permette di
controllarle. La possiamo amare in quanto ci dà il ruolo di padrone. L’amore della
verità lucens è alla fin fine amore di se stesso, non della verità come tale. Se amassimo la verità come tale, la ameremmo anche quando ci accusa.
Allora, dire che la verità è pericolosa perché c’è il rischio di fanatismo, ecc. può
darsi che sia una scappatoia. La verità che si vuole annientare è quella redarguens.
Ci lascia da soli con la verità lucens, cioè, con la propria volontà di potere.
3) L’elogio dell’onestà intellettuale è molto bello. Ma non risponde a una domanda semplice: perché dobbiamo accettare una verità che ci dispiace? Perché questa
accettazione rassegnata dovrebbe essere una cosa buona, una virtù? Perché non sarebbe giusto preferire l’illusione, la finzione? Così faceva per esempio Puškin in un
poema in cui dice preferire alla sobria verità storica la leggenda eroica su Napoleone
e, più generalmente, “l’inganno che ci alza” (нас возвышаюшчий обман)14.
L’onestà intellettuale davanti alla verità brutta è l’ultima traccia dell’amore per
la verità bella. Si può chiedere se potrebbe sussistere a lunga scadenza senza tale
amore. Anche Nietzsche ammetteva che ogni brama di verità si accende a una
fiamma che già bruciava da Platone e dal cristianesimo15.
È ancora più difficile pensare l’onestà intellettuale quando si tratta d’accettare
una verità redarguens, “riprendente”, cioè una verità che è necessariamente spiacevole? Forse non si può senza la speranza nel perdono di un Dio che mi vuole tale
quale sono.
L’ultima parola la dice forse Claudel, criticando implicitamente il nemico Renan
e alludendo alla fede nel Creatore che ha detto che, ultimamente, «tutto quanto
aveva fatto era cosa molto buona» (Genesi, 1, 31). Fa dire al re di Spagna il drammaturgo francese nella Scarpina di raso: «Triste? Come dire senza empietà che la
verità di queste cose che sono l’opera di un Dio eccellente sia triste?» (Triste?
Comment dire sans impiété que la vérité de ces choses qui sont l’œuvre d’un Dieu
excellent / Est triste?)16.
Rémi Brague
Paris I/LMU München
[email protected]
14 A. Puškin, Герой [29.9.1830], v. 63-64; in Сочинения, Parigi, YMCA Press, 1991, p.
362b.
15 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, V, §344; KSA, t. 3, p. 577.
16 P. Claudel, Le Soulier de satin, Première journée, scène 6; Théâtre, ed. J. Madaule, t. 2,
Paris, Gallimard, 1965, p. 687.
Philosophical News
POSSIAMO AMARE LA VERITÀ?
53
Rémi Brague, nato nel 1947, è professore emerito di Filosofia Medievale e Araba presso
l’Università Parigi I. Insegna anche alla Ludwig-Maximilian-Universität di Monaco dove è titolare dalla Cattedra Romano Guardini. È stato professore invitato alla Boston University, all’Universidad de Navarra (Pamplona) e all’Università San Raffaele (Milano). È membro dell’Institut
de France (Accademia delle scienze morali e politiche). È autore di: La loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance, Gallimard, Paris 2008; Au moyen du Moyen âge. Philosophies
médiévales en chrétienté, judaïsme et islam, Flammarion, Paris 2008; Les Ancres dans le ciel ou
l’infrastructure métaphysique, Seuil, Paris 2011. In italiano esistono: Il futuro dell’occidente. Nel
modello romano la salvezza dell’Europa, Bompiani, Milano 2005; La saggezza del mondo. Storia
dell’esperienza umana dell’universo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; Il Dio dei cristiani, l’unico Dio?, Cortina, Milano 2009.
Michele Lenoci
Si può amare la verità?*
This essay intends to defend three statements: truth can be loved; thanks to love
the range of truths can be widened in extension and breadth as in intension and
depth; truth gives the act of love its real value and permits to experience love in the
right way. A survey of post-modern philosophical situation points out that truth and
love are explained in a restricted empirical manner, influenced by naturalism. Classical philosophical tradition (Aristotle and Thomas) and contemporary thinkers like
Scheler make possible to understand love as aiming at the greatest value of persons
and things and truth as not only referred to knowing and reasoning, but also to the
ontological realm of things themselves.
Per rispondere a questa domanda, fondamentale per l’esistenza umana e particolarmente significativa nell’attuale temperie culturale, mi proporrei di esporre e
difendere le seguenti tre tesi:
1) solo la verità può e deve essere veramente amata;
2) l’amore consente di allargare l’ambito delle verità conosciute, in estensione e
ampiezza, come in intensità e profondità;
3) la verità rettifica, verifica e rende autentico l’atto di amore, cosicché solo la verità consente di vivere autenticamente l’amore.
1. La situazione attuale
A questo scopo può essere utile premettere alcune riflessioni relativamente alla
situazione attuale, quale si presenta, nell’epoca della post-modernità, sul piano culturale, prima ancora che su quello più specificamente filosofico. In una prospettiva
generale, anche se non generica o imprecisa, si può dire che, riguardo all’amore e
alla verità, prevalgano concezioni tendenzialmente riduttive e ristrette, vale a dire
tali che delimitano l’estensione e l’intensione di questi termini ad ambiti molto più
* Relazione tenuta in occasione della presentazione della presente rivista presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Milano, 15 ottobre 2010.
Philosophical News
SI PUÒ AMARE LA VERITÀ?
55
limitati e meno rilevanti di quelli a cui essi potrebbero legittimamente estendersi,
sicché la possibilità stessa di amare la verità appare paradossale o ingannevole.
Allorché ci si riferisce all’amore, infatti, esso viene in genere ridotto a pulsione
istintiva, arbitraria, irrazionale e incontrollabile, mancipia di impulsi prevalentemente inconsci nell’essere umano: ne segue che esso acceca e non solo non favorisce, ma ostacola e impedisce la conoscenza del vero, la quale, invece, dovrebbe
essere il più possibile oggettiva, fredda e disinteressata, in quanto priva di un interesse, qualunque esso sia. Allorché si parla di conoscenza, spesso si ha di mira
quanto viene conseguito dal sapere scientifico, in cui l’oggettività presuppone la
possibilità di verifica intersoggettiva, accessibile cioè, in linea di principio, a chiunque e quindi non propria di qualcuno o dipendente dalle soggettive peculiarità di
qualcuno.
In secondo luogo, l’amore viene spesso associato all’altruismo e all’umanesimo,
contrapposto all’egoismo e considerato nella sua valenza meramente ed esclusivamente sociologica, sicché deve essere il più possibile universale ed esteso a tutta
l’umanità, vista come una specie naturale. Scheler, che su questo fenomeno sviluppa riflessioni profonde e suggestive1, rileva come una tale concezione nasca
primariamente in opposizione, quasi per risentimento, nei confronti della Divinità,
del cristiano amore di Dio, per limitarsi a individuare un rapporto che si radica e
ha origine esclusivamente in un uomo per terminare in un altro, generico e universale, come nel suo oggetto proprio. In tal modo, non ci si rivolgerebbe al Divino
presente nell’uomo, ma solo all’uomo come appartenente alla specie umana, come
portatore dell’aspetto umano, e l’amore non implicherebbe un atto spirituale e
personale, indirizzato alla persona dell’altro, nella sua irripetibile unicità, ma si
limiterebbe a essere un semplice sentimento, quasi una forma di contagio psichico,
attento solo agli aspetti più superficiali come il piacere e il dolore fisici (importanti,
ma non essenziali e profondi), e tenderebbe a spersonalizzarsi quanto più è possibile, per rifugiarsi preferibilmente in dimensioni istituzionali e anonime, quali
gli enti assistenziali e di beneficenza, alla cui azione soccorrevole competerebbe
di eliminare le espressioni esteriori di dolore, le quali suscitano in noi sentimenti
di depressione e forme di compassione più apparente che reale. In accordo con
Nietzsche, Scheler ritiene che, in questi casi, si tratta solo di un egoismo mascherato, come dimostra il fatto che tale universale filantropia, tutta protesa all’amore
verso i lontani, dissimula invece l’indifferenza o l’ostilità verso i più vicini, che
richiederebbero, ove fossero veramente amati, un impegno più personale e incisivo. Sempre in questa prospettiva, l’uguaglianza fra gli uomini, cui tale altruismo
aspira, non consiste nel fatto che ciascuno ha valore, in quanto realizza pienamente
se stesso e la propria individua vocazione, nonostante le differenze che per tanti
1 Si veda, tra l’altro, M. Scheler, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen, in Vom Umsturz
der Werte, Gesammelte Werke, Bd. 3, Francke Verlag, Bern und München 1972, pp. 33-147 (in
particolare, pp. 96-114); tr. it. di A. Pupi, Il risentimento nella edificazione delle morali, Vita e
Pensiero, Milano 1975, pp. 113-139.
56
MICHELE LENOCI
Philosophical News
aspetti possano sussistere, ma piuttosto individua il valore di ciascuno in una mera
considerazione comparativa, per cui esso dipenderà solo dal confronto commisurante con gli altri. L’amore, insomma, non viene più rivolto alla persona come tale,
propria o altrui non importa, ma all’alterità dell’altro, sicché viene vissuto come
una fuga da sé, non come un movimento positivo, ma come una reazione implicitamente e sostanzialmente negativa.
In terzo luogo, poiché l’amore guarda agli uomini solo nel loro essere enti di natura, ne consegue che mirerà ad accrescere esclusivamente il benessere materiale in
una dimensione quantitativa ed estensiva, cercando, come prescrive l’utilitarismo,
di raggiungere il maggiore benessere per il maggior numero possibile di persone.
Anche per questo aspetto, l’amore assume una curvatura assai parziale e sottolinea
come primari ed esclusivi beni e dimensioni, che, pur essendo certamente rilevanti,
non sono unici, né assoluti.
Parimenti, la verità viene intesa in una maniera assai limitata, con l’esclusione, non ulteriormente giustificata, di altri aspetti ben più rilevanti. Quando ci si
interroga sulla verità, infatti, la si considera – nella migliore delle ipotesi – solo
come predicato delle nostre conoscenze o del nostro discorso, che esprime quelle
conoscenze e, quindi, essa avrebbe un valore meramente logico, gnoseologico o
epistemologico, ma non sarebbe in grado di possedere anche una valenza ontologica, che competa non solo alle proposizioni che parlano delle cose, ma anche
e primariamente alle cose stesse. A questa prospettiva altre, poi, se ne associano,
per le quali la verità perderebbe il suo valore e, relativizzandosi, si dissolverebbe
nelle molteplici conversazioni, tutte ugualmente legittime e tutte plausibili. In tal
modo, la verità sarebbe anche logicamente superflua e nulla direbbe di proprio, né
aggiungerebbe alcunché alla nostra conoscenza delle cose e al nostro discorso su
di esse: i fatti tenderebbero a svanire sotto il caleidoscopio delle infinite interpretazioni. Infine, e ulteriormente, la pretesa di affermare la verità, sia pure in forma
parziale e limitata ma sicura e fondata, avrebbe un ulteriore e grave svantaggio, in
quanto implicherebbe, sul piano sociale e su quello dei rapporti interpersonali,
un atteggiamento di intolleranza e di mancanza di rispetto nei confronti di quanti
dissentono, contestando una particolare verità o la verità come tale. Secondo questa prospettiva, infatti, la verità non ha affatto quel valore primariamente teorico
e oggettivo, che esplicitamente pretenderebbe di possedere, ma sarebbe solo il
frutto di pratiche sociali, storicamente tramandate, miranti a esercitare un dominio
e aventi pertanto un valore funzionale e strumentale2.
A questo proposito va fatta un’osservazione: spesso queste annotazioni polemiche circa i presunti effetti totalitari, impliciti nell’ammissione di una verità o
nell’aspirazione a una conoscenza vera e giustificata, poggiano su un’equivalenza
tra verità, verità assoluta e verità totale e compiuta, quale, ad esempio, poteva
2 In proposito si veda fra l’altro, di G. Vattimo, Addio alla verità, Meltemi, Roma 2009; ancor
prima, e all’origine di tutte le riflessioni e gli approfondimenti successivi, si può leggere: Id.,
Dialettica, differenza, pensiero debole, in AA.VV., Il pensiero debole, a cura di G. Vattimo e P.A.
Rovatti, Feltrinelli, Milano 1983, pp. 12-28.
Philosophical News
SI PUÒ AMARE LA VERITÀ?
57
valere nella concezione hegeliana, al termine del processo dialettico, grazie al quale si sarebbe necessariamente pervenuti al sapere assoluto, come sapere assoluto
dell’assoluto. Ora non è detto che questa equivalenza sia affermata da tutti quanti
difendono il valore della verità e di una conoscenza vera, che può essere rigorosa
ma parziale e limitata.
Come si evince da quanto precede, anche in questo caso si ha una visione falsata
e della verità si offre una prospettiva riduttiva, meramente utilitarista e sociologista, come aveva modo di denunciare Augusto Del Noce, in una sua puntuale
analisi condotta in tempi non sospetti3. Va smarrita, pertanto, la considerazione
del vero come trascendentale, come rilevante per ogni ente e decisivo anche per
l’intera esistenza umana, oltre che per la conoscenza.
2. Un’alternativa possibile
Un’alternativa alla prospettiva ora delineata consente di allargare il discorso e
di trovare una connessione tra amore e verità, nel senso indicato dalle tre tesi proposte all’inizio. Intenderei soprattutto fare riferimento alla lunga tradizione che,
richiamandosi al pensiero greco, in particolare platonico e aristotelico, attraverso
autori come Agostino, Anselmo e Tommaso (e in loro riprese contemporanee) invita a un cambiamento di prospettiva, a una metanoia, mentre ha come suo punto di
movenza la riflessione sull’esperienza concreta di fede, resa possibile dall’annuncio
salvifico del Cristianesimo. Tale mutamento vuole insieme essere un allargamento
e un approfondimento, che non intende affatto negare gli aspetti positivi emersi
nelle precedenti riflessioni ma ne suggerisce appunto un’integrazione, per evitare
che considerazioni parziali (e, entro certi limiti, pienamente corrette) pretendano
di valere come punti di vista esaustivi, capaci di escludere altre alternative possibili
e plausibili.
Proprio per quanto riguarda l’amore, la prospettiva cristiana innova radicalmente rispetto alla prospettiva greca: l’amore è certamente una passione (e, infatti,
Tommaso dice che “amor significatur per ignem”), ma non è solo questo; come
osserva Scheler, qui si ha a che fare con un atto intrinsecamente personale e spirituale, che è espressione di sovrabbondanza e di dono gratuito, che si partecipa
e strutturalmente si pone in relazione, come è attestato dal fatto che in teologia
l’amore è anche il nome dello Spirito Santo, al punto che nella Trinità esso viene
ipostatizzato. Mentre nel pensiero greco l’amore è una tendenza acquisitiva, che
implica un movimento dal meno al più, nel cristianesimo si ha un’inversione in un
tale movimento, giacché «ora non vale più l’assioma greco secondo cui l’amore sarebbe un movimento dell’inferiore verso il superiore, […], dell’uomo verso un Dio
che da parte sua è privo d’amore, del malvagio verso il migliore. Nel cristianesimo,
infatti, un amoroso atto di condiscendenza del superiore verso l’inferiore, di Dio
3 A. Del Noce, Il problema politico dei cattolici, Unione Italiana per il Progresso della Cultura, Roma 1967, pp. 23-28; pp. 32-35.
58
MICHELE LENOCI
Philosophical News
verso l’uomo, del santo verso il peccatore e così via, viene ascritto all’essenza stessa
di “chi è superiore”, quindi anche di “chi è superiore in senso assoluto”, ovvero di
Dio»4. In questa prospettiva l’amore è segno di sovrabbondanza, che gratuitamente si effonde, e non di una mancanza da colmare, e un tale movimento, inizialmente
divino, è partecipato all’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, che con
il suo amore finito corrisponde, pro modulo suo, all’amore principiale e infinito
di Dio, amando Dio e le creature in Dio. Esso è anche primariamente positivo e
costruttivo, proprio perché non è frutto del (e non si tramuta nel) risentimento,
che tende ad abbassare, ma nasce dalla dedizione fiduciosa, che mira a elevare.
L’animo risentito, infatti, consapevole della propria strutturale inferiorità, finge di
prediligere chi è inferiore a lui, ma, in effetti, esprime solo il suo odio verso quanto
è superiore ed è fuori dalla sua portata.
L’amore implica, nell’uomo, un appetito naturale, sensibile e intellettuale, a significare la profonda unità tra la componente spirituale e la componente corporea.
Esso è un movimento che non è e, insieme, è soggettivo: non lo è, in quanto non è
ripiegato su se stesso, è primariamente intenzionale e, quindi, è aperto all’altro da
sé, e nell’altro coglie il valore più alto, il fine che l’altro è chiamato ad attuare e in
cui si realizza e fiorisce pienamente; così concepito, l’atto di amore «semper tendit
in duo: scilicet in bonum quod quis vult alicui; et in eum cui quis vult bonum»5;
esso vuole il bene dell’amato e comporta una connaturalità con l’amato. In tal
modo, non è arbitrario o frutto di un’opzione soggettiva, che pretenda di porre
o di creare i valori; anzi, all’amore compete solo di riconoscere quel bene che
oggettivamente si dà, a prescindere da gusti o desideri privati. Per questo aspetto,
l’amore è rivelativo e non costitutivo del bene; è intenzionale e, pertanto, aperto al
dato in tutta la sua ampiezza e non limitato alla dimensione puramente empirica
dell’utile materiale; esso aiuta a scoprire valori che non sono realizzati, anche se
dovrebbero esserlo, perché costituirebbero ciò a cui certi enti sono destinati; se poi
questi enti sono persone, l’amore, aiutando a cogliere il valore più alto cui esse devono tendere, indica anche la meta cui sono chiamate, cioè la loro vocazione. Viene
così eliminato ogni rimando soggettivistico o emotivistico: volere bene a qualcuno
significa volere il bene di qualcuno; ne consegue che si può anche amare se stessi,
nella misura in cui si tenda a cogliere e attuare la propria vocazione, così come
può accadere, benché ciò appaia paradossale, che io ami un altro più di quanto
costui ami se stesso, giacché io potrei percepire quel fine e quella chiamata che egli
ancora non afferra. In questa concezione, infine, scompare il pregiudizio per cui
l’amore sarebbe cieco e accecante, ostacolo più che sostegno per una conoscenza
obiettiva e vera.
4 M. Scheler, Liebe und Erkenntnis, in Schrifen zur Soziologie und Weltanschauungslehre, Gesammelte Werke, Bd. 6, Francke, Bern und München 1963, p. 88; tr. it. di E. Simonotti, Amore e
conoscenza, Morcelliana, Brescia 2009, pp. 58-59. Si veda pure la traduzione, con testo tedesco a
fronte curata da L. Iannascoli, Liebe und Erkenntnis. Amore e conoscenza, Aracne, Roma 2010.
5 Thomae Aquinatis Summa Theologiae, Ia, 20, 1, ad 3. Si veda pure: Summa Thologiae, Ia
IIae, 26, 4, c.
Philosophical News
SI PUÒ AMARE LA VERITÀ?
59
D’altro lato, l’amore è un atto pienamente soggettivo, in quanto è espressione
dell’intera persona e a esso l’intera persona coopera: l’ordo amoris, cui una persona
si ispira, costituisce la determinazione della sua scala di valori, del suo ordine di
preferenze, e rivela la meta cui essa tende: «Chi ha l’ordo amoris di un uomo ha
l’uomo stesso». Scheler perviene a questa conclusione dopo aver osservato che il
concetto di ordo amoris ha una valenza normativa e descrittiva: non è primariamente un insieme di norme ma costituisce la «conoscenza dell’ordine gerarchico
in cui si trovano tutti i possibili aspetti che nelle cose sono degni d’essere amati, un
ordine gerarchico strutturato appunto in base al valore intrinseco e appropriato a
queste stesse cose. Tale conoscenza è il problema centrale dell’etica intera. Ma il
vertice massimo raggiungibile dell’uomo sarebbe amare le cose al più possibile nel
modo in cui le ama Dio e nel proprio atto d’amore esperire l’armonico incontrarsi
dell’atto divino e dell’atto umano in un unico e medesimo punto del mondo dei
valori». Sul piano descrittivo, «l’ordo amoris è infatti il mezzo per rinvenire […] la
struttura più semplice delle finalità più elementari presenti nel nucleo della persona, che agisce appunto conformemente a fini; l’ordo amoris diventa dunque il mezzo per scoprire la formula etica fondamentale in base alla quale il soggetto esiste e
vive dal punto di vista morale»6. Da queste parole si arguisce come la dimensione
soggettiva e quella oggettiva si richiamino e si integrino: infatti, l’attività più profonda del soggetto personale è orientata alla finalità oggettiva cui esso è chiamato;
certamente, stante la libertà e la possibilità di trasgredire, le due dimensioni non
necessariamente coincidono, sicché vanno distinti il momento normativo da quello
descrittivo, anche se sono complementari e, in linea di principio, dovrebbero armonicamente incontrarsi.
In modo analogo, la nozione di verità può ricevere un ampliamento rispetto
alle impostazioni post-moderne. A fianco della verità attribuita alla conoscenza
e all’asserzione, anzi a suo fondamento, sta la verità delle cose, intesa come verità ontologica, cioè come il valore intrinseco che esse realizzano e il senso che in
esse è stato immesso dal loro Creatore, sicché divengono intelligibili. Pieper, che
a questo tema ha dedicato riflessioni profonde e storicamente assai documentate,
scrive: «se, infatti, la verità dell’ente consiste nella sua relazionalità all’intelletto, e
se, d’altra parte, il rapporto tra essere oggettivo e intelletto conoscente trova la sua
più compiuta, specifica ed essenziale realizzazione nel reciproco rapporto dell’intelletto creativo alla sua opera, allora ne consegue questo: che “ogni cosa è assolutamente (absolute) vera in virtù della sua ordinazione all’intelletto conoscente da
cui essa dipende”. La verità di una realtà concreta può dunque essere affermata,
nel senso più proprio del termine, nella misura in cui la forma interiore di tale realtà riproduce un archetipo che risiede in un intelletto creatore, ossia creativamente
conoscente»7. La verità delle cose – il trascendentale verum – è, pertanto, riflesso
6 M. Scheler, Ordo amoris, in Schriften aus dem Nachlaß I, Gesammelte Werke, Bd. 10,
Francke, Bern und München 1986, pp. 347-348; tr. it. di E. Simonotti, Ordo amoris, Morcelliana, Brescia 2008, pp. 50-52.
7 J. Pieper, Verità delle cose. Un’indagine sull’antropologia del Medio Evo, tr. it. di L. Frattini,
Editrice Massimo, Milano 1981, p. 65.
60
MICHELE LENOCI
Philosophical News
di quell’amore di Dio, provvidente e buono, che si effonde, creando il mondo secondo un progetto e, nel mondo, l’uomo a sua immagine. Poiché il bene è diffusivo
di sé, l’amore, che tende al bene più alto, è intrinsecamente generativo e creativo.
La verità ontologica riguarda l’essenziale, che sfugge agli occhi dei sensi e a una
comprensione solo superficiale, e immette nel mondo una componente dinamica,
che nell’uomo diventa storia, concepita come il tempo dato al singolo e alla comunità umana per realizzare se stessi, secondo scelte libere e responsabili, adempiendo quel progetto, cioè quella vocazione che li costituisce, a cui sono stati chiamati
e a cui aspirano. E poiché tale compito è affidato alla libera iniziativa, il cammino
della storia non è necessariamente un percorso di progresso ascensionale, ma può
conoscere anche ostacoli, soste o involuzioni. La realizzazione, cui si è vocati, può
anche venire tradita.
La verità ontologica, infine, non ha solo un carattere universale, valido per tutti
gli enti e per tutti gli uomini, ma, come ben si comprende da quanto finora detto,
si particolarizza, e ciò assume nell’uomo un peculiare rilievo. Anche qui non viene meno l’oggettività, né si scade nell’arbitrio delle opzioni, giacché l’oggettività
implica l’universalità solo nel senso che unicamente gli aspetti universali possono
essere colti dal nostro intelletto, e quindi oggettivati, e su di essi si potrà incontrare
un consenso intersoggettivo. Delle dimensioni oggettive particolari e personali non
ci potrà essere una comprensione intellettiva, né una conoscenza; sicché, anche
per questo motivo, siamo invitati a non giudicare le singole persone, di cui non
riusciamo a penetrare intellettualmente l’intimo nocciolo spirituale, che ispira le
loro scelte e decisioni. Eppure quel progetto, cui ciascuno è chiamato, costituisce
il senso e il valore intrinseco (non estrinseco o attribuito da altri) della propria
esistenza, che solo Dio pienamente conosce e può adeguatamente giudicare; esso
è una sintesi di chiamata e di libera risposta ed è un vivente dialogo, quasi ipostatizzato, una relazione costitutiva che si sviluppa nella storia e lì decide le sue sorti.
3. Considerazioni conclusive
Da quanto finora detto si comprende perché solo la verità possa essere autenticamente oggetto d’amore, in quanto il retto amore è diretto primariamente alla verità
delle cose e, in particolare, alla verità delle persone, al senso più alto e profondo
che esse esprimono. L’amore stesso, che costituisce il grembo da cui germinano e
da cui sono permeate conoscenza, volontà ed emozioni, consente di vedere oltre le
apparenze, di trascendere il transeunte, di non farsi ingannare e condizionare dalle
contingenze, per cogliere ciò che gli occhi sensibili non riescono ad afferrare. Esso
ha la capacità dinamica di tendere (e di aiutare gli altri a tendere) a ciò che più e
meglio valorizza le cose e realizza le persone e, mentre rivela una connaturalità con
quanto è amato, assolve pure un importante compito educativo, in quanto genera
e fa crescere esistenzialmente chi viene amato.
In secondo luogo, l’amore ha anche la capacità di ampliare le nostre attitudini
a conoscere. A questo proposito Scheler cita un passo di Goethe: «non si acquista
Philosophical News
SI PUÒ AMARE LA VERITÀ?
61
conoscenza se non di ciò che si ama, e quanto più profonda e completa essa ha da
essere, tanto più intenso forte e vivo deve essere l’amore, anzi la passione»8. Viene
così rifiutata la tesi per cui l’amore accecherebbe e ostacolerebbe la conoscenza;
anzi, esso soltanto rende accessibile il dato e amplia il campo del conoscibile, estendendo quindi l’ambito del vero. Trattando della concezione agostiniana, Scheler
osserva come gli atti d’amore non siano semplicemente destinati ad aggiungersi a
un contenuto sensitivo e percettivo autonomo, e acquisito tramite l’esclusiva attività intellettuale, ma siano «atti assolutamente primari, nonché fondanti rispetto a
tutti gli altri atti mediante i quali il nostro spirito coglie in generale un “possibile”
oggetto. Essi sono il comune fondamento dei giudizi, delle percezioni, delle rappresentazioni, dei ricordi, delle intenzioni di significato che si rivolgono al medesimo oggetto». Infatti, senza un interessamento per qualcosa, non può esserci una
sensazione o una rappresentazione; tale interessamento orienta la nostra capacità
selettiva, in modo che alcune tra le cose oggettivamente percepibili diventino effettivamente contenuto del nostro pensiero; e questo interesse è guidato dall’amore.
Ma, secondo Scheler, Agostino va oltre questa concezione che potrebbe, con qualche integrazione, essere fatta risalire alla descrizione platonica dell’eros come via
e metodo per la conoscenza. La nostra capacità percettiva e il suo accrescimento
in funzione dell’incremento dell’interesse «non sono per Agostino semplicemente
attività del soggetto conoscente che penetra in un oggetto già in sé compiuto, ma
sono anche reazioni di risposta dell’oggetto stesso: un “darsi”, “dischiudersi” e
“aprirsi”, ovvero un autentico rivelarsi da parte dell’oggetto. V’è per così dire un
“domandare” dell’“amore” a cui il mondo “risponde”, “schiudendo” se stesso e
giungendo solamente in tal modo alla sua piena esistenza e al suo pieno valore. Così
per Agostino la stessa realizzazione della conoscenza “naturale” del mondo, se
considerata nell’ottica di ciò che la rende oggettivamente possibile, acquisisce un
“carattere di rivelazione”»9. Si vede come amore e conoscenza siano correlati e
come l’incremento del primo renda possibile un allargamento della seconda.
Infine, il riferimento alla verità consente che l’amore sia completo e integrale
in tutte le sue dimensioni, soprattutto in quelle più profonde, evitando riduzioni ai soli aspetti utilitaristici, istintivi o sentimentalistici (senza, naturalmente, che
l’istinto, il sentimento o l’utile abbiano ad essere negati o ignorati). Un tale amore
si rivela raffinato e delicato, capace di cogliere le sottigliezze (e le ambiguità e doppiezze) dell’essere umano; ma, al pari di tutto quanto è delicato, è anche fragile.
Esso, pertanto, genera la speranza che, nonostante ogni fragilità e insicurezza, il
cammino verso una piena rivelazione del senso coincida con una tensione effettiva
al valore più alto, secondo una modalità in cui ontologia e assiologia manifestano
la loro coappartenenza. Il motto paolino “spes contra spem” trova nell’antica sapienza dei greci e nel detto di Eraclito un’anticipazione e un contrappunto: «se
uno non spera, non potrà trovare l’insperabile, perché esso è difficile da trovare
8 M. Scheler, Liebe und Erkenntnis, cit., p. 77; tr. it., p. 31. Il passo è ricavato da una lettera
di Goethe a Jacobi del 10 maggio 1812.
9 M. Scheler, Liebe und Erkenntnis, cit., pp. 95-97; tr. it., pp. 76-79.
62
MICHELE LENOCI
Philosophical News
e impervio» (Fr. 18). Chi anima, ravviva e sorregge la speranza, affinché non sia
utopistica, ingannevole o velleitaria, è l’atto di un retto ordo amoris tendente alla
verità.
Michele Lenoci
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
Michele Lenoci insegna Storia della filosofia contemporanea e Ontologia e metafisica presso
l’Università Cattolica di Milano, dove dal 2002 è preside della facoltà di Scienze della formazione. Si è occupato, fra l’altro, del pensiero austriaco e tedesco tra Otto e Novecento, con
particolare attenzione a Brentano, Meinong e alle origini della fenomenologia husserliana. Ha
approfondito anche il personalismo scheleriano e le sue applicazioni, nonché i rapporti tra fenomenologia e filosofia dell’esistenza. Si interessa anche alle tematiche ontologiche nella filosofia di
indirizzo analitico. Su questi temi ha pubblicato volumi e articoli.
Letterio Mauro
Possiamo amare la verità?*
The trend to consider all opinions equally good, therefore not admitting any difference between truth and falsehood, seems prevailing today. Against this perspective,
the present paper argues that the most of people found their daily life on this double
persuasion: first, the truth does exist and must be affirmed, that is it must be loved;
second, such a persuasion is shared by the majority of the mankind.
È possibile amare qualcosa di cui si dubita, o addirittura si nega che esista? Tale
sembra essere la situazione della verità nel nostro tempo, in cui la “passione per
la verità” pare, per dir così, intiepidita e spenta, pare suscitare diffidenza, quando
non palese avversione, soprattutto se riferita agli interrogativi circa il senso ultimo
dell’esistere e circa le concrete soluzioni da dare ai problemi etici. Riguardo a tali
questioni sembra prevalere oggi piuttosto la tendenza, in apparenza molto urbana
e democratica, non solo a rispettare, come è giusto, in nome della dignità della
persona, tutte le opinioni, ma anche (cosa ben diversa) a considerarle tutte ugualmente vere, il che però equivale a dire che sono tutte false e che appunto non vi è
alcuna differenza tra il vero e il falso.
All’inizio dello scorso secolo Oswald Spengler aveva osservato in proposito:
«Che cosa è la verità? Per la massa è ciò che si legge e si sente dire continuamente. Qualche povero ingenuo può anche mettersi al tavolino e raccogliere princìpi
onde definire la “verità” – ma questa resterà la sua verità. L’altra verità, quella
pubblica del momento, quella che soltanto importa nel mondo reale dell’azione e
del successo, oggi è un prodotto della stampa. Ciò che la stampa vuole è vero. Chi
controlla la stampa crea, trasforma, cambia la verità»1.
Queste parole di Spengler fanno riferimento evidentemente alla verità intesa
come un “ritenere vero”; esse ci dicono che appunto il ritenere vero qualcosa da
parte della massa non ha nulla a che vedere con un dato oggettivo che il suo giudizio rispecchierebbe, ma piuttosto con la capacità dei moderni mezzi di comunicazione di esercitare effetti durevoli e una costante pressione sulle menti, spostando
di volta in volta l’ago della pubblica opinione verso altre e nuove “verità” sapien* Relazione tenuta in occasione della presentazione della presente rivista presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Milano, 15 ottobre 2010.
1 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, Longanesi, Milano 1981, p. 1338.
64
LETTERIO MAURO
Philosophical News
temente (e più insistentemente) fatte circolare. Si tratta di uno stato di cose di cui
l’età contemporanea ha tragicamente fatto esperienza, e che anche oggi, in contesti
senz’altro meno tragici ma per altri versi ancora più complessi, mette in luce le responsabilità di quanti operano nel mondo dei media. Rivolgendosi ai partecipanti
al Congresso sulla stampa cattolica promosso dal Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali, Benedetto XVI ha recentemente affermato in proposito che le
nuove tecnologie, poste al servizio del mondo dell’immagine, «assieme ai progressi
che portano, possono rendere interscambiabili il vero e il falso, possono indurre
a confondere il reale con il virtuale. [...] Questi aspetti suonano come campanello
d’allarme: invitano a considerare il pericolo che il virtuale allontani dalla realtà e
non stimoli alla ricerca del vero, della verità»2.
Quanto invece alla questione dell’esistenza di una verità “oggettiva”, qui intesa
nel significato classico di concordanza tra conoscenza e realtà, tra proposizione e
fatto, essa viene sbrigativamente liquidata da Spengler come preoccupazione da
«povero ingenuo» che, appunto nella sua “ingenuità”, ritiene esigenza naturale
del buon senso che ci sia una realtà in sé e che gli sia possibile conoscerla almeno
in una qualche misura. Ora, proprio di questo «povero ingenuo» che «raccoglie
princìpi onde definire la “verità”», che cioè si pone il problema della verità “oggettiva”, e che deve fare i conti con la diffusa “disaffezione” nei confronti di questi
temi che, come si è detto, caratterizza il nostro tempo, vorrei qui brevemente occuparmi, per mostrare come in realtà, anche oggi, il vivere quotidiano della gran
parte degli uomini sia basato proprio sulla persistente convinzione che la verità
esiste e deve essere sempre affermata, ossia che essa è (e deve essere) amata.
Certo, come si è affermato, oggi a questo riguardo sembra prevalere un generico
relativismo che ritiene equivalenti tutte le opinioni, ma che proprio per questo
priva implicitamente, come è evidente, di qualsiasi utilità lo stesso argomentare,
il portare giustificazioni, il discutere con gli altri (che pure costituiscono l’assunto
di fondo dei sostenitori di questo genere di “pluralismo”). Chi sostiene tale tesi
mostra, in altre parole, di confondere il pluralismo fondato sul rispetto delle altrui
opinioni con quello basato appunto sulla indifferenza rispetto ai valori, e dunque
di non voler autenticamente discutere, di non essere cioè seriamente interessato a
confrontarsi con le opinioni diverse dalla sua, dato che un serio confronto con le
opinioni altrui implica con tutta evidenza il non essere indifferenti ai loro contenuti (e quindi alle loro precipue motivazioni). Nei confronti di tale relativismo, che
presuppone appunto la negazione dell’esistenza della verità, come già nei confronti dello scetticismo, mantiene tuttavia intatto il suo valore, ad onta dell’accusa di
formalismo ad essa rivolta da Heidegger e, nella prospettiva di uno «scetticismo
aperto», da Weischedel, la confutazione di tale atteggiamento basata sulla sua autocontraddittorietà; anche il relativismo contemporaneo, come già lo scetticismo
antico, si presenta infatti come verità assoluta e quindi afferma proprio quanto si
propone di negare.
2 Benedetto XVI, Discorso pronunciato il 7 ottobre 2010 durante l’udienza ai partecipanti al
Congresso della stampa cattolica promosso dal Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali.
Philosophical News
POSSIAMO AMARE LA VERITÀ?
65
Torniamo allora agli interrogativi del «povero ingenuo» e domandiamoci: l’uomo è davvero indifferente alla verità e alla menzogna? Come già notava Agostino,
riferendo una esperienza della propria fanciullezza, tutti godono della verità e a
nessuno piace essere ingannato3; ma se si desidera non essere ingannati, si deve
pure ammettere che vi sia una verità, magari difficile da trovare, e in assenza della
quale non si comprende neppure perché non si vorrebbe essere ingannati. Ciò
vale innanzi tutto appunto riguardo al nostro esistere quotidiano: ci attendiamo,
ad esempio, che in un tribunale il giudice si impegni (per quanto gli è possibile) a
trovare la verità oggettiva; che lo storico ricostruisca “oggettivamente” quanto è
al centro delle sue indagini; che il ricercatore ci dica come stanno effettivamente
le cose riguardo all’oggetto delle sue ricerche, e siamo tutt’altro che indifferenti
al fatto che ciò si verifichi o meno. Soprattutto ci attendiamo che il giudice, lo
storico, il ricercatore sappiano mettere da parte interessi personali o partigiani, le
motivazioni “ideologiche” e quelle (non meno pressanti e invadenti) del mercato,
«per rappresentare uno stato di cose così com’è»4. Quando ciò non si verifica (e la
nostra cronaca è sin troppo ricca di esempi di questo tipo: da quello degli “storici”
che negano la Shoah, come un tempo gli intellettuali negavano la natura criminale
e totalitaria dello stalinismo, di cui pure avevano fatto esperienza, a quello degli
interessi economici e “ideologici” che inquinano una serena e corretta discussione
sull’uso delle cellule staminali adulte) non solo non restiamo indifferenti, ma siamo
indignati che la verità non sia stata riconosciuta.
Esemplare di quanto si è ora detto è, in riferimento all’ambito più propriamente
scientifico, un recente saggio di Michel Serres, dedicato a mettere a fuoco l’atteggiamento che sempre più nel nostro tempo dovrebbe caratterizzare appunto lo
scienziato nella sua ricerca, soprattutto nell’ascolto delle “ragioni” di quella che
egli ha chiamato la Biogea, la sfera della terra e della vita5. Dopo essere stata da
parte del filosofo oggetto di contemplazione nel mondo antico e in quello medievale, e poi da parte dello scienziato oggetto di dominio in quello moderno, quest’ultima dovrà essere nel nostro tempo, un tempo di “crisi” e quindi di giudizio e di
svolta, oggetto di «ascolto», riaffidando così allo scienziato il suo precipuo ruolo
di interprete della «voce» della natura, quale si esprime soprattutto attraverso i
sempre più frequenti fenomeni “estremi” che oggi la caratterizzano.
Quanto sopra si è affermato riguardo alla irrinunciabile esigenza di verità da
cui è guidato e orientato il nostro vivere quotidiano vale naturalmente ancor più
nel caso della verità circa il senso del nostro esistere e delle nostre scelte di fondo,
rispetto alla quale l’uomo si qualifica, per usare una espressione di Edith Stein,
come un Wahrheitssucher, uno che cerca la verità6 e che, proprio per quanto si è
detto, non può che cercarla con amore, passione, impegno: la verità insomma interessa l’uomo, e all’uomo interessa vivere in essa, perché per essa egli è fatto. Come
3 Cfr. Agostino, Conf. I, 20, 30.
4 R. Ferber, Concetti fondamentali della filosofia, Einaudi, Torino 2009, vol. I, p. 96.
5 Cfr. M. Serres, Tempo di crisi, Bollati Boringhieri, Torino 2010.
6 Cfr. E. Stein, Essere finito e Essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, Città
Nuova, Roma 1988, p. 50.
66
LETTERIO MAURO
Philosophical News
mostra proprio l’esempio della Stein, la cui intera esistenza è stata caratterizzata
da questa «passione per la verità»7, l’incontro con quest’ultima, allorché si tratta di
quanto lo riguarda più da vicino, non può lasciare indifferente l’uomo; essa infatti
dà un senso al suo esistere, uno scopo al suo agire, una ragione al suo soffrire, una
pienezza appunto al suo amare. Lungi dall’essere repressiva (come talora si afferma) per colui che la conosce, la verità è anzi liberante nel significato più pieno; essa
rivela l’uomo a se stesso.
Proprio per questo, l’umana ricerca del vero, quando è autentica, ossia condotta
con onestà intellettuale, non può che configurarsi come una ricerca, per dir così, a
tutto campo, aperta cioè al contributo di tutte le fonti che portino dati. Per citare
nuovamente Edith Stein, posto che «la filosofia vuole la verità nella più ampia
estensione possibile […] Se la fede rende accessibili verità, che non sono raggiungibili per altra via, allora la filosofia non può rinunciare a questa verità di fede
senza abbandonare, per l’appunto, la sua esigenza universale di verità e inoltre
senza correre il rischio che si insinui anche la falsità nell’insieme delle conoscenze
che le rimane»8.
Ciò non equivale ad affermare che l’uomo possa accedere a una verità “assoluta”, se con questa espressione si intende un sistema di enunciati definitivo ed
esaustivo dell’intera realtà, ossia che possa assumere nei confronti di quest’ultima
una prospettiva che solo Dio potrebbe assumere. Suo compito è piuttosto quello
di mantenere una costante apertura nei confronti della sua aspirazione alla verità,
rinunciando ai vantaggi e agli interessi personali; in questo senso, l’esigenza umana
di conoscere la verità si traduce sul piano fattuale in un graduale approssimarsi ad
essa, che non rende affatto illegittimo sul piano normativo l’attenersi alla nozione
(ideale) di verità come corrispondenza allo stato delle cose. Si tratta, dunque, di
un compito che resta sempre “aperto” e che in linea di principio può continuare
all’infinito, non però nel senso che l’uomo sia un essere condannato ad una ricerca
che non potrà mai aver esito, ma nel senso che, anche una volta raggiunta una
risposta sul significato ultimo del suo esistere, egli è chiamato ad approfondirla
costantemente al fine di acquisirne una sempre più piena e “saporosa” comprensione.
Dinanzi al rilievo di occuparsi e preoccuparsi di quella che sembra essere in
fin dei conti solo «la sua verità», il «povero ingenuo», dal cui interrogarsi intorno
alla verità “oggettiva” abbiamo preso le mosse, potrebbe dunque ribadire a buon
diritto la legittimità della sua “pretesa”; essa appare infatti confermata dallo stato
di cose esistente, ovvero dalla esperienza di tanti altri uomini che ricercano la verità come il proprio “bene” e che, proprio in quanto tale, la amano. Dinanzi poi
a coloro che mostrano sul piano teorico di non “amare” la verità, affermando di
non conoscere il vero o di non sapere quale è il bene e quale è il male, potrebbe far
7 Cfr. A. Ales Bello, Edith Stein. La passione per la verità, Edizioni Messaggero, Padova 2003.
8 E. Stein, La fenomenologia di Husserl e la filosofia di san Tommaso d’Aquino – Tentativo
di confronto, in La ricerca della verità. Dalla fenomenologia alla filosofia cristiana, Città Nuova,
Roma 1997, p. 67.
Philosophical News
POSSIAMO AMARE LA VERITÀ?
67
notare che, sul piano pratico, attraverso le scelte concrete che pure costantemente
compiono, costoro testimoniano almeno implicitamente di preferire una realtà ad
un’altra e, dunque, di sapere che quella è per loro il bene, ossia di sapere quale è il
bene e quale non. Dinanzi infine a quanti, senza neppure porsi la questione de veritate, assumono nel vivere quotidiano un atteggiamento di chiusura dogmatica nei
confronti di enunciati (e di fatti) evidenti o incontrovertibili, potrebbe, credo, non
meno legittimamente osservare che questo non prova nulla contro l’esistenza della
verità né contro l’esigenza di “spendere” la vita per essa. Potrebbe osservare che
ognuno è ovviamente libero di negare qualsiasi enunciato (e qualsiasi fatto), anche
i più evidenti, proprio come fanno gli “storici negazionisti” di cui sopra si è detto,
e che ad ognuno deve essere riconosciuto il diritto di esprimere tali sue convinzioni, difenderle e, se lo ritiene, mantenerle; ma che, ancora una volta, riconoscere
teoricamente tale diritto e rispettarlo praticamente non significa riconoscere tali
opinioni come vere o come equivalenti a quelle ad esse contrarie.
Letterio Mauro
Università degli Studi di Genova
[email protected]
Letterio Mauro è professore ordinario di Storia della filosofia nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova. Si è occupato di varie figure del pensiero medievale (Bonaventura da Bagnoregio, Tommaso d’Aquino) e contemporaneo (Rosmini, Gioberti, Stein, Weischedel)
soprattutto in riferimento al tema delle relazioni tra ragione e fede, e del rapporto tra musica e
filosofia dal tardo medioevo alla prima età moderna.
Emilio Baccarini
Fare la verità
Western philosophy has been seeking for truth through contemplation and theoresis. Moreover it has established a relationship between truth and memory (a-letheia),
characterizing truth as a completed totality to be pursued. Starting from “completeness” another path is possible, that of constructing truth. The article has proposed a
path that, considering truth as dynamic and not static, present a brief focus on three
paradigms deeply different from each other: Hegel-Rosenzweig-Pareyson. My conclusion is that truth is a result that cannot happen without human responsibility.
1. Premessa: l’aporia della questione
In maniera dura, provocatoria, ‘essenziale’, nell’Occidente la domanda sulla verità risuona a partire dal ‘confronto’ tra un politico e un condannato a morte che,
alla domanda: “che cos’è la verità?”, ha l’ardire di rispondere “io sono la verità”1.
Da quel momento la storia della domanda sulla verità ha imboccato strade altre
rispetto a quella esclusivamente filosofica che conosciamo a partire dalla filosofia
greca.
La domanda sulla verità è certamente la questione filosofica per definizione e
tuttavia è forse anche quella più aporetica, la questione impossibile. Impossibilità
di esibire una risposta determinante a una domanda necessaria e ineluttabile. Qual
è, infatti, il senso del rapporto inscindibile e inesorabile tra l’umano e la verità? Le
brevi riflessioni che seguiranno vogliono essere una prima mappatura di un percorso lungo e certamente tortuoso che trasversalmente tocca tutta l’avventura del
pensiero umano in qualsiasi latitudine.
L’essere umano non può non porre la questione e, tuttavia, nella stessa posizione della domanda essenziale che, in quanto tale, ha sempre di mira il determinato, si coglie il non senso di una ricerca che vorrebbe intenzionare il tutto.
Eric Weil, che nella sua Logica della filosofia ha sentito con molta lucidità il peso
della questione scrive: «ogni giudizio sulla verità è assurdo. […] Ogni spiegazione positiva è allora impossibile; volerne dare una significherebbe voler parlare
nel silenzio. La verità non è né l’essere né il nulla, non è l’oggetto né l’io. Non si
1 Si veda, rispettivamente, Gv 18, 38 e Gv 14, 6.
Philosophical News
FARE LA VERITÀ
69
può che evocarla e parlarne per immagini. È la luce che non illumina nulla, luce
invisibile perché non è altro che luce. È lo stato di veglia che non è preceduto
da nessun sogno. È ciò che precede il cominciamento. È l’istante eterno, più
vecchio e più giovane di ogni tempo. […] In effetti l’uomo è sempre nella verità
e, di conseguenza, la verità gli è inaccessibile come la base sulla quale si sostiene»2.
Le affermazioni del filosofo franco-tedesco, non vanno nella direzione dello scetticismo, bensì in quella di un approccio diverso e consapevole del limite. Se
non possiamo contemplarla nella sua totalità ineffabile, possiamo ‘tradurla’ nella
concretezza del vissuto dell’esperienza: “Tuttavia, – scrive ancora Weil – la verità
di cui si tratta non è inaccessibile. La verità non può essere esposta, è vero, ma
può essere vissuta”3.
Questo vissuto, a sua volta, ha il nome di Saggezza, a cui è dedicato l’ultimo
capitolo della Logica, ma la saggezza è l’azione attraverso cui la verità si rende
presente e il pensiero che si è pensato ritorna alla verità. Fare la verità diventa il
compito inesauribile assegnato all’essere umano nell’esercizio della sua libertà.
Si tratta di un semplice spostamento dallo speculativo alla prassi, o vi è in gioco
qualcosa di più decisivo? Ed eventualmente che tipo di fare è quello che opera
rivolto alla verità? L’orizzonte della nostra riflessione si arricchisce di una molteplicità di relazioni che non possono certamente essere adeguatamente affrontate
qui. Possiamo però almeno elencarle. Verità e libertà sembrerebbe la prima di
queste relazioni4, ma anche verità e inveramento, come vedremo, si relazionano
in maniera tutt’altro che scontata; verità e liberazione, come suggerirebbe il mito
della caverna di Platone. In termini più direttamente teoretici, che rapporto c’è
tra la manifestazione e l’essere che nella manifestazione si manifesta? Com’è noto
è questa la domanda peculiarmente heideggeriana che rilegge l’aletheia greca
non soltanto come non-oblio, ma piuttosto come s-velatezza5. Il mito platonico
della caverna, ma sono dati fin troppo noti, ci introduce anche a quello che sarà
forse uno dei percorsi più frequentati del pensiero occidentale, il rapporto tra
verità e memoria.
Tralascio naturalmente tutte le questioni legate alla verità proposizionale, alla
conformità e quindi alla verità del giudizio per soffermarmi brevemente su due
paradigmi che leggono la verità come totalità, Hegel e Rosenzweig, con risultati
contrapposti per poi esaminare un terzo paradigma che ci consente un approccio
ermeneutico, quello di Pareyson. Naturalmente ciò che segue vuole essere soltanto
una scelta di tre percorsi tra altri; il Novecento ha manifestato tutta la disillusio-
2 E. Weil, Logica della filosofia, Il Mulino, Bologna 1997, p. 129.
3 Ibid., p. 130.
4 «La verità vi farà liberi» leggiamo nei vangeli (Gv 8, 32). Una tematizzazione diversa del
rapporto tra verità e libertà, l’ha fatta Heidegger in Dell’essenza della verità e quindi in La dottrina platonica della verità, entrambe le opere si trovano ora in Segnavia, Adelphi, Milano 1987.
5 Oltre ai testi citati, Heidegger ha dedicato esplicitamente al tema della verità almeno altri
due lavori: L’essenza della verità. Sul mito della caverna e sul «Teeteto» di Platone, Adelphi, Milano 1997 e Logica. Il problema della verità, Mursia, Milano 2009. Un discorso diverso meriterebbe l’approccio jaspersiano che si modula secondo la prospettiva dell’Umgreifende.
70
EMILIO BACCARINI
Philosophical News
ne delle filosofie totalitarie della certezza assoluta. Un percorso particolarmente
fecondo sarebbe stato anche quello fenomenologico che rilegge la questione della verità nell’ottica della intenzionalità costituente donatrice di senso. Anche per
Husserl la verità è il risultato di una processo che vede coinvolto il soggetto attraverso la sua ‘autoconsapevolezza’.
Come conclusione di questa premessa vorrei accennare ancora alla relazione tra
parola e verità che ritroveremo più avanti e che forse è quella che esprime meglio
la dimensione del fare. La parola abita l’uomo che, attraverso la parola, riceve una
sorta di investitura che gli consente di comprendere anche la sua origine. Noli foras exire, in interiore homine habitat veritas. L’espressione agostiniana nel De vera
religione, ci permette di risalire a quella trascendenza interiore che abita l’uomo e
che rende la sua parola segno di un al di là. Nell’interiorità, nella transdiscendenza
che apre alla transascendenza, è possibile reperire le fonti della verità della parola.
L’uomo, agostinianamente, in quanto imago Dei, è il luogo della presenza della
verità. Nell’interiorità risiede la verità della parola, ma ciò non significa un invito
a uno sterile narcisismo autocontemplativo, bensì piuttosto ci rende responsabili
in quanto custodi della verità. La parola nasce sempre dal silenzio della contemplazione interiore.
Dire la verità è verum facere se ipsum. La verità comunicata è originariamente
verità vissuta, verità esperita. Vivere nella verità. Esiste una relazione etica fondamentale da cui non può prescindere un’autentica comunicazione interpersonale,
altrimenti la parola sarà semplicemente il supporto di una logica aberrante della
persuasione che è poi in ultima istanza strumentalità a scopo di potere. La logica
della persuasione è l’implicita ammissione della limitazione/negazione della libertà
e della singolarità personale del destinatario della comunicazione. Qual è il senso
del verum facere se ipsum se non la conformazione di sé alla logica della verità? La
conformazione è a sua volta un termine relazionale che indica un porsi di fronte-a,
non possiamo porci come modelli originari a noi stessi, sarebbe un controsenso.
Ma dove reperire la dimensione del formarsi-con? Attenzione alle differenze come
disponibilità a recepire l’indicazione della verità, sarà l’opera dell’inveramento di
Rosenzweig, ma anche dell’apertura dialogica di Pareyson.
La verità della parola assomiglia quindi a un continuo ‘inveramento’ della parola e di se stessi, è questo il fare la verità a parte subjecti. Si istituisce una relazione
tutta particolare tra la struttura di datività ontologica, per cui l’uomo si scopre soggetto di un dono, e il dare la parola come essere veri. Essere veri significherà dare
la parola vera (la parola data) come fedeltà duplice alla verità e all’interlocutore, è
questo il fare la verità a parte objecti.
Si comprende meglio anche la prospettiva vichiana del verum est ipsum factum,
che esula dalle mie intenzioni e che tuttavia, mostra la dimensione operativa della
verità che diventa storia. Rivolgiamoci ora ai due paradigmi ‘operativi’ della verità.
Philosophical News
FARE LA VERITÀ
71
2. La verità in opera
La prospettiva della verità come atto, piuttosto che soltanto come stato, implica una comprensione dinamica che ha almeno due impliciti teoreticamente assai
significativi: che la verità non è mai data per intero e che la totalità della verità è
risultato.
2.1 La verità è il tutto
Quest’ultimo termine ci rimanda immediatamente alla tematizzazione del problema quale la troviamo in Hegel. Per brevità, ma anche per la significatività del
testo, mi riferirò esclusivamente alla Vorrede alla Fenomenologia dello spirito6 che,
forse, è una chiave d’accesso privilegiata al sistema hegeliano. Scrive Hegel: «La
figura (Gestalt)7 autentica (wahre) in cui la verità può esistere è soltanto il sistema
scientifico della verità stessa» (p. 53). Poste le cose in questi termini, fuori della
figura non può esserci nulla; la figura è l’assoluto che però non può essere pensato
nella sua neutralità astratta, bensì nella sua soggettività che, tuttavia, in quanto assoluto, può procedere esclusivamente a partire da sé. Con le parole di Hegel: «Secondo il mio punto di vista [...] tutto dipende dal concepire ed esprimere il vero
non tanto come sostanza, bensì propriamente come soggetto» (p. 67). Prosegue poi
Hegel: «la sostanza vivente costituisce l’essere che è veramente soggetto, che è veramente reale, solo nella misura in cui essa è il movimento del porre-se-stessa, solo
in quanto è la mediazione tra il divenire-altro-da-sé e se stessa. In quanto soggetto,
la sostanza è la negatività pura e semplice, e proprio per questo è lo sdoppiamento
del semplice, è la duplicazione opponente che, a sua volta, costituisce la negazione
di questa diversità indifferente e della sua opposizione: solo questa uguaglianza
restaurantesi, solo questa riflessione entro se stesso nell’essere-altro – non un’unità
originaria in quanto tale, né immediata in quanto tale – è il vero. Il vero è il divenire
se stesso, è il circolo che presuppone e ha all’inizio la propria fine come proprio
fine, e che è reale solo mediante l’attuazione e la propria fine» [...] «Il vero è il
tutto. Il tutto, però, è solo l’assenza che si compie mediante il proprio sviluppo.
Dell’Assoluto, infatti, bisogna dire che è essenzialmente un risultato, che solo alla
fine è ciò che è in verità» (p. 69).
Un corollario della concezione del vero come sistema della totalità consiste
nell’imprescindibilità del negativo. Se, come dice Hegel, «il vero è essenzialmente
soggetto, e in quanto tale non è altro che il movimento dialettico, questo cammino
che produce se stesso, si proietta in avanti e ritorna entro sé» (p. 131), allora nel
processo dialettico il negativo si produce come positivo. In un passo di grande
6 Edizione con il testo tedesco a fronte, Bompiani, Milano 1995. Citerò direttamente nel
testo.
7 Questo termine è di grande rilevanza, poiché anche Rosenzweig, come vedremo parlerà
della verità come figura anch’essa con una propria dinamicità intrinseca che, tuttavia, vuole essere il rovesciamento della prospettiva hegeliana. Gestalt è una figura ‘plasmata’, c’è dentro tutto
il peso del fare che sto cercando di mostrare, è quindi il ‘risultato’ di un’azione.
72
EMILIO BACCARINI
Philosophical News
densità, ma anche direi di forte tensione speculativa, Hegel tiene ferma la totalità
del vero e, tuttavia, abbiamo la sensazione che rimanga qualcosa di irrisolto. Leggiamo: «La verità include dunque al proprio interno anche il negativo. Ora se si
potesse considerarlo come qualcosa da cui fare astrazione, il negativo si chiamerebbe ‘falso’. Di fatto, invece, ciò che va dileguando dev’essere considerato esso
stesso come essenziale, e non va irrigidito in una determinazione che, recisa via dal
vero, debba essere abbandonata in un qualsiasi punto fuori della verità; né il vero,
a sua volta, dev’essere considerato come il morto positivo che giace inerte dall’altra
parte. Il fenomeno, l’apparire, infatti, è il movimento del nascere e del perire, movimento che non nasce né perisce esso stesso, ma che è in sé e costituisce la realtà e
il movimento della vita della verità. In tal modo, il vero è il delirio bacchico in cui
non c’è membro che non sia ebbro; e poiché ciascun movimento, mentre tende a
separarsi dal Tutto, altrettanto immediatamente si dissolve, questo delirio è anche
la quiete trasparente e semplice» (p. 105).
La conclusione del percorso consisterà nel ‘compimento’ delle figure in cui lo
Spirito nella sua assolutezza si scopre come la propria verità nel concetto. Soltanto
ora il vero è veramente il tutto: «Nel sapere assoluto, dunque, lo Spirito ha concluso il movimento delle sue figurazioni (Gestaltens); adesso, infatti, è ormai superata
quella differenza della coscienza che contrassegnava tale movimento. Lo Spirito ha
raggiunto l’elemento puro della sua esistenza, il Concetto» (p. 1059).
2.2 La verità messianica
Al sistema della totalità del concetto Franz Rosenzweig, a suo tempo grande
studioso del pensiero hegeliano poi rifiutato, contrappone il sistema della totalità
messianica. Rosenzweig è infatti forse il più grande e originale filosofo ebreo del
secolo XX, certamente la sua opera più importante, La stella della redenzione8, rimarrà come una delle (poche) opere più significative del pensiero contemporaneo.
La complessità della sua elaborazione rende difficile una schematizzazione
che riesca a dar conto della sua prospettiva sulla verità. Il suo progetto è la frantumazione della filosofia della totalità, che è anche la filosofia dell’unità della tradizione “dalla Ionia a Jena”, per far posto a una filosofia della pluralità che non è
equivocità, bensì visione dialogica della verità e della sua costruzione. Proviamo
a ripercorrere brevemente alcune tappe della Stella, alla ricerca della sua visione
della verità.
Il punto di partenza, Rosenzweig li definisce gli Elemente, è la considerazione di
Dio, uomo e mondo come ‘tre’ fattualità-totalità non riconducibili a unità; infatti,
ognuno di essi nella sua ‘totalità’ fattuale rimanda soltanto a se stesso e in tal modo
diventa indice di un meta come impossibilità di fondamento e quindi di ricon-
8 F. Rosenzweig, La stella della redenzione, Marietti, Casale Monferrato 1985. Una nuova edizione è stata pubblicata da Vita e Pensiero nel 2005. Anche in questo caso, per non appesantire
eccessivamente con le note citerò direttamente nel testo.
Philosophical News
FARE LA VERITÀ
73
duzione all’essenza9. In tal modo Dio è meta-fisico, l’uomo meta-etico, il mondo
meta-logico. «Il mondo – scrive Rosenzweig – aveva la pretesa di essere il Tutto;
‘tutto’ è il soggetto della prima frase che venne pronunciata al momento della sua
nascita. Contro questa totalità che abbraccia il Tutto come unità, un’altra unità,
che fino a quel momento vi era inclusa, si è ammutinata ed estorce con la minaccia
il proprio distacco in quanto singolarità, in quanto vita singola del singolo uomo. Il
Tutto quindi non può più sostenere di essere ‘tutto’, ha perso la sua unicità» […]
«L’unità del logos fonda l’unità del mondo come un’unica totalità. E quella unità
dà prova a sua volta del suo valore di verità con il fondare questa totalità. Perciò
una ribellione vittoriosa contro la totalità del mondo significa al tempo stesso una
negazione dell’unità del pensiero» (p. 12). Poco oltre, riflettendo ancora sulla verità del mondo, Rosenzweig, a partire dalla metalogicità del mondo, compie un
passo particolarmente importante nel nostro percorso. «Il fatto che il mondo, il
mondo pensabile, sia meta-logico proprio nella sua pensabilità risulta con certezza
sia dall’emergere della dimensione logica da esso, sia dall’inserirsi ordinato del
momento logico in esso. Per il mondo la verità non è legge, ma contenuto. Non
la verità invera la realtà, ma la realtà contiene e preserva la verità. L’essenza del
mondo è questo preservare (e non ‘inverare’) la verità. Il mondo allora fa a meno di
quella protezione verso l’‘esterno’ che la verità aveva garantito al tutto da Parmenide fino a Hegel; siccome alberga la sua verità nel proprio grembo, il mondo è privo
di quello scudo della Gorgone che era la sua intangibilità dall’esterno; esso deve
lasciare che avvenga del suo corpo ciò che ne può avvenire, si trattasse pure della
sua creazione» (p. 15). Occorre uscire dal pensiero riduttivo che nell’unità dell’essenza lascia scomparire la molteplicità: «L’unidimensionalità è la forma dell’unità
e totalità del sapere che tutto include senza residui. Il manifestarsi sempre molteplice, dell’essere è risolto assolutamente in quell’unità in quanto Assoluto» (p.
111). Verso la conclusione del libro III della II parte dedicato alla redenzione Rosenzweig esplicita la propria prospettiva di unità: «L’unità che la filosofia aveva
preteso come un’ovvietà, in veste di presupposto per il Tutto, per noi è soltanto un
risultato ultimo, anzi il risultato del risultato, un punto che si trova già tanto al di
là del ‘percorso’ quanto la sua origine divina sta ben al di là del suo inizio. In verità
quindi l’unità è soltanto un divenire unità, essa è solo in quanto diviene. Ed essa
diviene solo come unità di Dio. Solo Dio è, no anzi, diviene unità che tutto porta
a compimento» (p. 277).
Rosenzweig riprende anche la considerazione del fenomeno che abbiamo già vista in Hegel, ma la ribalta: «Il fenomeno era stato la crux dell’idealismo e quindi di
tutta la filosofia da Parmenide fino a Hegel; all’idealismo non era lecito concepirlo
come ‘spontaneo’, poiché ciò equivaleva a negare la suprema signoria del logos:
l’idealismo quindi non gli aveva mai reso piena giustizia e aveva dovuto trasformare artatamente la spumeggiante ricchezza nel morto caos del dato. L’unità del
Tutto pensabile non permetteva in fondo alcuna concezione alternativa. Il Tutto in
9 La parte introduttiva della Stella è significativamente intitolata “Sulla possibilità di conoscere il Tutto”.
74
EMILIO BACCARINI
Philosophical News
quanto Tutto unico e universale può essere tenuto unito solo da un pensiero che
possegga una forza attiva, spontanea. Ma ascrivendo la vitalità al pensiero si deve,
bene o male, negarla alla vita, negare alla vita la vitalità! Soltanto la visione metalogica del mondo può reintegrare la vita nei suoi diritti» (p. 49). Questa ‘vitalità’
sarà considerata l’elemento ‘plastico’ del mondo, una plasticità indispensabile a
proiettare il mondo nello spazio-tempo del futuro assoluto della redenzione e della
verità eterna.
Nelle ardite e suggestive pagine in cui Rosenzweig tratta della stella come figura
della verità eterna, ci troviamo di fronte a una ripresa dei tre elementi – Dio, mondo e uomo – nella prospettiva di una teoria della verità che li rende per così dire
trasparenti a loro stessi, ne rivela l’intima struttura e insieme rimanda a quell’unico orizzonte possibile di comprensione che è il compimento della redenzione. E
proprio per questo, tuttavia, restano in una dimensione che potremmo definire di
‘sospensione’ teo-teleologica che trasforma la dottrina della verità da teoria della
conoscenza a modello dell’esistenza il cui nome è in-veramento. La verità si invera. Al di là della teoria della conoscenza formale che cerca di stabilire sempre
forme di giudizio categoriali, Rosenzweig ci pone di fronte a una teoria ‘escatologica’ della verità che, quindi, per definizione, si colloca nel tempo, ma nell’orizzonte
aperto del tempo a-venire.
Dio, verità e spirito, questi sono i termini che Rosenzweig utilizza qui per
ridire gli elementi – Dio, mondo e uomo – che ora però nell’orizzonte della redenzione e quindi dell’eternità, sono diventati manifesti e oggetti di una nuova
‘logica’: la teo-logica, la cosmo-logica e, infine, la psico-logica. Tutti confluiranno
nella figura dell’inveramento che è l’escatologia la cui legge interna è la teleologia, ma allora bisognerà uscire dalla teoria e dal libro per entrare nel quotidiano
della vita. Questa, vita, è l’ultima parola della Stella che era iniziata con il suo
opposto, la morte.
«Dio è la verità» (p. 407) con questa proposizione si apre l’ultimo libro della
terza parte. Ma ciò significa che Dio è «il Signore del Tutto e Uno» (p. 412), Egli
troneggia sulla realtà che, proprio a partire da questa signoria, è garantita nella sua
verità, anche la realtà è verità. Contrariamente a tutto il percorso apofantico della
tradizione occidentale, alla domanda circa la verità – che cos’è la verità? – Rosenzweig propone una risposta di carattere ‘fattuale’ che, se da un lato richiama Descartes, dall’altro si poggia su una nuova posizione che non è possibile ricondurre
tout court alla metafisica. La verità, nella sua innegabilità «è un dato di fatto vero,
ma è un dato di fatto» (p. 415) e il dato di fatto di questa innegabilità esige fede.
Scrive Rosenzweig: «Così tutta la fiducia nella verità riposa su una fiducia ultima, e
cioè che il terreno su cui poggia la verità con i propri piedi sia in grado di reggerla.
La verità è essa stessa il presupposto ultimo della verità e non lo è in quanto verità,
che si regge sui propri piedi, ma in quanto dato di fatto su cui si fa affidamento.
La verità stessa è dato di fatto ancor prima del dato di fatto della sua innegabilità
[…] La fiducia della ragione in se stessa, cui i maestri della scuola dedicano le loro
cure, è del tutto legittima. Ma è legittima soltanto perché si basa su una fiducia di
tutto l’uomo, di cui la ragione è solo una parte; e tale fiducia non è una fiducia in se
stesso. La fattualità della verità sarebbe allora l’ultima cosa che la verità stessa ha
Philosophical News
FARE LA VERITÀ
75
da dirci su di sé. Questa ultima cosa è che essa esige fiducia in lei come in un dato
di fatto. E con ciò essa confessa proprio questo: di non essere Dio. Non è lei Dio.
Ma Dio è la verità […] Se Dio è la verità, che cos’è enunciato dicendo questo, circa
la sua essenza? Nulla più di questo, che egli è il fondamento originario della verità
e che tutta la verità è verità soltanto perché viene da lui» (pp. 415-416).
Si disegna così un percorso verso la verità la cui intima tensione è verso il Tutto,
ma «il Tutto dev’essere colto al di là della conoscenza e dell’esperienza vissuta, per
poter essere colto direttamente. Questo cogliere avviene appunto nell’illuminazione della preghiera» (p. 419). In questo modo ritroviamo noi stessi nella verità
che in quanto verità ultima è anche la nostra verità. L’uomo però deve rinunciare
all’esperienza della verità come verità intera, deve limitarsi a contemplarla in Dio.
«La verità deve dunque essere convalidata/in-verata e proprio nel modo in cui di
solito la si nega: cioè abbandonando a se stessa la verità ‘intera’ e tuttavia riconoscendo come verità eterna quella parte a cui ci si attiene» (p. 421). All’uomo, che
nella vita rimane uomo, resta come proprio ambito il ‘così’ e come propria parola
l’‘è vero!’. È esattamente a questo punto che si inseriscono l’ebreo e il cristiano
come ‘figure dell’umanità’ e anche come il duplice modo «in cui la verità, che
nella rivelazione irrompe dentro il ‘qui’ ed ‘ora’, poteva unirsi con l’‘è vero!’ detto dall’uomo» (p. 423). A queste due figure dell’umano è consegnato il compito
dell’in-veramento della verità, che è la prospettiva escatologica della via cristiana
e della vita ebraica tese entrambe verso il compimento (Voll-Endung) della redenzione, l’unificazione/unità di Dio già ricordata. La verità è così proiettata alla fine,
fine del tempo, verso l’eternità come il dopo del tempo.
3. Il processo ermeneutico
Rivolgiamoci ora brevemente all’ultimo paradigma in cui si annuncia la verità
come risultato, il paradigma ermeneutico come ci si presenta in Luigi Pareyson10,
in cui pure risuona la ‘formatività’, la Gestaltung di cui abbiamo già parlato. A
chiarificazione del significato che egli intende dare alla parola formatività, nelle
prime righe del suo libro Estetica. Teoria della formatività11, Pareyson scrive: «per
‘forma’ intendo organismo, vivente di vita propria e dotato di una legalità interna: totalità irripetibile nella sua singolarità, indipendente nella sua autonomia,
esemplare nel suo valore, conclusa e aperta insieme nella sua definitezza che rac-
10 In particolare in Verità e interpretazione, Mursia, Milano 1971. È chiaro che il discorso
potrebbe riguardare anche l’opera di H.G. Gadamer, Verità e metodo, dove pure è presente
la dimensione dell’operatività. L’ermeneutica è, per definizione, un ‘procedimento’ che è teso
teleologicamente e intenzionalmente verso un compimento che non si dà nell’immediatezza.
La fondazione ontologica heideggeriana ci costringerebbe a rivedere alcuni dati fondativi. Un
diverso approccio consentirebbe la prospettiva ermeneutica di P. Ricoeur, più vicina a quanto
sto qui presentando. Non a caso la prospettiva ultima del filosofo francese è nella direzione di
una ‘poetica’.
11 La prima edizione è Ed. di Filosofia, Torino 1954. Io cito da Sansoni, Firenze 1974.
76
EMILIO BACCARINI
Philosophical News
chiude un infinito, perfetta nell’armonia e unità della sua legge di coerenza, intera
nell’adeguazione reciproca fra le parti e il tutto... carattere dinamico della forma,
alla quale è essenziale l’essere un risultato, anzi la riuscita di un ‘processo’ di formazione ché la forma non può essere vista come tale se non la si scorge nell’atto di
concludere, e insieme includere, il movimento di produzione che vi pone capo e vi
trova il proprio successo» (p. 7).
Mi limito qui semplicemente a registrare queste affermazioni che indubbiamente ci aprono su prospettive particolarmente allettanti, ma che ora servono soltanto
a contestualizzare e a nutrire il ‘processo’ ermeneutico. L’ermeneutica è una teoria della verità, ma anche una metodologia che implica un’ontologia. Tutto ciò
nel filosofo torinese assume dei connotati di significativa originalità. Una prima
distinzione, certamente molto feconda, che egli propone è la differenza tra il pensiero espressivo e il pensiero rivelativo. In tal senso scrive: «Il pensiero rivelativo è
sempre insieme espressivo, perché la verità non si offre se non all’interno di ogni
singola prospettiva: la verità è accessibile solo mediante un insostituibile rapporto
personale e formulabile solo attraverso la personale via d’accesso ad essa. Il pensiero che muove da questa solidarietà originaria di persona e verità è al tempo stesso
ontologico e personale, e quindi insieme rivelativo ed espressivo, cioè esprime la
persona nell’atto di rivelare la verità e rivela la verità nella misura in cui esprime la
persona, senza che l’uno dei due aspetti prevalga sull’altro» (p. 17).
Il legame stretto, direi essenziale, tra persona e verità non produce una reductio e quindi una più o meno larvata forma di soggettivismo, al contrario significa
che della verità si dà esclusivamente un’interpretazione personale senza però che
la persona possa appropriarsi della verità. Il processo dell’interpretazione è, pur
nella finitezza della persona, teleologicamente proiettato in un tempo infinito che
ha il suo presupposto in una ontologia dell’inesauribile12. Il peso ermeneutico della persona ci ricollega a quanto sopra si diceva del rapporto tra verità e libertà in
Heidegger, e anche Pareyson, utilizzando la stessa espressione ‘lasciar essere’, non
vede nel processo ermeneutico un mostrarsi o manifestarsi della verità ‘attraverso’
il soggetto personale; non è un rapporto strumentale, anzi «nell’interpretazione
la persona interviene soprattutto come via d’accesso e organo di conoscenza» (p.
83). Tuttavia, «il senso di tutta questa attività libera e solerte consiste pur sempre
nell’ascolto, giacché la verità non è cosa che l’uomo inventi o produca, o che si possa in generale produrre o inventare: la verità bisogna lasciarla essere, non pretendere d’inventarla; e se la persona si fa organo della sua rivelazione è soprattutto per
riuscire ad essere sede del suo avvento» (p. 84). L’attività dell’umano e l’esercizio
della libertà nel processo ermeneutico corre sempre il rischio di non essere soltanto rivelazione, ma anche occultamento. «Questa precarietà dell’interpretazione
12 Parlando dello statuto dell’interpretazione (p. 81 e ss.) Pareyson chiarisce in che modo
bisogna intendere il ‘possesso’ personale della verità, senza che questa venga ingabbiata nei limiti
del tempo e conclude: «L’interpretazione è infatti l’unica forma di conoscenza che sia capace per
un verso di dare una formulazione personale e quindi plurale di qualcosa di unico e indivisibile,
senza per questo comprometterne o disperderne l’unità, e per l’altro verso di cogliere e rivelare
un infinito, senza limitarsi ad alludervi o girarvi intorno, ma possedendolo veramente».
Philosophical News
FARE LA VERITÀ
77
non è dovuta alla sua personalità e pluralità, ch’è più una ricchezza che un’imperfezione, ma all’alternativa posta dalla libertà stessa della persona, la quale può fare
di sé una prigione angusta, opaca all’avvento del vero, oppure un’ariosa apertura
dischiusa alla sua rivelazione; tant’è vero che quando sceglie di farsi tramite della
verità, non c’è nessun organo di conoscenza che sia altrettanto acuto, penetrante
e sicuro» (pp. 84-85). Queste ultime affermazioni ci riportano a quanto dicevamo
sopra e sollecitano a prendere radicalmente sul serio questa ‘operatività’ dell’umano. Fare la verità significa situarsi dialogicamente di fronte alle molte, infinite, altre
prospettive con la consapevolezza che ciascuno è responsabile della sua porzione
di verità da rivelare e che nessun altro lo farà al suo posto.
Emilio Baccarini
Università di Roma Tor Vergata
[email protected]
Emilio Baccarini è docente di Antropologia filosofica presso l’Università di Roma Tor Vergata. Di formazione fenomenologica (Fenomenologia. La filosofia come vocazione, Roma 1981),
negli anni si è occupato a lungo anche del pensiero ebraico contemporaneo, in particolare di
Rosenzweig, Levinas (Levinas. Soggettività e infinito, Roma 1985), Heschel e del pensiero dialogico (La soggettività dialogica, Roma 2002; La persona e i suoi volti, (Roma 20032). Baccarini è
inoltre fondatore e direttore della rivista di fi losofia on line Dialegesthai (http://mondodomani.
org/dialegesthai).
Marco Buzzoni
Verità ed epistemologia evoluzionistica
The theory of evolution and the theory of truth are closely connected in the program of Evolutionary Epistemology (EE). This paper aims to show that the very
broad, naturalistic conception of cognition and truth adopted by EE, which comprises
an amoeba’s reactions as well as human symbolic thinking, usually leads to confusion
between “adaptation to the environment” on the one hand and knowledge (as presupposing claims which can be either true or false) on the other hand. However, the
main thesis of EE can be consistently upheld if we make this distinction.
1. Il problema della verità nell’epistemologia evoluzionistica
Seguendo Bradie 1986, si è soliti tracciare una distinzione fra due diversi, anche
se profondamente intrecciati programmi di ricerca nell’ambito dell’epistemologia
evoluzionistica (evolutionary epistemology; d’ora innanzi EE):
One is the attempt to account for the characteristics of the cognitive mechanisms in
animals and humans by a straightforward extension of the biological theory of evolution
to those aspects or traits of animals which are the biological substrates of cognitive activity [...]. The other program attempts to account for the evolution of ideas, scientific
theories and culture in general by using models and metaphors drawn from evolutionary
biology.1
Comune a queste tendenze, tuttavia, è il cosiddetto “argomento evoluzionistico” (evolutionary argument). Già presente in Herbert Spencer e in Ernst Mach2,
l’argomento è stato mediato al dibattito epistemologico contemporaneo soprattutto grazie a Konrad Lorenz. Non soltanto il cervello, ma anche la percezione e
la cognizione umana (coscienza, pensiero, ecc.), sono il risultato della selezione
naturale, in un senso analogo a quello in cui è tale ogni tratto fenotipico o compor-
1 M. Bradie, “Assessing evolutionary epistemology”, p. 403, in Biology and Philosophy, 1,
1986, pp. 401-459.
2 Ernst Mach, com’è noto, aveva insistito sul «valore biologico» della conoscenza (cfr. per
esempio E. Mach, Erkenntnis und Irrtum, Barth, Leipzig 1905, pp. 450-452); sull’interpretazione biologica dell’a priori kantiano in Mach, cfr. M. Čapek, “Ernst Mach’s biological theory of
knowledge”, in Synthese, 18, 1968, pp. 171-191.
Philosophical News
VERITÀ ED EPISTEMOLOGIA EVOLUZIONISTICA
79
tamentale. Nell’adattamento di un organismo al suo ambiente è quindi presente,
sotto forma di una sorta di corrispondenza fra l’organismo e l’ambiente, una qualche conoscenza o informazione sull’ambiente stesso. Il sistema degli organi di senso
e il sistema nervoso, che consentono agli esseri viventi di sopravvivere ed orientarsi
nell’ambiente circostante, sono evoluti filogeneticamente, adattandosi, mediante
interazione con la realtà che esperiamo, allo spazio fenomenico3. Proprio come
lo zoccolo del cavallo è adattato al terreno della steppa, così il nostro apparato
cognitivo – come del resto ogni altro organo – ha acquisito la sua forma funzionale
grazie a lunghe epoche d’incontro della realtà con la realtà4.
Ora, v’è un innegabile motivo di vero nella tesi secondo cui, nell’adattamento di
una specie ad un ambiente, v’è una certa informazione o conoscenza. Proprio per
poter sostenere coerentemente questo motivo di vero, tuttavia, è necessario togliere la duplice tendenziale confusione che attraversa quasi ogni variante di EE e che
concerne, per un verso, le nozioni di “adattamento” e di “conoscenza”, e per altro
verso quelle di “evoluzione naturale” e di “evoluzione culturale”. L’uso di una vaga
analogia – che va dal comportamento di un’ameba al pensiero astratto-simbolico
umano – oscura qui una distinzione di principio, quella fra il dominio ipoteticoriflessivo della mente e la realtà.
A ben vedere, da un punto di vista meramente biologico e naturalistico, è impossibile porre un nesso qualunque fra il carattere adattivo e di sopravvivenza
delle variazioni evolutive (comunque esse siano generate) e la verità delle credenze.
Ciò è possibile soltanto se il valore di sopravvivenza d’una variazione è interpretato
sin dal principio nei termini dell’alternativa del vero o del falso, presupponendo
cioè l’irriducibilità di questa stessa alternativa al puro bios. Soltanto così il carattere adattivo (o non adattivo) di una variazione può essere considerato come conseguenza di credenze vere (o false).
In caso contrario, infatti, saremmo costretti a sostenere che la corrispondenza
fra due pezzi di un puzzle (o fra lo zoccolo del cavallo e il terreno della steppa, per
riprendere l’esempio di Lorenz) sia dello stesso genere della relazione simbolica di
corrispondenza tra i fatti e gli enunciati veri o falsi che li asseriscono. Ma le cose non
possono stare in questi termini. La relazione simbolica di corrispondenza possiede
un’intrinseca duplicità, quella del vero o del falso, che non possiede alcuna controparte oggettiva nella natura delle cose, ove tutto accade e si svolge in un sol modo.
Quest’ambiguità coinvolge entrambe le tendenze che vanno sotto il nome di
EE. Anche i sostenitori dell’EE nel secondo senso distinto da Bradie – come Campbell (1974a), Popper (1972), Toulmin (1972) e Hull (1988) – sono talvolta incorsi
nell’errore di farsi affascinare dalle pur notevoli e importanti analogie che esistono
fra la conoscenza umana e le forme pre-umane di feedback adattivo all’ambiente
naturale, perdendo di vista la differenza di principio che sussiste fra questi casi.
3 Cfr. K. Lorenz, Die Rückseite des Spiegels, Piper, München, Engl. Transl., Behind the Mirror, Methuen, London 1973, p. 9.
4 Cfr. K. Lorenz, “Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie”,
1941/1942, pp. 98-99, in Blätter für deutsche Philosophie, 15, pp. 94-125.
80
MARCO BUZZONI
Philosophical News
L’esempio più interessante è forse quello di Popper, che rimane oscillante fra
due tendenze opposte. Egli, per un verso, ha scorto una stretta analogia fra, da un
lato, il “trial and error”, inteso come metodo consapevolmente e sistematicamente
impiegato dallo scienziato, e, dall’altro, il “trial and error”, considerato come processo reale d’adattamento seguito dagli organismi nella loro lotta per l’esistenza.
Gli animali tenterebbero diverse strade per risolvere i loro problemi di sopravvivenza, in modo del tutto analogo allo scienziato, che usa il metodo del “trial and
error” nella sua ricerca della verità, avanzando ipotesi e selezionandole alla luce del
verdetto dell’esperienza5.
Per altro verso, tuttavia, Popper ha chiaramente scorto che vi è un punto in
cui l’analogia tra il procedimento scientifico e il processo biologico d’adattamento
viene meno, rivelando uno iato fra natura e cultura, fra realtà animale ed esistenza
umana (che però egli crede di poter nuovamente colmare mediante la nozione
d’evoluzione emergente): nella formulazione linguistica, le teorie scientifiche si trasformano in oggetti esterni a noi stessi. In tal modo possiamo sbarazzarci di una
teoria inadatta prima che la sua adozione renda inadatti noi alla sopravvivenza:
con il criticare le nostre teorie, noi possiamo far morire le nostre teorie al nostro
posto. Anche se il metodo del tentativo e dell’errore è comune sia all’ameba sia
ad Einstein, l’ameba paga il proprio errore con la vita, mentre Einstein, potendo
far morire le teorie al proprio posto, va consapevolmente alla ricerca dell’errore6.
Ora, qui Popper mostra di aver colto il vero limite di principio dell’analogia
fra evoluzione biologica ed evoluzione culturale7. In quanto metodo, il “trial and
error” non può venir esteso al mondo della materia inanimata o anche organica,
perché qui, anche secondo Popper, manca un «io», un soggetto responsabile che
possa dar senso alla nozione di metodo, conoscenza e verità. Se, come Popper
afferma, è tipico degli animali il fatto di perire insieme con le loro “teorie” errate,
ciò a ben vedere può soltanto significare che in questo caso è del tutto fuorviante
parlare di teorie (o d’ipotesi o di conoscenze). Ogni ipotesi teorica, secondo l’epistemologia popperiana, ha carattere radicalmente ipotetico: si congettura che sia
vera (e può effettivamente essere tale), ma può anche essere falsa. È invece evidente
che le preferenze, le aspettazioni e i tentativi “errati” degli organismi biologici
5 K.R. Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Clarendon Press, Oxford
1972.
6 Cfr. per es. K.R. Popper and J.C. Eccles, The Self and Its Brain. An Argument for Interactionism, Springer, Berlin, 1977, p. 463.
7 L’analogia popperiana fra evoluzione darwiniana ed evoluzione culturale è stata spesso
contestata (cfr. per es. J. Worrall, “Revolution in Permanence: Popper on Theory-Change in Science”, in A. O’Hear (ed.), Karl Popper: Philosophy and Problems, Cambridge University Press,
Cambridge, 1995, pp. 75-102) o difesa nei suoi contenuti specifici (cfr. D. Turner, “Universal
Darwinism and process essentialism”, pp. 116-117, in Gontier N. et al., Language and Culture,
Springer, Dordrecht 2006, pp. 109-118, che la intende come una somiglianza di famiglia di tipo
wittgensteiniano) e talvolta addirittura tecnici (cfr. per es. F.M. Akeroyd “Popper’s Evolutionary
Epistemology Revamped”, in Journal for General Philosophy of Science, 35, 2004, pp. 385-396),
mentre qui importa porre in evidenza il solo punto fondamentale che distingue in linea di principio evoluzione biologica ed evoluzione scientifica.
Philosophical News
VERITÀ ED EPISTEMOLOGIA EVOLUZIONISTICA
81
conducono alla morte di questi ultimi soltanto perché sono, per così dire, tentativi
“reali”, i quali possono essere eliminati o distrutti (non contraddetti) da altre forze
reali, senza che di loro resti nulla. Diversamente dalle teorie scientifiche, essi non
hanno la possibilità d’essere diversi da ciò che sono.
2. Epistemologia evoluzionistica e verità scientifica
Una volta che sia stata tolta l’ambiguità che abbiamo segnalato nella prima parte di questo scritto, è possibile accogliere l’argomento evoluzionistico? Secondo
l’obiezione più spesso mossa contro quest’argomento, il fatto di essere sopravvissuti è compatibile anche col fatto di possedere delle credenze false. Questo mostrerebbero in modo palese le illusioni percettive, e questo mostrerebbero i comportamenti cognitivamente non ottimali cui gli esseri umani sono ripetutamente succubi
sia nella vita di tutti i giorni sia nella scienza8. Talvolta, anzi, una convinzione errata
può essere utile alla sopravvivenza o, viceversa, una convinzione corretta può essere dannosa9.
Ora, a me pare che l’argomento evoluzionistico – di per sé preso – sia sostanzialmente corretto. L’argomento centrale dell’EE non richiede affatto che le facoltà o
gli organi di cui dispone una specie conducano sempre a conclusioni vere, ma soltanto che dovrebbero far ciò nella maggior parte dei casi. E ammettere che in alcuni
casi anche credenze che sappiamo false si sono rivelate utili per la sopravvivenza,
non esclude ovviamente che, nella maggioranza dei casi, siano le credenze vere ad
aumentare le probabilità di sopravvivenza.
Ma anche qui, per comprendere bene la portata e il senso dell’argomento evoluzionistico, è necessario evitare di ricondurre affrettatamente sotto un unico genere
o concetto sia la nozione biologica di “adattamento” sia quella gnoseologica di “conoscenza” o di “verità”. A rigore, infatti, l’argomento dell’EE in favore della corrispondenza fra la maggior parte delle nostre credenze e la realtà vale soltanto per la
conoscenza percettiva e per gli schemi ereditabili propri del senso comune, mentre
non pare, almeno direttamente, poter valere per la conoscenza o la verità scientifica.
Perché mai l’evoluzione biologica avrebbe infine condotto a un tipo di conoscenza
8 Cfr. per es. A. Tversky and D. Kahneman, “Judgment under uncertainty: Heuristics and biases”, in Science, 185, 1974, pp. 1124-1131; “Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment”, in Psychological Review, 90, 1983, pp. 293-315; R. Falk, “The
perception of randomness”, in Proceedings of the Fifth International Conference for the Psychology
of Mathematics Education, Vol. 1, Laboratoire I.M.A.G., Grenoble (France) 1981, pp. 222-229;
G. Gigerenzer and D.J. Murray, Cognition as Intuitive Statistics, Lawrence Erlbaum Associates,
Hillsdale (NJ) 1987, per es. 64 e 85; J. Evans, Bias in human reasoning: Causes and consequences,
Erlbaum, Hillsdale (N.J.) 1989; M. Gorman, Simulating Social Epistemology, in R.N. Giere (ed.),
Cognitive Models of Science, University of Minnesota Press, Minneapolis 1992, pp. 400-426.
9 Cfr. per es. S.P. Stich, “Could Man Be an Irrational Animal?”, p. 347, in H. Kornblith
(ed.), Naturalizing Epistemology, The MIT Press, Cambridge (Mass.) 1994, pp. 337-357; D.S.
Wilson, “Species of Thought: A Comment on Evolutionary Epistemology”, p. 39, in Biology and
Philosophy, 5, 1990, pp. 37-62.
82
MARCO BUZZONI
Philosophical News
che s’interessa d’ogni cosa, e non soltanto di cose direttamente utili alla sopravvivenza? Come ha fatto a emergere, nell’uomo, una molla conoscitiva i cui scopi vanno
oltre i bisogni biologici? Come ha fatto a sorgere l’impulso a dirigersi non soltanto
verso il mesocosmo, ma anche verso il microcosmo e il macrocosmo, cioè verso realtà
non immediatamente accessibili alla nuda percezione? E ancora, l’argomento centrale nell’EE depone anche in favore dell’esistenza dei neutrini e dei campi di forza?
In effetti, alcuni sostenitori dell’EE si sono limitati ad applicare il meccanismo della
selezione naturale a livello degli oggetti di grandezza media, quelli della lotta naturale
per la sopravvivenza dell’uomo10. Questa limitazione, tuttavia, per quanto tatticamente
coerente, si trova in conflitto strategico difficilmente conciliabile con uno degli intenti
fondamentali dell’EE – anzi, con il suo intento fondamentale –, quello di spiegare evolutivamente la conoscenza umana, da cui non può certo essere esclusa la scienza.
Fra coloro che hanno discusso nel modo più approfondito questo problema
v’è Gerhard Vollmer. Secondo Vollmer – seguito da altri autori11 –, la tesi centrale
dell’EE non vale soltanto per l’evoluzione biologica, ma anche per quella culturale.
È infatti un vantaggio evolutivo – è questo il suo argomento – possedere una conoscenza disinteressata come quella umana, capace di volgersi non soltanto agli oggetti di grandezza quotidiana (il «mesocosmo»), ma anche al microcosmo e al macrocosmo; non soltanto ad alberi e animali, ma anche a virus e galassie. In altre parole,
la stessa indagine disinteressata del mondo non è in contrasto col valore biologico
della conoscenza, ma è al contrario un comportamento biologicamente adeguato12.
Tutto ciò riguarderebbe la stessa genesi della mente umana, che si può soltanto
spiegare evolutivamente: disporre di una facoltà di pensiero capace di afferrare le
strutture del mondo reale rappresenterebbe un evidente vantaggio nella lotta per
la sopravvivenza13. Vollmer si spinge anzi sino ad affermare che, proprio grazie al
fatto d’essere l’unico essere che sa d’essere un prodotto dell’evoluzione, l’uomo può
modificare il decorso di quest’ultima, intervenendo su di essa e guidandola14.
10 Cfr. per es. D.T. Campbell and B.T. Paller, “Extending evolutionary epistemology to ‘justifying’ scientific beliefs (a sociological rapprochement with a fallibilist perceptual foundationalism?)”, 1989, p. 232, in K. Hahlweg and C.A. Hooker (eds.), Issues in Evolutionary Epistemology, State University of New York Press, Albany (NY), pp. 231-257.
11 Cfr. per es. G. Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie, Hirzel, Stuttgart 1975, p. 35. Fra
gli altri autori, v. per es. D.T. Campbell, “Unjustified variation and selective retention in scientific
discovery”, p. 141, in F.J. Ayala and T. Dobzhansky (eds.), Studies in the Philosophy of Biology,
Macmillan, London, pp. 139-161, e F.M. Wuketits, “Evolutionary epistemology – a Challenge to
Science and Philosophy”, p. 14, in F.M. Wuketits (ed.), Concepts and Approaches in Evolutionary
Epistemology, Reidel, Dordrecht 1984, pp. 1-33.
12 G. Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie, Hirzel, Stuttgart 1975, p. 121 (le citazioni
sono tratte dalla quinta edizione del 1990).
13 G. Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie, Hirzel, Stuttgart 1975, pp. 102-106.
14 G. Vollmer, Evolutionäre Erkenntnistheorie, Hirzel, Stuttgart 1975, pp. 85-86. Per una
tesi analoga cfr. per es. M. Ruse, Taking Darwin Seriously, Blackwell, Oxford 1986, cap. 5; A.H.
Goldman, “Natural Selection, Justification, and Inference to the Best Explanation”, pp. 41-43,
in N. Rescher (ed.), Evolution, Cognition, and Realism: Studies in Evolutionary Epistemology,
University Press of America, Lanham (MD), 1990, pp. 39-46; S. Pinker, How the Mind Works,
Norton, Oxford 1997, p. 155.
Philosophical News
VERITÀ ED EPISTEMOLOGIA EVOLUZIONISTICA
83
Ora, a causa della differenza di principio che abbiamo visto sussistere fra il
processo biologico d’adattamento all’ambiente e il processo conoscitivo (intrinsecamente caratterizzato dalla duplicità del vero o del falso), l’argomento evolutivo
non può essere legittimamente esteso alla conoscenza scientifica in senso stretto.
Ciò si scorge subito, non appena si provi ad estendere la tesi del carattere adattivo d’ogni conoscenza alla stessa epistemologia evoluzionistica in quanto tale.
Possiamo giustificare l’epistemologia evoluzionistica in termini d’epistemologia
evoluzionistica? In un certo senso sì: almeno in via congetturale, anche l’epistemologia evoluzionistica – posto per esempio che promuova la ricerca scientifica
– può rivelarsi indirettamente utile per la sopravvivenza del genere umano. Ma in
un altro senso la risposta è negativa: il fatto che una risposta evolutiva sia favorevole o meno alle capacità di sopravvivenza va di volta in volta discusso, valutato o
giudicato, e questa discussione, valutazione o giudizio – o meglio la pretesa di verità
che questi implicitamente contengono – non si lascia in alcun modo ridurre evoluzionisticamente. Proprio la pretesa di avere un valore di verità, che l’epistemologia
evoluzionistica necessariamente solleva, non può essere spiegata o giustificata in
termini di mera sopravvivenza biologica.
Pensando a casi come quelli di Bruno o di Socrate, forse si potrebbe riassumere
questo punto come segue: poiché si può anche morire perché si nutrono credenze
che potrebbero essere vere, anche se non sono socialmente accettate (sino al punto
di avere un valore che pregiudica la stessa sopravvivenza), è chiaro che la verità
delle nostre credenze non può essere spiegata senza residui sulla base del solo valore di sopravvivenza. E tuttavia, tolta la confusione di cui s’è detto, l’adattamento
biologico può certamente costituire un buon indicatore della verità delle nostre
conoscenze, anche di quelle scientifiche.
Marco Buzzoni
Università degli Studi di Macerata
[email protected]
Marco Buzzoni è professore ordinario di Filosofia della Scienza presso il Dipartimento di
Filosofia e Scienze Umane dell’Università di Macerata. Ricercatore von Humboldt presso le
università di Würzburg (1988-1989, 2002, 2006), Marburg (2004) ed Essen (2010), è membro
ordinario dell’Académie Internationale de Philosophie des Sciences. Fra i suoi libri: Conoscenza
e realtà in K.R. Popper (1982), Semantica, ontologia ed ermeneutica della conoscenza scientifica.
Saggio su Thomas Kuhn (1986), Paul Ricoeur. Persona e ontologia (1988), Operazionismo ed ermeneutica. Saggio sullo statuto epistemologico della psicoanalisi (1989); Scienza e tecnica. Teoria ed
esperienza nelle scienze della natura (1995), Esperimento ed esperimento mentale (2004), Thought
Experiment in the Natural Sciences (2008).
Lorenzo Fossati
La verità della parola.
La critica di Ebner all’idealismo e alla filosofia in generale*
The paper examines the fierce criticism of the Austrian philosopher Ebner to the
idealism of Hegel and to philosophy more generally, which he deems unable to account for the spiritual dimension. In order to understand the «dialogic thought» of
the author, this paper first proposes an analogy between Ebner and the acrobat player
Jof of the movie The Seventh Seal by Ingmar Bergman. The paper then carries out
a comparison between the thought of Ebner and that of Hamann, who also reflected
on the limits of reason and of the word as something that cannot be simply defined
as concept, particularly in the case of the dimensions of spirituality and faith. In the
conclusion, the paper examines the actual possibility of finding a balance between the
need for rationalism and the infiniteness of faith.
1. Jof il saltimbanco
Di ritorno dalle crociate, dopo molto pellegrinare e soffrire, il cavaliere svedese
Antonius Block finalmente riguadagna la terra natia; ma ad attenderlo sulla spiaggia c’è la Morte, che esige la sua vita. Questo l’inizio del celebre film di Ingmar
Bergman, Il settimo sigillo (1957), che narra della partita a scacchi giocata dal cavaliere contro la Morte, nella speranza di guadagnare tempo e di poter riabbracciare
la moglie che lo attende nel castello; è nel corso di questa partita itinerante che
altri personaggi si aggiungono ad Antonius nel viaggio e, in un certo qual modo,
prendono parte anche loro alla sfida, rivelando così la sua natura metaforica della
stessa vita umana.
Ora, se il protagonista è roso dai dubbi e dall’angoscia, ed esprime a pieno titolo una sensibilità tutta «moderna», nel suo avvertire la lontananza di un Dio che
continua a invocare ma che gli si nega (un caso tipico di esistenzialismo nordico,
si direbbe), a questi si contrappone Jof, il saltimbanco. Nella prima scena in cui
compare sta raccontando alla moglie di aver appena visto la Madonna, e la cosa
* Una prima versione di questo articolo è stato ospitato dal sito www.filosofionline.com nel
settembre 2010; chi scrive desidera ringraziare il Professor Adriano Pessina che ha consentito
a che venisse qui ripresentato. Rispetto a quella prima pubblicazione, il testo introduce alcune
integrazioni e modifiche.
Philosophical News
LA VERITÀ DELLA PAROLA
85
che spicca immediatamente è la gioiosità del suo credere e l’immediata e semplice
naturalezza con cui il Divino gli si fa presente; egli nulla ha a che spartire con il Cristianesimo problematico del crociato (che si delinea in funzione della morte, quella
che ha inflitto nel corso delle battaglie combattute e quella incombente sul suo
capo) o con quello cupo e angosciante della superstizione fanatica che fa da sfondo
alla vicenda. Anzi, egli è l’unico che riesce a scorgere la Morte oltre ad Antonius, e
quindi a scappare e a porsi in salvo con la famiglia, per poter assistere, nell’ultima
scena, alla danza macabra di tutti i personaggi che, tenendosi per mano, seguono
la nera signora nell’ultimo, definitivo viaggio.
Il filosofo austriaco Ferdinand Ebner (nato a Wiener Neustadt il 31 gennaio
1882 e morto a Gablitz il 17 ottobre 1931) sembra assomigliare a questo semplice,
a questo puro di cuore che vede Dio (ed è quest’ultima una delle espressioni evangeliche più ricorrenti nelle sue pagine). La sua attualità, la sua modernità, non è certo
dovuta a un tormento analogo a quello che affligge Antonius: piuttosto colpisce la
sua religiosità che sembra aver superato ogni problematicità e angoscia1.
2. Ebner contro l’idealismo: il «realismo spirituale»
Questo «superamento», certamente diverso dall’Aufhebung idealista, viene descritto nel Quaderno blu, risalente agli anni 1909/10, ove si parla di tre gradi di
esistere in rapporto allo spirito2.
Nel primo sorge nell’uomo l’interrogativo sul senso della vita, la problematicità
della discrepanza che egli avverte tra l’idea e la realtà, vale a dire tra il Dio che esige
e la Sua assenza che esperisce; la ricerca di Dio, a questo livello, è destinata a restare senza soddisfazione, giacché l’uomo si trova ancora «come in sogno» (Ebner
parla di «sogno dello spirito», «Traum vom Geist»), vale a dire nell’inconsapevolezza della propria natura – e avremmo detto «essenza», se Ebner non ci avvertisse
che l’errore dell’ipostatizzazione, la tendenza a sostanzializzare, è assolutamente
incompatibile con il discorso sulle realtà spirituali: quanto siamo lontani dallo
«Spinozist sein» che Hegel poneva come irrinunciabile premessa per l’autentico
filosofare! È qui che si gioca lo spazio della cultura, della speculazione filosofica,
dell’arte, tutte attività accomunate dal loro carattere «onirico», irreale e inefficace.
Ed è infatti nel secondo grado che avviene il «risveglio» e si diviene consapevoli
della sproporzione tra la realtà esistenziale e «il significato spirituale di essa»: qui
si avverte la frantumazione della vita, la quale non più solamente esige un’ulteriorità per essere autosufficiente, ma si accorge della propria strutturale eccentricità,
cioè di avere il proprio fondamento fuori di sé. Si tratta di un’alienazione assoluta,
1 Per la bibliografia completa si rimanda a S. Zucal, Ferdinand Ebner. La «nostalgia» della
parola, Morcelliana, Brescia 1999, pp. 311-347.
2 F. Ebner, Parola e amore. Dal diario 1916/17. Aforismi 1931, a cura di E. Ducci e P. Rossano, Rusconi, Milano, 1983, pp. 80-81 (il volume offre una raccolta di brani tratti da Schriften,
a cura di F. Seyr, München, Kösel 1963, I, pp. 19-73, 909-1013, e da Wort und Liebe, a cura di
H. Jone, Pustet, Regensburg 1935).
86
LORENZO FOSSATI
Philosophical News
che ci appare in tutta la sua drammaticità angosciante (viene in mente Barth e il
«totalmente Altro»).
Ma a liberarci da tale angoscia interviene la Grazia – ed eccoci al terzo livello
– per l’azione della quale «l’uomo vive la sua vita come un rigenerato dallo spirito»: Dio accoglie in sé la sua anima e lo salva. Ebner sottolinea la superiorità di
questa dimensione propriamente religiosa rispetto alle precedenti e non si stanca
di precisare come solo ed esclusivamente in essa lo spirituale viva autenticamente;
nei Frammenti pneumatologici del 1921 si dice: «Il perché? tace quando Dio parla
all’uomo. Ed egli vuol essere ascoltato. La sua parola non è però davvero la risposta alle domande speculative della metafisica circa il motivo ultimo delle cose»3.
Tanto è vero che Ebner rimarca tale contrapposizione restringendo la rosa della
scelta: solo due sono gli eventi spirituali nell’uomo, e si calibrano sulla persona di
Gesù: il primo è la concezione dell’idea, nella quale si attua il sogno dello spirito,
il secondo è il mettere l’intera esistenza interiore «in rapporto al fatto che Gesù
è vissuto». È evidente come da questa seconda prospettiva tutt’altro significato
acquistino la ricerca filosofica o la produzione artistica: non si tratta che di mezze
verità balbettate, di pallidi spiragli della luminosa magnificenza che l’uomo religioso può gustare.
A questo punto, potremmo essere tentati di riconoscere in questa figura i tratti
di una sorta eremita chiuso nella propria torre d’avorio, che dall’alto della superiorità conseguita giudica con sufficienza gli altri uomini; ma nulla sarebbe meno
appropriato: è anzi il filosofo a essere chiuso all’interno del proprio Io (Icheinsamkeit), a trincerarsi ostinatamente entro la propria «muraglia cinese», nel disprezzo
per l’uomo (Menschenverachtung) e nell’assenza di Tu (Dulosigkeit). Si tratta di
una condizione naturale, che va superata nel «salto», nella scelta personale: «L’inclinazione a intendere la vita come un sogno l’uomo la porta con sé già venendo
al mondo. Egli nasce, per così dire, già come filosofo idealista. È la concezione
dell’idea che travia i filosofi a intendere la vita come sogno. L’uomo deve andare
oltre il sogno della vita, anche se non è proprio filosofo, e vuol comprendere il significato spirituale della sua esistenza nel mondo. All’inizio questa comprensione è
sempre un sogno»4. E infatti «ci sono solo due realtà spirituali. Dio e l’io». La vita
dello spirito nell’uomo si gioca tra questi: «Con il suo insegnamento Gesù ha preparato la fine di ogni idealismo, la sua vita ha dato inizio a quello che si potrebbe
chiamare il realismo dello spirito»5.
Se anche i più distratti avranno colto gli echi kierkegaardiani di queste pagine
già nel riferimento a tre stadi della vita o nel ripensamento del concetto hegeliano
di superamento, la consonanza si fa ancora più esplicita nella fortissima tensione
posta da Ebner tra l’astrattezza intellettuale e la concretezza del rapporto personale che si instaura non solo tra l’Io e Dio, ma anche tra l’Io e il Tu: proprio in rappor3 Id., La parola e le realtà spirituali. Frammenti pneumatologici, a cura di S. Zucal, tr. it. di P.
Renner, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998, p. 29 (ed. or. Das Wort und die geistigen Realitäten.
Pneumatologische Fragmente, Brenner, Innsbruck 1921).
4 Così nel Diario 1916/17, pp. 50-51.
5 Ibi, p. 84.
Philosophical News
LA VERITÀ DELLA PAROLA
87
to al Tu, anzi, l’Io viene a definirsi nella sua realtà, a liberarsi della sua astrattezza,
giacché alla Dulosigkeit, all’«assenza di Tu» come stato patologico non originario,
si contrappone la Duhaftigkeit, la «natura di Tu» della coscienza. E qui si specifica
nella sua valenza positiva quella alienazione cui sopra si accennava: interessante è
notare il modo in cui Ebner utilizza uno schema concettuale idealistico proprio
nel tentativo di superare il solipsismo cui sembra obbligato il pensiero filosofico.
Si legge a tal proposito nei Frammenti del ’21: «L’Io non ha alcuna esistenza
assoluta, in quanto esiste solo in rapporto verso il Tu. Al suo esser oggettivamente
dato nella parola corrisponde la sua sussistenza soggettiva nell’amore; in maniera
tale che la parola e l’amore stanno assieme per quanto riguarda il comune fondamento spirituale»6. Ebner individua la radice dell’errore nel concepire l’Io come
realtà autoponentesi (chiaro il riferimento a Fichte), ma è già nel cogito cartesiano
che si assiste a un imperdonabile prescindere dal fondamentale elemento del volo;
insomma: la ragione dell’uomo risulta da subito connotata affettivamente, e in tale
carica affettiva si trova quell’amore che fa da pendant soggettivo alla parola che
oggettivamente instaura la relazione dell’Io con l’alterità.
Tale alterità non va però intesa metafisicamente, come sostanza o come nonIo non ulteriormente specificato; al contrario, si tratta di intendere pienamente il
carattere personale del Tu e la dinamica esistenziale che presiede alla posizione di
esso: se l’Io Divino pone infatti il Tu umano nella creazione, spetta a questi porre
«maieuticamente», in quanto a sua volta Io, un nuovo Tu.
3. Dalla dialettica alla dialogicità: Ebner e Hegel
Qui siamo assai distanti dalla dialettica servo-padrone della Fenomenologia
dello spirito, e possiamo rilevare il vero scarto tra questa e la posizione ebneriana
proprio in una diversa concezione dell’alienazione: da un lato, il servo hegeliano
aveva una propria essenza grazie al padrone (che a differenza di lui non ebbe
paura della morte) e si era dunque ritagliato un’esistenza alienata che poteva
riconquistare solo con il lavoro, come oggettivazione dello spirito (e poi la riconquista procedeva sempre più su nella dinamica dell’Aufhebung, fino a giungere
al sapere assoluto); dall’altro, l’uomo di Ebner conosce, o meglio è chiamato a
conoscere un’alienazione positiva: Dio chiama l’uomo e, nella sua Parola, lo crea
(il Logos del Prologo di Giovanni) e l’uomo risponde, divenendo, da uditore della
parola, facitore della parola. Al lavoro come strumento di riappropriazione della
propria essenza si è sostituita la parola come affermazione dell’impossibilità di
tale riappropriazione, la quale viene anzi a connotarsi negativamente come chiusura dell’Io e negazione del Tu.
Il punto nodale del distacco della pneumatologia dalla speculazione precedente
è senz’altro in questa eteronomia positiva che costituisce la natura vera dello spirituale nell’uomo, che – finché mira all’autonomia e non all’incontro personale con
6 Id., La parola e le realtà spirituali, p. 7.
88
LORENZO FOSSATI
Philosophical News
Dio – resta relegato nell’inautenticità dell’idea irreale e fredda, nelle proprie vuote
proiezioni. Il monologo della coscienza hegeliana deve diventare il dialogo dell’esistenza personale, la dialettica deve ridefinirsi dialogicamente, vale a dire rinunciare
alla conclusività, alla totalizzante ricomprensione del reale in sé: «Trarre la legge
dell’essere dal pensare è idealismo. Ma non rendere l’esistenza conforme alla legge
del proprio pensare è un realismo che solo al vero uomo religioso è concesso»7.
La critica ebneriana può così considerare anche altri aspetti tipicamente idealistici: primo fra tutti la priorità della collettività rispetto al singolo (che viene immediatamente abbandonata sulla scorta di Kierkegaard), nozione che pure aveva un
peso fondamentale nella proposta dialogica di Feuerbach, per il quale il singolo si
definiva in quanto Gattungwesen, per la sua «essenza generica»: «L’uomo è per se
stesso in pari tempo Io e Tu, può porre sé al posto dell’altro appunto perché non
solo la sua individualità, ma anche la sua specie (Gattung), la sua essenza possono
essere l’oggetto del pensiero»8. Ebner afferma invece che la solitudine dello spirito, contrapponentesi alla vita della generazione, è una condizione imprescindibile
per il rapporto con Dio: essa è anzi proprio «la solitudine dell’Io davanti a Dio»9,
in cui all’Io si rivela il vero senso del Tu, del tutto differente dalla solitudine della
morte, come solitudine dell’Io nel mondo.
In seconda battuta occorrerà sbarazzarsi dell’«ottimismo dello sviluppo», con
cui gli uomini si ingannano per poter sopravvivere10, e gli hegeliani spiegano il divenire cosmico-universale, manifestando la propria natura di «outsiders della vita»;
ecco l’abbaglio del filosofo, cioè dell’idealista (e si vede come la critica di Ebner
all’idealismo venga a coincidere con quella alla filosofia tout court): non comprende che «la vita naturale dell’uomo è qualcosa di incompiuto, la cui compiutezza
egli sogna nel suo sogno dello spirito»11.
Se Hegel parla spesso della «fatica del concetto», Ebner esige di sottrarsi alla
necessità della mediazione dialettica: «Ogni realtà veramente spirituale vuol essere
compresa direttamente»12. In questa prospettiva va inteso il suo «realismo spirituale» che propone un radicale rifiuto della metafisica, che, strutturalmente, costringerebbe Dio nell’angustia della ragione umana, con le sue dimostrazioni tanto
inefficaci per colui che non crede, quanto inutilmente fuorvianti per il credente.
Ma dobbiamo dunque concludere per un irrazionalismo di fatto? Davvero Ebner ci chiede di abdicare alla nostra ragione per una razionalità sì superiore, ma
essenzialmente non più umana, giacché proveniente da Dio stesso?
Ancora una volta il pensiero ebneriano scarta all’ultimo momento, e si sottrae
alle conseguenze che la mentalità filosofica tradizionale crede di riuscire a presagire: il nostro, infatti, si «riallea» a Hegel nella sua lotta contro l’intelletto, contro un
7 Ibi, p. 90.
8 L. Feuerbach, L’essenza del Cristianesimo, trad. it. di C. Cometti, Feltrinelli, Milano 19602,
p. 26 (ed. or. Das Wesen des Christentums, Wigand, Leipzig 1841).
9 Ebner, La parola e le realtà spirituali, p. 48.
10 Ibi, p. 59.
11 Ibi, p. 60.
12 Ibi, p. 64.
Philosophical News
LA VERITÀ DELLA PAROLA
89
pensare per concetti o per idee (l’imperativo etico, l’umanità, il piacere estetico,
l’autocoscienza…), che prescindono dalla concretezza dello spirituale, dalla sua
personalità dialogica. Così nei Frammenti si accusa l’intelletto di non comprendere
il «mistero della vita (che si rivela nella parola, nella quale è la vita)», di lasciare
«che l’uomo affidatosi alla sua guida, viva dimentico di tale mistero»13, e ci si
schiera per la ragione, intesa come «orecchio spirituale per la parola»14: il termine
Vernunft viene ricondotto da Ebner a vernehmen, cioè percepire, sentire, udire.
4. La ragione come «orecchio spirituale»: Ebner e Hamann
Ma in tale proposta, piuttosto che al filosofo di Stoccarda, per trovare un vero
alleato è forse meglio ricorrere a Johann Georg Hamann, al «mago del nord», che
fu tra i primi a ricalibrare la nozione di «ragione» in contrapposizione a quella
dell’«intelletto» caro agli illuministi; alla pretesa hegeliana di erigere la ragione a
unico criterio di verità, egli oppose il valore insuperabile e infinito di una Rivelazione che, contenuta principalmente nella Scrittura, non si esaurisce però in essa:
l’intero universo è parola di Dio che l’uomo è chiamato ad ascoltare. Tutto infatti
è parola e linguaggio: accanto al libro della Scrittura, la natura e la storia sono
altrettanti libri che parlano all’uomo, ma questa parola divina incarnata supera i
confini del puro raziocinio umano e – perché se ne intendano i segni, le immagini
e i simboli – esige il ricorso ai sensi, alla fantasia e alle passioni.
Ma Ebner non può seguire Hamann fino a tale rivalutazione del poetico e del
simbolico, e anzi nel Diario la combatte: «L’umanità sopporta lo spirito soltanto
nel simbolo; finora ha ritenuto pazzo chiunque ha preso seriamente la parola spirito e non l’ha voluta intendere soltanto simbolicamente»15; ma è indubbia una
profonda sintonia, che appare manifestamente laddove, ancora nel Diario, leggiamo: «Dio ha creato l’uomo, ciò non significa realmente altro che: gli ha parlato.
L’uomo non era ancora uomo fintanto che Dio non gli ebbe rivolto la parola. Egli
è diventato tale mediante la parola. Prima non aveva nessuna lingua. Ma in questo
senso Dio non cessa di creare l’uomo»16.
Alla Rivelazione di Hamann corrisponde la Parola di Ebner, così come analoga
è l’idea della «creazione continua» che avviene nel linguaggio. Il vero scarto è nella
centralità attribuita alla persona: la nozione di «parola» subisce una torsione proprio
nella sottolineatura della sua intenzionalità nei confronti del Tu interpellato, che diviene, nella sua irriducibile concretezza personale, il centro di ogni realtà spirituale.
Così come non ha alcun significato parlare di Dio «alla terza persona» e affermare
che c’è – e questo sarebbe l’errore del pensiero oggettivante della metafisica e della
teologia17 – allo stesso modo Dio non parla indifferentemente all’umanità, ma al sin13
14
15
16
17
Ibi, p. 19.
Ibi, p. 27.
Ebner, Dal diario 1916/17, p. 59.
Ibi, p. 58.
Cfr. La parola e le realtà spirituali, p. 65.
90
LORENZO FOSSATI
Philosophical News
golo, e in questo lo costituisce: l’uomo non ha a che fare con una natura o un mondo
in generale, ma principalmente con un altra persona, sia essa il Tu di Dio o quello
del prossimo: se così stanno le cose, non stupisce la squalificazione ebneriana di ogni
attività spirituale che non si fondi su Dio, in breve: che non sia quella religiosa.
6. Dalla filosofia alla filologia
È tuttavia interessante constatare come vi sia negli Aforismi del 1931 un’evoluzione su questo punto, che tende a riguadagnare la dimensione artistica ed estetica:
se tale variazione potrebbe essere ricondotta a fattori di carattere personale (l’amicizia con la poetessa Hildegard Jone e lo scultore e pittore Josef Humplik), ciò
non necessariamente la indebolirebbe, almeno in un pensatore come Ebner; essa
potrebbe però anche avere radici più profonde in una sorta di «coerentizzazione»
(seppure sia probabile che un’esigenza di questo tipo fosse piuttosto aliena dalla
forma mentis del Nostro). Nei Frammenti del ’21 si diceva che la parola del poeta
è solo «in grado di risvegliare nell’uomo il Tu ideale», mentre «la parola religiosa
il Tu concreto», e che colui che parla nella parola poetica, per il fatto di rivolgersi
a un Tu ideale, è un Io ideale, mentre «chi parla nella parola religiosa, ad esempio
un apostolo, non è l’Io dell’uomo ma Dio stesso, che si serve dell’uomo per parlare
per suo tramite»18; nel ’31, invece, si rivaluta il poeta come colui che è «custode
e depositario della parola e della lingua. Scopre nuove possibilità di espressione
sopite in esse e le rende vive. Anche il grande pensatore, è poeta in questo senso»19.
Egli cioè contribuisce a non ridurre le parole (Wörte) a vocaboli (Wörter): e
questo sarebbe proprio l’errore della scienza e della filosofia del linguaggio, della
psicolinguistica e della filologia tradizionale (in cui ci si dimentica dell’amore, che
è invece la componente imprescindibile del linguaggio nel suo essere essenzialmente comunicazione, e del «calore» che lo innerva).
Eravamo in attesa che si operasse finalmente il passaggio dalla filosofia a qualcosa di superiore, anche se difficilmente questo poteva essere la poesia: a questo
punto si vede come la pneumatologia esiga che la filo-sofia venga abbandonata
per la filo-logia, intesa nel senso pregnante di amore per la parola, proprio per poter rendere effettivamente e realmente conto dello spirituale che afferma: «In un
pensiero si pensa sempre di più di quanto non sia espresso nel corpo linguistico
della parola. […] Il corpo della lingua è qualcosa di finito; un vero pensiero invece
è qualcosa di infinito, che trascende la finitezza della sua significanza linguistica.
Naturalmente questo vale anche per il pensiero pervaso dalla vita e dal sentimento
del poeta». Per definire meglio la sua proposta, Ebner si richiama al pascaliano
«se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher», giacché l’amore per la
sapienza deve derivare davvero dal rapporto d’amore personale che l’Io instaura
con Dio, suo vero Tu, e si può sorridere della ricerca di «criteri oggettivi» come si è
18 Ibi, p. 16.
19 Id., Aforismi 1931, p. 123.
Philosophical News
LA VERITÀ DELLA PAROLA
91
delineata nella filosofia e nella teologia tradizionali: la pretesa scientificità non può
che mancare il vero criterio oggettivo della spiritualità della vita umana che è «la
lingua che vive in parole (e si dissolve in vocaboli). Ma qual è la natura, il senso della parola, non di questa o quella parola, ma della parola semplicemente? Questo:
essa è data realmente e in maniera efficace solo in quanto uno parla a un altro»20.
Nel Frammento 12 si ribadiva che «il senso della proposizione originaria era Io
sono, e non invece Io sono Io; dell’Io che si pone in relazione al Tu, non invece nell’assolutizzazione della sua chiusura di fronte al tu come avviene nell’autoposizione che
si ha nella proposizione di identità»21. Così negli Aforismi si può concludere con la
ripresa del prologo al Vangelo di Giovanni, ove si parla del Logos, che «va preso alla
lettera, nel senso di parola semplicemente. In principio c’era il rapporto dell’io al tu,
e questo rapporto era presso Dio e Dio era il rapporto dell’io al tu»22.
7. Una risposta personale
È alla fine necessario chiedersi fino a che punto sia percorribile la via proposta
da Ebner. Per rispondere a questa domanda in modo adeguato, credo che lo si
debba fare sul piano personale, esprimendo quindi il mio particolarissimo punto
di vista; questo infatti mi sembra l’esigenza più profonda di un pensiero dialogico
come quello ebneriano: che si reagisca come un Io a un Tu, non parlando astrattamente in terza persona.
E allora: fino a che punto è allora percorribile la via proposta da Ebner? Per
quanto riguarda me, la risposta vorrebbe essere un entusiastico grido di gioia:
«Fino in fondo! Fino all’abbraccio stesso di Dio Padre!». Tuttavia trovo preferibile diffidare dall’entusiasmo, almeno quando si tratta di cose che interpellano e
coinvolgono altre persone oltre a quelle che lo provano: e come si sa che la buona
fede non è sufficiente a giustificare ogni azione (e che la coerenza ai propri principi
non è la somma fra le virtù, giacché questi principi possono pur sempre essere
sbagliati), allo stesso modo non considero sufficiente un inno di lode per affrontare
e risolvere il problema di Dio, proprio perché a noi uomini è dato, spessissimo, di
prendere cantonate e di commettere errori, e l’unica possibilità che abbiamo è cercare di valutare intersoggettivamente, argomentando, la qualità dei nostri principi.
Certo non basta desiderare che Dio esista perché Dio effettivamente esista, anche se indubbiamente il nostro sapere di Lui non si potrà mai dare prescindendo
dal desiderio di Lui che proviamo: ma un conto è dire che quando desideriamo
qualcosa essa deve esistere (e l’esperienza quotidiana dovrebbero lasciarci pochi
dubbi in questo senso), altro conto è dire invece che non abbiamo una conoscenza
disgiunta dal desiderio, cioè che, quando sappiamo qualche cosa, essa, concreta,
sta di fronte a noi, concreti, vale a dire non solo richiedendo un atto cognitivo, ma
20 Ibi, pp. 146-147.
21 Id., La parola e le realtà spirituali, p. 56.
22 Id., Aforismi 1931, p. 147.
92
LORENZO FOSSATI
Philosophical News
anche, magari, risvegliando un desiderio e suscitando un bisogno (sottolineando
la sfumatura tra i due). Qui poi poco importa se questi momenti distinti siano tali
in sé stessi o solo dal nostro parlarne: del resto non siamo Dio, che certamente
avrebbe la risposta per questo problema e per molti altri ancora.
La cosa che conta, invece, è che se anche non esistesse una ragione pura, che
potesse astrarre del tutto dai presupposti e dalla nostra concretezza di carne e
sangue, che potesse tranquillamente «misurare» e abbandonarsi al pensiero oggettivante, certo però la possibilità di comunicare fra noi resterebbe comunque
legata a questo sforzo continuo di imparzialità e astrazione. Il dialogo, cioè, è
praticabile solo se tutti vogliono parlare, se si accetta di mettere in gioco le proprie
convinzioni: esso ha vita dalle proposizioni che i partecipanti mettono sul tappeto, nel rischio che il nostro interlocutore intenda non le vibranti parole (Wörte),
ma solo i banalissimi vocaboli (Wörter). Ma se per caso, all’improvviso, uno di noi
affermerà di non aver bisogno di aggiungere altro, e che Dio gli si è direttamente
manifestato, non potremo che congratularci con lui e continuare a parlare fra
noi, escludendolo… E questa esclusione non sarà motivata dall’invidia, dal risentimento o da chissà quale pregiudizio, bensì dalla semplice applicazione delle
regole del gioco: il dialogo (filosofico? umano?) si muove per argomentazioni e
tutti possono opporre altre argomentazioni in alternativa, ma se non si argomenta
più ci si pone ipso facto al di fuori del gioco, dunque al di fuori della dinamica
discorsiva che caratterizza noi mortali (e qui si vede certamente come la parola sia
essenziale all’uomo, come peraltro anche Ebner affermava, forse intendendo un
senso più pregnante).
«Ogni realtà spirituale vuole essere compresa direttamente», sembra quasi obbiettare Ebner, ma appunto: quando si tratta di una Rivelazione o dell’incontro
personale e diretto con Dio, la proposizione è di origine divina e cessa, per definizione, di essere argomentazione umana, non potendo più entrare nella dinamica
che dà vita al nostro dialogo, non potendosi (dovendosi?) più discutere. Questo è
lo spazio della Rivelazione e della preghiera, non più quello della filosofia (appena
più dignitoso del quotidiano): qui non siamo più uomini o, meglio, non siamo più
solamente uomini, ma «figli». Se però iniziamo a fare confusione, e a confondere
la preghiera (che chiede la salvezza) all’argomentazione (che chiede solo il perché),
allora faremo, se ne siamo all’altezza, splendida poesia o, più verosimilmente, cattiva filosofia, finendo di fatto col dire quello che ci verrà in mente, senza badare al
riscontro con la realtà (e qui con realtà intendiamo anche, e soprattutto, gli altri e
quello che pensano, non solo gli oggetti muti da manovrare).
A me pare meglio un Dio «alla portata di tutti», cioè che, fatta salva la Sua personalissima comunicazione a ciascuno di noi, ci lasci la possibilità di discuterne,
cioè di vivere la proposizione «Io ci sono per te e ti salvo» nella maniera concreta
e umana che su questa terra ci è data: vale a dire argomentandola, mettendola in
discussione continuamente nel dialogo che ogni giorno portiamo avanti non solo
con Dio stesso (e questo momento, pur fondamentale, non può che sottrarsi allo
sguardo altrui), ma anche con gli altri uomini, che possono avere oppure no la
fortuna di contare su un interlocutore di tanto valore come è Dio per il credente.
Tutti siamo come Jof il saltimbanco nella preghiera: non dobbiamo dimostrare
Philosophical News
LA VERITÀ DELLA PAROLA
93
niente, perché ci troviamo nell’amore avvolgente della presenza divina; ma nel
momento in cui abbiamo a che fare con altri esseri umani occorre parlare e, se vogliamo comunicare loro la gioia della fede, ci sarà, ancora una volta, da elaborare
un’argomentazione in grado di rendere conto e di rendere comunicabile la nostra
personale e irriducibile esperienza. Certamente potremo mettere in discussione
l’efficacia delle argomentazioni di coloro che ci hanno preceduto, ma, ancora una
volta, lo faremo argomentando e parlandone insieme – credenti, atei e agnostici.
Chi ritiene di avere motivi tali da giudicare inutile il proseguimento della discussione (e i motivi possono essere i più diversi: Dio gli ha parlato, Kant gli ha
mostrato che la metafisica è definitivamente morta, il pensiero meditante rifugge
dall’oggettivazione verofunzionale delle proposizioni, quello con cui si dovrebbe
discutere è stupido o è brutto), ebbene, costui avrà certamente un contatto diretto con la verità (maiuscola o minuscola che sia l’iniziale), ma questo contatto
non sarà più alla portata degli altri, e lo separerà inesorabilmente da essi. Possiamo allora essere d’accordo con Ebner quando insiste sulla centralità del dialogo,
ma forse occorre intendere tale centralità come l’aspetto strutturale dell’uomo,
senza fare di tale centralità una metafora, quand’anche le metafore siano la nota
dominante del nostro comunicare: la realtà ci si dà sì soggettivamente (e come
potrebbe essere altrimenti?), ma è anche oggettivabile – almeno esigenzialmente,
almeno fino a un certo punto – e in questa possibilità di oggettivazione, in questa
quota seppur minima di condivisibilità, consiste la comunicazione razionale fra
gli uomini, cioè la vita umana nella sua specificità rispetto ad animali e ad angeli (e
troppe volte si sono visti angeli rivelarsi demoni camuffati per poterci permettere
il lusso dell’avventatezza).
È allora vero che Dio lo possiamo vedere solo nei nostri cuori, ma penso sia
ugualmente vero che, se vogliamo che la nostra fede sia «operativa», occorre sforzare anche un po’ il cervello e inventarci qualcosa per poter comunicare questo
messaggio di salvezza (anche se già sappiamo che le cose «interessanti», quelle realmente fondamentali, resteranno tagliate fuori dai nostri tentativi argomentativi).
E se mi si concede un gioco di parole, dopo tanto insistere contro lo stile «oracolare», vorrei concludere dicendo che, quand’anche Dio non fosse dimostrabile (ed
esistono pagine su pagine al riguardo), Egli resterebbe certamente dialogabile (ne
possiamo parlare tutti, e in particolare chi crede ne deve parlare), proprio perché
è discutibile (cioè non tutti sono credenti, non a tutti è data la grazia di essere stati
toccati dalla Grazia, che magari può usare proprio noi per toccare chi vuole).
Lorenzo Fossati
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
94
LORENZO FOSSATI
Philosophical News
Lorenzo Fossati è Ricercatore di Storia della filosofia presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica Sacro Cuore; svolge attività di insegnamento anche presso
l’Istituto di Filosofia applicata della Facoltà di teologia di Lugano e presso l’Università Europea
di Roma. I suoi ambiti di interesse sono il rapporto tra epistemologia e teologia, la filosofia austriaca e tedesca tra Otto e Novecento, la relazione tra logica e ontologia nella fenomenologia e
nella filosofia analitica e il pensiero di Bernard Bolzano. Tra la sue pubblicazioni Ragione e dogma. Hans Albert critico della teologia (Guida, Napoli 2003) e Il concetto della filosofia in Bernard
Bolzano (Isu Università Cattolica, Milano 2006).
Michael P. Lynch
Thoughts, the World and Everything in Between
Two of the biggest problems faced by deflationary theories of truth are these: First,
how can such views, drawing on such limited resources as they do, provide an adequate and meaningful definition of truth? And second, how can such views be reconciled
with our intuition that truth involves a correspondence between thought and world?
Christopher Hill has recently claimed that a broadly deflationary view of truth he
calls substitutionalism can solve both problems. In this discussion, I argue that Hill’s
theory comes up lacking on both counts.
A century ago, debates over truth were mostly debates over whether its nature
consists in correspondence, coherence, or pragmatic utility. Things have changed.
Today, the field is just as much concerned with whether truth even has a nature as
it is with what that nature is. Accordingly, philosophers working on truth fall into
two broadly defined camps: those who defend one version or another of a robust
metaphysical theory of truth, and the deflationists, who think that truth is either
not a property or at least not a substantive property. The latter sort of position is
increasingly popular, and today it might even be said to be the received view.
Two of the biggest problems faced by deflationary theories of truth are these:
First, how can such views, drawing on such limited resources as they do, provide
an adequate and meaningful definition of truth? And second, how can such views
be reconciled with our intuition that truth involves a correspondence between
thought and world? Christopher Hill has recently claimed that a broadly deflationary view of truth he calls substitutionalism can solve both problems1. In this
discussion, I argue that Hill’s theory comes up lacking on both counts.
1. Hill’s version of deflationism is called substitutionalism. Substitutionalism is
deflationary in that «truth is philosophically and empirically neutral, in the sense
that its use carries no substantive and empirical commitments» (p. 4). The view has
three distinctive features. First, it concerns the truth of thoughts or propositions
and constituents of thoughts. Thus, in a sense, substitutionalism is much more
1 Thought and World: An Austere Portrayal of Truth, Reference, and Semantic Correspondence, Cambridge University Press, Cambridge 2002. All references in the text are to this book.
96
MICHAEL P. LYNCH
Philosophical News
rooted in the philosophy of mind than in the philosophy of language. Second,
Hill argues that propositional truth and other semantic concepts can be ‘reduced’
to substitutional quantification (p. 23). Third, he claims he can pay due homage
to the intuitions behind the correspondence theory of truth without abandoning
deflationism. As such, it can be understood, he argues, as a sort of compromise
between deflationary views and correspondence theories.
Hill’s account of semantic concepts comes in both a simple and extended form.
Simple substitutionalism is the view that the concept of truth can be explicitly defined as follows, (where Σ stands for substitutional quantification)
(S): For any x, x is true if and only if (Σp) (x = the thought that p) and p).
This is all that needs to be said about the concept of truth; in particular, no account of correspondence or the like is the needed to define that concept. Thus we
arrive at the first of three apparent advantages substitutionalism has over its rivals:
it gives a truly deflationary but nonetheless reductive definition of the concept of
truth. And not just truth – it also claims that it can give similar definitions of other
key semantic concepts, like denotation and reference. More traditional accounts,
such as the so-called redundancy theory, have long had trouble offering such a
definition because using ordinary objectual quantification, it is hard to see how
one could convert
(T): The proposition that p is true if and only p,
into a suitable explicit definition. Consider for example, the natural suggestion:
(RT): x is a true proposition if and only if (∃x) (x = the proposition that p & p).
This sort of position was briefly considered by Ramsey. But as he noted himself,
the phrase “‘and p’ sounds like nonsense because it seems to have no verb”. The
problem, in short, is that if we interpret the quantifier in the normal way, “x = the
proposition that p & p” is just not grammatically formed; “p” can’t serve by itself
as a conjunct here2. Hence the virtue of substitutional quantification, which is literally tailor-made to get around this problem. More on this in a moment.
The second advantage of (S) is connected to the first. Unlike Paul Horwich’s minimalist theory, substitutionalism avoids Gupta’s well-known generalization problem. Horwich’s own theory gets around the “no explicit definition” problem we
just discussed by simply abandoning the attempt to give one. Instead, Horwich takes our concept of truth to implicitly defined by all the non-paradoxical instances
of (T); these instances form the axioms of what Horwich calls the minimal theory.
2 F.P. Ramsey, “The Nature of Truth” in M. P. Lynch, ed. The Nature of Truth, MIT Press,
Cambridge 2001, p. 437.
Philosophical News
THOUGHTS, THE WORLD AND EVERYTHING IN BETWEEN
97
Our grasp of the concept consists in our disposition to accept without evidence
every instance of that schema. This all we need to explain all the facts about truth3.
Gupta has famously pointed out that this is not so4. As Gupta notes, many of
the propositions we accept a priori that involve the concept of truth are generalizations, such as:
Only propositions are true
Every instance of if p then p is true.
Presumably, the minimalist should be able to derive these propositions from
the axioms of its theory. But this is not possible. First, the axioms of the minimalist theory contain no universal generalizations about truth. They only explain the
conditions under which particular propositions are true. Second, one can’t validly
infer a generalization from any consistent list of particular propositions. But third,
the examples above are universal generalizations. This is a big problem for minimalism. And thus (S) would seem to have the advantage. For it is a generalization.
And as Hill shows, we not only can derive every instance of (T) from (S), we can
use (S) to help us derive other generalizations involving truth.
Those are the pros of substitutionalism. The con is that definitions like (S) face a
well-known problem. The normal way of explaining the meaning of ‘(Σp)(…p…)’ is
to say any thought of that form is true «if and only if there is a thought T that results
from replacing occurrences of the propositional variable p in the matrix (…p…) by
T is true» (p. 18). But as Hill notes, this statement of the truth conditions for ‘(Σp)
(…p…)’ invokes the concept of truth. Hence if that is what our understanding of
substitutional quantification amounts to, then the right-hand side of (S) presupposes
an understanding of truth, and so can’t be used to explicitly define it.
Hill’s solution to this problem is to explain the substitutional quantifiers by
appeal to certain rules of inference. He notes, «it is common practice in logic to
define logical operators by describing their logical behavior» (p. 18). By doing
similarly with substitutional quantifiers, Hill argues, he can ‘capture all of the inferences involving them that we are prepared to endorse’ (Ibid.). Accordingly, he
gives rules for Universal elimination, Universal Introduction, Existential Introduction and Existential Elimination. In other words, simple substitutionalism gives an
explicit definition of truth in terms of substitutional quantification but an implicit
or ‘use’ definition of substitutional quantification in terms of our commitment to
certain rules of inference.
I wonder how much ground is gained by this move, however. The problem, as I
see it, is that according to Hill, simple substitutionalism ‘maintains that the content
of the concept of truth is fully captured by’ (S). Presumably this means that the
content of the concept is stated on the right-hand side of the biconditional. But
again, what content is that exactly? By saying this, I am not saying I don’t under-
3 These claims are taken from Paul Horwich, Truth, 2nd edition, Oxford University Press,
Oxford 1998, see especially chapter 2 and the Postscript.
4 A. Gupta, “A Critique of Deflationism” in M. P. Lynch, ed. The Nature of Truth, MIT
Press, Cambridge 2001, 538 ff.
98
MICHAEL P. LYNCH
Philosophical News
stand what ‘true’ means. I think I do understand the concept expressed by that
word. I am just not sure it is the concept expressed on the right hand side of (S),
for I am not sure what is expressed there unless I invoke the notion of truth to understand the quantifier. To grasp this concept without doing so, we are told to refer
to the relevant inference rules. Is this good enough? Well, as Peter van Inwagen
has noted, we can do better in the case of objectual quantification5. There, we can
say what an existentially quantified phrase means: it means that there exists an x
such that…. No comparable explanation that does not already invoke the concept
of truth can be given here. And one wonders why not.
Of course, one might point out that on Hill’s view substitutional quantification
is, in a certain sense, primitive. The quantifier ‘(Σp)(…p…)’ , the view suggests, is
like the conjunction sign ‘&’. It cannot be non-circularly defined except in terms
of its inferential role. I worry, however, that applied in the present case, this gets
things the wrong way around. I certainly can see some sense in thinking that the
concept of truth is primitive in the sense that it cannot be non-circularly reductively defined in terms of anything else6. But that is not what is at issue. At issue
is whether it is legitimate to reductively define the concept of truth in terms of
substitutional quantification, and then claim that substitutional quantification is
primitive in that it can only be explicated in terms of various inference rules. Compare this with the following reductive analysis of the concept existence: “x exists iff
∃ y (y = x)”, where I then go on to define “∃” in terms of certain standard rules of
inference7. The obvious problem with such a proposal is that we have no reason to
think that the concept of existence isn’t already embedded in our understanding
of “∃”, and accordingly in our grasp of the corresponding inference rules. If so,
the proposal can’t be said to be a non-circular reductive definition of the concept.
Similarly, explicating substitutional quantifiers in terms of inference rules is fine,
but that explication can be a step in a reductive analysis of truth only if we are
assured that our concept of truth isn’t already embedded within our grasp of the
quantifiers and the inferences that explicate them.
Perhaps not everyone will find this problem so troubling. But those that do will see
it as undermining the advertised advantages of (S). They were two. The first was that
(S), unlike other deflationary theories, gives an explicit reductive definition of truth. But
insofar as we are not clear about the meaning of substitutional quantification independently of our grasp of the concept of truth, we are not clear about the meaning of ‘true’
either. The second advantage is a solution to Gupta’s generalization problem. But here
too, our amorphous hold on substitutional quantification independently of our grasp of
the concept of truth may be problematic. For if we are uncertain about the meaning of
‘true’ we will be uncertain about our use of it in generalizations.
5 See his “Why I don’t Understand Substitutional Quantification” in Philosophical Studies
39 (1981) pp. 281-285.
6 See, e.g. Ernest Sosa’s “Epistemology and Primitive Truth” in The Nature of Truth, pp. 641662 and M. P. Lynch “The Elusive Nature of Truth” in Principia 4 (2000), pp. 229-255.
7 The example originates from one given by Marian David, Correspondence and Disquotation, Oxford University Press, Oxford 1994, p. 93.
Philosophical News
THOUGHTS, THE WORLD AND EVERYTHING IN BETWEEN
99
2. So far I’ve argued that substitutionalism fails to get around the classic definitional problem facing deflationary views of truth. A second classic problem
for deflationary views is that they seem to conflict with what we might call the
correspondence intuitions about truth, such as the thought that true thoughts correspond to the way things are, or actual states of affairs. The problem is that such
intuitions seem part and parcel of our concept of truth, something which it seems
that standard deflationary views cannot accept.
Suprisingly, Hill agrees with this criticism of typical deflationary views. Indeed, Hill
goes so far as to announce that, taken as an account of our semantic notions in total,
substitutionalism is incomplete unless it is expanded in order to explain semantic
correspondence, which is the key idea in what he calls our correspondence platitude:
(CP): For any thought x, if there exists a state of affairs y, such that x semantically
corresponds to y, then x is true if and only if there exists a state of affairs y such that
x semantically corresponds to y and y is actual.
As Hill says, a natural way of explaining semantic correspondence is to say that
it is the relation that links the thought that roses are red with the state of affairs that
roses are red. Hill therefore suggests we define it as follows:
(SC): For any thought x and any state of affairs y, x bears R to y if and only if (Σp)
(x = the thought that p and y = the state of affairs that p).
The rough intuition here, I take it, is that the thought that p semantically corresponds to the state of affairs that p just because they are both…well, related in some
way to p. But related how? Hill’s answer is that a thought semantically corresponds
to a state of affairs when our ways of referring to them (their ‘canonical names’) are
formally related by «having the same thought as a constituent» (p. 49, p. 106).
One worry here is how the canonical name of something like a thought could
have that very something as a constituent of itself. After all, the name of something
is one thing, the something it is a name of something else. But put that aside. For
Hill’s understanding of semantic correspondence fails to accord with the intuitions
he is trying to capture with it. According to Hill, thought x semantically corresponds to state of affairs y when our canonical names for x and y bear a certain
formal relation. Yet this doesn’t seem to describe a link between states of affairs
and thoughts as much as it describes a link between our ways of referring to those
states of affairs and thoughts. And that doesn’t seem to be what many have in mind
when they think of semantic correspondence, which is typically thought of as an
objective relation between the states of affairs and thoughts themselves. Yet a given
thought and states of affairs could semantically correspond in Hill’s sense (their
names could be formally related in the specified way) even if there were no objectively real relationship between states of affairs and thoughts out in the world.
Hill argues convincingly that the concept of semantic correspondence (understood in the above way) is useful for various theoretical purposes. But those with
correspondence intuitions are still apt to feel cheated by Hill’s account. Since again
100
MICHAEL P. LYNCH
Philosophical News
it is hard to see how extended substitutionalism justifies the intuition that there is
a real relation between our thought and world, given that it is consistent with there
being no such relation. Of course, my (and Hill’s) deflationary-minded friends may
think so much the better – correspondence, smorrespondence, they’ll say. But if
so, then why worry about justifying our intuitions in the first place – why not just
declare them false – if perhaps practically useful for certain theoretical purposes?
Those with serious correspondence intuitions might balk at Hill’s justification
of (CP) for another reason. Hill deduces (CP) from (SC) and a substitutionally
quantified version of
(AT): if the state of the affairs that p exists, then the thought that p is true if and
only if the state of affairs that p is actual.
Further, (AT), Hill argues, is not a basic fact about truth. Instead it in turn can
be derived from substitutional versions of
(T) It is true that p if and only if p
and
(A): if the state of affairs that p exists, then the state of affairs that p is actual if and
only if p.
But all by itself, this proof does not show that (AT) is not basic. It would only
show that if we had independent evidence to think that (T) is more basic than
(AT). But presumably, this will be contested by the correspondence theorist, who
sees the link between actuality and truth as deeply ground into our conceptual
scheme as (T) – or substitutional quantification, for that matter, on which Hill
holds our understanding of (T) itself depends.
3. In conclusion, substitutionalism, even in its extended form, is still an exceedingly deflationary theory of truth. And while it offers some advantages over many
of its deflationary rivals, it is not in the end any more successful. It does not tell us
that what “true” means or in what our concept of truth consists; and it is inconsistent with the correspondence intuition about truth8.
Mychael P. Lynch
University of Connecticut
[email protected]
8 Thanks to Christopher Hill and Jc Beall for useful discussion.
Philosophical News
THOUGHTS, THE WORLD AND EVERYTHING IN BETWEEN
101
Mychal P. Lynch insegna filosofia all’Università del Connecticut. È membro del Northern Institute
of Philosophy all’Università di Aberdeen, e di Arché, centro di ricerca per gli studi filosofici all’Università di St. Andrews. Ha anche ottenuto una borsa di ricerca dal National Endowment for the Humanities (2009-2010). Si interessa principalmente di epistemologia, metafisica e di filosofia del linguaggio,
sebbene si sia dedicato anche alla storia della filosofia e alla teoria del valore. È autore di molti testi tra
cui Truth in Context (1998, 2001), True to Life (2004), e Truth as One and Many (2009).
Marco Santambrogio
Verità e liberalismo politico
Many philosophers who thought about democracy in the Twentieth century have
rejected the notion of absolute truth and even that of truth as such. Hans Kelsen
draws a parallel between, on the one hand, philosophical absolutism and autocracy
and, on the other, relativism and democracy. For the very same reasons, Hannah
Arendt directly infers from her democratic conception of politics that truth is to
be rejected. It seems that such views are closely reminiscent of some statements by
John Rawls about the notion of truth. I claim that the similarity is only superficial.
Joshua Cohen’s interpretation of some passages of Political Liberalism concerning
truth will be discussed, in an attempt at showing that Rawls’ view is not the No
Concept View, which Cohen ascribes to him. Rawls endorses no particular conception of truth, but he freely uses the notion with its ordinary meaning. The arguments of public reason should start not just from agreed premises, but from true
ones, if that is possible. This is quite consistent with the view that the conclusions
of those arguments are put forward as being only reasonable – not as being true.
Relativism about truth, on the other hand, is definitely inconsistent with Rawls’
conception of public reason and, in particular, cannot jibe with his notion of overlapping consensus.
1. Il rifiuto della verità assoluta o addirittura della verità tout court è comune a
molti teorici della democrazia del Novecento. Hans Kelsen assimila l’assolutismo
filosofico all’autocrazia e il relativismo alla democrazia1. Il suo argomento è questo:
la democrazia è una pratica di compromessi e mediazioni tra punti di vista contrapposti, nessuno dei quali è privilegiato. Ma «[s]olo se non è possibile decidere
in via assoluta cosa sia giusto o ingiusto, è consigliabile di discutere il problema
e, dopo la discussione, di sottomettersi a un compromesso». Dunque – questa la
conclusione – bisogna respingere l’idea che esistano valori assoluti.
1 «[Q]uesto antagonismo [tra assolutismo filosofico e relativismo] sembra essere, per molti
rispetti, analogo all’opposizione fondamentale tra autocrazia e democrazia come a quella tra
i sostenitori, da un lato, dell’assolutismo politico e, dall’altro, del relativismo» (H. Kelsen, La
democrazia, Il Mulino, Bologna 1981, p. 441).
Philosophical News
VERITÀ E LIBERALISMO POLITICO
103
Questa fede [nei valori assoluti] conduce irresistibilmente – e sempre ha condotto
– a una situazione in cui chi asserisce di possedere il segreto del bene assoluto reclama
il diritto di imporre la sua opinione come la sua volontà agli altri che sono nell’errore.2
Si può essere relativisti in molti modi. Non è difficile ad esempio ammettere che
gli esseri umani hanno credenze e preferenze molto diverse: ciò che uno ritiene
vero un altro può ritenere falso, ciò cui uno attribuisce valore non ne ha per un
altro. Ma per Kelsen il contrasto tra relativismo e assolutismo investe direttamente
il concetto stesso di verità: «la filosofia relativistica […] riconosce […] solo verità
e valori relativi»3.
Hannah Arendt è in sintonia con Kelsen. Ma, invece di concludere che la verità
deve essere relativa, passa direttamente da una concezione della politica democratica al rifiuto della verità tout court:
La verità fattuale, come qualunque altra verità, pretende perentoriamente di essere
riconosciuta e preclude il dibattito, e il dibattito costituisce l’essenza stessa della vita politica. I modi di pensiero e di comunicazione che riguardano la verità, se visti in una prospettiva politica, sono necessariamente imperialistici; non considerano le opinioni degli
altri, mentre considerarle è la caratteristica di qualunque pensiero strettamente politico.4
Sembra che ci sia una forte somiglianza tra questa affermazione della Arendt e
alcune affermazioni di Rawls sul concetto di verità nel liberalismo politico:
Dunque avanzare delle pretese riguardo alla verità fomenta inutilmente il disaccordo: scalza i fondamenti della ragione pubblica ed è in conflitto con l’uguale dignità promessa dalla democrazia nelle argomentazioni pubbliche, politiche.5
Queste parole pongono almeno tre problemi distinti, ma non del tutto indipendenti. Il primo è se Rawls e la Arendt intendano la stessa cosa. Il secondo è se
abbiano ragione e se si debba o no fare a meno della verità. Il terzo è se dobbiamo
fare a meno della verità assoluta e ripiegare su quella relativa.
Il punto su cui certamente Kelsen, Arendt e Rawls concordano è che la politica
democratica richiede che le decisioni collettive siano discusse pubblicamente e che
si forniscano ragioni convincenti. Inoltre, sono le regole della discussione pubblica
che stabiliscono se si debba far uso o no del concetto di verità. Abbiamo visto
che secondo Kelsen è «consigliabile discutere il problema e, dopo la discussione,
sottomettersi a un compromesso». Per la Arendt, ancora più esplicitamente, «il
dibattito costituisce l’essenza stessa della vita politica».
2 Ibid. p. 451.
3 Ibid. p. 442.
4 H. Arendt, “Truth and Politics”, Between Past and Future, Penguin, New York 1977, pp.
227-64.
5 «Advancing claims about truth is, then, needlessly divisive: it undermines public reason
and conflicts with the equal standing in public, political arguments that democracy promises» (J.
Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, New York 1996, p. 129).
104
MARCO SANTAMBROGIO
Philosophical News
Anche secondo Rawls le decisioni politiche riguardo alle linee guida di una concezione politica della giustizia devono essere discusse e giustificate appellandosi ai
valori politici condivisi, al senso comune e ai metodi di indagine condivisi, in modo
che ci si possa aspettare che le conclusioni raggiunte siano sottoscritte ugualmente
da tutti i cittadini, anche se questi hanno concezioni complessive della vita, dei
valori e di altre cose che sono loro proprie e inconciliabili con quelle altrui. Queste
giustificazioni fanno parte della “ragion pubblica”, che fa tutt’uno col liberalismo
politico. Vediamo più precisamente di che cosa si tratta.
Le concezioni complessive sono quei complessi di idee che prendono posizione
riguardo alla religione, alla morale, alla politica, alla vita degli esseri umani e a
qualunque altra cosa, inclusa la verità e altre nozioni filosofiche. Le concezioni
complessive motivano gli esseri umani che le sottoscrivono. Sono molte e sono in
conflitto tra loro. Questo conflitto non è in sé una cosa negativa e Mill ne ha fatto
un appassionato elogio. Naturalmente però in una democrazia, in cui le decisioni
che riguardano la collettività in linea di principio sono prese da tutti, la diversità
delle concezioni complessive rende difficile individuare e motivare decisioni pubbliche convergenti.
Esistono forme di liberalismo che sono concezioni complessive6. Sono elementi
di alcune di queste concezioni l’etica dell’autonomia individuale, la santificazione
della ragione e della scienza moderna e qualche forma di rifiuto della religione,
delle tradizioni, dell’autorità. Questo liberalismo non è accettabile da parte di quei
cattolici, ad esempio, che dopo un lungo periodo di diffidenza, sono venuti a patti
col mondo moderno e aderiscono a qualche forma di democrazia liberale.
Ma il liberalismo politico di Political Liberalism non è di questo tipo, non è una
concezione complessiva. Il suo punto di partenza è il conflitto tra le concezioni
complessive e l’osservazione che esiste comunque un terreno comune per la discussione. Infatti tutte le concezioni complessive ragionevoli riconoscono l’importanza e la centralità dei valori politici che sono quelli fondamentali del liberalismo
politico – i valori dell’egual libertà politica e civile, l’uguaglianza delle opportunità
e così via – in quanto riconoscono il criterio della reciprocità7. Dunque l’intersezione di tutte le concezioni complessive ragionevoli non è vuota e costituisce un
“consenso per sovrapposizione” (overlapping consensus).
Ora, poiché anche i principi dell’argomentazione razionale sono comuni a
tutti, da quei valori comuni si possono trarre conseguenze riguardo alle leggi e
alle politiche che sono accettabili da parte di tutti i cittadini ragionevoli, liberi
e uguali8. Questo basta perché, nelle sedi pubbliche, i legislatori, i funzionari
pubblici e i magistrati possano dare pubblicamente ragione delle leggi e delle
6 Come quella dello stesso Rawls di A Theory of Justice: «Ma in A Theory of Justice la giustizia come equità è anche presentata come una dottrina liberale comprensiva (sebbene il termine
‘dottrina comprensiva’ non vi compaia), come la dottrina che tutti i membri della società ben
ordinata che essa descrive difendono» (J.Rawls, “Un riesame dell’idea di ragione pubblica”, in Il
diritto dei popoli, Edizioni di Comunità, Milano 2001, p. 238).
7 Il riconoscimento di questo criterio è un ingrediente essenziale della ragionevolezza.
8 Political Liberalism, 1996, p. 224.
Philosophical News
VERITÀ E LIBERALISMO POLITICO
105
politiche che votano e che seguono, adempiendo così un “duty of civility” morale. È questo il compito della ragion pubblica – «l’ideale dei cittadini democratici
che cercano di trattare le questioni politiche in modo conforme ai valori pubblici
che ci si può ragionevolmente aspettare che tutti gli altri approvino», un ideale
che «esprime anche la volontà di ascoltare quello che gli altri hanno da dire e
di essere pronti ad accettare aggiustamenti e modifiche ragionevoli del proprio
punto di vista»9.
Proprio perché tutte le persone ragionevoli devono poter trovare ragionevoli
le conclusioni ottenute dalla ragion pubblica, quest’ultima deve osservare limiti
molto stretti. Deve innanzitutto rispettare certi principi generali che riguardano
il giudizio, l’inferenza, l’evidenza, senza i quali non si avrebbe giustificazione, ma
solo retorica e propaganda. Inoltre, ci sono limiti che riguardano le premesse a
cui è lecito fare appello. Ad esempio, non è lecito che nel motivare una propria
decisione sulle questioni fondamentali di giustizia i legislatori facciano appello a
quello che la concezione complessiva loro propria considera una verità, se questa
non è condivisa dal senso comune o non fa parte dei risultati non controversi della
ricerca scientifica. Quelle che una sola concezione complessiva particolare considera verità non sono quindi (normalmente10) disponibili per essere usate come
premesse in una giustificazione condotta secondo i canoni della ragione pubblica.
Rawls sostiene che «in un regime costituzionale con judicial review la ragion
pubblica è la ragione della sua corte suprema»11. Ebbene,
i giudici non possono, ovviamente, invocare la loro morale personale, né gli ideali e
le virtù della morale in generale. Devono considerare irrilevanti queste cose. Non possono, ugualmente, invocare le proprie posizioni religiose o filosofiche, né quelle di altri, e
non possono citare i valori politici senza restrizioni. Devono invece fare appello ai valori
politici che pensano facciano parte dell’interpretazione più ragionevole della concezione
pubblica e dei suoi valori politici di giustizia e di ragione pubblica. Questi sono valori
che essi credono, in buona fede come richiede il dovere di civiltà, che ci si possa ragionevolmente aspettare che tutti i cittadini, in quanto ragionevoli e razionali, sottoscrivano.12
2. Dopo aver così brevemente esposto l’idea di ragion pubblica di Rawls, esaminiamo il ruolo che vi ha il concetto di verità. Alcuni commentatori di Rawls (ad
9 Ibid. p. 253.
10 Ci sono eccezioni, che Rawls discute in “The Idea of Public Reason”, § 8, in Political Liberalism e di nuovo in “The Idea of Public Reason Revisited”, Collected Papers, S.Freeman ed.,
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1999, pp. 573-615.
11 Political Liberalism, 1996 p. 231.
12 «The justices cannot, of course, invoke their own personal morality, nor the ideals and
virtues of morality generally. Those they must view as irrelevant. Equally, they cannot invoke
their or other people’s religious or philosophical views. Nor can they cite political values without
restriction. Rather, they must appeal to the political values they think belong to the most reasonable understanding of the public conception and its political values of justice and public reason.
These are values that they believe in good faith, as the duty of civility require, that all citizens, as
reasonable and rational might reasonably be expected to endorse» (Ibid, p. 236).
106
MARCO SANTAMBROGIO
Philosophical News
esempio Joshua Cohen13) hanno sostenuto che, proprio per i limiti che la ragione
pubblica deve osservare, alcuni concetti non possono trovarvi posto. Ad esempio,
non vi trova posto il concetto di salvezza associato a quello di un Dio trascendente,
che appartiene solo ad alcune concezioni complessive, ma non a tutte14. Questi
stessi commentatori leggono nei seguenti passi di Rawls l’intenzione di escludere
lo stesso concetto di verità dalla ragion pubblica:
[Il liberalismo politico] non usa (né rifiuta) il concetto di verità; non mette neppure
in discussione quel concetto e non dice nemmeno che il concetto di verità e la propria
idea del ragionevole siano la stessa cosa. Invece, nei propri limiti, la concezione politica
fa a meno del concetto di verità.15
Una volta che si accetti il fatto che un ragionevole pluralismo è una condizione permanente della cultura pubblica sotto istituzioni libere, l’idea del ragionevole è più adatta
a costituire una parte della base della giustificazione pubblica di un regime costituzionale dell’idea di verità morale. Sostenere che una concezione politica è vera e per questa
sola ragione l’unica base adeguata per la pubblica ragione è motivo di esclusione ed è
perfino settario e quindi una probabile causa di divisione politica.16
Come ho detto, abbiamo qui due problemi distinti. Il primo è quello esegetico:
è proprio questo – la pura e semplice esclusione del concetto di verità dalla ragion
pubblica – ciò che intende Rawls? Il secondo è se davvero, qualunque cosa abbia
affermato Rawls, si possa fare a meno del concetto di verità. Cominciamo dal secondo problema.
Innanzitutto, evitare completamente di usare il concetto di verità, pur continuando a usare altri concetti come quelli di giustificazione, di credenza, di conoscenza, di affermazione, di ragionevolezza e così via, è impossibile. Affermare
qualcosa è lo stesso che affermare che quella cosa è vera: affermare, ad esempio,
che piove è lo stesso che affermare che è vero che piove. Credere che piova è lo
stesso che credere che sia vero che piove; sapere che piove è lo stesso che sapere
che è vero che piove, e così via. Tutti i verbi di atteggiamento proposizionale (oltre
ad ‘affermare’, ‘sapere’, ‘credere’, ci sono ‘assumere’, ‘dubitare’, ‘temere’ e tutti
quelli che reggono completive oggettive) si comportano in questo stesso modo. In
13 J. Cohen, Truth and Public Reason, in “Philosophy & Public Affairs”, 37 (2009), n.1, pp.
2-42.
14 «For example, concepts of self-realization, associated with the view that there is an essential human nature that consists in the possession of certain self-governing power, and of
salvation, associated with the idea of a transcendent God, are not available to public reason.
Moreover, Rawls thinks that the concept of truth is unavailable», (ibid. p. 8).
15 «Does not use (or deny) the concept of truth; nor does it question that concept, nor could
it say that the concept of truth and its idea of the reasonable are the same. Rather, within itself,
the political conception does without the concept of truth» (Political Liberalism, p. 127).
16 «Once we accept the fact that reasonable pluralism is a permanent condition of public
culture under free institutions, the idea of the reasonable is more suitable as part of the basis of
public justification for a constitutional regime than the idea of moral truth. Holding a political
conception as true, and for that reason alone the one suitable basis for public reason, is exclusive, even sectarian, and so likely to foster political division» (Political Liberalism, p. 129).
Philosophical News
VERITÀ E LIBERALISMO POLITICO
107
qualche modo, il concetto di verità è implicito in tutte questi concetti, di cui tutti
facciamo liberamente uso. Inoltre, per usare correttamente il concetto di conoscenza dobbiamo sapere che sapere che p implica che p sia vero – ciò che distingue
sapere da credere, poiché, anche se è una norma che riguarda la credenza quella
per cui dobbiamo cercare di credere solo ciò che è vero, non sempre ci riusciamo.
I linguisti esprimono tutto ciò dicendo che ‘sapere’, ma non ‘credere’, è un verbo
fattivo.
Anche a parte il fatto che non sembra possibile fare a meno di usare il concetto
di verità pur continuando a usare i concetti di affermazione, conoscenza eccetera, non è chiaro che vantaggio ne avremmo se potessimo farne a meno. Poiché
affermare, ad esempio, che gli individui hanno un diritto alla libertà di coscienza
è proprio la stessa cosa di affermare che è vero che gli individui hanno un diritto
alla libertà di coscienza, anche se ci vietassimo di usare la parola ‘vero’, potremmo
ugualmente dire la maggior parte delle cose che diciamo usandola. La parola ‘vero’
è indispensabile solo quando diciamo cose come ‘Tutto ciò che il teste dice è vero’,
poiché non riusciremmo a dire la stessa cosa senza usare ‘vero’, a meno che non
sapessimo esattamente quali affermazioni ha fatto il teste. Ma non sembra che il
liberalismo politico abbia molte occasioni di fare affermazioni del genere. Privandoci del termine ‘vero’ rinunciamo ad alcune delle nostre capacità espressive, ma
non a quelle politicamente cruciali.
Sembra dunque che né i teorici politici né altri possano fare a meno del concetto di verità e non si capisce che vantaggi ne trarrebbero se potessero farlo17. Si
potrebbe obiettare che una buona ragione per fare a meno della verità in realtà
esiste. Della verità esistono diverse concezioni. Il corrispondentismo è una di queste. Nella filosofia morale è stato fatto proprio ad esempio dall’intuizionismo, il
quale considera veri i giudizi morali quando corrispondano all’ordine indipendente dei valori morali18. Non tutti sono tuttavia disposti ad ammettere che esista un
tale ordine indipendente. Quelli che non lo ammettono potrebbero voler adottare
una diversa concezione della verità – ad esempio una concezione minimalista19. Si
tratta di concezioni metafisiche diverse della verità, che trovano posto in diverse
concezioni complessive. Esistono anche filosofi che pensano che i giudizi morali e
politici non esprimano nulla che si possa dire vero o falso. Per questi non-cognitivisti, un’affermazione come “Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza” non è né
vera né falsa, ma esprime un’approvazione, un consiglio, un impegno o qualcosa
di genere. Poiché non si possono sottoscrivere contemporaneamente due di queste
concezioni, nessuna di esse può entrare nell’overlapping consensus – l’area comune
17 Cohen riconosce tutto ciò e ritiene che sia un’ottima ragione per non fare a meno del
concetto di verità, contrariamente a quanto afferma la No Concept view, che Cohen attribuisce
a Rawls.
18 «Rational intuitionism conceives of truth in a traditional way by viewing moral judgments
as true when they are both about and accurate to the independent order of moral values» (Political Liberalism, p. 92).
19 Il minimalismo è stato difeso con buoni argomenti ad esempio da P. Horwich, Truth, 2nd
edition, Oxford University Press, Oxford 1998.
108
MARCO SANTAMBROGIO
Philosophical News
a tutte le concezioni ragionevoli complessive. Avremmo così trovato una ragione
per cui il liberalismo politico, se vuole raggiungere conclusioni condivisibili da
parte di tutti, deve fare a meno di qualunque concezione della verità.
La risposta a questa obiezione è abbastanza ovvia. Un conto è usare un concetto
come quello di verità, un altro è adottare una teoria o una concezione del concetto. Tutti, anche i bambini, sanno che cosa vuol dire affermare, discutere, sapere,
e usano il concetto di verità, ma solo alcuni filosofi hanno teorie della verità. La
stessa cosa vale delle nozioni di ragionevolezza e di giustificazione, di cui sicuramente esistono concezioni diverse20. Sarebbe assurdo pretendere che il liberalismo
politico ne faccia a meno. Ugualmente, una teoria psicologica può far uso di tutti
questi concetti, pur lasciando alla filosofia il compito di chiarirli e di formularne
teorie o concezioni compiute.
Questa distinzione tra l’uso di un concetto e la sua teoria filosofica mi sembra
sufficiente, tra l’altro, per non cercare di elaborare uno speciale concetto di verità
che sia appropriato alla ragione pubblica, la verità politica. Cohen ha invece sostenuto che è vantaggioso poter disporre di un concetto del genere, e lo ha caratterizzato con alcuni principi apparentemente ovvi che riguardano la verità e che elenca.
Oltre ai bicondizionali tarskiani, il concetto deve includere alcuni luoghi comuni
sulla verità (che Cohen chiama Attitudes, Correspondence, Contrast, Value e che
non espongo)21. Ma non è chiaro se quello da lui definito sia un vero e proprio
concetto di verità. Ad esempio, è essenziale al concetto di verità che tutti usiamo
che esso dia luogo ai ben noti paradossi? E la versione politica di Cohen lo fa? È
necessario rispondere a entrambe queste domande per sapere se il concetto definito da Cohen sia davvero un concetto di verità.
Proprio perché i punti precedenti sono abbastanza ovvi, e certamente Rawls
non li ignorava, mi sembra difficile che con le parole che ho citato volesse sostenere che il liberalismo politico debba evitare di usare del tutto il concetto di verità.
Rawls dice invece che è sufficiente ai suoi scopi che le conclusioni della ragion
pubblica e del liberalismo politico siano ragionevoli, e la ragionevolezza può essere
qualcosa di meno della verità.
Supponiamo che, rispettando questi limiti [della ragione pubblica], riusciamo a conseguire un consenso per sovrapposizione su una concezione della giustizia politica. Essa
sarà, almeno per il momento, ragionevole. Alcuni potrebbero insistere che aver conseguito un tale accordo riflessivo sia di per sé un fondamento sufficiente per considerare
vera quella concezione, o comunque altamente probabile. Ma noi evitiamo questo passo
ulteriore: non è necessario e può interferire con l’obiettivo pratico di trovare una base
pubblica e condivisa di giustificazione. Per molti il vero, o ciò che è ben fondato dal
punto di vista religioso e metafisico, va al di là del ragionevole. L’idea di un consenso per
sovrapposizione lascia che siano individualmente i cittadini, in linea con le loro posizioni
complessive, a fare questo passo.22
20 Vedi A. Ferrara, 2006.
21 J. Cohen, cit., p. 27.
22 «Let us suppose that by respecting these limits [of public reason] we succeed in reaching
an overlapping consensus on a conception of political justice. It will then be, for the moment
Philosophical News
VERITÀ E LIBERALISMO POLITICO
109
Ecco una citazione che mostra che Rawls non si vieta affatto l’uso del termine
‘vero’:
Per quanto è possibile, la conoscenza e i modi di ragionamento che fondano la nostra
affermazione dei principi di giustizia e la loro applicazione ai tratti costituzionali essenziali e ai fondamenti della giustizia devono basarsi sulle verità semplici [sottolineatura
mia, MS] ora ampiamente accettate dai, o disponibili ai, cittadini in generale. Se non
fosse così, la concezione politica non fornirebbe una base pubblica di giustificazione.23
Qui Rawls precisa i limiti della ragion pubblica riguardo alle assunzioni utilizzabili. Non tutto quello che qualcuno crede che sia la verità può intervenire come
premessa nelle giustificazioni della ragion pubblica: la ragion pubblica deve basarsi su verità che sono disponibili a tutti (e non, si osservi, a ciò che tutti credono sia
la verità. Ritorneremo su questo punto)24.
Non è chiaro neppure perché si dovrebbe escludere l’uso di un qualunque
concetto (in quanto distinto da un’assunzione o da un’affermazione) dalla ragione pubblica. Mi sembra che perfino il concetto di salvezza legato a quello di un
Dio trascendente sia ammissibile nella ragione pubblica. Quasi tutti gli adulti,
compresi gli atei, hanno il concetto, anche quando pensino che sia un concetto
vuoto, sotto cui non cade nulla. E se non avessero il concetto, potremmo sempre
spiegarglielo e così lo acquisirebbero. È vero che raramente la ragion pubblica
avrà occasione di usare il concetto di salvezza, perché non ci sono molte proposizioni, che siano verità disponibili a tutti, in cui esso compare. Un’eccezione
tuttavia è questa: «Non tutti i cittadini credono di dover perseguire la propria
salvezza e coloro che non lo credono hanno il diritto di comportarsi di conseguenza», di cui non è difficile immaginare l’uso in una argomentazione della
ragion pubblica. Il concetto di salvezza dunque non è illegittimo. Del resto non
è affatto chiaro come possa un concetto essere illegittimo (anche se può essere
sconsigliabile usarlo)25.
at least, reasonable. Some might insist that reaching this reflective agreement is itself sufficient
grounds for regarding that conception as true, or at any rate highly probable. But we refrain
from this further step: it is unnecessary and may interfere with the practical aim of finding an
agreed public basis of justification. For many the true, or the religiously and the metaphysically
well-grounded, goes beyond the reasonable. The idea of an overlapping consensus leaves this
step to be taken by citizens individually in line with their own comprehensive views» (Political
Liberalism, p. 153).
23 «As far as possible, the knowledge and ways of reasoning that ground our affirming the
principles of justice and their application to constitutional essentials and basic justice are to
rest on the plain truths [sottolineatura mia, M.S.] now widely accepted, or available, to citizens
generally. Otherwise, the political conception would not provide a public basis of justification»
(Political Liberalism, p. 225).
24 Un altro passo significativo è questo: «Si assume, come sempre, che i giudizi si basino su
informazioni vere» (“Political Constructivism”, PL, p. 96).
25 I filosofi del linguaggio hanno discusso a lungo le particolarità del connettivo ‘tonk’ e
dell’aggettivo spregiativo ‘boche’, che sono in qualche modo difettosi. Sicuramente però i concetti di salvezza e di verità non rientrano nella stessa categoria.
110
MARCO SANTAMBROGIO
Philosophical News
3. Resta da spiegare perché attribuire la verità, oltre alla ragionevolezza, a una
determinata concezione politica sia, secondo Rawls, «motivo di esclusione e settario e quindi una probabile causa di divisione politica». È una banale questione di
logica che se due proposizioni sono l’una la negazione dell’altra, o sono comunque
incompatibili, non possono essere entrambe vere. Dunque se colui che ne crede
una ha ragione, necessariamente colui che crede l’altra ha torto. In questo senso
la verità è singolare. La ragionevolezza invece non è singolare, perché di due proposizioni incompatibili può essere ragionevole crederne una e ragionevole anche
credere l’altra – anche se ovviamente non è ragionevole credere contemporaneamente l’una e l’altra. Ad esempio, in circostanze diverse, e anche nelle stesse circostanze se si dispone di evidenze diverse, può essere ragionevole credere che piova
e ragionevole anche credere che non piova. Questa è dunque una ragione – non
per fare del tutto a meno della verità, ma per limitarsi a dire che le conclusioni
dell’overlapping consensus sulla giustizia politica sono solo ragionevoli, senza affermare che siano anche vere. Se due persone sostengono due posizioni incompatibili
e ciascuno pensa che la propria sia vera, entrambi sono tenute a sostenere che
quella dell’altra è falsa, ma non vale la stessa cosa per la ragionevolezza: entrambi
possono ammettere che l’avversario è ragionevole, anche se ciascuno continua a
preferire la propria. In questo senso la verità è divisiva e persino settaria, mentre
non lo è la ragionevolezza.
Joshua Cohen ha obiettato a questo ragionamento che non solo la verità, ma
anche altre nozioni di cui la ragione pubblica non può fare a meno sono singolari.
Due proposizioni incompatibili possono essere entrambe ragionevoli, ma non possono essere entrambe più ragionevoli della rivale, né le più ragionevoli. Inoltre, non
è il concetto di verità che crea i conflitti e le divisioni. Se uno pensa che la privacy
sia tra le libertà fondamentali previste dalla giustizia politica e un altro pensa che
non lo sia, le loro posizioni sono conflittuali, tanto quanto se uno pensa che sia
vero che la privacy è tra le libertà fondamentali ecc. e l’altro che non sia vero. Non
possono aver ragione entrambi. Dire che entrambi potrebbero essere ragionevoli
non fa nulla per togliere né per risolvere il conflitto. Quindi divisione e intolleranza
continuerebbero ad esistere anche se si facesse a meno del concetto di verità (ammesso che sia possibile).
Una risposta possibile è che Rawls non vuole evitare i conflitti in generale e
riconosce che è inevitabile che anche all’interno della ragion pubblica i conflitti si
diano. Accettare l’idea di ragione pubblica e i principi della sua legittimità «decisamente non vuol dire accettare una particolare concezione liberale della giustizia
fino ai minimi dettagli». Anche la «giustizia come fairness» è solo un esempio di
concezione politica liberale: esistono altre versioni del liberalismo che differiscono
da questa, ad esempio, riguardo alla struttura generale del governo e, poiché ne
differiscono, sono in conflitto con questa. Anche i giudici di una corte suprema
e la corte nel suo complesso possono giungere a conclusioni diverse su ciascun
singolo caso. Poiché sono diverse e in conflitto, è escluso che siano tutte vere. È
importante però che i giudici «possano credere in buona fede che ci si possa aspettare che tutti i cittadini, in quanto ragionevoli e razionali, approvino» ciascuna
delle conclusioni possibili. Se l’approvazione richiedesse la verità, questo non si
Philosophical News
VERITÀ E LIBERALISMO POLITICO
111
potrebbe dare. È evidente però che non saranno possibili due conclusioni ciascuna
delle quali sia più ragionevole dell’altra. E può ben darsi che non esista nessuna
conclusione possibile che sia la più ragionevole. Se quella che emerge (forse per
ragioni contingenti e senza essere la più ragionevole) resta all’interno dei margini
di ragionevolezza di tutte le concezioni ragionevoli complessive, tutti potranno
approvarla26 e l’autorevolezza della corte non sarà scalfita.
Si osservi, incidentalmente, che anche i non-cognitivisti, per i quali nessuna concezione politica si può propriamente dire vera o falsa, non hanno difficoltà ad ammettere che può essere ragionevole accettarne una qualunque in una certa classe
(ma, ovviamente, non più d’una).
Resta da chiarire un punto. Le conclusioni della ragion pubblica sono ragionevoli, dice Rawls, ma potrebbero non essere vere, per quanto lo riguarda. Il passaggio dalla ragionevolezza alla verità (e anche il passaggio inverso, aggiungerei io, che
è ugualmente problematico) è lasciato alle concezioni complessive individuali. Ma
se è possibile che le conclusioni della corte suprema, la cui ragione è la ragion pubblica, siano ragionevoli ma non vere, come può la corte affermarle? L’asserzione
come atto linguistico è regolata da norme, la principale delle quali dice che si deve
affermare solo ciò che si crede (in alcune versioni più forti: solo ciò che si sa) essere
vero. Ma se la corte suprema si impegna solo sulla ragionevolezza delle proprie
conclusioni e non sulla loro verità, come può affermarle? Le sue sentenze sono atti
linguistici di quale tipo? Non ho una risposta a queste domande.
Dovrebbe essere chiaro a questo punto che la somiglianza tra la posizione
di Rawls sulla verità e quella della Arendt, espressa dalla citazione qui sopra da
“Truth and Politics”, è solo superficiale. La Arendt sostiene che il concetto di verità come tale è imperialistico (domineering), perché sarebbe inevitabile che coloro
che credono di conoscere qualcosa e sono quindi convinti che quella cosa sia vera
ignorino le opinioni altrui come non meritevoli di considerazione. Abbiamo visto
invece che per Rawls la ragion pubblica fa obbligo ai giudici della corte suprema,
ad esempio, di considerare la totalità delle posizioni ragionevoli complessive e vieta
loro di usare nelle loro argomentazioni le proposizioni che fanno parte di una sola
posizione – fosse pure la loro. E questo nonostante Rawls ammetta senza difficoltà
– a mio parere – che il concetto di verità trova posto nella ragion pubblica (anche
se le sue conclusioni sono presentate solo come ragionevoli e non come vere).
Oltre a ciò, Rawls dice molto chiaramente che la semplice verità di una proposizione – ad esempio di una proposizione scientifica – non è condizione sufficiente
perché la ragion pubblica possa assumere quella proposizione come premessa in
una sua argomentazione. Si richiede non solo che la proposizione sia conosciuta come vera – ciò che comporta che esistano prove o giustificazioni convincenti
della sua verità – ma che non sia controversa e che sia conosciuta, o possa diventare conosciuta in tempi ragionevoli27, alla totalità dei cittadini. Se dunque ciò che
26 Più precisamente, tutti i giudici potranno «credere in buona fede che ci si possa aspettare
che tutti i cittadini, in quanto ragionevoli e razionali, approvino». Non è la stessa cosa.
27 Questa precisazione si trova in “The Idea of Public Reason Revisited”, cit.
112
MARCO SANTAMBROGIO
Philosophical News
una particolare posizione complessiva crede vero – ad esempio una proposizione
in materia religiosa, come l’esistenza di un’anima immortale nell’embrione – non
trova posto tra le assunzioni di cui può far uso un’argomentazione della ragion
pubblica, non è perché la ragion pubblica abbia le proprie verità e ignori quelle
altrui. È invece il vincolo per cui le sue conclusioni devono poter essere giudicate
ragionevoli da tutte le persone ragionevoli, che esclude che tali conclusioni si basino solo su proposizioni che forse sono di fatto vere, ma che attualmente hanno
il consenso solo di alcune, e non di tutte le persone ragionevoli (e non si sa come
convincerle). Si osservi che la maggior parte delle persone religiose e ragionevoli
non avrà difficoltà ad ammettere che le proposizioni delle loro rispettive confessioni possono essere credute vere, ma non sono conosciute come vere. Si osservi
anche che non è sufficiente che una proposizione sia creduta vera da tutte le posizioni complessive perché la ragion pubblica possa assumerla come premessa in una
propria argomentazione. È possibile ad esempio che tutte le posizioni complessive
in una certa epoca credessero all’esistenza delle streghe. Ma una delle citazioni da
Rawls qui sopra dice chiaramente che «la conoscenza e i modi di ragionamento
che fondano la nostra affermazione dei principi di giustizia e la loro applicazione ai tratti costituzionali essenziali e ai fondamenti della giustizia devono basarsi
sulle verità semplici [sottolineatura mia, M.S.] ora ampiamente accettate dai, o
disponibili ai, cittadini in generale». Se di fatto le streghe non esistono (e non sono
mai esistite) qualunque decisione presa sulla base di quella credenza comune è in
qualche modo difettosa.
4. Abbiamo parlato finora della verità come di una proprietà di proposizioni.
Secondo il relativismo della verità – quello che Kelsen sembra raccomandare – la
verità è invece una relazione che intercorre tra alcune proposizioni e qualche altra
cosa – individui, epoche, concezioni complessive o altro. Così, una proposizione
potrebbe in linea di principio essere vera relativamente a una concezione e falsa
relativamente a un’altra, cioè vera per qualcuno o qualcosa e falsa per qualcuno o
qualcosa. La relatività del concetto di verità sembra a Kelsen condizione necessaria perché abbia luogo una discussione: «[s]olo se non è possibile decidere in via
assoluta cosa sia giusto o ingiusto, è consigliabile di discutere il problema e, dopo
la discussione, di sottomettersi a un compromesso».
Rawls non considera il relativismo della verità. Il suo concetto di verità è quello
tradizionale – “assoluto” o, come preferisco dire, non relazionale. Credo che esistano buone ragioni, che si trovano nell’idea di overlapping consensus, per ignorare
la verità relazionale.
Prima di esporle, una breve osservazione sulla citazione da Kelsen. È proprio
vero che ha senso discutere un problema solo se non è possibile deciderlo in via
assoluta? A me sembra vero esattamente il contrario. I biologi, come la maggior
parte degli scienziati, non sono particolarmente inclini al relativismo. Mi risulta
tuttavia che ormai da centocinquant’anni la teoria della selezione naturale continui
a costituire un argomento di accese discussioni tra i biologi. È difficile pensare che
si sarebbero avute le stesse discussioni se non si fosse assunto che sarà possibile,
Philosophical News
VERITÀ E LIBERALISMO POLITICO
113
presto o tardi, decidere la questione in via assoluta – che sarà cioè possibile stabilire se la teoria abbia la proprietà di essere vera o quella di essere falsa (una volta
che si sia accertato, ovviamente, che si tratta di una teoria ben formulata, non vaga,
non circolare eccetera). Infatti, se i biologi fossero convinti che la teoria può essere
vera per qualcuno o qualcosa – individui, scuole di biologia, visioni del mondo,
concezioni religiose o qualunque altra cosa – e falsa per qualcun altro o qualcos’altro, probabilmente avrebbero evitato la discussione e si sarebbero accontentati di
dividersi in partiti, pro e contro la teoria dell’evoluzione, soddisfatti ciascuno della
propria verità al riguardo.
La stessa cosa vale per la discussione politica. Per vedere come il relativismo della verità anche in questo caso renda vana la discussione, consideriamo di nuovo la
nozione di overlapping consensus che è centrale, come abbiamo visto, nel liberalismo politico di Rawls. L’overlapping consensus è, in particolare, un consenso. Parti
diverse, che sottoscrivono concezioni complessive diverse, si trovano a condividere un certo numero di proposizioni, cioè ad ammettere che tutte le proposizioni
sottoscritte dall’overlapping consensus sono vere – assolutamente vere. Potrebbe
ciascuna parte ritenere invece che ciascuna di quelle proposizioni sia vera per sé,
senza essere vera per le altre parti? Forse sì, ma quello che si perderebbe in questo
caso è il consenso. Le nozioni di consenso e di dissenso perderebbero, infatti, il
loro significato abituale.
Consideriamo un relativista che ritenga che la verità sia relativa alle epoche storiche. Secondo lui, cioè, una proposizione è vera o falsa solo per una certa epoca
storica. Se avesse ragione, dovremmo dire cose di questo genere: la proposizione
per cui è giusto che alcuni esseri umani siano schiavi di altri è vera per il Seicento e
falsa per il Novecento. (Niente, si badi, dipende da questo particolare modo di relativizzare la verità. Avremmo potuto prendere la verità come relativa a concezioni
religiose o a qualunque altra cosa. Mutatis mutandis, il ragionamento proseguirebbe nello stesso modo.)
Se io lunedì dicessi che è vero che piove – intendendo dire che è vero relativamente a lunedì che piove, cioè che piove lunedì – e voi martedì diceste che non è
vero che piove – intendendo dire che non è vero relativamente a martedì che piove,
cioè che non piove martedì – è chiaro che non saremmo né d’accordo né in disaccordo. Semplicemente parleremmo di cose diverse28. Lo stesso vale se due persone,
collocate rispettivamente nel Seicento e nel Novecento, sostenessero l’una che la
proposizione per cui è giusto che alcuni esseri umani siano schiavi di altri è vera relativamente al Seicento, e l’altra che non è vera relativamente al Novecento. Quelle
due persone non sarebbero in disaccordo. E non sarebbero nemmeno d’accordo
se entrambe ritenessero vera la stessa proposizione, ma ciascuna la ritenesse vera
relativamente alla propria epoca. Alla stessa conclusione si arriva se la verità, invece
28 Questo non vuol dire che persone collocate in momenti diversi del tempo non possano
parlare delle stesse cose e anche contraddirsi. Ad esempio, se qualcuno lunedì dice che piove e
un altro il martedì successivo dice “Ieri non pioveva”, i due si contraddicono. Nel testo però si
considera solo il caso in cui la proposizione affermata o negata sia la stessa (e sia contingente).
In casi del genere, e salvo eccezioni ricercate, non si ha effettivamente né accordo né disaccordo.
114
MARCO SANTAMBROGIO
Philosophical News
di essere relativa alle epoche storiche, fosse relativa alle concezioni complessive, o
a qualunque altra cosa.
Si ricorre generalmente al relativismo della verità nelle situazioni in cui sembra
che un conflitto sia insolubile. In questi casi le posizioni dei contendenti appaiono
perfettamente simmetriche o perché le loro ragioni sono ugualmente buone o perché sono entrambi insensibili alle ragioni dell’altro o per ragioni analoghe e non si
vede a quali altre considerazioni ricorrere per risolvere il conflitto. Sembra allora
che sia una buona soluzione quella di dire che hanno ragione entrambi, ciascuno
dal proprio punto di vista. In questo modo il conflitto è risolto, in qualche modo.
Ma il costo da pagare è che è venuto meno anche il dialogo: si è stabilito che i contendenti parlano di cose diverse e non c’è più ragione di contendere perché non c’è
né accordo né disaccordo tra loro. A queste condizioni evidentemente non si può
parlare di overlapping consensus.
Marco Santambrogio
Università degli Studi di Parma
[email protected]
Marco Santambrogio è ordinario di Filosofia del Linguaggio alla Facoltà di Lettere dell’Università di Parma. Ha lavorato nell’ambito della filosofia analitica principalmente in filosofia del
linguaggio, sulla semantica delle iscrizioni di credenza, il riferimento e la teoria della verità. Tra
i suoi interessi professionali la filosofia morale occupa una posizione non marginale. Alcuni dei
suoi articoli sono stati pubblicati su The Journal of Philosophy, Nous, Synthese, Dialectica. È
socio fondatore della European Society for Analytic Philosophy (ESAP) e della Italian Society
for Analytic Philosophy (SIFA).
Recensioni
Convegni
Religion in the public sphere
Oxford – 26-29 agosto 2010
Questo il titolo del diciottesimo convegno biennale della European Society of the
Philosophy of Religion che si è svolto dal 26 al 29 agosto 2010 a Oxford. Il tema è
di grande attualità nel contesto europeo e contemporaneamente una vera e propria
sfida a cui il vecchio continente è chiamato a far fronte. La sfera pubblica è stata
declinata in senso sociologico e politologico, così da mettere al centro dell’attenzione sia la tensione tra privatizzazione della sfera religiosa e suo ruolo pubblico,
gli aspetti più pratici riguardanti la legislazione e la giurisprudenza. Il tema inoltre
è stato trattato sia da un punto di vista descrittivo, sia da un punto di vista prescrittivo, cioè sono stati delineati i variegati modi in cui le diverse nazioni europee si
rapportano con la dimensione religiosa e si è tentato di offrire delle soluzioni condivisibili. La religione, inoltre, è stata intesa sia in senso generale, sia considerando
le confessioni religiose tradizionali, sia tenendo conto delle tradizioni religiose che
si presentano in Europa attraverso l’immigrazione; in quest’ultimo caso sono stati
affrontati i temi dell’interculturalità e del multiculturalismo.
L’intero convegno si è articolato in un keynote speech, in quattro sessioni plenarie con due lezioni ciascuna e in quattro sessioni parallele che hanno visto una
quarantina di studiosi più giovani presentare le loro ricerche. In attesa che gli atti
vengano pubblicati in un prossimo numero della rivista on-line Ars Disputandi,
organo ufficiale della ESPR, sintetizzo di seguito i punti salienti delle relazioni, evidenziandone gli aspetti critici e innovativi. La lezione magistrale, tenuta da Nicholas Wolterstorff, ha per titolo Does Forgiveness Violate Justice? Questa domanda
nasce dal noto brano del Proslogion di Anselmo, dove il dottore medievale sembra
suggerire che la punizione sia una delle condizioni della giustizia, dal che seguirebbe che il perdono sia inaccettabile in un ordine sociale giusto. Wolterstorff ha
fornito un’analisi concettuale della nozione di perdono, distinguendo il perdono di
chi ha commesso un atto malvagio dal perdono dell’atto in sé attraverso la categoria storia morale e storia personale. Con la stessa acribia ha esaminato la categoria
di punizione, distinguendola dalla pena. Mutuando dalla filosofia del linguaggio
la teoria degli atti linguistici, egli ha concluso, contra Kant, che il perdono viola la
giustizia solo se il primo è assoluto e la seconda è intesa in senso legalistico, mentre
il perdono è compatibile con la giustizia se si tiene conto di aspetti quali la riabilitazione, la protezione sociale e la deterrenza. L’impostazione proposta riguarda non
solo la giustizia umana, ma anche la giustizia divina, tant’è che, come Woltertorff
Philosophical News
CONVEGNI
117
stesso ha sottolineato, alcuni spunti gli sono stati suggeriti dalla teologia ebraicocristiana.
La prima sessione plenaria aveva per titolo Religion and Law ed è stata introdotta da Moxter e Clark. Il primo ha presentato i principali paradigmi storici del rapporto tra legge e religione, quali il progetto illuminista, l’età della secolarizzazione
e il post-secolarismo. Soffermandosi sul caso della Germania, dove le confessioni
religiose mantengono un ruolo garantito dalle leggi costituzionali, egli ha messo in
luce i limiti del tentativo di far leva sui diritti naturali per fondare una relazione
interna tra religione e sfera pubblica, suggerendo che nelle attuali società liberali
è meglio rifarsi ad alcune intuizioni della teologia culturale perché capaci di considerare il valore simbolico e la fluidità del significato degli elementi di una religione.
Clark condivide l’importanza della religione sia quale generatrice di senso e di
scopo per la vita dei singoli individui, sia per l’importanza che riveste negli aspetti
più quotidiani e persino banali della nostra esistenza. Tale consapevolezza implica
secondo lui un approccio più pragmatico, quello cioè tipico delle società liberali.
Vroom e Leirvik hanno presentato il tema della seconda sessione plenaria: Blasphemy and Offence. La domanda sottesa a entrambi gli interventi è radicale: come
è possibile, ammesso che lo sia, giustificare la proibizione della blasfemia da parte
dell’autorità statale? I modelli presi in considerazione sono diversi e dipendono
dalle diverse concezioni della religione, dello stato e della loro relazione. Il divieto
di blasfemia può dipendere da un comando religioso (come nel caso degli stati
teocratici), da una generica applicazione della regola d’oro (negli stati moderni),
dal fatto che venga offesa una comunità o dal fatto che vengano offesi gli ideali
di un individuo. In questi ultimi casi il riferimento alla trascendenza viene meno,
così come quello all’aspetto religioso: ciascuno ha diritto alla propria cultura e
alle proprie opinioni, indipendentemente dalla loro connotazione religiosa, estendendosi piuttosto anche alla sfera etnica o sessuale e all’integrità fisica. Il divieto
di offesa deve però essere controbilanciato dal diritto alla critica. In quest’ottica
può essere utile distinguere l’I dal self, cioè quello che inerisce a una persona in
quanto tale, da quello che ella vorrebbe essere attraverso valori acquisiti e scelti.
Il totale disaccordo, addirittura l’odio, verso determinati modi di vivere non è del
tutto intollerabile, quanto il nullificare il modello di vita altrui senza proporre nulla
di costruttivo. Lo stato ha in questo caso la responsabilità di favorire l’interazione
tra persone di opinioni diverse per il loro e per il suo stesso bene. Sempre lo stato
però dovrebbe rimanere il più neutrale possibile, tanto da proibire la blasfemia,
senza però punirla; questo suggerimento, apparentemente paradossale, richiama
le distinzioni tra restrizioni legali e responsabilità morale e tra diritto legale e obbligazione morale.
Religious Freedom era l’argomento della terza sessione plenaria. Trigg ha individuato la nascita della tensione tra libertà e religione nell’Illuminismo. Tale corrente
sottolineava l’importanza della libertà, dell’autonomia e della ragione, ma mentre i
platonici di Cambridge mostrarono come tali aspetti hanno una connotazione religiosa e, in ultima analisi, teologica, gli altri illuministi si limitarono a contrapporre la
libertà all’autorità di qualsiasi tipo e a rifiutare la religione, associandola alla superstizione. La rilevanza della religione per la moralità e per il bene di un’intera società
118
CONVEGNI
Philosophical News
nel contesto pluralista contemporaneo è un qualcosa di discusso e discutibile. Il
dato da cui partire è però l’illusorietà della perfetta neutralità. Ogni discussione
inevitabilmente coinvolge degli esseri umani che hanno un orientamento religioso
per natura, come hanno mostrato le ultime ricerche di scienze cognitive. L’ateismo
non è una posizione di partenza, perciò non deve esserlo nelle discussioni pubbliche. Se nessun uomo è ateo per natura, allora la tolleranza non è sufficiente: è
necessario garantire e promuovere la libertà religiosa, tanto degli individui, quanto,
soprattutto, delle comunità di fede. La pretesa di una singola religione di detenere
verità universali, non implica di per sé l’incapacità di partecipare al dibattito pubblico e di rendere le proprie credenze disponibili al pubblico esame. Limitarsi a
perpetuare la neutralità religiosa in seno alle democrazie liberali, come continuano
a fare la maggior parte delle istituzioni comunitarie europee, rischia di aprire le porte a un pernicioso relativismo dagli esiti incontrollabili e nefasti. Modelli legislativi
più coerenti sarebbero quelli statunitense e canadese. Mostrando apprezzamento
per la relazione di Trigg, Gräb-Schmidt ha mostrato come la libertà religiosa vada
considerata addirittura il fondamento di tutte le altre libertà. In quest’accezione la
libertà religiosa è un diritto umano fondamentale e inalienabile. La riforma luterana
ha contribuito a presentare la libertà come libertà di coscienza, che poi è l’accezione
di libertà oggi comunemente accettata. Questo slittamento implica la rilevanza del
tutto particolare per l’autodeterminazione e dunque, in primis, per la scelta del proprio credo religioso. Se le società pluralistiche non saranno in grado di supportare
il diritto a questa scelta, violeranno pertanto la libertà individuale e sottrarranno
alle persone la loro dignità, svuotando di significato la stessa tolleranza. Tale impostazione presuppone l’esistenza di un concetto pre-legale di dignità umana e di una
nozione metafisica di verità connessa alla libertà attraverso l’ermeneutica.
Infine la quarta sessione plenaria, dedicata a Multiculturalism and Pluralism in
Secular Society. La prima relazione, tenuta da Roald, ha valutato criticamente il
multiculturalismo dalla prospettiva femminista. Per ovviare all’ambiguità del multiculturalismo, la relatrice ha proposto di distinguerne una versione forte da una
debole, caratterizzando il primo in senso liberale e riconoscendo al secondo una
maggiore capacità di tutela delle minoranze. Il multiculturalismo deve tenere conto dei contesti culturali delle società che intende promuovere e delle modalità di
educazione dei diversi gruppi presenti, se vuole essere efficace. Esso inoltre deve
riuscire a gestire non solo la pluralità di comportamenti, ma deve essere capace di
supportare la diversità con cui le religioni e le culture si autocomprendono. De Wit
ha completato il quadro prospettato da Roald, declinando in senso multiculturalista le nozioni di tolleranza e legalità, svelando come alcuni pregiudizi di matrice
ed eurocentrica vizino la teoria multiculturalista in sé. Il problema maggiore è la
tendenza a pensare agli europei come a coloro che “hanno” una cultura e che devono pertanto aiutare in qualche modo gli altri, che “sono” culture “diverse”. In
questo modo si dà un modo asimmetrico di concepire le diverse culture che travia
ogni teoria, pur con tutte le buone intenzioni. La moderne democrazie pluraliste
hanno il compito di garantire la coesistenza di persone differenti e, per perseguire
questo scopo, non possono né santificare, né sacrificare le rispettive singolarità, ma
semplicemente renderle “visibili”.
Philosophical News
CONVEGNI
119
Le relazioni delle sessioni parallele hanno puntualizzato alcuni aspetti e trattato temi complementari a quelli appena presentati. Identificando in sintesi nuclei
tematici ricorrenti, esse hanno contribuito: a far conoscere la condizione del rapporto tra istituzioni religiose e stati europei (Russia e paesi da poco emancipatisi
dall’ateismo di Stato), tra stati e particolari gruppi religiosi (Ebrei); a riflettere
sui limiti del relativismo di Rorty e Vattimo; a presentare il dibattito interno al
liberalismo e quello interno al collettivismo; a ricordare l’opportunità di riflettere
sul pensiero di autori ormai classici sull’argomento (Rawls, Habermas, Levinas); a
valutare il contributo di singole confessioni religiose (prospettiva “dogmatica”) o
di determinate impostazioni filosofiche (inclusivismo ed esclusivismo in Plantinga
e Hick); a offrire la testimonianza di esperienze particolari (legislazioni, creazioni
artistiche, ecc.).
Nonostante la varietà delle tematiche considerate, sono emersi alcuni punti condivisi che mi limito a elencare schematicamente: è necessario tenere presente che
l’agire pubblico non è mai perfettamente razionale, ma ha sempre una componente
emotiva; la neutralità della sfera pubblica nei confronti della religione è una mera
astrazione; la secolarizzazione è l’esito di un processo, non una posizione di partenza; è urgente attrezzarsi contro il rischio di una “dittatura razionalistica” e di un
“assolutismo illuminista”; la ration alone deve essere abbandonata a favore di una
più concreta e plausibile ration informed from. Molte sono le domande sollevate,
che impegneranno gli studiosi nel proseguo delle loro ricerche. In particolare si
tratterà di approfondire l’origine dei diritti umani: un generico spirito cristiano?
La forma mentis del protestantesimo? L’esigenza delle minoranze in risposta alla
modernità omologante? La fondazione dei diritti umani è stata comunque presentata quale cartina di tornasole per valutare il rapporto tra religione e sfera pubblica, in quanto la fondazione dei diritti umani stessi è o direttamente teologica o
informata religiosamente attraverso l’antropologia, come suggerisce Finnis riprendendo Tommaso.
Degna di nota la metodologia prescelta: il punto di partenza è quasi sempre stata l’esperienza concreta, su cui poi si è riflettuto in vista di una proposta teoretica.
I riferimenti ai testi legislativi in vigore o in discussione, i casi di cronaca quali la
pubblicazione delle vignette anti-islamiche in Danimarca, i saggi di Rushdie e così
via non sono stati utilizzati solo come esempi emblematici, ma come paradigmi e
sfide concrete da affrontare e da cui iniziare a discutere.
In generale si è assistito allo slittamento dallo studio delle dinamiche della secolarizzazione alla tematizzazione del rapporto tra istituzioni religiose e stati. La
controversia tra chi promuove il rapporto tra religioni e dibattito pubblico e chi
vorrebbe limitarlo, passa attraverso nozioni chiave della filosofia politica, quali democrazia, buon governo, liberalismo. Quest’ultimo, nello specifico, è dibattuto tra
il proporre valori autonomi (il caso francese è il più rilevante) e la protezione dei
valori già esistenti. Anche la prospettiva antropologica deve essere affrontata con
decisione: quale il rapporto tra cultura e natura? Chi è l’uomo? Che cosa desideriamo per lui? Che cosa distingue la persona dal mero cittadino? Le urgenze della
globalizzazione e l’incalzare dei flussi migratori costringono talvolta a mettere da
parte le grandi costruzioni teoretiche per concentrarsi su questioni pragmatiche:
120
CONVEGNI
Philosophical News
esistono almeno a questo livello punti comuni di collaborazione? Se sì, qual è il
loro rapporto con teorie più comprensive, ammesso che tale rapporto sia auspicabile?
Il monito più ricorrente è stato l’invito, da una parte, a non dimenticare la lezione di Socrate, suicida per blasfemia, e, dall’altra, a non dimenticare il ruolo
implicito che il cristianesimo ha ricoperto – e ricopre – nella cultura occidentale
e nell’esperienza americana. Questi due moniti tradiscono i due limiti maggiori
dell’intero convegno: la non sempre adeguata attenzione alla dimensione storica
e la talvolta scarsa applicazione di categorie prettamente filosofiche. Una chiara
prospettiva diacronica e il saggio uso della tradizione filosofica favorirebbero il superamento di distinzioni sottili e talvolta sofistiche, proprio come hanno mostrato
alcune relazioni che hanno fatto un appropriato uso della storia e della filosofia.
Ciò non deve stupire se si considera la composizione della ESPR. Le nazioni maggiormente rappresentate sono la Gran Bretagna, la Germania e il Benelux. Assenti
i paesi di lingua latina, eccenzion fatta per una dignitosa presenza italiana. Tale
distribuzione geografica spiega perché i fenomeni religiosi vengano approfonditi
dal punto di vista delle altre scienze umane, rischiando di trascurarne l’originalità, la storicità e l’interazione con la filosofia. Nell’Europa continentale, infatti, la
filosofia della religione fa parte dei dipartimenti umanistici, a fianco di sociologia,
psicologia, teologia, discipline politiche e artistiche, per la maggior parte avvezze
al metodo ermeneutico. La consapevolezza esplicita di questo aspetto aiuterebbe
il lavoro del nuovo presidente della ESPR nel biennio 2011-2, Peter Jonkers, già
attivatosi per organizzare il diciannovesimo convegno dell’associazione in Olanda.
Questo prossimo appuntamento ufficiale si preannuncia interessante e fecondo
come quello appena concluso; esso avrà infatti per tema Mind, Brain and Religion:
Interpreting Human Nature.
Marco Damonte
Università degli Studi di Genova
[email protected]
Il dono: valore di legame e valori umani.
Un dialogo interdisciplinare
Università degli Studi di Macerata – 16-17 settembre 2010
Il dono costituisce uno degli argomenti più affascinanti e controversi che ha
ammaliato con le sue contraddizioni e infinite applicazioni e modalità, studiosi di
tante discipline e di tutte le epoche. È per questo che a distanza di due anni dal
convegno tenutosi presso l’Università di Milano Bicocca “Il dono, le sue ambivalenze e i suoi paradossi. Un dialogo interdisciplinare”, che vide la presenza di
decine di economisti, antropologi, sociologi, filosofi, teologi, matematici e giuristi,
ci si è dati appuntamento a Macerata per discutere questa volta di “Il dono: valore
di legame e valori umani. Un dialogo interdisciplinare”.
Nel convegno che si è tenuto il 16 e 17 settembre nella bella città marchigiana,
si è tentato infatti di approfondire, in una prospettiva sempre interdisciplinare, il
tema del valore del dono, legandolo a quello dell’esperienza umana del valore in
economia come in etica, in antropologia come in sociologia.
Il valore di legame diventa quindi il centro di una riflessione ampia sulle sue
possibilità di essere calcolato, misurato, o almeno circoscritto in quanto strumento
per il riconoscimento della struttura donante.
È proprio questa la specificità del dono: avendo nel donatario il suo fine, il
donare istituisce una relazione in vista della realizzazione del bene altrui. Quale
sia questo bene dovrà essere determinato a partire dalla natura delle soggettività
in gioco (Zanardo, 2007). Il dono infatti, come ha affermato il filosofo Carmelo
Vigna, primo keynote speaker del convegno, professore ordinario di Filosofia morale presso l’Università Cà Foscari di Venezia, è tale se esiste sempre un donatore,
almeno nel senso che il dono è, in ultima istanza, lo stesso gesto di un donatore. Il
dono quindi come intenzionalità radicale, come relazione che lavora su un’alterità
per lui, quando si accosta al tu è come se porgesse una domanda: “Puoi venire tu
a me saturando il desiderio dell’altro?”.
La maggior parte delle cose che scambiamo, sulle prime riescono a soddisfare,
eppure il desiderio continua a domandare e sperimenta delle soste. Ecco dove si
trova uno dei momenti topici del valore di legame: proprio nel momento in cui troviamo un desiderio che ci desidera e ci lega. Un movimento continuo che si ferma
e ci avvolge: un movimento e un dolce indugiare di cui non possiamo fare a meno,
di cui abbiamo bisogno. Il legame trova quindi il suo valore nella stabilità, perché
la fruizione di cui si nutre non finisce, non si censura, ma anzi si può alimentare
dall’aspettativa di proseguire di ritrovare e di ricercare ancora il desiderio dell’altro. È la condizione di finitudine dell’uomo che è legata allo scambio; l’infinità
122
CONVEGNI
Philosophical News
intenzionale, cioè la trascendentalità (intesa in senso medievale e non kantiana), è
invece la fonte del dono. Noi esultiamo del dono, ma viviamo di scambi.
Difficile parlare di dono nel tempo del narcisismo e dell’autoaffezione. Pierangelo Sequeri, teologo, vicepreside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
e celebre musicista, ha voluto proseguire la riflessione concentrandosi sul presente
e sul ripiegamento su noi stessi che caratterizza il nostro tempo. Non basta infatti
riscoprire l’altro, ma c’è bisogno di un correttivo perché oggi il tu non è che lo
specchio dell’io. Nel nostro tempo, siamo stati condotti a considerare l’amore, la
relazione, come un sentimento, mentre per i primi cristiani l’amore costituiva un
lavoro che costruisce la comunità. Da qui la lunga e inesorabile scomposizione tra
affetto e lavoro, che produce uno dei più grandi problemi della nostra epoca. Costantemente allo specchio, suddivisi tra un lavoro che spesso viviamo con freddezza e un amore del tutto proiettivo e narcisistico di fatto non facciamo che investire
nell’autoaffezione ancor più che nell’egoismo, relegando il dono ad un momento
del tutto astratto, impossibile, proprio come descriveva Derrida. Eppure, riprendendo il più recente lavoro di Marion, nonostante tutto la forma del dono si manifesta e appare come criterio intrinseco della specifica qualità di molte relazioni ed
esperienze. La coscienza identifica la donazione pura in un ordine di relazioni che
appare irriducibile alle forme economiche dello scambio equivalente, come anche
alla congiuntura sentimentale delle intenzioni affettuose.
La forza del dono appare, con tutta la sua ambivalenza e la sua vitalità, anche
nella nostra contemporaneità, a prima vista fondata e embedded nel solo scambio
di mercato. Su questo punto Mark Anspach, antropologo americano che insegna
presso il Centre de Recherches en Epistémologie Appliquée, Ecole Polytechnique
di Parigi, ha dato un contributo illuminante: l’obbligo della reciprocità è ciò che
distingue il dono dallo scambio mercantile. La reciprocità infatti è sempre radicale o esiste ed è positiva o non esiste ed è negativa, cancella la relazione. Non
può esistere la reciproca indifferenza né la neutralità benevola. L’etica del dono
risiede, infatti, non nel “pagare un prezzo” per ciò che si riceve, ma proprio nel
“non spezzare la catena”: non si tratta di restituire immediatamente l’equivalente
economico della cosa o prestazione ricevuta, quanto piuttosto di trovarsi all’interno di un circolo di reciprocità che ci porterà a donare a nostra volta in un secondo
momento. Infatti, chi dona diventa inconsapevolmente un modello da seguire. Il
dono tuttavia, proprio per le sue caratteristiche che lo vedono fondato sull’obbligo di reciprocità tende a creare una dicotomia che può essere violenta, difficile
se non impossibile da superare, vale a dire quella tra amico e nemico. Da questo
punto di vista lo scambio di mercato, ed in particolare il pagamento attraverso la
mediazione della moneta, in un certo senso ci ha fornito una via d’uscita: grazie
alla razionalità e all’impersonalità dello scambio, il mondo non risulta più diviso
tra amici e nemici, ma viene a essere popolato da soggetti che scambiano senza un
eccessivo carico emotivo, senza obblighi se non quelli freddi del contratto. Eppure
il dono segna anche il momento della fine della violenza, del conflitto. Il passaggio
dalla guerra alla pace implica sempre uno scambio di doni. Il dono, proprio grazie alla sua forza e ambivalenza, diviene quindi il motore che può far tramutare il
nemico in amico.
Philosophical News
CONVEGNI
123
Assumere il dono significa quindi accogliere la relazionalità del bene: il filosofo
Sergio Labate dell’Università di Macerata ha così sintetizzato la prima giornata di
lavori concentrandosi in particolare sulla persistenza del dono. Si potrebbe quindi
affermare, con Labate, che il dono è tale se riesce a resistere alle asimmetrie e continua incessantemente a lavorare per il bene. Ecco che diviene necessario introdurre una nuova fondamentale categoria che è quella della “Giustizia”: quando infatti
il dono viene ricambiato, possiamo assistere alla coincidenza tra amore e giustizia.
Esiste un ‘regime di pace’ nel quale talune persone rinunciano a esercitare quel “do
ut des” che è alla base di un’idea retributiva di giustizia. È la condizione nella quale
nessuno può sostituire un altro e la reciprocità delle azioni si sottrae alla sfera del
misurabile: le persone danno di più di quanto esiga in quel momento la situazione.
È la logica del dono, del gratuito (Boltanski, 2005). L’uomo, nell’agire concreto
della vita, alterna momenti in cui dona per il piacere di dare, chiede giustizia o
oscilla tra pace e disputa. Tuttavia, l’agape conserva la propria forza, e la sua presenza nella società degli uomini, per quanto modesta, è tutt’altro che trascurabile:
rende ‘interessanti’ e vitali le nostre più ordinarie relazioni, le sospinge in avanti,
dando respiro e speranza al vivere quotidiano. Il dono dovrebbe quindi infonderci
la speranza di superare le scissioni, di valicare la scissione e la confusione operata
dal nostro tempo tra amore e giustizia.
Gli interventi proposti nelle sessioni parallele, che si sono svolte durante la giornata del 17 settembre, hanno arricchito e articolato le diverse relazioni iniziali, fornendo contributi quanto mai ampi e che dimostrano non solo l’attualità del tema
del dono, ma soprattutto il suo presentarsi nelle più diverse forme, oggi come ieri.
Diciotto interventi suddivisi in tre diverse sezioni, hanno permesso di approfondire diverse declinazioni del dono considerandone soprattutto gli aspetti teologici,
filosofici, economici. Il dono è così apparso come categoria concettuale feconda e
utile nel comprendere fenomeni legati alla scuola, all’impresa, alle politiche sociali,
alle dinamiche di relazione in Rete. Durante le sessioni, tuttavia, non è stato possibile, per motivi di tempo, lasciare spazio a una discussione e a un confronto: le
domande e il bisogno di condivisione sono sembrati tuttavia assai necessari, tanto
che appare ormai importante rendere più stabili e continuativi questi appuntamenti; il fascino e la generatività del dono non sembrano di certo esaurirsi.
Anna Cossetta
Università degli Studi di Genova
[email protected]
Erik Peterson. La presenza teologica di un outsider.
Simposio internazionale
Roma – 24-26 ottobre 2010
Un atto dovuto di riconoscimento, a cinquant’anni dalla sua morte, è stato il
Simposio internazionale dedicato alla memoria di Erik Peterson (1890-1960), svoltosi lo scorso ottobre a Roma, città in cui il teologo ha vissuto trent’anni dopo la
sua conversione dal protestantesimo al cattolicesimo.
Peterson fu innanzitutto storico della Chiesa ed esegeta neotestamentario, dal
1924 al 1929 professore alla Facoltà di Teologia evangelica a Bonn; nel 1930 la sua
ammissione alla Chiesa cattolica l’ha condotto in Italia, dove ha insegnato Storia
della Chiesa antica, Storia della liturgia e Patrologia al Pontificio Istituto di Archeologia cristiana (Roma). Le sue ricerche hanno spaziato dal giudeocristianesimo,
alla gnosi e all’encratismo; ma le numerose conferenze, i molteplici interventi teologici, i corsi universitari, i saggi sulla storia delle religioni, sulla mistica, sul significato della scolastica per il sapere teologico, sulla legittimità della teologia politica,
insieme alle lettere, ai brevi racconti, ai frammenti e aforismi sulla cultura europea
ampliano enormemente lo spettro della sua produzione. I risultati dell’intenso lavoro teorico degli anni giovanili confluiscono nella sua abilitazione e unica monografia pubblicata Heis Theos (1926), a cui ancora oggi egli deve la fama affermatasi
già allora tra gli studiosi in ambito teologico ed extra-teologico. La sua vastissima
ed eterogenea produzione, tuttavia, fino agli anni ’60, rendeva pressoché impossibile una ricostruzione coerente del suo pensiero. È stato grazie al voluminoso lascito di testi inediti e schedari all’Università di Torino e al lavoro di F. Bolgiani che
è stata decisa la pubblicazione delle Ausgewälte Schriften di Erik Peterson ancora
in corso in Germania (dal 1994 sono stati pubblicati 10 volumi). Come il Simposio
ha confermato, ciò ha reso possibile offrire un’immagine progressivamente più
nitida del “fenomeno Peterson”, nella complessità delle implicazioni teoriche e del
metodo di ricerca adottato dal teologo, che prende avvio dai dettagli minimi e dalla
ricostruzione delle fonti per poi aprirsi alle questioni fondamentali della teologia.
Con la sua presenza teologica da outsider, come l’ha definita Karl Barth, si è
posto decisamente al confine fra tradizioni confessionali e culturali diverse, delle
quali ha cercato gli intrecci, tentando soprattutto di illuminare i nodi fondamentali
della dogmatica, dell’esegesi biblica, della storia della Chiesa e della teologia politica. Lungo queste direttrici, che segnalano gli ambiti in cui la ricerca di Peterson
ha effettivamente lasciato le tracce più significative, si sono mossi i numerosi interventi del Simposio romano, organizzato da Giancarlo Caronello e aperto dalla relazione del card. Karl Lehmann. Questi ne ha sottolineato la formazione culturale
Philosophical News
CONVEGNI
125
e religiosa, specificamente pietista, influenzata fortemente, così come accadde agli
esponenti del primo periodo della teologia dialettica (K. Barth, R. Bultmann, E.
Brunner), dalla lettura di Kierkegaard. È probabilmente nella serietà con cui il filosofo danese ha riscoperto il vissuto cristiano, insieme all’idea di martirio che Peterson vi ha riscontrato, che si possono individuare fattori determinanti per la sua
conversione al cattolicesimo e alla sua svolta teologica, che prende avvio nel deciso
rifiuto sia della teologia liberale sia di un orizzonte teorico rigidamente sistematico.
La teologia accademica, tesa soprattutto alla chiarificazione razionalistica dei nessi
interni al proprio sistema, gli è infatti da subito apparsa insensibile all’autenticità
della fede vissuta e alla concretezza delle sue molteplici figure di esperienza, che
istruiscono le domande teologiche essenziali. Lungo questa via, storica, teorica,
ma anche esistenziale, ha notato il card. Lehmann, Peterson ha maturato la sua
riflessione sulla Chiesa in un lungo e sofferto percorso interiore, mai sfociato in un
atteggiamento apertamente polemico nei confronti della sua originaria appartenenza cristiana: tanto che oggi, in un clima ecumenico radicalmente mutato, è per
Lehmann possibile una nuova lettura della sua conversione, a suo tempo accolta
scetticamente sia dai protestanti sia dai cattolici, in una chiave di vero dialogo
confessionale. In questo senso Peterson può essere interpretato come un “teologo
di ieri per la Chiesa di domani”, al di là delle controversie, degli estremismi e delle
chiusure ecclesiali, verso un orizzonte autenticamente evangelico.
Proprio in questa volontà di purificazione procede l’edizione tedesca degli scritti, diretta dallo stesso cardinale e curata dalla dott.ssa Barbara Nichtweiß, studiosa
di riferimento dell’opera di Peterson, che ha svolto la relazione «Guardare il nuovo
rompendo con il vecchio», offrendo un quadro del pensiero di Peterson alla luce
di quattro “miniature testuali”. La prima, che ha tratto spunto da un brano del
suo diario sul tema escatologico, invita a un theorein che è davvero un “guardare”
attraverso il tempo e la storia decomposta di un’Europa al tramonto (1918-1922),
in una volontà – distruttiva e creativa insieme – di visione più aperta, meno compromessa e, dunque, più pericolosa; la seconda afferma il valore del dogma – tema
decisivo nel pensiero di Peterson –, in rapporto al quale il cristianesimo non deve
cominciare sempre da capo nella comprensione dei contenuti di fede, argomento
di una essenziale gratitudine fra le generazioni; la terza miniatura ha toccato il tema
del rapporto fra vedere mistico e capacità conoscitiva degli angeli, affinità importante per il cristianesimo antico, ricca di significato spirituale e sapienziale, al di
là di ogni pregiudizio moderno. Il tema angelico svela quel “tratto ispirato” dello
stile di Peterson, quel suo nucleo anche “infantile”, come nota la Nichtweiß, che
gli permette di osare una spontaneità inusuale nella trattazione storico-teologica,
in consapevole antifrasi sia di ogni entusiasmo mistico negatore del dogma, sia
delle asettiche dispute razionalistiche che rimuovono ogni espressione di lode e
di ascesi dall’esperienza credente e teologica. L’ultima nota riguarda l’impresa di
rottura cui la teologia è chiamata in ogni epoca, in nome di quello sguardo escatologico che apre a una peculiarissima concezione del tempo: se Dio stesso ha aperto,
incarnandosi, un nuovo eone, allora l’intreccio e la tensione continua fra storicità e astoricità, fra discontinuità e rottura devono diventare i tratti fondamentali
dell’esperienza cristiana.
126
CONVEGNI
Philosophical News
In questo senso il prof. G. Uribarri (Universidad Pontificia Comillas, Madrid)
non solo ha sostenuto che il rapporto fra storia ed escatologia ha costituito un tema
trasversale negli scritti di Peterson, ma ha anche mostrato come la resurrezione
di Gesù sia uno degli elementi costitutivi della sua teologia, capace di ridefinire
la mappa della sua sistematica “incompiuta”. Il tema della seconda venuta, cioè
della definitività del Regno, va oltre, ha sostenuto Uribarri, l’ipotesi del “già e non
ancora” di O. Cullmann, e vincola radicalmente a sé il senso dell’ekklesia, che vive
in una condizione di diastasi e di “riserva escatologica”: ciò significa che la Chiesa
è chiamata a una relazione costante con il mistero della parusia, e dunque a uno
sguardo rivolto alla città celeste, della quale solo in parte partecipa nella sua fede
nella morte e resurrezione di Cristo. L’ascensione e l’intronizzazione di Cristo divengono per Peterson il simbolo del nuovo eone, in cui gli uomini vivono “sotto
la giustizia”, nonostante il compimento di tale condizione sia per ora rimandata al
futuro.
In questa direzione si è mosso Romano Penna (Università Lateranense, Roma),
presentando l’apporto petersoniano all’ermeneutica della Lettera ai Romani. Il biblista, pur mostrando i limiti del lavoro esegetico del teologo, ha individuato il
suo principio interpretativo fondamentale nell’apocalittica: la svolta epocale che la
morte, la resurrezione e l’intronizzazione di Cristo rappresentano, inaugura infatti
il nuovo eone (pneumatischer Äon), che corrisponde al tempo della fine della storia
stessa (Taubes, Agamben), in cui l’“uomo nuovo” è chiamato a sperimentare, nel
presente del suo battesimo, una nuova vita e una nuova giustizia.
La lettura delle lettere paoline ha esercitato in questo senso sul teologo un forte
influsso. L’intervento di T. Söding (Università di Bochum) ha preso avvio dalla
definizione petersoniana di Paolo come “apostolo dell’eccezione”, che sembra rispecchiare il loro comune essere “fuori-luogo”: Peterson, che ha dedicato numerose lezioni sia alla Prima lettera ai Corinzi sia alla Lettera ai Romani, si è ispirato
autenticamente, per molti temi, aspetti e passioni, alla predicazione dell’apostolo
delle genti; soprattutto la drammaticità della sua biografia di credente può essere intesa alla luce dello scenario paolino – la dimensione pubblica della fede, la
passione per la verità del vangelo, la critica al moralismo religioso, la centralità
dell’agape. Söding ha mostrato come Paolo fosse per Peterson un’eccezione anche
per il suo agire dialettico, reattivo, proprio del suo essere testimone tardivo. Nei
confronti di Pietro e della comunità dei Dodici, a cui non apparteneva, e rispetto
alla Chiesa che secondo Peterson non fonda, Paolo sembra infatti muoversi “per
moto sospinto”. In ogni caso, contro il paolinismo iperbolico della tradizione che
da Agostino porta a Lutero, Peterson fa risaltare dell’apostolo non solo la dottrina
della giustificazione, ma il carisma profetico e il mistero della croce.
L’apporto della storia delle religioni, della patristica e della storia della Chiesa all’esegesi si trovano in Peterson ultimamente filtrate attraverso il “canone del
paradigma dogmatico”, in una centralità cristologica che porta a distinguere fra
Parola di Dio e Scrittura. Peterson aveva individuato la crisi dell’esegesi nella perdita del suo significato teologico, che si rispecchiava in una Chiesa priva di slancio
profetico e di energia critica, dunque di peso politico. Paolo ha rappresentato in
questo senso un reattivo essenziale, nella forza del suo annuncio ai gentili, nella
Philosophical News
CONVEGNI
127
sua proclamazione di una salvezza non individuale e nell’apertura di una speranza
radicalmente ecclesiale.
Il rapporto di Peterson con il vasto scenario delle origini cristiane – nei suoi
intrecci con il giudeocristianesimo, l’ebraismo, la gnosi e l’encratismo – è stato
affrontato dalle relazioni di Jörg Frey (Università di Zurigo), di Gerard Rouwhorst
(Università di Utrecht), di Christoph Markschies (rettore dell’Università Humboldt di Berlino) e di Giulia Sfameni-Gasparro (Università di Messina). Pioniere
degli studi sulle esperienze ascetiche del cristianesimo primitivo, nella fitta trama
delle citazioni testuali, nel rigore storico-filologico delle sue ricerche e nell’acribia
delle sue analisi, Peterson ha rimarcato anche in questi ambiti la sua convinzione di
studioso della natura specifica del cristianesimo come messaggio ascetico ed escatologico, sebbene tale conclusione teologica abbia talvolta assimilato orientamenti
morali, atteggiamenti pratici, prospettive ideologiche che avrebbero richiesto distinzioni più accurate.
La complessità della relazione fra cristianesimo primitivo ed ebraismo ha accompagnato la ricerca del teologo anche anticipando l’interesse storico a lui successivo, sebbene in un atteggiamento globalmente contraddittorio, tipico del suo
essere un “errante tra mondi” – Patristica e Nuovo Testamento, Protestantesimo
e Cattolicesimo, mondo tedesco e mondo romano – che sfugge ancora a un facile
inquadramento.
Il culto dei martiri e la liturgia, questioni che occupano un posto eminente nel
pensiero di Peterson così come nel suo itinerario esistenziale, sono stati il tema
delle relazioni di Stefan Heid (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) e di
Michael Kunzler (Facoltà Teologica di Paderborn). Entrambe le questioni sono
maturate nel periodo della sua conversione, in cui la preoccupazione per la crisi
del Protestantesimo si univa alla sua opposizione nei confronti di un’esperienza
religiosa relegata nell’interiorità della sfera privata, nei cui confronti la proclamazione pubblica della fede, fino al martirio – di cui Cristo è l’archetipo assoluto –,
rappresentava l’antitesi più profonda. Nello stesso senso, come ha mostrato M.
Kunzler, la riflessione liturgica di Peterson ha inteso rilanciare l’elementare contenuto simbolico dell’esistenza, smarcandosi dalla deriva mediatica, didascalica e
pedagogica della liturgia. Sulla scia della teologia tardo-giudaico della Shekinah,
della dimora e presenza divina nel culto, Peterson ha infatti interpretato lo spazio
liturgico come relazione tra città celeste e assemblea popolare terrena, in cui si
compie davvero la salvezza del mondo.
L’ultima sessione del convegno, affidata a Paolo Siniscalco (Università La Sapienza, Roma) e a Michele Nicoletti (Università di Trento), ha affrontato il tema
del monoteismo e della teologia politica. Peterson, intraprendendo nei tempi bui
del nazionalsocialismo una lunga diatriba con Carl Schmitt, si è interrogato sulla
possibilità o impossibilità di una teologia politica, giungendo a definirne ereticale
ogni espressione (Il monoteismo come problema politico, 1935). È di nuovo alla
luce della differenza escatologica tra Regno di Dio e storia che si pone quella distanza assoluta che separa il cristianesimo dalle sue possibili traduzioni politiche,
preservandolo da ogni idolatria del potere. È dunque ancora in nome della tensione escatologica che Peterson, come ha notato Nicoletti, si è potuto opporre,
128
CONVEGNI
Philosophical News
proprio di fronte alla potenza del totalitarismo, alla sacralizzazione di ogni ordinamento giuridico-politico, nella difesa di una libertà religiosa fondata sullo “stato di
eccezione” che l’esperienza credente incorpora.
La poliedrica figura di Erik Peterson, nella sua condizione di outsider, è apparsa
un segnale profetico, di provocante “inattualità”. Nella sua affezione al dettaglio,
nella sua opera di “filologo teologico”, mostra i tratti di un’intempestività feconda:
di una relazione col tempo, cioè, che, come afferma Agamben, sembra aderire ad
esso attraverso una sfasatura e un anacronismo. Grazie a questo suo tenere fisso lo
sguardo sul tempo per percepirne lo scarto, per sentirne anche il buio, Peterson è
forse un vero contemporaneo. E un teologo del contrattempo: a tal punto trafitto
dalla riserva escatologica in cui è posta la condizione cristiana, da non poter aderire compiutamente neppure a se stesso.
Isabella Guanzini
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
Libertà e necessità in Al di là di bene e male
Settima edizione del Seminario permanente nietzscheano
Scuola Superiore di Studi Umanistici,
Bologna – 16-18 novembre 2010
Dal 16 al 18 novembre si è tenuta presso la Sala rossa della Scuola Superiore di Studi Umanistici di Bologna la settima edizione del Seminario permanente
nietzscheano. Progetto costituitosi nel 2003 nell’ambito delle attività del Centro
interuniversitario di studi “Colli-Montinari” su Nietzsche e la cultura europea, il
Seminario avvia i propri lavori nel 2005 con lo scopo di incentivare la ricerca collettiva e continuativa da parte di un nutrito gruppo di giovani studiosi sull’opera
nietzscheana. Nel corso degli anni gli incontri hanno progressivamente assunto
l’attuale struttura che prevede una parte seminariale del lavoro, riservata ai membri effettivi del gruppo e agli uditori ammessi previa richiesta, e una parte pubblica
durante la quale è per tutti possibile assistere agli interventi dei relatori di volta in
volta ospitati. La scelta delle tematiche su cui soffermarsi nelle edizioni successive
risponde a esigenze emerse in fase di ricerca e la selezione dei relatori ospiti è volta
a coinvolgere esperti che possano fornire un contributo prezioso alla riflessione
sul tema affrontato, anche partecipando alle sessioni chiuse di discussione seminariale. La settima edizione ha preso in esame il rapporto tra libertà e necessità in
Jenseits von Gut und Böse, avvalendosi della partecipazione di Maurizio Ghelardi
della Scuola Normale superiore di Pisa, Vivetta Vivarelli dell’Università di Firenze
e Aldo Venturelli dell’Università di Urbino.
Nel pomeriggio del 16 novembre la prima sessione pubblica, moderata da
Carlo Gentili, si apre con una relazione dal titolo La visione della storia di Jacob
Burckhardt, tenuta da Maurizio Ghelardi, membro del Comitato scientifico per la
nuova edizione critica delle opere dello storico tedesco. A segno della profonda e
mai sopita stima che Nietzsche nutrì lungo tutto il corso della propria attività di pensiero nei riguardi del maestro basileese, Gentili introduce il relatore facendo riferimento al testo di una lettera nietzscheana a Burckhardt datata 22 settembre 1886:
Stimatissimo signor professore,
mi dispiace essere stato tanto tempo senza vederLa e senza parlarLe! E con chi potrei ancora parlare, se non mi è permesso parlare con Lei? Il silentium intorno a me va
crescendo sempre più.
Spero che nel frattempo C. G. Naumann abbia fatto il proprio dovere, e il mio Al di
là, di recente pubblicato, sia ormai nelle Sue venerate mani. La prego, legga questo mio
libro (sebbene dica le stesse cose del mio Zarathustra, ma diversamente, molto diversamente…). Non conosco nessuno che, come Lei, condivida con me una tale quantità di
130
CONVEGNI
Philosophical News
presupposti: mi sembra che Lei abbia scorto i medesimi problemi; che sia travagliato
dagli stessi problemi in modo simile al mio, forse addirittura ancor più fortemente e
profondamente di me, perché Lei è più silenzioso. In compenso io sono più giovane…
[…] La mia consolazione è che per ora manchino le orecchie per le mie grandi novità: escluse le Sue, mio caro e venerato: e per Lei non saranno “novità”! […].1
Dopo aver ricordato come Burckhardt abbia spesso stemperato gli slanci entusiastici nietzscheani con risposte pacate e non scevre di malcelata ironia, la relazione di Ghelardi prende avvio dalla sottolineatura delle molteplici possibilità di lettura del rapporto burckhardtiano con la storia: teoretico, biografico-accademico,
wirkungsgeschichtlich. Per ciò che concerne il primo punto, il relatore insiste sulla
necessità di non cedere alla tentazione di distinguere tra un Burckhardt storico e
un Burckhardt storico dell’arte. Ancorché infatti sul piano biografico sia possibile
individuare nel 1874, anno di abbandono dell’insegnamento della storia per quello
della storia dell’arte, un momento di netta cesura, una più puntuale analisi del rapporto tra testi resi pubblici e lascito postumo mostra come i due ambiti teoretici
si tengano insieme lungo il filo rosso della meditazione sulla cultura. Il tema che
unifica le riflessioni burckhardtiane è il sorgere e il destino dell’individualismo
moderno, affrontato con una visione prospettica eurocentrica: il problema è quello di definire quale sarà il tipo d’uomo dominante del futuro, laddove la storia si
configura come punto di partenza critico-teoretico.
Nonostante già a questo proposito si avvertano forti consonanze con il pensiero
nietzscheano, Ghelardi ritiene che il maggior credito burckhardtiano nei confronti
di Nietzsche sia piuttosto da ravvisarsi nelle riflessioni che Burckhardt rivolge,
soprattutto a partire dal 1860, all’antica Grecia. Individuando nel dispotismo democratico greco il punto sorgivo di quella cultura moderna individualistica culminante nella formazione degli Stati nazionali alla fine del XIX secolo, la ricerca
burckhardtiana di un ideale di nobiltà e grandezza muove verso la Grecia arcaica,
religiosa ed aristocratica. Si tratta di un’immagine della grecità che contrasta nettamente con quella classicistica, democratica e bayreuthiana promossa da Wagner
e che pure sembra essere più vicina alla concezione nietzscheana dei primi anni
del 1870. Il suggerimento del relatore è quello di recuperare l’autonomia teoretica
dei testi cosiddetti minori di questa prima fase di produzione nietzscheana, contrastando l’egemonia che, sulla scorta dell’autorità della lettura Colli-Montinari, è
stata riservata in via esclusiva alla sola Nascita della tragedia. In tal modo sarebbe
possibile rinvenire quella coerenza di opinioni e quel graduale processo metabolico che caratterizza il pensiero nietzscheano su Burckhardt dall’inizio del 1870 fino
alla pubblicazione di Umano, troppo umano.
Lungi dal permanere sul piano della teoresi, il legame tra le opere dei due pensatori coinvolge la storia degli effetti del pensiero burckhardtiano cui si era fatto cenno all’inizio dell’intervento: è infatti sfruttando l’onda della fortuna nietzscheana
che il nipote di Jacob Burckhardt, suo esecutore testamentario, ricreò sulla scorta
di appunti destinati al macero un’opera inesistente, conferendole quel titolo di
1 Carteggio Nietzsche-Burckhardt, a cura di M. Montinari, Boringhieri, Torino 1961, pp. 33-34.
Philosophical News
CONVEGNI
131
Weltgeschichtliche Betrachtungen che le permise di circolare con Nietzsche lungo
tutto il corso del Novecento.
L’intervento di Ghelardi è seguito dalla relazione di Vivetta Vivarelli dal titolo
Libertà come costrizione: risvolti stilistici di un tema filosofico. La relatrice invita anzitutto a considerare come in Al di là di bene e male Nietzsche si rivolga al tema della libertà secondo diverse sue accezioni: come libertà dello spirito, di cui il filosofo
aveva già avuto modo di parlare in Umano, troppo umano, come libertà del volere,
come libertà dell’interpretare e quindi, entro certi limiti, di cambiare prospettiva –
basti pensare alle numerose occorrenze del prefisso Um- nel testo del 1886. Il tema
della non libertà è per sua parte affrontato soprattutto nel primo libro (Sui pregiudizi dei filosofi), laddove l’attacco nietzscheano non è più rivolto contro le prime
cose ultime come in Umano, troppo umano, testo di cui Al di là di bene e male è
la rielaborazione, ma contro la Fälschmünzerei – potrebbe dirsi l’opposto della
Redlichkeit – dei filosofi che difendono i loro pregiudizi. Il radicalismo di Al di là
di bene e male è tuttavia tale che Nietzsche attacca anche tutte le virtù dell’uomo
della conoscenza, quasi mostrando d’essere infastidito dalle belle parole, tanto da
rifiutare quelli che un tempo aveva proclamato come suoi ideali. Nell’aforisma 20,
sul quale anche la discussione seminariale si è a lungo confrontata, il filosofo mette
in luce criticamente, in maniera non distante da quella herderiana, come i sistemi
linguistici non siano che atavismi, gabbie contro cui devono combattere gli spiriti
liberi, che proprio e solo entro e contro la costrizione (Zwang) possono nascere.
A partire da queste considerazioni, la relatrice si propone di enucleare l’articolazione del rapporto tra libertà e costrizione sul piano linguistico, di approfondire sia la relazione che quest’ultimo intrattiene con la dimensione teoretica sia la
configurazione che in questa prospettiva assume una filosofia sperimentale quale
quella nietzscheana. Ricordando come nel 1991 a Weimar Wolfgang Müller Lauter
sottolineasse l’importanza delle procedure stranianti della scrittura nietzscheana
(corsivo, trattini, virgolette, …) quali artifici che creano un ostacolo e costringono
il lettore alla ruminazione, Vivarelli sottolinea la correlazione che sussiste in Al di
là di bene e male tra la scelta dell’aforisma e il tema della Maske, dell’Hintergrund
sotto il Grund, e che è tale da consentire un’interpretazione della scrittura stilistica
nietzscheana nei termini di una vera e propria trattazione filosofica. La Maske ha
un doppio versante: uno attivo per cui il mascheramento è un elemento di difesa
o di Versuchung (tentativo e tentazione), uno passivo per cui la maschera è ciò che
si forma intorno al filosofo dai fraintendimenti che ne appiattiscono il pensiero
e la persona. L’aforisma dal canto suo può essere compreso come un tentativo
sperimentale (essai, Versuch) di offrire una visione prospettica, la quale deve concedere a coloro che si accingono ad interpretarla un sufficiente spazio o “gioco”
(Spielraum) per l’intuizione e il fraintendimento. Versucher e Rätsel sono altresì gli
attributi che l’aforisma 42 di Al di là di bene e male conferisce agli spiriti liberi.
Per ciò che concerne il rapporto tra scrittura sperimentale e filosofia, la relatrice
pone in evidenza come Nietzsche da un lato sembri accettare un’interpretazione
prospettica anche nell’ambito della riflessione filosofica e dall’altro lato paia avallare un’appropriazione violenta, affine alla goethiana formula “sich das Fremde amalgamieren”. Il criterio alla luce del quale Vivarelli propone di rileggere le antitesi
132
CONVEGNI
Philosophical News
nietzscheane può essere detto del “quanto più, tanto più”. Principio strutturale già
ne La nascita della tragedia e affine ai meccanismi freudiani di spinta (Dioniso) e
controspinta (Apollo), si tratta di una polarità di romantica memoria tra espansione e contenimento, metamorfosi e forma, tale per cui i due impulsi sono costretti
a esercitare le loro forze in reciproca interdipendenza ed equivalenza, creando un
equilibrio dinamico. Questa tensione si mantiene costante nel pensiero nietzscheano illuminando progressivamente coppie diverse di opposti: nella fattispecie del
tema oggetto di indagine, si può parlare di libertà nella costrizione, per cui solo
sotto il giogo della tirannia delle leggi e non nell’anarchia del laisser aller l’azione
umana acquista forza e libertà. Il criterio sopra enunciato trova applicabilità anche
al dominio stilistico: quanto più lo stile è allusivo, enigmatico, complesso, tanto
più è incisivo e tanto maggiore è l’impegno del lettore. Dopo aver rilevato come
le caratteristiche dello stile aforistico siano le stesse che Nietzsche attribuisce alla
verità e alla vita in quanto “femmine”, la relatrice dedica l’ultima parte del proprio
intervento a una lettura analitico-stilistica degli aforismi 105, 101, 164, 295 e 296
di Al di là di bene e male, volta a rinvenire il non-detto che li anima e attenta a considerare insieme il piano filosofico, quello stilistico e quello biografico.
La seconda sessione di studi pubblici nel pomeriggio del 17 novembre ospita
l’intervento di Aldo Venturelli su L’idea di nobiltà in Nietzsche con particolare
riferimento al libro nono di Al di là di bene e male. Sia l’ideale di nobiltà quivi
trattato da intendersi in senso strettamente politico o più decisamente spirituale, la
parte conclusiva del testo del 1886 è riferimento imprescindibile per qualsivoglia
riflessione sulla concezione politica di Nietzsche. Venturelli pone in evidenza come
in effetti anche il tema della libertà, oggetto di studio del Seminario, è assunto in
Al di là di bene e male non semplicemente nella prospettiva pratico-morale propria di testi come Aurora e Genealogia della morale, ma altresì in una dimensione
cosmopolita.
Dopo aver delineato il contesto bibliografico di edizione dell’opera – successiva
a Umano, troppo umano ed alla terza parte di Così parlò Zarathustra, ma antecedente alla seconda edizione della Gaia scienza e alla pubblicazione di Genealogia
della morale – e aver sottolineato come il libro nono sia una delle sue parti meno
variate nelle diverse edizioni, il relatore propone una lettura dell’aforisma 262. Il
tema centrale del brano è l’aristocrazia, cui Nietzsche associa due riferimenti politici, alla polis greca e alla città di Venezia, che forniscono l’occasione di riflettere
sul rapporto nietzscheano con l’hegelismo e con la già citata visione della storia di
Jacob Burckhardt. Se infatti l’ascendenza burckhardtiana permette di comprendere un insolito richiamo alla città wagneriana par excellence, la problematizzazione dell’idealità della polis, così come emerge dalla lettura dell’aforisma, non è
che un’estensione della problematizzazione del pensiero hegeliano promossa da
Nietzsche. D’altro canto, nonostante i puntuali riferimenti, l’ideale di nobiltà cui
il brano si rivolge non è da intendersi come restaurazione di un passato storico prerivoluzionario, quale che sia, bensì come apice del benessere, della pace e della ricchezza raggiunto e raggiungibile dall’umanità. Per conseguire questo stato sono sì
necessarie durezza e forza, ma la nobiltà è propriamente altro, vale a dire la nascita
Philosophical News
CONVEGNI
133
dell’individuo sovrano, quasi il compimento dell’uomo. È infatti anzitutto contro
se stesso che l’uomo deve rivolgere durezza e forza, al fine di conservare la possibilità e la potenzialità di autosuperamento, senza la quale rischia di cader preda della
morale della mediocrità. Precisando come la condanna nietzscheana sia diretta
solo contro quest’ultima, in un velato riferimento a Socrate che chiude l’aforisma,
Venturelli riconferma ancora una volta le riflessioni dell’intero Seminario: Al di là
di bene e male apre a un pensiero che oltrepassi le tradizionali contrapposizioni
dicotomiche della storia della metafisica – quali bene e male, soggetto e oggetto,
libertà e necessità – per comprendere l’intima e necessaria unità che non solo lega
ma altresì rende impossibile la piena esistenza di un termine se non nell’alveo della
tensione contro ciò che comunemente si intende come suo opposto. Per richiamare un’immagine nietzscheana più volte menzionata nel corso dell’incontro bolognese e tratta dalla Prefazione del testo esaminato:
Ma la lotta contro Platone o, per esprimerci in modo più accessibile e adatto al «popolo», la lotta contro la secolare oppressione cristiano-ecclesiastica – giacché il cristianesimo è un platonismo per il «popolo» – ha creato in Europa una splendida tensione
dello spirito come ancora non si era avuta sulla terra: con un arco teso a tal punto si può
ormai prendere a bersaglio le mete più lontane. […] Noi buoni europei e spiriti liberi,
assai liberi – noi la sentiamo ancora, tutta la pena dello spirito e la tensione del suo arco!
E forse anche la freccia, il compito, e chissà? la meta...2
Selena Pastorino
Università degli Studi di Genova
[email protected]
2 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, tr. it. di F. Masini, in Opere di Friedrich Nietzsche,
a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1968, vol. VI, tomo II, pp. 4-5.
Il primato di Dio nella vita e negli scritti del beato John
Henry Newman. Simposio internazionale
Pontificia Università Gregoriana – 22-23 novembre 2010
Nei giorni 22-23 novembre 2010 un centinaio di studiosi e appassionati della
figura di J. H. Newman si sono ritrovati a Roma in occasione del simposio internazionale Il primato di Dio nella vita e negli scritti del beato John Henry Newman,
organizzato dall’International Centre of Newman Friends e dalla Pontificia Università Gregoriana.
Il convegno si è svolto all’indomani della beatificazione che Benedetto XVI ha
voluto celebrare lo scorso 19 settembre durante il suo storico viaggio nel Regno
Unito. Nel suo messaggio inviato al convegno il Papa ha affermato che la percezione della “verità oggettiva di un Dio personale e vivente, che parla alla coscienza e rivela all’uomo la sua condizione di creatura”, è ciò che ha determinato fin
dall’adolescenza la vita del cardinal Newman dopo un iniziale periodo che lo vide
soggetto allo scetticismo maturato in seguito alla lettura di Hume e di Voltaire. Non
ci fosse stata questa percezione che divenne certezza di essere di fronte alla Verità
oggettiva, così intimamente relazionata all’io da essere parimenti Verità soggettiva,
non si potrebbe parlare del primato di Dio nella vita e nelle opere di Newman. Tale
primato è stato poi vissuto da Newman assumendo due fondamentali criteri che
hanno definito l’intera sua attività di teologo, storico, filosofo, poeta, romanziere:
“la santità piuttosto che la pace” e “la crescita come sola espressione di vita”.
Il convegno ha inteso delineare come Newman abbia vissuto e sviluppato questo esperire la Verità che è Dio. Dai lavori svolti sono emerse considerazioni e
indicazioni che aiutano a comprendere l’importanza della riflessione newmaniana
anche per il dibattito filosofico contemporaneo.
Non è facile definire Newman, egli stesso infatti non si riteneva teologo, né
filosofo, ma se una definizione deve essere indicata, la più adeguata sembra essere
quella di un grande ricercatore cristiano che desidera addentrarsi sempre più nel
contenuto della fede in Dio, una fede che è animata da una certezza viva che lo fa
vivere. È questo quello che è emerso con chiarezza dalla prima sessione. Fortunato
Morrone ha messo in luce come il cuore dell’attività del cardinale fu quel quaerere
Deum di cui parla Agostino quando afferma: «Cerchiamolo [Dio] per trovarlo, e
cerchiamolo ancora dopo averlo trovato. Per trovarlo bisogna cercarlo, perché è
nascosto; e dopo averlo trovato, dobbiamo cercarlo ancora, perché è immenso»
(Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, Omelia 63). Questo permanere di
Newman nella tensione alla conoscenza del Mistero di Dio ha plasmato la sua esistenza di uomo moderno. Egli visse una inquietudine per la verità che lo mantenne
Philosophical News
CONVEGNI
135
sempre in cammino, nell’acquisizione di una fede personalissima nella Santissima
Trinità il cui mistero, come ha mostrato Rino La Delfa non cessò mai di contemplare a partire dall’evento dell’Incarnazione, cuore e metodo della Rivelazione.
La ricchezza misteriosamente inesauribile della Rivelazione è ciò che lo condusse ad elaborare la sua dottrina degli sviluppi del dogma cristiano secondo cui il cristianesimo deve svilupparsi nel tempo non per diventare diverso ma per rimanere
sempre se stesso. Perché è nel tempo e in risposta alle circostanze storiche che la
verità della Rivelazione si spiega sempre più profondamente. Fu questo il frutto
dello studio storico e teologico sui concili che Newman intraprese con audacia nei
suoi anni ad Oxford e che un ruolo importante ebbe nella sua decisione di passare
dalla Chiesa d’Inghilterra alla Chiesa di Roma. Rifacendosi a tale dottrina dello sviluppo Ian Ker ha mostrato come Newman seppe guardare al Concilio Vaticano I
anticipando le questioni che il Concilio Vaticano II dovette affrontare e indicando
di fatto alla Chiesa di oggi come guardare e considerare i frutti e gli sviluppi del
Vaticano II, specie per quanto riguarda il fattore carismatico essenziale alla vita
della Chiesa.
Questi primi tre interventi hanno documentato come la riflessione teologica di
Newman si sia declinata partendo da quell’atteggiamento iniziale di decisione per
la verità e di disponibilità continua alla conversione espresso dai due principi sopra
accennati.
La sessione si è conclusa poi con la relazione di Michael Paul Gallagher che ha
indicato i cinque fattori fondamentali della pedagogia di Newman, che sinteticamente riporto qui di seguito:
1. una certa disposizione del cuore, un certo desiderio di significato che è essenziale
per ogni approccio alla religione;
2. la consapevolezza di che cosa sia coscienza (tale fattore è stato indicato come la
cifra della modernità della fede di Newman);
3. un uso della ragione che radicata nell’avventura personale della verità venga
vissuta in piena unità con l’immaginazione e il cuore;
4. il rivelarsi di Dio nel cuore di ogni uomo e in Cristo;
5. la lotta al tentativo di ridurre la religione a mero stupore o moralismo.
Questi aspetti della modernità pedagogica di Newman sono strettamente collegati ai contenuti della seconda sessione che ne hanno rivelato l’attualità.
Wilhelm Tolksdolf si è soffermato sulla importanza della dimensione personale della fede in un contesto culturale secolarizzato considerandola in termini di
Self-Assurance e approfondendo la visione newmaniana della Chiesa come garante
della coscienza personale. In relazione alla concezione newmaniana della religione
Terrence Merrigan ha invece approfondito il ruolo della coscienza in quanto voce
di Dio nell’intimo dell’uomo e dono di grazia in vista della Chiesa.
La relazione di Michele Marchetto è stata dedicata interamente all’attualità filosofica del pensiero di Newman. Come il primato di Dio può essere riproposto
oggi in un contesto culturale postmoderno che affida l’assoluto solo all’uomo? Tale
primato è anche primato della verità, può quindi riproporsi il pensiero di Newman
con la sua radicale certezza circa la verità in alternativa al relativismo attuale? Nel
contesto di queste domande, Marchetto ha richiamato quel senso di invulnerabili-
136
CONVEGNI
Philosophical News
tà di cui parla Charles Taylor, presente nell’io dell’età secolare che ha chiuso i confini porosi del proprio essere e che si ritrova a vivere in un mondo disincantato ove
egli stesso si pone come invulnerabile padrone di sé. Per un tale io, il rapporto con
il passato e la tradizione assume la forma di una disdegnata e presuntuosa presa di
distanza. Già Newman aveva individuato in Gibbon questo abuso della ragione,
destinato a lasciare l’io in balia del dubbio e a relativizzare Dio, confinando la fede
nella sfera del sentimento e allontanandola dalla storia in nome di assoluti terrestri.
Newman colse questo malaise dell’immanenza, che oggi Taylor definisce essere
proprio della modernità. Egli offrì come proposta di riscatto la propria comprensione dell’uomo e del suo rapporto con la verità, maturata – per così dire – dal di
dentro della modernità. È un primato di Dio posto in termini nuovi quello che
Marchetto individua in Newman.
Anzitutto è un motivo di attualità l’accento posto sulla centralità della persona come sistema vivente che ha nella coscienza il proprio centro e che vive di
una ragione intrisa di fattori antecedenti. Marchetto ha quindi messo il principio
dell’egotismo in relazione con alcuni filosofi contemporanei. Dalla sua relazione
si evince come l’approccio di Newman alla coscienza presenti delle affinità con
Meinong e al tempo stesso ne superi il realismo fenomenologico proponendo un
soggetto intenzionale in piena comunione con l’essere. Nella riflessione newmaniana la persona è un tutto concreto e individuo di cui la razionalità è predicato.
In linea con il personalismo cristiano, Newman pone quindi l’accento non tanto
sulla natura razionale, ma sull’individua substantia che informa la natura razionale.
Vengono con ciò richiamati non solo Boezio e Tommaso, ma anche lo stesso Kierkegaard che a sua volta enfatizza proprio il valore del “singolo individuo esistente”
cui solo spetta la decisione per la verità. È una metafisica in prima persona quella
che propone Newman, che anticipa le qualità personali descritte da Guardini e
sintetizzate nel carattere dell’“auto-appartenenza”: vi è un proprio dell’uomo in
cui egli rimane, di cui egli deve appropriarsi e nessun altro al suo posto. In questo senso il cardinale inglese presenta secondo Marchetto una fede moderna che
riconosce la persona come soggetto incomunicabile, irripetibile, singolare, che in
prima persona deve intraprendere l’esperienza della certezza della verità.
Il recupero della persona concreta avvicina Newman anche all’ermeneutica di
Gadamer, specie per quanto riguarda il ruolo positivo dei pregiudizi come fattori antecedenti all’assenso. Il tema delle probabilità antecedenti non ha ricevuto
molta attenzione nel convegno e tuttavia è stato richiamato in questa relazione
considerando le affinità che sembrano esserci tra le probabilità antecedenti, quali
fondamenti dell’inferenza informale, e gli schemi irriflessi, i pregiudizi, di cui parla
Gadamer. Ogni concreto pensiero storico presenta ragioni implicite che appartengono alla sua costituzione più che quelle esplicite. Marchetto ha perciò posto in
evidenza come il recupero della phronesis da parte di Gadamer rispecchi il newmaniano illative sense: un sapere orientato alla situazione concreta, che sussume il
dato particolare sotto l’universale. Per Gadamer la phronesis non è semplicemente
una facoltà, è piuttosto un dato modo d’essere, un assetto morale, un orientamento
della volontà in base a quell’universalità concreta cui fa riferimento Vico definendola sensus communis. Questo paragone mette in luce come Newman si inserisca a
Philosophical News
CONVEGNI
137
pieno titolo nel dibattito sul rapporto tra particolare e universale, che per lui si dà
come dramma tra la persona che è il singolo individuo concreto e la verità oggettiva che parla alla coscienza.
Anche da questo contributo è emerso come l’illative sense costituisca un punto
centrale nella riflessione di Newman e la collochi ad un livello vertiginoso. Con
esso infatti si riconosce la piena dignità alla persona nella sua concreta interezza e
storicità e parimenti il fatto che il darsi della verità, nella sua oggettività, si sottopone al concreto esercizio del conoscere da parte del soggetto libero, per divenire
in tal modo verità per e del soggetto. È una posizione vertiginosa che Marchetto
ha delineato marcandone le differenze sostanziali rispetto al relativismo. A tal fine
ha presentato un confronto tra Newman e L. Pareyson. Nella polarità tra verità
e persona, tra verità e interpretazione personale, il relativismo è risolto perché
l’interpretazione non esaurisce mai la ricchezza della verità, ma si perfeziona col
dialogo nella verità.
In questa prospettiva va visto anche il finale riferimento alla rilevanza politica
della religione, altro aspetto che rende Newman attuale. Opponendosi al liberalismo in religione egli ha rivendicato il posto che spetta alle idee religiose nella
sfera pubblica. Qui Marchetto ha notato che anche la riflessione di J. Habermas
trova una consonanza con quella newmaniana nella misura in cui per Habermas
la ragione è una e al tempo stesso si dà in molti linguaggi. C’è una dimensione
implicita della vita di ogni individuo così come di ogni società (ritorna qui il riferimento al sensus communis di Vico e alla tradizione di Gadamer). Solo se vi è una
condivisione della razionalità implicita del common sense di una società, questa
può trasformarsi in una sfera pubblica polifonica, dove il relativismo cede il passo
al pluralismo.
L’intervento di Marchetto ha con questo messo in luce come il riscatto del primato di Dio, che è primato della Verità, possa avvenire solo se anzitutto si recupera
il primato della persona concreta come luogo in cui si incarni appunto la verità e
si abbracci con ciò una concezione della ragione più ampia di quella meramente
procedurale, sillogistica, formale. Dal recupero della verità dell’uomo si può arrivare alla verità di Dio.
Infine dell’ultima parte del convegno dedicata in particolare alla spiritualità e
all’aspetto missionario della vita di Newman, indico solo alcune riflessioni.
È toccato a Keith Beaumont mostrare come in Newman la morale non è separata dalla preghiera, egli parla della preghiera come parla della morale e viceversa. Al
fine di comparire davanti a Dio, ciò che occorre non è il rispetto di regole, quanto
piuttosto una preparazione della ragione e dell’affezione. Ecco la pratica della fede
nei sacramenti e della preghiera come compimento della morale nella preparazione all’incontro escatologico definitivo con la Sua Presenza. Abbandonato un certo
moralismo e rigorismo giovanili, Newman ritiene infine che l’atteggiamento morale autentico sia essenzialmente quello dell’attenzione, dell’apertura e disponibilità
volte a ricevere la Presenza di Dio.
Bernadette Waterman Ward ha dedicato la sua relazione all’attività letteraria
di Newman, rilevandone lo specifico scopo pedagogico, ovvero quello di aiutare
a prendere coscienza che vi è nella società secolare un potere che tenta di proibire
138
CONVEGNI
Philosophical News
alla verità di competere con l’opinione e il sentimento. La storia di Callista, una
martire cristiana del III secolo, vuole essere il racconto di questa irriducibilità della
certezza cristiana al potere della secolarizzazione che Newman vide in atto nell’Inghilterra vittoriana. Secondo Waterman Ward il potere nuovo che i martiri hanno
testimoniato si basa sulla forza del desiderio di una verità stabile. Essi testimoniano
che il desiderio di Dio nel cuore dell’uomo è l’arma principale del cristianesimo.
Con i loro interventi Donna Orsuto e Kathleen Dietz hanno richiamato l’attenzione degli studiosi sull’incisività e operosità della fede di Newman, impegnata
nella educazione di un laicato immerso nel mondo e animata da un affidamento e
obbedienza radicale alla Provvidenza. Aspetto che è stato toccato anche da Roderick Strange, il quale si è soffermato sulla vita di Newman come testimonianza di
santità, vissuta nella certezza della presenza di quella Verità percepita a quindici
anni e che sebbene invisibile agli occhi si rivelava per lui assai più reale di ciò che è
visibile. Infine, il vescovo anglicano Geoffrey Rowell si è soffermato sull’esperienza
di limitatezza della nostra conoscenza di Dio che Newman viveva con profonda
consapevolezza senza essere scoraggiato, ma proteso ad addentrarsi sempre più nel
Mistero di Dio, procedendo in ginocchio coram Deum.
Il merito di questo convegno è stato certamente quello di aver offerto un focus,
grazie alla competenza dei relatori, sul rapporto con Dio vissuto da Newman, che
può essere considerato a ragione il centro affettivo della sua vita e che perciò è anche il nucleo centrale della sua riflessione teologica, filosofica, storica e della sua attività letteraria. Un primato di Dio che è frutto di quella personale esperienza della
verità di Dio come verità di sé e per sé che costituisce il vero motivo per parlare di
una attualità di Newman e che offre importanti riflessioni per il dibattito filosofico.
Samuele Busetto
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
Pluralità e interpretazione
Università degli Studi di Genova – 22-23 novembre 2010
Il convegno è stato inaugurato dai saluti del preside della facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli studi di Genova Francesco Surdich e del direttore
del Dipartimento di filosofia genovese Michele Marsonet. L’organizzazione è stata
curata dai professori Gerardo Cunico e Francesco Camera della sezione Etica e
scienze religiose del suddetto dipartimento. Tema di ineludibile attualità, “Pluralità
e interpretazione” si apre con un riferimento all’etica globale di Hans Küng, il teologo tubinghese che proprio a Genova ricevette la laurea honoris causa in filosofia
nel novembre 2004.
Gerardo Cunico, docente di Filosofia teoretica a Genova, presiede la seduta del
22 novembre, presentando il convegno quale frutto più maturo di un progetto di
ricerca genovese, allargato, per l’occasione, ad altri atenei, che pone «la filosofia
di fronte alla storicità ed alla pluralità delle culture e delle religioni». L’esigenza di
ripensare filosoficamente una questione cruciale per la sopravvivenza dell’umanità
stessa è quanto mai stringente nel tempo della pluralità, segnato dallo strutturale
convivere di persone orientate in maniere differenti nelle proprie esistenze. Una
differenza che, se irrigidita, può sfociare in aperti conflitti, come testimonia la tesi
del cosiddetto «scontro di civiltà». Se lo statuto ermeneutico del comprendere
si dispiega come una mediazione circolare e progressiva che intreccia il proprio
e l’estraneo, avviene proprio così l’incontro tra le differenze culturali e religiose
che tenga auspicabilmente conto della diversità come fatto, come necessità, come
valore e come problema. La validità interculturale dell’esperienza, delle norme, dei
valori è infatti qualcosa di problematico, che impone alcuni interrogativi circa la
possibilità di un dialogo tra le culture e le religioni e di un linguaggio comune che
strutturi la loro comprensione. Interrogativi che non potranno trovare risposta in
una riduzione delle differenze, tesa alla ricerca di un senso comune, a tutti sotteso.
Michael Eckert, docente presso la Facoltà di teologia cattolica a Tübingen, avvia
la propria esposizione chiedendosi se partendo dal presupposto della pretesa di
verità delle diverse visioni religiose del mondo sia possibile costruire un dialogo
interreligioso. L’attuale dibattito su unità e pluralità della religione può, secondo
Eckert che in ciò si rifà esplicitamente a Schleiermacher, aiutare a ritrovare il nesso
tra teoria filosofica della verità ermeneutica e pluralismo religioso. Lo scenario
contemporaneo presenta infatti conflitti tra le religioni in un mondo secolare dove
la globalizzazione si dispiega sovente come uniformazione del mondo e gli scontri
tra religioni si possono leggere come scontri tra rappresentazioni per l’unico vero
140
CONVEGNI
Philosophical News
ordine. I potenziali di violenza derivano a ben vedere dalle pretese veritative: proprio su queste può esercitarsi il ruolo della razionalità filosofica e dell’ermeneutica,
capaci di costruire un dialogo. Occorre tuttavia chiedersi quali siano le condizioni
ermeneutiche in virtù delle quali sia possibile distinguere e conservare standard razionali di argomentazioni e come si possano connettere pluralità e verità. Posto che
lo stato di tensione all’interno del pluralismo delle visioni religiose del mondo sta
nella caratteristica pretesa di universalità e totalità, la ragione filosofica – il riferimento è qui rivolto a Habermas – può porsi come mediatrice tra la dichiarazione di
possesso della verità assoluta e le minacce del relativismo. Non bisogna, pertanto,
rinunciare alla ragione: solo una mediazione razionale potrà, infatti, stemperare i
fondamentalismi religiosi. La postmodernità si scaglia contro i “grandi racconti”
elaborando una ragione trasversale tra diversi paradigmi di razionalità, per la quale
non esisterebbero più rappresentazioni indiscusse e la verità sarebbe contestuale,
prospettica, interpretativa, ermeneutica. Al tempo stesso, bisognerebbe preservare
l’idea di verità dal divenire del tutto obsoleta. La teoria della ragione e della verità
di Schleiermacher può secondo Eckert essere la via d’uscita tra assolutismo e relativismo, una impostazione capace di mediare il pluralismo. Contro la pretesa della
ragione hegeliana di giungere a un sapere assoluto, Schleiermacher ha infatti legittimato una critica della ragione d’ispirazione kantiana, affermando l’impossibilità
di una autofondazione riflessiva della ragione. Occorre allora affrontare un “pluralismo apparente” (cattivo soggettivismo), contrapponendolo a un pluralismo
razionalmente compreso, fondato sul modello schleiermacheriano. La tesi finale
di Eckert è che proprio nell’indisponibilità della verità assoluta sta la possibilità
ermeneutica di riconoscere le prospettive religiose, rapportandole e conducendole
a una unificazione qualitativa.
Chiude la sessione mattutina Donatella Di Cesare, docente di Filosofia del linguaggio all’università romana La Sapienza, che pone come oggetto della sua riflessione Il dialogo delle lingue e la globalizzazione, con particolare attenzione a
quelle che sono le esigenze umane di differenziazione e condivisione. Ancorché la
globanglizzazione sia da intendersi anzitutto come processo storico e quindi al di
là di ogni possibile valutazione, è pur nel suo incedere che la relatrice intravvede
ciò che per la pluralità delle lingue risulta essere un duplice pericolo: da un lato la
globalizzazione spinge avanti un processo di unificazione linguistica, che non può
non rievocare il fantasma di Babele, tanto che ciò che le lingue nazional-culturali
hanno fatto con i dialetti, estromettendoli dai domini del pensiero, succede adesso
a loro stesse; dall’altro lato il linguaggio tecnico-scientifico, che corrisponde gadamerianamente all’erezione della torre, si è progressivamente mutato da mezzo di
comunicazione a fine comunicativo in sé, estromettendo dal dicibile quanto non
fosse codificabile all’interno del proprio sistema. Posto che ogni tentativo di unificazione omogeneizzante si fondi su una concezione primitiva del linguaggio che si
limita a rilevarne le mere funzioni denotative e comunicative, Di Cesare propone
di rivalorizzare e la strutturale capacità del linguaggio di riarticolare visioni (Anschauungen) del sé e del mondo, riconoscendo dunque la necessarietà del dialogo
e della pluralità per la vita dell’Io, e la possibilità di eversione dalla semplice comunicazione per cui il linguaggio si fa poesia, condivisione, festa.
Philosophical News
CONVEGNI
141
La sessione pomeridiana si apre con l’intervento di Leonardo Samonà in
merito al rapporto tra Il pluralismo e l’universalità ermeneutica. Riconoscendo
nell’anelito all’universale quella patologia irredimibile del pensiero filosofico
che lo rende inviso a chi teme un ritorno del “pensiero unico” – che pure già
sottende al funzionamento dell’intero mercato globale – il relatore riconsidera
il pluralismo non solo come fenomeno storicamente e culturalmente radicato,
ma altresì come il luogo ultimo in cui quell’unità cui il pensiero non può fare a
meno di riferirsi si è dislocata. A partire dalle riflessioni gadameriane sul tema
dell’interpretazione e sulle note pagine degli Analitici II che ospitano la metafora dell’esercito in fuga, Samonà invita a ripensare la mediazione tra familiarità
ed estraneità come riconfigurazione semantica del rapporto uno/universalepluralismo/diversità: l’universalità si darebbe solo nella fusione di orizzonti,
nella prospettiva di un riconoscimento reciproco che sappia fare a meno di un
garante assoluto, e l’unità come familiarizzazione sarebbe essa stessa un prodotto del pluralismo. Sulla base di questa riconfigurazione dell’universale anche il
divino verrebbe ad assumere tratti contrari a quelli che gli furono in principio
tributati, vale a dire l’essere immutabile, eterno, non compromesso, mentre la
verità si riapproprierebbe della linguisticità e della storicità che determinano il
suo stesso accadere.
Segue l’intervento di Francesco Camera, docente di Ermeneutica filosofica a
Genova, che interviene sul rapporto tra Identità ed alterità in una prospettiva ermeneutica, interrogandosi su quello che potrebbe essere il contributo costruttivo
da parte dell’ermeneutica ad un pensiero del pluralismo. La proposta avanzata è
quella di un ripensamento dell’alterità e dell’identità, non come categorie indipendenti o momenti diversi di una maggiore universalità, ma altresì come profondamente relati, a partire dalla consapevolezza che né ciò che è altro si colloca
in uno spazio lontano e circoscritto, né l’identico può più essere compreso come
medesimezza autoreferenziale ed autocentrata della metafisica idealistica, dimenticando cioè quello che Lévinas chiama il residuo di alterità ineliminabile che lo
costituisce. Secondo Camera, proprio dall’ermeneutica, che sovente si è posta il
tema della pluralità delle interpretazioni e della comprensione dell’altro – basti
pensare a Schleiermacher e Dilthey –, può trarsi un importante contributo per le
riflessioni condotte nell’ambito di questo convegno. A partire dalle fondamentali
indicazioni fornite dalle più tarde riflessioni gadameriane ma nella consapevolezza
di dover promuovere un loro oltrepassamento, sulla scorta della denuncia derridiana di una riconferma del primato dell’identità, il relatore delinea le possibili
acquisizioni promosse dal paradigma ermeneutico nella definizione dell’alterità in
un contesto pluralistico: la riconfigurazione dell’appartenenza come permeabilità
e della tradizione come plurale; il carattere relazionale del rapporto Io-Altri che
riesce a scongiurare il pericolo e dell’assimilazione e dell’esclusione o marginalizzazione dell’alterità; la sottolineatura dell’importanza della correlazione tra estraneo
e proprio, alterità ed identità, per cui la comprensione non può mai essere esaustiva ma sempre soltanto asintotica; l’apertura a un dibattito sull’appartenenza che
promuova una concezione della cultura come orizzonte mobile in continua Bildung, cui si partecipa e di cui si fa parte, e che nemmeno nel suo sorgere può dirsi
142
CONVEGNI
Philosophical News
pura, il che equivale a dire che l’alterità è da sempre annidata e parte nel processo
di formazione dell’identità.
La prima giornata di studi si chiude con l’intervento di Pierfrancesco Fiorato
dell’Università di Sassari sul rapporto tra Appartenenza religiosa e identità culturale nel pensiero di Hermann Cohen. A partire da una ricognizione filologica del
breve scritto conferenziale Ein Bekenntnis in der Judenfrage (1880), l’intervento è
volto a difendere la complessità della posizione coheniana contro la tentazione di
ridurla nell’alveo dell’assimilazionismo tout court, attraverso una chiarificazione
terminologica delle occorrenze del sostantivo Bekenntnis e dei verbi bekennen e
sich bekennen zu. Anzitutto il relatore ripercorre la faticosa gestazione del testo a
partire dalla consapevolezza dell’impraticabilità di un’intesa con il crescente antisemitismo tedesco rappresentato da Heinrich Treitschke. Successivamente sottolinea come né il Bekenntnis, ancorché mosso da un dovere religioso, coincida con
una professione di appartenenza religiosa, né la possibilità, prospettata dall’autore,
di una riunificazione tra ebrei e cristiani in una “forma più pura di religione” rimandi alla necessità di una conversione religiosa, quanto piuttosto, sulla scorta del
“concetto scientifico della religione”, a una realizzazione concreta della convivenza
tra religioni, tanto invisa a Treitschke, che deve trovare nel corso della storia il
proprio adempimento e nel frattempo fungere come punto prospettico d’incontro.
Così anche la forma di assimilazionismo caldeggiata da Cohen non sarebbe che
il riconoscimento del fondamento e dell’idea culturale che sostanzia la religione
tedesca e non già la conversione a essa. Pur in questa forma attenuata, l’invito
all’assimilazione si pone in contraddizione paradossale con la dura indignazione
coheniana, ma la lettura di Fiorato invita a considerare questa tensione funzionale
a disinnescare la logica dell’identità.
La seconda giornata di studi, presieduta dal professor Camera, si apre con la
relazione di Franz Martin Wimmer, docente dell’Università di Vienna, in merito
a quelle che sono le Prospettive dell’identità culturale nel mondo globale. Sottolineando come spesso il problema dell’identità culturale si ponga nei termini di
un’adesione da parte delle componenti minoritarie a quella che è la solida struttura identitaria della maggioranza, il relatore offre una disamina fenomenologica
dei possibili modi di pensiero dell’identità: identità retrospettiva o tradizionalismo,
che valuta il presente sulla scorta di un’origine situata in un passato immaginario o
perduto, demarcando nettamente il confine tra le tradizioni buone e quelle cattive,
tra la storia e la terra del “noi” di cui è espressione e quelle di tutti gli altri; identità
prospettica o utopismo, che non trova certezza nel passato ma in un futuro migliore
ancora da venire e che, ancorché superando i limiti del tradizionalismo e dell’autoritarismo si appoggi al solo utilizzo della ragione, rischia di trovarsi in competizione tanto con le numerose proposte utopiche del pensiero filosofico, quanto con
la realtà concreta; identità momentanea o evoluzionismo, per cui il presente non
è che un momento di transizione e l’identità non è che l’essere perennemente in
cammino, tanto che di un pensiero del genere le maggiori testimonianze vengono
dai popoli migranti; identità pluripolare o turismo, per cui il presente si costituisce
di esperienze plurali in mondi diversi (bricolage, patchwork-identity) che non sono
Philosophical News
CONVEGNI
143
tuttavia espressione di una spontaneità autentica bensì di una sorta di costitutiva
irrequietezza inconscia; identità reiterativa o metempsicosi, per cui il sé permane
prima e dopo il presente in molte vite diverse; identità perenne o A=A, in cui il
presente coincide con l’eternità. Considerando le possibili applicazioni dei suddetti pensieri identitari nell’ambito della filosofia, la quale da sempre si confronta
con il dilemma della culturalità, id est la tensione tra aspirazione all’universalità e
necessità di ricorrere a un sistema espressivo contingente, Wimmer propone l’ideale regolativo di un polilogo tra le culture, che possa in virtù dell’esigua quantità
di presupposti incontrollati che lo guidano scongiurare i rischi dell’autoritarismo,
dell’inconfessato radicamento tradizionale e del relativismo rispettivamente insiti
nelle prime tre modalità di pensiero identitario.
Chiude il convegno l’intervento di Claudio Ciancio dell’Università del Piemonte Orientale sul rapporto tra Unità e pluralità della verità in filosofia e in religione,
attraverso tre snodi fondamentali: la verità nella religione, il conflitto tra la filosofia
e il cristianesimo, e l’affermazione della compresenza di unità e pluralità nel pensiero filosofico. Muovendo dall’assunto che la questione dell’unità del vero può
non essere prioritaria nelle religioni in senso teoretico, Ciancio intende riaffermare
l’attualità delle religioni come pratiche di vita o vie della salvezza e la possibilità di
meditare intorno alla valenza teoretica del concetto religioso di verità, con riferimento esemplificativo a due passi del Vangelo di Giovanni («Conoscerete la verità
e la verità vi farà liberi» Gv 8,32; «Io sono la via, la verità, la vita» Gv 14,6) che il
relatore pone in dialogo con l’imperativo evangelico del “rendere testimonianza”.
L’evento della rivelazione rappresenterebbe allora, con parole di Schelling, la liberazione da una religione cieca in virtù di una causa libera fuori dalla coscienza.
Ricordando come in Grecia il passaggio dalla religione alla filosofia avvenne nella
forma della coscienza, sicché il mito non fu ripudiato ma reinterpretato come condizione naturale della coscienza stessa, Ciancio reinterpreta l’opposizione postagli
dalla coscienza biblica come sorgere di una verità altra, alternativa sia alla coscienza mitica naturale sia alla ragione naturale: se il cristianesimo è in Paolo «follia per
la ragione» è perché va contro le tendenze naturali di cui le religioni mitologiche
sono espressione. Il problema dell’unità della verità si profila allora come esigenza di accordare le verità razionali con le verità rivelate. Alla domanda sull’unità
del vero anche la filosofia ha dato tuttavia diverse risposte. Si dovrebbero forse
intendere, così propone il relatore, le molteplici verità come molteplici pretese
di verità. In questa prospettiva diviene allora necessario superare sia le “verità
parziali” sia l’egemonia di un’unica verità, per lo stesso principio filosofico per cui
«i sensi dell’essere devono essere unificabili», nella misura in cui l’interpretazione
è una visione sull’intero da un particolare punto di vista. Così inteso il carattere
ermeneutico della verità non sarebbe allora semplicemente qualcosa di parziale e,
di conseguenza, la verità non necessiterebbe più della riduzione ad un’unica formulazione, ma altresì permetterebbe il confronto non conflittuale tra prospettive
diverse oltre ogni dogmatismo, sia esso ideologico, confessionale o relativistico.
Il convegno Pluralità e interpretazione ha saputo proporsi come terreno fertile
per l’incontro reale di interpretazioni plurali sul tema, fornendo spunti di incommensurabile fecondità teoretica, quali possono solo darsi nell’ascolto di un fornito
144
CONVEGNI
Philosophical News
gruppo di pensatori in dialogo. La miglior chiusa è forse il suggerimento proposto
da Gerardo Cunico di considerare le due giornate di studi, sulla scorta dell’abbozzo fenomenologico di Franz Martin Wimmer, come un esempio ben riuscito di
polilogo in atto.
Francesco Ferrari
Università degli Studi di Genova
[email protected]
Selena Pastorino
Università degli Studi di Genova
[email protected]
Filosofia e Mistica
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano – 24-25 novembre 2010
Nelle giornate del 24 e del 25 novembre 2010 la prestigiosa aula dedicata a Pio
XI ha accolto il convegno dal titolo Filosofia e Mistica, evento organizzato dal dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica in collaborazione con il Progetto
Culturale della C.E.I. Il convegno si è aperto con i saluti del Magnifico Rettore
Lorenzo Ornaghi che ha augurato il buon svolgimento dei lavori, e che nel suo
discorso ha inoltre ricordato l’importanza del dialogo con Dio (dialogo di cui la
mistica rappresenta appunto il vertice) quale base che rende possibile anche la
comunicazione tra noi uomini. A lui ha fatto seguito il saluto e l’augurio di mons.
Sergio Lanza, Assistente Ecclesiastico Generale, dopo il quale hanno preso la parola Angelo Bianchi, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, e Michele Lenoci, preside della Facoltà di Scienze della Formazione, i quali hanno sottolineato
l’estrema attualità del tema in questione, la fecondità di un confronto ad alto livello
tra l’ambito filosofico e la sfera della mistica, nonché la significatività che questo
incontro avvenga proprio nell’Università Cattolica.
Dopo i saluti delle autorità, la sessione pomeridiana ha preso quindi l’avvio
presieduta dal prof. Alessandro Ghisalberti. Nell’introdurre i primi tre relatori,
Ghisalberti ha proposto una riflessione preliminare che ha mostrato la peculiarità
della mistica ebraico-cristiana rispetto a tutte le altre tradizioni mistiche: essa, infatti, si caratterizza come una forma di passività del soggetto umano di fronte alla
chiamata di un Altro, tuttavia senza che ciò implichi una perdita o una dispersione
dell’identità del soggetto stesso, che anzi nell’esperienza mistica riesce paradossalmente a svolgere l’attività di cogliersi come soggetto passivo. Per questo motivo,
nel cristianesimo possono essere riconosciute due modalità dell’esperienza mistica:
quella affettiva, dove Dio si comunica in modo indiretto nell’orazione e nella contemplazione, e quella unitiva, che è la più particolare, poiché Dio entra nella vita
del mistico in modo diretto comunicandosi nella forma dell’estasi.
La parola è stata poi data al prof. Marco Paolinelli, che ha offerto una dissertazione sul tema de La filosofia verso la religione nella tradizione dell’Università
Cattolica. Contro chi pretende una riduzione della filosofia a mero ragionamento
calcolante, a solo sapere scientifico, viene fatto notare che in realtà la filosofia nasce dalla volontà di dare risposte ai grandi “perché” e ai più profondi problemi
della vita, mostrando quindi un fondamentale aspetto sapienziale, ben compreso
e coltivato nell’Università Cattolica da illustri docenti come Masnovo e Sofia Vanni Rovighi. In questi termini si spiega la pregnanza della speculazione metafisica
in filosofia, nonché il suo naturale rivolgersi anche a tematiche religiose, come i
146
CONVEGNI
Philosophical News
fenomeni mistici: Paolinelli precisa, però, che la metafisica (e più in generale la filosofia) non è chiamata a fondare la fede (né la mistica), bensì a creare un contesto
di trascendenza, un’apertura razionalmente giustificata, in cui fede (e mistica) possano svilupparsi. Gli esempi citati sono le figure celebri di san Tommaso d’Aquino e san Bonaventura, che furono contemporaneamente filosofi, teologi, religiosi
e mistici. Tra l’altro, pur essendo il fenomeno mistico un’esperienza tipicamente
personale, la mistica riceve però degli effettivi aiuti dalla filosofia, poiché questa
spesso fornisce un apparato concettuale e terminologico di cui gli stessi mistici si
servono per comunicare, anche solo parzialmente, le loro esperienze.
Il secondo intervento, della prof.ssa Angela Ales Bello, ha toccato il rapporto tra
fenomenologia e mistica: dato che la fenomenologia si configura come l’indagine
dei fenomeni, di ciò che si manifesta, ed essendo la mistica caratterizzata proprio
dal manifestarsi di Dio all’uomo, si giustifica così la possibilità da parte della fenomenologia di occuparsi del fenomeno mistico. La mistica, dunque, concepita come
l’incontro con “qualcosa di potente”, come l’irruzione di una presenza di un essere
Onnipotente manifestatasi e sentita nella sua concretezza, può essere indagata per
via negationis esaminando la posizione di coloro che rifiutano il valore di tale esperienza religiosa, come ad esempio Feuerbach. Egli notoriamente rigetta la religione
e l’idea di Dio ritenendola soltanto un’illusoria proiezione umana, eppure il desiderio stesso di un essere superiore è già indizio di una presenza-assenza costitutiva
dell’uomo, una mancanza che richiede conseguentemente un appagamento, come
viene descritto in modo magistrale ne Il castello interiore di santa Teresa d’Avila.
In questo testo si parla, infatti, di un viaggio in stanze concentriche di un castello
(quale metafora della stratificazione dell’animo umano) verso l’incontro, che avviene nell’ultima stanza centrale, con la figura divina capace di soddisfare pienamente
ed eternamente il desiderio più profondo dell’uomo. Angela Ales Bello fa notare,
però, che la percezione a livello psichico di questa presenza-assenza può essere sia
accettata e accolta (cominciando così il cammino mistico), sia rifiutata (e allora si
elaborano appunto delle pretestuose giustificazioni per considerarla illusoria).
L’ultimo intervento della prima sessione è spettato al prof. Giuseppe Colombo,
che ha trattato il problema dei fondamenti antropologici della relazione di fede,
additando nella mistica il luogo dove la cura di Dio implica inscindibilmente anche
la cura dell’uomo: il cristianesimo, con la mistica, rilancia infatti la sua capacità
di essere l’unico vero mezzo per l’appagamento dei bisogni antropologici fondamentali. Ricordando santa Caterina da Siena, viene perciò posto in primo piano il
tema dell’amore, quale fine e aspirazione autentica che anima intimamente l’uomo:
emblematiche a riguardo sono le parole riferite in visione da Dio, e riportateci
dalla santa, “senza amore non potete vivere, perché io vi ho creati per amore”,
parole dove emerge con straordinaria chiarezza che non solo l’uomo è stato fatto
per amare, ma anche che è stato fatto per amore, cioè che è Dio stesso a essere
ebbro d’amore nei confronti dell’uomo e che dunque ci ha creati per amarci. Altri
temi antropologici fondamentali che affiorano sono poi quelli della sofferenza e
del perdono, tra loro interconnessi: essi si trovano laddove c’è il bivio tra la vita e
la morte. La sofferenza scava e consuma dal di dentro, secondo un’espressione di
Claudel, lima e toglie tutte le forze; essa può condurre alla disperazione totale, a
Philosophical News
CONVEGNI
147
un annientamento mortale, oppure può sublimarsi nel per-dono, nel dono di sé,
traendo così anche da essa nuova vita.
Concluso il primo giorno, la seconda sessione si è aperta il giovedì mattina presieduta dal prof. Adriano Fabris, che l’ha introdotta riflettendo su un’idea diversa
del rapporto mistico tra Dio e l’uomo, uniti da un legame in cui viene mantenuta
la differenza tra i legati.
Mons. Franco Giulio Brambilla, il primo relatore, si è occupato di esaminare la
fondazione teologica e cristologica della mistica, andando a ricercare l’elemento
unificante che congiunge il vissuto soggettivo dell’esperienza mistica con il contenuto oggettivo della fede. Una soluzione viene trovata tramite la considerazione
che nel cristianesimo l’oggetto di fede non è propriamente un oggetto, bensì una
persona viva, ed è perciò possibile instaurare con Lui una relazione tanto oggettiva
quanto personale e confidenziale. I mistici ci ricordano infatti che la fede in determinati contenuti religiosi è anche contemporaneamente un rapporto di fiducia
e di affetto, al punto che si può persino sperimentare direttamente nel vissuto
quotidiano.
Il tema del linguaggio della mistica è stato poi oggetto della dissertazione del
prof. Luigi Borriello: premettendo che l’esperienza privata che ha un mistico è
incomunicabile e ineffabile, Borriello spiega che il linguaggio mistico è dunque soltanto una forma di mediazione per condurre a loro volta gli ascoltatori a una personale conoscenza amorosa di Dio, con funzione mistagogica. Il linguaggio usato dal
mistico potrà perciò essere simbolico e anche paradossale, essendo tra l’altro esso
del tutto secondario rispetto al linguaggio di Dio, il Logos per eccellenza: infatti, il
mistico può (tentare di) parlare di Dio solo perché Dio ha già parlato per primo.
Il terzo intervento della mattinata è stato tenuto dalla prof.ssa Elisabetta Zambruno, e ha riguardato l’uomo e il desiderio di Dio con specifico riferimento alla
mistica tedesca. Dopo aver condotto una ricognizione storica di una famosa opera
dal titolo Una teologia tedesca, attribuita ad un Anonimo francofortese, la prof.ssa
Zambruno ne ha analizzato il contenuto per indagarne le suggestioni mistiche in
essa presenti. Pervasa da un’eccessiva influenza neoplatonica, quest’opera venne
condannata e censurata nel 1612 come eretica. Nel testo compare molto spesso
l’immagine metaforica della luce e del sole: la nascita delle creature dal creatore,
ad esempio, viene paragonata all’emanazione dei raggi dal sole; così come si sottolinea sovente la distinzione tra una “luce vera”, che è quella che proviene da Dio, e
una “luce falsa”, che deriva dall’illusione umana di potersi rendere come Dio con
le proprie sole forze. Ulteriore caratteristica di quest’opera è che si sostiene che
non sono solo i religiosi, con una particolare vocazione alla vita consacrata, a poter
aspirare ad una contemplazione mistica di Dio, ma a ogni buon cristiano è aperta
questa possibilità.
La terza e ultima sessione pomeridiana è stata presieduta dal prof. Francesco
Botturi, che ha puntualizzato come il linguaggio mistico sia intrinsecamente composto da parola e da assenza di parola, parola e silenzio, essendo cioè contemporaneamente dicibile e indicibile, relazionale ma anche soggettiva e assoggettante.
Una trattazione della mistica in Meister Eckhart è stata poi esposta dal prof.
Aniceto Molinaro, comparando la mistica religiosa con la mistica filosofica. Par-
148
CONVEGNI
Philosophical News
tendo da una considerazione sulla differenza ontologica di Dio, visto come totalmente distaccato dal mondo, anzi, come “Supremo distacco”, Eckhart ritiene
che se l’uomo vuole imitare Dio deve cercare di svuotarsi e di distaccarsi da tutto,
perfino da se stesso. Solo in questo modo, trovando spazio nell’animo umano, Dio
può allora comunicarsi alla sua creatura in una compenetrazione mistica: tanto più
l’uomo è vuoto, tanto più è pieno di Dio.
Nel secondo intervento, il prof. Domenico Bosco si è invece occupato della mistica nella modernità, di come essa sia stata recepita nel mondo contemporaneo. A
questo proposito Bosco ha fatto notare l’avanzare del dubbio attorno al fenomeno
mistico, guardato con sempre maggior sospetto soprattutto in seguito alla nascita,
nel ‘900, di quelle tecniche psicologiche e psicanalitiche che propongono chiavi di
lettura potenzialmente differenti dei fenomeni mistici, portando a dubitare della
loro complessiva autenticità. Viene portato il caso del mistico seicentesco Jean-Joseph Surin, studiato dal gesuita contemporaneo Michel de Certeau, per dimostrare l’incredibile complessità del fenomeno mistico e la sua impossibilità ad essere
equiparato e ridotto a mero fenomeno psichico. Al contrario, l’intreccio dialogante
e la fitta trama di relazioni che caratterizzano l’esperienza mistica porta piuttosto
a ripensarla nella forma della fabula mistica, del progetto di una anti-Babele: la
ricerca di un parlare comune, di una sorta di lingua degli angeli, di un credere che
nel mistico si fa conversante.
Il prof. Massimo Marassi ha proposto un ultimo intervento con cui ha riportato
le posizioni assunte da Heidegger e da Wittgenstein nei confronti della mistica. Il
primo filosofo mostrò sempre un particolare interesse verso questo tema, sia da
un punto di vista storiografico che teoretico, vedendovi la possibilità di un’eccedenza rispetto alle possibilità della filosofia stessa. Entrambi concordano inoltre
nel concepire la filosofia non come una dottrina (basata su ragionamenti e argomentazioni), ma come un’attività, un fare vitale, un approccio globale al mondo:
dunque, in quanto eccedenza, la mistica si prefigura come l’istituzione di un senso
di trascendenza di tale attività vitale.
Estremamente interessante è stato, infine, il dibattito conclusivo con cui il convegno si è chiuso. Ghisalberti ha sollevato il problema di una fondazione filosofica
del fenomeno mistico, e non solo di una sua descrizione, parlando di una figura anticipante e anticipata della coscienza, mossa dal desiderio, che consenta di esperire
un’intenzionalità unitiva con Dio; mentre Botturi ha domandato precisazioni circa
la mistica di Eckhart. Molinaro, rispondendo a Ghisalberti, ha asserito di essere
poco propenso ad un avvicinamento troppo stretto tra l’ambito della filosofia e
quello della mistica, temendo indebiti sconfinamenti e preferendo che la filosofia
studi le condizioni di possibilità in cui può darsi l’espressione dell’esperienza mistica; rispondendo a Botturi, ha invece ribadito che per Eckhart la comunicazione
mistica di Cristo può avvenire nell’anima di chiunque, in quanto ogni uomo è
immagine del Verbo, che è immagine di Dio. Marassi ha a sua volta criticato l’utilizzo di una nozione quale quella di coscienza intenzionale riguardo l’esperienza
mistica, ritenendola troppo vincolata all’oggettivazione, che è proprio ciò che il
mistico vorrebbe evitare; anche se Molinaro, citando san Tommaso, ha precisato
che intenzionalità non è necessariamente un sinonimo di oggettualità, e quindi non
Philosophical News
CONVEGNI
149
sarebbe in fondo così incompatibile il suo uso in un approccio alla questione della
mistica. Numerose sono state anche le domande provenienti dal pubblico presente
in sala, che si è dimostrato vivamente interessato verso un tema che, pur nella sua
complessità ed “esotericità”, è stato capace di interpellare e toccare nel profondo
le sensibilità di tutti.
Luca Vettorello
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
SILFS 2010 – International Conference of the Italian Society
for Logic and Philosophy of Sciences
Università di Bergamo – 15-17 dicembre 2010
L’appuntamento triennale della Società Italiana di Logica e Filosofia delle
Scienze ha avuto luogo nell’accogliente atmosfera dell’ex convento Sant’Agostino,
a ridosso delle mura di Bergamo alta. Il comitato scientifico che ha provveduto
all’organizzazione è stato composto da Mauro Ceruti (SILFS President), Roberto
Arpaia (SILFS Secretary), Giovanni Boniolo, Marcello D’Agostino, Enzo Di Nuoscio, Mauro Dorato, Vincenzo Fano, Enrico Giannetto, Giulio Giorello, Roberto
Giuntini, Simone Gozzano, Corrado Sinigaglia. Sono intervenuti più di centocinquanta relatori provenienti da diversi continenti. I tre giorni del convegno si sono
svolti alternando sessioni plenarie a sessioni parallele, queste ultime suddivise in
sei aree tematiche: Logic and Application, Philosophy of Mathematical and Physical Sciences, Philosophy of Life Sciences and Cognitive Sciences, Methodology and
Philosophy of Science, Philosophy of the Social Sciences, Epistemology and History
of Sciences.
Dai titoli di ciascuna sessione si intuisce quante siano ormai le discipline che si
possono trovare sotto l’etichetta di “Filosofia della Scienza”; tale suddivisione ha
permesso di fornire una prova della vastità dei temi, delle prospettive e dei paradigmi presenti e di mettere in luce la profonda specializzazione richiesta, in primo
luogo, dal metodo utilizzato per accedere agli oggetti indagati, pena l’impraticabilità o l’irrilevanza della ricerca, e, in secondo luogo, dalla complessità cui ogni
campo di studio filosofico-scientifico è giunto.
La logica, in senso ampio, e alcuni soggetti di filosofia della matematica e della
fisica hanno avuto un ruolo preminente nello svolgimento dell’intero convegno,
anche in sessioni non specificamente dedicate: ciò è dovuto al fatto che esse, insieme a un certo background di tipo storico, svolgono una funzione trasversale e che,
dunque, costituiscono il bagaglio comune ai filosofi della scienza.
Non è stato possibile seguire tutte le sessioni parallele per evidenti ragioni di
continuità dello spazio-tempo a cui chi scrive è sottoposto, desidero comunque
fornire un’idea delle problematiche affrontate nei diversi gruppi di interventi1.
1 Mi scuso preventivamente con tutti coloro che non sono riuscito a citare, precisando che
ciò è avvenuto per mere ragioni di spazio. Per il programma completo del convegno rimando
all’indirizzo web: http://dinamico2.unibg.it/silfs/SILFS2010/programma.htm.
Philosophical News
CONVEGNI
151
Nella serie denominata “Logica e Applicazioni” le relazioni si possono porre
sotto due categorie: quelle che hanno esplorato ambiti di “semplice” logica, se così
si può dire, e quelle che hanno esemplificato le applicazioni possibili del lavoro del
logico. Del primo gruppo citiamo solo alcune tra cui: Carrara Gaio Martino How
dialetheism avoids trivialism; Paoli Non classical theory of conditionals; Porello Resource allocation in substructural logics; Piazza, Pulcini Disentangling truth from
undecidibility. Another look at incompleteness; Hannikainen Might-counterfactuals
and the principle of conditional excluded middle; Bruni, Shuster On Beppo Levi’s
approximation principle; Tesconi Towards an isomorphism with natural deduction:
a labelled sequent calculus; D’Agostini Paradoxes and probable truth. Del secondo
sottolineiamo le applicazioni della logica alla Quantum Computation, la tecnologia nata dalla sinergia tra Teoria dell’Informazione e della Meccanica Quantistica;
alcuni esempi sono stati: Freytes The algebric approach to quantum computation;
Dalla Chiara Giuntini The standard disk √ quasi-MV algebra is not finitely axiomatizable; Sergioli Representing continuous t-norms in quantum computation with
mixed states; Garola Recovering quantum logic within an extended classical framework; Ledda The algebric structure of an approximately universal system of quantum
computational gates; Conte Structures for classical objects in categorial semantics for
quantum information flow. Altri campi classici dell’applicazione della logica presentati sono stati il linguaggio, artificiale e naturale, e il controllo della correttezza
delle spiegazioni scientifiche.
Le relazioni raccolte sotto la dizione “Filosofia della Biologia e Scienze Cognitive” hanno proposto problemi svariati, tra i più interessanti: i meccanismi evolutivi
(Longy Selection and drift as causes: how to analyze the role of chance in biological
evolution; Ioannidis Population genetics and evolutionary developmental biology),
la definizione dei generi naturali (Macleod Inspired by Mill: an epistemic conception
of natural kinds for the Life Science; Schmietov Against life as a natural kind; Del
Savio Life as a natural kind), questioni legate agli esperimenti (Nardini The role of
quantitative experiments in cotemporary biology) e allo statuto degli stati biologici
(Swiatczak Ontological autonomy of biological states). Tra le altre principali tematiche affrontate troviamo quelle legate alle pratiche mediche (Sojic Explanatory role
of the classificatory units in clinical and biomedical knowledge representation; Germain The conditions for epistemic emergence in biomedical sciences; Benzi Medical
diagnosis and actual causation) e alle neuroscienze (Piredda Extended mind and
belief conception: a critical assessment; Bacchini Mental causality: a defence).
La “Filosofia delle Scienze Matematiche e Fisiche” ha trovato spazio in una
sessione che ha annoverato interventi molto eterogenei. Oggetto comune a diverse
relazioni è stata la natura dello spazio e del tempo in differenti prospettive: Allori
What does quantum mechanics tell us about time; Macchia On the relational constitution of the cosmological spacetime; Calosi Persistence and change in Minkowski
spacetime; Torrengo Time travel, individuals, and the space-time-actuality manifold;
Farr The role of the metaphysics of time direction in the past hytpothesis; Disalle
Explanation, explication, and interpretation of space-time theories; Mazzola Becoming and the algebra of time; Cometto The riemannian turn in the conception of
space. Altri contributi, maggiormente inerenti alla matematica, in particolare alla
152
CONVEGNI
Philosophical News
sua natura e ai suoi oggetti, sono stati: Oliveri Object, structure and form; Pedeferri,
Friend Are mathematicians better descrive as formalists or pluralists?; Arrigoni On
sets and infinite sets; Tarziu Pure versus applied mathematics.
Nella sessione dedicata a “Epistemologia e Storia delle Scienze”, hanno avuto
grande rilievo molti personaggi e temi classici; per citarne alcuni, si è parlato di
Pierre Duhem (Bordoni From analytic mechanics to energetics: Duhem’s early
steps towards complexity; Fortino Physics and metaphysics in Pierre Duhem), del
Principio di Conservazione dell’Energia (Bevilacqua History and the meaning of
the Principle of Energy Conservation), Ernst Mach (Schrenk Ernst Mach on the
self: the deconstruction of the ego as an attempt to avoid solipsism), Henri Poincaré (Toscano Poincaré and the determinism), Esperimenti mentali (Arcangeli
Urban legends about Thought Experiment), John von Neumann (Numerico John
von Neumann: doubts on mathematical rigor and on digital representation), Alan
Touring (Gherardi Alan Touring and the foundations of computable analysis), Donald Davidson (Rivara Truth in predication?), il problema di Gettier (Alai A partially externalist notion of justification as a solution to Gettier’s problem), la scala
di Wittgenstein (Bazzocchi Against the acrobatic interpretation of Wittgenstein’s
ladder), Kurt Gödel, Erwin Schroedinger (D’Agostino The original Schroedinger’s paper on the poor cat’s paradoxical situation), Leibniz (Mariani, Moriconi
Negation and quantification in Leibniz), Lyell, Maxwell, Darwin, la paternità del
Secondo Teorema di Incompletezza (Formica Almost von Neumann, definitely
Godel. The 2nd incompleteness theorem’s early story), Benedetto Croce (Zappoli
Benedetto Croce’s thory of science).
La sessione “Metodologia e Filosofia delle Scienze” ha permesso di analizzare
i problemi connessi al realismo scientifico sia in modo teorico sia con riferimento
a particolari oggetti utilizzati nella pratica scientifica, due esempi: Ghins van Fraassen’s view on representation: a new challenge to scientific realism?; Katzav The
reality of climate models. Si è discusso, inoltre di progresso scientifico (Tambolo
Verosimilitudinarian versus the Epistemic approach to scientific progress), identità
(Borghini Diachronic identity in Biology and Philosophy), femminismo (Amoretti,
Vassallo Scientific Knowledge: situatedness and intersubjectivity without standpoints), teoria della decisione (Ivanova Can theory virtues solve the problem of
theory choice?) e induzione (Volpone The problem of induction in the light of contemporary cognitivism).
Lo spazio dedicato a “Epistemologia delle Scienze Sociali” è risultato un buon
complemento per l’andamento del convegno poiché ha permesso di mettere a
tema questioni collaterali rispetto alle scienze di cui sopra; largo spazio hanno avuto l’economia (Cevolani Hayek in the lab. Austrian school, game theory and experimental economics), la sociologia (Rizza Applied mathematics in social choice theory)
e la psicologia (Lo Dico The puzzle of verbal report in cognitive psychology). Hanno
avuto un piccolo riscontro anche tematiche di filosofia della religione, Mantovani
Could Santa Claus be a god? The Cognitive Science of Religion and the explanation
of religious commitment, e Giovagnoli Analytic pragmatism, artificial intelligence
and religious beliefs.
Philosophical News
CONVEGNI
153
Da mettere in rilievo sono certamente le sessioni plenarie che hanno fornito
chiavi di lettura di grandi temi che sono oggetto di intersezione della ricerca di
molte delle discipline presenti nelle sessioni parallele.
La relazione di apertura è stata A Methodical Theory of Emergence di Peter Janich (Phillipps Universitaet-Marburg). Il filosofo tedesco ha descritto efficacemente l’importanza del concetto di emergence (la derivazione di un sistema complesso
o una proprietà a partire da interazioni semplici), che dal suo ambito originale,
cioè la biologia evolutiva, è risultato essere un concetto esplicativo prolifico anche
nell’interpretazione di fenomeni non immediatamente prossimi alle scienze della
vita, come nelle teorie circa la relazione mente-corpo. La sua applicazione ad ambiti e fenomeni differenti ne ha arricchita la finezza, tanto che i tipi di emergence
catalogati sono molto diversificati (weak or strong, synchronic or diachronic, logical or causal, ontological or methodological). La lezione si è poi soffermata su un
ulteriore campo di esercizio della relazione di emergence: essa può essere utile qualora si ponga l’attenzione sugli attori della ricerca, gli scienziati, piuttosto che su
qualche oggetto specifico, utilizzandolo nella descrizione del rapporto tra i mezzi
a disposizione degli studiosi e i fini cui pervengono attraverso di essi. Si potranno,
così, intendere i fini tecnici come fenomeni emergenti, e i mezzi tecnici disponibili
per realizzarli, come fenomeno originale da cui essi derivano. Questa è ciò che
Janich ha chiamato una Teoria Metodica dell’Emergence, la quale, tra le altre cose,
interpreterebbe correttamente come certe teorie scientifiche si sono effettivamente
affermate.
Samir Okasha (University of Bristol) ha proposto con Why does Darwin matter
for Philosophy? una interessante difesa della rilevanza del punto di vista darwiniano e della sua teoria dell’evoluzione per la filosofia. Considerando un certo numero
di tradizionali problemi filosofici, mutuati da diverse discipline come l’epistemologia, la metafisica, l’etica e le teorie della decisione, Okasha ha mostrato come
per ognuno di essi sia possibile impostare una soluzione a partire dal Darwinismo.
L’esposizione è stata chiara e molto provocatoria. È stato, inoltre, interessante notare che la platea di docenti e studiosi non abbia sollevato alcuna obiezione alle
proposte ipotizzate, le quali, senza entrare nel merito della bontà o meno del progetto darwiniano in ambito scientifico, per quanto puntuali, hanno mostrato le
lacune proprie di ogni prospettiva particolare che si voglia fare totalizzante. Ciò
vale a maggior ragione per una teoria scientifica che si faccia filosofia e creda di
poterne risolvere tutti, o buona parte, dei problemi. Nonostante ciò, bisogna dare
atto a Okasha del rigore utilizzato, delle competenze dimostrate e del fascino che
sempre esercita il tentativo di trovare una prospettiva da cui spiegare tutto ciò che
è problematico.
Amit Hagar (Indiana University), con il suo intervento dal titolo Counting Steps:
A New, Finitist, and Objective Interpretation of Probability in Physics, affrontando
il tema della probabilità oggettiva in fisica, ne ha approntato una nuova interpretazione basata sulla nozione di complessità computazionale (l’analisi delle risorse minime necessarie per risolvere un problema computazionale), la quale supererebbe
le difficoltà relative alla giustificazione delle misurazioni, proprie dell’interpretazione della probabilità come regolarità humeana e come probabilità deterministi-
154
CONVEGNI
Philosophical News
ca, mostrando, inoltre, come la sua proposta abbia connessioni con un altro modo
di intendere la probabilità in fisica e cioè la possibilità stocastica, nell’ambito della
fisica quantistica.
In chiusura dei lavori, due tavole rotonde: Science and Democracy e Education
and Innovation. La prima si è svolta con gli interventi efficaci e non banali della
Prof.ssa Maria Luisa Dalla Chiara (Firenze), che ha proposto tra le altre cose nuovi
metodi per l’esercizio del diritto di voto nelle democrazie occidentali, e del Prof.
Giulio Giorello (Milano), il quale, con la consueta presenza storica, ha ripercorso
momenti significativi del rapporto tra l’affermazione della moderna democrazia,
in particolare americana, e il progresso scientifico, senza perdere l’occasione per
alcune battute caustiche riguardanti l’attuale situazione della democrazia italiana.
Per quanto riguarda la seconda tavola rotonda, essa non ha potuto avere luogo a
causa delle abbondanti nevicate in corso quel giorno in tutta l’Italia settentrionale.
In generale, i lavori del convegno sono stati fruttuosi, l’organizzazione buona
e la location gradevole. La grande quantità di interventi ha fornito contenuti approfonditi pressoché in ogni ambito proposto in cartello. In questo senso, sono
da sottolineare con qualche rammarico le scelte obbligate tra relazioni avvenute
contemporaneamente, le quali avrebbero meritato un’attenzione particolare.
Stefano Rivara
Università degli Studi di Genova
[email protected]
Livelli di significato e prospettive di ricerca in Ordine e storia
rivelazione, Vita e Pensiero, Miladi Eric Voegelin. I. Israele e la rivelazione,
no 2009
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – 20-21 gennaio 2011
Il convegno interdisciplinare “Livelli di significato e prospettive di ricerca in
Ordine e storia di Eric Voegelin” è stato frutto di una collaborazione accademica a
livello internazionale: tra gli enti promotori, oltre al Dipartimento di Filosofia e al
Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell’Università Cattolica, ricordiamo il Voegelin-Zentrum für Politik, Kultur und Religion, che ha sede presso
la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco. I relatori – provenienti da università italiane, tedesche, spagnole e statunitensi – si sono confrontati in particolare con
il primo dei cinque volumi di Ordine e storia dedicato a Israele e alla rivelazione (a
cura di Nicoletta Scotti Muth), recentemente pubblicato dalla casa editrice Vita e
Pensiero. La casa editrice milanese, in collaborazione con un comitato scientifico
composto dai professori Evandro Botto, Maria Luisa Gatti, Peter J. Opitz, Roberto Radice e Nicoletta Scotti Muth ha in progetto di portare a termine la traduzione
italiana dell’intera opera Ordine e storia.
I lavori si sono aperti con il saluto del prof. Massimo Marassi, direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica, il quale ha introdotto il tema del
convegno mettendo in luce il duplice obiettivo conseguito dall’opera di Voegelin:
in primo luogo essa, poiché utilizza una pluralità di registri epistemici (filosofico,
storico, esegetico, critico-letterario), è in grado di produrre una sintesi inusuale,
che trae vantaggio da ciascuno di essi; proprio per questo la sua opera supera la
frammentarietà del sapere proponendo invece una visione unitaria che non risulta
esauribile da una sola prospettiva disciplinare. L’ordine della storia, ha sottolineato
Marassi, nasce per Voegelin da una storia dell’ordine: ogni società crea un ordine
attraverso il quale conferisce significato all’esistenza. L’ordine della storia, tuttavia, eccede la concretezza di ogni società e la sua dimensione politica, in quanto
rimanda all’ordine stesso dell’essere (che implica sempre la presenza di un Oltre)
al quale l’uomo costitutivamente partecipa e che esprime attraverso la rappresentazione simbolica. La storia, secondo tale prospettiva, costituisce l’avvicendarsi delle
rappresentazioni simboliche del senso ultimo della realtà: per questo l’oggetto della storia non è identificabile con un insieme di idee astratte; esso coincide piuttosto con le esperienze concrete vissute dall’uomo e da lui espresse attraverso l’uso
del simbolo. Con l’avvento della rivelazione da parte di Dio al popolo di Israele
cambia la concezione stessa del tempo: da una visione ciclica del tempo (secondo
la prospettiva delle civiltà antiche) si passa a vivere nella forma storica, in cui Dio
viene sperimentato come presenza.
156
CONVEGNI
Philosophical News
All’intervento di Marassi ha fatto seguito il saluto del prof. Evandro Botto (Direttore del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa, docente di Storia
della filosofia e di Filosofia politica nella stessa Università) che ha presieduto la
prima sessione del convegno. Botto ha messo in luce l’importanza delle forme simboliche attraverso le quali Voegelin ha espresso l’esperienza dell’ordine e l’allontanamento da esso, soprattutto nell’epoca moderna che è caratterizzata dal trionfo
del disordine.
Nella prima sessione sono state presentate tre relazioni, rispettivamente, da parte dei professori Nikolaus Lobkowicz (emerito di Politische Theorie und Philosophie, München, già Rettore della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco
e della Katholische-Universität di Eichstätt), Peter J. Opitz (emerito di Politische
Philosophie und internationale Politik presso la Ludwig-Maximilians-Universität
e fondatore del Voegelin-Archiv presso il Geschwister-Scholl-Institut für politische Wissenschaften di Monaco), Nicoletta Scotti Muth (docente di Storia della
metafisica antica presso l’Università Cattolica di Milano).
Lobkowicz (che ha intitolato il suo intervento Ideologie – und Voegelin?) dopo
aver accennato al suo rapporto personale con Voegelin, lo ha descritto innanzitutto
come uno studioso della scienza politica alla ricerca della verità dell’esistenza. Sebbene Lobkowicz abbia definito lo scopo della ricerca voegeliniana come lodevole,
al tempo stesso non ha inteso tacere quelli che – a suo giudizio – sarebbero i limiti
della sua indagine e della sua produzione scientifica. A suo parere, infatti, Voegelin
attribuirebbe il carattere di gnosticismo a molte prospettive di pensiero, tra loro
spesso distanti: la tendenza a descrivere sia alcuni pensatori che un’epoca intera (la
modernità) come gnostici inficerebbe la capacità di giudizio e di analisi filosofica
dell’Autore tedesco. Voegelin, infatti, non approfondirebbe adeguatamente il pensiero degli autori da lui presi in considerazione, e non sarebbe in grado di valutarne
gli aspetti positivi, essendo maggiormente interessato a spiegare il sorgere di ideologie come il comunismo e il nazional-socialismo attraverso l’influenza filosofica
che un pensatore ha esercitato su un altro o su un’intera epoca che a sviluppare
uno spassionato studio relativo alla storia delle idee. Lobkowicz ha anche accusato Voegelin di non aver messo adeguatamente in luce la differenza esistente tra
l’auto-rivelazione da parte di Dio (che avviene in un determinato momento storico
e coincide con l’Incarnazione) e un generico sforzo, da parte del pensiero umano,
volto a interpretare l’Oltre.
Di parere molto diverso è invece Opitz, che ha focalizzato il suo intervento sul
tema “Auf der Suche nach Ordnung” – Kognitive und existenzielle Grundlagen der
politischen Philosophie Eric Voegelins. Opitz ha ribadito l’importanza di collocare
le singole argomentazioni sviluppate da un autore all’interno del contesto nel quale
sono sorte, tenendo conto anche dei successivi sviluppi del suo pensiero e delle
eventuali auto-correzioni apportate dallo stesso. Alla luce di questo accorgimento
metodologico, Opitz ha sottolineato che il concetto di gnosi, sebbene presente
negli scritti di Voegelin degli anni Cinquanta, è stato poi da lui relativizzato nelle
opere di epoca successiva, come emerge dalla decisione di abbandonare l’idea di
dedicare un sesto volume di Order and History al tema della gnosi. Un destino
analogo riguarda i concetti di “religione politica” e di “idee”. Opitz ha poi messo
Philosophical News
CONVEGNI
157
in luce l’importanza della figura di Agostino per Voegelin, suo punto di riferimento principale come teoreta e come mistico. Di Agostino, in particolare, Voegelin
riprende il concetto di meditazione, inteso come “dare la scalata ai gradi dell’essere” fino all’intentio Dei. Questa visione sottende tutta l’opera di Voegelin (che,
tuttavia, non gode di uno sviluppo omogeneo e non è priva di ripensamenti) ed
emerge in particolare nell’ultimo volume di Order and History. In Search of Order,
pubblicato postumo nel 1987. I due principali obiettivi della ricerca voegeliniana
– ha sottolineato Opitz – sono quello cognitivo-scientifico e quello esistenzialepolitico. Per quanto riguarda il primo di questi obiettivi occorre ricordare che
Voegelin – in profondo disaccordo nei confronti del neo-kantismo di Hans Kelsen,
il quale intendeva ricondurre la scienza delle dottrine politiche alla giurisprudenza,
depurando quest’ultima da tutto ciò che esula dal positivo contenuto giuridico – si
è sempre adoperato per restituire alla scienza politica tutta la sua profondità teoretica, trasformandola in una disciplina umanistica, dalla prospettiva multiculturale,
caratterizzata dal metodo delle scienze empiriche, ma che ultimamente trova le
sue radici in un’antropologia filosofica. Il secondo obiettivo di Voegelin è stato
quello di fondare filosoficamente la dottrina dello Stato, le cui radici devono essere
ricercate nell’essenza dell’uomo. Il fondamento della sua antropologia filosofica
consiste in una esperienza esistenziale e umana nella quale l’uomo, partecipando a tutti gli ambiti dell’esistenza, vive un costante rapporto con la trascendenza,
pur essendo un essere inframondano. Le problematiche centrali dell’opera voegeliniana, espresse in modo sintetico, sono riconducibili a tre: la prima consiste in
una “ricostruzione” delle dottrine politiche come scienza umanistica ovvero come
“scienza della sostanza”. In secondo luogo, il fondamento di questa “nuova scienza
politica” è un’antropologia filosofica costruita sulla base di “esperienze esistenziali
umane”, in particolare le esperienze di creaturalità e di ricerca di una causa, di un
fondamento (Grund). Alla fine degli anni Quaranta l’Autore abbandona il concetto di “idea politica” per le nozioni di “esperienza” e di “forma simbolica”, termini
che a partire dagli anni Sessanta del Novecento confluiscono in una filosofia della
coscienza. Il terzo ambito consiste nella storicità dello spirito. Nei volumi conclusivi di Order and History emerge una nuova filosofia della storia: il suo carattere,
fino ad allora unilaterale, si trasforma in una rete di linee di senso che scorrono parallelamente alle linee del tempo. Per quanto riguarda il giudizio dell’Autore sulla
modernità, Opitz ha sottolineato come Voegelin si sia interrogato sul significato e
sulla ricerca dell’ordine a partire dall’esperienza di crisi delle civiltà. L’Autore riconduce tale crisi proprio all’epoca moderna che caratterizza come un sostanziale
disordine dovuto alla separazione dello spirito mondano dalle sue radici religiose,
riconducendo a quest’ultima categoria non solo il cristianesimo, ma tutte le manifestazioni dello spirito umano nella direzione della trascendenza. La crisi odierna
è dovuta alla secolarizzazione dello spirito, evidente in quelle religioni immanenti che identificano il divino in singoli elementi inframondani. Un sottogruppo di
questo tipo di religione sono le cosiddette “religioni politiche” che divinizzano
elementi come la “nazione”, lo “Stato”, la “razza”, la “classe”, il “genere umano”.
Accettando una tale religiosità inframondana, secondo Voegelin, l’uomo accetta
di essere un semplice tassello di una grande totalità e – così facendo – viene meno
158
CONVEGNI
Philosophical News
il suo rapporto diretto con Dio. Un tale rinnovamento religioso – ha sottolineato
Opitz – non si identifica innanzitutto con una restaurazione della civiltà cristiana,
ma con la riscoperta dello spirito in tutte le sue forme e manifestazioni, in tutte le
grandi civiltà di tutti i tempi.
Alla relazione di Opitz ha fatto seguito quella di Nicoletta Scotti Muth, intitolata “Dovetti abbandonare le idee per far posto all’esperienza della realtà”: motivazioni
e circostanze di un ripensamento sulla storia. Scotti Muth ha innanzitutto voluto
mettere in luce le ragioni che stanno alla base della mancata recezione dell’opera
di Voegelin. Oltre alle motivazioni connesse allo stato apparentemente frammentario della sua produzione, occorre ricordare la tendenza a infrangere i tabù sui
limiti del positivismo in tutte le sue varianti e la lettura non convenzionale del
nazionalsocialismo come esito di un processo piuttosto che come sconvolgimento inatteso. Se osservata secondo la giusta prospettiva, l’opera di Voegelin risulta
coerente, in quanto costituisce la verifica su materiale storico di precise intuizioni teoriche. Proprio l’attenzione ai dati di fatto lo ha reso più volte disponibile
a correggere la sua prospettiva, come nel caso di Ordine e storia, opera sfociata
dalla messa in crisi di un progetto precedente, consistente in una Storia delle idee
politiche. Da un’analisi minuziosa del carteggio dei primi anni Cinquanta, di recente pubblicazione, Scotti Muth ha cercato di mettere in evidenza alcune tracce
di questo cambiamento di prospettiva. Si è soffermata su un ristretto gruppo di
lettere, inviate a Karl Löwith, Leo Strauss e Alfred Schütz, nelle quali Voegelin,
sforzandosi di rispondere ad alcune obiezioni, puntualizza con rigore la propria
posizione. In particolare, egli rimprovera a Löwith di confondere l’uso dei termini “empirico” e “secolare” applicandoli alla storia, a Strauss di contrapporre
nettamente conoscenza e fede, riservando la prima alla filosofia, la seconda alla
rivelazione, infine a Schütz di non vedere che la ragione non è circoscrivibile al
solo lumen naturale. Di conseguenza, con Löwith vengono ridiscusse le categorie
di “storia sacra” e “storia profana o secolare”, con Strauss il fatto che fra fede e
ragione, pur non dandosi identità, si dà tuttavia continuità, poiché quest’ultima è
già all’opera nel necessario discernimento sul sapere rivelato, con Schütz che due
millenni di riflessione cooperativa sulla dogmatica cristiana hanno permesso alla
ragione di sviluppare potenzialità implicite e di conseguire importanti guadagni
critici. In particolare, quest’ultimo punto viene esemplificato sulla scorta di alcuni
aspetti della cristologia, della mariologia, del dogma trinitario e della riflessione
filosofico-teologica della traditio cristiana. Tutti questi sono guadagni essenziali
di quello che Voegelin chiama “cristianesimo essenziale”, da tenere ben distinto
dalla concezione di cristianesimo incentrata sull’attesa escatologica che è propria
della teologia protestante posthegeliana. A partire da questa distinzione Voegelin auspica una riconsiderazione critica della convinzione ampiamente condivisa
secondo cui il guadagno del cristianesimo consisterebbe principalmente, se non
addirittura esclusivamente, nell’aver reso possibile l’idea di storia come sviluppo,
apertura verso il futuro. Proprio su quello che a suo avviso è un fraintendimento
si basa la lettura della “forma gnostica” dell’esperienza come immanentizzazione
dell’eschaton. Scotti Muth ha concluso il suo intervento sottolineando l’interesse
della lettura dello gnosticismo come “cifra” spirituale piuttosto che come agglome-
Philosophical News
CONVEGNI
159
rato di movimenti circoscrivibili a una determinata fase storica. Se lo gnosticismo
è possibile solo in un contesto che abbia ormai chiarito la differenza fra uomo e
Dio, in chiave gnostica potrebbe leggersi anche l’odierno tentativo di negare radicalmente l’apertura dell’uomo alla trascendenza, apertura che gli è connaturale,
come ben sintetizzato dal dictum voegeliniano che l’uomo partecipa di uno spazio
quadridimensionale (che quindi implicitamente e originariamente sperimenta) i
cui vettori di senso sono Dio, il cosmo, la società, e l’uomo stesso.
I lavori del convegno sono proseguiti il giorno successivo, in una sessione mattutina e in una pomeridiana, entrambe presiedute dal prof. Roberto Radice, docente
di Storia della filosofia antica presso l’Università Cattolica di Milano. La presentazione dei diversi interventi è stata preceduta da un saluto da parte del prof. Lorenzo Ornaghi, Magnifico Rettore dell’Università Cattolica, e da una breve presentazione dell’edizione italiana di Ordine e storia da parte del dott. Aurelio Mottola,
direttore di Vita e Pensiero. I relatori sono stati i professori Giorgio Buccellati,
Giulia Sfameni Gasparro, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Ignacio Carbajosa.
Buccellati (Direttore del Mesopotamian Lab presso il Cotsen Institute of Archaeology, UCLA) ha inviato un contributo dal titolo Coerenza e storia. La Mesopotamia nell’ottica storiografica di “Ordine e storia”: istituzioni politiche, trasmissione del pensiero e percezione dell’assoluto. Buccellati ha inteso sottolineare la
continuità strutturale di certe istituzioni e atteggiamenti mentali presenti nella
storia dell’antica Siria e Mesopotamia come aspetti caratteristici della visione della storia avanzata da Voegelin, secondo il quale anche i guadagni culturali più remoti devono essere inseriti all’interno di una visione continuativa dell’esperienza
umana. Nel caso dei popoli appena menzionati, l’aspetto sotteso alla loro storia
consiste nella capacità di prendere coscienza della loro coesione sociale attraverso un movimento al contempo centrifugo (per la loro espansione territoriale) e
centripeto (per la capacità di creare una sempre nuova coerenza istituzionale). Il
vincolo di solidarietà rimane al centro della loro dinamica storica e prende forma
all’interno di tre dimensioni: una territoriale, una etnica e una etnico-territoriale
(quest’ultima costituisce il fondamento di una dimensione nazionale, ossia di un
gruppo sociale legato da un’affinità che trascende ma non esclude la contiguità
fisica). La storia di questi popoli è inoltre caratterizzata dall’uso della scrittura
come immagine visiva del pensiero che permette di trattare il contenuto mentale
proprio e degli altri come un oggetto a sé stante, favorendo l’emergere di una categorizzazione fino ad allora impensabile, nonché di una rapida trasmissione del
pensiero in aree geografiche distanti. Un terzo fattore consiste nella percezione
dell’assoluto. Al processo di reificazione che avviene con il linguaggio segue un
analogo processo di categorizzazione e di controllo anche nei confronti dell’assoluto. Il politeismo consegue così un grande risultato intellettuale, che consiste
nell’aver per così dire fissato la totale coerenza degli ambiti della realtà: le forze
che condizionano la vita umana sono ricondotte a categorie definibili e perciò
risultano prevedibili. Secondo questa prospettiva gli dei e le dee sono solo apparentemente antropomorfi, in realtà costituiscono sfaccettature del reale così come
viene compreso attraverso l’approccio analitico. Ma mentre nel politeismo l’assoluto proprio per questo non agisce, nel monoteismo biblico il Dio è un Dio viven-
160
CONVEGNI
Philosophical News
te, assolutamente imprevedibile, ma fedele a se stesso e alla sua alleanza. Nei fenomeni di queste civiltà esiste quindi una profonda coerenza rispetto a un referente
che mantiene la sua identità nel tempo e condiziona le modalità dello sviluppo:
nel primo caso si tratta del gruppo sociale, nel secondo del contenuto nascosto
della mente umana, nel terzo si tratta dell’assoluto (la percezione dell’assoluto si
fonda sempre sul senso del limite). Dal punto di vista del fenomeno storico, la coerenza che caratterizza tali civiltà deve considerarsi in relazione al referente, che
può essere visto come fondamento dell’ordine. Come sosteneva Voegelin, quindi,
la storia universale si deve leggere in rapporto a realtà nascoste che influenzano
profondamente le scelte umane. All’interno di questo contesto l’assoluto che caratterizza il monoteismo gioca un ruolo del tutto particolare: conseguenza di ciò
è l’unicità delle tradizioni dell’antico Israele, che in tal senso vanno a costituire il
momento fondante della storiografia universale.
La professoressa Giulia Sfameni Gasparro (docente di Storia delle religioni
presso l’Università di Messina) ha presentato un intervento dal titolo La tipologia
di “ordine cosmologico” in Eric Voegelin: osservazioni storico-religiose. Nel rispondere alle obiezioni mosse da Th. J.J. Altizer su The Ecumenic Age (il quarto volume
di Ordine e storia), Voegelin ebbe l’opportunità di mettere in luce le modalità e
lo scopo della sua ricerca: il metodo è “positivo” e lo scopo della ricerca storicodocumentaria ha avuto una finalità “teologica”, da intendersi come “discorso sul
divino”, secondo l’accezione ampia del termine. Nonostante i cambiamenti di direzione che caratterizzano i cinque volumi di Ordine e storia, Voegelin mantiene
il principio-base del suo progetto, ossia l’individuazione di quei momenti epocali
che nella storia segnano la presenza di un “prima” e di un “dopo”. Questa visione
porta alla distinzione tra le “culture cosmologiche” caratterizzate da un “simbolismo compatto” proprio delle culture antiche e dei loro intracosmic gods (i tre casi
descritti in Israele e la rivelazione sono la Mesopotamia, l’Iran achemenide e l’Egitto) e culture come quella di Israele, che hanno effettuato un “balzo nell’essere”
che li ha condotti a identificare il Dio creatore dell’inizio con il Dio sconosciuto
dell’“Oltre”. La Sfameni Gasparro ha sottolineato come per Voegelin il termine
“rivelazione” non si debba applicare in modo esclusivo alla storia di Israele, ma
riguardi anche le epoche e le civiltà precedenti. Lo scopo del volume su Israele e la
rivelazione consiste nel rinvenire nelle singole società la presenza di momenti epocali che stabiliscono un prima e un dopo. Con la nozione di historiogenesis viene
tuttavia meno la rigida distinzione tra la storia ciclica delle civiltà antiche e quella
lineare di Israele e dei cristiani. La relatrice ha poi messo in luce la diversità tra
l’atteggiamento di Voegelin e quella dello storico delle religioni: mentre il primo
non procede a una personale analisi documentaria, ma si affida alle fonti maggiormente accreditate per perseguire il proprio progetto epistemologico, ossia quello
di identificare la realtà divina che si rivela nel processo storico, il secondo procede
attraverso un metodo storico-induttivo. Il metodo di ricerca di quest’ultimo, inoltre, deve essere il più scevro possibile da condizionamenti provenienti da visioni
ideologiche e teologiche. Secondo questa prospettiva la Sfameni Gasparro ha poi
considerato la nozione voegeliana di “ordine cosmologico” in relazione all’impero
achemenide, che la studiosa ritiene eccessivamente restrittiva, sebbene lo stesso
Philosophical News
CONVEGNI
161
Voegelin apporti alcune modifiche nel volume The Ecumenic Age alla luce del concetto di historiogenesis.
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (docente di Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft presso la Technische Universität di Dresda) ha presentato un intervento dal titolo Offenbarung vs. Ordnung? Ein prüfender Blick
auf Voegelins Deutung von Israel. La studiosa ha innanzitutto sottolineato che per
Voegelin la rivelazione, che interrompe il procedere ciclico di una storia originaria
cosmica, ha la pretesa di essere un ordine superiore a quello della realtà politica. Certamente Voegelin, ha sostenuto la Gerl-Falkovitz, rimane in debito di una
spiegazione adeguata sull’uso del concetto di rivelazione: come l’Autore tedesco
scrive in una lettera a Strauss, tuttavia, una verità rivelata deve essere comunicabile e avere la sua origine in Dio. In particolare, ciò che caratterizza l’aspetto
specifico della rivelazione – e che, ad esempio, la separa dai miti – risiede nel
concetto di libertà: il Dio di Israele è infatti libero di creare e non risulta in alcun
modo necessitato a farlo. Si tratta quindi di una grazia, il cui unico fondamento
risiede nell’amore. La rivelazione è un avvenimento, una forza formatrice che non
si lascia influenzare da una catena causale, essa ha il carattere di irruzione in un
determinato luogo e in un altrettanto determinato momento storico. Al contrario,
tutte quelle prospettive che vedono nel mondo una continua presenza del divino
senza alcuna interruzione ostacolano la formazione di una presa di distanza critica
nei confronti di un potere che viene considerato come da sempre dato. Il divino,
se inteso in questo modo, si trasforma facilmente in un idolo, in un aspetto della
realtà circoscritto, che può essere continuamente misurato dall’uomo: è solo la sovrabbondanza dell’amore divino che può quindi salvarci da un tale atteggiamento
idolatrico. Questo è proprio ciò che accade con la storia di Israele che libera il
mondo dalle sue potenze mediante la liberazione dagli idoli. La dimensione continuamente invocata da Voegelin è quella della trascendenza, contro ogni tentativo
di immanentizzare l’uomo e il senso della sua vita. Sebbene a livello della scienza
politica non sia possibile dimostrare la trascendenza nei suoi effetti sulla storia
politica, tuttavia – ha concluso la Gerl-Falkovitz – se ne possono considerare le
devastanti conseguenze della sua assenza.
L’intervento conclusivo dei lavori è stato presentato da Ignacio Carbajosa, docente di Antico Testamento presso la Facoltà di Teologia di San Dámaso a Madrid.
Il tema da lui trattato è stato Storia e storiografia di Israele. Luci e Ombre dell’opera
di Voegelin, “Israele e la rivelazione”. Carbajosa ha sottolineato come solo nel
corso degli anni Novanta si sia iniziato a mettere in crisi un metodo di ricerca che
nell’esegesi biblica si riteneva un dogma fondamentale, ossia lo studio diacronico
dei testi. Questo aspetto, ha affermato Carbajosa, è di fondamentale importanza
per mettere in luce i guadagni raggiunti da Voegelin in un momento storico in cui
la sua visione era controcorrente rispetto a quella allora predominante. Per lunghi
secoli la storia di Israele è stata identificata con la storia che i libri dell’Antico
Testamento ci propongono. Il merito dello storico Julius Wellhausen consistette
nella ricostruzione della storia di Israele così come essa emerge dalla teoria documentaria del Pentateuco: nel modello di Wellhausen storia e critica letteraria si
richiamano a vicenda, giungendo quasi a confondersi. Se si vuole quindi usare la
162
CONVEGNI
Philosophical News
Bibbia come fonte storica, si deve accettare la ricostruzione della sequenza storica
proposta dalla critica letteraria. Voegelin, osservando la storia dei fatti così come
viene proposta dalla storiografia positivista, si interroga sulla storia di Israele che
viene descritta nell’Antico Testamento, e – a partire da questi elementi – mette in
luce la distinzione tra storia pragmatica e storia paradigmatica. Sebbene la storia
di Israele si componga di fatti ed eventi (storia pragmatica) essa si fonda innanzitutto sulla relazione di Israele con Dio: alla luce di tale relazione gli eventi storici
diventano paradigmatici del rapporto con Dio. Un tale guadagno spinge Voegelin
a criticare la storiografia moderna in quanto essa non è invece in grado di superare
una mera raccolta delle fonti: una tale prospettiva – a suo giudizio – non manca
solo di scrupolosità nell’analisi delle fonti, ma risulta anche condizionata da precisi interessi teologici caratterizzanti la prospettiva condivisa da molti studiosi
protestanti dell’epoca. La scuola di Wellhausen, a partire dai criteri filologici, ha
spezzato l’unità della storia del Pentateuco in fonti diverse, negando l’esistenza
di un unico autore responsabile del testo che ci è arrivato, attribuendolo invece
a quattro diversi autori. Una tale visione, a giudizio di Voegelin, porta a considerare la Bibbia come un’opera letteraria, scritta a tavolino ed è colpevole di
non cogliere il simbolismo che esprime l’esperienza d’ordine vissuta dal popolo
di Israele. Questo limite – a sua volta – non è tuttavia dovuto a una semplice
dimenticanza, ma a una determinata visione ideologica della realtà che influenza
con decisione il modo di fare ricerca. La prospettiva voegeliniana, a differenza
di quella di Wellhausen, si focalizza sul riconoscimento del mistero della storia e
dell’essere: essa – in particolare – nasce proprio dalla partecipazione dell’autore
stesso a quel mistero, partecipazione storicamente segnata dall’appartenenza al
popolo giudaico-cristiano. È proprio per questo motivo che Voegelin apprezza
maggiormente il metodo della storia delle tradizioni, del quale i maggiori esponenti sono Ivan Engnell e Gerhard von Rad. Questi ultimi, infatti, raccontano la
formazione della narrazione biblica attraverso la tradizione invece che attraverso
l’attività letteraria di autori ben definiti e riconoscono il particolare carattere della
storia delle tradizioni, in quanto distinta dalla storia pragmatica. Accanto alle luci
presenti nell’analisi proposta del pensiero voegeliniano, il relatore ha riscontrato
anche la presenza di alcune ombre: la scuola prediletta da Voegelin, infatti, soffre
di un pesante limite riguardante l’identificazione delle fonti del Pentateuco (ossia
la presenza di quattro documenti completi che percorrono tutto il Pentateuco)
e i loro legami interni che eredita dalla scuola documentaria senza mai metterla
in dubbio. Voegelin, come filosofo della storia, all’interno di un’opera che pretende di tracciare la storia dell’ordine, avverte la necessità di tracciare una storia
pragmatica di Israele che gli permetta di fissare almeno le tappe fondamentali di
sviluppo del pensiero israelitico: questa ricostruzione viene rinvenuta nel modello di Wellhausen, anche se leggermente modificato da von Rad. Quell’immagine
storica oggi non è più accettata, tuttavia a questo modello non ne è ancora seguito
un altro, in tal senso – ancora oggi – non si può ancora parlare di una storia pragmatica alternativa.
Philosophical News
CONVEGNI
163
Al termine delle relazioni è seguito un acceso dibattito, dal quale è emerso un
rinnovato interesse nei confronti dell’opera voegeliniana, che – per la sua originalità, ricchezza e profondità – merita un attento studio multidisciplinare e pluridisciplinare, capace di portare alla luce significati ancora inesplorati, che finora non
sono emersi in modo adeguato forse perché quest’opera è stata abbondantemente
in anticipo rispetto ai tempi.
Alessandra Gerolin
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
Quale esperienza per la filosofia della religione? Due giornate seminariali al Centro Studi del Fenomeno Religioso di
Verona
Fondazione Centro Studi Campostrini – 27-28 gennaio 2011
Si è da poco costituito presso la Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona il Centro Studi del Fenomeno Religioso.
Votato tanto alla ricerca quanto allo scambio e alla comunicazione delle conoscenze sulle forme di religiosità contemporanee, il Centro si smarca dall’approccio prevalentemente storico e/o apologetico proprio della gran parte dei centri di
ricerca religionistici presenti in Italia. Oltre all’attenzione privilegiata per le forme contemporanee di religiosità, che lo spinge a impegnarsi in un tipo di ricerca
essenzialmente interdisciplinare, esso si caratterizza per l’interesse verso tutte le
religioni esistenti, articolandosi così anche in un lavoro comparatistico. Questo
orientamento di ricerca, contemporaneista, comparatista e interdisciplinare, non
rafforzerebbe davvero questo particolare settore di studi religionistici, oggettivamente più debole in Italia rispetto ai più solidi settori storico e apologetico, se non
fosse supportato da un’approfondita indagine teorica. Per questo motivo il Centro
Studi del Fenomeno Religioso ha pensato di affiancare al suo lavoro in “scienze
delle religioni” un’attenzione privilegiata alla “filosofia della religione”.
Anche la metodologia di lavoro del Centro è relativamente innovativa. Oltre a
un’attività editoriale regolare, esso punta particolarmente al coinvolgimento e la
valorizzazione delle leve più giovani della ricerca italiana. È a loro che il Centro
affida la gestione di progetti di ricerca annuali o biennali mirati alla realizzazione
di un lavoro monografico o collettivo. In quest’ultimo essi possono esporre in un
primo momento una tesi teorica originale su una tematica precisa, da sottoporre
in un secondo momento al vaglio del dialogo con gli studiosi specializzati nella
tematica stessa. Questo secondo momento viene elaborato attraverso degli incontri
seminariali presso il Centro a Verona che costituiscono un aspetto fondamentale
dell’attività di ricerca del Centro stesso. Questo investimento sull’attività seminariale è motivato dalla convinzione che l’avanzamento della ricerca, oltre allo studio
testuale ed individuale, passa necessariamente attraverso il confronto pubblico dal
vivo e la discussione filosofica.
In questo contesto, il settore di ricerca di “filosofia della religione” ha inaugurato le sue attività di studio con un progetto che propone una riflessione di ampio
respiro sulla filosofia delle religione stessa. Il progetto inaugurale non poteva non
intercettare anche alcuni aspetti metodologici che investono lo statuto da sempre
discusso della filosofia della religione in quanto disciplina.
Philosophical News
CONVEGNI
165
Quale nozione costituisce un crocevia tra quelle potenzialmente molto distanti
tra loro di “filosofia” e di “religione”? Una proposta interessante è indubbiamente
la nozione di “esperienza”. Infatti, da una parte essa sembra un dominio di legittima indagine per la filosofia, che con quella sfida la sua declinazione esclusivamente
concettuale, tradizionale spina nel fianco per la coordinazione di filosofia e religione. Dall’altra, per quanto discutibile, sembra difficile negare che della religione o
del religioso non si dia alcuna esperienza e che la religione e il religioso non sia per
l’uomo largamente una questione di esperienza.
Di qui nasce il progetto “Esperienza e filosofia della religione a partire da Jean
Héring”, che muove dalla traduzione del prezioso testo di Jean Héring Phénoménologie et philosophie religieuse del 1925 come Fenomenologia e religione, a cura
di Giuseppe Di Salvatore (con una prefazione di Roberta De Monticelli, Edizioni Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona 2010). La scelta di approcciare
la questione dell’esperienza a partire dalla proposta di Héring è motivata dalla
centralità assoluta della nozione di “esperienza” nel testo del filosofo della religione strasburghese. Questo testo, inoltre, fa leva su una particolare declinazione
dell’esperienza proprio per realizzare una riformulazione originale della filosofia
della religione. In costante dialogo con la riflessione filosofica di Max Scheler,
Héring tenta la strada che incrocia la fenomenologia husserliana e la filosofia della
religione, nello sforzo di sorpassare l’alternativa tra un approccio positivista e uno
spiritualista alla religione. Ora, non è senza una punta di sconforto che ci si trova
costretti a constatare come la nostra epoca ci metta sempre più dinanzi a quella
stessa sterile distinzione tra positivismo e spiritualismo, pur se in forme culturali
diverse da quelle dei primi decenni del XX secolo. Sembrando quindi doveroso
registrare una sorta di regresso culturale rispetto agli stimoli e alle proposte elaborati durante tutto il XX secolo (spesso appunto per sfuggire a quella dicotomia),
la pubblicazione del saggio di Héring non vuole solo fornire un’ispirazione generica, o uno spunto di riflessione, ma si presenta immediatamente con una funzione
militante e attualissima, nonostante gli ottantacinque anni che ci separano dalla
redazione del testo.
La lucida analisi filosofica di Héring risulta così per più di un aspetto un esercizio fecondo per la filosofia della religione contemporanea, perché la richiama a
una rinnovata riflessione su di sé e sul suo statuto moderno. E la sua riformulazione
fenomenologica sembra offrirci gli strumenti concettuali per prendere sul serio la
specificità della religione e del religioso, senza ridurla a paradigmi teorici sterili e
antiquati (ad esempio quelli positivisti e spiritualisti) estranei al regime di pensiero “speciale” a cui la realtà della religione e del religioso spinge la filosofia della
religione.
Questo tentativo di restituire filosoficamente la specificità della religione e del
religioso passa, nella proposta fenomenologica di Héring, attraverso la messa a
fuoco dell’importanza di considerare la religione e il religioso come fenomeni. Insistere sulla nozione di “fenomeno” significa mettere al centro il fatto della religione
e del religioso: il fatto che appare, ma anche il fatto storico, e ancora il fatto in
quanto inaudito, ovvero il fatto indipendentemente da ogni teoria della religione
e del religioso. Inoltre, “fenomeno” significa anche mettere al centro il vissuto re-
166
CONVEGNI
Philosophical News
ligioso e della religione, dunque affermare l’interesse della realtà dell’esperienza
religiosa – ed eventualmente l’interesse di un importo di conoscenza implicato in
quella esperienza. Ma l’aspetto più originale di questa attenzione per la nozione
di “fenomeno” è catturato dalla sua dimensione propriamente fenomenologica. Il
testo di Héring costituisce uno dei primi tentativi di mettere in luce il senso preciso
di questa dimensione: secondo lui, le regole e i criteri di analisi del fenomeno religioso non sono dettati esclusivamente da chi lo analizza come un oggetto di studio,
ma sono dettati anche dal fenomeno religioso stesso, di cui quindi si apprezza la
misura in cui esso in parte impone, o propone, le regole per la sua lettura.
È con tutto questo bagaglio problematico e propositivo che si è pensato di rinnovare la domanda filosofica sull’esperienza per la filosofia della religione e insieme sulla filosofia della religione stessa. Cercando di accogliere le prospettive più
diverse presenti nella filosofia della religione italiana è stata dunque sottoposta a
dodici professori che si occupano prevalentemente di filosofia della religione la
domanda “Quale esperienza per la filosofia della religione?”. Nella due giorni di
incontro seminariale organizzato dal Centro Studi del Fenomeno Religioso a cura
di Giuseppe Di Salvatore, incontro che si è tenuto a Verona il 27 e 28 gennaio 2011
presso la Fondazione Centro Studi Campostrini, i professori hanno risposto rispettando la richiesta di un impegno prevalentemente teorico e originale. Invertendo
i ruoli e imitando la struttura dell’universitas parigina medievale, le tesi originali
dei professori sono state messe sul banco degli imputati e discusse criticamente dai
più giovani allievi. In questo modo dodici giovani commentatori hanno posto domande critiche ai professori aprendo poi la discussione generale. Questa formula
seminariale forse inusuale ha prodotto un risultato di ricerca di alta qualità, proprio in quanto largamente basato su una discussione filosofica vera – di cui forse si
potrebbe lamentare in Italia una certa mancanza, peraltro a fronte di una quantità
e qualità di risorse filosofiche particolarmente vivaci. La discussione, inoltre, si è
arricchita di una tavola rotonda sul testo di Héring Fenomenologia e religione.
Non si ha intenzione di produrre qui un sunto critico di quanto è stato discusso,
anche perché il dibattito particolarmente acceso si è spinto più di una volta su territori filosofici di grande spessore, dinanzi ai quali è più fruttuoso lasciare la parola
difficile pronunciata in forma di domanda risuonare nella vertigine del pensiero,
invece di voler chiudere in fretta qualche frase con uno sforzo di sintesi destinato
a essere maldestro. Né si fornirà un resoconto dettagliato dei singoli interventi, dal
momento che presto sarà possibile leggerne una versione scritta e pubblicata. Si
tratterà dunque solo di anticipare qualche problematica emersa nei due giorni di
incontro seminariale, che sarà qui avanzata in forma puramente interrogativa e interlocutoria attraverso un’appropriazione libera e personale delle singole proposte
teoriche e soprattutto della discussione che quelle hanno indotto.
Come ha ricordato con acutezza Francesco Ghia, solo nel 1907 la Pascendi dominici gregis del papa Pio X accusava proprio la nozione di “esperienza religiosa”
come inappropriata perché pericolosamente tendente a un’interpretazione universalistica del religioso, la quale avrebbe fatto travalicare al religioso stesso i limiti del
Philosophical News
CONVEGNI
167
dominio cristiano cattolico definito dalla rivelazione. Con questa accusa emerge il
problema di sottintendere la nozione di esperienza come propria di una dimensione “umana” nel senso antropologico del termine. Ma anche, allo stesso tempo, il
problema di sottintendere che la dimensione antropologica necessariamente confligga con la dimensione rivelativa. Si tratta di “problemi”, qui, perché sembra legittimo porsi la domanda se l’esperienza, ancor prima di essere definita immediata
o mediata (da conoscenza o riflessione concettuale), abbia essa stessa una funzione
di mediazione tra una considerazione antropologica o anche psicologica della religione e del religioso e una considerazione che presuppone la rivelazione (di Dio,
del divino, del sacro). Questo eventuale ruolo di mediazione potrebbe essere favorito proprio dallo statuto particolarmente complesso della nozione di esperienza
in generale: radicata nel vissuto individuale ma allo stesso tempo necessariamente
aperta all’evenienza di qualcosa di radicalmente contingente per l’individuo stesso,
il quale di fatto finisce per essere da quello costituito. Chi esperisce è qualcuno che
fa qualcosa, ma allo stesso tempo è qualcuno perché esperisce.
Muovendo da questa intrinseca ambivalenza della nozione di esperienza non
si dovrà leggere nell’esperienza religiosa un caso particolarmente esemplare per
l’esperienza in generale, dal momento che la specificità religiosa dell’esperienza
sta anche proprio nell’ambivalenza di quanto nell’esperienza religiosa si esperisce?
Infatti, non è il religioso stesso intrinsecamente ambivalente in quanto estraneo e
tremendo da una parte, seducente e affascinante dall’altra? Se chi esperisce è in
generale sempre attivo e passivo allo stesso tempo (forse nel senso più preciso di
“attivamente passivo” – cosa su cui molti convengono) non è allora questa ambivalenza particolarmente evidente nel caso dell’esperienza religiosa?
Ma interrogando più a fondo, se questa particolare solidarietà sembra stabilirsi
tra la struttura, la fenomenologia dell’esperienza e quella dell’esperienza religiosa,
ciò non rimanda forse ad un’altra solidarietà, più tecnicamente fenomenologica,
che può essere istituita tra fenomeno in generale e fenomeno religioso? Infatti,
non mostrano questi ultimi due lo stesso carattere di irriducibilità? Irridicibilità a
spiegazioni appunto riduttive, che snaturerebbero in senso naturalistico, oppure
concettuale-razionale, la specificità del fenomeno religioso come esperienza della
religione e del religioso.
Questa irriducibilità si è imposta storicamente con l’affrancamento della religione e del religioso, rivendicato nella sua autonomia, da spiegazioni esclusivamente razionali. Tale affrancamento autonomista non ha preso solo la forma della
separazione della religione dalla filosofia, ma anche la forma dell’istituzione di una
filosofia della religione come disciplina “speciale” – analogamente a come la metafisica speciale si distingueva in epoca medievale dalla metafisica generale. Allora
l’irriducibilità fenomenologica dell’esperienza religiosa non dice forse in maniera
esemplare la specificità problematica di una filosofia della religione che non riduce
la religione alla filosofia “generale” ma fa della religione il problema della filosofia
che è chiamata a divenire “speciale”?
La lettura problematica della filosofia della religione come filosofia speciale è
forse un fatto storico prima che teorico, un fatto storico che pare impensabile
168
CONVEGNI
Philosophical News
senza il fatto storico della secolarizzazione, in un certo senso legato a quello della dimitizzazione. La tradizionale tematica della secolarizzazione mette in risalto anch’essa un’ambivalenza intrinseca alla sua inaggirabile storicità – che ha per
esempio poderosamente segnato la storia di tanta teologia e filosofia della religione
protestante nella modernità (da Sebastian Frank a Ernst Troeltsch, passando ovviamente da Kant e Schleiermacher, per approdare infine alla rivoluzione e radicalizzazione “dialettica” di Karl Barth e compagni). Si tratta qui dell’ambivalenza del
positivum storico – quindi della religione più che del religioso: la religione è oggetto di una considerazione oggettivante propria delle scienze esatte da una parte (che
porterebbe a parlare esclusivamente di una “filosofia delle religioni”), dall’altra è
fatto contingente la cui evenienza scardina ogni tentativo di oggettivazione dal momento che presenta essa stessa un’oggettività che si impone come fatto primitivo
incommensurabile – tipicamente la rivelazione.
Sotto forme diverse è stata spesso posta la questione, nell’incontro seminariale,
di riformulare questa ambivalenza del positivum, proprio nella misura in cui esso
inside la specificità dell’esperienza. Allora, la positività dell’esperienza religiosa
significa, certo, che la filosofia ne può parlare oggettivamente, sottolineandone
l’eventuale struttura a priori, ma significa anche, sempre e necessariamente che di
essa se ne può parlare solo nella misura in cui si è già fatta proprio quell’esperienza.
Quest’ultima circolarità tra l’esperienza religiosa e la sua indicibilità, pertanto, da
una parte è intrinseca all’ambivalenza storica della positività della religione e del
religioso, che costituisce la “specialità” della filosofia della religione come problema dinanzi all’autonomia irriducibile della religione e del religioso in regime di
secolarizzazione. Dall’altra, questa circolarità non è nient’altro che un modo di
dire proprio l’irriducibilità fenomenologica del fenomeno religioso – fenomeno
religioso che dunque declina ancora una volta proprio quell’autonomia irriducibile della religione e del religioso in regime di secolarizzazione che la filosofia della
religione “problematica” è chiamata a pensare.
Solo nel quadro della complessità qui espressa di ambivalenza, circolarità e irriducibilità dell’esperienza religiosa, andrà allora coniugata ogni formulazione di
questa esperienza in termini di interiorità – termini, quindi, chiaramente non psicologici.
Non è dunque un caso che nell’incontro seminariale la questione dell’irriducibilità dell’esperienza religiosa ha costituito insieme la spina nel fianco e lo stimolo
fecondo di discussione, tanto per la nozione di esperienza quanto per quella di
filosofia della religione stessa.
In una prima lettura, questa irriducibilità è spina nel fianco per quanti ritengono
che l’esito tautologico a cui si perviene parlando di esperienza religiosa sia un vizio
capitale che intaccherebbe la comunicabilità filosofica dell’esperienza stessa, ovvero che intaccherebbe la filosoficità della filosofia della religione, la quale sarebbe
così necessariamente, in un certo senso, solo filosofia religiosa. Questo senso di
“filosofia religiosa”, qui, viene considerato come uno spauracchio per la filosofia
della religione perché si intende in essa non semplicemente il fatto che si deve presupporre il religioso perché se ne parli (questa resta ovviamente una condizione
Philosophical News
CONVEGNI
169
necessaria e inaggirabile per poter parlare di qualcosa di specifico in filosofia della
religione!), ma il fatto che ci si deve collocare all’interno del religioso accettando
che quello solo detti le regole della sua ricezione filosofica e soprattutto che faccia
questo in maniera esaustiva e/o determinata.
In una seconda lettura, invece, l’irriducibilità dell’esperienza religiosa costituisce uno stimolo fecondo per quanti sottolineano, appunto, come non si possa
prescindere dall’assunzione del religioso nella sua specificità e autonomia, ovvero
nella misura in cui è il religioso a dettare le regole della sua ricezione filosofica.
Questa posizione lascia aperta la possibilità che la filosofia della religione si dica
ancora “filosofia religiosa”, ma in un senso diverso da come prima inteso, cioè senza ammettere che la filosofia della religione debba abdicare alla sua filosoficità. Ciò
è possibile perché la ricezione delle regole dettate dall’esperienza stessa è filosofica
nella misura in cui o quel dettato non è esaustivo e/o determinato, o è comunque
filosoficamente che quel dettato viene recepito, per quanto questo significhi rimettere in discussione, allargare e parzialmente modificare i limiti interni della filosofia
stessa.
Forse questa doppia lettura dell’irriducibilità dell’esperienza religiosa secondo
un’altrettanto doppia interpretazione della filosofia della religione come filosofia
religiosa tocca uno degli snodi fondamentali della discussione filosofica emerso nei
due giorni di lavori seminariali. Particolarmente la seconda lettura, ovvero considerare quell’irriducibilità come stimolo fecondo e non come spina nel fianco, pare
a miei occhi una sfida ardita e degna di essere colta dalla filosofia della religione,
anche perché significa al contempo rivendicare la filosofia della religione così sfidata come a sua volta una sfida alla filosofia stessa.
Nell’ambito di questa specifica interrogazione sulla ridefinizione della filosofia
propria della filosofia della religione, è stato ampiamente discusso il ruolo che giocano rispettivamente l’ermeneutica, la metafisica e la fenomenologia – come anche
la loro relazione all’interno della filosofia della religione.
È l’ermeneutica un atteggiamento interpretativo che dipende comunque da una
previa oggettivazione del suo oggetto di interpretazione, o non è essa piuttosto
l’atteggiamento che meglio intercetta la specificità dell’oggetto entrando nella sua
logica (per quanto paradossale possa essere) e quindi facendo fare un “passo indietro” alla filosofia stessa? In questo secondo caso il passo indietro della filosofia
corrisponderebbe al passo indietro che anche la religione fa, egualmente rispetto alla pretesa del possesso della verità. La filosofia della religione direbbe allora
nient’altro che la complementarietà di filosofia e religione nella loro differenza e
reciproca autonomia?
Questa strategia “negativa” dell’ermeneutica appare opposta a quella tradizionalmente “positiva” della metafisica, che invece assume pienamente il compito di
rendere conto della verità della religione e del religioso nell’esperienza che se ne
fa. Ma quale è quella metafisica che così facendo riesce a evitare di applicare alla
religione e al religioso categorie concettuali estranee alla sua essenza fenomenologicamente irrudicibile? Non è solo in quella crisi della metafisica storicamente
legata alla vicenda della secolarizzazione che si può evitare tale applicazione final-
170
CONVEGNI
Philosophical News
mente troppo concettualista? Certo, la grande tradizione occidentale e soprattutto
medievale della metafisica presenta un ampio spettro di varianti che sicuramente
non si riducono alla soluzione concettualista propria del teismo filosofico e di molta teologia razionale. Ad ogni modo, almeno si può convenire sul fatto che la metafisica utile per la filosofia della religione problematica non può non assumere la
sfida dell’ambivalenza del positivum della religione e del religioso, la quale implica
in sé di accettare anche la sfida di assumere la specificità irrudicibile della religione
e del religioso.
In assonanza con molto strumentario operativo di questa metafisica sembrano
porsi molte delle posizioni di filosofia della religione espresse nell’ambito della
filosofia analitica contemporanea. Di particolare interesse sono le sottili analisi che
rivalutano l’importo della dimensione epistemica (ovvero riferita alla credenza)
dell’esperienza religiosa, che pure non si vuole esaustivo per questa stessa esperienza. Beneficia la credenza di una garanzia sulla base dell’esperienza? Oppure
ha la credenza un supporto puramente evidenziale? Queste domande non interrogano propriamente il correlato oggettivo della credenza: dell’esperienza viene
considerata non tanto la sua verità oggettiva quanto piuttosto la sua struttura presentazionale. Significa questo che l’indagine sulla dimensione epistemica dell’esperienza dice dell’esperienza meno la sua verità e più la sua veridicità, o ancora la
sua pretesa alla verità? Insomma, la relazione di credenza ed esperienza disegna
forse un territorio intermedio tra quello meramente doxastico – sempre esposto
alla critica di individualismo – e quello pienamente conoscitivo – che richiederebbe la piena assunzione della questione della verità, chiaramente al di là di una sua
formulazione ristretta in termini di congruenza?
Ugualmente in una posizione intermedia sembra collocarsi il ruolo puramente
descrittivo della fenomenologia, la quale nei limiti della sola descrizione rivendica
comunque la fedeltà alle cose stesse e la precisione nell’aderire all’essenza specifica,
individuale, del fenomeno descritto. Esercizio di attenzione e di ascolto, più che di
definizione e spiegazione, la postura fenomenologica sembra particolarmente adeguata a rendere conto filosoficamente della specificità irriducibile dell’esperienza
religiosa. Ma non implica questa postura una necessaria interrogazione sui limiti
idealisti dell’operazione di riduzione che sola è capace di veicolare appieno la suddetta specificità irriducibile? La fedeltà alle essenze individuali permette davvero
di considerare l’operazione di riduzione come un problema metafisico esterno alla
fenomenologia (un problema meta-fenomenologico), oppure esso va considerato
necessariamente un problema di cui la fenomenologia stessa deve farsi carico? In
questo secondo caso, sono questi limiti idealisti anche dei limiti rispetto all’impegno realista che invece l’indagine metafisica si assume esplicitamente quando si dà
il compito di rendere conto della verità dell’esperienza irriducibile? E quindi non
sono finalmente, e paradossalmente, dei limiti per lo stesso compito di descrizione
da parte della fenomenologia che vuole andare appunto alle cose stesse? Oppure è
la metafisica a continuare ad assumere nel suo compito di indagine della verità un
realismo ingenuo ignaro delle condizioni inaggirabili proprie di qualsiasi esperienza che si vuole chiamare tale? Certo, tocchiamo qui problemi che investono, sì, il
ruolo della filosofia dinanzi all’esperienza religiosa, ma che forse non sono proble-
Philosophical News
CONVEGNI
171
mi specifici dell’esperienza in quanto esperienza religiosa. E ad ogni modo mi pare
che i limiti della fenomenologia, per quanto eventualmente riconosciuti come tali,
non confliggano con gli intenti della metafisica, ma lascino aperta la compatibilità
tra le analisi fenomenologiche e quelle metafisiche.
Altra strategia ancora sembra quella che considera questi limiti della fenomenologia non come un vizio ma come una virtù: una virtù necessaria e intrinseca
all’esperienza religiosa nella sua irriducibilità. Si apre qui la possibilità di una terza
lettura dell’irriducibilità dell’esperienza religiosa: né spina nel fianco della filosoficità della filosofia della religione, né stimolo fecondo per la filosofia in filosofia
della religione, l’irriducibilità dell’esperienza religiosa significherebbe l’esibizione di un potenziale dissidio disputabile ma inconciliabile tra esperienze. Questo
dissidio non sarebbe allora foriero di un abbandono della filosofia né di una sua
ridefinizione, ma dell’attestazione di uno spazio radicalmente altro rispetto alla
filosofia, lo spazio incolmabile del dissidio. Questo spazio del dissidio si dice come
spazio dell’alterità stessa, in particolare dell’alterità dell’altra persona, essendo riconosciuta l’esperienza irriducibile come intimamente propria, personale. Questo
è lo spazio dell’intersoggettività come non fondabile sull’interoggettività e allora,
forse, del dialogo e della comunicazione, in quanto già sempre necessariamente
etici, perché l’alterità vissuta nell’irriducibilità della propria esperienza è già accusa
che convoca colui che esperisce ad una disponibilità e ascolto assoluti.
Ma allora è forse questa una ridefinizione filosofica della filosofia della religione,
meglio: una ridefinizione della filosofia propria alla filosofia della religione dinanzi
all’irriducibilità dell’esperienza religiosa – così rientrando questa terza lettura nella
seconda? O l’alterità vissuta nell’esperienza irriducibile è in senso stretto alterità
rispetto alla filosofia, la quale dunque non può che declinarsi negativamente come
affermazione filosofica di resa delle armi filosofiche, dimostrazione (filosofica?)
dell’inconciliabilità filosofica del dissidio inerente all’assunzione piena dell’irriducibilità dell’esperienza – così rientrando questa terza lettura nella prima?
Per testimoniare la ricchezza della discussione di questi due giorni di incontro
seminariale andranno menzionate anche altre problematiche in parte direttamente
connesse con le questioni di fondo su cui si è fin qui insistito.
Il tempo non gioca un ruolo essenziale nella struttura irriducibile dell’esperienza
religiosa? Se si riconosce la portata specificamente personale dell’essenza individuale in gioco nell’esperienza religiosa in quanto irriducibile, non si deve riconoscerne automaticamente il valore etico ed esemplarmente morale? La dimensione
trascendente dell’esperienza religiosa (che è altro modo di dire l’irriducibilità di
cui qui si è parlato) non deve rimanere sempre in tensione con un fondo di pura
immanenza, che può essere detto come fondo di indistinzione rispetto alla hybris
maschile, concettuale e astratta della distinzione – in ciò polarizzando sacro e divino in una tensione inaggirabile per l’esperienza religiosa? Non è insita nell’ambivalenza del positivum qui spesso ribadita una seria considerazione del correlato
fisico e fisiologico dell’esperienza religiosa, come esso è sottolineato ad esempio
dalle neuroscienze? Ma allora, per altro verso, non è l’esperienza di un eventuale
172
CONVEGNI
Philosophical News
riduzionismo naturalista dell’esperienza religiosa una trasformazione nihilista di
quella stessa esperienza, che finisce così per aprire proprio alla trascendenza tipica
dell’esperienza religiosa stessa? O si tratta in quest’ultima operazione semplicemente di un avvitamento dialettico autoreferenziale e finalmente intellettualista?
Fin qui non sono stati menzionati filosofi e correnti specifiche, che pure sono
stati ampiamente chiamati in causa durante i lavori seminariali, nonostante il taglio
programmaticamente teorico che in qualche modo si è voluto restituire in questo
testo. Oltre ovviamente a Héring, è capitato di interloquire particolarmente con
autori classici come Troeltsch e la tradizione di teologia liberale protestante, Husserl, Scheler, Guardini, Welte, Zambrano, Alston, Swinburne, ma anche specialmente con alcune figure della tradizione italiana di filosofia della religione come
Pareyson, Caracciolo, Mancini e Olivetti.
Questi ultimi riferimenti risultano particolarmente preziosi per intravvedere
una continuità ma forse soprattutto un’evoluzione particolarmente interessante
della filosofia della religione italiana, che nel consesso veronese ha espresso tutte le
generazioni filosofiche italiane, da quella dei professori prossimi all’Emeritierung
fino a quella dei giovani dottorandi.
Sono stati relatori Andrea Aguti, Stefano Bancalari, Roberto Celada Ballanti,
Roberta De Monticelli, Adriano Fabris, Mario Micheletti, Marco Ravera, Stefano
Semplici, Sergio Sorrentino, Oreste Tolone e Silvano Zucal; commentatori Damiano Bondi, Giovanni Cogliandro, Marco Damonte, Francesco Ferrari, Ezio Gamba, Francesco Ghia, Marco Grosso, Edoardo Simonotti, Hagar Spano, Claudio
Tarditi e Francesco Valerio Tommasi; hanno partecipato attivamente, anche come
presidenti di sessione Emilio Baccarini, Pietro De Vitiis, Giovanni Salmeri. La tavola rotonda sul testo di Héring Fenomenologia e religione è stata introdotta da
due interventi di Roberta De Monticelli e Giuseppe Di Salvatore.
Giuseppe Di Salvatore
Centro Studi del Fenomeno Religioso
[email protected]
Recensioni
Libri
Antonio Allegra, Metamorfosi. Enigmi filosofici del cambiamento, Mimesis, Milano 2010. Un volume di pp. 172.
In un panorama costellato di trattazioni filosofiche prevalentemente specialistiche e settoriali, è piuttosto infrequente incontrare percorsi di analisi e riflessione
trasversali e ampi, che congiungano in modo originale ambiti disciplinari diversi
pur senza perdere le virtù della chiarezza e del rigore. Questo recente testo di
Antonio Allegra, dedicato al tema della metamorfosi intesa in senso ampio come
fenomeno che dice del cambiamento in modo peculiare, assomma felicemente in
sé tali caratteristiche.
La trattazione mette al centro il nucleo tematico di interesse per disporre poi
intorno ad esso in modo concentrico i contributi e le prospettive di diverse discipline, dalla metafisica classica a quella di matrice analitica, dalla filosofia della
biologia alla teologia, dalle teorie evoluzionistiche alla storia della letteratura. Il
cuore del lavoro è dunque un’analisi ontologica del fenomeno del mutamento e
della trasformazione, ma tale analisi si sostanzia attingendo continuamente a una
diversità di fonti e riferimenti che rendono lo svolgimento del discorso significativamente variegato e variabile.
Fin dalle prime battute l’autore mette in luce la direttrice fondamentale della
propria riflessione, esplicitando come questione cruciale quella del rapporto fra
cambiamento e identità, sostenendo l’impossibilità di pensare adeguatamente ogni
metamorfosi se non in riferimento a una qualche forma di continuità. Tale riferimento acquisisce tuttavia nella metamorfosi una particolare criticità poiché, a differenza degli altri tipi di cambiamento, essa mette a tema un mutamento radicale,
cioè un mutamento di forma. Se dunque è la forma stessa con cui le cose ci appaiono a modificarsi nelle metamorfosi, diventa urgente chiedersi come sia possibile
individuare un substrato oltre le forme, come si possa pensare la metamorfosi senza smarrirla in una mera molteplicità senza storia e senza processo.
La trattazione di Allegra prende le mosse dal riferimento ad autori classici, come
Ovidio e Dante, per cercare di cogliere come il modo di pensare e descrivere la
metamorfosi, soprattutto in epoca medievale, abbia in qualche modo fin da subito
espresso diffidenza verso l’idea di un cambiamento senza alcuna permanenza. Sotto le apparenze sempre mutevoli si nasconderebbe infatti sempre un soggetto che,
se venisse meno, non potrebbe essere raccontato nel suo sviluppo. In questo senso
la metamorfosi, intesa ampiamente, abbraccia molteplici forme di cambiamento,
ma deve anche poter essere distinta dalla morte, cioè dalla semplice fine di sviluppo di un organismo.
Philosophical News
RECENSIONI
175
Ambito di analisi privilegiato per circostanziare un concetto potenzialmente
così esteso è quello della biologia, innanzi tutto quello della biologia degli insetti e
degli invertebrati, nella quale si osserva immediatamente come la metamorfosi sia
un fenomeno universalmente diffuso. Mettendosi alla scuola dell’esperienza e delle scienze naturali, l’autore si interroga speculativamente sulla distinzione fra ciò
che permane e ciò che cambia, individuando uno snodo cruciale nel rapporto fra
predicati temporali e definizione dei soggetti del mutamento. In questa prospettiva
egli sottolinea la rilevanza del trovare parole che abbraccino appropriatamente
la medesima sostanza attraverso i vari stadi della sua trasformazione, per cui ad
esempio sarà logicamente più appropriato usare sostantivamente il riferimento al
termine ‘batrace’ per abbracciare l’evoluzione da girino a rana o il riferimento al
termine ‘essere umano’ per abbracciare l’evoluzione da bambino ad adulto.
La continuità del cambiamento è d’altra parte definita dal tipo di cosa di cui si
sta trattando. Per questo la comprensione tipologica di ciò che muta è fallibile e
provvisoria, e nondimeno cruciale. Il rapporto fra concetti unitari e realtà cangiante implica progressive correzioni e aggiustamenti, per cui solo l’esperienza prolungata nel tempo porterà a riconoscere un’unica identità che racchiude insieme
il bruco, la crisalide e la farfalla. D’altra parte non ogni cambiamento può essere
inteso come metamorfosi: in alcuni casi esso va oltre, in direzione di una maggiore
discontinuità, come nel caso della morte di un organismo.
Il tema teoretico più rilevante è qui quello del rapporto fra concetti e realtà:
estendere troppo o troppo poco i concetti porta a rinvenire nel reale solo essenze
oppure nessuna essenza. Per questo la strada suggerita è quella di costruire una
comprensione di ciascuna cosa a partire dalla presenza di regolarità attendibili
nel suo sviluppo, considerando tali regolarità come indici affidabili di una essenza
permanente e della sua ricorrente dinamica. Nel riferimento consapevole al contesto di pensiero della metafisica analitica, Allegra mira dunque ad affermare una
forma semplice e moderata di essenzialismo, intendendo con essenza ‘un certo tipo
di esistenza’ che si manifesta in sostanze che, esprimendo singolarmente un certo
genere, sono caratterizzate da determinati percorsi di mutamento piuttosto che da
altri. In altre parole, il genere sostanziale segna i limiti dell’esistenza dell’individuo
che le appartiene, per cui ogni entità appartiene essenzialmente al proprio genere
e questa appartenenza determina l’ambito delle sue trasformazioni nel permanere
dell’identità di fondo.
L’analisi non si ferma tuttavia all’ambito della biologia, e intraprende delle
esplorazioni verso altri territori del cambiamento. La prima di queste esplorazioni
avviene in senso teologico e mette a tema il concetto cristiano di resurrezione, proponendo la metamorfosi come una possibile chiave di lettura.
Anche in questo caso, si osserva, perché vi sia vera resurrezione è necessario
postulare che vi sia una forma di continuità nel cambiamento e che dunque la
morte sia in qualche maniera non una vera e propria fine seguita da un nuovo inizio, quanto piuttosto un passaggio all’interno di un unico processo. L’alternativa
sarebbe dover ammettere che il risorto altri non sia se non una copia, per quanto
nuova e accresciuta, del soggetto precedentemente deceduto. Il risorto non è infatti una copia identica del defunto, quanto piuttosto l’esito di un passaggio ad una
176
RECENSIONI
Philosophical News
ulteriore condizione di pienezza. Qui si colloca la rilevanza del concetto di anima
come principio di continuità, purché intesa come principio personale e specifico,
forma del corpo e non essenza generica o elemento pitagoricamente imprigionato
nel corpo come nella propria prigione.
Anche in questo caso il percorso analitico di Allegra si snoda attraverso un interessante excursus storico, mettendo a tema l’evoluzione del pensiero sulla resurrezione nel corso dei primi secoli del Cristianesimo, per muovere poi verso l’attenzione dedicata ad esso anche dalla tradizione alchemica, risalendo fino alla teologia
scolastica. Un percorso tortuoso e articolato, sempre comunque alla ricerca di un
principio materiale o spirituale di continuità, disegnando un’idea di resurrezione
intesa come esenzione dai processi di consumazione e corruzione tipici del corpo
stesso.
L’approdo dell’analisi, seppure senza pretesa di esaustività sul tema, è di fatto
un ritorno alle tesi già anticipate in precedenza. Le parti non costituiscono mai
l’identità del soggetto mutevole, l’identità è data piuttosto dall’individuo di cui
le parti sono componenti. Così anche nel caso della resurrezione il principio di
identità dell’individuo non può che intendersi di natura personale e non materiale.
La trattazione torna successivamente sulla direttrice principale della metamorfosi intesa in senso naturalistico e biologico.
Con le figure di Federico Cesi e Giordano Bruno, si ripropone agli albori della
modernità la ripresa innovativa dell’idea di una ‘grande scala dei viventi’ e della
non facile questione della loro classificazione. In seguito, a partire da un ‘600 che
riscopre significativamente Ovidio e con esso il fascino della metamorfosi e del
mutamento universale, diventa attuale la ricerca del cosiddetto anello mancante
fra le specie e del suo versante oscuro nel confronto con il mostruoso, inteso come
ibrido indefinibile e non collocabile.
Diventa così sempre più centrale la questione delle specie e della speciazione,
articolata secondo l’autore in due parti, fra loro in reciproca dialettica: la necessità di individuare le entità di base e la necessità di stabilire una tassonomia di
ordinamento fra tali entità. Il passaggio da Linneo a Darwin, in questo senso, è il
passaggio a una concezione ove il tema della trasformazione e della metamorfosi si
fa più pervasivo, al punto da rendere problematica la questione stessa dell’identificazione delle specie nel tempo. In quel contesto storico fu innanzi tutto influente
la visione lamarckiana, di carattere nominalista, secondo la quale esistono solo
esseri individui e una dinamica di lenta ma continua trasformazione di tutti essi.
La prospettiva nominalista sulla realtà portò logicamente a una rappresentazione
della trasformazione di tutto in tutto, nel decadere del valore delle classificazioni a
mere astrazioni. Anche in Darwin, d’altra parte, si riscontra tale tendenza non priva di contraddizioni, per cui da un lato ogni classificazione può essere a suo avviso
intesa solo come genealogica e dall’altro però l’evoluzione stessa viene concepita
come generatrice di specie identificabili. Ci si trova, dunque, da un punto di vista
speculativo, a un inatteso ritorno dell’antica questione degli universali.
L’autore osserva a riguardo come la questione della genesi della specie sia da
tenere distinta rispetto a quella della loro definizione: il processo di speciazione è
altro rispetto alla considerazione della specie come risultato di quel processo. In
Philosophical News
RECENSIONI
177
altre parole, le specie sì mutano, ma mutano quanto alla comparsa e scomparsa dei
soggetti che le istanziano, non quanto alle specie in sé, le quali restano definibili anche quando non vi fossero più soggetti a instanziarle in un dato momento storico.
Si tratta, dunque, di tenere intatta la distinzione fra types e tokens, considerandone
appropriatamente il rapporto, ma senza operare confusioni fra gli uni e gli altri.
Torna dunque a ripresentarsi, per approfondimenti successivi, la proposta teoretica di un essenzialismo moderato proposta fin dalle prime battute del libro
come linea di indagine. In questo quadro, l’esprimersi di una determinata essenza
determina l’appartenenza alla specie. Una specie può certo evolvere in un’altra,
ma questo non pone un problema insolubile al livello dell’individuo, il quale può
sempre provenire da una specie e al tempo stesso appartenere già a un’altra. Il
fatto che un discendente da una certa specie si trovi in realtà a esprimere un’altra
essenza, non è di per sé una critica radicale a una lettura essenzialista, a patto che
questa non si vincoli oltremodo a una concezione fissista delle essenze stesse. Tenendo ferma la distinzione fra piano epistemologico e ontologico della questione,
si osserva, è possibile dunque accettare il limite della conoscenza senza per questo
sacrificare radicalmente la possibilità di disegnare un quadro ontologico congruo.
Si inserisce qui la seconda esplorazione dell’autore oltre l’ambito della biologia,
questa volta in direzione delle suggestioni proprie dell’epoca della tecnica.
La trattazione si avvia qui dal manifesto cyborg della Haraway e dalla letteratura,
filosofica e non, collegata a quel tipo di prospettiva. Non solo filosofia, dunque ma
più ampiamente letteratura fantastica, cultura e opinione come ambiti privilegiati
in cui si esprime una sensibilità incline alla mutazione dell’umano oltre il biologico
e il naturale, intendendo tale processo come il logico proseguimento di quel rapporto di manipolazione trasformativa del mondo esterno da parte dell’uomo che è
la tecnica. Ecco dunque che il transumanesimo è affermato come vero umanesimo,
nel senso dello sviluppo di una virtualità che caratterizza l’umano profondamente,
come radicale contestazione dei paradigmi della “normalità” e della specie su tutti
i piani – biologico, sessuale, storico – in direzione di una dinamica dell’evoluzione
continua, una sorta di ripresa in chiave pragmatica e tecnica delle suggestioni filosofiche di Deleuze. Una vera e propria sfida ai confini fra umano e non umano, organico e tecnico, in direzione di una perenne trasformazione, senza fine e senza finalità.
Eppure, ricorda Allegra, nella metamorfosi la funzione meta non può essere mai
del tutto separata da quello che è la morphé: il puro e indefinito mutamento è in
questo senso inconcepibile. Il divenire può essere infatti tenuto distinto dal morire
solo a patto di mantenere un qualche plausibile riferimento ad una teleologia. Un
divenire puro, ateleologico non avrebbe in sé le risorse per giustificare tale distinzione. Anche l’opzione postmoderna, ma di sapore spinoziano, per una Vita-Zoé
indistinta e in continuo mutamento, senza inizio né fine, senza forma né traguardo mantiene comunque la necessità concettuale di riferirsi a un qualche sostrato
permanente, fosse anche identificandolo tout court con la materia della totalità in
trasformazione.
In questo contesto, il paradigma emergente di un rapporto fusionale e indistinto
con ciò che è altro rispecchia una crisi della soggettività per cui in fondo non esiste
più né sé né altro, e dunque non esiste più propriamente relazione fra i diversi.
178
RECENSIONI
Philosophical News
In chiusura la trattazione si rivolge a una interessante ricapitolazione delle tesi
chiave attraverso un’acuta messa a tema del rapporto fra forme viventi e metabolismo. Negli organismi viventi, osserva l’autore, emerge chiaro il primato della forma sulla materia. Il metabolismo è esattamente un processo che assume, muta ed
espelle materia per mantenere in vita la forma stabile dell’organismo. L’organismo
vivente è dunque autotelico in questo senso peculiare: nel mantenere e realizzare
se stesso continuamente, in una condizione di relativa stabilità della propria forma.
Per questo accanto al processo metabolico si affianca anche l’azione del sistema
immunitario: l’organismo mantiene la propria forma nel rapporto con l’altro da
sé ma difende anche la forma dall’aggressione di ciò che è alieno e lo destabilizza.
Non ogni mutamento è infatti conveniente alla forma, ma può essere anche per
essa nocivo e contraddittorio. È dunque necessario riaffermare la presenza di un
principio di identità attivo in ogni metamorfosi, che ne definisce senso e orientamento. E d’altra parte è anche importante osservare come il continuo cambiamento costituisca immancabilmente la trama e lo svolgimento stesso di ogni identità.
Nel complesso, l’intenzione filosofica che emerge dal testo è quella di un’ambiziosa e attuale riproposizione di alcune prospettive ontologiche radicate consapevolmente nella classicità, ma altrettanto consapevolmente pensate all’interno
di problematiche e categorie tipicamente moderne e contemporanee. L’ampiezza
delle fonti e la trasversalità interdisciplinare della riflessione sono in questo senso
l’aspetto più convincente della trattazione, che si caratterizza anche per una grande
vivacità di esempi e di riferimenti che rendono la lettura genuinamente avvincente e
comunque per lo più accessibile anche a un pubblico non strettamente specialistico.
Potrebbe forse rimanere in parte deluso il lettore che cercasse l’approfondimento specialistico sui singoli ambiti disciplinari toccati dalla ricerca. La natura
stessa della trattazione rende infatti non esaustivo sui singoli temi lo svolgimento
e la discussione delle posizioni filosofiche presenti sul campo. Non è d’altra parte
dichiaratamente questo l’intento dell’autore e di conseguenza anche tale aspetto
non può essere imputato come una rilevante mancanza nella qualità complessiva
di questo ottimo testo.
Paolo Monti
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
Giuseppe Bonvegna, Per una ragione vivente. Cultura, educazione e politica nel pensiero di John Henry Newman, Vita e
Pensiero, Milano 2008. Un volume di pp. 265.
La figura di John Henry Newman ha goduto di una certa notorietà in Italia a
partire dalla sua recente beatificazione, proclamata da Benedetto XVI lo scorso
settembre 2010 durante il suo viaggio in Inghilterra. Dietro questa felice ricorrenza
molte sono state le pubblicazioni d’occasione, atte a divulgare l’opera e la figura
del Cardinal Newman, la cui vicenda di convertito e la cui produzione culturale
hanno, in Italia, un pubblico troppo modesto.
Eppure vi sono testi e ricerche che non nascono specificamente per questa occasione e che hanno il merito di scandagliare in profondità la proposta culturale
del convertito oxoniense, facendone emergere l’originalità e fecondità teorica oltre
che la vasta conoscenza teologica e storica.
La ricerca che Bonvegna compie sul pensiero di Newman si segnala immediatamente per la sua attualità e unicità, in quanto rilegge il contesto e l’opera di
Newman dal punto di vista del suo pensiero politico e delle strutture culturali,
educative e antropologiche che ad esso sono legate.
Si tratta sicuramente di una prospettiva del tutto peculiare, unica in lingua italiana e rarissima anche nella bibliografia in lingua inglese.
Questa angolatura dell’opera newmaniana viene svolta con metodo sicuro e padronanza dei documenti da Bonvegna, che raccoglie in quest’opera i frutti di una
serie di meticolose ricerche sul tema svolte nel corso degli ultimi anni.
L’analisi ha da subito un andamento in qualche modo provocatorio, iniziando
il suo percorso da una frase raramente ripresa all’interno dell’analisi critica su J.
H. Newman, e tratta dalla sua Lettera al duca di Norfolk: «Noi siamo fedeli verso
la tradizione del quindicesimo secolo. Tutto questo veniva chiamato Torismo, e gli
uomini si gloriavano di questo nome; oggi viene chiamato Papismo e denigrato».
Questa continuità riscontrata da Newman tra torismo conservatore e dottrina della
fede cattolica sicuramente fece storcere il naso a più di un inglese, e qualche perplessità genera anche nel lettore contemporaneo.
Ebbene, Bonvegna indaga questo legame costruendo un articolato quadro che
da un lato svolge in maniera analitica l’evolversi della politica inglese, soprattutto
dopo le grandi riforme che si attuarono tra il 1828 e il 1833. Contemporaneamente
intreccia questi avvenimenti con la narrazione della biografia di Newman, letta
innanzitutto alla luce dei suoi tormentati rapporti con la Chiesa d’Inghilterra e con
l’ambiente sociale e culturale legato all’Università di Oxford.
Newman, infatti, nasce a Londra nel 1801 e trascorre la prima parte della sua
180
RECENSIONI
Philosophical News
vita come sacerdote anglicano, per la maggior parte del tempo ad Oxford, dove
viene a contatto sia con le tendenze riformatrici di marca evangelica sia con i tentativi messi in campo da alcuni esponenti del mondo anglicano di non perdere i
riferimenti sacramentali, liturgici e apostolici della Chiesa inglese.
Il testo di Bonvegna mette in luce sia il tribolato lavorio interiore del giovane
Newman, sia i motivi che portarono il fellow di Oriel ad aderire alla corrente “tradizionalista” in nome di una concezione della verità insieme teologica e politica.
Infatti egli vedeva la verità come la roccia cui aderire, i principi di fedeltà alla
tradizione e al messaggio biblico come donati all’uomo in modo che egli potesse
riconoscerli e non come un oggetto proposto alla capacità dell’uomo di modificarli
e ristrutturarli secondo il proprio arbitrio. Come Bonvegna illustra, è questo l’animo con cui il giovane Newman assiste alle profonde modifiche della Chiesa inglese
che il Parlamento di Sua Maestà introdusse a cavallo tra gli anni ’20 e ’30 del secolo
XIX ed è questo lo spirito che lo anima quando aderisce al progetto di difesa della
tradizione anglicana attraverso lo studio e la pubblicazione di testi dei padri della
Chiesa e di saggi di teologia che passano alla storia come movimento trattariano.
Come riportato da Bonvegna, Newman non si sente un politico, «questo però non
significa che, da un pulpito filosofico, teologico e storico, abbia perso l’occasione
di giudicare i fatti della politica» (p. 31).
Bonvegna ricostruisce quindi la lotta che Newman intraprese all’interno della
teologia e del mondo universitario inglese, ripercorrendo il difficile rapporto tra
la gerarchia anglicana e il potere regio fino a Guglielmo III (1688) e poi i rapporti
ancor più difficoltosi con il Parlamento inglese nel corso del XVIII secolo. Utilizzando ciò che Newman stesso riporta nella Lettera al duca di Norfolk, emerge chiaramente dal testo tutto il disagio dello studioso oxoniense di fronte all’avanzata apparentemente inarrestabile di un relativismo religioso che la politica non solo non
combatteva, ma al contrario sosteneva. In questo clima di apparente smarrimento
matura il torismo di Newman, che, nota Bonvegna, va correttamente compreso:
Il conservatorismo di Newman non va inteso innanzitutto come dottrina politica,
quanto piuttosto come principio di natura spirituale, che, a dispetto del termine (torysm), non può essere confuso con il partito tory, perché si fonda sulla consapevolezza
del fatto che la tradizione anglicana fa parte della ben più ampia tradizione cattolica
dell’Occidente (p. 32).
È questa la strada che conduce Newman a studiare e diffondere le radici patristiche del Cristianesimo, operando attivamente al Movimento di Oxford a partire
dal 1833 e rileggendo la storia dell’anglicanesimo come una lunga serie di contese
circa il tentativo dello stato di sottomettere la Chiesa inglese e di innervarla di dottrine calviniste e luterane, percorso che trova il suo compimento proprio nell’opera di Guglielmo III d’Orange.
La lotta di Newman per la riscoperta delle origini dell’anglicanesimo lo porta
a ripensare alla vita stessa anglicana come ad una Via Media tra protestantesimo e
cattolicesimo, capace di recuperare le verità dell’esperienza della Chiesa dei primi
secoli senza cadere nell’apparente servitù alla monarchia assoluta del papismo.
Philosophical News
RECENSIONI
181
Tuttavia tale conclusione viene attaccata da molti esponenti della stessa gerarchia anglicana e Bonvegna ci conduce a comprendere come, da questa delusione,
Newman maturi la convinzione di dover approfondire ancora meglio la natura del
Cristianesimo. Approfondisce quindi la disputa sul monofisismo ariano dei primi
secoli e comincia a comprendere come la confessione anglicana possa non essere
quella che traduce nella contemporaneità l’esperienza della fede e della comunità
dei Padri della Chiesa. Scrive Bonvegna:
La conversione di Newman al cattolicesimo romano fu il risultato dell’esercizio di
una ragione intesa come risposta a quelle circostanze nelle quali era possibile sentire
sinceramente l’eco della voce di Dio (e non come facoltà che decideva senza tener conto
della propria strutturale dipendenza dalla realtà, dalla storia e dal Mistero): ecco perché Newman cambiò confessione religiosa non soltanto senza rinnegare nulla della sua
battaglia in difesa della Chiesa anglicana, ma essendo profondamente convinto che quel
cambiamento si giustificava con la percezione del fatto che la Chiesa di Roma offriva non
tanto una via di fuga dalla tradizione, quanto la possibilità di viverla più autenticamente
(p. 71).
A partire dal 1839 comincia un profondo ripensamento della sua appartenenza
alla Chiesa inglese: finisce infatti nel 1841 la pubblicazione dei Tracts, i saggi con
cui anima insieme ai suoi amici il Movimento di Oxford, e si ritira a riflettere presso Littlemore a partire dal 1843. Al termine del suo cammino di ripensamento,
Newman passa alla Chiesa cattolica il 9 ottobre del 1845 e il neoconvertito parte
quindi alla volta di Roma per un periodo di studi e di meditazione; qui decide di
aderire alla congregazione dei Padri dell’Oratorio di San Filippo Neri e di portarne l’esperienza di nuovo in Inghilterra, fa ritorno nel 1847.
Bonvegna passa quindi a sviscerare la posizione del Newman cattolico, che investe il mondo della cultura e della politica inglese con tutta la sua preparazione,
profondità e capacità culturale ed educativa. L’autore comincia ad analizzarne le
prime produzioni apologetiche, costruite intorno alla necessità di difendere il cattolicesimo da una serie di accuse avanzate da personaggi vogliosi di pubblicità e di
facili guadagni, fino alla pubblicazione nel 1850 delle Lectures on certain difficulties
felt by anglicans in submitting to the Catholic Church, una serie di conferenze pronunciate per evidenziare quali siano le peculiarità del cattolicesimo e come esso
fosse in continuità con la ricerca del vero che il Movimento di Oxford aveva messo
in campo. Così Bonvegna rilegge la riflessione di Newman sia dal punto di vista
religioso che sociale, quando evidenzia come per il convertito di Oxford:
Bisognava oltrepassare la Manica e imparare dai Paesi cattolici; soltanto alla loro
scuola era possibile apprendere qual modo di trattare la persona che, riconoscendo fino
in fondo il primato delle dimensioni spirituali su quelle materiali, era all’origine di una
convivenza secondo Newman di gran lunga più umana delle società nate dalla Riforma
(p. 103).
La polemica di Newman non è tanto rivolta verso il mondo dei servizi o dei diritti
civili presenti nelle società cattoliche, quanto al fondamento antropologico cui que-
182
RECENSIONI
Philosophical News
ste dimensioni fanno riferimento. Bonvegna, infatti, nota come in Newman la preoccupazione sia duplice: da un lato difendere l’integralità della persona umana, non
omettendo alcuna dimensione dall’antropologia con cui legge il dato storico-sociale.
In secondo luogo, il convertito di Oxford non intende cedere dalla proposta di una
razionalità che non valuti solo gli aspetti materiali e quantificabili della convivenza
umana, ma che sappia invece valorizzare l’educazione della persona ad un rapporto
consapevole e adulto con Dio, rapporto che non può che avere una forma religiosa
strutturata e storicamente accessibile da parte di ogni persona. Tale modalità dell’incontro con Dio è stata decisa e posta da Dio stesso e coincide con la Chiesa cattolica.
La narrazione di Bonvegna investe quindi, nel terzo capitolo, una parte peculiare della vita e dell’opera di Newman, che coincide con la sua nomina a rettore della
neocostituita Università Cattolica di Dublino a partire dal 1851. Questo periodo
coinvolse il futuro cardinale in un lavoro assiduo e molto particolareggiato per la
preparazione, la cura ed il felice esito della proposta educativa e culturale dell’Università che gli viene affidata e che produce una grande delusione quando Newman
è costretto a dimettersi dal ruolo di rettore nel 1858.
Assieme a questo dato negativo, però, l’avventura di rettore universitario spinge
Newman a dare forma ad uno dei grandi capolavori sulla trasmissione della cultura universitaria, cioè l’opera L’idea di Università che viene a costituirsi come la
raccolta delle sue lezioni magistrali svolte all’interno e all’esterno dell’Università
Cattolica di Dublino per spiegarne i contenuti, gli scopi e l’orizzonte formativo nel
quale si inseriva questa istituzione.
Bonvegna ci aiuta a capire come il testo costituisca una tappa fondamentale nello sviluppo della concezione politica e sociale di Newman: infatti è a partire dalla
sua responsabilità educativa che Newman dettaglia come il compito di un’università non possa coincidere unicamente con l’accumulo di conoscenze specialistiche
o con la trasmissione di un modello sociale che equivale a quello del gentleman,
ma occorre che ogni disciplina collabori esplicitamente al percorso di scoperta che
il maestro e il discente fanno dell’ultima relazione tra la disciplina studiata e Dio
principio e fondatore di ogni razionalità. I contenuti trasmessi, se corretti, non si
chiudono in una semplice somma algebrica di nozioni, ma si aprono in una domanda di significato, cioè «il contrario dell’affannoso accumulo conoscitivo era un
atteggiamento molto simile a quello religioso, in quanto capace di dare significato
unitario alle conoscenze accumulate» (p. 140).
Educare, per Newman, coincideva con l’aprire, sostenere, incoraggiare la ricerca che il singolo intraprendeva del significato della realtà, investendo con questo
interrogativo l’intero spettro delle conoscenze ed offrendo la proposta cattolica
come luogo capace di far vivere l’esperienza di una coscienza unitaria del reale.
Bonvegna analizza con cura l’insieme delle opere che Newman compone a corredo
di questi discorsi, evidenziando gli strumenti efficaci di questa pedagogia: il rapporto personale tra maestro e discente, la prudenza nello studio e la cura della vita
spirituale, morale ed intellettuale di quanti vi sono impegnati a vario titolo.
È in questo contesto che Newman matura la battaglia culturale e politica per
l’insegnamento della teologia presso l’università: contro le tentazioni liberali di
escludere questa disciplina dagli insegnamenti universitari in quanto considerata
Philosophical News
RECENSIONI
183
frutto della coscienza del singolo e quindi impossibile da insegnarsi come scienza,
Bonvegna ci mostra che per Newman:
proprio in forza di questa sua diversità rispetto alla riduzione alla fisica e ad ogni prospettiva che volesse sottacere il suo occuparsi di Dio come creatore trascendente della
realtà, la teologia si configurava dunque come quella scienza nella quale non soltanto era
possibile parlare degli attributi di Dio, ma doveva trovare anche spazio la dimostrazione
razionale dell’esistenza di Dio (p. 164).
Nel quarto e quinto capitolo Bonvegna attraversa la riflessione non sistematica
che Newman matura intorno alle nozioni di “stato” e “storia”, compiendo un lavoro di infinita pazienza nel riannodare i fili dispersi nel corpus newmaniano su questi
temi per cercare di rendere accessibile quale fosse il quadro d’insieme che Newman possedeva e che utilizzava spezzandone l’unità negli strumenti che lui riteneva
più utili brandire per le sue battaglie. Queste pagine storiograficamente pregevoli
ci danno una visione a tutto tondo di Newman, impegnato contro un’immagine
di tolleranza resa equivalente all’incredulità, contro la secolarizzazione della vita
sociale, pronto a difendere l’autonomia della Chiesa dallo Stato fino al punto di
difendere il diritto della Chiesa a gestire in proprio un almeno minimo potere temporale. Bonvegna inoltre riprende il tema del “torismo” di Newman dandone una
lettura più profonda e in linea con la sua produzione culturale da cattolico:
il conservatorismo dei papi (cioè l’unico autentico), spiegava Newman, derivava dal
fatto che la Chiesa, essendo da sempre interessata a ricevere protezione da parte del potere civile, non sopportava l’anarchia, riteneva che la rivoluzione fosse un male, pregava
per la pace nel mondo e per la prosperità di tutti gli Stati cristiani e appoggiava la causa
dell’ordine e del buon governo (p. 201).
Diventa questo il metro con cui Newman giudica le scelte politiche del suo tempo
e quindi giudica anche le scelte della politica nella storia del Cristianesimo, che viene
da lui riattraversata con l’intento di scoprirne le movenze profonde e le aperture o
chiusure della coscienza dei singoli e delle società di fronte alla proposta cristiana.
L’opera di Bonvegna rilegge questi temi evidenziando come Newman ponga in
una ragione illuminata dalla fede la chiave ermeneutica per comprendere le scelte
e gli avvenimenti della storia come della politica del suo tempo.
Questo lavoro di ricucitura, insieme alla minuziosa ricostruzione storica delle riflessioni e degli episodi della vita di Newman, costituisce il valore aggiunto dell’opera di
Bonvegna, che ha il merito dell’originalità della prospettiva con cui guarda al convertito di Oxford, riproponendone la figura e la riflessione politica, teorica e pedagogica.
Naturalmente, in coda al testo è presente una ricca bibliografia primaria e secondaria, che danno strumenti di verifica seri e documentati delle tesi proposte
dal testo.
Gianni Bianchi
Università degli Studi di Bergamo
[email protected]
Gabriele De Anna, Causa, forma, rappresentazione. Una
trattazione a partire da Tommaso d’Aquino, Franco Angeli,
Milano 2010. Un volume di pp. 269.
Nel 2001 presso l’editore Il Poligrafo di Padova usciva il testo di De Anna dal
titolo Realismo metafisico e rappresentazione mentale. Un’indagine tra Tommaso
d’Aquino e Hilary Putnam, testo che non solo portava il pubblico italiano a conoscenza di un dibattito in corso presso gli analitici, ma che soprattutto mostrava
come il ricorso alla metafisica e all’ontologia di Tommaso potesse aiutare ad affrontare temi spinosi dell’epistemologia contemporanea. Esso, pertanto, oltre che presentare quella corrente denominata da John Haldane “tomismo analitico”, offriva
a essa un contributo originale e decisivo. D’altronde quel testo poneva con forza
l’interrogativo circa il nesso causale implicito in ogni forma di conoscenza, senza
però affrontare l’argomento direttamente.
Il libro pubblicato ora da De Anna era perciò atteso dagli studiosi del settore,
in quanto assolve proprio quei compiti là accennati. Restavano (1) da chiarire i
presupposti metafisici della causalità formale, (2) da proporre un’analisi della causalità fruibile nel dibattito contemporaneo e (3) da indicare se e come la causalità
formale può servire alle finalità della spiegazione tomistica della cognizione e, in
particolare, a rendere ragione della rappresentazione mentale. Questi tre punti costituiscono proprio la scansione del saggio: ai primi due vengono dedicate le prime
due coppie di capitoli e il terzo viene affrontato nel capitolo quinto, prima di una
breve conclusione, di una esaustiva bibliografia e di un utile indice dei nomi.
L’accurata introduzione si presenta come un’ottima guida in cui l’autore chiarisce
gli obiettivi intermedi che intende raggiungere in vista della tesi finale. L’incalzare delle dimostrazioni rende pressoché impossibile riassumerle. Ritengo pertanto opportuno limitarmi a presentare le tesi di ciascun capitolo, evidenziandone la progressione.
Il primo capitolo si sofferma sulla teoria ilemorfica, con particolare attenzione
alla distinzione tra forme accidentali e forme sostanziali e alla nozione di materia
intesa come principio di individuazione. Tali principi metafisici vengono utilizzati
nel secondo capitolo per affrontare la questione dell’intelletto umano e delle sue
capacità cognitive. La cognizione viene concepita come un insieme di abilità che
caratterizzano alcune forme di vita e che sono rese possibili grazie all’immaterialità
dell’intelletto, condizione perché i suoi contenuti (cioè le specie intelligibili) siano
universali. A questo punto è possibile, nel capitolo quarto, prendere in considerazione la teoria della causalità. Tommaso si rifà alla quadrupla distinzione aristotelica, arricchendola di numerosi elementi concernenti la relazione tra le cause
Philosophical News
RECENSIONI
185
e il loro rapporto con la nozione di spiegazione, che però non sono sufficienti a
renderla direttamente fruibile nel dibattito contemporaneo circa la filosofia della
mente. De Anna ne è consapevole e si impegna di conseguenza a sviluppare una
teoria della causalità, ispirandosi ai risultati metafisici dei primi capitoli, ma formulando un’analisi della causalità basata sulle condizioni INUS proposte da Mackie
(per le quali la causa è un congiunto insufficiente e necessario all’interno di una
condizione che è nel suo insieme sufficiente, ma non necessaria). La necessità di
questa mossa è dovuta al fatto che l’ontologia tomista è incompatibile con l’ontologia dei mondi possibili presupposta dall’analisi controfattuale che renderebbe
l’analisi più spedita, ma fuorviante. Il quarto capitolo insiste ancora sulla causalità,
soffermandosi sui relata causali, cioè su ciò che può essere causa ed effetto. Si tratta
qui di dar conto della possibilità causale delle sostanza immateriali, della natura
della causalità formale e dell’identità formale. Infine i risultati conseguiti in questi
ultimi due capitoli devono essere applicati alle conclusioni emerse nei primi due.
L’ultimo capitolo, il quinto, identifica nella causalità formale il nerbo della teoria
tomista della conoscenza e argomenta come l’identità formale tra mente e mondo
spiega le caratteristiche del processo di formazione dei concetti, senza comunque
trascurare il ruolo della causalità formale nel caso della percezione e del pensiero.
Riporto un solo passo che reputo particolarmente significativo, in quanto denuncia l’aporia presente nelle discussioni contemporanee a cui il libro intende dare
risposta: «il problema messo in luce dall’argomento della permutazione è che, per
quanto precisamente siano specificate le cause delle rappresentazioni, le teorie
causali non riusciranno mai a fissare i riferimenti delle rappresentazioni, in parte
perché ci saranno sempre connessioni causali devianti che soddisferanno tutti i
requisiti specificati, in parte anche perché l’identificazione attraverso i concetti
è più precisa e dettagliata dell’individuazione causale […]. La ragione di questo
problema, secondo Haldane, è che le teorie causali non considerano le relazioni
semantiche, che sono fondamentali per connettere il pensante all’oggetto pensato.
La nozione di forma diventa imprescindibile in questo contesto: è il fatto che un
certo pensiero e un certo oggetto siano formalmente identici che rende quel pensiero il pensiero di quell’oggetto. Tra tutte le connessioni causali responsabili per
l’accadere di una certa rappresentazione, le uniche rilevanti a livello semantico saranno quelle che daranno conto della forma del contenuto della rappresentazione.
La connessione causale, perciò, non potrà mai essere solo una forma di causalità
efficiente, ma dovrà implicare anche rapporti di causalità formale» (pp. 218-9).
Il rifiuto della riduzione della causalità alla causalità efficiente implica un rifiuto
dell’empirismo e del razionalismo, con effetti tanto devastanti quanto fecondi per le
principali teorie della conoscenza oggi presenti. Volentieri si paga questo scotto, se,
come mostra De Anna, è finalmente possibile prendere posizione sul tema dell’inerranza delle percezioni e dei concetti e sulla questione della consapevolezza riflessiva
legata all’intenzionalità. L’abbandono delle posizioni post-cartesiane e post-lockiane
implica un modo “nuovo” – aristotelico-medievale! – di concepire il pensiero che va
visto «come un atto dell’intelletto, atto strutturato secondo la struttura dell’oggetto
pensato. Una specie intelligibile, così, risulta essere un’abitudine dell’intelletto ad
agire in certi modi per riferirsi alle cose che instanziano quella specie» (p. 232).
186
RECENSIONI
Philosophical News
La tesi di De Anna risulta convincente e solleva interesse verso i due presupposti sul cui sfondo si muove l’intero libro: (1) il ricorso a Tommaso da parte dei
filosofi analitici può essere decisivo e (2) l’epistemologia, la filosofia della mente, la
metafisica e l’ontologia, sono ambiti fortemente interdipendenti e non ha più senso
tentare implausibili distinzioni settoriali. A fronte di tali aspettative il lettore è persuaso a pagare il costo metafisico delle tesi sostenute nel libro, perché, rispondendo a criteri di economia concettuale, risultano capaci di sostenere l’alternativa più
plausibile di una filosofia della conoscenza. Il realismo diretto, oggi, non solleva
più i sospetti suscitati fino a qualche anno fa; la sua versione aristotelico-tomista è
infatti compatibile con l’anti-realismo semantico proposto da Putnam.
Per quanto riguarda il metodo di De Anna, esso può risultare eccessivamente meticoloso, ma sempre necessario. Egli deve confrontarsi continuamente con gli autori
analitici che propongono tesi alternative alle sue, se vuole raggiungere uno dei suoi
scopi, cioè quello di inserirsi nel dibattito in corso: da qui il confronto serrato con,
tra gli altri, Davidson, Haldane, Hughes, Kenny, Kim, Kripke, Lewis, Lowe, Mackie,
Pasnau e Putnam. Il lento incedere dei ragionamenti e l’intreccio delle argomentazioni, solo apparentemente accidentali, accompagnano mano mano il lettore, anche
il meno avvezzo al linguaggio analitico. L’autore mostra una sensibilità e un equilibrio esemplari nell’interpretare il dettato tomista, usando sempre l’opportuna carità
interpretativa; nel distinguere la posizione di Tommaso dalle intuizioni ascrivibili a
una mentalità tomistica e solo compatibili con essa; nel fruire dei risultati della fisica,
della neurobiologia e delle neuroscienze; nell’usare esempi pertinenti ed esaustivi;
nel sintetizzare i risultati ottenuti prima di proseguire nel percorso proposto.
L’aver circoscritto l’argomento è un merito di De Anna, al quale non si può pertanto
imputare di non aver adeguatamente contestualizzato questo dibattito nelle discussioni
più ampie care ai tomisti analitici, quali il confronto con Wittgenstein che ha storicamente promosso la riscoperta di Tommaso, né tanto meno di non aver tenuto conto di
importanti esegeti analitici di Tommaso, quali la Stump. Anche l’essersi smarcato dal
prendere posizione circa la disputa intorno al naturalismo della sua posizione, risponde a condivisibili criteri di opportunità. Unica nota stonata la presenza di un eccessivo
numero di errori di stampa, a partire da un’anomala concentrazione nella nota 52 di
pagina 45, che farebbe pensare a imprecisioni di impaginazione, più che a refusi.
La lettura del libro è raccomandata ai cultori di Tommaso e ai filosofi analitici
studiosi di filosofia della mente, metafisica ed epistemologia (a cui è propriamente
dedicata, vista la collana in cui il libro è stato pubblicato), ma solo se disponibili a
mettere in questione gli assunti da cui ordinariamente partono e dai quali rischiano
di farsi ingabbiare. Chi teme di doversi spostare in un territorio nuovo della teoresi o dell’interpretazione storiografica farà bene a evitarlo. Al contrario studenti
e appassionati della materia dovrebbero vincere l’iniziale resistenza all’incedere
argomentativo, perché il distacco formale delle dimostrazioni cela la possibilità
di plasmare le proprie categorie concettuali e aprire nuove prospettive di ricerca.
Marco Damonte
Università degli Studi di Genova
[email protected]
Massimo Donà, Il tempo della verità, Mimesis, Milano 2010.
Un volume di pp. 398.
In questo testo Massimo Donà procede, con una serie di scandagli tematici in
parte differenziati ma coerenti, il lavoro teoretico avviato in opere come Sulla negazione (Milano 2004) e L’aporia del fondamento (Milano 2008), dalle quali quest’ultima dipende.
In sintesi, il tema del volume è il rapporto espresso dal titolo tra tempo e verità;
rapporto che, per Donà, è costitutivamente aporetico. Per meglio dire è aporetica
anzitutto la stessa verità, che nelle sue condizioni rimanda a un processo indefinito che esclude una fondazione metodica. È la determinatezza di qualsivoglia
proposizione o asserto teorico, detto altrimenti, che rimanda sempre alle proprie
condizioni, né può ambire a una fondazione assoluta (cfr. p. 28 ad es.). La pretesa,
originariamente greca, di una verità “eterna” si scontra, così, con tale struttura
logica; e sposa per converso la struttura della temporalità prospettatasi a partire
dal cristianesimo, in cui la totalità viene rotta quale eternità circolare infranta dalla
novitas radicale (cfr. p. 121 e 144).
Dunque all’eterno ritorno naturalistico subentra l’esperienza aporetica della rivelazione – che corrisponde all’essenza stessa della verità. D’altra parte, è la natura
stessa del tempo a rivelare la sua indeterminatezza, giusta la lezione agostiniana.
Per essa le dimensioni temporali sono distinte ma non si escludono tout court: il
presente si apre e determina nelle forme diverse del passato e del futuro.
In questo modo, mentre da un lato si sfugge dalla fuorviante tentazione di liberarsi dalla temporalità in favore dell’eterno, fuorviante nella misura in cui non fa
i conti con l’aporeticità che caratterizza allo stesso titolo tempo e vero, si afferma
anche la potenza della verità. Essa infatti è capace di rappresentare l’aporia fondamentale presente anche nella dimensione temporale. In questo senso l’intenzione
fondamentale del testo di Donà potrebbe essere riassunta nell’avvicinamento di
tempo e verità, di contro al loro tradizionale distacco; avvicinamento che ha luogo
non solo nel senso di una temporalizzazione del vero, ma simmetricamente, e in
maniera più originale, di una “veritatività” della temporalità. Avvicinamento, inoltre, che trova il proprio luogo emblematico e il proprio paradigma esemplare nella
tradizione teologica impegnata a pensare la verità e l’assoluto sub specie cristiana,
ovvero in forma assolutamente irriconciliabile con l’assolutizzazione/eternizzazione del determinato tentata dal pensiero di matrice greca (il quale, sarà bene notare,
ha una storia di successive e talvolta insospettabili incarnazioni che va ben oltre la
filosofia antica).
188
RECENSIONI
Philosophical News
Suggestivo dunque il tema fondamentale; e assai netta l’opzione teoretica, che
cerca di congedarsi dalla duplice ossessione della ricerca del fondamento e del
congedo dalla temporalità che segna indubbiamente una linea maggioritaria della
riflessione occidentale. Nutrita soprattutto della meditazione di Andrea Emo e della lezione della filosofia classica tedesca, la riflessione di Donà cerca di fare i conti
con questioni letteralmente fondamentali – sia pure risolvendole in una forma che
cerca di restare strutturalmente non-fondamentale e dialettica (in questo senso
la maggiore vicinanza ai classici dell’idealismo, soprattutto con una certa lettura
di Fichte, nonché con le pagine kierkegaardiane più pregne di densissimo sforzo
speculativo).
Al tempo stesso si tratta di un testo di ardua lettura, forse un po’ rapsodico
nell’esposizione che avrebbe guadagnato da una maggiore sistematicità e una maggiore cura stilistica.
Antonio Allegra
Università per Stranieri di Perugia
[email protected]
Roberto Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della
filosofia italiana, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2010. Un
volume di pp. 265.
Riuscire a rintracciare il filo rosso sotteso all’intricata vicenda della filosofia italiana non è cosa da poco, tuttavia questo è l’obiettivo che si prefigge la nuova opera
di Roberto Esposito. Impresa difficile, ma certamente ricca di possibilità qualora
la si portasse a compimento. Chi scrive, quindi, vorrebbe cercare di mostrare se,
e in che modo, l’autore sia effettivamente giunto alla meta, esplicitando alcuni dei
concetti che sono sembrati più meritevoli (o più ostici) durante la lettura.
La premessa che rimane sullo sfondo, ma comunque necessaria a comprendere
il volume, è il venir meno delle grandi strutture di riferimento della filosofia occidentale che potremmo riassumere, anche se in maniera un po’ grossolana, nei
tre cespiti rappresentati dalla filosofia analitica anglosassone, dal decostruttivismo
francese e infine dall’ermeneutica tedesca. É all’interno di questa situazione precaria che recentemente si è iniziato a parlare di una “Italian Theory”, esattamente
come qualche tempo fa si parlava di “French Theory”. La filosofia italiana sembra
tornare in auge, in particolar modo in territorio americano. Perché? Ovviamente
perché ci troviamo di fronte a un pensiero differente, con caratteristiche che lo
contraddistinguono: in opposizione con le tradizioni ricordate sopra, la filosofia
italiana si distanzia da quello che Esposito chiama “il primato trascendentale del
linguaggio”. Questa tematica non è soppressa, ma “contestualizzata”, e questo
risulterebbe chiaro analizzando quella variegata costellazione di protagonisti del
pensiero italico (per citarne alcuni: Macchiavelli, Bruno, Vico, Leopardi, Galileo,
Campanella, Croce, Gramsci) tutti accomunati dalla passione e dall’indagine sulla
relazione tra politica, storia e vita, che è poi quel legame “costitutivo” che rappresenta il “contesto” in cui il linguaggio è inserito. Ma non c’è solo questo: il
grande pensiero italiano non è mai stato una “filosofia dello stato” o, per essere
più precisi ci troviamo di fronte, secondo l’autore, a una filosofia che ha preso
sempre le distanze dai poteri costituiti, dalle istituzioni come lo Stato-Nazione e la
Chiesa. La storia della penisola è una storia di frammentazione ed è a causa di questo che il pensiero italico può essere definito, per dirla con Deleuze, una filosofia
“deterritorializzata”. Esposito sottolinea come questa caratteristica, in un’epoca di
globalizzazione, venga percepita più come una risorsa che come una mancanza. Lo
studioso che si accostasse alla tradizione di pensiero sorto in Italia scoprirebbe in
essa strumenti innovativi per adattarsi alla nuova era globale. È il tema del conflitto
infatti la radice e allo stesso tempo la soluzione del problema. La modernità ci ha
mostrato impianti di pensiero che si opponevano al caos insito nella natura delle
190
RECENSIONI
Philosophical News
cose definendo un ordine a esso alternativo. Secondo Esposito la filosofia italiana
invece ha sempre pensato quest’ordine a partire dal conflitto, imbrigliando le sue
energie e volgendole verso nuovi obiettivi, rendendole “argani” dalla forza costruttiva impareggiabile (e qui sembra essere la lezione di Macchiavelli e di Giordano
Bruno a ispirare l’autore). In Italia quindi nasce un pensiero resistente e dissidente,
duttile e concreto, che nel conflitto cerca quella potenza in grado di non far deperire la forza politica. Questa è in buona sostanza la “materia” che l’autore ci espone,
la quale tuttavia lascia aperte delle domande e delle questioni irrisolte.
Il titolo del libro sembra promettere una disamina del pensiero italiano in senso
generale quando in realtà esso viene affrontato secondo un taglio ben preciso. La
scelta degli autori trattati lo conferma. Si parla di Gianni Vattimo e di Massimo
Cacciari ma perché escludere, ad esempio, una figura così rilevante per il dibattito filosofico italiano come Emanuele Severino? Egli, a quanto pare, non rientra
all’interno di quei caratteri costitutivi della filosofia italiana enucleati da Esposito,
i quali sono intrecciati senza soluzione di continuità con il ragionamento politico.
La speculazione pura risulta quindi meno italiana (e soprattutto meno attuale) del
pensiero “conflittuale”? Siamo davvero sicuri che all’origine della filosofia che caratterizza la nostra penisola ci sia solo questo: resistenza e antagonismo? Anche
ammessa la premessa di Esposito che vede nella filosofia una sorta di grande apparato per costruire “macchine concettuali” in grado di analizzare la vita allo scopo
di trasformare la realtà (come a dire che dal pensiero si vuole passare all’azione
per mezzo di forze performative) rimane comunque da chiedersi la direzione da
prendere.
Pensiero vivente è un libro destinato a un pubblico che già conosce l’opera di
Roberto Esposito, che sia quindi in grado di apprezzare i codici in esso presenti
e le premesse da cui parte. A chi invece il testo fosse nuovo, esso potrebbe presentarsi come un po’ ostico, con dei sottintesi che spesso non vengono esplicati,
rendendo così più difficile, seppur non impossibile, gustare l’originalità dell’impostazione. Il compito che il volume si prefigge non è certo semplice e ciò nonostante
il tentativo può dirsi riuscito: da una parte Esposito aggiunge un nuovo capitolo
alla narrazione della propria impostazione filosofica e allo stesso tempo getta le
basi di un percorso che andrà certamente approfondito da altri studiosi del campo. Possiamo concludere, parafrasando l’autore, che il pensiero (politico) italiano
resta in ascolto, aperto più di altri all’ampio ventaglio delle possibilità, e in esso
rimane, acutamente presente, l’esigenza di trasformazione.
Andrea Ciceri
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
Guglielmo Forni Rosa, L’amore impossibile. Filosofia e letteratura da Rousseau a Lévi-Strauss, Marietti, Genova-Milano
2010. Un volume di pp. 199.
«Il paese delle chimere»: così il Rousseau delle Confessioni definisce il mondo
della fantasia poetica, sottolineando il valore della verità radicale che soggiace alla
creazione artistica, di contro alla contraddittorietà e limitatezza di ogni esperienza
umana. Questo paese «è il solo degno di essere abitato quaggiù, e il nulla delle cose
umane è tale che salvo l’Essere che esiste di per sé non esiste nulla di bello se non
ciò che non esiste». Anche Giulia, la giovane nobildonna protagonista della Nuova
Eloisa, romanzo epistolare del filosofo francese, di fronte alla passione impossibile
per il suo precettore, con il quale non potrà mai convolare a nozze, ripete con insistenza la formula «non esiste nulla di bello se non ciò che non esiste»: l’amore più
vero appartiene alla sfera dell’immaginazione, mira a ciò che non esiste, si realizza
nella Bellezza e nella Verità assolute, prevarica i conflitti terreni di istinto e ragione
per trionfare nell’Idea, non si consuma nella quotidianità dell’esistenza e per questo è destinato a non estinguersi. La Verità e il Bene risiedono dunque in un mondo
ideale, che è sia quello dell’amore senza tempo che riscalda il cuore di Giulia, sia
quello in cui si proiettano le più sublimi creazioni filosofiche e letterarie. Ecco
dunque spiegato il titolo dell’opera che si sta recensendo, titolo che si apprende
appieno solo dopo aver letto l’intero libro ed essere approdati all’ultimo capitolo
(L’amore impossibile. Passione e matrimonio nella «Nuova Eloisa»): l’«amore impossibile» tra la filosofia e la letteratura consiste in un rapporto complesso, spesso
in un sottile scambio di ruoli, dal quale scaturisce la rivelazione di verità supreme.
Forni Rosa affronta tale tematica attraverso otto saggi, che corrispondono ad altrettanti capitoli tesi a indagare la relazione esistente tra il campo filosofico e quello
letterario: ogni saggio è dotato di una sua indipendenza e scandaglia la materia
secondo un suo specifico punto di vista.
Il primo capitolo (Che cos’è un’autobiografia? Modelli e problemi della confessione) si occupa del genere autobiografico, dal racconto odissiaco di Ulisse nella
reggia di Alcinoo, dalla Lettera VII di Platone e dalle Confessioni di Sant’Agostino fino ai grandi scrittori dell’epoca moderna, quali Rousseau, Goethe, Tolstoj,
Dostoevskij e Thomas Mann, dall’interpretazione psicologica dei sistemi filosofici
propria del Dilthey dell’Introduzione alle scienze dello spirito al Cassirer di Spirito
e vita, secondo il quale «ogni interrogativo sull’essere riconduce alla fine all’unico
interrogativo sull’uomo». Sullo sfondo di quest’ultima questione esistenziale (secondo Cassirer «il problema della metafisica si trasforma in questa unica domanda
radicale»), l’autobiografia viene dunque considerata un «luogo» da cui può partire
192
RECENSIONI
Philosophical News
una ricerca sull’essere e sul mondo. Su tutto aleggia la vita dello «spirito», della
fantasia creativa in grado di inoltrarsi verso le verità più profonde, sulla scia del
Goethe di Poesia e verità, il quale mirava a «produrre nella vita una seconda vita
per mezzo della poesia».
Il secondo capitolo (Claude Lévi-Strauss: dal dubbio antropologico alla metafisica
dell’inconscio) affronta il complicato problema della dimensione soggettiva che risiede nelle scienze antropologiche e nella ricerca etnologica. Claude Lévi-Strauss,
padre dell’antropologia strutturale, ricerca la struttura matematica della realtà sociale, vuole scoprire le leggi e i meccanismi propri di un’occulta Ragione universale. Nel fare questo, è inevitabile che l’antropologo venga coinvolto in una totale
interrogazione sull’uomo: mentre osserva, si fa anche osservato, oggetto della propria indagine. Non si può nascondere la dimensione soggettiva di questo processo
e, difatti, Lévi-Strauss non la nega, affermando che, poiché nell’antropologia è in
gioco la comprensione dell’altro come uomo, la posizione confessoria è fondamentale per una corretta indagine («E l’etnologo, che cosa scrive se non confessioni?»).
Il punto centrale è che l’ineliminabile momento soggettivo deve poi subordinarsi
alla determinazione oggettiva: l’«apprendimento interno» dell’osservatore deve
essere positivisticamente «trasportato nei termini dell’apprendimento esterno»,
ovvero oggettivato e formalizzato.
Nel terzo capitolo (Borges, o della solitudine) viene analizzata l’opera del grande
scrittore argentino sulla base di due assunti. In primo luogo si evidenzia come Borges si serva di una «scrittura classica» (in opposizione a una «scrittura romantica»),
ovvero teorizzi il classicismo come «postulazione della realtà», accordo naturale di
parole e cose, segni e significati: la sua scrittura è un «gioco di simboli rigorosamente organizzato» e la struttura, la «forma logica» che regge la narrazione non è affatto
occulta, bensì esplicitamente presentata, modificata e discussa col lettore, tanto che
i racconti di Borges presentano in primo piano un elemento formale che si richiama
o si modifica da un testo all’altro sulla base di una fondamentale continuità. Il secondo punto affronta il «mito della letteratura senza autore»: come rileva Genette,
in Borges è a tratti presente una visione estrema o panteistica tale per cui la letteratura universale viene concepita come una vasta creazione anonima in cui ogni autore è soltanto l’incarnazione fortuita di uno Spirito intemporale e impersonale, uno
spazio omogeneo e reversibile in cui le particolarità individuali non hanno valore.
Il quarto capitolo (Michail Bachtin: il romanzo polifonico di Dostoevskij) scandaglia l’opera del grande romanziere ottocentesco alla luce degli studi di Michail
Bachtin, a partire dall’importante scritto Dostoevskij. Poetica e stilistica. Bachtin
cerca una comprensione della letteratura come «enciclopedia» e non come «sistematica»: a partire da ciò, il formalista russo constata che in Dostoevskij si fonde
una pluralità di coscienze equivalenti con i loro singoli mondi, le quali riescono a
conservare la propria incompatibilità nell’unità di un certo evento. La caratteristica fondamentale dell’opera di Dostoevskij consiste dunque nella pluralità delle
coscienze indipendenti disgiunte, in una polifonia di voci pienamente autonome:
l’unità dei romanzi è data non da una coscienza (autore, personaggio portavoce) e
dal suo mondo, come nel consueto romanzo «monologico» della tradizione europea, bensì dall’unità dell’evento, dall’unità di una struttura.
Philosophical News
RECENSIONI
193
Il quinto capitolo (L’autoalienazione del soggetto nell’ultimo Rousseau) analizza
l’evoluzione del pensiero di un Rousseau ormai maturo, il quale, nelle Rêveries du
promeneur solitaire lascia emergere il limite di essenzialità e di consapevolezza e
insieme di angoscia e di tensione cui è pervenuta la sua situazione umana. L’intera
esistenza di Rousseau si fonda sulla coscienza di una differenza che lo divide dal
suo ambiente storico-sociale e, difatti, nelle stesse Rêveries rivela un forte spirito
polemico nei confronti dei philosophes: «La loro filosofia è fatta per gli altri; io ne
avrei bisogno di una fatta per me». Respinto dagli ambienti colti, abbandonato da
tutti, egli non trova più un’immagine di sé cui abbandonarsi con fiducia («Sono
dunque solo sulla terra, senza fratelli, né parenti, né amici, né altra compagnia
che me stesso... Ma io, separato da loro e da tutto, che sono io?») e, richiudendo
pericolosamente l’io in se stesso, giunge ad asserire: «Scrivo le mie Fantasticherie
soltanto per me».
Nel sesto capitolo (Cassirer e la dimensione simbolica) si esamina la nozione
cassireriana di «forma simbolica», la quale compare già nelle opere del Cassirer
degli anni Venti e affonda complesse radici nella cultura neo-kantiana, nella riflessione estetica e nella scienza naturale della fine del XIX secolo. Semplificando, si
può affermare che per il filosofo tedesco un simbolo non è una cosa o un oggetto,
ma una legge (una «forma») che permette la scoperta di più oggetti o di campi
diversi dell’esperienza. Se ad esempio prendiamo una sfera, questa è la legge, matematicamente determinata, che ci permette di conoscere, esprimere, comunicare
ogni sorta di cose rotonde. In una stessa legge sono presenti diverse possibilità di
determinazione o espressione o oggettivazione che riguardano i settori più diversi
e perciò il simbolo ha una particolare intensità: esso non è una cosa, ma una funzione e per di più una funzione molteplice. Partendo da queste riflessioni, il discorso
approda al Saggio sull’uomo, in cui Cassirer cita l’esempio di Goethe, il quale, nel
titolo stesso della sua autobiografia Poesia e verità, indica un significato importante
della relazione simbolica: la memoria poetica si serve necessariamente dell’immaginazione non perché voglia mentire o falsificare i dati, ma perché cerca la verità a
partire da una riorganizzazione simbolica del suo senso.
Il settimo capitolo (Un mondo oltre il mondo. Vita e poesia nella formazione del
concetto di spirito) affronta la relazione vita-poesia, aspetto decisivo della relazione
vita-spirito che ha occupato tanta parte della cultura tedesca nell’Ottocento e nel
primo Novecento. Lo «spirito» è una sfera omnicomprensiva di possibilità vitali,
che non coincide con la vita reale, con le possibilità effettive di esperienza, ma,
sorgendo da queste, le supera e le approfondisce verso una verità ultima. Così il
Dilthey del saggio Goethe e la fantasia poetica afferma che «la poesia è rappresentazione ed espressione della vita» e, dopo aver sottolineato il rapporto tra poesia e
realtà, evidenzia che la «fantasia poetica», motore della creazione artistica, stabilise un nesso tra ricordo e immaginazione. Per il giovane Nietzsche de La nascita
della tragedia ogni conoscenza del passato è «arte» e non «scienza», espressione
soggettiva del ricercatore, confessione del suo rapporto con l’oggetto, piuttosto
che descrizione dell’oggetto stesso. Nel Werther Goethe compie un processo di
«tramutazione della realtà in poesia», trasformazione il cui impatto si rileva tanto
forte da far sì che altri ritengano di dover «tramutare la poesia in realtà, imitare un
194
RECENSIONI
Philosophical News
tale romanzo e spararsi». Il rapporto vita-poesia emerge anche nella Nuova Eloisa
di Rousseau, la quale nasce essenzialmente dalle delusioni della realtà: è una specie
di compensazione ideale o fantastica che l’autore si concede dopo aver lasciato la
confusione e i conflitti della vita parigina.
Dell’ultimo capitolo (L’amore impossibile. Passione e matrimonio nella «Nuova
Eloisa») si è già detto in apertura.
Per concludere, nel suo insieme il libro offre la possibilità di esaminare il rapporto tra filosofia e letteratura da una specola privilegiata, l’osservatorio di uno
studioso che ha il merito di possedere una cultura ampia e articolata, capace di
spaziare in modo trasversale nel campo di diversi ambiti di ricerca. Si potrebbe
avanzare una sola critica: i singoli capitoli, dotati in sé di un alto valore, sovente
stentano a manifestare quei tratti comuni (pur presenti, ma spesso non evidenti e
rintracciabili solo in seguito a un’analisi profonda) che dovrebbero giustificare la
loro unione sotto un solo titolo. Si sarebbero forse rivelati opportuni una premessa
generale o brevi cappelli introduttivi ai singoli capitoli, in modo da guidare il lettore lungo il fil rouge che unisce le varie sezioni.
Emanuele Romanini
[email protected]
Isabella Guanzini, Lo spirito è un osso. Postmodernità, materialismo e teologia in Slavoj Žižek, Cittadella editrice, Assisi
2010. Un volume di pp. 261.
Per un autore come Slavoj Žižek il lavoro del pensiero deve sempre confrontarsi
con la prova della realtà: fatto-vero anche grazie alla scena di un film. Non entreremmo nel mood teoretico di Žižek senza strizzare l’occhio alla settima arte.
Iniziamo, dunque, da Casey – personaggio rubato alla sapienza visiva di John Ford
che, nel 1940, firma con The Grapes of Wrath (Furore), ispirato al romanzo di John
Steinbeck, un capolavoro assoluto della storia del cinema – e dalle sue parole decisive:
Mi sono chiesto: ma che sarà questa cosa che chiamano Spirito Santo? Forse è amore.
Ma io amo tutti così tanto che a volte potrei scoppiare. Insomma forse non esiste il peccato e non esiste la virtù. Esiste solo quel che la gente fa. Certe cose che la gente fa sono
belle; certe altre meno belle. E non c’è proprio nient’altro da dire.
Casey (John Carradine) è un predicatore. O meglio, lo era. Era un predicatore
prima di perdere lo spirito. Ora non è più sicuro di niente e non ha niente da predicare. Si consola sorseggiando gin. Accovacciato ai piedi di un grande eucalipto,
scomposto dal vento, confessa – con forza profetica – il proprio smarrimento al
giovane Tom Joad (Henry Fonda). Ricorda quando, un tempo, teneva sermoni
camminando, come un saltimbanco, sulle mani o in equilibrio sul tetto di una
stalla. Le sue parole infervoravano le ragazze. Le ragazze svenivano. Casey si avvicinava per confortarle, ma finiva sempre con l’amarle. Allora, stretto dal senso di
colpa, pregava… ma non serviva a nulla. Pensava di non meritare la salvezza, anche
se, per lui, una ragazza non era semplicemente una ragazza: era una creatura sacra
che doveva essere salvata… “I asked myself, what is this here called holy spirit?
Maybe that’s love”. Saranno le storture della Storia e l’intreccio della sua storia con
quella di Tom Joad, in viaggio dall’Oklahoma alla California per sfuggire, con la
sua famiglia, alla miseria, a dischiudere l’enigma di quell’amore che, senza esitazione, aveva fatto affermare a Casey: “It’s just what people does”.
Lo struggimento che segna il volto ruvido, dolcissimo, di Casey – predicatore e
ubriacone, clown e profeta – nel tentativo di rendere amore lo spirito perduto, è
presente anche nel saggio di Isabella Guanzini. Siano gli occhi spaesati di Casey a
guidarci nell’avventura speculativa che le pagine dense – serrate nell’argomentazione, radiose nelle intuizioni – di Lo spirito è un osso raccontano.
La posta in gioco è il “fuori-luogo” della filosofia žižekiana: l’incontro perturbante con gli indizi teologici disseminati nei «testi animati – come libri pop-up –»
(p. 11) del filosofo di Ljubljana.
196
RECENSIONI
Philosophical News
La teologia è il “fuori-luogo” della filosofia di Žižek in due sensi:
1) idealismo tedesco e psicoanalisi lacaniana reagiscono e si fanno operativi proprio nello spazio dell’ortodossia cristiana;
2) la lettura lacaniana di Hegel, che innesta idealismo ed esistenzialismo (la tesi
hegeliana, “l’Assoluto è Soggetto”, si confonde con l’angoscia del “Singolo” kierkegaardiano), scava il “thriller del cristianesimo”, l’idea cioè che Dio sia esposto
e fragile. La “kenosi del Padre” diventa pensabile, però, solo a partire da un
radicale e inaggirabile materialismo, senza il quale l’Evento cristiano si dissolve
e, con esso, la verità dell’uomo. Incarnazione ed Ecce homo diventano paradigma
dell’umano, sola resistenza possibile nel panorama postmoderno che ha estenuato l’Io, narcisisticamente rarefatto, ridotto all’imperativo del godimento. La teologia žižekiana diventa così, dopo aver riletto la storia di Dio e quella dell’uomo
alla luce di agape, la prima radice di una nuova ontologia politica:
La buona notizia del Vangelo, l’amore come pura gratuità, costituisce quel nocciolo
duro e sovversivo che per l’ateo materialista risulta fondamentale e insuperabile per
pensare la costituzione umana degli affetti e della mente. Da questo spregiudicato riconoscimento dell’inedito cristiano viene la possibilità di una rinnovata condizione eticopolitica, in grado di articolare in modo significativo i legami sociali e le pratiche condivise (p. 94).
Questa inaudita libertà si manifesta solo nella misura in cui l’esperienza religiosa
sospende e, al contempo, fonda la dimensione etica, proprio come avviene al “cavaliere della fede”, Abramo:
La vita religiosa [...] non appare mai rassicurante, ma sempre in sospeso, attraversata
da istanti di angoscia assoluta, così che la coscienza vive l’impasse dell’incomprensione,
nel silenzio della sua solitudine. È impossibile, infatti, per Kierkegaard dare ragione del
proprio atto di fede, illustrare la differenza del suo senso assoluto. Abramo non può
parlare, altrimenti è perduto [...] solo la perdita, la lacerazione, il punto abissale della
contingenza, che sembrano ciò che più mi separano da Dio, sono ciò che in realtà mi
uniscono a Lui (p. 173).
È interpretando la dinamica kierkegaardiana della “ripetizione”, rielaborata
dalla filosofia della storia benjaminiana del “futuro anteriore” che, secondo Žižek,
si manifesta il senso reale della libertà: «La dialettica storica presuppone un’operazione di riattivazione delle potenzialità emancipatorie, delle idee rivoluzionarie, la
cui gestazione è avvenuta in un passato storico tradito, rimasto irrealizzato […]. Se
da una parte la ripetizione è ciò che lega, ciò che incatena a ciò che è stato, dall’altro è ciò che libera e che spinge ad agire» (pp. 171-172).
Cristo che sceglie se stesso fino alla croce è l’atto archetipico cui l’uomo deve
guardare quando ripropone la scelta originaria di sé. È nell’eccezione del “Singolo” che può prodursi universalità:
Il mondo si salva, grazie a una manifestazione evenemenziale di Dio, impossibile da
nominare e da afferrare, che si incunea nella storia aprendola al mistero e rivelandone
il senso: tale rivelazione interpella gli uomini nel loro spazio di vita più normale, si offre
Philosophical News
RECENSIONI
197
nell’autenticità di gesti ordinari, comprensibili a tutti, in paesaggi familiari, che sembrano tuttavia generarsi da una dimensione profonda, da un Tempo originario. Lo spirituale
diviene nel cristianesimo l’umano più autentico [...]. Nello stesso tempo, il Singolo coronato di spine, l’Ecce homo che offre se stesso, aggiunge Žižek, nella mite potenza della
sua persona, rappresenta l’unica figura autentica di umanità, la sola forma possibile di
pienezza dell’umano [...]. In rapporto a Cristo, ogni soggetto diviene, lacanianamente,
soggetto barrato, esistenza in angoscia, presa in un inevitabile e tragico stallo, laddove
creda di realizzarsi compiutamente in se stessa (pp. 211-213).
L’esito sconcertante del percorso teoretico di Žižek viene tematizzato a partire
dall’assunto fondamentale che costituisce il cuore pulsante della sezione V della
Fenomenologia dello spirito: “lo spirito è un osso”.
Qual è il senso profondo di questa affermazione?
Non si deve intendere l’ipotesi frenologica in termini riduzionistici: la forma del
cranio struttura la vita della mente. Si tratta piuttosto di cogliere che, al di là di
ogni dualismo,
anche la materia più inerte viene attraversata dallo spirito [...] anche l’osso più insignificante diviene traiettoria e movimento spirituale, così come negli infimi dettagli di
una situazione quotidiana risplende, balthasarianamente, la presenza eminente, benché
sottilissima e fragile, dello Spirito.
Questo significa, nello stesso tempo, che può darsi Spirito se c’è un osso, e cioè un
dato materiale, una presenza contingente, un frammento di vita, in cui possa incarnarsi,
in cui possa farsi mondo [...]. Senza “un osso da mandare giù”, non si dà semplicemente
esistenza, non si costruisce alcun senso possibile (pp. 19-20).
Isabella Guanzini sviscera le implicazioni sottese all’ipotesi frenologica articolando il suo lavoro in quattro capitoli:
1) Estenuazione postmoderna dell’io.
2) Ricomposizione del “soggetto scabroso”.
3) Idee per un materialismo cristiano.
4) Teologia postmoderna di agape.
Chiave di volta per l’intero percorso argomentativo del saggio è l’analisi – accattivante anche dal punto di vista storico-filosofico – della prospettiva che Žižek espone
nel suo Il soggetto scabroso. La certezza del cogito cartesiano, che deve restare indubitabile (se si perdesse la coscienza si dissiperebbe anche il suo fondo oscuro), diventa
verità solo quando “la notte del mondo” che abita il soggetto si manifesta nel desiderio. Si tratta di un desiderio che divide il soggetto al suo interno, di un’“intimità straniera” che rende il soggetto inappropriabile: l’inconscio è il nome proprio per dire
l’Altro nel soggetto. Il filo del pensiero si srotola, pur continuando ad attorcigliarsi,
in un continuo rimando dall’antropologia alla teologia, dalla teologia all’antropologia, senza mai aver cessato di significare, per parafrasare – insieme all’autrice – Boris
Pasternak, il fragilissimo e «onnipossente Dio dei dettagli» (p. 211).
Francesca Mazzini
[email protected]
Fabrice Hadjadj – Fabrice Midal, Qu’est-ce que la vérité?,
Salvator, Paris 2010. Un volume di pp. 115.
Il volume, che esce nella collana «Controverses» dell’editrice parigina Salvator,
raccoglie il dibattito svoltosi il 4 giugno 2010 a cura del Centre théologique universitarie di Rouen, sul tema della verità indicato nel titolo. La disputa è affidata a due
intellettuali, filosofi di orientamento diverso, entrambi di origine ebraica: Fabrice
Midal, docente di meditazione buddhista, e Fabrice Hadjadj, di origini tunisine,
ateo e anarchico fino alla conversione al cristianesimo, autore di una dozzina di
volumi di cui alcuni tradotti in italiano (Mistica della carne. La profondità dei sessi,
Medusa 2009; Farcela con la morte. Anti-metodo per vivere, Cittadella 2009; La
fede dei demoni, Marietti 2010; La terra strada del cielo. Manuale dell’avventuriero
dell’esistenza, Lindau 2010). La disputa, di notevole interesse, mette di fronte a
due possibili esiti, opposti, della lunga stagione del post-‘68 francese: da un lato un
pensatore buddhista che ritrova la mistica dell’Oriente al termine della decostruzione nichilista, nietzschiana e heideggeriana, della soggettività; dall’altro un ateo
che riscopre, mediante la conversione al cristianesimo, il rilievo dell’io, della relazione intersoggettiva, del realismo come incarnazione. Il volume esordisce, nella
prima parte, con una riflessione distinta, da parte degli autori, sul tema della verità,
a cui segue, nella seconda, il “debat”, la dialettica delle domande e delle risposte.
Spiegando il suo punto di vista, il primo Fabrice, Midal, giustifica la sua appartenenza alla tradizione del buddhismo indo-tibetano tantra per la sua dottrina sulla
«nature veritable de toutes choses qui constitue le continuum ininterrompu sousjacent au samsara et au nirvana» (ivi, p. 21). La natura profonda, reale, è continuità
ininterrotta «par-delà la dualité apparente» (ibidem), oltre i dualismi che segnano
la storia della metafisica. Il messaggio di Buddha è «une pensée non marquée par
la métaphisique occidentale» (ivi, p. 22). Ciò che egli insegna è un’altra “verità”.
Nel caso dell’uomo ciò significa andare al di là de «l’union d’une raison et du
sentiment, de l’âme et du corps» (ibidem). Per Midal «la voi du Buddha est une
pensée tout autre de l’être de l’être humain» (ivi, p. 23). Per comprenderlo, oltre
la ragione e il sentimento, occorre situarsi in un orizzonte meta-antropologico.
Lungo questa china Midal riscopre la tradizione dei moralisti francesi, di coloro
che hanno criticato la roccaforte dell’“io”, lo hanno spogliato di ogni alone, gettato
nella polvere. Questo ego è «une mascarade qui, sous prétexte de nous protéger
de tout, nous fait vivre de façon radicalment inauthentique. Ce moi-moi-mêmeet-ancore-moi, voilà ce que les grands penseurs français que sont Molière ou La
Rochefoucald ont nommé l’amour propre (et que Rousseau oppose à l’amour de
soi) et que la tradition bouddhique tente de penser comme non-ego» (ivi, p. 33).
Philosophical News
RECENSIONI
199
Da La Rochefoucauld a Buddha, passando per Nietzsche e la sua decostruzione
del soggetto – per il Nietzsche erede di Schopenhauer e della sua critica buddhista al principium individuationis – il percorso di Midal è chiaro. È l’esito mistico,
orientale, post-umanistico, delle critiche decostruzionistiche conseguenti al “‘68
pensiero”. A questa fuga da “sé”, dal mondo, l’altro Fabrice, Hadjadj, oppone la
via del realismo ebraico-cristiano, la via di Buber, di Rosenzweig, di von Balthasar:
quella sulla persistenza dell’io, più forte di ogni negazione, sulla strutturale relazione io-tu, identità-alterità. La «vérité, c’est que nous sommes ici, moi, Fabrice
Hadjadj, vous, qui m’entendez, qui m’écoutez peut-être, avec le foutu désir de
béatitude dans les entrailles, et en même temps la peur au ventre devant la mort»
(ivi, p. 50). Ciò significa che siamo dramatis personae, «protagonistes d’un drame»
(ivi, p. 51). La vita non è una continuità indolore dove il contrasto è apparenza,
come vorrebbe Midal. La vita è la “prova”, nella lotta tra il positivo e il negativo,
tra la gioia e il dolore. «La preuve, c’est que l’angoisse devant la mort monte en
même temps que nos joies terrestres. Plus j’ai de joie a tenir Élisabeth dans mes
bras (Élisabeth, c’est ma quatriéme fille), plus aussi j’ai d’angoisse de la perdre»
(ivi, p. 52). Rispetto a questo dramma la strategia del “distacco” (détachement),
messa in atto da una saggezza vecchia come il mondo, non funziona. Anticipa la
morte per paura della morte. «Mais perdre l’angoisse devant la mort, c’est avoir
perdu l’émerveillement davant la vie. Parce que ce n’est que dans la mesure où je
m’émerveille encore devant la vie, cette vie, celle Élisabeth, celle de Jacob (Jacob,
c’est mon fils), ou même celle de Françoise (là, c’est ma belle-mère), que la mort,
en tant qu’elle me prive de cette vie que j’aime, peut m’apparaître angoissante.
Et c’est pourquoi l’angoisse devant la mort n’est pas l’affection fondamentale de
l’existence, mais d’abord, plus profondément, l’émerveillement devant la vie» (ivi,
pp. 52-53).
L’angoscia di fronte alla morte non è l’affezione fondamentale. Hadjadj critica lo
Heidegger di Sein und Zeit e, insieme, mostra il limite della posizione buddhista. Il
timore della morte sorge, in seconda battuta, a partire dall’affezione ad un reale positivo di cui temiamo la perdita. Per questo «la vérité ne doit rien diminuer de mon
désir de béatitude, mais elle ne doit rien obscurcir non plus de ma lucidité devant
la mort, et donc la vérité ne peut se révéler que dans ce lieu d’extrême tension, à
l’endroit même de cette déchirure» (ivi, p. 53). Il che significa che essa è «quelche
chose comme une résurrection» (ibidem).
Se la verità è colta in un “dramma” la seconda osservazione che Hadjadj trae
dalla nozione di dramatis personae è che noi, i soggetti, siamo protagonisti, non
spettatori inerti come il saggio buddhista che osserva la scena dal di fuori. «La vérité de la situation, c’est que je suis là avec mon visage, et que vous êtes là, chacun,
avec le vôtre, et que notre recherche d’un savoir ne doit jamais nous faire oublier
cette première vérité-là: nous sommes d’abord des persone avec des noms propres,
et le regard de chacun pour l’autre paraît contenir un mystère plus profond que
toutes les encyclopédies» (ivi, pp. 53-54). La verità si manifesta in un dramma i cui
protagonisti, come affermava Franz Rosenzweig, non sono gli uomini in generale
ma le persone con il loro volto, con il loro nome e cognome. «Ce dont il s’agit,
ce n’est pas l’homme, mais Robert, Corinne, Fatima, Chögyam ou meme Fabrice
200
RECENSIONI
Philosophical News
[...] Telle est la réalité, si bien que la Vérité non seulement ne sarait méconnaître
la diversité des visages, mais elle ne peut qu’ouvrer pour leur amour et leur communion» (ivi, p. 55). Per questo la saggezza, quella vera, «réclame autour d’elle la
moltitude des visages» ( ivi, p. 56), non il loro annullamento. Concludendo il suo
intervento Hadjadj fissa quattro condizioni entro le quali la verità prende forma:
L’incarnation, L’epreuve, Le drame, La communion des visages. Quattro condizioni
che, secondo l’autore, trovano la loro realizzazione nel racconto della Passione di
Cristo narrata nel Vangelo di Giovanni, di Cristo che di fronte alla domanda di
Pilato “Qu’est-ce que la vérité?”, non risponde. Non può rispondere «parce qu’il
est lui-même la réponse» (ivi, p. 64).
Il realismo ebraico-cristiano si oppone, in tal modo, al buddhismo post-moderno dell’ebreo (di origine) Midal. Il dibattito che segue, tra i due autori, illumina le
prospettive marcando le differenze. Alla domanda di Hadjadj: «Quelle consistance
donnes-tu à la diversitè des voix et des visages?» (ivi, pp. 73-74), Midal ribatte
che «Le “moi-moi-même-et-encore-moi” est cette crispation qui nous empêche
d’entrer en rapport avec la vérité» (ivi, p. 77). Il “me”, l’io, non è il “proprio”, il
profondo meta-personale. «Le moi n’est pas haïssable, il est illusoire, un effet d’optique qui recouvre notre être propre» (ivi, p. 78). Questo è l’autentico messaggio di
Buddha. «Je crois donc qu’on peut dire que le “non ego” est la vérité la plus simple
de l’existence humaine» (pp. 80-81). È la verità che si apre alla dimensione mistica,
nell’opera ad es. di Madame Guyon a cui Midal ha dedicato un capitolo nel suo
volume Et si de l’amour on ne savait rien? (Albin Michel, Paris 2010). All’obiezione
di Hadjadj, per cui c’è mistica e mistica, una mistica de-realizzante e un’altra che si
fonda su «la necessité d’une médiation, d’un rapport à l’autre» (ivi, p. 94), Midal
ribatte che «la vérité de mon être n’est pas d’être un “moi” ni un “sujet” face à des
objects et d’autres sujects!» (ivi, p. 99). La mistica non ricade nel soggettivismo;
essa introduce in quella terra di nessuno che è oltre «le rapport moi-autre» (ivi, p.
102), introduce al continuum profondo della natura dove non ci sono più barriere,
distinzioni tra soggetto e oggetto, dove «on n’a pas besoin pour cela de rigidifier
“moi” et “autre”, pas plus qu’on a besoin d’une mediation» (ivi, pp. 102-103). Nella natura si è originariamente uniti nel vincolo della compassione universale, oltre
le differenze io-tu, io-mondo, che implicano, come tali, il problema del “terzo”,
della mediazione. Una posizione ermeticamente chiusa alla provocazioni “personalistiche”, al realismo esistenziale patrocinato da Hadjadj. A cui non rimane che
riaffermare, contro ogni detachement di tipo orientale l’insopprimibile realtà del
proprio essere individuale. «La question, ce n’est pas “être pour autrui”, la question, c’est moi, Fabrice, face à vous, Georges… Parce que ce qui importe, c’est de
retrouver le sens du nom propre, de l’irréductibilité du nom propre désignant une
personne unique» (ivi, p. 108). Tutto questo contro la fascinazione dell’astratto che
«perd de vue la primauté du visage, la primauté de la rencontre, la primauté de
l’événement» (ivi, p. 109).
Massimo Borghesi
Università degli Studi di Perugia
[email protected]
Mario Micheletti, La teologia razionale nella filosofia analitica, Carocci, Roma 2010. Un volume di pp. 230.
Il presente volume, che inaugura per i tipi di Carocci la Serie “Metafisica tomistica e metafisica analitica. Pubblicazioni dell’Istituto di Filosofia applicata della
Facoltà di Teologia di Lugano”, riproduce e propone all’attenzione generale il corso intensivo di lezioni che presso l’istituzione accademica svizzera Mario Micheletti ha tenuto nel febbraio del 2009. Tema delle lezioni, e proposito del volume,
è quello di fare il punto sulla “rinascita” della teologia razionale nell’ambito della
filosofia analitica, attraverso l’analisi delle condizioni che l’hanno prodotta e incoraggiata; non solo, l’intento è altresì quello di ricostruire le vie che tale Renaissance
ha seguito nel corso degli ultimi decenni.
È senz’altro evidente la continuità di questo con due precedenti lavori di Micheletti – Filosofia analitica della religione. Un’introduzione storica (Brescia 2002)
e Tomismo analitico (Brescia 2007) – se è vero che il primo capitolo e l’ultimo
del presente volume rispettivamente recuperano e sviluppano, aggiornandoli nel
merito teoretico e bibliografico, gli argomenti focalizzati nel fortunato testo del
2002 e nel suo sequel. E però non di mero aggiornamento e ricognizione si tratta
ne La teologia razionale nella filosofia analitica. È qui infatti seriamente tangibile,
tra le altre cose, un più vigoroso sforzo dell’Autore di contenere, e in un certo
senso neutralizzare, quella divaricazione tra la filosofia analitica della religione e
elaborazioni filosofico-religiose “tradizionali”, sviluppate all’interno di «contesti
non-analitici», che pure si è sovente tentati di accogliere acriticamente. Beninteso,
già il saggio intitolato La rinascita della teologia naturale nella filosofia analitica –
dapprima pubblicato in un fascicolo di “Hermeneutica” del 2005 dedicato al tema
Quale metafisica? e poi riproposto in Appendice a Tomismo analitico – si muoveva
in tal senso. Tuttavia nel presente volume lo sviluppo si fa “organico” e l’Autore,
oltre a sviluppare nel primo capitolo un’accurata indagine dello statuto della filosofia della religione nella propria specificità epistemica (in un ambito, qual è quello
analitico, dove è perfino difficile distinguerla da discipline come la “teologia naturale o razionale” e la “teologia filosofica”), ha occasione di argomentare in modo
circostanziato e pertinente la tesi secondo cui la “rinascita” della teologia naturale
nella filosofia analitica sia legata non solo alla riaffermazione della possibilità della
metafisica e al «superamento» di quei divieti che, a partire da Hume e Kant per
finire al positivismo logico, erano stati imposti al discorso razionale su Dio, ma
anche con la forte ripresa del realismo epistemologico e metafisico, e segnatamente
attraverso l’affermazione di un «realismo senza empirismo».
202
RECENSIONI
Philosophical News
Non sorprende in tal senso il richiamo che sin dalle pagine prefatorie Micheletti
fa al Jean Greisch de Le buisson ardent, di cui egli evidentemente condivide la raccomandazione che così riassume: «Meritano di essere approfondite le ragioni che
hanno consentito la recente fioritura della teologia filosofica nel contesto analitico
in deciso contrasto con le tendenze culturali oggi prevalenti». Né è sorprendente
l’acuto riferimento alla tesi che Marco M. Olivetti andava esponendo quindici anni
fa allorché, intercettando la tendenza della filosofia analitica della religione a includere in sé la teologia naturale, individuava i due «generi sommi» della odierna
filosofia della religione, «quello non storico (e sostanzialmente prosecutore della
“teologia naturale”, di cui è talora sinonimo) prevalente nella filosofia angloamericana di stile analitico-empiristico [...] e quello storico e ermeneutico prevalente
nella filosofia di tradizione europeo-continentale»; “acuto” perché Micheletti, nel
raccomandare di non irrigidire oltremodo questa distinzione, avrà buon gioco nel
dimostrare come, seppur in contrasto con le più accreditate tendenze continentali
odierne, «è la filosofia analitica della religione, insieme alla metafisica analitica, a
connettersi con la grande tradizione filosofica europea».
«Il fatto – afferma l’Autore a proposito delle critiche rivolte alla teologia razionale – è che [da un lato] non si sarebbe potuta verificare l’attuale rinascita della
teologia naturale se non si fosse aperta una breccia, almeno parzialmente, nel muro
di ostacoli» che pure per lungo tempo erano stati considerati insormontabili. Ostacoli di carattere filosofico: le sopraccitate critiche di Hume a qualsivoglia giustificazione filosofica della credenza teistica e di Kant ai tentativi di teologia razionale;
ma anche, più recentemente, le severe obiezioni di natura logico-positivistica, la
stessa critica heideggeriana all’ontoteologia o i “moniti” di Marion intorno ai rischi della “idolatria”; o di carattere teologico, quali per es. le critiche barthiane
indirizzate a ogni pretesa di teologia naturale. D’altro lato, come pure Micheletti
ha chiarito in scritti precedenti e qui ribadisce, la recente fioritura della teologia
naturale è da ricondurre a «sviluppi interni» alla filosofia analitica della religione.
Non solo infatti essa «si è avvalsa di strumenti concettuali resi disponibili dalla metafisica analitica, ma ha reso possibile anche un approfondimento di questa nella
direzione della ricerca delle cause prime e nel disvelamento delle radici teistiche
della realtà». Di fatto l’ambito analitico è ormai pressoché l’unico in cui oggi si
possano affrontare e svolgere le questioni relative all’intelligibilità e coerenza degli
attributi divini o vagliare e discutere argomenti in favore dell’esistenza stessa di
Dio. E ciò, per inciso, «deve apparire sconcertante» a chi ancora identificasse la
filosofia della religione di stampo analitico con il neoempirismo logico e con le
critiche di tipo positivistico sollevate, nel quadro del moderno fondazionalismo
epistemologico, da Ayer in Language, Truth and Logic (sulla scorta del Carnap della
Überwindung der Metaphysik); a chi cioè volesse proiettarsi, e proiettare la filosofia
della religione di stampo analitico, nel lontano tempo in cui la Hauptsache concerneva ancora lo status logico della credenza religiosa e la stessa significanza cognitiva degli enunciati religiosi (beninteso, da determinare assecondando i criteri fissati
dall’argomento verificazionistico).
Al riguardo degli argomenti in favore dell’esistenza di Dio è necessaria una
rapida puntualizzazione: Micheletti non manca di definire “parziale” la propria
Philosophical News
RECENSIONI
203
ricostruzione della teologia razionale nella filosofica analitica in virtù della scelta
di trattare soltanto gli argomenti – ontologico, cosmologico e teleologico – che
tradizionalmente vengono considerati nevralgici con riferimento alle prove della
realtà divina; essi occupano i tre densi capitoli centrali del volume, nei quali l’Autore contestualizza gli argomenti teistici in un quadro storico capace di restituire
una ricca e puntualissima panoramica dei più recenti sviluppi della filosofia della
religione di stampo analitico (da quella di matrice wittgensteiniana alla cosiddetta epistemologia riformata, alle posizioni più aggiornate; di fatto «la discussione
sull’argomento ontologico rimane aperta»); nondimeno nella sezione conclusiva
del volume, sebbene per ovvie ragioni di opportunità non vengano sviluppati in
modo altrettanto articolato e accurato, non mancano preziosi riferimenti ad altri
e più specifici argomenti teistici (quali per es. quelli proposti più di recente da
Swinburne o da Copan).
Di più, nel puntuale quadro storico che l’Autore ricostruisce ampio spazio è
altresì riservato allo specifico segmento del “tomismo analitico”, al quale è interamente dedicato il capitolo quinto e conclusivo. In esso vengono recuperati, calibrati e ampliati alcuni dei temi e delle suggestioni già sviluppate nell’agile volume
del 2007. Inevitabilmente, come Micheletti notava allora, la lettura e interpretazione analitica di Tommaso ha portato allo sviluppo di un tomismo diverso dal
neo-tomismo di ispirazione ecclesiale della fine del sec. XIX e dai lavori di Gilson
e Maritain. Parlando di “tomismo analitico” – come ha asserito Pouivet, secondo
cui propriamente «appellarsi a S. Tommaso significa fare oggi filosofia» – ci si riferisce nel presente alla particolare tendenza filosofica che ha preso avvio in Gran
Bretagna verso la metà del secolo scorso e ha visto i suoi maggiori interpreti in
Peter Geach, Elizabeth Anscombe e Anthony Kenny, autori che pure Micheletti
introduce in modo estremamente accurato.
Il volume è corredato da un ricco e aggiornato apparato bibliografico.
Hagar Spano
Università degli Studi di Salerno
[email protected]
Jan Patočka, Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo, a cura di G. Di Salvatore, postafazione di R. Barbaras, Edizioni Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona
2009. Un volume di pp. 384.
Nel 1929 Jan Patočka vince una borsa di studio e decide di muovere alla volta
di Parigi, dove ha l’occasione di assistere alle celeberrime prolusioni di Edmund
Husserl che anticipano le Meditazione cartesiane dell’iniziatore del movimento
fenomenologico. Nel 1933 lo ritroviamo a Berlino, «luogo più di scienza che di
filosofia», dove egli si confronta con gli ultimi sviluppi delle scienze naturali. A
Friburgo perfeziona le sue conoscenze in biologia, prosegue gli studi aristotelici
e inaugura la collaborazione con lo stesso Husserl e con l’assistente di lui Eugen
Fink. Nel 1934 è a Praga, dove figura tra i fondatori del Circolo filosofico di Praga
e conosce Roman Ingarden.
Sono questi, per Patočka, gli anni di quella formazione filosofica coerente nel
suo disegno di fondo, ma straordinariamente varia e ricca quanto a fonti, autori,
problemi di cui Che cos’è la fenomenologia? Movimento, mondo, corpo vuole oggi
presentare gli esiti al pubblico italiano: esiti diretti, quando il riferimento agli anni
giovanili dell’autore è rispecchiato dalla scelta di testi pensati e scritti in quel tempo; esiti indiretti ma non meno significativi, quando l’attenzione cade su scritti della maturità che trovano tuttavia nelle letture tedesche e praghesi e nei significativi
incontri di tale periodo la fonte prima della loro ispirazione.
Che cos’è la fenomenologia? è infatti, per esplicita ammissione del curatore Giuseppe Di Salvatore e di Renaud Barbaras che firma un’intensa Postfazione, un’antologia di testi ancora poco conosciuti e quindi imprescindibili per riaprire il dibattito sul vero Patočka: non il Patočka a tutti noto, e troppo spesso riassunto in sigle
che ne irrigidiscono il messaggio, con il rischio di tradirlo; e nemmeno il Patočka
presentato dai suoi stessi commentatori ricorrendo a «diciture in maiuscolo come
“Altro”, “Essere”, “Tutto” e soprattutto “Libertà” che sono un’offesa ad ogni spirito genuinamente fenomenologico». È piuttosto il Patočka che si cela nelle pieghe
di manoscritti talvolta «incompiuti o frammentari», dai quali emerge un pensiero
colto in fieri e perciò tanto più teoreticamente incisivo quanto più capace di rimettere in discussione assunti considerati ormai intangibili.
L’innegabile pregio di questo testo è così l’andare alla fonte e il risalire all’origine: il curatore con le sue scelte bibliografiche e il lettore con la pazienza della sua
esegesi ritornano o devono ritornare a quel “punto zero” nel quale Patočka può
apparire forse come autore di testi minori che mancano ancora di un loro riconoscimento pieno da parte della critica, ma che proprio per questo ce lo restituiscono
nella piena autenticità (e negli eventuali limiti) del suo essere filosofo alla ricerca
Philosophical News
RECENSIONI
205
delle buone ragioni del proprio argomentare, in presa diretta con il mondo e la
normatività sua propria.
Che cos’è la fenomenologia? evita d’altra parte di cadere nel rischio di presentare una pluralità di testi irrelati gli uni rispetto agli altri: non estremizza una parte
e un momento a vantaggio dell’intero, facendo di manoscritti poco noti l’unica
possibile relazione d’accesso alla poliedrica figura di questo pensatore. La scelta
delle fonti segue infatti un criterio che si gioca sulle parole chiave di «movimento»,
«mondo» e «corpo». Tre parole care agli studi fenomenologici qua talis e ancor più
care a Jan Patočka, il quale arrivò a fare della possibile mediazione tra le istanze
speculative di Husserl e di Heidegger, e del loro superamento, uno degli scopi
esplicitamente dichiarati del proprio lavoro filosofico.
Qui il «movimento» porta al «mondo» e il «mondo» porta (o meglio riconduce)
al «corpo». Il movimento porta al mondo perché è “movimento vivo”, ripensato
come «il filo conduttore per definizione dei nostri incontri nel mondo». È un movimento che si estende oltre e al di là del moto della res extensa, e che include «i
moti dell’animo» di brentaniana memoria, «le emozioni e le commozioni» e la vita
stessa intesa come «viaggio e pellegrinaggio»: anche per Patočka, non c’è dubbio,
«Dasein ist immer unterwegs». Il mondo d’altra parte riconduce al corpo. Il mondo
stesso è la «totalità delle possibilità mie», delle possibilità che il mondo stesso dà a
me essere “incarnato”, a patto che io «le individualizzi in me».
Dal movimento al mondo e dal mondo al corpo, l’analisi fenomenologica di
Patočka perviene poi a un quarto e decisivo aspetto: l’aspetto della storia, che è
storia del fare e del pensare, dell’essere come dell’agire. «La filosofia entra nella
storia»; «prima della filosofia l’uomo vuole sapere e immagina che sa», ma solo con
la filosofia l’uomo «comprende». E questa comprensione non è qualche cosa che
si possa improvvisare.
Per Patočka come per Husserl, essa richiede infatti l’acquisizione di una specifica «postura» e l’assunzione di un atteggiamento speculativo ben preciso: la Einstellung fenomenologica, sul ritmo della quale anche l’antologia si chiude. Per Jan
Patočka la fenomenologia non è infatti una filosofia. È piuttosto un modo sempre
antico e sempre nuovo di accostarsi al mondo naturale e al mondo storico partendo da quella presunzione di innocenza nei suoi riguardi che in gergo tecnico
potremmo chiamare “attendibilità” del mondo stesso rispetto a colui che lo coglie,
il soggetto conoscente.
Lodovica Maria Zanet
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
Antonio Pavan – Emanuela Magno (a cura di), Antropogenesi. Ricerche sull’origine e lo sviluppo del fenomeno umano, Il
Mulino, Bologna 2010. Un volume di pp. 672.
Riflettere sull’origine dell’essere umano (sull’antropogenesi, appunto) significa
riflettere, in ultima istanza, su ciò che caratterizza l’uomo in quanto uomo e, al
contempo, sul «destino» dell’umanità in relazione ai mutamenti ambientali, tecnologici e culturali del tempo presente. Il pensiero del nostro secolo, infatti, sembra
dominato in maniera sempre più pressante dalla cosiddetta «questione antropologica»: il nostro tempo, scrivono Elena Magno e Antonio Pavan, «è tempo in cui
ne andrebbe dell’essenza stessa dell’uomo e in cui ne va, ed è in gioco, l’umanità
dell’uomo», poiché «ci interroghiamo sempre più su che cosa costituisca l’umanità
dell’uomo; su che cosa ne stiamo facendo dell’umanità dell’uomo, in età tecnologica» (p. 11). E «sembra succedere che quanto più l’uomo [...] pare avvicinarsi alla
possibilità di prendersi in mano in una sorta di inedita “generatività artificiale” e
di nuova potenza di pianificazione razionale, anche biologica, anche mentale, di sé,
tanto più entri in una sconosciuta perplessità, fino all’angoscia, circa il futuro della
sua umanità» (ibidem). Fin qui, dunque, questo volume collettaneo sull’antropogenesi non pare aggiungere alcunché alla posizione della questione antropologica. Le
domande filosofiche sull’essenza dell’uomo, del resto, pur dettagliandosi sempre
più nel corso dei secoli e pur aggiungendo sempre nuovi elementi alle loro formulazioni (elementi che spesso accrescono le difficoltà, più che diminuirle), restano
sostanzialmente immutate: cos’è l’uomo? Cosa distingue l’uomo dagli altri viventi?
Qual è il corretto modo di intendere, rispettare e valorizzare l’umanità dell’uomo?
Le nuove possibilità di intervento tecnologico degli uomini sugli uomini non modificano tali interrogativi, ma rendono sempre più urgente (e complicata) qualsiasi risposta. La filosofia della tecnica contemporanea, insomma, non pare sancire
una «morte dell’uomo», ma, al contrario, pone sempre più in rilievo la centralità
dell’essere umano, definito in maniera più o meno vaga e variegata, in modo esplicito o implicito, anche laddove ci si concentri sulla fine del concetto di «essere
umano», esaltando o demonizzando la tecnica. Anche perché (ci sia consentito
questo breve rilievo) la dismissione di un concetto di «uomo» (o del concetto di
«uomo» in generale) non implica la cessazione della realtà umana: l’uomo continua a esistere, come agente e fondamento della tecnica, anche quando i filosofi, gli
antropologi o gli scienziati non se ne accorgono.
Il percorso di indagine proposto nel libro, tuttavia, è degno di nota: non si parte,
in questo caso, da una data definizione dell’essere umano (come «animale razionale», ad esempio), allo scopo di verificare la legittimità di tale definizione dinnanzi
Philosophical News
RECENSIONI
207
ai progressi della scienza e della tecnica. Al contrario, si esaminano i molteplici
aspetti del fenomeno umano e delle sue origini, per elaborare un fondamento di
risposta largamente condiviso alla «questione antropologica». I differenti orientamenti degli autori e le loro differenti competenze (si tratta pur sempre di un lavoro
interdisciplinare) rendono notevolmente complicata qualsiasi risposta univoca. I
curatori, nondimeno, sembrano individuare una sorta di unità di intenti nella comune opposizione ai riduzionismi contemporanei del fenomeno umano: l’umanismo spontaneista (che intravede la specificità dell’umano in elementi indefinibili
e non investigabili concettualmente), il post-umanismo (che accetta il superamento dell’umano mediante la tecnica), il naturalismo neuro-mentalistico (che riduce
l’uomo alle sue componenti fisiche, chimiche e biologiche), l’umanismo soprannaturalista (che rende sempre più radicale la distinzione tra natura e spirito) (cfr. p.
12). Questi riduzionismi, tuttavia, paiono condividere una tesi di fondo: l’essere
umano (in tutte le sue componenti o in una sua componente soltanto) può essere
spiegato deterministicamente tramite lo studio dei processi semplici che lo hanno
originato. L’uomo, insomma, non sarebbe altro che la somma di elementi nonumani più o meno semplici, i quali, per una sorta di necessità intrinseca, si sarebbero uniti e avrebbero prodotto una struttura complessa come quella umana. Questo
riduzionismo deterministico, in effetti, è il padre di ogni altro riduzionismo, sia di
quel naturalismo e di quel post-umanismo che si rifanno espressamente a esso, sia
di quegli umanismi spontaneisti o soprannaturalisti che intendono circoscriverne
la portata, dando a esso partita vinta in ambito scientifico.
Pavan e Magno, in questo senso, intravedono la «dismisura» dell’uomo proprio
nel fatto che egli emerge come possibilità a partire dalla natura e si radica come
soggetto di possibilità rispetto a se stesso, alla natura e a ciò che trascende entrambi. Se si riesce a mostrare che l’uomo è un ente «possibile» (e non già un risultato
necessario) rispetto ai suoi processi di generazione, si può anche preservare quella
libertà dell’uomo sui possibili che, altrimenti, in un meccanicismo naturalista, sarebbe ridotta a mera illusione, legittimando qualsiasi intervento di modificazione
della natura (non-umana e umana). L’uomo emerge dalla natura pre-umana e, di
fatto, la trascende sotto numerosi punti di vista. Se non vi fosse alcun limite e se
tutto fosse già scritto nel libro della natura, pertanto, non potrebbe esservi affatto alcuna «novità umana», né alcuna novità introdotta dalla libertà dell’uomo: la
tecnica prolungherebbe semplicemente l’opera della natura, finanche rivoltandosi
contro i suoi agenti (gli uomini) e determinandone l’estinzione. Una natura intesa
deterministicamente, insomma, e ricomprendente il fenomeno umano tout court,
ci sembra essere null’altro che l’immagine riflessa di una tecnica che provvede
soltanto ad alimentare se stessa e a crescere indefinitamente nelle proprie potenzialità, fino alla distruzione dell’uomo e, con l’uomo, di se stessa. Le categorie di
«emergenza», «eccedenza» e «invenzione» tracciano il profilo dell’antropogenesi:
l’invenzione (che rivela nuove virtualità nell’essere, strutturando la materia) «da
emergenza e per (par) eccedenza, dice dell’essere come novità, cioè anzitutto come
possibilità» (p. 19). Nell’uomo, allora, «appaiono nuovi potenziali, appare una forma aperta e inconclusa che non ama essere ribattuta sul solo ricevuto (da natura),
che non ama essere violata e occlusa nella sua trascendenza (da avventura) (p. 21).
208
RECENSIONI
Philosophical News
Non possiamo certamente ripercorrere tutte le tappe del movimento dell’antropogenesi, così come viene descritto nel libro a partire dall’origine dell’universo,
passando per i grandi racconti delle religioni e per lo studio dell’evoluzione biologica e antropologica, fino a soffermarsi sulle «forme» tipiche dell’umano. Preferiamo esaminare gli spunti filosofici forniti da alcuni saggi, che non sono di certo
le uniche parti rilevanti del libro, ma che offrono, a nostro avviso, un importante
contributo al dibattito sulla «questione antropologica».
Nel saggio di Antonio Pavan «Del sé che dice io» (pp. 411-427), la distinzione
tra la coscienza e il sé, da un lato, e l’io, dall’altro, si manifesta nell’autoriflessività
di quest’ultimo: «dire io implica sempre, e anche, una condizione come di ritorno
della coscienza su se stessa, o una presa di coscienza del proprio essere coscienti»,
che «non solo è il luogo della sopravvenienza dell’io, ma insieme è il luogo della
rivelazione del sé che, nell’io e attraverso l’io, si dà a vivere e pensare come sfondo
dell’io» (p. 411). Per questo motivo, «un semplice coscienzialismo psicologistico
non fa un io propriamente umano» (ibidem). In altri termini, «la criticità cruciale
della forma umana è il suo stesso dire io, è la sua stessa egoità; o altrimenti: è il suo
prendere coscienza e il farsi una ragione della sua stessa pretesa di consistenza» (p.
415). L’io, tuttavia, è risvegliato a se stesso dal proprio essere-nel-mondo, al punto
di intersezione tra il sentire (la dimensione estetica), il fare o l’agire (la dimensione
pragmatica) e il sapere (la dimensione noetica) (cfr. p. 414). L’io, pur avvertendosi
come il centro unificatore del mondo, percepisce nondimeno anche la propria contingenza: il mio «io» è uno dei tanti centri di condensazione dell’energia dell’universo, destinato a manifestarsi e a morire. Il soggetto, allora, cioè quel «riferimento
funzionale ai processi del farsi e del mutare delle cose e delle forme» (p. 419), non
può essere mai colto esclusivamente in una dimensione staticamente concettuale,
giacché il soggetto «dice nel sé la dimensione costituente di tutta la fenomenalità
attraverso la quale l’io si adempie e si manifesta e si viene facendo nella sua consistenza» (ibidem). Tutti gli uomini sono «eventi dell’energia di fondo» (p. 420), ma
«nessuna forma, per elementare che sia la sua costituzione, è energia semplicemente, o al fine, contratta, contenuta, addomesticata nella perfezione di un peras manifesto» (p. 421). Tutte le manifestazioni dell’energia sono potenzialmente accompagnate dalla seità, preparano la seità, che giunge ad autocoscienza solo nell’io, in
cui l’energia «continua la sua espansione, la sua invenzione generando nuova vita e
nuove possibilità» (p. 425). L’io, pertanto, è una «novità» all’interno della natura,
ma non è distaccato dalla natura stessa: la natura è permeata da quell’energia, che
prepara la libertà manifesta nell’uomo e che, nell’uomo, continua a operare. In
questa visione dell’essere umano, dunque, non vi è né dualismo, né monismo: il
concetto di «natura» viene espanso al di là di un semplice determinismo meccanicista e incontra (pur non causando da sé) il fenomeno umano.
La novità umana, poi, è colta da Roberta De Monticelli nella dimensione dell’atto (pp. 467-482): la persona «emerge come una realtà di tipo nuovo da una base
neurobiologica specifica» e «viene ad esistere come un tipo essenzialmente, ontologicamente nuovo di ente rispetto alla sua base» (p. 467). Una persona è un
soggetto di atti che emerge sui propri stati e, nella fattispecie, l’identità personale
emerge negli atti liberi (cfr. p. 468). La persona prende posizione sui propri stati
Philosophical News
RECENSIONI
209
e, decidendo, trasforma gli stati in motivi efficaci di azione (ferma restando la distinzione tra l’atto e l’azione). Il soggetto è tale, solo e soltanto se prende posizione
sui propri stati e «una persona è un soggetto d’atti» (p. 475). Tra i diversi livelli di
atti, gli atti liberi in senso stretto sono quegli atti mediante i quali ci autorizziamo
«a fare qualcosa dei dati fattuali e valoriali», «a fare qualcosa di noi stessi» (p. 478).
Se gli atti in generale sono prese di posizione sulla vita affettiva e cognitiva, gli atti
liberi sono «prese di posizione del secondo livello», che consentono alle persone
«di intervenire sul corso della loro vita sia modulando l’esposizione all’impatto affettivo e cognitivo, “gestendone”, per così dire, anche la sfera passiva e contribuendo per questa parte alla formazione della propria identità personale; sia dirigendo
la loro vita col fare qualcosa dei dati e, insieme, inevitabilmente, di se stessi» (p.
481). Lo stato, allora, non spiega l’atto, così come l’insieme degli stati naturali non
motiva, né determina l’origine della persona. La persona «emerge» sui propri stati
e, in questo senso, li trascende.
Carmelo Vigna, infine, coglie la specificità dell’umano nello studio della dinamica del desiderio (pp. 599-607). In un breve trattato dal forte impatto speculativo,
Vigna distingue anzitutto l’impulso dal desiderio: l’impulso è un «desiderio cieco»,
«che vive e viene innanzi non perché tratto avanti da un “oggetto” conveniente,
come è ad esempio il cibo per l’affamato, ma da una qualche misteriosa vis a tergo»
(p. 599). Il desiderio, al contrario, vede il proprio oggetto e lo intenziona: esso è
governato dalla causalità finale. L’oggetto è un «altro positivo», determinato in
molteplici forme, ma il desiderio è libero rispetto ad esso, a meno che l’oggetto
desiderato non sia «il tutto». Il desiderio, allora, non può arrestarsi a un oggetto
determinato, «ma cerca anche un oggetto che sia in qualche modo una totalità
o alcunché di intero» (p. 603), un oggetto a esso conveniente (simile a sé) e sul
quale eccedere (altro da sé): questo oggetto è «l’altro come soggetto, ossia un altro
essere umano» (ibidem). Il soggetto del desiderio può trascendere il mondo solo
se si rapporta a qualcosa di adeguato al «suo essere un orizzonte trascendentale»
(p. 605), a un’altra soggettività. Gli uomini, tuttavia, possono garantire soltanto
un appagamento parziale al desiderio di infinito e di eternità: il desiderio umano,
allora, «chiede alla ragione di proseguire nella ricerca di un Altro che finalmente lo
possa rassicurare ed appagare» (ibidem). Il desiderio, in definitiva, non riposa sul
nulla, né su qualcosa di inadeguato a se stesso, così come non può accontentarsi né
della coscienza del nulla, né della coscienza del finito: il suo tragitto tende sempre
a una mèta, a una destinazione ulteriore, che può essere tale, solo e soltanto perché
l’origine stessa dell’uomo rimanda a una forma di ulteriorità. Interrogarsi sull’antropogenesi, allora, equivale a interrogarsi sulla presenza dell’infinito nel finito e
sulla possibilità di una libertà, come quella umana, che solo muovendo dall’infinito
e dai suoi segni può risultare fondata e valorizzata.
Michele Paolini Paoletti
Università degli Studi di Macerata
[email protected]
Georg Sans, Al crocevia della filosofia contemporanea, Gregorian & Biblical Press, Roma 2010. Un volume di pp. 328.
Quello di cui parleremo è un libro di storia della filosofia contemporanea, e
l’oggetto stesso è già di per sé meritevole d’attenzione.
Potrebbe sembrare che il primo requisito per scrivere di storia sia la distanza tra
colui che scrive e ciò di cui scrive, perché verrebbe così garantita quell’oggettività
necessaria per distinguere la storia dalla testimonianza: interessanti e importanti entrambe, non vanno però confuse. La prima distanza da frapporre dovrebbe
allora essere quella temporale, per cui diventa arduo scrivere una storia contemporanea che non voglia essere né la cronaca di quanto registrato né il racconto di
quanto vissuto: come nel caso della cronaca ci si limiterebbe alla raccolta di informazioni che spetterebbe ad altri valutare, così nel caso del racconto si offrirebbe la
propria voce che spetterebbe ad altri ascoltare. È dunque lo spettro dell’oggettività
a turbare chi si accinge a scrivere di cose recenti e voglia che il suo discorso abbia
un valore non esclusivamente personale. Evitare la partigianeria o più semplicemente l’avventatezza pare difficile se non impossibile.
Se poi ci si accinge a scrivere di storia della filosofia, la matassa si ingarbuglia ulteriormente, giacché neppure la distanza temporale sembra sufficiente a garantire
la pretesa di oggettività e attendibilità, e molto spesso le nostre storie della filosofia
rischiano di dire più di noi che le scriviamo che non di coloro di cui scriviamo.
Ma anche questa, ormai, è cosa nota e sostanzialmente irrimediabile: si tratta di
mantenere un certo equilibrio e di essere parchi e morigerati, da un lato, e di non
limitarsi a un riassunto sostitutivo o alla mera riedizione di testi perduti, dall’altro.
Insomma, senza scomodare Dilthey, se scrivo la storia della vita di Alessandro
Magno, non avendo vissuto quegli eventi e dovendoli ricostruire, tenterò in qualche
modo di “sostituirmi” a lui e cercherò di farlo nel modo più accurato e pertinente,
selezionando quegli aspetti che considero rilevanti, per esempio non parlando di
chi gli sellava il cavallo o di come erano vestite le sue guardie di scorta; ma se scrivo
di chi lo ha istruito, Aristotele, anzi non di lui ma del suo pensiero, non avendo
pensato quello che lui ha pensato e dovendolo ricostruire, la mia “sostituzione” a
lui e la mia “selezione” degli aspetti rilevanti sono senz’altro più problematiche,
perché entrambi – Aristotele ed io – stiamo pensando e selezionando… e non essendo il mio pensare e selezionare il suo, è quasi necessario che il mio sostituirmi a
lui acquisti il volto del tradimento. Posso certamente dire: Volete sapere quel che ha
pensato Aristotele? Be’, leggetevelo!, e questo invito – anche se sgarbato – avrebbe
un senso, mentre suonerebbe molto più paradossale se dicessi: Volete sapere quello
Philosophical News
RECENSIONI
211
che ha fatto Alessandro Magno? Be’, andate in Macedonia nel IV secolo avanti Cristo
e corretegli dietro. La mediazione dello storico tout court sembra necessaria e accettabile, mentre quella dello storico della filosofia crea più diffidenza e ci si aspetta
che sia ancora più circospetta.
Se il discorso si potesse concludere con un invito all’aurea mediocritas, non si
spiegherebbe come e perché sulla storia e sullo scrivere di storia si siano impegnati
così tanti e tali ingegni, e come altrettanti continuino a dedicarsi all’improba fatica
di spingere il masso di Sisifo su per la rupe. Alla fine, forse è meglio semplicemente
far finta di niente, mettere in conto le difficoltà che ci aspettano confidando nella
nostra buona stella e porci all’opera: questa verrà poi giudicata e valutata o magari
bellamente dimenticata. Del resto, si può anche centrare un bersaglio importante pur avendo mirato altrove: chi potrà mai dire che non vale la pena di leggere
Dialettica dell’illuminismo perché l’illuminismo di cui parla non è mai esistito e
ogni storico del Settecento alza più d’un sopracciglio quando glielo si nomina? E
chi mai dirà che non si impara nulla dalle lezioni hegeliane di storia della filosofia
perché il peso dell’aggettivo hegeliano è troppo gravoso e l’autore è un Procuste,
geniale sì, ma pur sempre sanguinario?
Consapevole dei rischi, anche Georg Sans si è cimentato nell’impresa, raccontando la sua storia della filosofia contemporanea con un libro che nasce dalla
sua attività didattica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Lo fa
affrontando di petto la difficoltà lampante di un oggetto sfuggente e multiforme
di principio, la filosofia, occupandosi proprio del punto di cui è ancor più difficile
scrivere, la contemporaneità. Egli propone l’immagine del crocevia (donde il titolo
del volume) costituito dalle tre linee fondamentali di sviluppo del pensiero degli
ultimi duecento anni, a partire cioè dalla stagione del “pensiero puro” dell’idealismo speculativo, che viene diversamente criticato e “superato” secondo direzioni
accomunate dal punto di partenza e dal volersene allontanare, ma che poi procedono secondo proprie autonome dinamiche, rispettivamente come “pensiero
scientifico”, “pensiero esistenziale” e “pensiero linguistico”.
L’assunzione centrale del lavoro, dunque, non è semplicemente quella per cui
con Hegel giungerebbe al proprio compimento e alla propria massima espressione
un progetto e un’idea di ragione successivamente abbandonato, per cui lo storico dovrebbe seguire le diverse e successive vie battute dal pensiero filosofico;
Sans propone invece una connessione più forte, perché «la filosofia, dopo Hegel,
è sostanzialmente una reazione a Hegel» (p. 5). Se questa tesi, in senso stretto, è
storicamente discutibile (giacché v’è anche una parte dell’Ottocento e del Novecento che non subisce un influsso hegeliano né positivo né negativo), essa si rivela
però euristicamente feconda a livello meta-filosofico, ed è una bussola che effettivamente permette di orientarsi in un dibattito così caleidoscopico come quello
contemporaneo. Sans cerca di evitare una mera rassegna dossografica di vari autori
e correnti che si limita alla sequenza cronologica: se allora quel che accomuna la
contemporaneità è il rifiuto dell’idea di «pensiero puro» che trova in Hegel il suo
apice, può esser considerato indifferente che sia ingaggiata direttamente con lui
una polemica oppure no, ed è possibile raggruppare autori e correnti in base al
modo in cui hanno elaborato un pensiero non più «puro», proponendo una filo-
212
RECENSIONI
Philosophical News
sofia di volta in volta incentrata sulla scienza empirica, sull’esistenza umana o sulla
dimensione linguistica.
Il volume si apre dunque con la parte dedicata al «pensiero puro» (pp. 19-92),
e affronta dapprima i presupposti kantiani dell’idealismo e le reazioni alla filosofia
critica (anche circa il rapporto tra fede e ragione), poi l’esigenza dell’assolutezza
del fondamento e della sistematicità del suo svolgimento che emerge con Fichte e
prosegue con la multiformità del percorso di Schelling, per giungere finalmente a
Hegel, a partire dalla cui logica speculativa si chiariscono il senso della dialettica e
la portata della Fenomenologia dello spirito, passando quindi alla sua filosofia politica (di cui si esplicitano i nessi col dibattito tra liberali e comunitari) e alla frattura
tra destra e sinistra hegeliane, in particolare sulla questione della religione come
«rappresentazione», considerando Strauß e Feuerbach. Il tema dominante di questa stagione è lo spinoziano (ma già neoplatonico) , l’aspirazione cioè
alla comprensione della parte nel tutto che si esprime tanto a livello ontologicometafisico che gnoseologico.
Fin qui il discorso di Sans segue – efficacemente – una narrazione consolidata;
è con la seconda parte, riservata al «pensiero scientifico» (pp. 93-172), che manifesta la sua originalità. Se in generale questa impostazione si definisce in relazione
ai progressi delle scienze, per cui qualsiasi riflessione filosofica deve partire dagli
esiti delle scienze positive, si tratta di vedere in particolare come ne venga seguito
lo sviluppo. Vengono distinte due direttive principali: la prima è quella che individua il riferimento della filosofia nelle scienze sociali e nella storia, dove presenta
il positivismo di Comte e il liberalismo di Mill, per proseguire con il socialismo
di Marx (sottolineando il retaggio hegeliano del tema dell’alienazione), passando
poi allo storicismo di Dilthey e alla sociologia di Weber (di cui si approfondisce
l’analisi delle origini del capitalismo), per giungere alla Scuola di Francoforte e
alla teoria dell’agire comunicativo di Habermas; nella seconda linea la filosofia si
confronta invece con le scienze naturali e la matematica e vengono considerati l’empirismo logico (da Frege, Russell e il Circolo di Vienna fino al naturalismo di Quine), la filosofia della scienza (dal verificazionismo neoempirista al falsificazionismo
popperiano e all’analisi kuhniana delle rivoluzioni scientifiche, approfondendo la
questione del realismo) e infine il pragmatismo (Peirce, James e Dewey, ma anche
Putnam e Papini).
Qui il criterio proposto mette alla prova la sua efficacia, giacché le connessioni e gli apparentamenti sono meno scontati o consolidati: la scelta di collegare il
positivismo a Marx e allo storicismo, infatti, non è banale e risponde allo sforzo
di individuare un tratto comune nell’approccio scientifico alla realtà (umana, in
questo caso) diverso da quello hegeliano, mirando a un sapere positivo e non assoluto. In ogni caso, il neoempirismo e il suo sviluppo restano distinti e di fatto non
assimilabili al primo schieramento, e questo non solo perché nel secondo il collegamento a Hegel è praticamente assente (può esserci il dato biografico di alcuni
dei suoi esponenti che sono stati idealisti, ma certo il loro pensiero non si svolge
in contrapposizione a lui, ma su tutt’altre premesse), ma anche perché l’idea di
scienza dei due gruppi è troppo diversa e può essere considerata come la stessa
cosa solo se elevata a un livello che probabilmente nessuno dei due avrebbe rite-
Philosophical News
RECENSIONI
213
nuto condivisibile. Questo è invece proprio il livello che Sans prospetta: sarebbe
una scelta illegittima solo se venisse affermato che tale concetto è condiviso dagli
autori considerati, ma non lo è perché il punto di vista dello storico non è sullo
stesso piano delle concezioni esaminate, di cui al contrario egli cerca di mettere in
risalto le differenze e specificità; il difetto sarebbe nell’appiattire le concezioni che
si esaminano sulla propria, ma questa non entra in gioco se non per organizzare e
rendere possibile il confronto.
La storia del «pensiero esistenziale» (terza parte, pp. 173-238) procede dalla
netta opposizione non solo alla filosofia hegeliana ma anche a quella scientifica,
di cui si mette in questione il comune presupposto: la fiducia nella capacità della
ragione di conseguire una verità. Vengono presentati quindi Nietzsche e Kierkegaard come precursori dell’esistenzialismo novecentesco, che viene poi esaminato
nell’opera di Heidegger, Sartre e Lévinas, non prima di aver affrontato Husserl e
la fenomenologia.
E qui chi scrive trova un inciampo, personalissimo, che gli rende il percorso più
accidentato del previsto. Si tratta però di un ostacolo per me, che a molti invece
potrà non apparire tale. Ciò che mi lascia perplesso è considerare Husserl come
«la terza figura da annoverare tra i precursori dell’esistenzialismo» dopo Nietzsche e Kierkegaard (p. 174), anche se Sans non manca di sottolineare sia la sua
irriducibile specificità, sia il modo in cui i suoi «seguaci» ne hanno trasformato il
progetto in una direzione che il fautore di una «filosofia come scienza rigorosa»
non avrebbe certamente condiviso; non avrei poi dedicato lo stesso numero di
pagine a Husserl (pp. 197-206) e a Lévinas (pp. 229-238), ma anche questa è una
scelta che potrebbe invece sposata da molti fenomenologi di oggi: che il cammino
della fenomenologia sia quello delineato in questo libro è forse proprio il modo
in cui maggioritariamente l’attuale fenomenologia concepisce se stessa. Resta incontestabile che il pensiero di Husserl è oggettivamente il riferimento prossimo di
Heidegger, Sartre e Lévinas. Al limite, si potrebbe porre la questione se tale pensiero si esaurisca nell’essere condizione di possibilità dell’esistenzialismo, ma non
si potrebbe considerare tale rilievo pertinente se fosse sollevato dal punto di vista
teorico e resterebbe solo da valutare se la scelta regge da quello storiografico: bisogna cioè domandarsi se si capisca meglio Husserl mettendolo in relazione a Frege
e a Russell o connettendolo a Kierkegaard e Heidegger. Sans opta per la seconda
possibilità, io preferirei la prima, e questo è quanto.
L’ultima parte considera il «pensiero linguistico» (pp. 239-316), che muove dalla considerazione del ruolo centrale del linguaggio non solo nell’espressione ma
anche nella formulazione del pensiero: da questo punto di vista, sono considerate
complementari la filosofia «analitica» e quella «continentale». Il profilo della prima
è tracciato a partire dall’opera di Wittgenstein (di cui si esaminano le cosiddette
due fasi, del Tractatus e delle Ricerche filosofiche) e se ne seguono gli sviluppi nella
filosofia del linguaggio ordinario, in particolare soffermandosi su Austin e Ryle,
passando poi alle questioni affrontate dalla filosofia della mente (la critica ryleana
al dualismo, il comportamentismo, il materialismo e il funzionalismo con Turing,
Nagel e Davidson) e dalle teorie del significato (approfondendo Frege, Russell e
Kripke). Passando alla tradizione continentale vengono presentate l’ermeneutica
214
RECENSIONI
Philosophical News
di Gadamer e Ricoeur (ma già di Schleiermacher, Dilthey e Heidegger), lo strutturalismo dalla linguistica di Saussure alle altre scienze umane con Lévi-Strauss, Barthes, Lacan e Foucault, fino ad arrivare alla decostruzione di Derrida e al pensiero
postmoderno con Lyotard e Vattimo.
La contrapposizione tra i cosiddetti “analitici” e “continentali” è ormai un punto acquisito del dibattito attuale e della storiografia filosofica che tenta di occuparsene, anche se la definizione stessa delle due famiglie è problematica, se i loro
contorni non sono sempre così netti e se ultimamente vi sono tentativi di dialogo
importanti, improntati al superamento delle unilateralità caratteristiche di qualche
decennio fa. In effetti stiamo forse entrando in una nuova fase, anche se i frutti
di un incontro sembrano al momento ancora modesti o di difficile valutazione.
Si potrebbe dire che, in realtà, l’opposizione tra analitici e continentali non sia
che una ripresa di quell’opposizione che aveva già diviso “scientifici” ed “esistenziali”, solo in una nuova veste che attribuisce la centralità al linguaggio, peraltro
inteso (e usato) in due modi quasi incommensurabili. Ci troviamo qui di fronte a
un problema analogo a quello incontrato relativamente al termine scienza: se là si
trattava di impostare un livello ulteriore e un concetto più ampio o astratto per
ricomprendere sia Marx e lo storicismo sia il neoempirismo e il pragmatismo, qui è
necessaria una mossa analoga con il termine linguaggio, che è una cosa assai diversa
per Wittgenstein e per Derrida, ma che può diventare la stessa per Sans che scrive
di loro. Come che sia, pur con tali precisazioni, il linguistic turn è proprio il punto
che accomuna e che, dal punto di vista del racconto di Sans, è preponderante rispetto a quanto divide: si possono connettere all’esistenzialismo l’ermeneutica e la
decostruzione intendendole come suo sviluppo, ma è stimolante presentarle invece
in relazione alla filosofia linguistica e, anche qui, va valutato è se questa scelta sia
migliore rispetto all’altra in vista della loro comprensione.
Lo scopo del libro è in effetti di «mettere in luce una logica insita nello sviluppo
del pensiero contemporaneo» (p. 239) ed è chiaramente necessario operare una
ricostruzione del suo percorso che evidenzi e privilegi certi nodi teorici a scapito
di altri; altrettanto chiaro è che tutto questo non sarebbe possibile senza una personale opzione filosofica. Sans è convinto che «la pretesa di elaborare un sistema
puramente razionale […] continua a essere una valida alternativa teorica sia al
naturalismo sia all’ermeneutica» (p. 13): correttamente, non mette però in gioco
questa sua posizione nella presentazione del pensiero altrui; semmai la sua filosofia
è quella che gli permette di impostare le coordinate del racconto, e quindi si deve
solo valutare se essa permetta un orientamento efficace al lettore e crediamo che
sostanzialmente vi riesca.
Sans sottolinea poi come oggi il filosofo debba comunque compiere una scelta
rispetto alle quattro possibilità che la contemporaneità gli prospetta – e questo è un
dato di fatto; interessante è però quello che gli chiede, e cioè che sposi un pensiero
puro, scientifico, esistenziale o linguistico in base a motivi che siano razionalmente
argomentabili e che critichi le alternative in base a considerazioni razionali. Ove
così non fosse, si sarebbe abbandonata l’impresa filosofica, che si può diversamente modulare, ma che deve comunque trovare nella ragione (seppure variamente
intesa) un «punto di riferimento comune a tutti»; questa esigenza è avanzata nelle
Philosophical News
RECENSIONI
215
ultime pagine del volume, dedicate alla discussione del pensiero postmoderno, cui
si oppone la lecita speranza «che la modernità non sia finita» (p. 316). Pur non
sposando completamente la sua preferenza per un pensiero puro, si tratta di un
auspicio che chi scrive condivide e che spera siano in molti a sottoscrivere.
Lorenzo Fossati
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
Holger Zaborowski, Robert Spaemann’s Philosophy of the
Human Person. Nature, Freedom and the Critique of Modernity, Oxford University Press, Oxford-New York 2010. Un
volume di pp. 293.
Holger Zaborowski, assistant professor alla Catholic University di Washington,
raccoglie in questo volume un percorso attorno ai temi che costituiscono la trama dell’intero cammino speculativo di Robert Spaemann. Gli scritti spaemanniani
sono preferibilmente brevi saggi e articoli nei quali dall’argomento in questione la
riflessione si allarga fino a toccare nodi fondamentali e fenomeni ampi. La struttura del volume di Z., così come l’organizzazione interna di ciascuno dei capitoli, riflette questo carattere del filosofare spaemanniano; le questioni si rimandano
e intrecciano tratteggiando un quadro denso ma che l’autore riesce a mantenere
chiaro e coerente.
Nel primo capitolo, intitolato Philosophy in a time of crisis, Z. presenta la filosofia di Spaemann come una riflessione sulla modernità e sulla sua fine. Egli osserva
come Spaemann insista sulla carenza autofondativa del moderno per evidenziare
come sia questo problema a generare il carattere astratto della sua riflessione e
a metterne in moto la dinamica dialettica. I concetti cardine della speculazione
filosofica infatti, quando vengono pensati entro tale paradigma, tendono a subire un incontrollabile capovolgimento di significato nella loro traiettoria storica.
La modernità, inoltre, continua ad aver bisogno, per l’intelligibilità e operabilità
stessa della sua proposta, di quel fondo di cultura e di umanità che essa tenta di
smontare. Per questo nel secondo capitolo, intitolato Conversation, recollection,
and the search for happiness: Spaemann’s understanding of philosophy, Z. qualifica
il pensiero di Spaemann come un pensiero “rammemorante”, un movimento nella direzione della comprensione di sé e del mondo nei loro contenuti irriducibili
a una ragione astratta e funzionalizzante. Queste caratteristiche lo avvicinano ad
alcune istanze fondamentali della fenomenologia, anche se Z. preferisce definire
la filosofia di Spaemann come un metaphysical realism, come un’ontologia che si
connette essenzialmente all’etica in virtù della convinzione che è nell’essere personale che la realtà dischiude la sua pienezza. Ciò delinea le due strade intraprese dal
filosofare spaemanniano: la prima è quella della distruzione della «representation
of Being as process, not only by means of a close historical analysis of how this
representation of Being developed but also by shedding light on its implications,
which are counter-intuitive in so far as they contradict the way human beings always already understand themselves» (p. 42). Per l’autore è a questo percorso che
devono venire riallacciate le serrate critiche che Spaemann indirizza agli approcci
genealogici all’ontologia e all’etica, caratteristici, ad esempio, delle riflessioni di
Philosophical News
RECENSIONI
217
Nietzsche e Luhmann, o, più specificamente, le obiezioni all’utilitarismo. La seconda strada è quella positiva di una «reconstruction of a realistic understanding of
Being by means of a recollection of what Spaemann considers self-evident – that
is, the experience that reality is ultimately not an endless stream of becoming, but a
mixtum compositum of substantial Being and becoming. It is a reality of substances
and subjects and, in its highest form, the reality of persons who freely ‘have’ their
nature» (p. 42).
Z. ritiene che ciò possa mostrare le analogie con i percorsi di Charles Taylor e,
con qualche distinguo, di Alasdair MacIntyre. Il punto comune è quello di una
riproposizione delle nozioni chiave della tradizione metafisica ed etica in un contesto, come quello moderno (o di fine della modernità), che pur “iconoclasticamente” perseguitandole, continua ad affannarsi senza successo nel tentativo di
surrogarne la validità epistemologica e deontologica. La filosofia spaemanniana,
nell’analisi di Z., è quindi un “far memoria” di ciò che è in sé evidente che si oppone al carattere costruttivistico della filosofia moderna, la quale assegna a se stessa il
ruolo di dichiarare quali esseri umani siano persone. L’originalità naturale dell’esser-persona per Spaemann non è tuttavia qualcosa di naturalistico proprio in virtù
della piena (e autoevidente) qualità teleologica del concetto di natura. Z. osserva
che ciò che la filosofia spaemanniana si è impegnata a realizzare è stata proprio la
riscoperta della natura come condizione teleologicamente normativa della libertà.
Si tratta di una riscoperta che può avvenire solo ermeneuticamente e non attraverso la ragione deduttiva in quanto, appunto, ciò che vale come evidenza, seppur
obliata, può essere solo mostrato o riportato alla memoria. Si radica qui, secondo
Z. la riproposizione spaemanniana del tema del “giusto di natura” secondo una
prospettiva feconda dal punto di vista critico e, allo stesso tempo, originale nella
sua classicità. Z. osserva inoltre che la fisionomia ermeneutica della praxis filosofica
spaemanniana le fornisce quel carattere di “conversazione” che la distanzia tanto
dai tentativi di Apel e Habermas quanto dal decisionismo schmittiano.
Questa concezione socratico-platonica della filosofia è quella con la quale Spaemann entra tra le maglie del pensiero moderno con la convinzione di aver evitato in
partenza le trappole riduzionistiche, recuperando una conoscenza «that provides a
measure and criterion for ‘absolute reflection’ and universal judgment, particularly
for a critique of the scientistic and functionalistic spirit of modernity» (pp. 88-89).
Nel terzo capitolo, intitolato The dialectic of Enlightenment: Spaemann’s critique of modernity and its dialectic, la fisionomia dialettica della modernità viene
mostrata come l’esito coerente del suo incedere astratto. Per Spaemann essa colpisce tutti i concetti strutturanti la tradizione filosofica occidentale (natura, storia,
libertà, ragione) radicalizzandone a tal punto i caratteri da renderli irriconoscibili
e fatalmente esposti a una procedura di uguale e contraria reductio ad nihilum da
parte di istanze opposte di pensiero, anche se, come osserva Z., Spaemann non
appartiene a coloro che criticano la modernità tout court. Alla lettura spemanniana
di Rousseau Z. dedica uno spazio giustamente ampio. Il Rousseau di Spaemann,
infatti, mostra in azione non solo i presupposti moderni del pensiero ma anche
una precisa consapevolezza della rottura con la tradizione classica, finendo per
incarnare esemplarmente anche il carattere problematico e oscillante della critica
218
RECENSIONI
Philosophical News
moderna. In tal senso egli è il padre di ogni modernismo e di ogni anti-modernismo. Nel suo cammino di pensiero si può vividamente percepire il rovesciamento
dei concetti classici di ‘natura’, ‘storia’, ‘socialità’ una volta che questi vengono
disancorati dalla loro base teleologica. Importante è anche il riferimento al ruolo
della dottrina cristiana nel valutare l’impatto della trasformazione moderna. È ad
esempio, il caso della dottrina del peccato originale la quale è per Z. questione
decisiva nell’analisi spaemanniana della modernità.
Nel quarto capitolo, intitolato Society, philosophy, and religion: Spaemann and
the dialectic of anti-modernism, Z. tratta le analisi spaemanniane dell’antimodernismo muovendo innanzitutto dalla tesi di dottorato dedicata al visconte de Bonald
e pubblicata nel 1959 (Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration. Studien über L. G. A. de Bonald, Klett-Cotta 19982; tr. it. Laterza 2002). Z.
rileva con acume che in Spaemann la tesi del carattere dialettico della modernità
si salda a un fondamento così profondo da definire anche gran parte dei tentativi
di reazione a essa. Per questo Spaemann non abbraccia l’antimodernismo. Z. riconnette i temi del volume spaemanniano del 1959 al dibattito in Germania nel
secondo dopoguerra. La ricerca di una nuova e umana fonte dell’autorità e di una
nuova immagine della società riproponevano le questioni fondamentali del fine
dell’uomo e della società, questioni per le quali una certa volontà di restaurazione
vedeva nelle chiese cristiane una forza da reintrodurre nello spazio pubblico per
riproporre e consolidare la rinascente democrazia. Z., pur osservando che in quel
testo poco rimanda ai dibattiti in atto nella Germania di allora, annovera a ragione
Spaemann tra gli scettici riguardo a una tale prospettiva. Il riferimento, sorprendentemente attuale, a Chesterton e, soprattutto, all’antimodernismo di Peguy serve a Spaemann per mettere in evidenza quel «substantial belief» nella vera libertà
che rifiuta ogni sua interpretazione funzionale alle necessità della politica. Il testo
su Bonald contiene, da questo punto di vista, secondo Z., una implicita critica
anche a Schmitt. La pretesa universale del Cristianesimo, il quale in Spaemann
è sempre riguardato come il luogo e il garante dell’inoperabilità funzionalistica
delle verità sostanziali della vita umana, subisce, in Bonald e in Schmitt, una vera
e propria assimilazione all’orizzonte politico. È però nella sociologia di Luhmann
che, secondo Z., Spaemann ha individuato il tentativo più sistematico di riduzione
funzionalistica (e nichilistica). La dissoluzione di ogni realtà a una rete di relazioni
funzionali pensate dalla prospettiva del “sistema” viene assimilata da Spaemann
alla (problematica) pretesa totalizzante del pensiero hegeliano. Essa dissolve quella
struttura d’esperienza sulla quale tanto la fede cristiana quanto la filosofia nel suo
senso più essenziale si basano.
Nel quinto capitolo, intitolato Nature, freedom, and persons: Spaemann’s philosophy of Selbstsein, Z. affronta la parte della filosofia speamanniana più recente
e nota. Di fronte ai sempre più frequenti tentativi di problematizzare e relativizzare il riconoscimento di chi è persona, Z. rileva che è l’impostazione stessa che
Spaemann offre del problema della persona a risultare caratteristica: mantenere
l’originarietà di tale nozione è questione decisiva per la possibilità stessa di esperire qualcosa come veramente reale. Nel confronto puntuale che Z. istituisce tra
Spaemann e le tesi di Parfit e Singer emerge infatti che il punto focale della que-
Philosophical News
RECENSIONI
219
stione risiede sul piano ontologico della “sostanza” vivente più che non su quello
etico-pratico. Contro l’assolutizzazione degli estremi astratti della realtà personale
concreta – materia e spirito – il pensiero spaemanniano procede, in un certo senso
fenomenologicamente, a mostrare che il dato originario della nostra personalità,
quale appare nell’esperienza di sé e degli altri come esseri viventi in un libero rapporto pratico con il mondo, si offre come presupposto persino negli stessi tentativi
di una sua riduzione in senso naturalistico o trascendentale. Sul piano più positivo
l’affermazione spaemanniana secondo la quale ogni essere umano è persona viene
ripercorsa da Z., coerentemente con l’approccio sviluppato in Personen. Versuche
über den Unterschied zwischen ‘etwas’ und ‘jemand’ (Klett-Cotta 20063; tr. it. Laterza 20072), seguendo il complesso lavoro di “ostensione” dell’identità personale
che il pensatore tedesco svolge tra le pieghe profonde dell’esperienza linguistica,
etica e conoscitiva dell’uomo. Ciò che tale lavoro incontra al fondo è la persona
come Selbstsein, come esser-sé, come identità la cui base naturale, lungi dall’essere qualcosa di distaccabile da essa, agisce piuttosto come tensione immanente
ed estatica allo stesso tempo nella direzione specificamente umana della riuscita
della vita nella sua totalità. È al «more comprehensive horizon» dell’amor benevolentiae che, osserva Z., Spaemann àncora il rischiaramento, ontologico ed etico
assieme, dell’essere personale. Scrive Z.: «One of the most fundamental arguments
Spaemann proposes for the connection between ethics and ontology is the fact
that we need to conceive the other as real, as a ‘thing-in-itself ’, not as an image of
ourselves or as a fiction, in order to have the experience of obligation towards the
other» (p. 217). Z. dedica pagine dense all’analisi spaemanniana delle esperienze
fondamentali della ‘promessa’ e del ‘perdono’. Si tratta di atti praticabili solo tra
persone, i quali tuttavia possiedono un peculiare carattere rigenerativo dell’identità personale stessa e ostensivo della sua dimensione trascendente. Nella parte
finale del quinto capitolo Z., in uno dei paragrafi più densi del suo volume, riflette
proprio sulla caratteristica valenza della nozione spaemanniana di ‘trascendenza’.
L’atto di riflessione presuppone, per non essere vuoto, questo essere-in-sé al quale,
in ogni caso, esso si può rivolgere sempre e solo nell’atto di riflessione. È però difficile trovare un equilibrio capace di mantenere senza ridurre un polo all’altro. Z.
osserva giustamente che è a Schelling e alla sua nozione di unvordenklich, più che
a Hegel, che Spaemann si rivolge per trovare un modo meno ambiguo di pensare
la relazione tra trascendenza e riflessione. Se l’essere è liberamente creato, non è
né necessario né possibile, ma contingente. Una contingenza storica che la filosofia
deve prendere sul serio, lasciandola essere come luogo della propria origine. Si
può così comprendere la caratteristica difesa del Cristianesimo sviluppata da Spaemann. Z. osserva che l’influenza della speculazione dottrinale cristiana non solo
è decisiva per la nozione di persona come Selbstsein, ma è solo da una prospettiva
creazionistica, pur rivisitata filosoficamente, che Spaemann ritiene si possa mantenere la concepibilità di tale nozione nella sua pienezza.
Il sesto capitolo – Christianity, philosophy, and the end of modernity – è dedicato
proprio alla concezione spaemanniana del rapporto tra Cristianesimo e filosofia e
alle sue implicazioni per le filosofie post-moderne. Il contributo di Spaemann alla
riflessione sul Cristianesimo è un contributo da laico, osserva Z., ed è normalmente
220
RECENSIONI
Philosophical News
orientato ad affrontare questioni specifiche. Spaemann muove da una posizione di
«Christian orthodoxy» ma da questa svolge una critica della modernità che possiede la pretesa non solo di difendere il Cristianesimo dalla tentazione di autointerpretarsi secondo lo spirito della modernità, ma anche di affermare che solo in
esso si può trovare una difesa piena della ragione. Ciò tuttavia esige che il carattere
storico e non-speculativo del Cristianesimo rimanga qualcosa che la filosofia non
deve pretendere di assimilare. Secondo Z. ciò conduce Spaemann a mostrare una
preferenza per un pluralismo filosofico nel quale le differenti teorie non pretendono di ergersi a verità religiose.
Z., richiamandosi esplicitamente a Schelling, parla della filosofia spaemanniana come di un empirismo speculativo il quale «not only shows that philosophical
speculation does not need to contradict the gift of reality (thus being empirical in
a non-dogmatist way), it also shows how the ‘in-self ’ and the ‘for-me’ are brought
together and reconciled in the experience of the absolute, most importantly in the
‘experience’ of God and of the person» (p. 251).
In conclusione si può affermare che questo volume di Z. è uno studio denso che
mostra tutta la competenza e familiarità che l’autore possiede non solo con la ricca
e variegata produzione spaemanniana ma anche con il quadro di autori e di temi
che attraversano il dibattito filosofico attuale. Z. riesce nell’impresa di indicare un
percorso adeguato e rispettoso che consente di entrare nella trama della filosofia di
Spaemann comprendendone i capisaldi, gli obiettivi critici e positivi, ma anche di
replicarne lo sguardo e, per così dire, di ripercorrerne il “gesto”. Essa viene presentata mettendone bene in evidenza le matrici “classiche”, facendola allo stesso
tempo interagire, criticamente e positivamente, con gli autori più recenti e generando così una “osmosi” da cui esce arricchita tanto la comprensione del pensiero
spaemanniano quanto il quadro di alcuni dei più recenti dibattiti filosofici. Chiude
il volume una ricca bibliografia primaria e secondaria.
Matteo Amori
Università degli Studi di Bergamo
[email protected]
Cristina Zaltieri, L’invenzione del corpo. Dalle membra disperse all’organismo, collana “Il corpo della filosofia”, Negretto Editore, Mantova 2010. Un volume di pp. 168.
Nell’esergo che spiega il titolo dell’originale e interessante collana della casa editrice Negretto, “Il corpo della filosofia”, si legge che il “nutrimento” della filosofia
è quel “fuori del pensiero”, sia esso scrittura, carne, materia del mondo, corpo che,
nel contaminare una presunta purezza del pensiero stesso, in realtà lo alimenta e lo
illumina. Per questo motivo la filosofia, lungi dall’eliminare tale sua alterità corporea, deve essere in grado di affrontarla, deve in altri termini pensarla.
In piena sintonia con l’istanza della collana che lo ospita si colloca il testo di Cristina Zaltieri, L’invenzione del corpo. Dalle membra disperse all’organismo. Il titolo
stesso dell’opera, particolarmente curioso, suscita nel lettore una serie di domande
che preannunciano alcune peculiarità del corpo, legate al suo essere strumentale,
al rapporto con il fautore della sua presunta scoperta/invenzione.
Spinoza e Nietzsche, non a caso anomali nel panorama del pensiero occidentale, ammoniscono: la saggezza del corpo sfugge alla ragione. L’autrice ha scritto
questo libro assumendosi la gravità delle loro osservazioni per giungere al risultato
di trovarle confermate dalla sua indagine: il corpo apre a un territorio vastissimo
ancora in buona parte inesplorato. Ma quest’esito non è fallimentare se si pensa
la filosofia non come soluzione razionale d’ogni problema bensì come pratica che
aiuti ad abitare il mondo accettandone la complessità, la dismisura, il disordine, il
mistero e assumendo interamente la sua natura di “caosmo”.
L’Introduzione conduce il lettore lungo il cammino che lo porterà a scoprire il corpo attraverso il breve racconto di un ipotetico dialogo tra l’antropologo missionario
Leenhardt e un selvaggio canaco divenuto suo discepolo, costruito sulla base delle
memorie di Leenhardt. Il selvaggio dichiara all’antropologo di aver imparato da lui
“il corpo”, sconosciuto nella loro cultura “primitiva”, suggerendo così l’idea che esso
non sia oggetto indiscutibile di ogni umana conoscenza, bensì che divenga tema di
sapere all’interno della cultura occidentale. Tale processo di costruzione dell’oggetto
di conoscenza “corpo” avviene mediante l’affermazione di una coppia oppositiva
potentissima, dominante l’intera nostra cultura: quella di anima e corpo. Il problema
della relazione tra anima e corpo non si presta a una facile definizione. Nella società
contemporanea il corpo appare imperante, tirannico, focus d’ogni nostro interesse (somatocentrismo). Eppure, sempre all’interno della nostra tradizione culturale
esso risulta schiacciato dall’imperio dell’anima (somatofobia). In realtà l’ambiguità
dell’oggetto-corpo rende ben più problematiche tali superficiali analisi che tuttavia
illuminano la natura polemologica e agonale del rapporto tra anima e corpo.
222
RECENSIONI
Philosophical News
Il testo si confronta in prima istanza con la somatofobia dominante posta alle radici
della nostra cultura filosofica, a partire da Platone, erede del dualismo orfico e del suo
disprezzo per il corpo, per passare al cristianesimo, nella sua versione paolina che lega
al corpo, o meglio alla carne, la dimensione del peccato. In entrambi i casi si assiste
però a un’implicita padronanza e affermazione dell’elemento corporeo: il pensiero
platonico ricorre, pur senza tematizzarlo, al ruolo politico, conoscitivo e paidetico
giocato dal corpo e Paolo è pur sempre apologeta di una religione il cui cuore pulsante è l’incarnazione di Dio, la sua scelta di assumere il corpo di un uomo.
La socratica “cura dell’anima”, così come emerge nel Carmide o nell’Alcibiade
Maggiore di Platone, non a caso si rivolge ai corpi belli di Carmide e Alcibiade e si
esplica nel dialogo serrato tra il maestro e l’allievo, determinando un percorso di
formazione destinato a coronare l’ingresso del giovane nella vita pubblica.
Come insegnano Nietzsche, Artaud, Deleuze e Foucault – pensatori che ispirano e contribuiscono a dare corpo al testo di Zaltieri – il corpo consiste in una
pluralità di forze, di istanze che affermano la sua vibrante e inarrestabile molteplicità rispetto al “fraintendimento del corpo” operato da Platone. Sostiene a tal
proposito Artaud: «è una moltitudine impazzita, una specie di baule a soffietto che
non può mai aver finito di rivelare quello che racchiude». Dunque la filosofia, per
ridurlo alla ragione, deve “addomesticarne” le forze selvagge, “misteriose” e tale
ammansimento del corpo avverrà attraverso la sua costituzione in organismo. La
genealogia foucaultiana si traduce in una vera e propria somatologia che trova nel
corpo il suo nucleo fondante: i corpi assoggettati dei dispositivi di potere-sapere,
i corpi governati e puniti dal somatopotere, i “corpi docili” della società disciplinare, i corpi trasformati in forze produttive ed economiche dalla politica. L’autrice
sottolinea come in tutti i casi citati si assista alla dinamica messa in atto dal circolo
del potere-sapere che declina, oppone e definisce il dualismo corpo-anima. Sulla
scia del metodo genealogico, Zaltieri scava nella storia del pensiero fino a raggiungere le origini organiche del corpo, scoprendo che l’organismo è un’invenzione
platonica che fa del corpo una totalità chiusa, gerarchica, psicocentrata nella riflessione del filosofo greco e poi encefalocentrata nella successiva tradizione filosoficoscientifica tutt’ora imperante.
Due funzioni sono fondamentali nell’organismo: la funzione economica, esaminata mediante una fine analisi del famoso apologo di Tito Livio, e la funzione immunitaria, presa in considerazione attraverso la lettura di S. Paolo. Nel primo caso
si tratta di leggere l’organismo come totalità in cui le differenti parti si trasformano
in “organi” e la cui funzione è finalizzata all’efficienza e produttività dell’intero. La
funzione immunitaria invece consiste nell’esplicazione dell’unità organica come
chiusura difensiva verso ciò che è fuori da tale unità, laddove il “fuori” è avvertito
come negativo e pericoloso.
Tale duplicità di funzioni ci fa comprendere l’efficacia, da sempre messa a frutto, dell’immagine del corpo-organismo come potente metafora della comunità politica in Occidente il cui senso è stato ed è ancora spesso ridotto per lo più a tale
duplice valenza: economica e immunitaria.
Eppure l’esperienza umana ci insegna che il corpo è un gioco di forze molteplici,
difficilmente rinserrabile nell’organismo gerarchico e chiuso. Ecco perché Deleuze
Philosophical News
RECENSIONI
223
invita, insieme a Guattari, a farsi un Corpo senz’Organi, secondo un’enigmatica
espressione coniata da Artaud che allude non allo svuotamento degli elementi che
abitano il corpo, ma alla libertà che il corpo stesso dischiude rispetto alla fissità dei
suoi compiti. Il Corpo senz’organi è dunque il principio che scombina organismi
assestati, afferma la pluralità dell’esistenza e viene attivato per non ridurre la vita a
meccanico espletamento di funzioni.
Una scrittura del corpo molto lontana da quella del corpo-organismo che Platone inaugurerà nel Timeo quattro secoli dopo, una diversa somatografia, in consonanza con una particolare descrizione del politico, anch’essa molto lontana da
letture organiciste, l’autrice la incontrerà nell’Iliade.
Il corpo degli eroi omerici non mostra traccia di unità organica: è una pluralità
di forze patiche, di agenti patico-fisiologici che sono elementi emozionali e allo
stesso tempo luoghi fisici del corpo. L’uomo di cui parla Omero non ha neppure
“volto”, ossia non ha espressioni che richiamino una concezione del viso quale cartografia dei segni dell’anima, perché nell’uomo omerico non vi è traccia neppure
di essa (psychè è il respiro, il soffio vitale che abbandona il corpo dopo la morte).
Un uomo, quello iliadico, senza corpo né anima è attraversato da forze composite
che svolgono una indubbia funzione politica, nel senso che fungono da elementi
connettivi di un tessuto politico anch’esso descritto come disperso e plurale. Il
corpo omerico è privo dei caratteri che si attribuiscono al corpo organismo: è antieconomico, si esprime nel costante dispendio della forza, nella sua dissipazione
(dépense, direbbe Bataille) ed è aperto al “fuori” della comunità e del mondo, dal
momento che condivide con gli altri le forze che lo attraversano e che hanno natura
divina, cosmica. A questo punto, la domanda con cui la ricerca si conclude è la seguente: come è potuto accadere che dal “corpo senz’organi” d’Achille si sia giunti
al corpo-organismo del Timeo consegnato da Platone all’umanità successiva?
La risposta a tale epocale questione viene trovata nel passaggio dalla cultura
orale (di cui Omero è ancora testimone, pur “raccogliendola” e “fissandola” nella
scrittura) alla civiltà della scrittura.
Una sotterranea ma determinante connessione tra la piena affermazione del discorso scritto e l’emergere del corpo-organismo è la traccia che l’autrice segue.
L’ipotesi conclusiva di Zaltieri pone l’accento sulla pratica della scrittura che, a
suo avviso, determina la comparsa del corpo organismo e, più precisamente, esso
emerge dalla scrittura del logos filosofico che sottopone la molteplicità degli elementi all’unità dell’idea, dell’universale, del concetto.
Il Fedro di Platone conferma per l’autrice tale ipotesi laddove il “buon discorso” del filosofo è paragonato al corpo del quale deve condividere l’ordine, la retta
disposizione, la taxis. Nel dialogo platonico assistiamo a continui rimandi impliciti
del rapporto tra scrittura e corpo (come già aveva compreso Derrida): entrambi
sono esteriorità che celano e obnubilano una verità interiore, portando all’oblio
della stessa. Nel contempo entrambi posseggono una natura “segnica”, ovvero si
fanno segno per il discorso vivo, quello orale, e per l’anima che lo vivifica. Il discorso – organismo della dialettica, le cui membra si compongono in una taxis che
fa capo all’idea definitoria, rende possibile l’affiorare alla visione del filosofo di un
corpo-organismo. Attraverso l’organismo, le forze del corpo vengono rinserrate in
224
RECENSIONI
Philosophical News
un’unità razionale, sottoposte al comando dell’anima e, tramite essa, ricondotte
nell’alveo dell’elemento politico, che di tali forze – anche se Platone non lo esplicita – si nutre e si corrobora.
Il prezzo che il corpo paga, in tale sua trasformazione in organismo, è la rottura
del suo rapporto con il “fuori” cosmico, la perdita della sua ambigua, enigmatica
e preziosa collocazione tra interno ed esterno, l’incapacità di essere riconosciuto
come la soglia che ci rende vive risonanze di mondo. Il testo riesce così nel suo
intento: mettere in causa lo sguardo sul corpo che noi consideriamo “naturale”
mostrando come esso sia in realtà l’esito di una lunga e complessa vicenda.
Roberta Sofi
Università degli Studi di Bergamo
[email protected]