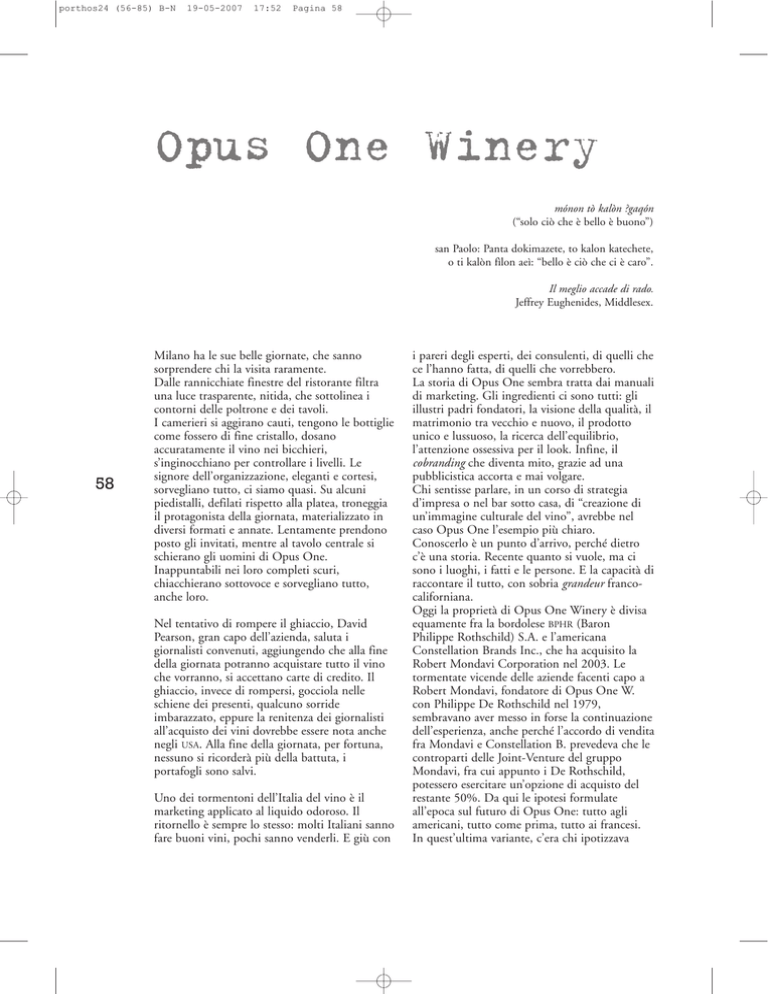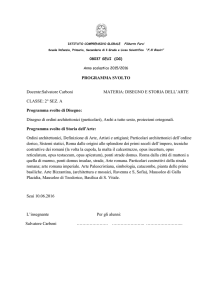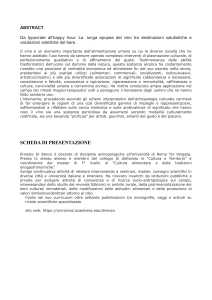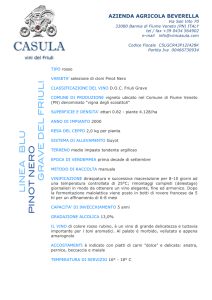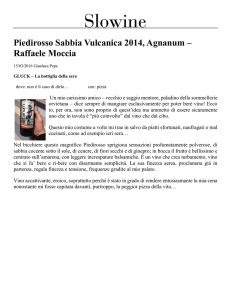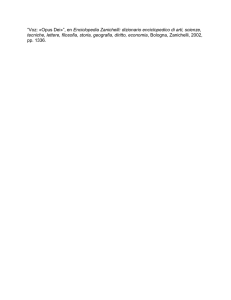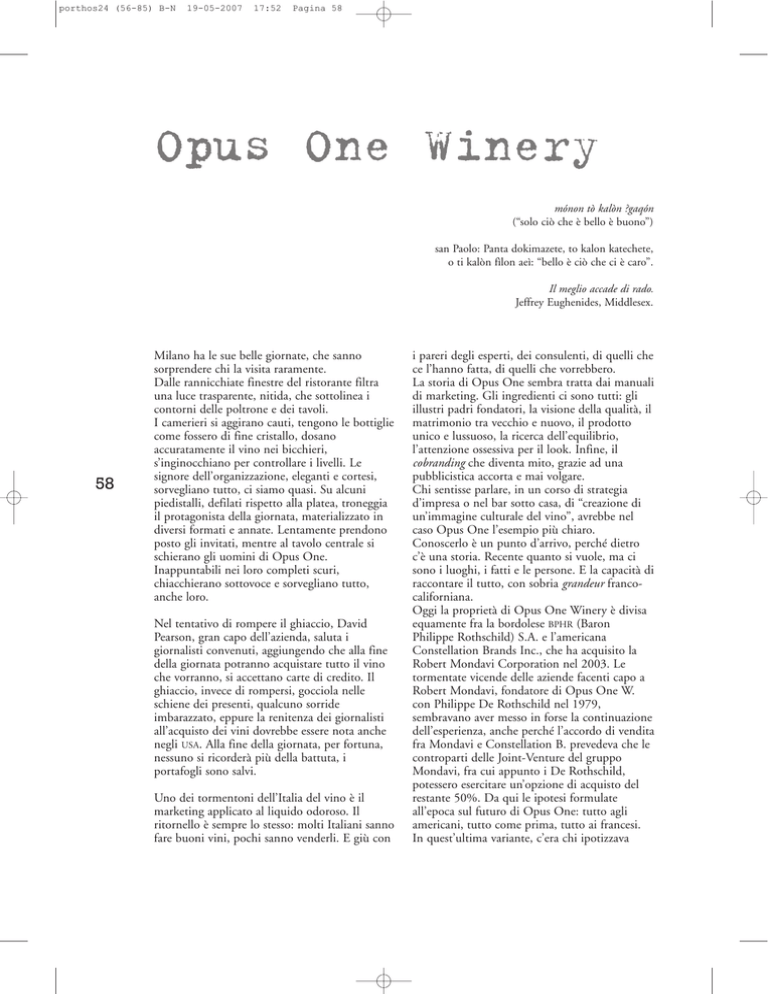
porthos24 (56-85) B-N
19-05-2007
17:52
Pagina 58
Opus One Winery
mónon tò kalòn ?gaqón
(“solo ciò che è bello è buono”)
san Paolo: Panta dokimazete, to kalon katechete,
o ti kalòn fìlon aeì: “bello è ciò che ci è caro”.
Il meglio accade di rado.
Jeffrey Eughenides, Middlesex.
58
Milano ha le sue belle giornate, che sanno
sorprendere chi la visita raramente.
Dalle rannicchiate finestre del ristorante filtra
una luce trasparente, nitida, che sottolinea i
contorni delle poltrone e dei tavoli.
I camerieri si aggirano cauti, tengono le bottiglie
come fossero di fine cristallo, dosano
accuratamente il vino nei bicchieri,
s’inginocchiano per controllare i livelli. Le
signore dell’organizzazione, eleganti e cortesi,
sorvegliano tutto, ci siamo quasi. Su alcuni
piedistalli, defilati rispetto alla platea, troneggia
il protagonista della giornata, materializzato in
diversi formati e annate. Lentamente prendono
posto gli invitati, mentre al tavolo centrale si
schierano gli uomini di Opus One.
Inappuntabili nei loro completi scuri,
chiacchierano sottovoce e sorvegliano tutto,
anche loro.
Nel tentativo di rompere il ghiaccio, David
Pearson, gran capo dell’azienda, saluta i
giornalisti convenuti, aggiungendo che alla fine
della giornata potranno acquistare tutto il vino
che vorranno, si accettano carte di credito. Il
ghiaccio, invece di rompersi, gocciola nelle
schiene dei presenti, qualcuno sorride
imbarazzato, eppure la renitenza dei giornalisti
all’acquisto dei vini dovrebbe essere nota anche
negli USA. Alla fine della giornata, per fortuna,
nessuno si ricorderà più della battuta, i
portafogli sono salvi.
Uno dei tormentoni dell’Italia del vino è il
marketing applicato al liquido odoroso. Il
ritornello è sempre lo stesso: molti Italiani sanno
fare buoni vini, pochi sanno venderli. E giù con
i pareri degli esperti, dei consulenti, di quelli che
ce l’hanno fatta, di quelli che vorrebbero.
La storia di Opus One sembra tratta dai manuali
di marketing. Gli ingredienti ci sono tutti: gli
illustri padri fondatori, la visione della qualità, il
matrimonio tra vecchio e nuovo, il prodotto
unico e lussuoso, la ricerca dell’equilibrio,
l’attenzione ossessiva per il look. Infine, il
cobranding che diventa mito, grazie ad una
pubblicistica accorta e mai volgare.
Chi sentisse parlare, in un corso di strategia
d’impresa o nel bar sotto casa, di “creazione di
un’immagine culturale del vino”, avrebbe nel
caso Opus One l’esempio più chiaro.
Conoscerlo è un punto d’arrivo, perché dietro
c’è una storia. Recente quanto si vuole, ma ci
sono i luoghi, i fatti e le persone. E la capacità di
raccontare il tutto, con sobria grandeur francocaliforniana.
Oggi la proprietà di Opus One Winery è divisa
equamente fra la bordolese BPHR (Baron
Philippe Rothschild) S.A. e l’americana
Constellation Brands Inc., che ha acquisito la
Robert Mondavi Corporation nel 2003. Le
tormentate vicende delle aziende facenti capo a
Robert Mondavi, fondatore di Opus One W.
con Philippe De Rothschild nel 1979,
sembravano aver messo in forse la continuazione
dell’esperienza, anche perché l’accordo di vendita
fra Mondavi e Constellation B. prevedeva che le
controparti delle Joint-Venture del gruppo
Mondavi, fra cui appunto i De Rothschild,
potessero esercitare un’opzione di acquisto del
restante 50%. Da qui le ipotesi formulate
all’epoca sul futuro di Opus One: tutto agli
americani, tutto come prima, tutto ai francesi.
In quest’ultima variante, c’era chi ipotizzava
porthos24 (56-85) B-N
19-05-2007
17:52
Pagina 59
porthos24 (56-85) B-N
60
19-05-2007
17:52
Pagina 60
addirittura un restyling dell’etichetta, con la
cancellazione del profilo di Robert Mondavi. In
realtà, nel settembre del 2005, quando ormai il
gruppo Robert Mondavi ha un posto stabile
nella struttura di Constellation B., la baronessa
Philippine, erede e continuatrice del papà, il
barone De Rothschild, dice sì alla continuazione
della partnership. Ci sono subito alcune novità.
La prima è la scelta di un unico responsabile per
la cantina e i vigneti, a sostituire la gestione
condivisa di Tim Mondavi, figlio di Robert, e
Patrick Leon, enologo di Château MoutonRothschild. La seconda è che la vendita di Opus
One fuori degli USA è affidata a negociant
bordolesi. Il perché lo spiega il responsabile delle
pierre, Roger Asleson: «Questo sistema è stato
usato da Château Mouton-Rothschild per
diverse generazioni e ha funzionato bene per
praticamente tutti i migliori châteaux del
Medoc. Opus One ha una tradizione di
innovazione, così ci tenevamo molto a
continuare a essere pionieri, la prima azienda
vinicola californiana a essere distribuita così su
tutti i mercati fuori degli USA». In altre parole,
distinguersi per vendere sempre meglio. A
proposito di vendite, alla Opus One W. fanno
300.000 bottiglie l’anno di un solo vino e le
vendono tutte, ad un prezzo che, secondo Jarue
Manning, professore all’Università di Davis in
California, «is outrageous at $129 to 169 for the
current release». Fatte le dovute moltiplicazioni e
sottrazioni, si può avere una stima dei ricavi di
un’azienda ostinatamente monoprodotto, che
orgogliosamente non diversifica. Segno ulteriore
che l’idea avuta dai due fondatori è ritenuta
ancora valida.
Si narra che Robert Mondavi e Philippe De
Rothschild non abbiano faticato ad intendersi,
pur nelle tante differenze: l’italo-americano
rampante, alfiere di una California in crescita
tumultuosa, il colto e raffinato francese,
campione dell’aristocrazia vinicola bordolese.
Quest’ultimo, solo qualche anno prima della
nascita della JV, sembrava distante dal concepire
un vino made in USA. Intervistato dalla rivista
Time nel 1972, il Barone affermò, in sintesi, che
i grandi vini, per sviluppare il carattere, devono
vedersela brutta, passando attraverso difficoltà
come la neve, le tempeste e la siccità. Un
calvario difficile da vivere in California, dove il
suolo e il clima sono così favorevoli, dove «tutto
è troppo perfetto». Il risultato era un vino
«industrially uniform, like Coca-Cola». Da qui a
Opus One la distanza non è breve, ma le logiche
del business sembrano averla colmata.
Al di là dell’aneddotica, la sostanza è innegabile:
un vino progettato a tavolino, di grandi
ambizioni, voluto fortemente come il risultato
dell’incontro fra due realtà ritenute
complementari.
Nel corso della giornata, i manager di Opus One
torneranno spesso su questo incontro fra nuovo
e vecchio mondo, a rimarcare con forza il
radicamento dell’identità aziendale.
Basata, ancora oggi, sulle intuizioni dei due
fondatori, che avevano pensato proprio a tutto.
A cominciare dal nome, che presenta
caratteristiche distintive dei brand più efficaci:
inconfondibile, non necessita di traduzioni,
evoca scenari di grandiosità e di unicità.
Un nome dal suono così altero e magnificente
aveva bisogno di un tempio, che i due fondatori
si sono premurati di erigere, qualche anno dopo
la nascita della Joint-Venture. A Oakville,
California, sorge la cantina di Opus One,
sebbene il termine cantina sia un tantino fuori
posto. A metà fra un mausoleo e un’astronave,
ricorda tanta architettura monumentale del
passato, ti aspetteresti di vederne uscire delle
vestali, o dei guerrieri aztechi, o Russel Crowe in
costume da gladiatore.
La ricercata eleganza degli interni non è slegata
dalla funzione: la sala degustazione, ad esempio,
è affacciata sulla Grand Chai, una barricaia
sotterranea dove sono disposte, ad anfiteatro,
centinaia di botti tutte uguali. Curiosamente, un
commentatore statunitense definisce
“understated” proprio la sala di degustazione,
perché fruibile da pochi eletti. In più, aggiunge
lo stupito giornalista, probabilmente abituato ai
ben diversi flussi di visitatori in altre aziende
della zona, i posti auto sono solo 28.
L’etichetta merita un discorso a parte. Proprio a
Philippe De Rothschild è attribuita l’intuizione
di trasformare l’etichetta di una bottiglia di vino
in un’opera d’arte. Oggi anche l’ultima delle
cantine affida le proprie etichette all’ispirazione
di artisti e affini, ma il Barone era un precursore:
nel 1924 incaricò Jean Carlu di realizzare uno
speciale design per l’etichetta del vino Château
Mouton-Rothschild di quell’anno, il primo ad
essere imbottigliato direttamente dallo chateau,
anche questa una piccola rivoluzione. Dal 1946
ad oggi, le etichette d’artista sono diventate una
tradizione dello Château, che vanta la
collaborazione di firme illustri: Dalì, Mirò,
Chagall, Picasso, Bacon, Cocteau.
L’etichetta di Opus One, attribuibile con tutta
porthos24 (56-85) B-N
19-05-2007
17:52
Pagina 61
probabilità a uno schizzo dello stesso De
Rothschild, ritrae i profili stilizzati dei due
fondatori, una vera e propria griffe, facilmente
replicabile persino sulle spillette.
Non è quindi un caso che l’incontro odierno si
svolga da Marino alla Scala, locale dove si respira
Trussardi prima ancora di entrare. Questione di
stile e di vicinanza, la moda produce lusso e
immagine e Opus One non è da meno.
Nell’America del fatto a macchina, i manager di
Opus One esaltano l’handpicking1 ed il lavoro
manuale in genere. Ci spiegano, ad esempio, che
le stesse persone che potano fanno poi la
vendemmia. Un modo per responsabilizzare,
aumentare il focus sul prodotto e sulla qualità.
E’ ovvio che tanta attenzione si paga, ma qui di
crisi non si parla. Neanche per sbaglio, come
conferma Asleson: «Noi siamo fortunati a essere
nella stessa fascia di quei produttori di vini di
lusso internazionali per i quali inventari in
eccesso non sono un problema. In anni
specialmente forti, le nostre allocazioni (scorte?)
si vendono totalmente in poche settimane
dall’uscita. In anni meno forti, finiamo per dire
di no a un minor numero di persone, ma ancora
dobbiamo dire di no più spesso di quanto
vorremmo».
E’ il sogno di tutti i venditori, i rapporti di forza
si ribaltano, altro che clienti da blandire e
convincere.
Si capisce quindi perché i padroni di Opus One
abbiano deciso di lasciare la briglia sciolta. E’
ancora Asleson che parla: “Riconoscendo il
bisogno per Opus One di rimanere unico,
Constellation ha convenuto con BPHR che
l’azienda opererà in indipendenza in tre aree
chiave: amministrazione, vendite e gestione dei
vigneti/produzione del vino.” Un’indipendenza
che “Scotty” Barbour, responsabile delle vendite,
ci spiegherà essere importantissima, poiché non
si può vendere Opus One a chiunque.
I padri fondatori, nel loro progetto, avevano
ovviamente pensato anche ai vigneti. L’affabile
Pearson se la cava con poche parole, fidando
probabilmente nella sontuosa cartella stampa. Le
uve che danno vita a Opus One vengono da tre
vigneti; il primo fu un appezzamento di 14
ettari chiamato To-Kalon (Block Q), venduto da
Robert Mondavi alla nascente Joint Venture nel
1981. Quasi una dote, non fosse per i soldi.
To-Kalon. Il Bello. L’ambizione comincia dal
nome. La storia invece comincia intorno al
1870, quando Hamilton Walker Crabb fonda la
To-Kalon Winery a Rutherford, in quella che
oggi è la Oakville & Rutherford Area,
California. Negli anni a seguire la cantina di
Crabb si espande, acquista fama e guadagna
premi. Famoso per le sue sperimentazioni, sia
varietali, sia anti-fillossera, Crabb produce un
Cabernet rinomato e uno strano “Black
Burgundy”, che altro non era se non Refosco. E
si lascia andare a inneggianti profezie: “Whoever
lives a half a century hence, will find the grapes of
California in every city of the Union; her raisins
supplying the whole Western hemisphere; her wines
in every mart of the globe, and then, with her
golden shores, her sunny clime, her vine-clad hills
and plains, will California, indeed, be the
Vineland of the world.2”
Alla sua morte, nel 1899, la proprietà va ad un
banchiere di nome Churchill, che nel 1902, un
anno prima di morire, ne cede 20 acri3 al
Department of Agriculture, a scopi scientifici.
Oggi quei terreni sono la Oakville Field Station
dell’Università di Davis.
Prima la moglie e poi il figlio di Churchill
continuarono ad occuparsi dell’azienda, ma sulla
loro strada incontrarono il Proibizionismo, tante
vicissitudini e qualche truffatore. Nel 1937 la
parabola dell’azienda era ormai al termine e
l’incendio che, nel 1939, distrusse gli edifici, è
definito “anticlimactic”.
Nel 1943 la famiglia Mondavi, che già produce
fiumi di vino, pur senza possedere vigneti,
compra la Charles Krug Winery, avviando una
strategia espansiva che porterà lontano.
Nello stesso anno la famiglia Churchill vende
To-Kalon ad un dinamico quarantenne di nome
Martin Stelling. Membro del Bohemian Club, è
ritenuto un precursore del “varietal”, uno che
fece da esempio ai viticultori californiani
dell’epoca, perché credeva nell’uso di varietà
qualitativamente superiori, a discapito di quelle
maggiormente in uso. Nella California del
tempo, dove le cantine sembravano fare a gara
per dimensioni e volumi di produzione, fare
vino “varietal”, cioè ottenuto da un solo vitigno,
che fosse Chardonnay piuttosto che Cabernet o
Zinfandel, significava tentare di affrancarsi dalla
schiavitù del bulk-wine imperante, ottenuto
spesso da un mix dei vitigni più disparati.
Gli ambiziosi progetti di Stelling furono fermati
da un incidente d’auto, che lo uccise nel 1947.
To-Kalon passò nuovamente di mano nel 1951,
acquistata dalla Italian Swiss Colony, che la
rivendé poco tempo dopo a Ivan Schoch. Per
61
porthos24 (56-85) B-N
62
19-05-2007
17:52
Pagina 62
qualche anno i vigneti di To-Kalon forniscono
uva a Beaulieu Vineyards, una delle aziende
storiche della Napa Valley.
Il bordolese che la fondò, ai primi del
Novecento, si chiamava Georges Latour ed aveva
fatto fortuna importando dalla Francia alla
California portainnesti resistenti alla fillossera.
Passata indenne attraverso il Proibizionismo,
anzi rafforzata dalla leadership nella produzione
di vini da messa, la Beaulieu V. era cresciuta
parecchio, ma, alla fine degli anni cinquanta, il
contratto a lungo termine fra Schoch e Beaulieu
per la vendita di uva entrò in crisi: da un lato,
To-Kalon stava producendo più di quanto
Beaulieu potesse usare; dall’altro Beaulieu
insisteva per dividere con Schoch la differenza
fra il prezzo da lui ottenuto vendendo uva sul
mercato e quello pattuito nel contratto. Lo
scontro finì quando Schoch, nel 1962, vendette
alla Charles Krug Winery, proprietà della
famiglia Mondavi.
Cos’ha di particolare To-Kalon? Il vigneto era
definito “one of the best premium wine growing
locations in California”. Genevieve Janssens,
responsabile dei vini della Robert Mondavi
Winery e per alcuni anni ufficiale di
collegamento fra Mondavi e Chateau Mouton in
Opus One, già allieva di Emile Peynaud, in una
recente intervista ha rilevato che To-Kalon ha un
“incredibile terroir”.
In origine includeva 500 acri di Cabernet, con
significativi appezzamenti di Sylvaner, Riesling,
Pinot nero, Sauvignon blanc, Chenin blanc,
Semillon e Gamay. Una babele, da cui i
Mondavi stimavano di ricavare un addizionale
quarto di milione di galloni4 di vino “varietale”,
migliorando così la gamma dei loro prodotti.
Erano passati quasi vent’anni dall’acquisto di
Krug, quindi si può affermare che comprare ToKalon fu la prima importante acquisizione di
vigneti da parte dei Mondavi.
E’ noto che, alla morte del patriarca Cesare
Mondavi, nel 1965, le redini delle aziende di
famiglia furono affidate a Peter Mondavi e non
al fratello Robert, che, pur restando socio di
Krug, nel 1966 fondò la Robert Mondavi
Winery, avviando la costruzione del suo gruppo.
Nel 1973 Robert fa causa alla C. Mondavi &
Sons, accusando la società di famiglia di
praticare politiche di bilancio a lui dannose. Alla
fine dell’iter giudiziario, che vede contrapposti i
due fratelli, la C. Krug Winery resterà a Peter,
mentre To-Kalon andrà a Robert, che ne farà un
uso sapiente nella costruzione dell’immagine del
proprio gruppo.
To-Kalon ha anche originato problemi legali: nel
2002 la Robert Mondavi Winery entrò in lite
con due aziende di Oakville, Schrader Cellars e
Beckstoffer Vineyards, fornitore di uva di
Schrader, ree di aver utilizzato la dicitura ToKalon, marchio registrato da Mondavi nel 1987,
su un Cabernet da loro prodotto. Dal canto suo,
Andy Beckstoffer, che affermava di possedere 89
ettari della To-Kalon storica, accusava Mondavi
di monopolizzarne indebitamente il nome, pur
possedendo solo una parte della To-Kalon
originaria. E’ finita, manco a dirlo, a tarallucci e
vino, giacché entrambe le aziende possono ora
fregiare del marchio To-Kalon le loro bottiglie,
purché siano, a loro giudizio, eccellenti.
Come si vede, non è solo un problema di
catasto, ma di veri e propri quarti di nobiltà,
traducibili, ovviamente, in margini economici.
Fra i tavoli del ristorante la degustazione va
avanti, lenta e misurata. Per la verità, quelli sotto
esame, più che i vini, sembrano i giornalisti,
mentre i manager della Winery ostentano
disinvoltura, abituati probabilmente a road-show
ben più impegnativi.
E stanno attenti anche alla forma: nessuno
risponde al cellulare, concentrati come al tavolo
del poker.
Sono in tre, a rappresentare le anime
dell’azienda: il capo supremo (David Pearson,
CEO), l’uomo della comunicazione (Roger
Asleson) e il responsabile delle vendite (Kenneth
“Scotty” Barbour). Manca solo Michael Silacci,
il nuovo responsabile della produzione, il primo
a occuparsi del vino da solo dopo anni di
gestione condivisa franco-americana. Una bella
responsabilità, tanto è vero che è rimasto in
California a badare alla cantina.
In realtà, più ancora della sua assenza, colpisce lo
sforzo di comunicazione della Winery.
Sebbene Pearson, che assomiglia a Sutherland
padre, assicuri che l’Italia per Opus One è
importante, sembra più un atto di cortesia che
una considerazione strategica. A sentire i
numeri, per loro contiamo quanto un sobborgo
di Tokyo, sarà che abbiamo tanti giornalisti. Una
possibilità ulteriore è che Constellation B. voglia
lentamente costruirsi un’immagine positiva, in
un paese nel quale mira ad espandersi nel lungo
termine. In tal caso, non lo danno a vedere,
perché qui si parla solo di Opus One e buona
parte dei presenti crede che Constellation sia un
modello della Ford.
porthos24 (56-85) B-N
19-05-2007
17:52
Pagina 63
Ancora una volta, meglio approfondire.
Il nome Constellation risale al 2000, ma quello
che vi è dietro ha radici ben più lontane. Anche
qui, come vedremo, c’è di mezzo una famiglia.
Fra le zone vinicole degli Stati Uniti, la Finger
Lakes Area, situata nel nord-ovest dello stato di
New York, non è certo la più famosa, ma è
proprio qui che, nel 1945, Marvin Sands,
fondatore di ciò che oggi chiamiamo
Constellation, acquistò la Canandaigua
Industries Company, un’azienda che produceva
bulk-wine per imbottigliatori. Della vita di
Sands prima di allora non è dato sapere nulla,
idem per le ragioni che lo spinsero all’acquisto.
E’ possibile che Marvin Sands abbia seguito le
orme dei Gallo, che nel 1940 avevano acquistato
proceduto a simili acquisizioni a Los Angeles e
New Orleans, ma è certo è che quasi subito lo
affianca il padre, Mordecai “Mack” Sands, uomo
d’esperienza, il quale nel 1951 fonda la Richard’s
Wine Cellars, in Virginia, chiamandola così in
onore del nipotino.
Lo scatto di crescita di Canandaigua avvenne nel
1954, grazie ad un prodotto dal nome
suggestivo: Richards Wild Irish Rose, conosciuto
anche come “Wild I”. Tuttora in commercio,
disponibile anche al ginseng, “Wild I” non è
certo un luxury wine: addizionato di alcol e
basato sul vitigno Concord, nella palette
aziendale è classificato fra i vini da dessert, ma la
sua collocazione vera è il fondo scala degli
alcolici. Al pari del cugino Cisco, anch’esso
aromatizzato e carico d’alcool, “Wild I” ubriaca
a poco prezzo e a lungo, tanto che qualcuno lo
63
porthos24 (56-85) B-N
64
19-05-2007
17:52
Pagina 64
definisce un crack liquido, la cui immagine è
legata ai ghetti neri e agli alcolisti, non certo ai
calici di cristallo in cui, davanti ai nostri occhi,
Opus One lentamente si ossigena, mandando
riflessi scarlatti sulle tovaglie immacolate. Nel
1989 la vendita di Wild I e Cisco, insieme a
prodotti simili della E. J. Gallo (anche qui nomi
evocativi, come Thunderbird e Night Train
Express), fu sospesa per sei mesi in una ristretta
area di San Francisco, il Tenderloin District, allo
scopo di limitare il dilagante alcolismo ed i
crimini ad esso collegati. Vi fu addirittura chi
propose, senza successo, che Canandaigua e
Gallo ritirassero dal commercio i prodotti in
questione su scala nazionale.
A proposito del Cisco, vale la pena di citare un
“agreement” tra Canandaigua e la Federal Trade
Commission statunitense, che, nel 1991, accusò
l’azienda di aver strutturato il packaging, il
marketing e le pubblicità di Cisco come se si
fosse trattato di una bevanda a basso contenuto
di alcol, in confezioni “single-serving”,
analogamente ai wine-cooler5. Rispetto ai quali,
tuttavia, Cisco aveva un contenuto alcolico da
tre a cinque volte superiore. Secondo la FTC era
quindi ingannevole presentare Cisco in una
bottiglietta come un wine-cooler, esponendo i
consumatori ad una fruizione inadeguata ed alle
relative conseguenze, anche ospedaliere. Dopo
qualche schermaglia, FTC e Canandaigua
trovarono un accordo: niente azioni legali, a
patto che Canandaigua rivedesse le politiche di
vendita di Cisco. E allungasse il collo alle
bottiglie, a scanso di equivoci.
Per decenni le vendite di “Wild I” hanno
costituito la spina dorsale dei ricavi di
Canandaigua, rendendo possibile l’aggressiva
strategia di crescita per acquisizioni del colosso
statunitense, guidato oggi da Robert e Richard
Sands, figli di Marvin e nipoti di Mordecai.
Dopo anni di crescita silente ma continua, la
quotazione in borsa, avvenuta nel 1973, dopo
essere divenuta Canandaigua Wine Company
Inc., fornì nuove risorse alla dinamica espansiva.
Nel 1986 Canandaigua comprò persino
Widmer, l’azienda dei Finger Lakes da cui
Marvin Sands aveva comprato la stessa
Canandaigua.
L’espansione obbliga le aziende a strutturarsi
adeguatamente. Persino nel nome, che in questo
caso diventa, gradualmente, lo specchio delle
cose: nel 1997 nasce, infatti, Canandaigua
Brands, società destinata a gestire la molteplicità
delle acquisizioni. E’ evidente come
Canandaigua abbia saputo approfittare della
tendenza al consolidamento propria del settore,
focalizzando sia sulle attività produttive, sia sulla
distribuzione, vera e propria catena di
trasmissione fra produttori e mercato.
Nel 1999 i tempi sono maturi per la creazione
della divisione Fine Wines, mentre nel 2000
Canandaigua Brands cambia nome in
Constellation Brands, che rende benissimo l’idea
di cosa sia diventata: un enorme arcipelago di
aziende e di marchi, presente ovunque e in tutte
le fasce di mercato. Canandaigua è ormai un
nome fra gli altri, la ribalta è riservata alle grandi
acquisizioni in tutto il mondo, Italia compresa.
Infatti, dal dicembre 2004 Constellation B. ha
una zampa in Ruffino, avendo rilevato per 89
milioni di dollari la quota che fu di
Investindustrial, la società di private equity che
fa capo a Andrea Bonomi e Alessandro
Benetton.
Nel carniere di Constellation B. oggi c’è di
tutto: birra, distillati, sidro, vino da poveri e
vino da ricchi, non manca neppure il vino alla
frutta. Creato nel 1998, si chiama Arbor Mist ed
è un campione di vendite, meglio dei Beatles.
Pare che nei primi 100 giorni di distribuzione ne
abbiano spedite 100 milioni di casse. Insomma,
il gigante americano può vendervi qualunque
alcolico vogliate bere, perché, se non lo produce
direttamente, di certo lo distribuisce.
La lista delle aziende inglobate vede nomi noti
del vino statunitense come Mondavi, Italian
Swiss Colony, Inglenook, Taylor, Almaden e
Simi, accanto ad australiani come BRL Hardy’s.
Nel caso di Mondavi, l’integrazione in
Constellation B. ha comportato ristrutturazioni
e licenziamenti, ma pare aver lasciato intatta la
fisionomia produttiva. In altri casi, le aziende
acquisite dallo juggernaut di Fairport, quando
non erano già dei puri marchi, svuotati di ogni
contenuto originario, lo sono diventate.
Inglenook, Widmer e Almaden, per esempio,
consegnano una realtà lontana dal valore che i
marchi si portano dietro. Almaden produce vino
Bag-in Boxes, mentre Inglenook, una delle
cantine californiane con la più radicata
tradizione qualitativa, oggi è associata a vini da
tavola di basso costo.
Alla luce di questo, è comprensibile che le
trattative fra i Sands e la baronessa De
Rothschild siano state laboriose. Ad ogni modo,
Asleson ci rassicura: “Sebbene noi non possiamo
parlare per Madame, siamo stati testimoni che
lei ha stabilito un rapporto cordiale con Richard
porthos24 (56-85) B-N
19-05-2007
17:52
Pagina 65
e Robert Sands. La baronessa Philippine ammira
l’ambizione e l’espansione di un’azienda che una
volta era un pulcino e che è diventata la
maggiore entità vinicola del mondo.”
Passata l’era Mondavi, sembra quindi
prospettarsi un nuovo modello di
complementarietà: se Mouton-Rothschild e
Bordeaux si propongono apparentemente come
l’ancoraggio alla tradizione europea,
Constellation B. è già oggi il probabile futuro
del vino in chiave mondiale e finanziaria.
La quotazione in borsa, secondo alcuni, fu per
Robert Mondavi l’inizio della fine. La pressione
esercitata da Wall Street esacerbò le difficoltà
distributive, le interferenze fra le logiche della
famiglia e quelle gestionali, gli errori strategici;
in altre parole, emergerebbe la difficoltà di
contemperare le caratteristiche di ciclicità del
vino con le aspettative borsistiche.
Per Constellation B., al contrario, la quotazione
è stata ad un tempo consacrazione e trampolino
di una irresistibile ascesa, da outsider a leader di
mercato, realizzata puntando sulla strategicità
dei marchi, prima ancora che dei prodotti,
piegando, all’occorrenza, i retaggi delle singole
aziende alle più ampie esigenze produttive del
gruppo.
Ci sono ovviamente notevoli differenze: il
gruppo Mondavi era interamente focalizzato sul
vino e dipendeva in gran parte dal mercato
domestico, mentre Constellation B. ha saputo
diversificare le proprie attività, nel tentativo sia
di ottimizzare i ricavi, sia di attutire eventuali
difficoltà locali o di prodotto.
Resta da capire il ruolo di Opus One in questo
scenario, oggi ancora più globale di quando i
due fondatori avviarono l’iniziativa.
E’ evidente che i due pilastri su cui si regge
Opus One sono la capacità di produrre reddito e
la forza iconica dell’immagine, caratteristiche
tutt’altro che sgradite a entrambi i soci. Il
numero di ricchi in giro per il mondo aumenta:
russi, cinesi, indiani, saranno in molti a volere
Opus One sulle loro tavole.
Tutto questo, aldilà della retorica d’occasione,
dovrebbe garantire una certa indipendenza, in
mancanza della quale rischiano di diluirsi i
caratteri distintivi del vino e del marchio. Ecco
perché non stupisce la risposta del solito
Asleson, a proposito di biodinamica: “Sebbene
alcuni dei suoi precetti siano percepiti forse
come superstizione, il forte vantaggio
dell’agricoltura biodinamica è che richiede alle
persone che curano i vigneti di focalizzare
ancora più intensamente e puntualmente su ogni
aspetto delle loro pratiche colturali. Noi stiamo
quindi studiando quali elementi di agricoltura
biodinamica possa aiutarci a raggiungere una
ancora maggiore attenzione al dettaglio nei
nostri vigneti.”
Alla fine dei conti, non diversamente un vino
che per alcuni è un marketing miracle deve
contare sulla propria identità e rafforzare la
propria unicità, per continuare ad esistere.
Leviamo i calici una volta ancora, poi tutti a
casa, sognando California.
Si fa tardi, è l’ora delle foto ricordo.
1 La raccolta a mano
2 “Chiunque viva per mezzo secolo da questo momento in poi, troverà le uve della California in ogni città
dell’Unione; la sua uva passa rifornire l’intero emisfero occidentale: i suoi vini in ogni negozio del globo, e
quindi, con le sue spiagge dorate, il suo clima soleggiato, le sue colline e le sue pianure ornate di vigne, la
California sarà davvero la vigna del mondo”. (citato da T. Pinney, “A History of wine in America – from
Prohibition to the present”, UCPRESS.
3 1 acro=0,40 ha
4 1 gallone=4,546 litri
5 Bevande alcoliche a base di vino e frutta, confezionate in bottigliette monoporzione, da bere fredde.
65