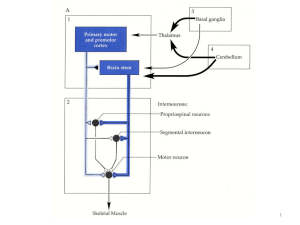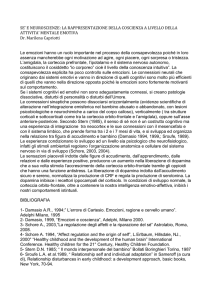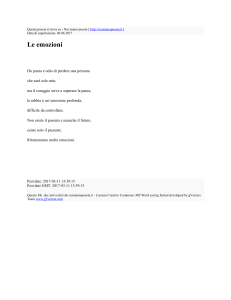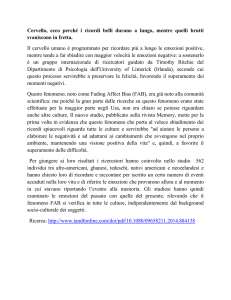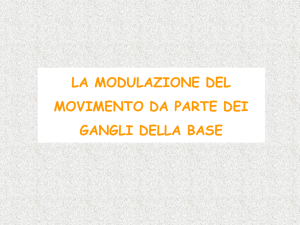NEUROVEGETATIVO
News
Quadrimestrale - Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009
NEUROVEGETATIVO
News
Periodico quadrimestrale
Direttore responsabile
Pietro Cortelli
Comitato Editoriale
Presidente
Giuseppe Vita
Segretario
Pietro Guaraldi
Revisore dei conti
Giuseppe Micieli
Consiglieri
Giovanni Barbara
Luciano Bernardi
Pietro Cortelli
Francesca Del Sorbo
Rita Di Leo
Simona Maule
Giuseppe Pelliccioni
Marcello Romano
Ufficio redazionale,
pubbicitario e amministrativo:
c/o MCC
via S. Stefano 57 - 40125 Bologna
tel. 051263703 - fax 051238564
e-mail: [email protected]
Garanzia di riservatezza:
Si garantisce la massima riservatezza dei dati
forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne
la rettifica o la cancellazione scrivendo all’ufficio
redazionale (Legge 675/96 tutela dati personali).
FOTOCOMPOSIZIONE E IMPIANTI:
La.Ser. srl - Granarolo E. (BO)
STAMPA: Tipografia Negri - Bologna
Aut. n. 7106-05/04/2001
riamo possa aiutarvi nella vostra
pratica clinica suggerendo nuovi
progetti di ricerca.
In “Alla ribalta”, troverete l’articolo della dott.ssa Alessia Nicotra su
sistema nervoso vegetativo ed
emozioni.
Negli highlights invece parleremo
dei nuovi criteri per la diagnosi di
Atrofia multi-sistemica pubblicati
di recente da Gilman et al. su Neurology e le differenze rispetto a
quelli pubblicati nel 1998.
Negli ultimi mesi si sono svolti diversi eventi organizzati o patrocinati dall’AINV.
Dal 23 al 26 agosto 2008 si è tenuto a Madrid il 10° congresso che
l’EFAS ha organizzato in joint con
l’EFNS. Nonostante le temperature equatoriali e la bellezza di Madrid apprezzabile successo hanno
ottenuto il teaching course su
“Diagnosi e management dei disordini autonomici in neurologia”, le
sessioni su patofisiologia e diagnostica strumentale dei disordini vegetativi, le sessioni poster. Durante il congresso il nostro Past President ed attualmente consigliere
Pietro Cortelli è stato eletto presidente dell’EFAS ed inoltre è stata
Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009
affidata all’Italia l’organizzazione
del congresso EFAS del 2010.
Dal 4 al 7 settembre 2008 si è tenuto ad Orvieto il 18° Meeting annuale del Neurodiab. Il programma è risultato molto interessante
spaziando dalla ricerca a diagnosi
e trattamento della neuropatia diabetica. È da segnalare purtroppo
una scarsa partecipazione da parte dei neurologi anche se la neuropatia diabetica vede figure come
il neurofisiologo ed il neurologo,
specie se si occupa dello studio del
sistema nervoso vegetativo, quotidianamente in prima linea.
Dal 18 al 22 ottobre 2008 si è tenuto a Napoli il XXXIX Congresso
Società Italiana di Neurologia in
cui l’AINV è stata presente con un
corso di aggiornamento ed una
riunione annuale dell’associazione. Il corso di aggiornamento è stato un vero trionfo e l’aula era gremita in ogni ordine di posto.
Il Prof. Albanese ha affrontato il tema
delle malattie con corpi di Lewy e
della disautonomia nei parkinsonismi. La Prof.ssa Bentivoglio ha parlato, riallacciandosi all’intervento
precedente, della diagnosi differenziale tra Atrofia multi-sistemica e m.
www.ainv.it
Cari Soci,
anche questo primo numero del
NeuroVegetativo News 2009 si preannuncia molto interessante e spe-
www.ainv.it
Editoriale
1
www.ainv.it
di Parkinson anche relativamente ai
disturbi autonomici.
Segue l’intervento del Prof. Vita il
quale ha illustrato la classificazione delle neuropatie vegetative secondo la modalità di esordio soffermandosi su alcune forme di interesse per la pratica clinica o, al
contrario, di raro riscontro come
le neuropatie vegetative disimmuni, da considerare in presenza di
una disfunzione vegetativa ad esordio in genere subacuto apparentemente idiopatica, o come la cold
induced sweating syndrome geneticamente determinata caratterizzata da iperidrosi dopo esposizione ad basse temperature.
Infine il Prof. Cortelli ha cercato
di dare cenni sulla terapia dell’ipotensione ortostatica (IO), dell’ipertensione supina talvolta concomitante all’ipotensione ortostatica e
dei disturbi della sfera uro-genita-
www.ainv.it
le. Ha trattato, inoltre, la terapia
della IO indicandone fasi e modalità: 1) fase educazionale-riabilitativa in cui ha indicato misure “non
farmacologiche” che possono migliorare l’ipotensione ortostatica e
l’ipertensione supina, 2) fase farmacologica in cui ha illustrato i
farmaci attualmente in uso e le
eventuali modalità di dispensazione da parte del S.S.N.
Durante il congresso si è inoltre
tenuta la riunione annuale dell’associazione in cui è stata assegnata
la “Valsalva Lecture” alla dott.ssa
Alessia Nicotra, siciliana di nascita ma londinese di “adozione”, che
si è distinta per i suoi studi di neurofisiologia e di Risonanza Magnetica Funzionale nei pazienti con
mielolesioni. Sono seguite tre relazioni di notevole interesse nella
pratica clinica sulle conseguenze
dello stroke sul sistema nervoso
vegetativo, su quando e come trattare la sincope neuromediata ed infine un’overview sulle neuropatie
vegetive disimmuni ed il loro possibile trattamento.
Sempre durante il Congresso della SIN si sono svolte le elezioni per
il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo AINV. Cogliamo l’occasione per porgere i nostri auguri al nuovo presidente Prof. Giuseppe Vita ed al nuovo segretario
Dott. Pietro Guaraldi.
Vi ricordiamo che sul nostro sito
www.ainv.it potrete trovare già alcune notizie sul prossimo congresso EFAS che si terrà in joint con
International Society for Autonomic Neuroscience nel settembre
2009 a Sydney (Australia).
Buona lettura
Simona Maule e Rita Di Leo
Alla ribalta …
Emozioni e sistema nervoso vegetativo
DOTT.SSA ALESSIA NICOTRA
Department of Clinical Neurophysiology, West London Neurosciences Centre, Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road,
London W6 8RF, UK - Email: [email protected]
www.ainv.it
Lo scopo di questo breve articolo
è quello di ricordare al lettore il
ruolo fondamentale del sistema
nervoso vegetativo nella modulazione delle emozioni e di stimolare quella curiositá che porta a nuovi studi e al progresso scientifico
in questo campo.
Cenni sulle teorie delle emozioni
Le emozioni sono state sempre
oggetto di studio da parte di filosofi, artisti, letterati, teologi e psicologi. Da un punto di vista strettamente neuroscientifico, diverse
teorie sulle emozioni sono state
formulate nell’arco di più di un
secolo, partendo dalla prospettiva
biologica ed evolutiva di Darwin
2
(1) fino alla elaborazione della “somatic marker hypothesis” di Damasio (2, 3).
Le emozioni sono associate alla
generazione automatica di risposte corporee. Queste sono manifestate dal sistema nervoso vegetativo come cambiamenti della pressione arteriosa, della frequenza
cardiaca e respiratoria, dell’attività delle ghiandole sudoripare, etc.
Questi cambiamenti sono definiti
“stati autonomici di attivazione
corporea” e sono a loro volta associati a cambiamenti nella attività
regionale cerebrale (4, 5).
Le risposte autonomiche periferiche, non solo agiscono da feedback
per i centri autonomici superiori
al fine di mantenere vari meccanismi corporei omeostatici, ma sono
anche una componente integrale
dell’apprendimento all’interno dei
sistemi corticali e sottocorticali
(così come avviene nel classico
“fear conditioning”) producendo
un pattern di risposte necessarie
per il supporto metabolico del
comportamento emotivo e per il
decision making (2).
Tra le varie teorie sulle emozioni,
quella “periferica” di James-Lange,
propone che le risposte di attivazione corporea, particolarmente
quelle mediate dal sistema nervoso vegetativo, sono la base delle
emozioni (6,7) “L’attività autonomica è l’essenza delle emozioni.
Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009
Uno studio importante che utilizza la PET in soggetti sani, ha analizzato la neuroanatomia funzionale del controllo cardiovascolare
centrale ed ha identificato regioni
encefaliche che rispondono a cambiamenti della frequenza cardiaca
e della pressione arteriosa in seguito a esercizio e sforzo mentale (5).
Gli autori confermano il coinvolgimento di aree encefaliche associate al comportamento cognitivo
ed emotivo nella generazione centrale e nella rappresentazione del-
Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009
www.ainv.it
la attivazione periferica cardiovascolare, suggerendo inoltre una
organizzazione funzionale nel sistema nervoso centrale designata
a produrre pattern di risposte cardiovascolari integrate per il supporto metabolico dei comportamenti volitivi e emotivi. Inoltre, i
risultati dimostrano che cambiamenti della pressione arteriosa sistemica si riflettono in cambiamenti nell’attività all’interno di
una regione distinta della corteccia cingolata anteriore di destra,
l’area di Brodmann 32 che si estende caudalmente fino all’area di
Brodmann 24. Questa regione può
essere importante per integrare i
cambiamenti periferici cardiovascolari con lo sforzo cognitivo, la
preparazione motoria e gli stati
emotivi. Questo studio ha dimostrato che le regioni della corteccia cingolata più posteriori (aree
di Brodmann 23, 24, e 31) presentano una ridotta attività durante
l’aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, che
concorda con la proposta dissociazione comportamentale delle funzioni della corteccia cingolata anteriore e posteriore; altre aree implicate nel controllo centrale cardiovascolare sembra siano la corteccia cerebellare laterale e strutture del tronco cerebrale (ponte).
I risultati di questo studio possono avere delle importanti implicazioni cliniche, considerando che
l’insufficienza centrale autonomica è una manifestazione principale della atrofia multisistemica
(MSA), e che si riscontra anche in
altri disordini neurodegenerativi,
come la malattia di Alzheimer e la
malattia da corpi di Lewy (20).
www.ainv.it
Studi con neuroimmagini
Anche se il controllo e la rappresentazione degli stati di attivazione periferica da parte delle aree
cerebrali superiori negli esseri
umani rimangono compresi in
maniera limitata, il contributo degli studi con le neuroimmagini è
stato fondamentale. Inizialmente
con la tomografia ad emissione di
positroni (PET), e più recentemente con la risonanza magnetica funzionale (fMRI), è possibile analizzare processi quali il controllo
motorio e la codificazione e rappresentazione di sensazioni visive,
uditive e somatosensitive. Inoltre,
le tecniche di neuroimmagine funzionale permettono di studiare
l’attività dei centri vegetativi superiori, correlando i cambiamenti
di segnale del functional imaging
alle fluttuazioni delle misure autonomiche periferiche.
Alcuni studi suggeriscono che il
danno alle regioni prefrontali, particolarmente alla corteccia orbitale e mediale prefrontale, compromette sia la generazione di risposte corporee che la guida emozionale al comportamento (10). Sembra che la corteccia cingolata anteriore e l’amigdala siano implicati nella generazione superiore e
riflessa di risposte agli stimoli
emotivi (4, 5, 12, 13,14, 15) e che
l’insula e la corteccia orbitofrontale siano a loro volta implicate nel
“mapping” delle conseguenti risposte corporee; è stato dimostrato che queste aree sono attive in
seguito a vari cambiamenti viscerali (16, 17,18,19).
www.ainv.it
Le emozioni dissociate dalle sensazioni corporee sono per noi incomprensibili” (7). Di conseguenza, la tristezza nasce dal piangere,
la paura nasce dal tremare o dallo
scappare via.
Partendo dalla teoria delle emozioni di James-Lange segue che gli
stimoli emotivi generano stati autonomici di attivazione corporea in
maniera autonoma (anche senza la
partecipazione della coscienza) e
che emozioni diverse sono associate a risposte corporee diverse. Quest’ultimo punto è stato l’argomento principale di Cannon (8) contro
la teoria periferica delle emozioni:
le reazioni di attivazione corporea
(soprattutto quelle simpatiche)
sono troppo stereotipiche e indifferenziate per rendere conto della
ricchezza e varietà delle esperienze emotive; le emozioni nascono
dalla valutazione degli stimoli
emotivi, e non dal feedback proveniente dal corpo. Molti psicologi
preferiscono la visione empirica a
due-fasi di Schachter e Singer (9),
secondo la quale cambiamenti di
attivazione periferica possono determinare l’intensità delle emozioni, ma la qualità (per esempio rabbia o euforia) è determinata dal
contesto cognitivo.
Modelli periferici delle emozioni,
che includono sia le componenti
vegetative che somatomotorie,
sono stati ripresi recentemente da
Antonio Damasio e collaboratori
nei loro studi su pazienti con lesioni della corteccia prefrontale
mediale: questi pazienti presentano disturbi del comportamento
sociale ed emotivo, mentre ritengono la capacità di ragionare; nonostante ripetute esperienze con
risultati negativi, prendono decisioni non ponderate e non sono in
grado di valutare “risk taking”,
durante il quale presentano diminuite risposte di attivazione corporea. Quindi è stata formulata la
“somatic marker hypothesis” che
enfatizza il feedback corporeo
come guida sul decision-making
motivazionale e influenza il comportamento emotivo e sociale (2,
3, 10, 11).
Studi molto importanti
Una maggiore conoscenza sui centri superiori del controllo vegetativo è stata raggiunta grazie allo
studio delle consequenze della interruzione periferica delle risposte
autonomiche.
I pazienti con insufficienza vegetativa (pure autonomic failure,
PAF) non possono generare risposte di attivazione autonomica a
3
www.ainv.it
causa della denervazione periferica del sistema nervoso vegetativo
(21). Uno studio con PET (17) ha
confermato che l’aumento di frequenza cardiaca e pressione arteriosa associati all’esecuzione di
calcolo mentale o esercizio isometrico non è presente nei pazienti
con PAF; inoltre, durante l’esecuzione di stimolo pressorio da sforzo, in confronto ai controlli sani,
questi pazienti hanno dimostrato
iperattività di aree encefaliche quali la porzione dorsale del ponte e
la corteccia cingolata anteriore
dorsale in assenza del feedback
periferico di attivazione vegetativa. Questo studio quindi fornisce
un modello di lesione autonomica
per studiare la dipendenza delle
aree encefaliche dal feedback proveniente dalla periferia, mettendo
soprattutto in evidenza l’attività
del tronco encefalico e della corteccia cingolata anteriore dorsale
in condizioni in cui manca l’apporto delle informazioni afferenti concernenti le risposte vegetative.
www.ainv.it
www.ainv.it
La “paura condizionata” (fear conditioning) può essere considerata
un utile modello sperimentale per
comprendere alcune delle predizioni della teoria delle emozioni di
James-Lange. Nella paura condizionata pavloviana, uno stimolo
precedentemente neutro attraverso l’associazione ad uno stimolo
avversivo incondizionato diventa
“emotional threat”; questa predice le consequenze corporee dello
stimolo incondizionato avversivo e
produce una risposta di attivazione comportamentale e vegetativa,
sia quando è accoppiata allo stimolo incondizionato sia quando non
lo è.
In uno studio che utilizza la risonanza magnetica funzionale in pazienti con PAF, Critchely et al. (18)
hanno valutato l’effetto della disconnessione delle risposte autonomiche periferiche dalle risposte
emotive encefaliche durante la paura condizionata, dimostrando che
l’attività encefalica associata al fear
conditioning è ridotta nell’ insula
di destra e nell’amigdala di destra
4
nei pazienti con PAF. Questo indica che sia la corteccia dell’insula
che l’amigdala, particolarmente
dal lato destro, sono coinvolte nella rappresentazione viscerale afferente degli stati di attivazione autonomica provocati dalle emozioni. Dato il ruolo dell’insula come
corteccia viscerosensitiva (16, 22,
23), queste osservazioni confermano l’importanza dell’insula di destra nella rappresentazione delle
emozioni, che a loro volta nascono dalla rappresentazione delle risposte corporee (3, 6,7).
Un altro modello lesionale per analizzare le consequenze della mancanza di feedback di attivazione
autonomica è dato dalle lesioni
spinali (spinal cord injury, SCI).
Disturbi emotivi, ansia e depressione, sono stati descritti nelle SCI
(24). Numerosi studi che dimostrano l’importanza delle influenze
ascendenti sui processi neurali
superiori, incluse le emozioni (3,
16, 25, 26, 27), suggeriscono che
il grado con cui le risposte di attivazione corporea sono percepite
possa modificare l’espressione delle emozioni sia in individui sani
(28) che in pazienti con SCI (29).
Questo è in contrasto con studi che
riportano un’assenza di disturbi
emozionali in questi pazienti, sulla base di misurazioni neuropsicologiche ( 29, 30, 31, 32, 33).
Uno studio recente ed interessante basato sulla risonanza magnetica funzionale e su un paradigma
di condizionamento pavloviano
(fear conditioning), ha valutato
l’ipotesi che nei pazienti con SCI
croniche l’assenza di informazioni spinali afferenti moduli l’espressione dell’attività encefalica associata ad emotional processing (34).
I risultati hanno dimostrato che la
risposta fMRI alla stimolazione
dolorosa è simile sia nei pazienti
con SCI che nei controlli sani, ed
è legata all’attivazione della corteccia cingolata anteriore dorsale, del
lobo temporale mediale e della corteccia somatosensitiva. Invece,
l’attività encefalica durante i processi di apprendimento emoziona-
le (“emotional threat”) ha mostrato differenze notevoli tra i due
gruppi. Innanzitutto, l’attività cerebrale è ridotta nei pazienti con
SCI in confronto a quella dei controlli sani in aree quali la corteccia cingolata posteriore e la porzione mediale della corteccia prefrontale, aree associate a controllo autonomico, suggerendo che l’assenza di informazioni spinali afferenti comporta un funzionamento
anomalo di queste regioni encefaliche durante emotional threat che
può contribuire alla predisposizione a disturbi emozionali e depressivi nelle SCI. Inoltre, l’attività
cerebrale durante emotional threat è aumentata nei pazienti con
SCI in confronto a quella dei controlli sani nella sostanza grigia
periacqueduttale e nella corteccia
cingolata anteriore, aree normalmente associate con “pain processing”, indicando una ipersensitività di queste aree encefaliche nei
pazienti con SCI.
Questo studio è il primo ad utilizzare la risonanza magnetica funzionale per analizzare processi di
apprendimento emotivo e meccanismi che possono avere un impatto sulla qualità di vita nei pazienti
con SCI croniche, e indica che in
questi pazienti le aree cerebrali
deputate al controllo delle emozioni presentano delle anomalie che
originano dal deficit cronico di feedback delle informazioni somatosensitive e viscerali, dal midollo
spinale all’encefalo, associato al
deficit di controllo ortosimpatico.
I risultati di questi studi contribuiscono al progresso scientifico in
un’area cruciale per l’assistenza
medica ed il benessere del paziente.
Bibliografia
1) Darwin C. 1898. The expression of the
emotions in man and animals. Third
edition, 1998, edited by P. Ekman.
Oxford: Oxford University Press.
2) Damasio AR, Tranel D, Damasio HC.
Somatic markers and the guidance of
behavior: theory and preliminary
testing. In: Levin HS, Eisenberg HM,
Benton LB, editors. Frontal lobe
function and dysfunction. New York:
Oxford University Press, 1991.
3) Damasio AR. Descartes’ error: emotion,
Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
Invitiamo i Signori Soci
a rinnovare l’iscrizione
per l’anno 2009
utilizzando l’allegata scheda
Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009
www.ainv.it
6)
24)
the physiological conditionof the body.
Curr Opin Neurobiol 2003; 13:500-05.
Kennedy P, Rogers BA. Anxiety and
depression after spinal cord injury: a
longitudinal analysis. Arch Phys Med
Rehabil 2000; 81:932-37.
Cameron OG. Interoception: the inside
story- a model for psychosomatic
processes. Psychosom Med 2001; 63:
697-710.
Bernston GG, Sarter M, Cacioppo JT.
Ascending visceral regulation of
cortical affective information
processing. Eur J Neurosci 2003; 18:
2103-09.
Damasio AR. The feeling of what
happens: body and emotion in the
making of consciousness. New York:
Hartcourt Brace; 1999.
Wiens S, Mezzacappa E, Katkin ES.
Heartbeat detection and the experience
of emotion. Cogn Emot 2000; 14: 41727.
Chwalisz K, Diener E, Gallagher D.
Autonomic arousal feedback and
emotional experience: evidence from
the spinal cord injured. J Pers Soc
Psychol 1988; 54: 820-88.
Dana C. The anatomical seat of the
emotions: a discussion of the JamesLange theory. Arch Neurol Psychiatr
1921; 6: 634-39.
Lowe J, Carrol D.The effects of spinal
cord injury. Br J Clin Psychol 1985; 24:
135-36.
Cobos P, Sánchez, García C, Vera MN,
Vila J. Revisiting the James versus
Cannon debate on emotion: startle and
autonomic modulation in spinal cord
injuries. Biol Psychol 2002; 61 251-69.
O’Carrol RE, Ayling R, O’Reilly SM.
North NT. Alexithymia and sense of
coherence in patients with total spinal
cord transaction. Psychosom Med
2003; 65: 151-55.
Nicotra A, Critchley HD, Mathias CJ,
Dolan RJ. Emotional and autonomic
consequences of spinal cord injury
explored using functional brain
imaging. Brain 2006; 129: 718-28.
www.ainv.it
5)
14) Critchley HD, Josephs O, O’Doherty J,
Zanini S, Dewar B-K, Mathias CJ,
Cipolotti L, Shallice T, Dolan RJ.
Human cingulated cortex and
autonomic cardiovascular control:
converging neuroimaging and clinical
evidence. Brain 2003; 216:2139-56.
15) Phelps EA, O’Connor KJ, Gatenby JC,
Gore JC, Grillon C, Davis M. Activation
of the left amygdala to a cognitive
representation of fear. Nat Neurosci
2001; 4: 437-41.
16) Craig AD. How do you feel? Interoception: the sense of the physiological
condition of the body. Nat Rev Neurosci
2002; 3: 655-66.
17) Critchley HD, Mathias CJ, Dolan RJ.
Neural correlates of first and secondorder representation of bodily states.
Nat Neurosci 2001; 2: 207-12.
18) Critchely HD, Mathias CJ, Dolan RJ.
Fear-conditioning in humans: the
influence of awareness and arousal on
functional neuroanatomy. Neuron
2002; 33:653-63.
19) Critchely HD, Wiens S, Rotshtein P,
Ohman A, Dolan RJ. Neural systems
supporting interoceptive awareness.
Nat Neurosci 2004; 7: 189-95.
20) Bannister R and Mathias CJ. Clinical
features and evaluation of the primary
chronic autonomic failure syndromes.
In: Mathias CJ and Bannister R, editors.
Autonomic failure. A textbook of
clinical disorders of the autonomic
nervous system. Fourth edition. New
York: Oxford University Press; 1999;
307-16.
21) Mathias CJ. Disorders of the autonomic
nervous system. In: Bradley WG, Daroff
RB, fenichel GM, et al., editors.
Neurology in clinical practice. Woburn,
MA: Butterworth-Heinemann 2000;
2131-65.
22) Saper CB. The central autonomic
nervous system: conscious visceral
perception and autonomic pattern
generation. Annu Rev Neurosci 2002;
25: 433-69.
23) Craig AD. Interoception: the sense of
www.ainv.it
4)
reason and the human brain. New York:
Grosset Putnam 1994.
Critchley HD, Elliot R, Mathias CJ,
Dolan RJ. Neural activity relating to the
generation and representation of
galvanic skin conductance response: a
functional magnetic imaging study. J
Neurosci 2000a; 20: 3033-40.
Critchley HD, Cornfield DR, Chandler
MP, Mathias CJ, Dolan RJ. Cerebral
correlates of autonomic cardiovascular
arousal: a functional neuroimaging
investigation in humans. J Physiol,
2000b, 523: 259-70.
Lange CG. The mechanism of the
emotions. In: Rand B, editor. The
classical psychologist. Boston:
Houchton Mifflin 1885; 672-85.
James W. Physical basis of emotion.
Psychol Rev 1894; 1:516-29. Reprinted
1994, Psychol Rev 101:205-10.
Cannon WB. The James-Lange theory
of emotions. Am J Psychol 1927; 39:
115-24.
Schachter S, Singer JE. Cognitive,
social and physiological determinants
of emotional state. Psychol Rev 1962;
69:379-99.
Bechara A, Tranel D, Damasio H,
Damasio AR. Failure to respond
autonomically to anticipated future
outcomes following damage to
prefrontal cortex. Cereb Cortex 1996;
6: 215-25.
Bechara A, Damasio H, Tranel D,
Damasio AR. Deciding advantageously
before knowing the advantageous
strategy. Science 1997; 275:1293-95.
Fredrikson M, Furmark T, Olsson MT,
Fischer H, Anderson J, Langstrom B.
Functional neuroanatomical correlates
of electrodermal activity: a positron
emission tomography study. Psychophysiology 1998; 35: 179-85.
Patterson JC 2 nd, Ungerleider LG,
Bandettini PA. Task-independent
functional brain activity correlation
with skin conductance changes: an
fMRI study. Neuroimage 2002; 17:
1797-1806.
5
www.ainv.it
Highlights
I nuovi criteri per la diagnosi di atrofia multisistemica
SIMONA MAULE*, RITA DI LEO**
*Ambulatorio per l’Ipotensione Ortostatica e le Disautonomie, Ospedale S. Giovanni Battista, Università degli Studi di Torino
**Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologiche, Università degli Studi di Messina
L’atrofia multisistemica (MSA) è
una malattia neurodegenerativa,
sporadica, progressiva che insorge
in età adulta. La diagnosi di MSA è
strutturata in tre livelli: definita
(possibile solo attraverso l’esame
autoptico), probabile e possibile. I
criteri diagnostici del 1998 (1)
hanno rappresentato il gold standard per la diagnostica della MSA,
tuttavia sono considerati complessi e difficili da memorizzare, nonché carenti delle recenti acquisizioni diagnostiche laboratoristiche
e di imaging (2). Studi di validazione hanno dimostrato un’elevata accuratezza predittiva dei criteri del 1998 per la diagnosi di MSA
“probabile”, tuttavia con sensibilità insufficiente soprattutto negli
stadi iniziali di malattia, mentre la
1998
2008
Criterio autonomico + criterio parkinsoniano con scarsa risposta alla levodopa o criterio cerebellare
• Disfunzione autonomica (urgenza minzionale o incompleto svuotamento vescicale con disfunzione erettile o OH
30 mmHg PAS. o 15 PAD) +
• Parkinsonismo con scarsa risposta alla levodopa (bradicinesia con rigidità, tremore o instabilità posturale) o
• Disfunzione cerebellare (andatura atassica con disartria
cerebellare, atassia arti o nistagmo cerebellare)
Criteri:
• Autonomico (urgenza minzionale o incompleto svuotamento vescicale con disfunzione erettile o OH 30
mmHg PS o 15 PD)
• Parkinsoniano (bradicinesia e rigidità o instabilità posturale o tremore)
• Cerebellare (andatura atassica e disartria cerebellare
o atassia arti o nistagmo cerebellare)
Un criterio + due segni di domini diversi
Possibile
www.ainv.it
Probabile
Tabella I
Segni:
• Autonomici (OH 20 PAS o 10 PAD, incontinenza urinaria o incompleto svuotamento vescicale)
• Parkinsoniani (bradicinesia, rigidità, instabilità posturale, tremore, scarsa risposta alla levodopa)
• Cerebellari (andatura atassica, disartria cerebellare,
atassia arti, nistagmo cerebellare)
• Parkinsonismo (bradicinesia con rigidità, tremore o instabilità posturale) o
• Disfunzione cerebellare (andatura atassica con disartria
cerebellare, atassia arti o nistagmo cerebellare) +
• Un segno di disfunzione autonomica (urgenza minzionale, incompleto svuotamento vescicale, disfunzione erettile o OH 20 mmHg PAS o 10 PAD) +
• Un segno addizionale (tabella sotto)
Tabella II
www.ainv.it
Segni addizionali di possibile MSA (2008)
Possibile MSA-P o MSA-C
• segno di Babinski con iperreflessia
• stridore
Possibile MSA-P
• parkinsonismo rapidamente progressivo
• scarsa risposta alla levodopa
• instabilità posturale entro 3 anni dall’insorgenza disturbi motori
• andatura atassica, disatria cerebellare, atassia arti, o nistagmo cerebellare
• disfagia entro 5 anni dall’insorgenza disturbi motori
• atrofia alla RM di putamen, peduncolo cerebellare medio, ponte o cervelletto
• ipometabolismo alla PET-FDG di putamen, tronco encefalico o cervelletto
Possibile MSA-C
• parkinsonismo (bradicinesia e rigidità)
• atrofia alla RM di putamen, peduncolo cerebellare medio o ponte
• ipometabolismo alla PET-FDG di putamen
• denervazione dopaminergica presinaptica nigrostriatale alla SPECT o PET
Legenda: OH, ipotensione ortostatica; PAS, pressione arteriosa sistolica; PAD, pressione arteriosa diastolica; P, MSA con predominante parkinsonismo; C, MSA con predominante atassia cerebellare
6
Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009
1998
2008
Criteri di esclusione
Elementi di supporto
Elementi non di supporto
Esordio prima dei 30 anni
Distonia orofaciale
Classico tremore a riposo
Storia familiare di disordine analogo
Antecollo sproporzionato
Neuropatia clinicamente rilevante
Malattia sistemica o altre cause
identificabili dei sintomi elencati sopra
Camptocormia e/o sindrome di Pisa
Allucinazioni non dovute a terapia
Allucinazioni non dovute a terapia
Contratture di mani o piedi
Esordio dopo i 75 anni
Demenza
Gasps inspiratori
Storia familiare di atassia o parkinsonismo
Paralisi nello sguardo verso l’alto
(caratteristica della PSP)
Disfonia grave
Demenza
Evidenza di disfunzione corticale
focale (es. afasia)
Disartria grave
Lesioni della sostanza bianca che
suggeriscono la sclerosi multipla
Russamento di nuova insorgenza
o peggiorato
Mani o piedi freddi
www.ainv.it
Tabella III
Tremore irregolare posturale o
da azione
retta dei sintomi e segni richiesti
per la diagnosi. Inoltre è stato aggiunto un elenco di elementi addizionali, risultante anche da indagini strumentali attualmente
validate in questa patologia. Gli
autori della seconda Consensus ritengono la diagnosi di MSA “possibile” facilitata dalla possibilità di
utilizzo di parametri clinici e di
imaging ulteriori e sgravata da falsi positivi.
Alleghiamo due tabelle (I, II) riassuntive dei criteri di entrambe le
stesure per consentire ai lettori un
confronto immediato che faciliti la
memorizzazione. È nostra personale opinione che, al di là dei nuo-
vi apporti diagnostici strumentali
(tabella II), i nuovi criteri non risultino sostanzialmente più facili
e maneggevoli. Risultano invece
completamente modificati i criteri di esclusione, distinti nella seconda versione in elementi diagnostici di supporto e non di supporto
(tabella III), scarsamente commentati nel testo dell’articolo.
Bibliografia
(1) Gilman S e coll. Consensus statement
on the diagnosis of multiple system
atrophy. J Neurol Sci 1999, 163: 94-98
(2) Gilman S e coll. Second consensus
statement on the diagnosis of multiple
system atrophy. Neurology 2008, 71:
670-676
CONGRESSI IN AGENDA
9th International Conference on Alzheimer‘s and Parkinson’s Diseases - ADPD 2009
March 11-15, Prague, Czech Republic
American Academy of Neurology 2009 Annual Meeting
April 25–May 2, Seattle, WA, USA
Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009
www.ainv.it
diagnosi di MSA “possibile” ha bassa accuratezza diagnostica e migliore sensibilità (2).
A differenza della prima stesura
(1), nella Consensus del 2008 (2)
la diagnosi definita di MSA richiede il riscontro neuropatologico degli inclusi citoplasmatici di !-sinucleina nel sistema nervoso centrale in associazione alla neurodegenerazione delle strutture striatonigrali e olivopontocerebellari.
La principale differenza tra i criteri attuali ed i precedenti riguarda la diagnosi di MSA “possibile”.
Nella stesura attuale è stata eliminata la distinzione tra criteri e segni a favore di una descrizione di-
www.ainv.it
Pianto o riso spastici
7
2009
www.ainv.it
L’AINV nasce nel 1996 e riunisce i neurologi interessati allo studio del sistema
neurovegetativo.
È affiliata SIN - Società Italiana di Neurologia ed EFAS – European Federation of Autonomic Nervous System.
Grazie alla continua e fruttuosa collaborazione tra neurologi, fisiologi, internisti, cardiologi, gastroenterologi, la ricerca sul sistema neurovegetativo ha portato ed è destinata a portare ancora a importantissime scoperte.
L’obiettivo principale dell’Associazione consiste nel favorire il dialogo e diffondere le conoscenze. Ciò porterà allo sviluppo di nuove idee che, inevitabilmente in quest’ambito, avranno valenza interdisciplinare.
www.ainv.it
Tra i vantaggi di essere socio dell’AINV:
• ricevere NEUROVEGETATIVO NEWS, il periodico dell’Associazione
• divenire automaticamente socio anche dell’EFAS, e avere di conseguenza agevolazioni per l’iscrizione al Congresso annuale EFAS
www.ainv.it
• abbonarsi al prezzo riservato ai soci di € 110,00 al Clinical Autonomic Research (Official journal of the American
Autonomic Society, Clinical Autonomic Research Society and Eyropean Federation of Autonomic Societies),
l'unico periodico indicizzato ricco di reviews, editoriali e lavori scientifici originali nel campo della ricerca clinica
del SNV. (Contattare direttamente la casa editrice Steinkopff Verlag [email protected];
[email protected], specificando che si è soci AINV).
La quota di iscrizione all’AINV è di € 36,00 (€ 18,00 per specializzandi e dottorandi), e può essere versata tramite
bonifico bancario sul c/c 1108490 intestato a AINV, Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Agenzia n. 20 di Bologna
CAB 02412 ABI 5387 IBAN IT76T0538702412000001108490, oppure tramite assegno di conto corrente bancario
intestato a AINV ed inviato alla Segreteria (MCC, via S. Stefano 57, 40125 Bologna BO, tel. 051263703, fax 051238564,
e-mail [email protected])
✂
SCHEDA AINV 2009
Cognome _________________________________________ Nome _________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
Sede di lavoro _____________________________________________________________________________
Via ____________________________________________ CAP _____________ Città ___________________
www.ainv.it
E-mail ______________________________________ Tel. __________________ Fax __________________
Indirizzo Abitazione ________________________________________________________________________
CAP _____________________________ Città ___________________________________________________
❑ Nuova Iscrizione
❑ Rinnovo
❑ € 36,00
❑ € 18,00 per specializzandi e dottorandi
❑ Allego assegno di c/c n. ________________________ della banca__________________________
❑ Allego copia del bonifico bancario
Data ________________________
Firma ____________________________________________
Si garantisce la massima riservatezza e tutela dei dati personali (Legge 196/2003), utilizzati solo per finalità strettamente funzionali alla gestione dei rapporti.
8
Anno 9 • Numero 1 • Gennaio - Aprile 2009