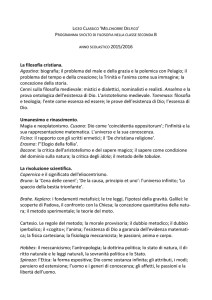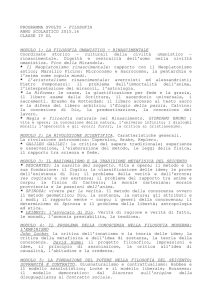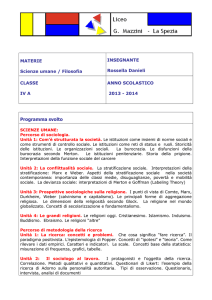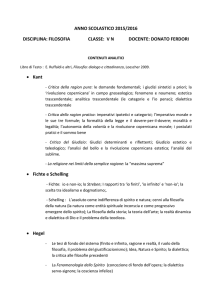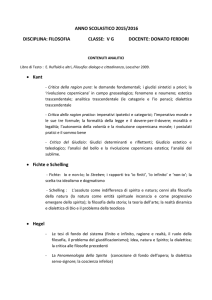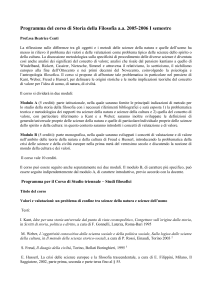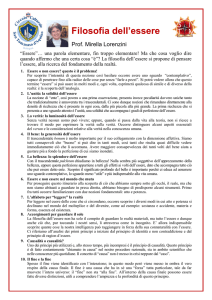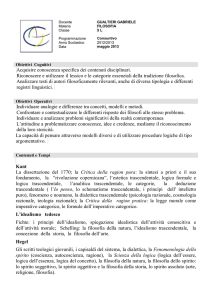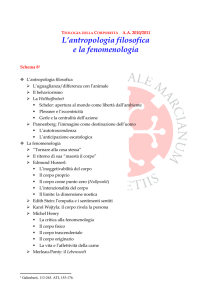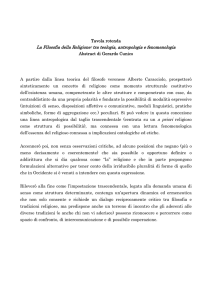Far filosofia
oggi
Intervista a Massimo Barale
a cura di Bachisio Deledda
Domanda Fin dai suoi albori, la ricerca filosofica si è caratterizzata quale tentativo di istituire le condizioni di un sapere universale. L’istanza di
universalità di cui si è fatta interprete e da cui si è lasciata guidare
anche quando ha finito per contraddirla è un suo tratto distintivo
di cui è lecito chiedersi se e a quali condizioni possa ritenersi ancora
attuale. È ancora pensabile un modo di far filosofia segnato dal tentativo di procedere oltre ogni visione parziale delle cose, in direzione
di strutture e principi, dell’essere e dell’agire, suscettibili di valere
per tutti e in qualunque circostanza?
Risposta: L’ipotesi di un sapere suscettibile di valere per tutti e in qualunque circostanza si presta a formulazioni diverse e non v’è dubbio
che alcune di esse debbano ritenersi non più attuali. In breve:
inattuale e da respingere considero ogni proposito di sapere universale il cui sottinteso siano una concezione monistica della ve-
rità: l’idea di una verità a cui ogni altra dovrebbe poter essere
ricondotta, l’assunto che le molte verità parziali suscettibili di
concorrervi debbano risultare infine componibili in una verità
unica, in grado di prenderne il posto e alla quale dovremmo pertanto, fin dall’inizio e in ogni momento, mirare. In questa tesi
che verità diverse possano essere ammesse, tollerate, solo quando
è possibile pensarle quali tappe di un cammino unico e, dunque,
solo nella prospettiva di un loro superamento, dobbiamo oggi
riconoscere un rigurgito del passato, un fantasma tra i più pericolosi perché incompatibile con quanto gli autonomi sviluppi
di saperi diversi ci hanno nel frattempo insegnato circa il nostro
modo di pervenire a una conoscenza quale che sia: un modo in
nessun caso incondizionato, in ogni caso e a ogni livello mediato
da una cornice teorica non altrimenti interpretabile se non come
un linguaggio nei limiti del quale stiamo procedendo. Avendo
imparato questo abbiamo imparato anche che nessuno dei linguaggi, naturali o artificiali, alle cui capacità di mediazione possiamo essere tentati di affidarci, può essere ritenuto funzionale
alla generalità delle esperienze per noi possibili: ognuno può risultare funzionale, tutt’al più, a una tipologia di esperienze che
altre ne sta escludendo. Nell’una o nell’altra di prospettive l’una
all’altra irriducibili il nostro modo inevitabilmente mediato di
pervenire a una conoscenza quale che sia ci obbliga a muoverci,
con la consapevolezza che a questa pluralità di accessi disponibili non potremmo rinunciare senza che la realtà di cui facciamo
esperienza non ne risulti impoverita, imprigionata in schemi che
le impedirebbero di rispondere alla maggior parte delle attese e
degli interrogativi che suscita. Quando mi si chiede se le proprietà del tavolo che ho di fronte siano quelle che gli sta attribuendo
la mia attuale, ordinaria percezione di esso (le proprietà di una
cosa, da ogni altra separabile al modo di un ente in sé consistente
e per sé sussistente) o non siano piuttosto quelle che, nel suo laboratorio e alla luce delle sue analisi, gli attribuisce il microfisico
quando altra realtà non è disposto a riconoscergli se non quella di
un campo di forze che con altri costantemente interferisce, devo
essere in grado di rispondere, non per quieto vivere, ma a ragion
veduta, che entrambe queste rappresentazioni del tavolo hanno
pieno diritto di cittadinanza, perché entrambe capaci di fungere
da veicolo e tramite di verità ad esso riconducibili. E questa risposta non sarebbe sufficiente se non fossi in grado di aggiungere
che un medesimo diritto, una analoga capacità di farsi tramite
di verità ad esso riferibili, è doveroso riconoscere anche ad altre
sue rappresentazioni possibili: ad esempio, alla rappresentazione che potrebbe darcene un pittore cubista, nelle forme di un
linguaggio certamente diverso da quello che disciplina le nostre
percezioni ordinarie non meno che da quello alle cui capacità
esplicative si affida il microfisico. Ma risposte come questa non
arrivano da sé e, soprattutto, vanno date con una consapevolezza
che eviti di fraintenderle, di attribuire loro un significato diverso
da quello che dovrebbero poter assumere.
Domanda
Può essere più esplicito?
Risposta
Voglio esserlo. La tesi che propongo di porre al centro del nostro
odierno modo di far filosofia, la tesi di una pari dignità di accessi
diversi a una realtà che non cesseremo per questo di considerare per tutti la medesima, non è un semplice corollario della tesi
che ne riconosce l’irriducibile pluralità. Questo riconoscimento,
infatti, è un accertamento con cui ci si limita a rispondere alla
questione di fatto circa la possibilità o impossibilità di una loro
reductio ad unum, mentre affermare che accessi diversi e di fatto
irriducibili godono di pari dignità teorica significa rispondere
a una questione di diritto o, se si preferisce, di valore, circa la
legittimità delle loro pretese. Una questione come questa può
essere proposta solo assumendo che si diano punti di vista in
grado di garantirne una valutazione equanime, quale potrebbe
darsi solo ammettendo che identici per tutti siano i titoli che
a ciascuno richiedono. Ma questo significa che, lungi dal poter
essere considerata un semplice corollario della loro riconosciuta
pluralità e irriducibilità, la tesi della pari dignità teorica di accessi irriducibilmente diversi, può essere coerentemente sostenuta
solo su presupposti incompatibili con qualsivoglia tentazione di
utilizzare il dato della loro irriducibilità come un’arma per escludere in partenza ogni prospettiva suscettibile di promuovere una
considerazione trasversale di ogni altra possibile: solo ammettendo che dia un modo di considerarle rispettoso della loro autonomia, ma nello stesso tempo in grado di far valere parametri
comuni a cui nessuna potrebbe pretendersi indifferente.
Domanda
Sarebbe una prospettiva certamente bene accolta da quanti sentono
il bisogno di ridefinire i compiti della ricerca filosofica salvaguardandone al tempo stesso l’autonomia. Ma si può dubitare che possa
effettivamente darsi ed è lecito chiedersi quali strategie potrebbero
istituirla e quali condotte teoriche potrebbero consentirci di mantenerla e svilupparla. Quali sono le sue risposte a questi interrogativi?
Risposta
Le mie risposte tengono conto di quanto ho imparato da tre
indirizzi del pensiero contemporaneo che su un’idea della filosofia come sapere eminentemente trasversale sostanzialmente
convergono: l’indirizzo che variamente si richiama ai principi di
un’ontologia definita “ermeneutica”, l’indirizzo che ha scelto di
chiamarsi “analitico” e l’indirizzo che si riconosce nell’originario
progetto husserliano di una fenomenologia trascendentale. Al
primo di questi tre indirizzi (primo, s’intende, nella ripresa che
sto qui facendone) riconosco un merito che non è tanto quello di aver sostenuto il primato ontologico del linguaggio, cioè
una tesi che, nelle sue formulazioni più radicali (là dove sconfina
nell’affermazione che tutto, in noi e per noi, è linguaggio e che
non unicamente nei limiti di un linguaggio, ma da eventi che
di natura linguistica già sempre sarebbero ogni nostra esperienza procede), mi sembra oggi difficilmente accettabile , quanto
quello di aver favorito un modo di considerarlo che in ogni linguaggio ha insegnato a cogliere le sue essenziali valenze ontologiche, ben al di là di quanto di convenzionale e arbitrario va
riconosciuto nei simboli di cui si avvale. In questa direzione, le
filosofie di indirizzo ermeneutico si sono incontrate con quelle di
indirizzo analitico, alle cui indagini di tipo morfologico-intenzionale hanno non poco contribuito. Su questo punto vorrei un
istante fermarmi, perché quel tipo di indagine che sto definendo
morfologico-intenzionale rappresenta un primo e imprescindibile livello di ogni considerazione di saperi diversi che “filosofica”
voglia risultare. Nella prospettiva che sto disegnando, coincide
col primo livello di formazione di quel punto di vista compiutamente trasversale che miriamo a istituire.
Domanda
Può dirci allora quando e come una riflessione filosofica su saperi
diversi può pretendere di aver soddisfatto le condizioni di una
ricostruzione morfologico-intenzionale della loro genesi?
Risposta
Le ha soddisfatte quando sia arrivata a privilegiarne la dimensione linguistica e a farci riconoscere in essa uno dei tanti linguaggi
attraverso i quali i possibili oggetti delle nostre esperienze risultano identificabili. Mi sembra questa l’unica via che una riflessione
filosofica consapevole dei propri debiti storici e dei limiti istituzionali che le impongono può oggi scegliere come specificamente
propria. È la via di un’indagine che ha il merito di spostare l’attenzione da quel mero dato di fatto che un sapere quale che sia
non cesserebbe altrimenti di essere verso condizioni in grado di
illuminarci circa la sua possibilità. Alla morfologica ricostruzione
di un sapere quale linguaggio tra altri possibili non si perviene,
infatti, se non riconoscendo nelle sue strutture formali una ratio a cui stanno rispondendo, un’intenzione da cui dipendono
e che può essere legittimamente assunta quale unità di misura di
una loro adeguatezza se non altro strumentale. A misurarla sono
criteri che nello spazio di una comprensione morfologico-intenzionale si rendono per la prima volta disponibili: compatibilità,
congruenza, funzionalità. Ad essi siamo debitori di un primo
esempio di considerazione trasversale, poiché non vi è linguaggio che a una valutazione condotta in loro nome possa legittimamente sottrarsi. Sono inoltre i più idonei a rendere visibili e
apprezzabili forme di razionalità di tipo strumentale variamente
operanti nelle diverse manifestazioni della nostra vita. È quanto
basta a giustificare l’interesse del filosofo del nostro tempo verso
quel tipo di indagine morfologico-intenzionale che ne consente
un’assunzione metodica e coerente. Ma la trasversalità dei criteri
che fa valere non è ancora quella di un’esperienza in grado di assumere i diversi linguaggi a cui si applicano quali proprie interne
articolazioni. Se a questa si mira, un passo ulteriore s’impone.
Domanda
Mi sembra di capire che proprio a un’esperienza siffatta lei stia pensando come a una pratica filosofica ancora possibile. Quali potrebbero esserne le condizioni?
Risposta
Ho già accennato a un mio debito verso il progetto husserliano
di una fenomenologia trascendentale. Da esso ho tratto stimoli
decisivi per recuperare su basi nuove, profondamente diverse da
quelle che aveva saputo offrirle la tradizione ontoteologica della
filosofia medioevale e moderna, l’ipotesi di un orizzonte delle nostre esperienze definibile come trascendentale e di un’esperienza
che di esso in qualche modo sia. Da sempre, cioè fin dalle sue prime apparizioni tardo-medioevali, la nozione di “trascendentale”
si è trovata associata all’idea di un punto di vista sovraordinato
rispetto a tutti quelli che vengono a coincidere con l’una o con
l’altra prospettiva categoriale . Oggi diremmo: rispetto a tutti
quelli che dobbiamo considerare conseguenti all’adozione di un
determinato linguaggio. Ma, nella prospettiva ontoteologica di
quelle filosofie tardomedioevali e protomoderne che lo teorizzavano, era inevitabile pensare che un punto di vista a ogni altro sovraordinato potesse essere assicurato solo da nozioni o predicati
dotati della massima generalità: tanto generali da poter valere in
ogni momento e per ogni ente in quanto tale. Questa più antica identificazione del trascendentale con un ordine di nozioni
tanto generali da non poter essere eluse, da dover essere ammesse come una forma di intelligenza implicita in ogni altra, è oggi
non meno improponibile dei tanti pregiudizi su cui si reggeva.
Nessuno si sognerebbe di riproporla, di ritenere attuali forme di
trascendentalismo che non potrebbero essere recuperate se non
riproponendo il modello di quelle ontologie che abbiamo imparato a definire classiche e, con esso, una concezione del pensare come classificare, del conoscere come restituzione alla realtà
di immagini di sé che essa stessa spontaneamente produrrebbe,
della realtà stessa quale universo di enti dotati ciascuno di una
propria irriducibile individualità e destinati a occupare in esso,
nell’universo finito di cui segnerebbero i confini, un luogo e un
tempo univocamente determinabili. Pensieri come questi sono,
per la nostra ricerca di un orizzonte comune a cui ancorare le
molteplici esperienze da cui possiamo essere tentati, una zavorra
che può solo scoraggiarla: fantasmi, nondimeno in grado ancora
di condizionarla e da cui non potrà interamente liberarsi finché
non cesserà di percorrere rotte che furono le loro. Fuor di metafora: finché suo tema continuerà ad essere un ipotetico fondamento meta categoriale delle nostre categoriali assunzioni che in
null’altro se non in nozioni più generali di quelle oltre le quali lo
stiamo cercando potrebbe consistere. È necessaria una svolta. E
la svolta decisiva verso una nuova concezione del trascendentale
esige che non più al modo di un metacategoriale fondamento,
ma al modo di un precategoriale orizzonte venga cercato. L’ho
imparato da Husserl ma, paradossalmente, la lezione di Husserl
mi è servita soprattutto per rileggere Kant. E proprio nelle pagine di un Kant riletto alla luce delle avvertenze husserliane ho
trovato la risposta che cercavo: una teoria di quella dimensione
delle nostre esperienze che trascendentale merita di essere detta
finalmente all’altezza delle mie aspettative, perché capace di farla coincidere con una vera e propria esperienza di ogni modo di
condurre esperienze quali che siano a cui ognuna deve la propria
possibilità e ai cui parametri non può pertanto, senza contraddizione, sottrarsi.
Domanda
Mi sembra inevitabile chiederle di quale esperienza si tratti e quali
pagine di Kant gliel’abbiano suggerita.
Risposta
Husserl mi ha insegnato a riconoscere, nella kantiana Critica della ragion pura, sepolte sotto le macerie di una metafisica delle
forme che rischia continuamente di soffocarla, le linee fondamentali di una fenomenologia del senso il cui approdo finale è
la scoperta di una precategoriale essenza della umana ragione: di
quella capacità di orientamento e di organizzazione a cui ogni
possibile assetto formale delle nostre esperienze costantemente
rimanda. Metafisica delle forme ho imparato a chiamare quei
momenti della teoria kantiana dell’esperienza che si prestano a
fungere da vero e proprio ricettacolo dei più tradizionali pregiudizi circa una conformazione naturale della nostra mente e una
conseguente impossibilità per le nostre esperienze di cogliere una
verità quale che sia quando dovessero uscire dai confini di una
logica e di un linguaggio ritenuti gli unici in grado di assecondarle. Fenomenologia del senso ho per contro imparato a chiamare
quei suoi momenti alternativi nei quali prevale l’istanza di esperienze disposte a interrogarsi sulle proprie condizioni di senso
e, pertanto, in linea di principio disponibili ad assumere forme
diverse. Su questi momenti alternativi ho concentrato la mia attenzione, cogliendone il nesso con una teoria della ragione non
vincolata all’assunto di una sua indeclinabilità, di un suo vincolo
strutturale con un’unica sua possibile articolazione formale. Anche questo c’è in Kant. Di questa mia rilettura del suo progetto
di una critica della ragione ho dato conto in molti lavori e, più
recentemente, in un saggio che la rivista “Studi kantiani” proporrà nel suo fascicolo di quest’anno. Ho mostrato come luoghi
canonici di una metafisica delle forme debbano ritenersi le cosiddette “esposizione metafisiche” delle forme pure della sensibilità e dell’intelletto e quei tentativi di esposizione o deduzione
trascendentale delle medesime forme che sui risultati delle loro
esposizioni metafisiche non possono evitare di basarsi. Ho contestualmente mostrato come, in alternativa, luoghi canonici di
una inedita fenomenologia del senso debbano invece considerarsi quei capitoli della Dialettica trascendentale della prima Critica
e quelle pagine della terza Critica in cui il tema diventa un’essenza dell’umana ragione non riducibile al alcuno di quegli assetti
formali delle nostre esperienze in cui può trovare espressione e
identificabile piuttosto come quel modo di promuoverli e svilupparli che, pur nel rispetto della loro specificità, li rende partecipi
di un’impresa comune: complici di un progetto che con la sua
stessa essenza si identifica. Ragionare, infatti, quali che siano le
forme in cui ragioniamo, significa sempre far valere un principio
di compossibilità e scommettere sulla possibilità di una finale coesistenza di tutti i possibili che accettino di obbedirvi. A Kant
dobbiamo la scoperta di questa essenza progettuale del nostro
ragionare, di una sua dimensione teleologica che lo caratterizza
nella sua stessa scelta dei propri codici formali e quali che siano
i codici formali di cui sta tentando di avvalersi. Ragionare, condurre le nostre esperienze in un modo che ragionevoli consenta
loro di risultare, significa offrire alle loro possibili articolazioni
formali una prospettiva che non cessa di essere la loro, l’unica
condizione di senso a cui non possono rinunciare, neppure quan-
do i parametri che ci offre risultino violati dall’interpreazione
che stanno dandone, da condotte che irragionevoli, non per
nulla, siamo allora autorizzati a definire. In quel progetto che la
nostra ragione in ultima istanza, in e per se stessa, si rivela quando ai sottintesi ontologici di quel potere di orientamento e di
organizzazione in cui la vediamo manifestarsi si sappia risalire,
è possibile riconoscere un orizzonte da cui le nostre esperienze
scoprono di non poter uscire quando sulla propria possibilità
riflettano e della propria possibilità vogliano prendersi cura. Definire “trascendentale” l’esperienza che ci è concesso farne ha un
duplice significato: è un modo di sottolineare i vincoli che mette
in luce, gli obblighi a cui una tale riflessiva esperienza di ciò che
ragionare significa per noi costantemente ci rimanda, ma è anche
un modo per ricordare il suo ineludibile carattere trasversale.
Più esattamente: il fatto che la sola esperienza possibile di quel
progetto che la nostra stessa ragione è, resta quella che compiamo ragionandone e scegliendo di compiere le nostre esperienze
in una forma e, dunque, entro limiti che ragionevoli consentano
loro di risultare.
La prospettiva che ho tentato di delineare corrisponde a un modo di far filosofia
la cui complessità non potevo certo esaurire in questa sede. Per chi lo vorrà, ci sarà
presto occasione di riparlarne. Ci sarà offerta dal grande Congresso internazionale
che vedrà riunirsi a Pisa, tra il 22 e i 26 maggio del 2010, i rappresentanti di tutte le
Società di studi kantiani sparse per il mondo. Il tema scelto quale suo filo conduttore (la prospettiva cosmopolitica implicita nella filosofia kantiana) ha molto a che
vedere con il modo di far filosofia che ho cercato di evocare. di uno stato in qualche
modo sociale, e dunque non riconoscere che la tecnica è un effetto di società, altrettanto impossibile sarebbe immaginare una società che non fosse effetto di tecnica.