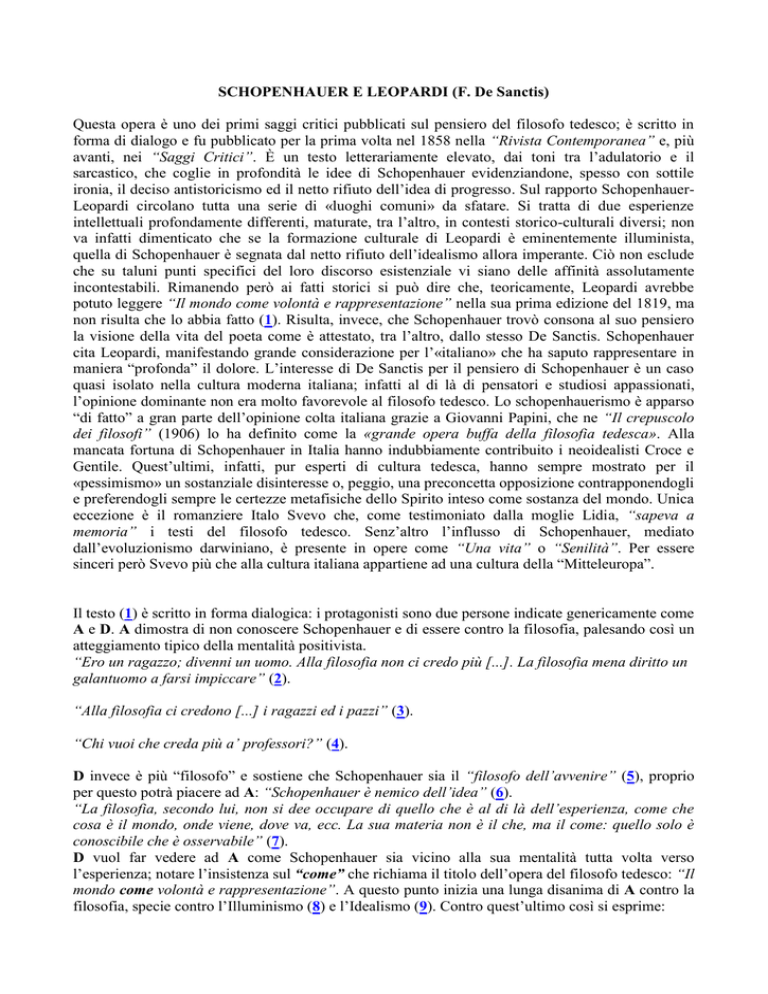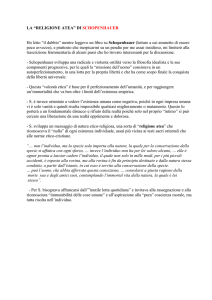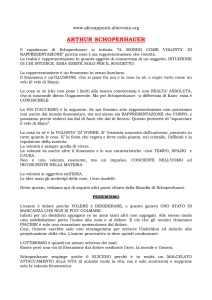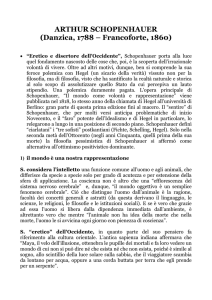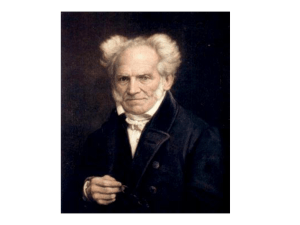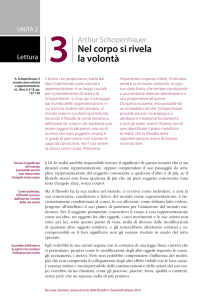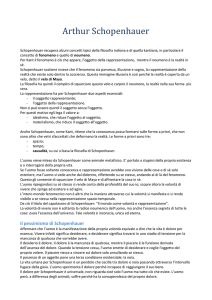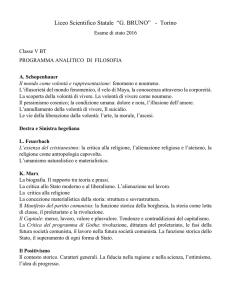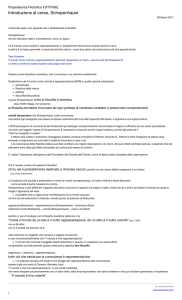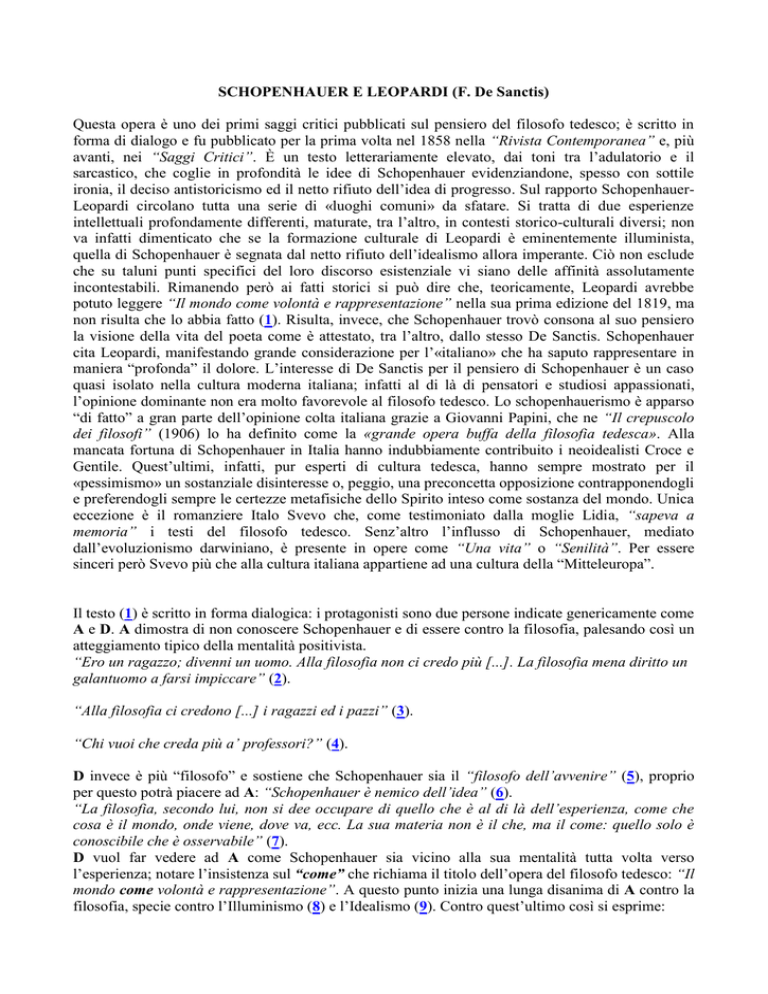
SCHOPENHAUER E LEOPARDI (F. De Sanctis)
Questa opera è uno dei primi saggi critici pubblicati sul pensiero del filosofo tedesco; è scritto in
forma di dialogo e fu pubblicato per la prima volta nel 1858 nella “Rivista Contemporanea” e, più
avanti, nei “Saggi Critici”. È un testo letterariamente elevato, dai toni tra l’adulatorio e il
sarcastico, che coglie in profondità le idee di Schopenhauer evidenziandone, spesso con sottile
ironia, il deciso antistoricismo ed il netto rifiuto dell’idea di progresso. Sul rapporto SchopenhauerLeopardi circolano tutta una serie di «luoghi comuni» da sfatare. Si tratta di due esperienze
intellettuali profondamente differenti, maturate, tra l’altro, in contesti storico-culturali diversi; non
va infatti dimenticato che se la formazione culturale di Leopardi è eminentemente illuminista,
quella di Schopenhauer è segnata dal netto rifiuto dell’idealismo allora imperante. Ciò non esclude
che su taluni punti specifici del loro discorso esistenziale vi siano delle affinità assolutamente
incontestabili. Rimanendo però ai fatti storici si può dire che, teoricamente, Leopardi avrebbe
potuto leggere “Il mondo come volontà e rappresentazione” nella sua prima edizione del 1819, ma
non risulta che lo abbia fatto (1). Risulta, invece, che Schopenhauer trovò consona al suo pensiero
la visione della vita del poeta come è attestato, tra l’altro, dallo stesso De Sanctis. Schopenhauer
cita Leopardi, manifestando grande considerazione per l’«italiano» che ha saputo rappresentare in
maniera “profonda” il dolore. L’interesse di De Sanctis per il pensiero di Schopenhauer è un caso
quasi isolato nella cultura moderna italiana; infatti al di là di pensatori e studiosi appassionati,
l’opinione dominante non era molto favorevole al filosofo tedesco. Lo schopenhauerismo è apparso
“di fatto” a gran parte dell’opinione colta italiana grazie a Giovanni Papini, che ne “Il crepuscolo
dei filosofi” (1906) lo ha definito come la «grande opera buffa della filosofia tedesca». Alla
mancata fortuna di Schopenhauer in Italia hanno indubbiamente contribuito i neoidealisti Croce e
Gentile. Quest’ultimi, infatti, pur esperti di cultura tedesca, hanno sempre mostrato per il
«pessimismo» un sostanziale disinteresse o, peggio, una preconcetta opposizione contrapponendogli
e preferendogli sempre le certezze metafisiche dello Spirito inteso come sostanza del mondo. Unica
eccezione è il romanziere Italo Svevo che, come testimoniato dalla moglie Lidia, “sapeva a
memoria” i testi del filosofo tedesco. Senz’altro l’influsso di Schopenhauer, mediato
dall’evoluzionismo darwiniano, è presente in opere come “Una vita” o “Senilità”. Per essere
sinceri però Svevo più che alla cultura italiana appartiene ad una cultura della “Mitteleuropa”.
Il testo (1) è scritto in forma dialogica: i protagonisti sono due persone indicate genericamente come
A e D. A dimostra di non conoscere Schopenhauer e di essere contro la filosofia, palesando così un
atteggiamento tipico della mentalità positivista.
“Ero un ragazzo; divenni un uomo. Alla filosofia non ci credo più [...]. La filosofia mena diritto un
galantuomo a farsi impiccare” (2).
“Alla filosofia ci credono [...] i ragazzi ed i pazzi” (3).
“Chi vuoi che creda più a’ professori?” (4).
D invece è più “filosofo” e sostiene che Schopenhauer sia il “filosofo dell’avvenire” (5), proprio
per questo potrà piacere ad A: “Schopenhauer è nemico dell’idea” (6).
“La filosofia, secondo lui, non si dee occupare di quello che è al di là dell’esperienza, come che
cosa è il mondo, onde viene, dove va, ecc. La sua materia non è il che, ma il come: quello solo è
conoscibile che è osservabile” (7).
D vuol far vedere ad A come Schopenhauer sia vicino alla sua mentalità tutta volta verso
l’esperienza; notare l’insistenza sul “come” che richiama il titolo dell’opera del filosofo tedesco: “Il
mondo come volontà e rappresentazione”. A questo punto inizia una lunga disanima di A contro la
filosofia, specie contro l’Illuminismo (8) e l’Idealismo (9). Contro quest’ultimo così si esprime:
“Accidenti a questi filosofi! I posteri [...] dovranno fare le grandi risa, quando penseranno che per
una buona metà di secolo si è creduto all’identità del pensiero e dell’essere” (10).
“I sistemi filosofici mi sembrano de’ castelli di ciottoli, fatti, disfatti, rifatti in mille guisa da’
fanciulli”
(11).
“È stato un tempo di una illusione, o piuttosto di una imbecillità generale” (12).
Mi sembra opportuno notare almeno due aspetti:
1. A non sembra capire per nulla, ottenebrato dal suo “positivismo”, che la grandezza
dell’idealismo consiste appunto nel recupero dell’identità pensiero-essere, anche se non più
nella primitiva ottica parmenidea;
2. quasi le stesse espressioni sono usate da Kierkegaard, precedentemente, per criticare il
sistema hegeliano (13).
D sostiene che appunto qui sta la grandezza di Schopenhauer che non ha ceduto al fascino di Fichte,
Schelling ed Hegel, anzi li ha combattuti in quanto:
“ciarlatani e sofisti [...] ‘non filosofi, perché volevano parere, non essere’” (14).
D mostra quindi ad A cosa fosse successo nella filosofia prima di Schopenhauer: Kant aveva parlato
di fenomeno, ma, sotto di esso, aveva trovato il noumeno e lì stava la sua colpa (15); Fichte - un
“ciarlatano” - sostiene che il noumeno non esiste perché tutto è prodotto dall’“Io” (16); Schelling,
alla gente che invocava la realtà - “Dateci il reale” (17) - , risponde che il reale non c’è perché è
l’ideale, essere e pensiero sono una cosa sola; Hegel fece del pensiero l’Assoluto e lo rese “un
essere vero e vivo” che “cammina attraverso i secoli” tramite il processo dialettico: Hegel “fece
dell’universo una logica animata” (18).
“Fichte fu la caricatura di Kant; Hegel fu il buffone di Schelling” (19).
Secondo D l’idealismo ha commesso tre peccati, puntualmente riconosciuti da Schopenhauer:
Fichte si dice discepolo di Kant, ma non lo è realmente (lo è sicuramente di più
Schopenhauer);
Schelling confonde reale con ideale ed infine li media nell’identità assoluta;
Hegel è un “mostro” che tramite la dialettica ha dato un’apparenza di armonia al mondo
(20).
Dopo una breve disquisizione sul rapporto nuovo venutosi a creare tra la filosofia e le donne (21), D
comincia ad esporre la filosofia di Schopenhauer.
“Questa filosofia è cosa solida, tutta carne ed ossa” (22).
Si inizia con il concetto di rappresentazione dove viene parafrasata l’introduzione a “Il mondo come
volontà e rappresentazione” del filosofo di Danzica:
“Togliete il soggetto, colui che vede, e il mondo non esisterebbe più” (23).
Ma la rappresentazione è solo un aspetto del mondo: “dietro le scene c’è il vero reale, la cosa in
sé” (24); tale realtà “nascosta” è il “Wille”, la volontà.
“Io sono il «Wille». Mi muovo, parlo, opero, perché voglio. [...] Il volere è la conoscenza a priori
del corpo, e il corpo è la conoscenza a posteriori del volere” (25).
D fa vedere ad A come il «Wille» sia la vera realtà; il mondo stesso, la materia altro non sono che
‘manifestazioni’ di tale volontà.
“Kant aveva detto: «Niente si sa». A questo i tre impostori risposero: «Tutto si sa». Schopenhauer
ha piantato le tende tra quell’ignoranza assoluta e quell’assoluto sapere, e ha conchiuso: «Una
sola cosa si sa e si può sapere, il ‘Wille’»” (26).
La volontà, il «Wille», non è conoscibile in quanto è assoluta ed ogni nostra conoscenza, invece, è
relativa; il «Wille» è ciò che spiega il mondo.
“Il «Wille» si trova al di sotto di tutti i fenomeni, ed è la cosa in sé per noi: così è spiegato il
mondo” (27).
Tale volontà altro non è che cieco impulso alla vita, uno “stimolo cieco, inconscio, che sforza ad
operare” (28). Dal momento che opera alla cieca e quindi nessuna necessità ha potere su di essa, la
volontà è assolutamente libera, al contrario dell’idea, “può starsene con le mani in saccoccia” (29).
Questo «Wille», prosegue D, genera le idee che sono ‘esemplari’ (30) del mondo.
“Uno è il «Wille», immanente alle cose, anzi le cose non sono che esso medesimo il «Wille» messo
in movimento” (31).
A questo punto A accusa Schopenhauer di essere un panteista; D risponde che poco importa,
sarebbe comunque meglio chiamarlo monista. D prosegue nell’analisi del pensiero di
Schopenhauer: la volontà tutto può perché è libera.
“Il «Wille» è libero finché non vuole niente [...], ma, come libero, può anche volere non volere”
(32).
A obietta che volere è desiderare e si desidera ciò di cui si è manchevoli; il «Wille» non può quindi
essere un “primum”, ma presuppone un’idea, un essere. D risponde di stare attento a non
confondere il «Wille» fenomenico con il «Wille» in sé stesso.
“Il «Wille» è cieco [...] perché [...] opera senza coscienza” (33).
Per questo motivo per il «Wille» “la vita è opera demoniaca” (34), la vita è un peccato. Per
Schopenhauer vivere è male, morire è bene, perché il «Wille»:
“Vivendo, cessa di essere libero, s’imprigiona nello spazio e nel tempo, entra nella catena delle
cause e degli effetti, diviene un individuo, si condanna al dolore ed alla miseria” (35).
Per liberarsi di ciò il «Wille» dovrebbe voler morire:
“La morte è la fine del male e del dolore, è il «Wille» che ritorna a sé stesso, eternamente libero e
felice” (36).
D, per puntualizzare ulteriormente il concetto, cita anche dei versi di Leopardi:
“Se
la
vita
è
sventura,
Perché da noi si dura?” (37)
A rileva che si è lasciata la filosofia e si è “caduti” nella poesia; finalmente è giunto il momento in
cui D può mettere a confronto Schopenhauer e Leopardi. La domanda sottesa alla poetica
leopardiana - perché il mondo? “Arcano
è
tutto
Fuor che il nostro dolor” (38)
trova risposta nella dottrina del «Wille» di Schopenhauer. Per D Leopardi è un “materialista”
perché “l’infinità vanità del tutto” (39) è dovuta ad una “materia eterna dotata di una o più forze
misteriose” (40); Schopenhauer, invece, è uno “spiritualista” perché per lui il ‘potere’ consiste in
una forza unica, il «Wille», e la materia, il ‘velo di Maya’, non è altro che apparenza, una
manifestazione della volontà.
“Tutti e due dunque ammettono lo stesso principio, ma l’uno lo profonda nella materia, e l’altro gli
fa della materia un semplice velo” (41).
Quello che accomuna i due autori, secondo D, è il fatto che, pur partendo da premesse differenti,
giungono alle medesime conseguenze.
“Leopardi e Schopenhauer si accordano nelle conseguenze, ponendo a principio lo stesso Potere
cieco e maligno; e poco rileva che nell’uno sia una forza della materia, e nell’altro una forza che si
manifesta sotto aspetto di materia: ne nasce lo stesso «ergo»” (42).
D fa anche vedere bene come la distinzione materia-anima sia un pregiudizio filosofico introdotto
da Cartesio (43) e giunto sino a Kant, superato solo nel pensiero di Schopenhauer (44).
“Il «Wille» è il «Wille», ed il mondo è il suo fenomeno. [...] Tutto è vanità; il «Wille», lo spirito
solo, è. [...] Lo spirito non è la ragione, ma il cieco appetito, origine del peccato; è lo spirito del
male. [...] Il «Wille» non solo è peccatore, ma è il solo peccatore” (45).
Stabilito ciò ne consegue un’antropologia che fa dell’uomo non un individuo libero, ma una sorta di
“schiavo” del «Wille».
“Tu sei un fenomeno del «Wille», e quello che hai fatto gli è che il tuo «Wille» lo ha voluto” (46).
Dopo un’illustrazione così particolareggiata dei fondamenti del pensiero schopenhaueriano, specie
del concetto di «volontà», D comincia a trarne tutta una serie di conseguenze su alcuni concetti
cardine riguardanti il pensiero e la vita.
1 - LIBERTÀ
È chiaro che l’uomo non potrà essere libero dato che è il «Wille» che condiziona tutto, che «vuole»
tutto.
“Uomo libero è «contradictio in adiecto»; perché uomo è un essere condizionato e determinato”
(47).
2 - DOVERE
Cade del tutto la morale kantiana del «Tu devi» e quindi anche il suo ‘formalismo’. Dovere suppone
libertà (48), ma libero l’uomo non è, il «Wille» lo determina.
“Dimmi pure: «Non devi ammazzare»; io ammazzerò, se il mio carattere porta così, e non farò
peccato” (49).
3 - DOLORE
Il dolore non è “personale”, perché è voluto dal «Wille» ed è il «Wille» che lo sente. Il dolore:
“...lo sente il «Wille»; perché quello che ci è in te di vero reale è il «Wille»; tutto l’altro è
fenomeno” (50).
In sede di commento mi pare giusto sottolineare come questa sia una posizione tipica del filosofo
tedesco: la Volontà di vivere spinge ad agire, ad affermarsi, ma la tensione continua porta al dolore,
in quanto tende solo chi non ha e la privazione è proprio ciò in cui consiste il dolore. E poiché
nell’uomo la Volontà è più cosciente, e quindi più affamata, egli risulta essere il più bisognoso e
mancante degli esseri, destinato a non trovare mai un appagamento: «Chi più sa, più soffre!». La
vita è quindi dolore per essenza. Anche nell’innamoramento si avrebbe soltanto l’illusione del
soddisfacimento, della felicità. L’individuo diventerebbe zimbello della Volontà che, per vivere,
spinge alla generazione. Mi sembra che nel discorso di Schopenhauer a questo punto si annidi
almeno un’aporia: se la Volontà è cieca, come fa a sapere tutto questo? Siamo forse in presenza di
una sorta di “astuzia della ragione” inconsciamente ereditata dall’“odiatissimo” Hegel?
4 - MORALE
Dato che il «Wille» è presente in tutti noi e in tutte le cose e, per di più, è sempre il medesimo, ne
consegue che siamo tutti fratelli:
“...attirati l’uno verso l’altro da reciproca simpatia” (51).
5 - COMPASSIONE
Dobbiamo compatirci l’un l’altro perché il «Wille» così ci ha voluti; compatire nel senso
etimologico di “cum patire”, soffrire con, cioè mettersi nei panni degli altri che pure soffrono, dato
che tutti possediamo un’unica essenza (52).
“La qual simpatia diventerà una profonda compassione quando penseremo che tutti per colpa del
«Wille» siamo infelici, tutti condannati irremissibilmente al dolore” (53).
Si può ritornare, a questo punto, a Leopardi per osservare che anche per quest’ultimo il principio
etico è la compassione (54).
6 - PIACERE
Il piacere è pura apparenza, perché di reale vi è solo il dolore; quindi il suo raggiungimento non è
un fatto positivo, ma solo una pausa del dolore, tesi quest’ultima tipicamente leopardiana (55), ma
anche di Pietro Verri (56).
“Il piacere è negativo, incapace di soddisfare il «Wille» infinito; [...] sotto i più desiderati piaceri
vedrai scaturire la noia e il dolore” (57).
7 - STATO
Gli uomini sono per natura portati alla violenza, “homo homini lupus” (come sostenevano già sia
Plauto, sia Hobbes), la funzione dello Stato è quindi quella di reprimere questo “istinto” per
garantire la proprietà e la vita.
“Siccome gli uomini sono inchinevoli al male ed alla violenza, e si fanno regolare nelle loro azioni
non dalla ragione ma dal «Wille», cioè dagli istinti e dalle passioni, lo Stato non dee a reggerli
adoperare la persuasione, ma la violenza” (58).
Per questo motivo è giustificato l’uso della violenza come deterrente contro l’indole cattiva
dell’uomo: è meglio che la forza sia nelle mani di uno solo (59); la monarchia è quindi la forma di
Stato più conforme al «Wille» (60), una monarchia assoluta e non una costituzionale come quella
Inglese considerata “ridicola” (61).
8 - STORIA
Viene giustificato l’antistoricismo di Schopenhauer.
“Il «Wille» esiste solo negli individui; patria, popolo, umanità, nazionalità sono astrazioni, concetti
vuoti. [...] Il «Wille» solo è cosa in sé. Il molteplice è apparenza, i popoli e la loro vita sono
astrazioni [...] solo l’individuo, non l’umanità, ha reale unità, la storia dell’umanità è una finzione.
[...] La storia non è una scienza” (62).
De Sanctis illustra qui bene una tesi fondamentale di Schopenhauer secondo la quale la storia altro
non è se non il ripetersi fatale di uno stesso dramma (63). Di conseguenza, se spogliamo la storia
della sua pretesa di rivelarci il “diverso” e il “progressivo” (64), se prendiamo coscienza del fatto
che essa esiste solo perché l’umanità si trova nel dolore e spera di metterlo a tacere, mutando
condizione o inseguendo un illusorio progresso, possiamo concludere che il compito vero della
storia sia quello di offrire all’uomo la coscienza di sé e del proprio destino (65).
9 - NOIA
Ricollegandoci a quanto detto prima e cioè che “il piacere è una negazione, ed il solo dolore è”
(66), si giunge a tale conclusione:
“Se sei guarito dal dolore, ti rimane non il piacere, che è una negazione, ma un nemico ancor più
molesto, la noia” (67).
Su questa tesi le convergenze con il pensiero leopardiano sembrano essere molte; facciamo un
confronto, ad esempio, con la poesia “A se stesso”:
“Amaro
e
noia
la vita, altro mai nulla”(68).
Quindi per Schopenhauer tra il dolore, che è una realtà durevole, e il piacere, momentaneo, c’è una
terza situazione esistenziale di base, la noia, che subentra quando viene meno il desiderio;
concludendo, la vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente fra il dolore e la noia,
passando attraverso l’intervallo fugace, e per di più illusorio, del piacere e della gioia (69).
10 - SUICIDIO
L’interlocutore di D, A, a questo punto si domanda che senso abbia vivere in un mondo così come
quello descritto da Schopenhauer.
“Perché viviamo dunque? Uccidiamoci. Bella, adorabile, pietosa morte” (70).
Ed a sostegno delle sue tesi cita Leopardi:
“Chiudi
alla
luce
omai
Questi occhi tristi, o dell’età reina” (71).
La risposta di D, e quindi di Schopenhauer, è, arrivati a questo punto, abbastanza scontata:
“Bisogna morire, ma senza cessare di vivere” (72).
Bisogna quindi uccidere in se stessi la stessa volontà di vivere e di godere:
“Vivi, ma rinunziando a’ godimenti della vita, come cosa vana; il che è dato di fare solo all’uomo
fornito di ragione. [...] Tu solo ti puoi mettere al di sopra della vita” (73).
Infatti il suicidio non sopprime la Volontà, ma solo l’individuo, ossia una, e solo una,
manifestazione fenomenica della Volontà di vivere, quindi va rifiutato. Per di più il suicidio non
nega la Volontà, ma la afferma perché il suicida vuole la vita, ma non questa vita che gli è toccata;
quindi il suicidio non è la sconfitta del «Wille», anzi ne rappresenta la vittoria.
11 - ASCESI
Conseguentemente, la vera risposta al dolore del mondo non consiste nell’eliminazione di una vita,
ma nella “liberazione” dalla stessa volontà di vivere: dalla “voluntas” bisogna passare alla
“noluntas”.
“Castità, povertà, ubbidienza. Così vivere è morire, senza che debba aver ricorso al suicidio,
rifugio degli animi deboli”(74).
A questo punto il dialogo tra A e D giunge alla sua conclusione e, paradossalmente, A, che
all’inizio affermava di essere un positivista “credente” solo delle esperienze, dice di preferire
Leopardi, il “poeta”, a Schopenhauer(75); D rimane invece fedele al “suo” filosofo.
“Schopenhauer è un ingegno fuori del comune. [...] Leopardi ragiona col senso comune [...] non
pensa a fare effetto, è troppo modesto, troppo sobrio” (76).
La risposta di A è la seguente:
“Leopardi morì giovane, martire delle sue idee; Schopenhauer continua ancora a morire senza
cessare di vivere” (77).
In tutto ciò mi pare di notare una vena ironica in De Sanctis che, terminando il suo discorso, mette
in bocca al “filosofo” D le conclusioni sui rapporti intercorrenti tra Leopardi e Schopenhauer
evidenziando i difetti del “poeta”-Leopardi. Ed è ironico, almeno così a me pare, come i “difetti”
notati dal “filosofo” D costituiscano invece proprio i grandi “pregi” del “poeta” italiano, quasi a
voler significare che la ragione, pur potendo accedere alle “vette” del pensiero, non possa
raggiungere la “profondità” dei sentimenti di una vita vissuta.
“Leopardi produce l’effetto contrario a quello che si propone. Non crede al progresso, e te lo fa
desiderare; non crede alla libertà, e te la fa amare. Chiama illusioni l’amore, la gloria, la virtù, e
te ne accende in petto un desiderio inesausto. E non puoi lasciarlo, che non ti senta migliore; e non
puoi accostartegli, che non cerchi innanzi di raccoglirti e purificarti, perché non abbi ad arrossire
al suo cospetto. È scettico e ti fa credente” (78).
“Leopardi [...] mentre chiama larva ed errore tutta la vita, non sai come, ti senti stringere più
saldamente a tutto ciò che nella vita è nobile e grande” (79).
“La profonda tristezza con la quale Leopardi spiega la vita, non ti ci fa acquietare, e desideri e
cerchi il conforto di un’altra spiegazione” (80).
L’ultima parola sembra averla però A che in tono non solo ironico, ma sarcastico così conclude:
“Se leggi Leopardi, t’hai da ammazzare; se leggi Schopenhauer, t’hai da far monaco; se leggi tutti
questi altri filosofi moderni, t’hai da far impiccare per amor dell’idea. [...] Lascio le matematiche e
studio le donne” (81).
CONCLUSIONI
Secondo un punto di vista largamente diffuso tra i critici, la teoria “orientalistica” dell’ascesi
costituisce la parte più debole e contraddittoria del sistema schopenhaueriano (1). Infatti, se la
volontà si identifica con la struttura metafisica del reale come si può ipotizzare un suo annullamento
da parte dell’asceta? E come si può coerentemente ritenere che la volontà, la cui essenza è appunto
il volere, ad un certo momento non voglia più se stessa? Per di più, la fuga ascetica dalla vita, che è
sempre un’avventura ideale che finisce con il coincidere con la chiusura dell’io in se medesimo,
come si concilia con l’ideale etico della pietà verso il prossimo che soffre? Inoltre è proprio vero
che l’unico sbocco logico del pessimismo sia il quietismo dell’asceta? Leopardi, ne “La Ginestra, o
il Fiore del deserto”, non testimonia un’altra possibile, e “occidentalmente” più impegnata, via
d’uscita dal pessimismo? Infine, il fatto che Schopenhauer non si sia sentito personalmente deciso
ad intraprendere la via dell’ascesi, non priva la sua filosofia della testimonianza viva del suo autore,
dando l’impressione della «non-sincerità» del suo pessimismo? Su quest’ultimo punto già il filosofo
danese Kierkegaard aveva avanzato molte critiche.
“Io tengo Schopenhauer per uno scrittore molto importante [...]. Nella sua malinconia indiana che
vivere
e
soffrire,
c’è
però
qualcosa
di
falso”
(2).
“Egli non è un pessimista sul serio, né completamente scevro dall’essere anch’egli un sofista; [...]
questo suo proposito di scegliere il pessimismo, diventa facilmente una forma di ottimismo; [...]
non senza una grande compiacenza egli dice di essere il primo che ha assegnato all’ascetica un
posto nel sistema” (3).
In conclusione, la filosofia di Schopenhauer sembra essere una sorta di “mistica” senza estasi in
Dio.
“Noi dinanzi alla morte rabbrividiamo soprattutto, forse perché scorgiamo in essa quelle tenebre,
dalle quali un giorno ci distaccammo ed alle quali ritorneremo. Ma io credo che, quando la morte
avrà chiuso i nostri occhi, noi ci troveremo in una luce, al cui confronto la nostra luce solare non è
che ombra”(4).
Tuttavia queste critiche non debbono far perdere di vista né la sua denuncia della “realtà” del
dolore, né la profondità di molte sue analisi, coincidenti, almeno a livello di «fenomenologia della
condizione umana», con le voci più alte della sapienza di tutti i tempi. Del resto, la «ricchezza» di
motivi del suo pensiero, al di là della cornice sistematica, è confermata dall’ampia serie di influssi
esercitati sulla cultura successiva.