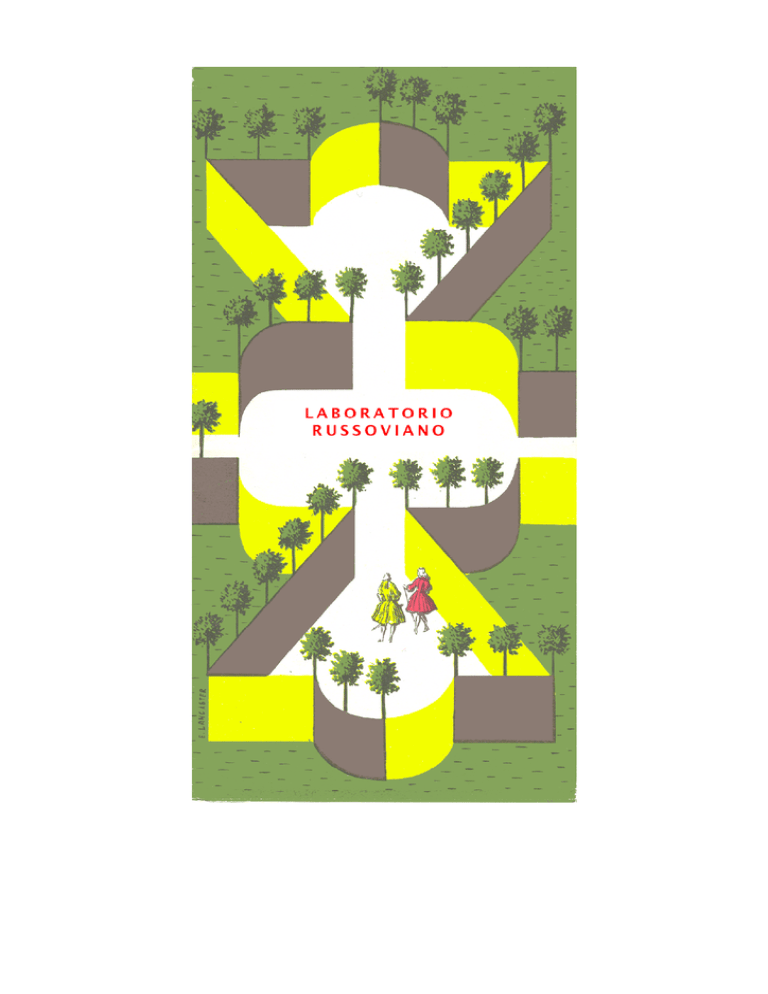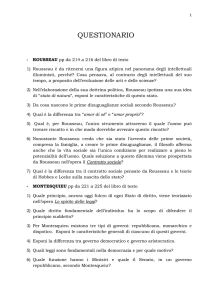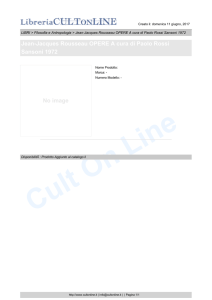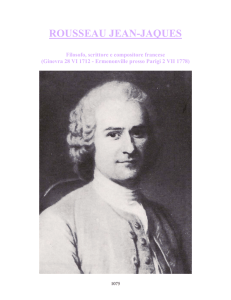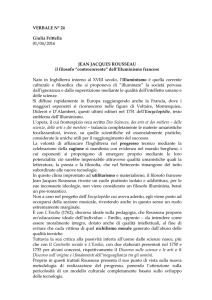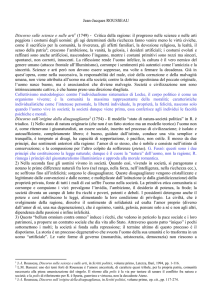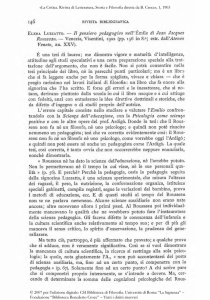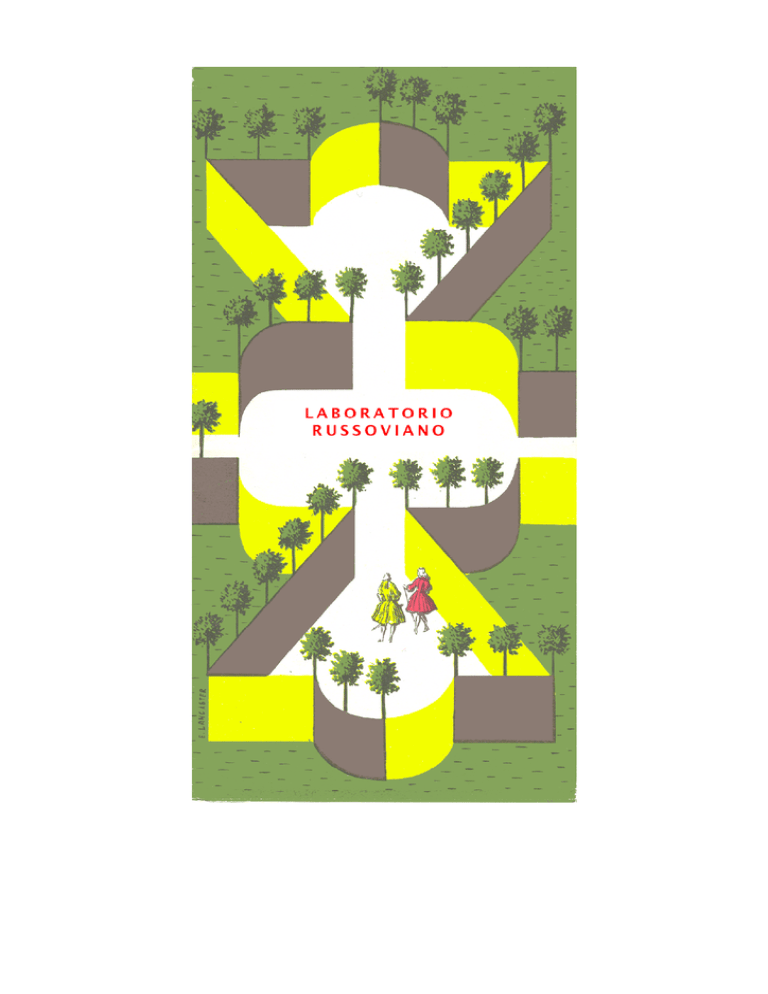
Jean-Jacques Rousseau
8 Massime
1. Il bisogno elevò i troni; le scienze e le arti li hanno rafforzati. ..................................................... 3
2. I vizi non appartengono tanto all’uomo, quanto all’uomo mal governato ..................................... 4
3. Se il cattivo uso della sua nuova condizione non lo degradasse, l’uomo dovrebbe senza posa
benedire l’istante felice che fece dell’animale stupido e limitato che era un essere intelligente .... 5
4. Solo alla legge gli uomini debbono la giustizia e la libertà........................................................... 6
5. Solo la volontà generale può dirigere le forze verso il bene comune ............................................ 7
6. Togliere la libertà alla volontà dell’uomo significa togliere ogni moralità alle sue azioni............. 8
7. I singoli vedono il bene che non vogliono, la collettività vuole il bene che non vede ................... 9
8. La volontà generale non si rappresenta: o è essa stessa, o è un’altra; una via di mezzo non esiste
................................................................................................................................................. 10
1. Il bisogno elevò i troni; le scienze e le arti li hanno rafforzati.
Lo spirito ha i suoi bisogni, come il corpo. I bisogni del corpo sono il fondamento della società, quelli dello
spirito il suo ornamento. Mentre il governo e le leggi provvedono alla sicurezza e al benessere degli uomini associati, le
scienze, le lettere, le arti, meno dispotiche e forse più potenti, stendono ghirlande di fiori sulle ferree catene che li
gravano, soffocano in loro il sentimento di quella libertà originaria per cui sembravano nati [...]. Il bisogno elevò i troni;
le scienze e le arti li hanno rafforzati.
(Discorso sulle scienze e le arti, 1750)
È la tesi clamorosa del primo scritto di Rousseau, il Discorso sulle scienze e le arti, col
quale il filosofo, allora trentottenne, risponde ad un quesito proposto dall’Accademia di Digione:
«Se la rinascita delle scienze e delle arti abbia contribuito a migliorare i costumi». Rousseau non si
limita a dare una risposta negativa, ma formula una sorta di filosofia della decadenza fondata su
un’antitesi radicale, elementare e catastrofica: «Le nostre anime si sono corrotte via via che le
scienze e le arti progredivano verso la perfezione. Diremo che si tratta di una sventura propria del
nostro tempo? No, signori: i mali causati dalla vana curiosità umana sono vecchi come il mondo».
Questa tesi paradossale – soprattutto agli occhi degli illuministi – che molti contemporanei
attribuirono a stravaganza o eccentricità, va individuata nel conflitto multiforme, sordamente
coltivato per anni, tra il Jean-Jacques «figlio della natura» e il mondo ostile, contrapposti l’uno
all’altro. Negli anni 1744-49, il «mondo» nel quale Jean-Jacques si trova a vivere, spaesato,
maldestro, a disagio, è la società parigina. Tenuto ai margini dei salotti letterari per la sua stessa
goffaggine di provinciale, insoddisfatto dei modesti successi ottenuti come musicista, umiliato al
rango subalterno di precettore e di cassiere in casa Dupin, orecchiante la polemica illuminista di
Voltaire e Montesquieu, legato di stretta amicizia a Diderot e Condillac, si sente escluso dal
brillante mondo delle «scienze e arti». In realtà l’argomentazione deduttiva sulla quale si basa il
Discorso è tanto elementare quanto diretta: alla cultura di élite si deve la «diseguaglianza funesta
[...] fonte di tanti abusi», e dunque se le scienze e delle arti sono originate dai «vizi» della società, la
loro influenza morale e sociale non potrà non essere in ogni caso corruttrice.
Naturalmente attribuire alla cultura intellettuale e al gusto tutti i guasti della civiltà era
combattere contro un falso obiettivo, e Rousseau si rese subito conto di attaccare nelle «scienze» e
nelle «arti» soltanto l’ideologia della classe dominante. Prova ne sia che non appena raggiunto dalle
polemiche di chi volle reagire alle sue tesi, rimeditò sulle «cause» identificate. Non ritrattò
l’imputazione rivolta alle scienze e alle arti, ma replicò disegnando una sorta di «genealogia del
vizio»: «La fonte prima del male è la diseguaglianza; dalla diseguaglianza sono venute le ricchezze
[...]. Dalle ricchezze sono nati il lusso e l’ozio; dal lusso sono venute le belle arti e dall’ozio le
scienze». Così i termini iniziali del Discorso sulle scienze e le arti si capovolgevano. La critica
dell’ideologia si sviluppava in un discorso politico e giuridico, che finiva per individuare altrove le
radici profonde della reciproca ostilità degli uomini, cioè del male sociale. Scienze e arti apparivano
ormai sovrastrutture o elementi concomitanti innocui di «vizi» ben altrimenti radicati nella natura
umana.
Quando nel 1753, dopo esser stato attaccato da ogni parte, Rousseau pubblicò la commedia
Narcisse, scritta vari anni innanzi e rappresentata con scarso successo a Parigi quell’anno stesso, vi
premise una prefazione, nella quale – più che le «scienze» e le «arti» in astratto – i singoli vizi, le
meschinità, gl’inganni, l’odio reciproco tra esseri umani, vigenti nella società organizzata, sono
ricondotti alla matrice dell’«interesse personale». Porre alla base della convivenza umana «le
scienze, le arti, il lusso, il commercio, le leggi» significa accettare e legittimare questo stato di
universale estraniazione, elevare a principi il mutuo sfruttamento, la concorrenza sfrenata e la
diseguaglianza. La virtù è resa impraticabile dal conflitto degli interessi e dalla «miseria» che ne
consegue. Così l’invettiva contro il lusso e l’ozio, ancora assai estrinseca nel primo Discorso, si è
ormai trasformata in analisi politico-economica.
2. I vizi non appartengono tanto allʼuomo, quanto allʼuomo mal
governato
Strana e funesta costituzione, dove le ricchezze già accumulate agevolano sempre l’accumulazione di ricchezze
maggiori, e dove riesce impossibile a chi non ha niente acquisire qualcosa: dove l’uomo onesto non ha modo di uscire
dalla miseria, dove i più fraudolenti sono i più onorati, e dove bisogna necessariamente rinunziare alla virtù per
diventare un buon borghese! So che i declamatori hanno detto questo infinite volte: ma loro lo dicevano declamando, e
io lo dico motivandolo; essi hanno intravisto il male, e io ne svelo le cause, e dimostro soprattutto una cosa assai
consolante e utile, mostrando che tutti questi vizi non appartengono tanto all’uomo, quanto all’uomo mal governato.
(Prefazione del Narcisse, 1753)
Secondo la concezione giusnaturalista, poi ripresa anche dagli enciclopedisti (Diderot in
particolare), malfattori e ribelli erano quei membri della comunità che rifiutavano la «volontà
generale di tutti». Le loro cattive azioni erano però determinate solo da insipienza ed ignoranza, e
pertanto – al di là dei mezzi di repressione da impiegare fino al loro ravvedimento – andavano «resi
edotti» dei principi supremi che regolavano la volontà generale. Sarebbe insomma bastato mostrare
come la ragione universale si identificava con la razionalità di tutti per far loro comprendere i
principi assoluti del giusto e dell’ingiusto.
La posizione di Rousseau in proposito è invece più radicale, riannoda tutte le fila della sua
riflessione attorno allo stato di natura, alla degenerazione sociale, al patto iniquo che le società
moderne hanno imposto ai propri membri, e così facendo trasforma il concetto di «volontà
generale» nella chiave di volta della sua critica anti-giusnaturalista. L’obiezione di maggior rilievo
verte sul concetto tradizionale di sociabilitas (sociabilité): com’è possibile concepire la volontà
della società come suprema depositaria dei principi del diritto e della giustizia quando la realtà
storica non ci presenta se non modelli di società antagoniste, competitive, violente? E poiché il
preteso «progresso» non è che corruzione e decadenza, e la ragione è un prodotto tardivo dello
stesso sviluppo sociale, «il preteso patto sociale dettato dalla natura è una vera e propria chimera,
poiché le sue condizioni sono sempre ignote e impraticabili [...]».
In altri termini, Rousseau respinge il patto ingiusto che i giusnaturalisti ritengono stipulato
in base alla legge naturale, né accetta la finzione di un’astratta volontà generale alla quale si
debbano rinviare malfattori: una simile volontà generale («un atto puro dell’intelletto che ragiona
nel silenzio delle passioni») è accettabile, soggettivamente, per l’individuo già «ragionevole», ma
non ha alcun valore cogente. Nelle società antagonistiche una «volontà generale» così definita è
viene regolarmente soverchiata dagli istinti egoistici e dalle passioni aggressive; non può imporsi al
«volgo», perché è una proiezione astratta della ragione stessa. Ed ecco il passo decisivo: prendiamo
atto di questo, ma «sforziamoci di trarre dallo stesso male il rimedio che deve guarirlo» facendo
leva sull’interesse dei singoli. «Mediante nuove associazioni correggiamo, se è possibile, la
mancanza di un’associazione generale», che detto in termini moderni significa: dotiamoci di
organizzazioni che sappiano rappresentare chiaramente i vantaggi per tutti in seno ad una non più
astratta «volontà generale».
La scelta morale consapevole dei singoli risolve dunque il conflitto tra scelte individuali e
volontà unitaria, ma questo non è un atto moralistico. Il malfattore – e la figura simboleggia ormai
l’intera umanità «civilizzata» – si convertirà e diventerà «il più fermo sostegno d’una società ben
ordinata», purché gli si sappia dimostrare che ha interesse a farlo. Fuor di metafora, la ragione «che
parla nel silenzio delle passioni», è di per sé impotente a modificare la decadenza umana, la spinta
egoistica dev’essere conservata nella costruzione della società giusta (non «soppressa» come aveva
detto Diderot), come lo strumento più efficiente di autocostrizione e di coesione sociale; nello
stesso tempo, la «socializzazione» del malfattore è una gara di liberazione per tutti.
3. Se il cattivo uso della sua nuova condizione non lo degradasse,
lʼuomo dovrebbe senza posa benedire lʼistante felice che fece
dellʼanimale stupido e limitato che era un essere intelligente
Il passaggio dallo stato di natura allo stato sociale, produce nell’uomo un mutamento molto notevole
sostituendo nella sua condotta la giustizia all’istinto, e conferendo alle sue azioni rapporti morali di cui prima
mancavano. Solo a questo punto, succedendo la voce del dovere all’impulso fisico e il diritto all’appetito, l’uomo, che
fin qui aveva guardato a se stesso e basta, si vede costretto ad agire in base ad altri principi e a consultare la ragione
prima di ascoltare le inclinazioni. Ma pur privandosi in questo nuovo stato di molti vantaggi che la natura gli accorda,
ne ottiene in compenso di tanto grandi, le sue facoltà si esercitano e si sviluppano, le sue idee si ampliano, i suoi
sentimenti si nobilitano, la sua anima intera si eleva a tal segno, che, se il cattivo uso della nuova condizione spesso non
lo degradasse facendolo scendere al disotto persino di quella da cui proviene, dovrebbe senza posa benedire l’istante
felice che lo strappò per sempre di là, facendo dell’animale stupido e limitato che era un essere intelligente ed un uomo.
(Contratto sociale, 1762)
Nel 1753 l’Accademia di Digione pubblica un quesito che sollecita ad indagare «l’origine
della diseguaglianza tra gli uomini, e se essa è autorizzata dalla legge naturale». L’enunciato era
audace e poneva in questione due assiomi correnti tra i teorici della scuola giusnaturalistica:
ammettere l’eguaglianza originaria di tutti gli uomini in quanto immediata espressione della legge
di natura, ma poi giustificare l’ineguaglianza presente come effetto della medesima legge.
Rousseau rivolge a questi autori un’obiezione comune riguardo l’utilizzo, nei confronti del
passato, di analisi morali e di modelli sociali che rispecchiano l’umanità contemporanea. Lo stesso
concetto di «stato di natura» costituisce un’astrazione alla quale «tutti i filosofi hanno sentito il
bisogno di risalire», ma al quale «nessuno è arrivato»; anche in questo caso si tratta di un concetto
costruito sulla misura moderna per giustificare uno stato di cose esistente. In questo modo Rousseau
rovescia il metodo dei giusnaturalisti: anziché giustificare la società presente in base alla fictio di
uno stato di natura, duplicato più o meno identico di questa società, pone sotto accusa la società
presente a partire da un’ipotesi circa l’autentica umanità primordiale – lo stato di natura quale
realmente fu – ricostruendo per successive approssimazioni il processo evolutivo secondo il quale, a
partire da una sostanziale eguaglianza «morale», se non «fisica», si è giunti alle profonde
diseguaglianze che dividono gli uomini moderni.
Poiché, per Rousseau, la morale è funzione della ragione, dell’associazione civile e della
legge, i primitivi erano esseri infra-umani, amorali o premorali. L’uomo naturale provava soltanto
un «amore di sé» congiunto a «compassione», ossia un istinto vitale primordiale, che esigeva
l’autoconservazione dell’individuo e attribuiva agli altri individui questo stesso impulso di
sopravvivenza. «Da questi due principi, senza che sia necessario ricorrere a quello della
socievolezza, sembrano derivare tutte le regole del diritto naturale»; beninteso, un diritto naturale
innato, grezzo, non interiorizzato come corpus dottrinale, e destinato a evolversi insieme con
l’uomo stesso.
A partire da questo momento, i singoli sviluppi concernenti la formazione della sensibilità,
della conoscenza intellettuale, del linguaggio, degli istinti associativi, illustrano il processo di
estraniazione donde è sorta la diseguaglianza. L’analisi della «diseguaglianza nascente» ha il suo
momento culminante nel processo di accumulazione della ricchezza sociale che segue l’invenzione
della metallurgia, dell’agricoltura e la difesa giuridica della proprietà privata. Di qui la rapina e la
violenza sfrenata dei ricchi a danno dei poveri: «La rottura dell’eguaglianza fu seguita dal più
spaventoso disordine [...]. La società in sul nascere fece posto al più orribile stato di guerra».
Dunque il momento della sopraffazione concerne non le origini remote, ma le società avanzate, ed il
patto sul quale queste si fondano non è che l’istituzione e organizzazione legale della violenza
mediante il consenso, estorto con l’astuzia. Ecco il «progetto più avveduto che sia mai venuto in
mente all’uomo: usare cioè a proprio vantaggio le forze stesse che lo attaccavano, fare dei propri
avversari i propri difensori, ispirare loro altre massime e dar loro altre istituzioni che gli fossero
favorevoli quanto il diritto naturale gli era contrario».
4. Solo alla legge gli uomini debbono la giustizia e la libertà
Per quale arte imperscrutabile si è potuto trovare il mezzo di assoggettare gli uomini per renderli liberi?
D’impiegare al servizio dello stato i beni, le braccia, la vita stessa di tutti i suoi membri, senza costringerli e senza
consultarli? D’incatenare la loro volontà con il loro beneplacito? Di far valere il loro consenso contro il loro rifiuto, e di
forzarli a punirsi da sé quando fanno ciò che non hanno voluto? Come può accadere che obbediscano e che nessuno
comandi? Che servano e non abbiano padroni? Tanto più liberi di fatto, in quanto sotto un’apparente soggezione,
ciascuno perde della propria libertà solo quel che può nuocere alla libertà altrui. Questi prodigi sono opera della legge.
Solo alla legge gli uomini debbono la giustizia e la libertà. È questo salutare organo della volontà di tutti che ristabilisce
nel diritto l’uguaglianza naturale tra gli uomini. È questa voce celeste che detta a ciascun cittadino i precetti della
ragione pubblica e gl’insegna a modellare la propria condotta sui princìpi dettati dal suo proprio giudizio e a non essere
in contraddizione con se stesso.
(Economia politica, in Enciclopedia, o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, 1755)
Nella parte conclusiva del Discorso sulle origini delle diseguaglianze, Rousseau accusa la
dottrina giusnaturalista di spacciare come una condizione «naturale» e ineluttabile la società
dell’ancien régime sorta dall’impostura, dalla violenza, dalla prevaricazione operata dai furbi e dai
forti contro gli onesti e i deboli. Lo Stato garantisce con le leggi e con le istituzioni lo sfruttamento
di questi da parte di quelli, ed il consenso dei governati è estorto mediante l’inganno e l’ipocrisia, in
nome di un falso ordine sociale e di una pace che è soltanto sopraffazione.
L’imputato principale in questo processo è dunque la dottrina che giustifica l’organizzazione
sociale: più precisamente, la teoria tradizionale del patto sociale, che aveva sostituito all’autorità di
diritto divino, d’origine feudale, una concezione del potere, della sovranità e dello Stato fondata sul
consenso tra governati, o tra governanti e governati. La fictio aveva fornito i loro titoli di legittimità
a Stati pseudo-democratici provvisti di istituzioni rappresentative, ma dominati in realtà da ristrette
élites di privilegiati. I giusnaturalisti e altre «persone pagate» avevano legittimato la presa del
potere da parte della borghesia commerciale dopo le guerre di religione; in Inghilterra, modello di
Stato rappresentativo per Montesquieu, il «consenso» si fondava in realtà sull’antagonismo tra
uomini d’affari, sulla competizione legata all’economia di mercato, sulla conseguente necessità di
una struttura «liberale» dello stato. Simili dottrine, use a travestire in formule astratte le condizioni
concrete, non avevano fatto altro che giustificare diversi modelli di società competitiva, possessiva,
individualistica, camuffata sotto i grandi ideali della libertà e della tolleranza, laddove però la
gestione del potere era riservata all’élite degli abbienti o delegata al sovrano.
Criticando quelle legittimazioni, Rousseau abbandona così questa specie di giusnaturalismo
«positivistico» dei suoi autori, per affermare i principi di un giusnaturalismo «normativo» che
distingue due «livelli» del diritto naturale: un diritto naturale «propriamente detto» o innato, che
coincide con l’inclinazione originaria del primitivo alla pietà e alla conservazione di sé; e un diritto
naturale «ragionato», che emerge dalla meditazione critica del filosofo e si esplicita in leggi.
Ciò che è bene e conforme all’ordine è tale per natura delle cose, indipendentemente da ogni convenzione
umana. La giustizia viene sempre da Dio, sua unica fonte, ma se sapessimo riceverla tanto dall’alto, non avremmo
bisogno né di governo né di leggi [...]. A considerare umanamente le cose, mancando una sanzione naturale, le leggi
della giustizia sono vane tra gli uomini [...]. Occorrono dunque delle convenzioni e delle leggi per unire i diritti ai
doveri e per ricondurre la giustizia al suo oggetto.
(Manoscritto di Ginevra, 1756-1760)
Naturalmente «convenzioni» e «leggi» debbono essere create mediante un consenso
autentico, un accordo tra libere volontà: le leggi di natura cui si appellavano i teorici del diritto
naturale non erano che una mortificazione del consenso, il risultato di uno pseudo-consenso tra
volontà di schiavi. Soltanto la distruzione del privilegio e l’eguaglianza possono dar luogo a «nuove
associazioni», fondate sull’equità, sulla retta ragione e sui costumi virtuosi: ossia, nel linguaggio del
Contratto sociale, sulla «volontà generale».
5. Solo la volontà generale può dirigere le forze verso il bene comune
Credo di poter fissare come principio incontestabile che solo la volontà generale può dirigere le forze dello
Stato secondo il fine della sua istituzione, che è il bene comune; infatti, se è stato il contrasto degli interessi privati a
rendere necessaria l’istituzione delle società civili, è stato l’accordo dei medesimi a renderla possibile. Il legame sociale
risulta da ciò che in questi interessi differenti c’è di comune, e se non ci fosse qualche punto su cui tutti gli interessi si
accordano la società non potrebbe esistere. Ora, poiché la volontà tende sempre al bene dell’essere che vuole, e la
volontà particolare ha sempre per oggetto l’interesse privato, mentre la volontà generale si propone l’interesse comune,
ne consegue che solo quest’ultima è, o deve essere, il vero motore del corpo sociale.
(Manoscritto di Ginevra, 1756-1760)
Il Giusnaturalismo, che all’epoca costituiva il riferimento principale per il pensiero politico,
descriveva l’ingresso degli individui nella società come un solenne impegno, assunto da ciascuno,
di rinunziare una volta per tutte alla propria volontà particolare, per costituire un corpo sociale,
sottomettendosi alla volontà positiva «di tutti». Secondo questa impostazione la volontà generale
era sempre «buona», mai ingannatrice, ed ad essa doveva rivolgersi l’individuo per riconoscere i
propri doveri di membro della comunità. Ma soprattutto la volontà generale rappresentava una
verità oggettiva e razionale, che era fondamento del diritto per le società civili così come delle
usanze per i popoli primitivi.
Rousseau critica l’impostazione giusnaturalistica, e nega che la volontà generale sia
«depositata» una volta per tutte nei patti, nei libri dei giureconsulti, nel diritto positivo: per lui la
volontà generale è una creazione continuamente rinnovata della coscienza popolare, un’espressione
immediata della ragione e della volontà dei membri del popolo sovrano riuniti in assemblea.
Viene così sancito il principio della consultazione popolare in regime di democrazia diretta,
per cui la volontà generale è in ogni caso espressa «dal basso». Ma come superare le difficoltà
pratiche di tale procedura? In un primo momento Rousseau lascia un margine di discrezionalità al
«governo» rispetto al «sovrano», ai capi rispetto al popolo: sarà sufficiente che l’esecutivo sia
composto di uomini «giusti», perché volontà generale venga correttamente interpretata. Ma quando
poi scrive il Contratto sociale si rivela ben più intransigente: la volontà generale non può essere
rappresentata né mediata, e la sua espressione diretta deve essere protetta da precise garanzie
costituzionali.
Che la sovranità risiedesse originariamente nel popolo o per dono di Dio o per natura, non
l’avevano negato né Tommaso d’Aquino, né Locke; che il popolo esprimesse la sua volontà
mediante il consenso o un «patto» – storicamente più o meno ipotetico – era un’idea corrente nella
filosofia politica assai prima del secolo XVII. Ma Rousseau dà a questi principi tradizionali, ed ai
relativi termini, un significato che nei suoi predecessori non si trova, occupandosi della
manifestazione effettiva della volontà generale e la sua traduzione in leggi civili, le garanzie e la
natura della sovranità, i modi di gestire il potere politico.
Appellarsi alla volontà di una «società generale del genere umano», intesa come suprema
depositaria dei principi del diritto e della giustizia, è per Rousseau un’illusione che esiste soltanto
«nei sistemi dei filosofi»: la realtà storica ci mostra solo modelli di società antagoniste, competitive,
violente. In società simili la voce dell’intelletto è soverchiata dagli istinti egoistici e dalle passioni
aggressive, davanti alle quali la «volontà generale» è inerme e non può prevalere, in quanto
proiezione astratta della sola ragione.
Perché invece la volontà generale sia realmente la risultante di una ricerca imparziale e
razionale del pubblico interesse, essa deve scaturire come espressione diretta e costantemente
rinnovata dell’assemblea popolare: «La volontà generale cui spetta la direzione dello stato non
appartiene al passato, ma al presente, e il vero carattere della sovranità consiste in un accordo
costante di tempo, luogo, effetto, fra la direzione della volontà generale e l’impiego della pubblica
forza».
6. Togliere la libertà alla volontà dellʼuomo significa togliere ogni
moralità alle sue azioni
Rinunziare alla libertà vuol dire rinunziare alla propria qualità di uomo, ai diritti dell’umanità, persino ai propri
doveri. Non c’è compenso possibile per chi rinunzia a tutto. Una tale rinunzia è incompatibile con la natura dell’uomo:
togliere ogni libertà alla sua volontà significa togliere ogni moralità alle sue azioni. Infine, una convenzione che
stabilisce, da un lato, una autorità assoluta e, dall’altro, un’obbedienza illimitata risulta vana e contraddittoria. Non è
forse chiaro che non si hanno obblighi di sorta verso colui da cui si ha diritto di esigere tutto, e non basta questa
condizione senza corrispettivo, senza scambio, a comportare la nullità dell’atto?
(Contratto sociale, 1762)
Secondo i teorici del Contrattualismo, i requisiti essenziali della libertà, della proprietà, della
vita, erano garantiti dall’autorità dello Stato in base a un «contratto di rinunzia»: per entrare a far
parte della comunità il singolo rinunciava – anche solo parzialmente – ai suoi diritti individuali,
arrivando fino a cedere definitivamente al monarca la propria libertà originaria. Secondo Rousseau
invece la risultante legale di una ricerca imparziale e razionale del pubblico interesse può consistere
solo nella «volontà generale», definita come l’espressione diretta e costantemente rinnovata
dell’assemblea popolare. Pertanto le giustificazioni del potere politico fondate sul diritto divino, sul
diritto ereditario o paterno, sulla schiavitù, sul diritto di conquista sono, secondo tale definizione,
fuori della legalità.
La garanzia di convivenza sociale deve nascere da un contratto tra eguali stipulato su una
base di perfetta reciprocità: il popolo non si assoggetta a un principe, non cede la propria sovranità,
non la delega né la affida ad altri, ma «si aliena» soltanto a se stesso, nell’atto in cui decide di
autogovernarsi. Le clausole del patto «si riducono tutte a una sola, cioè l’alienazione totale di
ciascun associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità». L’individuo ritrova se stesso nella
comunità di eguali. La reciprocità della «alienazione totale», la mancanza di riserve, la perfetta
integrazione tra individuo e collettività, danno luogo a «un corpo morale e collettivo [...] che trae
dal medesimo atto la sua unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà».
Questa «nuova associazione» egualitaria è l’unica che può conservare «con tutta la forza
comune la persona e i beni di ciascun associato, mediante la quale ognuno unendosi a tutti non
obbedisca che a se stesso e resti libero come prima». Il che significa che nel «corpo collettivo» la
libertà «civile» dell’individuo non è semplicemente protetta, ma viene creata dalla convivenza
sociale. Rousseau distingue accuratamente la libertà «naturale», dalla libertà «civile» garantita dalle
leggi; quest’ultima recupera e ristabilisce «nel diritto» la prima, assicurandole una sfera ben più
ampia e un nuovo status etico. L’«alienazione totale» che ciascun individuo fa della propria libertà
originaria mantiene sempre un carattere impersonale: «dandosi a tutti non ci si dà a nessuno», e ci si
sottrae alle molteplici forme di assoggettamento su cui si fondano le società autoritarie.
Si è obiettato a Rousseau che questo «dispotismo» della volontà generale comporta
un’intollerabile violazione delle libertà individuali ad opera della collettività. Formule
apparentemente paradossali, isolate dal contesto («chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà
generale – dice la più controversa – vi sarà costretto dall’intero corpo [...] sarà costretto ad essere
libero») sembrano giustificare l’interpretazione «totalitaria», che è però una distorsione della tesi
rousseauiana. La quale invece dà il massimo rilievo alla reciprocità e simmetria delle singole
«alienazioni», affidando all’«io comune» il compito di salvaguardare la sfera di libertà assegnata a
ciascuno e a tutti. L’accusa opposta, di individualismo, è egualmente infondata: la chiave del
duplice nesso libertà-autorità e libertà-eguaglianza sta, ancora una volta, nell’assoluta supremazia
dell’interesse generale. Affermare infatti che tutti i cittadini sono liberi ed eguali sotto il dispotismo
delle leggi da loro stessi volute («libertà è obbedire alla legge che ci si è data»), non significa
operare la sintesi degli egoismi individuali, ma elidere in nome del bene comune le spinte
centrifughe, gli interessi particolari che introducono discriminazioni e diseguaglianze.
7. I singoli vedono il bene che non vogliono, la collettività vuole il bene
che non vede
La volontà generale è sempre retta, ma il giudizio che la guida non sempre è illuminato. Bisogna presentarle
gli oggetti come sono, talvolta come devono apparirle, mostrarle la buona strada che cerca; garantirla dalle lusinghe
delle volontà particolari [...]. I singoli vedono il bene che non vogliono, la collettività vuole il bene che non vede. Tutti
ugualmente hanno bisogno di guida [...].
(Contratto sociale, 1762)
Secondo i giusnaturalisti la convivenza sociale consisteva in una sottomissione dei singoli
definitiva ed irrevocabile, e si articolava attraverso due patti impliciti: un pactum unionis (= la
comunità mi accetta come suo membro) e un pactum subjectionis (= io accetto di sottostare alla
volontà della comunità). La volontà unica che ne risultava era quindi autorizzata a servirsi delle
forze e delle facoltà di ciascun individuo per conseguire i suoi obiettivi, ad es. la pace e la sicurezza
comune. Grazie a questa spontanea sottomissione dei contraenti all’autorità da loro stessi prescelta,
il trapasso dallo stato «di natura» del singolo individuo allo stato sociale si verificava senza alcun
conflitto: la legge naturale si prolungava e si realizzava senza fratture nelle leggi della comunità.
Rousseau non esclude a priori questa impostazione, ma ne sottolinea il momento
dell’interesse come legame essenziale della convivenza umana, con questo si allontanandosi
decisamente dalla tradizione cristiana. La massima evangelica di fare agli altri ciò che vorremmo
che fosse fatto a noi è «sublime », osserva, ma priva di forza cogente; ad essa va sostituita la
massima settecentesca del «maggior bene di tutti» o «utilità comune».
Ponendo l’interesse comune come criterio di giustizia supremo e come vincolo della società
civile, Rousseau evita di rifugiarsi nell’utopia e di progettare l’ottimo governo, e ne determina
invece il fondamento legittimo:n elle votazioni la maggioranza ha ragione non perché sopraffà
numericamente la minoranza, ma perché il buon senso dei più fa prevalere infallibilmente
l’interesse generale sull’interesse privato. Ciò che la votazione verifica non è il consenso soggettivo
dei singoli su una particolare questione o proposta, quanto il confronto oggettivo tra la proposta
stessa e la «volontà generale».
Ovviamente la capacità di individuare l’interesse generale è propria soltanto di una comunità
consapevole, ben governata, «virtuosa», una collettività che «scopre» soggettivamente le migliori
regole per convivere, e Rousseau sottolinea con forza la natura oggettiva di tale criterio di ricerca e
di giudizio, indipendente dalle circostanze e dai tempi. Ad esempio, se la società entra in crisi e si
dissolvono i valori civili e morali, non significa che la volontà generale si annulli o scompaia, ma
rimane allo stato potenziale, «costante, inalterabile e pura». L’errore razionale o l’offuscamento
passionale dei cittadini «elude» il criterio del pubblico interesse, ma non l’intacca, giacché esso è
sempre determinabile razionalmente.
Restano i problemi pratici nel dare vita ad una costituzione, la quale ragionevolmente non
può sorgere «per una improvvisa ispirazione» della moltitudine disorganizzata, soprattutto in una
società ai suoi esordi, quando il popolo è ancora «una moltitudine cieca [...] ignara di ciò che
vuole». Dobbiamo dunque ammettere che un popolo possa mostrarsi immaturo e incapace di
autogovernarsi? Sorge insomma il problema di come mediare la volontà retta e l’intelligenza ancora
confusa (o, in altri termini, la «natura buona» e la mente fallibile) nell’impresa «grande e difficile»
di dar vita a una costituzione.
Qui Rousseau rifiuta ogni ricorso ad un’élite, e introduce la figura carismatica del
«legislatore» o fondatore di Stato. L’artefice delle leggi giuste non ha un ruolo autoritario, ma deve
rendere possibile l’individuazione dell’interesse comune, catalizzando e orientando verso un fine
ben individuato energie preesistenti allo stato potenziale, volontà o predisposizioni incerte, che
potrebbero facilmente tralignare. È colui che interviene a mediare l’astrazione dello stato di natura
originario con il «caso», cui la decadenza è dovuta, è il deus ex machina che fa inclinare la natura
umana dal lato buono.
8. La volontà generale non si rappresenta: o è essa stessa, o è unʼaltra;
una via di mezzo non esiste
La sovranità non può venir rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa consiste
essenzialmente nella volontà generale, e la volontà generale non si rappresenta: o è essa stessa, o è un’altra; una via di
mezzo non esiste. I deputati del popolo non possono essere i suoi rappresentanti, sono solo i suoi commissari; non
possono concludere niente in modo definitivo. Qualunque legge che non sia stata ratificata dal popolo in persona è
nulla; non è una legge. Il popolo inglese si crede libero, ma è in grave errore; è libero solo durante l’elezione dei
membri del parlamento; appena avvenuta l’elezione è schiavo; è niente. Nei suoi brevi momenti di libertà ne fa un uso
per cui merita senz’altro di perderla.
(Contratto sociale, 1762)
Una dottrina corrente tra gli scrittori giusnaturalistici affermava che la sovranità consta di
«parti» egualmente suddivise tra i vari organi dello Stato: potere legislativo ed esecutivo, giustizia e
guerra, forza e volontà, e via dicendo. Si tratta, obietta Rousseau, di «emanazioni» del potere, non
di sue «parti»: gli atti di sovranità operati dai diversi organi dello Stato non sono leggi ma loro
applicazioni, ed ogni compromesso introdotto dalle dottrine dell’equilibrio e della divisione dei
poteri lede la sovranità popolare, che oltre ad essere indivisibile, è inalienabile e illimitata.
Fermo restando questo concetto, l’esercizio del potere – in senso tecnico il «governo» – può
essere affidato a organi diversi senza che questo leda la legittimità delle istituzioni: esiste dunque la
distinzione tra legislativo ed esecutivo, ma essi non vanno intesi come poteri indipendenti in
equilibrio reciproco. Il legislativo, che compete esclusivamente all’assemblea del popolo sovrano,
fissa i principi generali, o leggi, ed ha il controllo completo dell’esecutivo; al quale invece spettano
unicamente gli «atti particolari» di governo.
Rousseau pone ogni cura nell’evitare di confondere la stipulazione del «patto» con la
nomina del «governo»: affidare all’esecutivo il compito di governare non significa che il popolo
delega la sua sovranità. Si tratta soltanto di un compito assegnato a magistrati che operano come
«semplici funzionari del sovrano ed esercitano in suo nome un potere del quale li ha fatti
depositari»; il mandato è provvisorio, revocabile e sindacabile. In realtà l’autore ha ben presenti i
rischi ai quali vanno incontro le forme di rappresentanza della volontà politica, nelle quali il corpo
dei rappresentanti finisce per costituire una casta a sé, usurpando di fatto la sovranità e anteponendo
la volontà propria a quella popolare: di fronte a simili casi di «corruzione del corpo politico», non
v’è più rispondenza tra l’aspetto soggettivo e quello oggettivo della volontà generale.
Una concezione così rigida della supremazia del legislativo rispetto all’esecutivo ha fatto
ritenere che Rousseau rifiutasse la rappresentanza parlamentare a favore della sola «democrazia
diretta». Ma questo è vero solo se si intende che le leggi debbono essere votate dall’assemblea
plenaria del popolo anziché da un organo intermedio elettivo. In pratica non si esclude che la
subordinazione dell’esecutivo al legislativo possa sussistere anche laddove «governa» una
minoranza elettiva o una sola persona, purché questa si uniformi alla volontà generale.
Per il resto si tratta di questioni «tecniche»: i grandi Stati non sono governabili se non
mediante esecutivi efficienti e ristretti, quindi a regime monarchico; mentre le forme elettive vanno
privilegiate in quegli Stati che presentino requisiti di medie dimensioni e moderazione di ricchezze.
E quando sostiene che è «contro l’ordine naturale che la maggioranza governi e la minoranza sia
governata» Rousseau non si contraddice affatto: simili asserzioni appaiono incoerenti soltanto se
avulse dal contesto, cioè se si fraintende l’uso tecnico del termine «governo».
È invece sempre da evitare il criterio pericoloso che «chi fa le leggi le esegue», ossia la
confusione tra sovrano e governo, che di fatto esautora il popolo dalla sua legittima sovranità:
Nel momento stesso in cui il popolo è riunito legittimamente in corpo sovrano ogni giurisdizione del governo cessa, il
potere esecutivo è sospeso e la persona dell’ultimo dei cittadini è altrettanto sacra e inviolabile quanto quella del più
alto magistrato; perché dove c’è il rappresentato non c’è più il rappresentante [...].
(Contratto sociale, 1762)