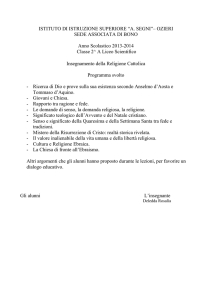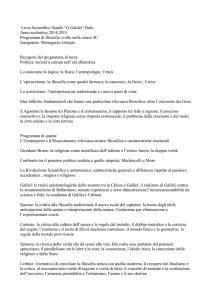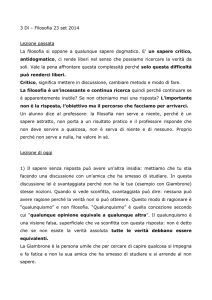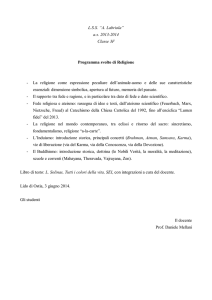TESTI CITATI E COMMENTATI NEL QUADRO DEL CORSO 2011/2012 DI STORIA DELLA FILOSOFIA, PROF. M. SAVINI
(aggiornato al 4 novembre 2011)
M. Mersenne, Quaestiones in Genesim (1623), col. 669 sgg. (dal colophon tagliato, trad. tratta dalle pagine
dell’ILIESI a cura di F.P. Raimondi: http://www.iliesi.cnr.it/Vanini/testimon/test11.php )
«Quando dunque sia stato scoperto come ateo si mandi ai dovuti supplizi, che certo non possono essere
soverchi, si metta a soqquadro la sua casa e si bruci pubblicamente con una nota di ignominia; ciò
allontanerà, se non tutti, moltissimi, come i Diagora [di Melo], i Protagora [di Abdera], i Callimaco [di
Cirene], gli Ippone, i Teodoro, gli Evemero, i Teagene, i Diogene [di Sinope], i Mezenzio, i Ciclopi, i
Luciano [di Samosata], i Vanini e moltissimi altri portenti del medesimo genere di uomini, sui quali si
possono leggere Laerzio, Tullio, Virgilio e Marziale, il cui ultimo libro quarto degli Epigrammi registra
Selio tra gli atei.
Ma non è necessario percorrere tutta la Francia; se non altro perché si è detto non una sola volta che la
sola Parigi è piena di almeno 50.000 atei, la quale puzza moltissimo per la melma e molto più per gli atei
sicché in un’unica casa ne puoi talvolta trovare 12 che vomitano questa empietà. I prudenti per
guardarsene stiano attenti se essi sostengono talune argomentazioni per dar forza alla maestà del divino
nume, se poi aggiungono talune obiezioni di senso contrario, alle quali in seguito forniscono risposte
deboluccie con animo simulato. così infatti dicono che abbia tentato di seminare l’ateismo a Parigi
Vanini, il quale dapprima insorgeva davvero violentemente contro gli atei e faceva credere di detestarli
sopra ogni cosa; infatti simulava ciò in termini piuttosto aspri; poi, come indignato, riportava le loro
obiezioni, le consolidava e le insinuava con forza e con ingegno ed era persuasivo; infine rispondeva ad
esse in così malo modo e con tale debolezza da imporle facilmente agli inesperti conculcandole nel loro
animo in modo che essi, partendo da quelle soluzioni così fragili, giudicassero e concludessero che non
c’è alcuna ragione che provi l’esistenza di Dio e che di contro ve ne sono moltissime che sembrano
provare che non esiste alcuna divinità.
Questi sono i dardi con cui quel maledetto fannullone si affannava a destinare altri alla perdizione, per
non parlare di altre sue empietà per le quali fu giustamente mandato a morte dal Senato tolosano.
[...] Ove vorrei che tu comprendessi non solo le pasquinate, ma anche i libri che sembrerebbero
contenere buone cose se non aprissero la strada all’ateismo. Tali sono i libri di Charron sulla Sagesse, di
Machiavelli sul Principe e sullo Stato, di Cardano De subtilitate, De astrorum iudiciis, De supplemento
Almanach e in diversi passi di altri suoi libri, di Campanella, dei dialoghi di Vanini, di Fludd e di moltissimi
altri, che sarebbe opportuno mandare alla totale distruzione o quanto meno correggere; appunto
perché questi insinuano non una sola volta l’ipotesi della mortalità dell’anima e divulgano altri errori che
possono condurre all’ateismo [...].
Né è libera da tale male l’Italia dal momento che dicono che Vanini dichiarò di essersi allontanato da
Napoli con 13 suoi compagni per diffondere in tutto l’orbe l’ateismo; cosa che credo di aver notato in
qualche luogo; a lui per la verità toccò in sorte Parigi, ma grazie a Dio la Francia non tollerò a lungo quel
mostro».
R. Descartes, dall’Epistola dedicatoria ai dottori della Sorbona (1641), trad. I Agostini in Opere (1637-1649),
Milano, Bompiani, 2009, pp. 681-683.
«Tanto giusta è la causa che mi spinge a offrirvi questo scritto, e tanto giusta confido che la riterrete
anche voi incaricandovi della sua difesa, una volta che abbiate inteso il motivo per cui la intento, che
non posso qui farlo meglio valere se non esponendo in poche parole che cosa mi sia in esso prefisso.
Ho sempre ritenuto che due questioni, quella di Dio e quella dell’anima, siano le più importanti tra
quelle che devono essere dimostrate per mezzo della filosofia, piuttosto che della teologia. Per quanto
infatti a noi fedeli basti credere per fede che l’anima umana non muore col corpo | e che Dio esiste, non
sembra davvero che gli infedeli possano essere persuasi di alcuna religione e, potrei dire, di alcuna virtù
morale, a meno che queste due cose non siano prima provate loro con la ragione naturale; e poiché in
questa vita vengono spesso premiati più i vizi che le virtù, sarebbero in pochi a preferire il retto all’utile
senza il timore di Dio e l’attesa di un’altra vita. E sebbene sia senz’altro vero che si deve credere
all’esistenza di Dio, in quanto è insegnata nelle Sacre Scritture e, viceversa, che si deve credere alle
Sacre Scritture, in quanto sono considerate come provenienti da Dio – in quanto, cioè, essendo la fede
dono di Dio, egli è colui che dà la grazia per credere a tutte le cose e, insieme, anche colui che può darla
perché crediamo che esista –, ciò non può tuttavia essere proposto agli infedeli, perché lo
giudicherebbero un circolo. E mi sono peraltro accorto non solo che voi tutti e gli altri teologi affermate
che l’esistenza di Dio può essere provata con la ragione naturale, ma anche che dalla Sacra Scrittura si
evince che la sua conoscenza è più facile di molte delle conoscenze che si posseggono sulle cose create;
tanto facile, in una parola, che coloro che non la posseggono sono colpevoli. Questo risulta infatti dalle
seguenti parole del Libro della Sapienza, 13: «Neppure costoro però sono scusabili, perché se tanto
poterono sapere da scrutare l’Universo, come mai non ne hanno trovato in modo più facile il
Creatore?». E nella Lettera ai Romani, cap. 1, è scritto che essi sono inescusabili . E, nello stesso luogo,
queste parole: Ciò che di Dio si conosce è loro manifesto sembrano anche ammonirci che tutto ciò che si
può sapere di Dio può essere mostrato con argomenti non ricavati che dalla nostra mente. È per questo
che ho ritenuto non fosse al di fuori delle mie competenze ricercare in che modo ciò accada e per quale
via Dio possa essere conosciuto in modo più facile e più certo delle cose del mondo».
H. Grotius, De Jure belli ac pacis (1625), II, xx, XLIV, pp. 440-441
«Siccome non tutti comprendono la forza di questa ed altre ragioni, basterà che in tutti i tempi e in tutti
i paesi, con l’eccezione di pochi casi, abbiano consentito a queste convinzioni tanto coloro che erano
troppo rozzi per voler ingannare quanto coloro che erano troppo sapienti per lasciarsi raggirare. Infatti
questo consenso in una così grande diversità di leggi e di opinioni in altre materie, mostra bene o una
certa luce insita negli animi che guida l’animo per una sua propria forza, oppure una tradizione derivata
dai primi uomini fino a noi e che non è mai stata solidamente confutata. Entrambe queste cose bastano
a convincerci a prestarvi fede».
H. Grotius, De veritate religionis christianae (1627, Ia ed. in fiammingo 1622, II ed. 1629), I, 1 («Dio esiste»)
I prova, p. 5
«L’opinione e il parere di tutti mettono fuor di dubbio che vi sono cose che hanno iniziato ad essere.
Ora, queste cose non si sono affatto prodotte da sole. Infatti produrre significa agire ; ora, per agire
bisogna esistere. Di conseguenza se esse si sono prodotte da sole, allora esse sono esistite prima di
essere, il che è contraddittorio. Segue dunque che hanno ricevuto l’essere da qualche altro principio.
.......... Ed è precisamente questo principio che noi chiamiamo Dio».
II prova (p. 5-7)
«La mia seconda prova è tratta dal consenso manifestato da tutte le nazioni del mondo (perlomeno
quelle in cui un temperamento selvaggio e rozzo non ha estinto i lumi della ragione e le idee del bene e
del male) a credere ad una divinità. Dico quindi che le cose stabilite su base puramente umana hanno
due caratteri che non si trovano affatto in questo consenso unanime. Il primo è quello di essere
differenti a seconda del paese e secondo le inclinazioni dei popoli, il secondo è quello di essere soggette
al cambiamento. Ora, come ha notato Aristotele stesso, che non avremmo ragione di sospettare di
credulità a tal proposito, la credenza in una divinità è generalmente sparsa ovunque. Del resto, come
l’ha riconosciuto anche questo filosofo, il tempo che cambia tutte le cose del tutto artificiali, non ha mai
potuto cambiare questa. Da dove viene dunque questa credenza, se non da una causa che agisce
naturalmente sulla mente di tutti gli uomini che sono al mondo ? Ora, questa causa non può essere che
una di queste due : una rivelazione espressa, emanata da Dio, o una tradizione, che di mano in mano sia
passata dai primi uomini fino a noi. La prima causa decide in nostro favore, poiché non può esservi
rivelazione divina, se non vi è un Dio. Se si dice che si tratta di una tradizione, che ci venga allora addotta
una qualche ragione per farci ritenere che questi primi uomini hanno avuto il disegno, in un affare di
tale importanza, di imporre la loro opinione a tutta la posterità. Aggiungete a ciò che sia che portiamo lo
sguardo su tutti i luoghi dell’antico mondo, sia che guardiamo tutti quelli del nuovo, non vedremo
popolo alcuno [...] che non riconosca una divinità, per quanto a dire il vero la conoscenza che ne hanno
sia tanto distinta o confusa a seconda della loro civiltà e delle loro conoscenze [...] Non ci si obietti qui
quel piccolo numero di uomini che, in un gran numero di secoli hanno creduto o fatto professione di
credere che non esiste alcun Dio. Il loro piccolo numero e l’opposizione generale che essi hanno
incontrato quando hanno voluto introdurre le loro opinioni fanno vedere che queste opinioni non erano
il frutto del buon uso che queste persone facevano della loro ragione, ma un effetto o dell’amore per la
novità, passione la cui stranezza ha qualche volta portato a sostenere che la neve è nera, oppure di una
mente corrotta, che, così come un gusto rovinato, giudica le cose non secondo quel esse sono in se
stesse, ma a seconda di quel che a lui sembrano».
E. Herbert di Cherbury, De veritate prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili, et a falso (1624,
II ed. 1636; III ed. 1645)
«|27| Queste verità sono certe nozioni comuni che si trovano in tutti gli uomini sani ed integri, con le
quali, ricevute per così dire dal cielo, la nostra mente giudica degli oggetti che si presentano su questo
teatro. È dunque grazie a questo solo mezzo (non un altro) che l’intelletto giudica delle cose note e delle
cose nuove in maniera tale che non vi è che lui solo che può riconoscere se le nostre facoltà anticipatrici
e banditrici hanno trovato veramente qualcosa».
«|38| Poiché ciò che si dimostra per consenso universale deve essere vero e essere istruito da qualche
facoltà interna (non vi sarà infatti nessuna ragione che convincerà che ciò è falso), poiché non vi è
nell’uomo alcuna facoltà cui deve piuttosto essere attribuita questa verità, poniamo come facoltà
istitutrice l’istinto naturale [...]. |39| La somma norma della verità sarà quindi l’istinto naturale, così che
non vi è nulla di tanto importante quanto lo scegliere queste nozioni comuni e metterle ciascuna al suo
posto come verità indubitabili. Ciò è tanto più necessario ora di quanto lo sia mai stato, in quanto i
mortali, nell’attuale estrema differenza di parole, si lasciano persuadere non dalla cattedra con le
ragioni, ma (nonostante la riluttanza della coscienza e del senso interno) la fede viene estorta con il
terrore al punto che tutti coloro che sono fuori dalla propria chiesa sono colpevoli di ignoranza o di
errore da dover subire la dannazione eterna dopo questa vita (senza alcun indugio o rinvio clemente).
Non vi è scampo per la misera folla di quanti sono da ciò spaventati, a meno che non si pongano dei
saldi fondamenti della verità a partire dal consenso universale, ai quali si possa ricorrere in qualunque
dubbio teologico o filosofico. Poiché infatti tutti quanti i popoli pongono una legge (cioè le loro Nozioni
comuni disposte in ordine) e poiché d’altra parte tale legge varia a seconda dei vari legislatori, siccome
infine come tra certe leggi vi è un dissenso, così in altre vi è un sommo consenso, tanto per quanto
riguarda la religione che il diritto civile e politico, poniamo quel consenso universale come
insegnamento dell’istinto naturale e opera universale necessaria della Provvidenza divina».
«|208| Non tutte le religioni che si vantano di una rivelazione sono buone, né ogni dottrina che si serve
di essa è sempre necessaria o utile. Alcune cose le si può espungere, altre le si può separare, altre
ancora devono proprio esserlo. A ciò la dottrina delle nozioni comuni può essere così utile che non si
può istituire alcuna rivelazione o religione senza il loro aiuto. Quanto si dice infatti comunemente circa
la fede implicita non solo qui da noi, ma anche presso i popoli più lontani, non servono per nulla al
presente proposito. Ora, sono cose di questo tipo l’affermazione secondo la quale la ragione deve
essere messa da parte e sostituita dalla fede; quella secondo cui è in potere della propria Chiesa (che
non può errare) prescrivere il culto divino e che quindi essa deve essere seguita in tutto e per tutto;
quella per cui nessuno deve affidarsi alle proprie forze al punto da osare esaminare la sacrosanta
potestà dei pastori e di quanti annunziano il verbo divino. [...] Tutte queste cose, intendo dire, e
argomenti di questo tipo (nella diversità dei tempi e dei luoghi) servono a stabilire di solito tanto la
religione vera che una religione falsa; [...] quale solenne impostore, infatti, non suggerirà queste cose al
suo gregge immondo? [...] Quindi a meno che non si apra la strada alla verità a partire |209| dalle
Nozioni comuni, e non si attribuisca a ciascuna parte il proprio valore, che cosa non otterrà qualunque
opinione, anche quella peggiore di tutte? [...] Per queste ragioni si devono stabilire le premesse della
religione a partire dalla sapienza universale, così che quindi tutto ciò che si sarà aggiunto a partire dal
genuino dettame della fede, sia puntellato e sostenuto come una architrave e un tetto da questo
fondamento. Da ciò consegue che non si deve accogliere cosi imprudentemente ogni sorta di religione, e
che per prima cosa si deve esaminare donde consista il suo onore. Il lettore troverà che tutte queste
cose dipendono dalle Nozioni comuni».
R. Descartes a M. Mersenne, 16 ottobre 1639, in Tutte le lettere, Milano, Bompiani, 2005, pp. 1061-1063.
Quanto al resto, dopo le mie ultime, ho trovato il tempo per leggere il libro che avete avuto la cortesia di
inviarmi, e visto che avevate chiesto il mio parere e che tratta un argomento a cui ho lavorato per tutta
la vita, ritengo di dovervene scrivere. Vi trovo parecchie cose molto valide, ma dal sapore non comune;
considerato che sono poche le persone capaci di intendere la metafisica. E quanto al libro nel suo
complesso, percorre una strada molto diversa da quella che io ho seguito. Esso esamina cos’è la verità; e
quanto a me, non ne ho mai dubitato, parendomi una nozione così trascendentalmente chiara che è
impossibile ignorarla: in effetti, vi sono certamente dei sistemi per valutare una bilancia prima di
servirsene, ma non se ne troverebbero di certo per imparare che cos’è la verità, se non la si conoscesse
per natura. Infatti quale ragione avremmo di assentire a chi ce lo insegnasse, se non sapessimo che è
vero, cioè, se non conoscessimo la verità? In questo modo si può certamente spiegare cosa significhi il
nome <verità> a chi non capisce la lingua, e dire loro che questo termine, verità, nel suo significato
proprio, denota la conformità del pensiero all’oggetto, ma che, quando lo si attribuisce a cose che sono
fuori dal pensiero, significa soltanto che queste cose possono fungere da oggetti di pensieri veri, sia
nostri, sia di Dio; ma non si può dare alcuna definizione di logica che aiuti a conoscere la sua natura. E
credo lo stesso di molte altre cose, che sono molto semplici e si conoscono naturalmente, come la
figura, la grandezza, il movimento, il luogo, il tempo ecc., sicché quando si vuole definire queste cose, le
si rende oscure e ci si ingarbuglia. Infatti, per esempio, chi passeggia in una sala, fa capire molto meglio
cos’è il movimento, di quanto non faccia chi dice: è atto dell’ente in potenza in quanto in potenza, e così
via. L’autore assume come regola delle sue verità il consenso universale. Per quanto mi riguarda, non ho
come regola delle mie se non la luce naturale, cose che in parte convengono: avendo infatti tutti gli
uomini uno stesso lume naturale, sembra che debbano tutti avere le medesime nozioni; esse sono però
anche molto diverse, nel senso che praticamente non c’è persona che si serva bene di questo lume, da
cui consegue che molti (ad esempio tutti quelli che conosciamo) possono consentire ad uno stesso
errore; e ci sono moltissime cose che possono essere conosciute grazie al lume naturale, su cui mai
nessuno ha ancora riflettuto. Egli sostiene che in noi ci sono tante facoltà quante sono le diverse cose da
conoscere, cosa che non posso intendere diversamente che come se, dato che la cera può ricevere una
infinità di figure, si dicesse che ha in sé una infinità di facoltà per riceverle. Il che è vero in quel senso;
ma non vedo che vantaggio possa derivare da questo modo di esprimersi, e mi sembra piuttosto che
esso possa nuocere dando modo agli ignoranti di immaginare altrettante diverse piccole entità nella
nostra anima. Ecco perché preferisco pensare che la cera, per la sua sola flessibilità, riceve ogni sorta di
figure, e che l’anima acquista tutte le sue conoscenze grazie alla riflessione che fa, o su se stessa per le
cose intellettuali, o sulle diverse disposizioni del cervello a cui è unita per le corporee. <Ciò avviene> sia
che queste disposizioni dipendano dai sensi, sia <che dipendano> da altre cause. Ma è utilissimo non
accettare niente nelle proprie credenze, senza esaminare a che titolo o per quale causa lo si è accettato;
con ciò si ritorna a quanto egli dice, che si deve sempre esaminare la facoltà di cui ci si serve ecc. Non c’è
dubbio che sia anche necessario, come dice, assicurarsi che non manchi niente, né dalla parte
dell’oggetto, né del mezzo, né dell’organo ecc., per non essere ingannati dai sensi. Egli vuole che si
segua soprattutto l’istinto naturale, da cui trae tutte le sue nozioni comuni; per quanto mi riguarda,
distinguo due specie di istinti: uno si trova in noi in quanto uomini ed è puramente intellettuale; è il
lume naturale o intuito della mente sul quale, solo, si deve fare affidamento; l’altro è in noi in quanto
animali ed è un certo impulso della natura alla conservazione del nostro corpo, al godimento dei piaceri
corporei ecc., che non sempre deve essere seguito. I suoi Zetetici sono molto utili come aiuto a fare le
enumerazioni di cui parlo a pagina 20; infatti, quando avremo esaminato precisamente tutto ciò che
contengono, si potrà essere certi di non aver omesso nulla. Per quanto riguarda la religione, ne lascio
l’esame ai Signori della Sorbona, e posso unicamente dire che vi ho trovato molte meno difficoltà
leggendolo in francese, di quante ne avevo incontrate in precedenza scorrendolo in latino; e che vi sono
parecchie massime che mi sembrano talmente pie e talmente conformi al senso comune, che spero
possano essere approvate dalla teologia ortodossa. Infine, come conclusione, per quanto non possa
accordarmi in tutto ai sentimenti di questo autore, non smetto di stimarlo molto al di sopra dei comuni
ingegni. Sono, Reverendo Padre, il Vostro molto umile e affezionato servitore, Descartes
16 Ottobre 1639
E. Herbert di Cherbury, De religione laici (1645).
«|127| È chiaro che a seconda della diversità dei tempi e dei luoghi esistono oggi e sono esistite in altri
tempi numerose credenze o religioni i cui legislatori hanno in tutti i casi assicurato che venivano
direttamente dal cielo. Così il viaggiatore ne trova una in Europa, un’altra in Africa e in Asia ed ancora
un’altra fino alle Indie. [...] Come se la caverà quindi il viaggiatore nato in un luogo e in un secolo così
poco fortunato? Soprattutto se ciascuno presenta l’insegnamento di una verità così necessaria e decisiva
da condannare qualunque altra, quale argomento permetterà a lui di distinguerle? [...] Così, fintanto che
il viaggiatore non avrà giustificato la sua causa con argomenti chiari e distinti, egli non potrà mai
difendere la sua religione, né scartarne un’altra.»
«|129| Le verità che sono riconosciute e sempre lo saranno dappertutto non sono chiuse all’interno di
una sola religione qualunque in quanto esse sono inscritte divinamente nella mente stessa e non sono
asservite ad alcuna tradizione, sia essa scritta o no. È da esse precisamente che questo universo è
amministrato e predisposto ad uno stato migliore. Prendile dunque come le verità cattoliche della
chiesa. Con ciò non ricercherai affatto in maniera più indolente le verità di fede. Più di una volta
abbiamo ammonito infatti che si può e si deve credere (quando si aggiunge la testimonianza insigne
della chiesa) a quelle verità che non ripugnano a queste. In effetti, chi otterrà un beneficio divino o
umano abbandonando la fede per diffidenza? Chi non si rende colpevole di un errore ignobile rigettando
ciò che appartiene alla potenza divina ed è garantito da una così grande autorità? Che la fede mantenga
quindi la sua dignità là dove si afferma e si distingue a sufficienza. Ci sia permesso osservare che il
termine ‘fede’ si prende in un duplice significato: a proposito degli eventi passati [Praeterita] e di quelli
futuri. Quella che si riferisce agli eventi passati è il fermo assenso attribuito alle cose che si raccontano,
ma in maniera tale da dipende principalmente dall’autorità umana, in riferimento ad una certa epoca e a
seconda delle circostanze più o meno verosimile. È inoltre debole e per sé non è analoga ad alcuna
facoltà ed è racchiusa in certi limiti né tocca tutti gli uomini. Ma la fede in Dio che porta sulle cose future
trae origine dalla più alta facoltà dell’anima (quella che ovunque distingue gli uomini dagli altri animali).
Essa è anche accompagnata da numerose nozioni comuni , mentre una sola (e cioè che così possa
accadere) è propria alla fede che riguarda il passato».
«Attesto infine di aver edito questo trattato non con animo insensibile alla migliore religione o alla vera
fede. Al punto che ho avuto in animo di gettare le fondamenta di entrambe, finché sorga comodamente
l’intero edificio del culto religioso e la macchina della fede vi si stabilisca sopra. Ma soprattutto attesto
di averlo pubblicato:
1. perché rivendica come sommo attributo di Dio la provvidenza divina universale (che nessun
argomento può affermare in misura adeguata alla sua dignità). Non vi è infatti una qualche religione o
fede particolare, per quanto lassa, da eliminarla [...];
2. perché insegna la giusta conformazione e uso delle facoltà insite nell’uomo. Non vi è infatti alcuna
verità universale che non si descritta nel foro interno, o che perlomeno non sia necessariamente
ricondotta ad esso;
3. perché distingue ciò che non è controverso da ciò che è controverso [...];
4. poiché getta le basi della concordia comune [...];
5. poiché conferisce una autorità ed una maestà indubbia alla religione, alla gerarchia e quindi allo stato
[...];
6. Poiché non indebolisce la religione, ma aggiunge uno sprone alla sua severità [...];
7. Poiché mette bene insieme il fine ultimo e l’intenzione delle Sacre Lettere[...]».
L. Meyer, Philosophiae S. Scripturae Interpres Exercitatio Paradoxa (1666)
Capitolo V, §§ 1-2, 4
«Ma in verità di quali facoltà deve essere fornito, da quali strumenti deve essere aiutato, da quale
norma, da quale metodo deve essere istruito colui che deve essere in grado di spiegare veramente la S.
Scrittura, vendicarla dalle false interpretazioni di altri ed essere in grado di assolvere il compito di
genuino interprete? I pontifici stabiliscono che il diritto e la norma di interpretare i S. testi e di giudicare
le interpretazioni degli altri risiede nella sola chiesa di Roma e perciò ritengono che non vi sia alcun vero
interprete se non quello la cui spiegazione è confermata e corroborata dall’approvazione di quella
chiesa. A questa opinione si oppongono strenuamente tutti quei cristiani che hanno fatto defezione
dalla fede di Roma affermando che, oltre ad altri mezzi riconducibili a questo lavoro – come la
conoscenza delle lingue, l’aiuto di interpreti pii e dotti, ecc. – la sola S. Scrittura è l’unica e la migliore
regola e la norma infallibile secondo la quale ogni interpretazione deve essere condotta. Noi, che
rigettiamo tanto questa quanto quella opinione per le ragioni che dovranno essere presentate più
avanti, abbiamo per il momento intenzione di sostenere una nuova e paradossale opinione, ovvero che
questa funzione compete alla vera filosofia e che questa è la norma certa e per niente fallace sia per
spiegare il libri sacri, sia per considerare le spiegazioni che di essi sono fornite. E vogliamo che il titolo
della nostra Esercitazione sia inteso in questo senso: poiché anche dai teologi Evangelici è ritenuta sia
l’interprete di se stessa che giudice delle controversie teologiche, è cioè ritenuta la norma e la regola
dell’interpretare e del giudicare».
§ 2.
«Ma la Filosofia della quale qui stiamo parlando (così che iniziamo anche a gustare alcune cose circa il
soggetto della nostra controversia, ci pare infatti di averne già più che a sufficienza passato in rassegna il
predicato), con il nome di Filosofia, dico, intendiamo non le opinioni o le congetture sulla natura delle
cose proposte con quel nome dal divino Platone, o dal grande Aristotele o da qualunque altro, ma la
conoscenza vera e senza alcun dubbio certa di quelle, la quale conoscenza la ragione – libera da ogni
involucro dei pregiudizi, sostenuta dall’acume e dal lume naturale dell’intelletto, aiutata e perfezionata
dallo studio, dalla premura, dall’esercizio, dalle esperienze e dall’uso delle cose – ricava e pone nella
luce certissima della verità a partire da principi fermi e per sé noti, attraverso legittime conseguenze e
apodittiche dimostrazioni percepite in maniera chiara e distinta».
§4
«Ma in verità in questo, ovvero nel fatto che Dio la causa prima e principale della filosofia, non si trova
tanta difficoltà, quanto nel lume naturale, cioè la ragione umana, che da alcuna è ritenuta causa
strumentale, da altri causa remota e meno principale, ovvero secondaria. Alcuni dei teologi odierni la
ritengono infatti così ristretta, così debole e povera, da essere quasi cieca nell’esaminare e nel
conoscere le essenze e le nature delle cose, e da dover raccogliere, invece del midollo e delle parti
interne, solo gusci e cortecce, sfamandosi con un così arido pasto, dal quale la fame della solida
conoscenza non può essere per niente riempita. Addirittura alcuni di quelli sono arrivati al punto da non
vergognarsi di affermare chiaramente che essa [la ragione umana] è del tutto nulla. Ma quanto sia
sbagliata, quanto lontana dal vero quando debba essere respinta questa opinione lo mostra tutta intera
la schiera delle nobilissime discipline matematiche, che senza dubbio – come è noto ai loro cultori –
penetrano fino alle stesse essenze delle cose che trattano e alle proprietà che derivano necessariamente
da tali essenze, dimostrandole in maniera apodittica. Che la medesima cosa possa avvenire tanto in
metafisica che in fisica, lo prova nei suoi scritti assolutamente degni di essere conservati quel nuovo
astro quanto mai chiaro e splendente sorto in questa nostra epoca nell’orbe filosofico, il nobilissimo
Renato Descartes, al punto che per coloro i quali queste verità così chiare e aperte non riescono a
rischiarare gli occhi della mente, si deve ricorrere all’elleboro, mediante il quale debbono venir espulsi i
viscidi umori delle anticipazioni e dei pregiudizi tenaci, dai quali il loro cervello è pervaso ed occupato da
ogni parte e vengano quindi dissipati e dispersi gli esalanti crassi vapori dei pregiudizi, che ottundono il
loro cervello. Questo uomo incomparabile mostra infatti col suo esempio che cosa possa
nell’investigazione delle cose la ragione o mente umana liberata dagli ostacoli e dagli intralci che le
impediscono di intendere, guidata dalle proprie forze e dalle proprie facoltà, a patto che assuma solo ciò
che è percepito in maniera chiara e distinta e passo dopo passo progredisca e avanzi dalle cose più
semplici e più note alle cose composte e ignote secondo il vero metodo di dirigere l’intelletto».
Capitolo VI
§1.
«Abbiamo sin qui spiegato il soggetto e il predicato della controversia, ora metteremo le fondamenta
mediante le quali procederemo ad edificare tutta la mole della nostra dimostrazione. [...] Abbiamo
infatti dimostrato nel capitolo 4 che tutte le verità dei passi della scrittura sono anche i loro veri
significati e che tutte le loro spiegazioni che non sono congruenti con la verità sono false. Al punto che
abbiamo dimostrato che il vero interprete dei testi sacri è colui che può far emergere, e può mostrare di
averlo fatto, le verità dei discorsi contenuti in essi, come anche dimostrare e svelare che le
interpretazioni confezionate da altri di quegli stessi discorsi non sono consone al vero. Poiché quindi,
come abbiamo insegnato nel precedente capitolo, la filosofia è la vera, certa e indubbia conoscenza
delle cose dedotta da principi conosciuti per il lume naturale e dimostrata in maniera incontrovertibile,
per tutto questo dico, potranno certamente essere portate alla luce da questa tanto le verità dei passi
della scrittura, e dimostrare che lo si è fatto, quanto esplorare se le spiegazioni di tali passi fornite da
altri corrispondano o meno alla verità e mostrare senza dubbio che esse sono segni di questo o meno.
Donde, in maniera quanto mai evidente consegue che la filosofia è la norma certa e infallibile tanto
dell’interpretare la sacra scrittura quanto del valutare le interpretazioni e inoltre consegue che colui che
è istruito in filosofia e che è illuminato dalla sua luce sincera e vera può assumere tutti i ruoli di
interprete della parola di Dio in maniera quanto mai degna e giusta».
R. Boyle, Some Considerations about the Reconciliableness of Reason and Religion(1675)
«I nostri nuovi libertini prendono un'altra strada più breve, (per quanto io speri che essa non sia una
strada più fruttifera) al fine di minare la religione. Senza preoccuparsi di esaminare le parti storiche
dottrinali della teologia cristiana così come avrebbero fatto ebrei, pagani e maomettani, costoro negano
infatti proprio quei principi della teologia naturale sui quali le religioni cristiane e quelle che differiscono
da esse convengono, e che sono supposti in quasi tutte le religioni che pretendono fornire una
rivelazione: l'esistenza e la provvidenza di una divinità, e uno stato futuro dopo la fine della vita. Questi
libertini si riconoscono nei principi epicurei o meccanici della filosofia, e quindi è inappropriato urgerli
con le Autorità utilizzate dai predicatori poiché sono tanto lontani dall'attribuire qualsiasi rispetto ai
venerabili padri della Chiesa che mancano di rispetto generalmente agli stessi filosofi pagani, giudicando
che non vi sono scrittori degni di questo nome ad eccezione di quanti, come Leucippo, Democrito,
Epicuro, ecc. spiegano le cose mediante materia e movimento locale. Non ci si deve dunque aspettare
che essi portino maggiore reverenza agli argomenti peripatetici di Scoto o Tommaso di quanta ne
portino alle omelie di Sant'Agostino o di San Crisostomo. [...] Questo, incidentalmente, può scusare il
fatto che non ho addotto nelle pagine che seguono le opinioni dei Padri o i filosofi morali, o l'autorità di
Aristotele o uno qualunque dei filosofi della scuola».(Preface, p. iv)
«Scrivo a uomini intelligenti, e non ho mai visto nel giudizio di tali persone che una dimostrazione
cessava di essere tale per essere proposta modestamente; ho visto invece spesso che un buon
argomento perde il proprio credito a causa dell'ingiusto titolo di "dimostrazione". E io devo piuttosto
portare il mio lettore a considerare il mio scopo in queste pagine a partire dal titolo, nel quale io non
pretendo far calpestare la ragione dalla religione, ma mostrare solamente la riconciliabilità dell'una con
l'altra e l'accordo amichevole tra di loro». (Preface, xiii)
«|9| Mi concederai che la teologia naturale è sufficiente per mostrare l'esistenza di una divinità; e
sappiamo che molti dei filosofi antichi, i quali non erano assistiti dalla rivelazione, erano, per la forza
della ragione, condotti a scoprire e a confessare un Dio, cioè un essere perfetto al sommo grado: molti
di essi lo rappresentano espressamente sotto questa nozione. Ora, se esiste un tale ente, non è affatto
ragionevole concepire che vi possano essere molte cose che si riferiscono alla sua natura, alla sua
volontà e alla sua condotta, che stiano al di fuori della sfera della ragione semplice o non assistita».
«|11| Vi possono essere molte cose riguardanti la divinità che sono al di sopra della ragione umana non
illuminata. Non che io affermi che tutte queste cose debbano essere nella loro propria natura
incomprensibili per noi (sebbene alcune possano esserlo) una volta che siano proposte; ma che la
ragione mediante il suo proprio lume non può scoprirle in maniera |12| particolareggiata e quindi deve
la sua conoscenza di esse alla divina rivelazione. E poiché non solo egli deve per forza sapere circa la sua
natura, attributi, ecc. quel che noi non possiamo sapere a meno che egli non ce lo dica, e siccome
sappiamo che qualunque cosa egli ci dica è infallibilmente vera, se Dio concede di rivelarci queste cose
abbiamo abbondanti ragioni per credere piuttosto quel che egli dichiara a noi circa se stesso e le cose
divine che non quello che noi possiamo concludere o arguire a proposito di esse mediante analogia di
cose di una natura infinitamente distante dalla sua, o mediante massime stabilite in accordo con la
natura degli enti inferiori. Se quindi egli ci rivela chiaramente che nella natura divina vi sono tre distinte
persone e che Dio è comunque uno, noi, che riteniamo noi stessi vincolati a credere alla testimonianza
di Dio in tutti gli altri casi, dobbiamo certamente non essere increduli nei suoi confronti quando parla di
se stesso, ma riconoscere che in un ente incomparabile ed incomprensibile può esservi una maniera di
esistere che non può essere comparata a quella di nessun altro ente, per quanto essa non possa mai
essere intesa da noi, che non possiamo comprendere come in noi stessi due nature così distanti tra loro
– quella del corpo pesante e |13| quella dello spirito immateriale – possano essere unite in modo da
formare un solo uomo. In casi come questi vi deve quindi certo essere qualcosa che sembra
assoggettare la ragione, ma si tratta di una sottomissione cui ci obbliga la ragione stessa; e colui che su
punti come questi crede ciò che la divina scrittura gli insegna piuttosto che quel che egli avrebbe
pensato se la scrittura non lo avesse mai informato, non rinuncia alla sua ragione né la schiavizza, ma
accetta di essere allievo di un insegnante onnisciente ed infallibile, che può insegnargli tali cose, le quali
né la sua semplice ragione, né nessun altro avrebbe mai potuto fargli scoprire».
«|60| A questo punto può essere tanto opportuno quanto pertinente prendere nota di tre o quattro
cose che, per quanto siano in certa misura implicate nella precedente considerazione generale, devono
ora essere distintamente inculcate qui, tanto per la loro importanza che per il fatto che esse possono
venir dedotte come corollari dal precedente discorso, come sarà confermato dalle prove che io addurrò
per ciascuna di esse. Di queste la prima è la seguente: che non dobbiamo al presente concludere che
una cosa è contraria alla ragione per il fatto che uomini dotti professano o addirittura lamentano che
non sono in grado di comprenderla chiaramente, purché vi sia prova adeguata che essa è vera e che la
cosa è primaria o eteroclita. [...]
|67| 2. Un altro un altro corollario che può essere tratto dal discorso che abbiamo prima affrontato può
essere il seguente: può non essere irragionevole credere una cosa sebbene la sua prova sia molto
difficile da comprendere.[...]
|71| 3. Può essere anche dedotto dal precedente discorso che non è sempre contro ragione l'aderire ad
una opinione che può essere gravata da una grande difficoltà o soggetta a una obiezione non facile da
risolvere; specialmente se il soggetto è tale che altre opinioni su di esso non evitano entrambi gli stessi
inconvenienti, o anche più grandi. [...]
|72| 4. L'ultimo corollario che (come ho detto) può essere dedotto dal precedente discorso è che non è
sempre irragionevole prendere come vera una proposizione di teologia, la quale non dico sia veramente
inconsistente con un'altra che prendiamo come vera, ma che noi non intendiamo chiaramente adattarsi
molto bene con un'altra che parimenti prendiamo per vera».
«|84| Quando dobbiamo giudicare quale tra due opinioni in disaccordo è più razionale, cioè più in
accordo con la retta ragione, dobbiamo propendere non per quella preferita dalla facoltà fornita di
questa o quella nozione, sia essa comune o |85| tratta da questa o quella setta di filosofi, ma per quella
che è preferita dalla facoltà fornita di tutta l'evidenza richiesta o vantaggiosa per poter dare un giusto
giudizio rispetto al caso sotteso: oppure, quando questo non può essere fatto, dalla facoltà con le
migliori e maggiori informazioni che può procurare».
R. Boyle, A Discourse of Things above Reason (1681)
«Non riesco a comprendere come un uomo, che ammetta la tua opinione, possa intelligibilmente
parlare di ciò che è infinito o di ogni cosa che sorpassi la nostra ragione, dal momento che, quando si
discorre di simili cose, le nostre parole o sono accompagnate o non sono accompagnate da idee chiare e
distinte o concetti delle cose di cui si parla; nel secondo caso noi non facciamo altro che dire delle cose
senza senso, o intrattenere i nostri uditori, al pari di un pappagallo, con delle parole che non
comprendiamo; mentre nel primo caso allora noi di fatto comprendiamo con le cose che tu mi avresti
indotto a credere, per un verso o per un altro, essere incomprensibili» (p. 61; trad. tratta da M. Sina,
L’avvento della ragione, p. 270)
«Quando noi parliamo delle cose che sono al di sopra della ragione, benché noi non possiamo averne
nessuna chiara, distinta ed adeguata nozione, tuttavia possiamo raggiungerne una nozione almeno
generale, confusa ed inadeguata, la quale può essere sufficiente a farci discriminare i loro rispettivi
oggetti da tutti gli altri, e l'uno dall'altro, il che può essere visto in alcune idee che sono costituite
negativamente, come quelle che noi possediamo dell'invisibile, incomprensibile» (p. 82, trad. tratta da
M. Sina, L’avvento della ragione, p. 275).