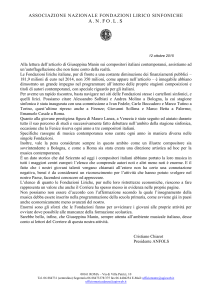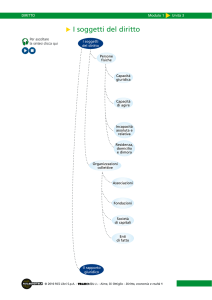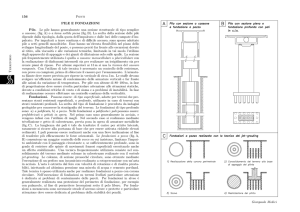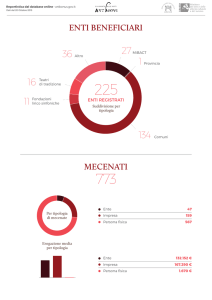GUIDO ALPA
Responsabilità sociale dell’impresa, enti non profit, etica degli affari
1. Una premessa
E’ variegato lo scenario nel quale sta evolvendo la “responsabilità sociale dell’ impresa”,
un’idea, poi trasformatasi in corrente intellettuale e in iniziative di natura culturale ed istituzionale,
che vede protagonisti le imprese, le categorie professionali, le Amministrazioni pubbliche, larghi strati
della società civile nonché Governi e Parlamenti. La responsabilità sociale impegna gli operatori
economici a valutare – nell’ambito di uno “sviluppo sostenibile” – gli effetti dell’attività economica
sui suoi destinatari e sull’ambiente, e a contribuire alla formazione di un’etica sociale: l’ente organizzato
in forma collettiva – corporate, come suona la formula importata dal mondo anglo-americano – è
chiamato a prender consapevolezza della dimensione sociale dello sviluppo in cui si confrontano e si
contemperano esigenze economiche ed esigenze della collettività e a recare il proprio contributo alla
tutela di diritti e interessi individuali e collettivi sui quali si ripercuotono le scelte, i comportamenti, le
strategie dell’agire economico. E’ una delle risposte – tra le molte che si potrebbero dare – al
progressivo sgretolamento dello Stato sociale, alle aggressioni all’ambiente, alla creazione dei bisogni
consumistici, alla precarietà del lavoro, alla opacità dei rapporti negoziali, alla ingovernabilità della
globalizzazione dei mercati. Questa risposta riposa sul contributo volontario degli operatori e si colloca
dunque in uno spazio che va al di là di ciò che ad essi è richiesto dagli obblighi imposti dalla legge [1].
In linea parallela si registra l’ evoluzione sul versante internazionale e sul versante interno
degli enti non-proft, gli enti che non hanno, istituzionalmente, la vocazione allo svolgimento di una
attività economica, ma piuttosto scopi di natura assistenziale, benefica, culturale, religiosa, filosofica,
artistica, e così via,e tuttavia, non potendo sopperire con le proprie risorse alle esigenze dettate dal
compiuto perseguimento degli scopi istituzionali, si avvalgono di iniziative economiche, svolte anche
mediante la creazione di imprese strumentali, dirette a realizzare profitti destinati a sostenere gli scopi
istituzionali.
Sono due processi che appaiono accomunati da valori convergenti. Il primo processo è
volto a consentire agli enti non profit l’esercizio di attività economiche lucrative a sostegno dei propri
fini, e quindi coniuga l’assistenza sociale, il mecenatismo, la beneficenza, la promozione della ricerca
scientifica e della cultura con il profitto economico, e quest’ultimo è considerato in modo
strumentale; la finalità di lucro assume contorni positivi, perché produce risorse rimanendo ferma la
loro destinazione a fini in senso lato “sociali”. Il secondo processo coniuga il profitto economico alla
solidarietà sociale, all’ etica degli affari su cui riposa la corporate social responsibility nei modelli, già
1 Innumerevoli sono i siti web che promuovono la responsabilità sociale delle imprese, testimoniano le
iniziative via via promosse, raccolgono documenti, mozioni, intenzioni: per qualche riferimento v. Fabrica
Ethica, www.fabricaethica.it; RESInwes, www.rsinews.it; WWW.BilancioSociale.it; CSRwire, www.csrwire.com;
si segnalano inoltre le iniziative della Banca Nazionale del Lavoro, della Compagnia di S.Paolo, delle
Fondazioni delle Casse di Risparmio, oltre che, ovviamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
dell’ Unione Europea, DG Lavoro e Affari sociali; i programmi del Ministero sono pubblicati nel denso Progetto
CRS-SC. Il contributo italiano alla campagna di diffusione della CSR in Europa; i programmi dell’ Unione europea sono
esposti nel Libro verde e nella Comunicazione, di cui dirò ( comunque già esposti nella relazione introduttiva di
Giuseppe Conte) nonché, sinteticamente, nel discorso del Commissario responsabile della DG menzionata,
tenuto il 13.12.2002, e pubblicato sul sito dell’ Unione europea. Ulteriori documenti sono offerti da N.E.F., il
Network of European Foundations for Innovative Cooperation (Research Report by Fondazione Fitzcarraldo);
dall’ ICCSR, International Centre for Corporate Social Responsibility (v. il Bulletin-Autum/Winter, 2004) e dal
Corporate Social Responsbility Forum,,, www.pwblf.org. Un particolare impegno nel settore è profuso dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, di cui si v. in particolare l’attività della Commissione Aziende
Non-Profit. Sul versante dlle fondazioni di orgine bancaria v. il periodico Fondazioni, a cura dell’ A.C.R.I.(in
particolare i nn.3-4 maggio/agosto 2004), reperibile sul sito web dell’ ACRI.
sperimentati, di derivazione americana e nei modelli, ancora in fase di definizione, di derivazione
comunitaria; considera pertanto prioritaria la redditività economica ma aggiunge ad essa regole
comportamentali rispettose degli interessi degli stakeholders e dei beni della collettività ed introduce la
possibilità di devoluzione a fini sociali di una percentuale dei profitti, che sono riflessi nei “bilanci
sociali”.
Questi due fenomeni paralleli si intersecano dunque nei valori di riferimento; anzi, vi sono
autori che tendono ad unificare questi fenomeni, a non considerarli distinti tra loro, ma piuttosto ad
assimilarli nella concezione istituzionale dell’impresa: sì che sul primo versante si registrerebbe sul
piano concettuale e sul piano pratico una prossimità notevole tra enti non profit ed imprese lucrative,
l’unica differenza tra queste categorie rimanendo la destinazione degli utili, nei primi a favore della
collettività, nelle seconde a favore dei “soci”; sul secondo versante si registrerebbe una formula
moderna del “capitalismo solidale” [2].
Considerare i due fenomeni come due facce della stessa medaglia oppure due immagini
simmetriche ma capovolte non è solo un’opzione concettuale, ma ben di più: corrisponde a due
visioni - politiche, economiche, sociali ed etiche - tra loro contrapposte. Esse quindi incidono sia
sulla valutazione della normativa destinata agli enti non profit, sia sulla valutazione della normativa
concernente la responsabilità sociale dell’impresa. In senso positivo si esprimono quanti postulano la
formazione di un diritto orientato ai valori [3]; in senso negativo quanti dubitano che il mercato debba
perseguire la tutela dei diritti fondamentali [4] e la tutela di interessi comunque estranei alla
realizzazione del profitto e anche quanti ritengono fumosa e mistificante la concezione stessa di una
responsabilità “sociale” dell’impresa [5].
Tuttavia, se si procede sulla base dei postulati del realismo giuridico - tendenti a considerare
il modo concreto in cui evolve un ordinamento - i valori in gioco appaiono coessenziali sia agli scopi
del legislatore, sia alle manifestazioni dell’ attività giurisdizionale, e quindi intrinseci alla norma,
piuttosto che non appartenenti all’area del meta-diritto. Il fatto che questi valori siano modellati,
proposti, adattati, prendendo corpo in atti ottativi, in direttive, persino in norme – essendo un dato
oggettivo e indiscutibile, come dimostrano il Libro verde elaborato dalla Commissione delle
Comunità europee nel 2001 [6] e la Comunicazione della stessa Commissione del 2002 [7] - esime i
giuristi da ogni valutazione di merito, concentrando piuttosto la loro riflessione sull’incidenza
dispiegata da questi fenomeni sul dato positivo e sui progetti di intervento legislativo in corso di
elaborazione, al fine di tradurre in normative moderne e adeguate le nuove esigenze del “terzo
settore” e dell’ “economia solidale”.
Vorrei dunque esaminare, nella prospettiva aperta dai due fenomeni accennati, tre modelli
normativi, che, proprio nell’unità di indagine, mostrano aspetti tra loro strettamente correlati: (i) le
proposte di riforma del Libro I del codice civile; (ii) la disciplina degli enti lirici; (iii) la disciplina delle
fondazioni bancarie. Per l’appunto questi modelli normativi si uniformano alla concezione che
coniuga i valori del profitto con i valori solidali, esprimendola in forme giuridiche destinate a
disciplinare o in via generale tutti gli enti non lucrativi, o in via speciale gli enti dotati di una
particolare fisionomia. Nell’esperienza italiana l’ iter normativo non ha proceduto (come la logica
2
Nell’ambito dei cultori del diritto commerciale la contrapposizione è netta tra gli Autori che escludono la
finalità lucrativa tra gli elementi essenziali dell’impresa (ad es., Oppo, Realtà giuridica globale dell’impresa
nell’ordinamento italiano, in Riv.dir.civ., 1976,I, p. 591 ss. ) e gli Autori che all’opposto ne sottolineano
l’indefettibilità (ad es., Bonfante e Cottino, L’imprenditore con una Introduzione al Trattato di Gastone Cottino, Padova,
2001, pp. 373, 404,437 ss. ). Ovviamente, il discorso coinvolge la natura delle società consortili, le cooperative,
e, in generale, la stessa concezione di “impresa”.
3 Per tutti v. Mengoni, Diritto e valori, Bologna, 1985; Lipari, Diritto e valori sociali.Legalità condivisa e dignità della
persona, Roma, 2004
4 Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998; Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione.Diritto e diritti nella
società transnazionale, Bologna, 2000; più in generale, P.Grossi, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003
5 Cottino, op.cit.,p. 373 ss.
6 COM (2001) 366 def.
7 COM (2002) 347 def.
sistematica avrebbe richiesto) dal generale al particolare, ma ha seguito il senso inverso, muovendo
dai presupposti e dalle regole di natura speciale per ampliarne ( e generalizzarne) la portata fino a
ricomprendere, nel modo più esteso possibile, gli enti esistenti e futuri che operano nell’ambito del
“terzo settore”.
2. I progetti di riforma del Libro I del codice civile.
In linea del discorso il quadro che si presenta agli occhi del giurista in materia di enti di
diritto privato appare oggi complesso e frammentario.
Come è noto, gli enti di diritto privato sono retti, oltre che da norme di tenore generale,
previste nel codice civile del 1942, da una miriade di leggi speciali, di volta in volta introdotte per
tutelare specifici interessi, ma anche per “liberare” questi enti dalla morsa in cui erano stati incapsulati
nel codice civile, per effetto della concezione autoritaria e sospettosa che ne aveva contrassegnato
l’ingresso nella nuova compilazione. Una morsa frutto al tempo stesso di due preoccupazioni che il
legislatore del 1942 vedeva come prioritarie: evitare ogni ostacolo che di frapponesse tra il cittadino e
lo Stato (come potevano essere gli enti “intermedi”), ed evitare la costituzione della manomorta
(come accadeva per il patrimonio degli enti, riguardanti un complesso di beni sottratto alla
circolazione giuridica).
Il modello originario non poteva reggere alle istanze della società civile. Ma anziché
modificare le regole di tenore generale, il legislatore ha preferito continuare ad alimentare una
normazione farraginosa, frantumata e non coordinata, attraverso interventi di tipo settoriale.
Con interventi successivi, destinati dapprima a consentire alle associazioni di volontariato di
acquistare beni immobili e beni mobili registrati, senza chiedere il riconoscimento della personalità
giuridica, alle Onlus, di poter svolgere attività economica, purché non unica o prevalente, alle
associazioni di promozione sociale, di svolgere attività di natura commerciale, artigianale e agricola, si
è venuta così modificando in modo sensibile sia l’originaria concezione delle associazioni e delle
fondazioni, sia la legislazione di settore, perché ciascun intervento ha eroso i dogmi sui quali erano
costruite le regole del codice, ed ha finito per rifluire addirittura in alcune modificazioni del codice
civile e nella normativa riguardante le procedure di riconoscimento della personalità giuridica.
Il legislatore infatti ha messo in cantiere e approvato altri provvedimenti destinati a istituire le
procedure di riconoscimento della personalità giuridica su base regionale, a sopprimere anche nel
codice civile l’obbligo di chiedere l’autorizzazione all’autorità tutoria per l’acquisto di immobili e
l’accettazione di donazioni, eredità e legati, e a semplificare la procedura per richiedere la personalità
giuridica di diritto statuale. Nel frattempo, la giurisprudenza ha ridisegnato la disciplina delle
associazioni e delle fondazioni: quanto alle prime, ha ammesso l’esercizio di attività economiche
purché non prevalenti su quelle istituzionali e destinate al perseguimento degli scopi di questi enti;
quanto alle seconde, consentendo al fondatore di mantenere un rapporto con l’ente fondato,
attraverso la gestione dell’ente, e definendo più precisamente le categorie delle fondazioni (
fondazioni di famiglia, fondazioni di erogazione, fondazioni di natura sociale, fino ad ammettere le
c.d. fondazioni d’impresa).
La materia è divenuta perciò sempre più complessa, affastellata e di difficile decifrazione.
L’ampliamento e la liberalizzazione dei mercati ha nel contempo consentito di avviare un
processo di privatizzazione che ha interessato gli enti pubblici economici, la RAI, e finanche le
banche di natura pubblica e le casse di risparmio, trasformate in enti conferenti (ora denominati
“fondazioni bancarie”) e in enti conferitari (ora denominati “banche”). Anche altri enti di natura
pubblica sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, come, per es., le casse di previdenza
dei professionisti.
Per sussumere in un quadro sistematico questi fenomeni così eterogenei tra loro la dottrina
ha proceduto su due direttrici.
Da un alto, ha proposto di considerare i modelli originari come archetipi di forme giuridiche;
pertanto, si è rivolta a questi enti con una terminologia che proviene dalla cultura anglo-americana, in
cui essi sono designati come enti “non profit”. Il mutamento di denominazione non è di poco
momento, perché – secondo il precetto medievale per il quale “nomina sunt omina” – l’uso di una
diversa terminologia ha consentito di elaborare nuovi principi. Gli enti non profit infatti possono
svolgere liberamente attività economica per realizzare gli scopi sociali, ma hanno solo l’obbligo di
non distribuire gli utili tra fondatori, amministratori e associati, e di reinvestirli nella gestione della
loro attività. Nell’ambito della categoria si distinguono poi enti che perseguono finalità per così dire
“interne”, destinate ad avvantaggiare solo soggetti dotati di un particolare status, enti che perseguono
finalità per così dire “esterne”,destinate ad intere collettività ( di varia dimensione), ed enti che
perseguono finalità miste.
Dall’altro lato, ha proceduto a progettare modelli alternativi, più consoni alle esigenze di una
società dinamica e orientata al mercato, con ampi poteri di autonomia.
In questo senso si sono mossi i programmi degli ultimi governi.
Le proposte di riforma sono molteplici, ma in particolare si possono segnalare tre iniziative.
Qualche anno fa, presso il Ministero degli Affari Sociali, retto in allora da Livia Turco, era
stata costituita una commissione di giuristi ed economisti, presieduta da Pietro Rescigno ( a cui ho
partecipato con Nicolò Lipari e Andrea Zoppini ), per la revisione del Libro I del codice civile.
L’intendimento era innanzitutto di uniformare e chiarire la disciplina delle associazioni e delle
fondazioni; poi di effettuare un inventario delle organizzazioni di tipo personale che negli anni si
erano moltiplicate in modo impressionante in Italia, anche sotto l’influsso di mode culturali,
parareligiose, etc., a cui si voleva assegnare una disciplina precisa e funzionale ai loro scopi; infine, di
rendere più libera l’attività, riducendo e semplificando i controlli.
Presso il Ministero della Giustizia, nel medesimo periodo, era stata costituita una
commissione per la riforma del L.V del codice civile, sotto la presidenza del sottosegretario Antonino
Mirone e il coordinamento di Luigi Rovelli. Si era avvertito infatti che non era possibile riformare la
disciplina dell’impresa e delle società, senza provvedere anche al coordinamento di questa disciplina
con quella prevista dal L.I; ed infatti, la perspicua relazione conclusiva predisposta da Luigi Rovelli
reca un capitolo sugli enti-non profit. Molte delle idee espresse da quel gruppo di lavoro ( di cui
facevo parte insieme con Bartolomeo Quatraro, Enzo Roppo, Giovanna Visintini, per la parte
relativa al settore non profit) sono state poi riprese dalla commissione di riforma delle società,
coordinata dal Sottosegretario Michele Vietti, e sfociata nel testo oggi vigente.
Tra l’altro è da segnalare che anche nell’ambito dell’attività societaria si è dato spazio ai
contatti con la disciplina degli enti non profit, quanto meno mediante la trasformazione eterogenea di
società in fondazioni.
Anche la disciplina delle fondazioni si è ammodernata, consentendo a questo tipo di enti di
avvalersi di imprese. Insomma, l’idea di una “fondazione-impresa”, un tempo considerata quasi un
ossimoro, oggi è accettata senza particolari preoccupazioni. E’ ovvio che se l’ente svolge attività
economica e non gode di un regime speciale, sarà assoggettato al fallimento in caso di insolvenza. Ma
non vi sono più preclusioni, né si possono nutrire avversioni, verso enti che, pur non avendo lo
scopo di lucro come proprio fine istituzionale, possano liberamente svolgere attività economica
lucrativa, purché i proventi non siano ripartiti tra coloro che hanno collaborato, in modo associato,
alla loro produzione.
Le proposte scaturite dai lavori delle due commissioni, tuttavia, non hanno avuto un esito
concreto.
Maggior fortuna potrebbe avere una nuova proposta, al momento non ancora fatta propria
dal Governo in carica, elaborata da un gruppo di studiosi, di cui fanno parte Giovanni Iudica, Mario
Nuzzo e Andrea Zoppini.
La proposta, destinata a riformulare solo una sezione del L.I del codice civile, riguardante gli
enti non profit, prevede tra l’altro l’esclusione di ogni intervento pubblico per tutti gli enti, anche
quando perseguano scopi di pubblica utilità; assegna a questi enti piena capacità giuridica, libertà
organizzativa e gestionale, senza quindi apporre limitazioni allo statuto e all’organizzazione interna, e
al tempo stesso, impone doveri di trasparenza nella gestione e regole sulla responsabilità degli
amministratori. Per gli enti di grandi dimensioni prevede anche la vigilanza di una autorità esterna,
non più di natura governativa, ma autonoma, cioè una vera e propria “authority”.
Il Governo, nel corso della passata legislatura, aveva progettato una disciplina unitaria di
tutte le formazioni (associative o di natura patrimoniale) che svolgono attività di natura sociale e per
imprimere loro un carattere più efficiente, le sta ridisegnando come “imprese sociali”, ma non è
prevista la redazione di un testo unico che raccolga e coordini la frammentaria normativa.
In ambito comunitario si possono rinvenire linee di tendenza, progetti e iniziative che
riguardano in generale le fondazioni.
Sinteticamente, va la pena di richiamare alcuni documenti comunitari e fare cenno alle
iniziative delle organizzazione delle fondazioni a livello europeo.
Nella Comunicazione della Commissione sulla “promozione del ruolo delle associazioni e
delle fondazioni” (COM 97, 241 def.) si prende atto che le fondazioni, rispetto alle associazioni,
costituiscono un gruppo più omogeneo, perché possono essere ripartite in due categorie, a seconda
che esse abbiano scopi privati oppure scopi pubblici. Si considerano poi solo le fondazioni che pur
svolgendo finalità pubbliche, sono indipendenti dallo Stato o da altri poteri pubblici, e sono gestite da
consigli di amministrazione indipendenti o da amministratori fiduciari. La Comunicazione prende
atto della varietà notevole dei modelli giuridici a cui sono assoggettate le fondazioni nei diversi
ordinamenti nazionali – tanto è vero che in sede comunitaria si è proposto uno statuto uniforme per
le associazioni, ma non per le fondazioni. E prende atto altresì dell’importanza nella vita economica
ormai rivestita da questi enti: per esempio, all’epoca della pubblicazione del documento (1999) in
Italia risultava impiegato nel settore quasi il 2% degli occupati, in Francia e nel Regno Unito la
percentuale saliva al 4, ma il trend era in crescita.La Commissione sottolinea il ruolo sociale e politico
di questi enti, ma anche il fatto che la loro attività comincia ad avere un raggio transnazionale. Di qui
l’invito a richiedere i finanziamenti europei, a presentare progetti, ad incentivare la rete informativa e i
collegamenti interni, insomma a rafforzare l’attività di tipo “orizzontale”.
Per parte sua il Comitato economico e sociale, in un parere reso alla Commissione sul tema (
98/C95/20) sottolinea come questi enti debbano avere una struttura democratica, e svolgere attività
di pubblica utilità, operando comunque senza fini di lucro; sottolinea come le 100.000 fondazioni
esistenti ( nel 1997, secondo le stime del European Foundation Centre) dispongono di cospicue
risorse da destinare agli scopi sociali e ad impiegare forza lavoro; per questo, da un lato il Comitato
invita gli enti a promuovere la loro attività economica in modo efficiente, e dall’altro a profittare dei
finanziamenti acquisibili dalla Commissione e impegna la Commissione stessa a creare un fondo
speciale per sostenere le fondazioni che operano a livello transnazionale.
A sua volta la Corte di Giustizia, in alcune sentenze, ha accentuato il profilo imprenditoriale
delle associazioni e delle fondazioni. Ad es., nel caso Hoefner (23.4.1991, C-41/90) ha stabilito che un
ufficio pubblico per l’occupazione che svolge attività di collocamento è considerato un’impresa; nel
caso Balthuis-Griffioen (11.8.1995, C-453/93) ha stabilito che un imprenditore persona fisica che aveva
istituito un asilo nido non può considerarsi ente pubblico; nel caso Sodemare (17.6.1997) ha
considerato impresa assoggettata alle regole di concorrenza una residenza per anziani; nel caso Pavel
Pavlov (12.9.2000) anche un fondo pensionistico costituito in forma di fondazione è stato considerato
impresa.
L’attenzione riservata alle fondazioni in ambito comunitario è giustificata dal fatto che le
indagini degli economisti registrano una crescita costante di questo settore in ogni Paese, che si
accompagna ad una presenza sempre più insidiosa e concorrenziale sul mercato a fianco delle
imprese rivolte al profitto.
Ma ormai occorre guardare a questo fenomeno in un quadro più vasto, dal momento che
esso è investito dalla globalizzazione dei mercati. E’ stato questo il tema discusso alla assemblea e alla
conferenza annuali del Eurpean Foundation Centre, tenutesi a Lisbona nel giugno del 2003. Non a
caso si è trattato di responsabilità sociale dell’impresa, di diritti umani, di ruolo delle fondazioni nella
promozione della cultura, nella alimentazione della filantropia e nella diffusione del benessere.
Insomma, le comunità intermedie stanno recuperando un ruolo essenziale nell’attività sociale
e nell’attività economica, ma esse appaiono sempre più rilevanti anche per preservare i valori della
democrazia nell’Occidente. Il che postula un rapido adeguamento della loro disciplina, possibilmente
in ambito comunitario, ma, già fin d’ora in ambito nazionale. Gli stereotipi del codice civile debbono
ormai essere abbandonati, perché la realtà richiede una svolta radicale, procedendo spedita verso
modelli diametralmente opposti a quello accolto nel 1942.
I dati emergenti dalle ricerche indicano infatti che negli Stati Uniti prevalgono le
organizzazioni che perseguono il public benefit (75%) rispetto a quelle che perseguono il mutual benefit;
che il numero delle organizzazioni non proft erano 1.600.000, con un fatturato di 600 miliardi di
dollari; che i finanziamenti derivavano per il 36% da erogazioni statali, per il 64% da erogazioni di
privati ( di cui il 54% per prestazioni di servizi); che il tasso di crescita (del 107%) superava il PIL (del
64%). Mentre nell’esperienza italiana i modelli associativi prevalevano su quelli fondazionali, che il
numero degli enti non profit ammontava a circa 221.000 unità, di cui l’ 88,5 % costituite negli ultimi
venti anni, e il 55,2% negli ultimi dieci anni, con un fatturato di 34 miliardi di euro, che i
finanziamenti si dovevano prevalentemente ai privati (per l’84%) [8].
3. Le fondazioni bancarie
Un discorso più articolato meritano le fondazioni di origine bancaria, che, nel contesto qui
considerato, offrono, se possibile, un esempio ancor più significativo degli enti lirici, perché appaiono
modellate, oggi, sull’archetipo dell’ ente non proft, e tuttavia operano in un ambito economico, come
quello bancario, che costituisce uno dei pilastri del sistema imprenditoriale di mode culturali,
parareligiose, etc., a cui si voleva assegnare una disciplina precisa e funzionale ai loro scopi; infine, di
rendere più libera l’attività, riducendo e semplificando i controlli.
Come è noto, le c.d. fondazioni bancarie sono state oggetto di ripetuti interventi normativi,
di vicende giudiziarie celebrate dinanzi ai giudici amministrativi e dinanzi alla Corte costituzione
inerenti la loro natura e l’ambito della loro autonomia, nonché di una ripetuta regolamentazione di
ambito amministrativo [9]. Il complesso di queste regole, articolate secondo la gerarchia delle fonti,
non è tuttavia sufficiente a completare un modello organico di disciplina. Ricorrendo alla tecnica
dell’interpretazione estensiva e della interpretazione analogica, e cercando di “colmare le lacune” delle
regole ad esse destinate, è necessario ricorrere alle disposizioni del Libro I del codice civile.
La sintetica ricostruzione della disciplina in esame [10] prescinde da un esame dettagliato dei
8
Maggio, Non profi, l’esempio USA, ne Il Sole 24 Ore, 5.11.2001 n. 305, p. 7
Ex multis,v. P. RESCIGNO, La fondazione ed i gruppi bancari, in Banca, impr. soc, 1992, II, pag. 389 e ss.;
COSTI, La riforma delle fondazioni bancarie, in Studi in onore di Pietro Rescigno, vol II, Milano 1998, II, pag.
227 e ss.; GENTILI, La riforma delle fondazioni di origine bancaria, in Riv. dir. civ. 1999, II, pag. 399 e ss.;
AA.VV., Le «Fondazioni» bancarie, dalla legge n. 218/90 al D.Lgs. n. 153/1999, a cura di Sandro Amorosino e
Francesco Capriglione, Cedam, 1999.
10 L’annosa vicenda prende le mosse dalla c.d. «legge Amato» (L. 30 luglio 1990, n. 218) che ha avviato la
disciplina di riforma delle casse di risparmio e dal decreto legislativo di attuazione (D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356) in cui si sono configurati due enti: gli enti conferenti e gli enti conferitari dell’azienda bancaria; gli enti
conferenti sono definiti dal d.lgs.cit. «persone giuridiche private senza fini di lucro dotate di piena autonomia
statutaria e gestionale» riconoscendo, quindi, ad essi soggettività giuridica. Con il d.l. 1994, n. 332 e, in
particolare, con la «direttiva Dini» del 18 novembre 1994 si è auspicata la promozione e l’accelerazione del
processo di dismissione della proprietà delle banche da parte degli enti conferenti, ribadendosi, tra l’altro, il
vincolo di destinazione dei proventi a fini di “interesse pubblico e di utilità sociale”. Di poi, la l. n. 461/1998
(c.d. «legge Ciampi») ed il d.lgs. n. 153/1999, nel disegnare un insieme di incentivi e di disincentivi per indurre
la graduale uscita degli enti conferenti dagli assetti proprietari delle banche, hanno delineato l’attività degli enti
conferenti, considerati come enti di diritto privato, operanti nel settore non profit. La l. finanziaria per il 2003 (n.
289 del 2002) ha introdotto la distinzione tra fondazioni con patrimonio non superiore a duecento milioni di
euro e le altre fondazioni, incidendo tale distinzione sugli obblighi di dismissione del controllo degli enti
conferitari. Il d.l. 24.6.2003 e la l. di conversione n. 212 del 2003 sono ulteriormente intervenuti sugli obblighi
di dismissione. Il d.l. 30.9.2003 n. 269, coordinato con la l.di conversione n. 326 del 2003 sono intervenuti sui
settori rilevanti.
Infine, la l.finanziaria per il 2004 ( n. 350 del 2003) ha introdotto nuove norme sulle incompatibilità dei
componenti degli organi delle fondazioni bancarie e il d.m. 18.4.2004,n. 150 ha riformulato la disciplina
attuativa dell’art. 11 della l. n. 448 del 2001.
9
contenuti dei provvedimenti citati, atteso che i problemi oggi rimasti aperti discendono proprio dalla
incompleta e inesatta formulazione delle disposizioni. In ogni caso si è in presenza di una disciplina
che ha natura speciale. Dal momento in cui gli enti conferenti hanno ricevuto la denominazione di
fondazioni (ancorché di origine bancaria, e a diritto speciale) – e cioè ben dieci anni dopo l’avvio della
vicenda - si è aperto il problema se tale denominazione volesse anche alludere alla inclusione di tali
enti nella categoria delle fondazioni, e quindi indicarne anche l’assoggettamento alla disciplina
generale dettata per le fondazioni nel Libro I del codice civile.
Dapprima gli orientamenti dottrinali sono stati tutt’altro che univoci, propendendo un
indirizzo per l’esclusione delle fondazioni bancarie dal novero delle fondazioni tout court, e altro
indirizzo per la loro inclusione, derivandone quindi l’applicazione, in forma residuale, delle regole di
tenore generale rispetto alle regole di tenore speciale.
Per risolvere la questione, inerente dunque, alle regole applicabili secondo un ordine
sistematico, alle “fondazioni bancarie”, è necessario ripercorrere l’iter (normativo e giurisprudenziale)
proprio con riguardo alle denominazioni utilizzate, che sono strettamente connesse con la
qualificazione di questi enti e quindi con la disciplina ad essi oggi applicabile.
Fin dal loro ingresso nel mondo del diritto (con la l.n.218 del 1990 e relativo d.lgs. n.356 del
1990) gli enti residuati dallo scorporo delle aziende o dei rami di azienda bancari dagli enti pubblici
creditizi o dalle casse di risparmio hanno posto problemi di nomenclatura: in modo formale, il
legislatore li ha denominati “enti conferenti”, in quanto a tali enti si faceva obbligo di trasferire
l’azienda bancaria alle società per azioni create ad hoc; si pone cioè attenzione all’operazione più
significativa che consiste per l’appunto nello scorporo; come si è detto, già dall’epoca in cui la riforma
“Amato” è stata introdotta, parte della dottrina, tenendo conto del fatto che tali enti svolgevano
anche attività di natura solidaristica e che amministravano un patrimonio (ancorché singolare,
essendo costituito da un’azienda bancaria) da cui traevano alimento per raggiungere anche i loro fini
sociali istituzionali, ha impiegato l’espressione di “fondazione”. Ma non si è trattato di un
orientamento uniforme: a quanti facevano impiego del termine senza frapporre dubbi, si sono
contrapposti coloro che premevano sulla distinzione, nel genere fondazione, della specie di
fondazione bancaria, e quindi denominavano questi enti “fondazioni di origine bancaria”, e altri
ancora che hanno usato l’espressione sottolineandone l’improprietà semantica, e quindi si sono
riferiti a questi enti come alle “c.d. fondazioni bancarie”.
Con la l. n. 461 del 1998 (c.d. legge “Ciampi”) e il d. lgs. n. 153 del 1999 gli enti conferenti
hanno assunto la denominazione di fondazioni; hanno continuato per un verso a conservare la loro
denominazione originaria, ma per altro verso, specie nella formulazione dei titoli della legge, hanno
cominciato ad essere denominate fondazioni ed hanno cambiato natura: il legislatore ha attribuito
loro la natura di persone giuridiche private senza fine di lucro (art.2 c.1). La terminologia oggi usata, di
fondazioni di origine bancaria, originariamente era solo di natura dottrinale e giurisprudenziale; e non era
neutra, anzi perché preludeva dapprima con assonanze, poi con assimilazioni, infine con
classificazioni alla sottrazione di questi enti dall’ambito del diritto pubblico per collocarli nell’ambito
del diritto privato, e, all’interno di questo, neil lla categoria degli enti non profit del genere
“fondazioni”.
Pertanto il settore giuridico entro il quale si collocano questi enti non può che essere il diritto
comune: lo sottolineano anche il titolo I che allude al “regime civilistico delle fondazioni”, e il titolo II,
sul regime fiscale delle fondazioni, risolvendosi così la diatriba sulla natura pubblicistica o privatistica
di questi enti dotati di una doppia personalità (v. l’art.11 c.2 del d.lgs. n.356 del 1990) nei confronti
della quale si era scagliata la dottrina, bollando la soluzione legislativa come una finzione. Per la
denominazione, invece, l’espressione usata dal legislatore non è vincolante, anche se può essere
orientativa. Non mancano esempi eclatanti della libertà dell’interprete con riguardo alle qualificazioni
ex lege di atti o di enti: basti pensare all’autorizzazione all’edificazione che con la l. n.10 del 1977
aveva assunto la denominazione di “concessione” e che la giurisprudenza amministrativa ben presto
ha riconvertito nella vecchia licenza edilizia.
Sulla base di queste premesse, si è sviluppata la vicenda normativa e il dibattito dottrinale
maturati negli ultimi anni, perché da questi due percorsi, che spesso si intrecciano, si possono
desumere elementi per chiarire se si sia in presenza di enti appartenenti al genus fondazione oppure
ad enti che, denominati “fondazioni” presentino una disciplina così peculiare da essere per la quasi
totalità incompatibile con la disciplina generale contenuta nel codice civile (o ricostruita da dottrina e
giurisprudenza sulla base del codice civile).
Per un verso, come si è anticipato, si è attratta nell’area semantica, normativa e operativa
delle fondazioni la categoria degli enti conferenti: il legislatore aveva evitato la specifica terminologia
e sono stati gli interpreti ad usare il termine tecnicamente più esatto per definire un fenomeno in cui
l’esistenza di un fondo di dotazione e la mancanza di struttura associativa riconducono (e l’esito del
discorso è pienamente giustificato) allo schema della fondazione [discorso che vale anche per le
fondazioni a struttura “associativa”, con le peculiarità che comporta tale forma giuridica]. E per
l’appunto nella fondazione-impresa (meglio, nella fondazione titolare di una o più imprese strumentali) si
è ravvisata la forma giuridica più consona o adeguata a quella degli enti conferenti.
Per altro verso, proprio perché tali enti conservavano originariamente, accanto alla
personalità di diritto privato, la personalità di diritto pubblico, ed erano dai più considerati enti
pubblici, si sono prese le distanze dalla qualificazione in termini di fondazione; fondazione peraltro
titolare della totalità delle azioni di una s.p.a., e quindi, non meritevole - per altri autorevoli studiosi di questo appellativo, ma piuttosto di quello di “pseudofondazione”.
La storia della legislazione in materia documentava, secondo la dottrina di diritto pubblico e
di diritto bancario, la natura pubblicistica degli enti in esame. Ma ad essa si faceva osservare che l’ente
pubblico è tale in quanto ha potestà d’imperio, capacità che faceva certamente difetto a quegli enti.
La reticenza del legislatore ad utilizzare l’espressione “fondazione” era giustificata con il fatto
che non tutti gli enti di quell’universo variegato che racchiudeva antichi monti di pietà, casse agricole,
associazioni di beneficenza, e così via aveva tratto origine dalla entificazione di un patrimonio, ma
molti avevano una origine nell’aggregazione di persone fisiche tra loro associate. Lo scrupolo
terminologico che aveva fatto rifugiare il legislatore in una dizione neutra come quella di enti
conferenti è stato fugato dalla osservazione che l’ascrizione al tipo ideale della fondazione non è
condizionata dall’aggregazione di persone, quanto piuttosto da un altro carattere, che si intravedeva
negli enti originari, cioè nello scopo sociale inderogabile e indisponibile rispetto al potere decisionale
delle persone che comparivano come associate.
In altri termini, secondo le categorie generali, l’autonomia privata che si affidi alle forme
giuridiche della fondazione soffre di limitazioni “che non hanno, per contro, ragion d’essere in
rapporto alle organizzazioni di tipo associativo, caratterizzate dagli opposti principi della
modificabilità, per deliberazione degli associati, dello scopo originario e della risolubilità, ad arbitrio
degli stessi associati, del vincolo associativo” e l’ammissibilità nell’ordinamento della fondazione è
dovuta “solo in presenza di uno scopo di pubblica utilità”. Si è poi aggiunto che i soci (o associati)
non erano i destinatari dei risultati dell’attività dell’ente, come normalmente accade per le
associazioni.
Stante
quindi
la
binarietà
delle
categorie
(istituzioni/corporazioni,
fondazioni/associazioni) se gli enti non ricadevano nella categoria delle corporazioni-associazioni,
dovevano necessariamente rifluire in quella delle istituzioni-fondazioni.
Senonché, la reticenza del legislatore non ha impedito che autorevoli fonti avessero
anticipato la qualificazione di fondazione ( v. l’obiter dictum contenuto nella sentenza della Corte
cost. 16.12.1993,n.440). Termine poi effettivamente entrato nel linguaggio normativo “di soppiatto”,
nel contesto delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 3 c.189 lett.a) della l.
23.12.1996, n.662).
Ora, il testo dei provvedimenti del 1998 e del 1999 hanno proceduto in un modo per così
dire compromissorio: hanno fatto impiego dell’espressione “fondazione” ma hanno mantenuto del
modello tradizionale o, come si dice, del tipo ideale ben poche caratteristiche, in quanto al nomen iuris
non corrispondono tutti i contenuti sostanziali che esso evoca. Ciò perché: gli scopi istituzionali
previsti negli statuti non sono espressione della libera autonomia privata, ma debbono essere
ricondotti ai settori espressamente tipizzati, anche se in modo generico, dalle disposizioni di apertura
del d.lgs.cit. (art.1, lett.d) e art.2 c.2); l’assetto organizzativo è imposto per legge ed è integrato da un
organo di indirizzo e da un organo di controllo (art.4); la composizione del patrimonio e la
destinazione del reddito, oltre che i criteri di amministrazione e gestione, sono definiti ex lege (artt.59); per non parlare poi della vigilanza (art.11) e delle altre disposizioni che riguardano materie più
specifiche (artt.12-29).
Tutte previsioni che risultano estranee alla disciplina di diritto comune delle fondazioni e che
confliggono con una autonomia statutaria e gestionale di cui le fondazioni ordinarie sono dotate. Il
fatto che il d.lgs.cit. riconosca agli enti conferenti una autonomia statutaria e gestionale “piena” (art.2
c.1) non deve trarre in inganno: queste limitazioni danno luogo ad una conformazione che attribuisce
agli enti una fisionomia loro propria che li allontana di molto dalla figura tradizionale di fondazione.
Pertanto, ancora nel 1999 la dottrina era incerta sulla configurazione giuridica di tali enti.
Tanto è vero che, secondo taluno, “la legge ha creato un fatto, le fondazioni bancarie, ma ha
sostanzialmente mancato di fissarne un modello”, enunciazione rafforzata dall’esame della nuova
normativa che, “anziché realizzare, ha tradito la nozione tradizionale di fondazione”.
La compatibilità degli scopi legislativi (prima ancora che delle disposizioni ora introdotte)
con il modello ideale di fondazione appare essere, allora, un falso problema: si tratta certo di enti di
natura privata, ma a statuto normativo rigido.
Una prima giustificazione potrebbe esser tratta dalla storia complessiva di questi enti. Nel
nostro caso, gli enti conferenti derivano da altri enti (e ne costituiscono la trasformazione) che
assolvevano un ruolo rilevante nel settore bancario.
Nella disciplina transitoria questi enti possono ancor orbitare nell’ambito bancario, ma de
futuro ne saranno completamente estromessi.
In ogni caso, non possono più esercitare direttamente l’attività bancaria né alcuna attività di
finanziamento a imprese, tranne le eccezioni fissate dall’art.3 c.2 del decreto. Possono però
mantenere rilevanti partecipazioni in imprese bancarie (sempre però minoritarie). Il legislatore
dunque ha voluto disciplinare questa presenza controllando sia gli scopi, sia gli statuti, sia gli organi,
sia l'amministrazione e la gestione di questi enti, attesa la loro rilevanza economico-sociale.
Il legislatore ha voluto inoltre introdurre le limitazioni all’autonomia privata che si sono
enumerate per rafforzare l’osservanza degli scopi statutari. In questo senso, le regole sulla
organizzazione interna, in particolare con la introduzione dell'organo di indirizzo, le regole sulla
amministrazione e gestione, le regole sulle dismissioni e sui reinvestimenti, le regole sulla contabilità e
sulla vigilanza sono funzionali al controllo sul perseguimento degli scopi istituzionali. L’applicazione
delle regole di diritto comune non avrebbero assicurato di per sé la realizzazione puntuale degli scopi
istituzionali, né la destinazione del patrimonio agli scopi istituzionali.
Sul piano della legittimità costituzionale queste regole “dirigistiche” non trovano
fondamento nell’art.41 c.2 Cost., perché le fondazioni bancarie non fanno parte del sistema bancario,
perché non svolgono esclusivamente attività economica privata, perché possono essere titolari di
imprese strumentali e partecipare a cooperative sociali ma solo nei limiti fissati, perché la loro attività
è orientata a fini di utilità sociale. Possono però trovare fondamento nell’art. 42 c.2 Cost., in quanto la
titolarità di ingenti patrimoni aventi l’origine storica e bancaria di cui si è detto giustificano
l’intervento del legislatore sulla base della clausola della funzione sociale della proprietà privata. La
funzione sociale della proprietà - cioè della titolarità del patrimonio (inteso in senso dinamico) avrebbe una duplice giustificazione: la destinazione originaria dei bei (o cespiti) e la destinazione a fini
sociali conseguenti alla antica origine pubblicistica degli enti.
Si tratta anche per questo di una disciplina speciale, che contraddistingue questi enti speciali.
E la specificità – se si vuole – l’eccezionalità che contrassegna l’odierna disciplina è ulteriormente
confermata dal fatto che per il futuro non si potranno costituire nuove fondazioni bancarie.
I problemi di conformità al dettato costituzionale sono sorti allora per altro verso.
La conformazione degli enti con imposizioni eccessivamente costrittive della autonomia privata
incidono sui diritti soggettivi riconosciuti agli enti privati.
Poiché il legislatore ha mantenuto ferma la disposizione secondo la quale le fondazioni
bancarie sono “persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e
gestionale” (art.2 c.1 d.lgs. 17.5.1999,n. 153; e che questo assunto non è stato modificato dai
successive interventi modificativi ed è stato confermato dalle sentenze della Corte cost. del
29.9.2003,nn. 300 e 301, è ormai orientamento consolidato della dottrina ritenere che, nella parte
residuale, siano applicabili le disposizioni del codice civile. Questa conclusione è avvalorata dalle
sentenze della Corte cost. più volte richiamate.
Ed infatti con la sentenza n. 300 del 2003 la Corte ha indicato come settore dell’ordinamento
a cui pertengono le fondazioni bancarie quello definito in termini di ordinamento civile, settore riservato
alla disciplina statuale e sottratto alla disciplina regionale (ex art. 117 Cost.); inoltre ha stabilito che le
fondazioni di origine bancaria non appartengono più all’ordinamento creditizio ( modificando quindi
le proprie precedenti statuizioni, fondate sulla disciplina abrogata, di cui alle sentenze nn. 341 e 342
del 2001); ed ha chiarito come debba essere inteso l’art.2 del d.lgs. n. 153 del 1999, nel senso che
questi enti sono “fondazioni-persone giuridiche private (…) indipendentemente dall’eventuale
perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni
particolari, accanto all’esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli
scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti”.
Ancora. Con la sentenza n. 301 del 2003 la Corte cost.ha ribadito quanto sopra ed in più ha
precisato che “deve escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni”.
In conclusione, si è in presenza di enti di natura privata, a regime speciale, a cui si applicano, là
dove la disciplina speciale sia lacunosa, le regole che l’ordinamento destina agli enti di diritto privato,
primieramente nel codice civile, al Libro I.
Ma si deve comunque sottolineare che, stando così le cose, questi enti conservano una natura
ibrida e la complessa ricostruzione del quadro normativo sopra richiamato presuppone una attenzione
particolare dell’interprete, che ne attenua la responsabilità dal punto di vista della conoscenza
approfondita del precetto normativo [11]. I ripetuti interventi della Corte costituzionale in materia
denunciano anche la non perfetta configurazione della normativa e la sua sostanziale precarietà, che
mina il principio della certezza del diritto. La dottrina si è espressa al riguardo con osservazioni
critiche, definendo la vicenda come “una strana vicenda legislativa” [12].
L’autonomia della gestione, che deve essere effettuata secondo principi di economicità,
risponde anche alla logica della responsabilità: se l’organo di indirizzo si ingerisse della gestione, o i
suoi indirizzi fossero così specifici da ordinare all’organo amministrativo i singoli atti da compiere,
non sarebbe poi in grado di verificare i risultati della gestione, sindacare l’operato dell’organo di
indirizzo, promuovere l’azione di responsabilità nei confronti di esso i di taluni suoi membri,
nominare e revocare i componenti dell’organo di amministrazione. Ecco perché, pur con termini
generici, la normativa parla di programmi, di obiettivi, di definizione delle linee generali della gestione
e della politica degli investimenti.
Tuttavia, il d.lgs. del 1999 contiene i poteri dell’Autorità di Vigilanza che invece le sono
attribuiti dall’art. 25 cod.civ. L’art.10 c.1 lett.j) dispone che – fino al momento in cui non entrerà in
vigore la nuova disciplina dell’autorità di controllo di cui al tit.II del Libro I del cod.civ., la vigilanza è
attribuita al Ministero del Tesoro. E i poteri del Ministero risultato ridotti rispetto a quelli fissati
dall’art. 25 cod.civ. Essendo prevista una specifica normazione al riguardo, è difficile poter sostenere
che, al di là dei casi previsti dal d.lgs. cit., il Ministero (quale Autorità di vigilanza) possa attribuirsi ed
esercitare i poteri attributi all’autorità di vigilanza dall’art. 25 cod.civ. La legge speciale - cioè l’art. 10
c.1 lett.j) prevede solo poteri sostitutivi (anche su segnalazione dell’organo di controllo, inteso nella
sua totalità deliberativa, anche se a sola maggioranza) per il compimento degli atti previsti dall’art. 4
c.1 lett.j).
11
12
v. Gentili, La riforma delle fondazioni di origine bancaria, in Riv.dir.civ., 1999, II, p. 399 ss
Oppo, Ancora sulle fondazioni (ex)bancarie, in Riv.dir.civ., 1999, II, p. 561.
II
Il labirinto giudiziario del caso Parmalat
1. Un quadro complesso di informazioni e una bussola per orientare i giuristi.
I mezzi di comunicazione di massa, i quotidiani economici e i siti Internet delle associazioni
dei consumatori e dei risparmiatori nonché i siti di contenuto giuridico hanno provveduto ad
informare il pubblico delle vicende riguardanti il “caso Parmalat”. Un pubblico attento, costituito non
solo dai risparmiatori che avevano investito in titoli emessi dalle società del gruppo, ma anche da
coloro che – presa coscienza dei rischi offerti dal mercato finanziario – intendono fare del “caso
Parmalat” un fenomeno da studiare per prevenire quanto più è possibile i rischi degli investimenti
finanziari. Per quanto mi riguarda, mi colloco in quest’ultima categoria, non avendo assunto
professionalmente né le difese dei risparmiatori, né le difese del gruppo, né le difese dei singoli
operatori all’interno del gruppo, né le difese del commissario straordinario nominato per la gestione
del gruppo. Ho avuto modo però di seguire le procedure conciliative tra risparmiatori e banche per
altri titoli in default, ed ho potuto così comprendere meglio sia alcune dinamiche del mercato
finanziario, sia alcune situazioni in cui si sono trovati gli investitori non professionali, cioè i
risparmiatori.
Mi preme allora subito precisare che – con riguardo ai titoli relativi al “gruppo Parmalat” – i
risparmiatori (non istituzionali) si possono distinguere almeno in tre diverse categorie, a seconda della
situazione in cui versavano al momento del “crack”. Coloro che avevano acquistato titoli Parmalat
molto tempo prima che si diffondessero notizie sulle difficoltà economiche in cui cominciava a
trovarsi il gruppo; questa categoria di risparmiatori a sua volta si distingue in soggetti che avevano
dichiarato all’ intermediario una propensione al rischio, oppure soggetti che nulla avevano dichiarato;
in soggetti che davano ordini diretti per l’acquisto dei titoli e soggetti che si rimettevano alla
professionalità dell’intermediario per la gestione del proprio patrimonio. Coloro che hanno acquistato
dopo la diffusione di queste notizie, e che quindi hanno voluto speculare sul titolo. Coloro che non
hanno acquistato volontariamente, ma hanno trovato sul proprio conto l’acquisto di titoli Parmalat,
in virtù di operazioni effettuate dalla banca o dalla società di investimenti di cui erano clienti.
Ciascuna di queste categorie riceve una tutela differenziata, a seconda che si possa dimostrare
il grado di conoscenza della situazione in cui versava il titolo e l’intenzionalità del suo acquisto.
A loro volta gli operatori finanziari hanno provveduto a collocare titoli Parmalat per tutto il
periodo in cui sul titolo non si erano ancora diffuse notizie allarmanti; qualche operatore però ha
continuato a trattare il titolo anche nel periodo successivo, acquistandolo per i clienti, previo loro
ordine o senza ordine, perché la mediazione era vantaggiosa, o, peggio, vendendo ai clienti titoli del
proprio patrimonio,al fine di sottrarsi alla perdita di valore del titolo “scaricandolo” sul patrimonio
altrui. Anche per gli intermediari dunque occorre fare distinzioni, in ordine alla loro responsabilità.
Ciò per quanto riguarda il rapporto tra il risparmiatore e l’intermediario.
Ma, ovviamente, vi sono rapporti che stanno “a monte” e “a valle” di questi. A monte sta il
“labirinto delle finanziarie di Collecchio”, come si è espresso il giornale finanziario italiano più letto e
prestigioso, “Il Sole 24 Ore”, che ha pubblicato un organigramma del gruppo al momento del crollo
finanziario, in cui campeggiano le società off shore.
In collegamento con il gruppo si debbono poi segnalare le banche finanziatrici, italiane e
straniere, delle quali si sta indagando il grado di consapevolezza della instabilità del gruppo, e le
società di revisione che si sono succedute nel controllo delle società del gruppo. A valle si collocano:
le vicende giudiziarie di natura penale, a carico degli amministratori del gruppo, dei revisori e delle
banche finanziatrici, in cui si sono costituiti come “parte civile” i risparmiatori danneggiati e le loro
associazioni; le vicende che riguardano il gruppo in sé, assoggettato alla disciplina del risanamento
delle grandi imprese in crisi, affidata ad un “commissario straordinario”; il fallimento di alcune società
operative del gruppo e l’insinuazione nel passivo dei creditori (compresi i risparmiatori); la sorte dei
dipendenti, che pone questioni sociali di non poco momento; la sorte dei titoli della “nuova
Parmalat”, la società costituita come risultato del risanamento del gruppo; la responsabilità civile delle
banche finanziatrici del gruppo, italiane e straniere; la eventuale responsabilità della Consob,
l’Autorità amministrativa di vigilanza del mercato finanziario, per omesso controllo dei bilanci e dei
prospetti del gruppo; la sorte dei procedimenti pendenti negli U.S.A., promossi in forma di class action,
da parte degli investitori colà residenti; la sorte delle altre società del gruppo sparse in altri continenti.
Al labirinto finanziario costruito da una società originariamente a conduzione familiare,
operativa nel settore lattiero, stimata per l’eccellenza dei prodotti alimentari, poi travolta dalle
spericolate operazioni finanziarie, si è dunque aggiunto il labirinto giudiziario.
Il quadro complesso che qui ho riassunto è esposto con ammirevole chiarezza da Guido
Ferrarini e Paolo Giudici in un working paper preparato per l’ European Corporate Governance
Institute [13], e la questione è stata discussa sotto il profilo dell’ analisi economica del diritto da
Francesco Denozza [14].
Osservato dall’esterno, questo labirinto sembra un vero e proprio laboratorio per il giurista,
perché diversi sono i rimedi a cui si è fatto ricorso e a cui si è pensato, per risolvere le complesse
questioni aperte dal caso.
2. L’intervento del legislatore
Il legislatore è intervenuto con la disciplina di attuazione della direttiva sul “market abuse” (
2003/6/CE) inserendo le relative disposizioni nel testo della legge comunitaria del 18.4.2005,n. 62.
Queste disposizioni, tuttavia, non risolvono in radice il problema della tutela del risparmiatore in
quanto si riferiscono solo all’abuso di informazioni privilegiate e rafforzano i poteri della Consob. Il
Parlamento ha approvato il progetto di legge in materia di “disposizioni per la tutela del risparmio e
la disciplina dei mercati finanziari” con legge262/2005. A questo testo erano affidate le speranze dei
risparmiatori, ma la complessità della vicenda Parmalat e la complessità della normativa avevano
frenato i lavori parlamentari. Si tenga anche conto del fatto che in questo testo si sono intrecciate
vicende estranee, in certo qual modo, agli scandali finanziari che si sono registrati in questo periodo
in Italia ( oltre al “caso Parmalat”, abbiamo anche il “caso Giacomelli”, il “caso Cirio” e il caso dei
bonds argentini, che non hano afflitto solo l’Italia): si tratta delle competenze della Banca d’Italia,
rispetto alla Consob, quanto alla vigilanza sulla concorrenza delle banche, dei poteri del Governatore
della Banda d’Italia, e, in particolare, della introduzione nel nostro ordinamento di regole processuali
sulle class actions, che spaventano le imprese, le quali si sono mosse attraverso il loro organo
associativo, la Confindustria, per ostacolare questo progetto.
La suddettaleggeha introdotto: (i) nuove regole sulla corporate governance, già integralmente
modificata con la riforma del 2003 (d.lgs.17-1-2003,n.6), modificata con due decreti correttivi
(d.lgs.6.2.2004,n.37 e d.lgs.28.12.2004,n.310) e introdotta nel codice civile; sul collegio sindacale nei
modelli di società per azioni diversi da quello tradizionale, l’azione di responsabilità, la trasparenza
delle società estere; (ii) nuove regole sul conflitto di interessi nella gestione dei patrimoni mobiliari, e
sui conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento; (iii ) le regole di attuazione della
direttiva comunitaria 2003/71/CE sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione
alla negoziazione di strumenti finanziari; modifiche alla disciplina dell’intermediazione finanziaria e
alla responsabilità dei dirigenti, e (iv) regole di natura amministrativa sul coordinamento delle
competenze delle diverse Autorità che si occupano della vigilanza del mercato finanziario.
13
G.Ferrarini e P.Giudici, Financial Scandal and the Role of Private Enforcement: The Parmalat Case, Law Working Paper N0. 40/2005, May 2005,
in http://ssrn.com/abstract=7304003
14 F. Denozza, Il danno risarcibile tra benessere ed equità: dai massimi sistemi ai casi “Cirio” e “Parmalat”, in Giur. comm., 2005, I, 111 ss.
3. L’intervento dei giudici
In attesa che il legislatore promuova l’intervento diretto a introdurre maggiori poteri di
controllo degli organi di vigilanza dei mercati finanziari, regole processuali sulle class actions e regole
sulla corporate governance, la gestione del caso Parmalat è affidata al Commissario straordinario e ai
giudici che si occupano delle procedure fallimentari e del risarcimento dei danni risentiti dai
risparmiatori.
In attesa di conoscere l’esito delle procedure fallimentari, la cui durata si annuncia
lunghissima, si può dare qualche indicazione sulla case law riguardanti casi analoghi – certo non di
questa dimensione – o profili di responsabilità registrati in altre vicende in cui sono stati coinvolti
soggetti operanti nel mercato finanziario. E’ appena il caso di precisare che il complesso delle forme
di protezione del risparmiatori è, nel nostro Paese, ancora in via di costruzione e che esso ha avuto
un notevole impulso per l’appartenenza dell’ Italia alla Unione europea. Pertanto i risparmiatori,
come già i semplici consumatori, si sono molto giovati della applicazione del diritto comunitario nel
diritto interno [15].
A chi possono si possono rivolgere i risparmiatori per chiedere il risarcimento del danno
subìto?
Innanzitutto agli emittenti, per responsabilità da prospetto. In un primo tempo i giudici non
avevano ritenuto ammissibile l’azione di responsabilità in quanto pensavano che la lettura del
prospetto non avrebbe potuto influenzare la volontà del risparmiatore che si era determinato a
sottoscrivere i titoli offerti al pubblico tramite il prospetto informativo [16].
Successivamente l’orientamento è mutato, e, insieme con la responsabilità dell’emittente, si è
affermata anche la responsabilità degli intermediari che abbiano partecipato al collocamento dei titoli [17]. E’
ancora dubbio se si tratti di responsabilità che inerisce alla fase della trattativa (ex art. 1337 cod.civ.),
oppure al rapporto contrattuale, oppure al semplice contatto sociale che si è formato al di fuori di un
rapporto contrattuale; quest’ultima è la soluzione preferita dalla giurisprudenza, che applica al caso le
regole del codice civile in materia di illecito, equivalenti ai principi applicati in common law per i torts
(art. 2043 ss.).
Nei confronti dell’emittente oggi, tuttavia, i giudici ritengono che i risparmiatori possano
avvalersi anche di altri rimedi: ad esempio, dall’azione di nullità del contratto sottoscritto dal
risparmiatore per effetto della violazione da parte dell’emittente delle disposizioni inerenti le
informazioni da fornire ai sottoscrittori [18], oppure per non aver comunicato al risparmiatore la
natura del prodotto finanziario offertogli [19];oppure addirittura per aver consentito ad un settlement
privo di “causa”, che corrisponde latu sensu alla consideration [20]. La dottrina sta ora valutando la
fondatezza di questi rimedi, che incidono sulla disciplina del contratto.
Per quanto riguarda specificamente gli intermediari che propongono ai propri clienti i prodotti
delle emittenti, oltre alla responsabilità da prospetto, si sta ora configurando un’altra ipotesi di
responsabilità (che ha natura contrattuale, perché discende dal contratto concluso con il
risparmiatore): la responsabilità per omesso controllo dell’ adeguatezza dell’ investimento, tenuto
conto della propensione al rischio del cliente. Si tratta in questo caso di un obbligo di acquisizione di
informazioni e di valutazione dei rischi, che l’intermediario deve osservare sulla base dei regolamenti
della Consob ( dei principi posti dalla direttiva n.22 del 1993) e del principio di diligenza
professionale desumibile dal codice civile, ex art. 1176 c.2, a cui la giurisprudenza aggiunge il
principio generale di correttezza, di cui all’art. 1175 cod.civ. [21]
Ma si sta facendo strada anche un’altra ipotesi di illecito: la responsabilità per la concessione
15[15]
G.Alpa, Il diritto dei consumatori, Roma-Bari, 2003; G.Alpa-M.Andenas, Fondamenti del diritto privato europeo, Milano, 2005
16[16]
Cass. 22.6.1978, in Giur.comm., 1979, II, 631
Trib.Trieste, 13.7.1994, in Società, 1995,539; Trib.Milano, 6.11.1987, in Giur.it., 1988, I, 499
18[18] Trib.Firenze, 21.3.2005 (data della decisione)
19[19] Trib.Brindisi, 21.6.2005 (data della decisione)
20[20] Trib.Roma, 23.3.2005 (data della decisione)
21[21] Trib. Mantova, 12.11.2004 (data della decisione)
17[17]
abusiva di credito da parte delle banche ai debitori insolventi. Risolto il problema – in senso negativo
- sulla ammissibilità della legittimazione ad agire del curatore nei confronti della banca creditrice [22], la
giurisprudenza si è chiesta quali soggetti siano legittimati a ottenere il risarcimento per aver sofferto
un danno derivante dalla maggior esposizione debitoria del cliente a seguito della concessione di
credito da parte della banca, consapevole delle difficoltà in cui versava il debitore. Il dissesto
economico dell’impresa ovviamente si aggrava con la concessione di credito, e i creditori diversi dalle
banche, se non sono assistiti da idonee garanzie, come normalmente lo sono le banche, rischiano di
non acquisire alcunché in sede di riparto delle attività. Trattandosi di atto illecito, la competenza
spetta al giudice del luogo in cui l’atto illecito è stato commesso [23]. Dell’illecito rispondono gli
amministratori e l’azione – essendo fondata sulla responsabilità extracontrattuale – ha una
prescrizione quinquennale [24]. I soggetti tutelati sono dunque: i depositanti, i fornitori della merce
all’imprenditore fallito, gli azionisti della banca, i creditori diversi da quelli bancari se danneggiati dalla
alterazione del principio della par condicio creditorum [25]. Per l’appunto a questa categoria appartengono i
risparmiatori che abbiano subito danno per il dissesto provocato dalla concessione abusiva (dolosa o
colposa) della banca alla società emittente i titoli in default.
Tra i soggetti responsabili occorre annoverare anche i soggetti responsabilit del controllo
interno e della revisione dei bilanci Qui ci stiamo però spostando dall’area di chi, per cosi’ dire, ha
“fabbricato” il titolo, o ha costruito un impero di carta, e da chi ha collaborato a costruire questo
processo criminoso, a chi doveva controllare perché questo disegno non potesse essere progettato e
portato a termine. Si tratta del collegio sindacale, dei revisori interni, e delle società di revisione che
esternamente controllano la contabilità e i bilanci delle società.
Il problema del nesso causale tra il danno risentito dal risparmiatore e il comportamento
illecito si attenua via via che ci si allontana da chi ha “fabbricato” il titolo o da chi lo ha negoziato o
da chi ha violato le regole di corporate governance.
La giurisprudenza tuttavia non si pone particolari problemi a questo riguardo, e considera il
nesso causale in modo piuttosto elastico.
La responsabilità della società di revisione è prevista per legge, dal testo unico
sull’intermediazione finanziaria (d.lgs.n. 98 del 1993). La società di revisione risponde a titolo
contrattuale per il danno risentito dalla società assoggettata alla revisione e a titolo di responsabilità
civile per i danni risentiti dai terzi danneggiati, che possono essere gli acquirenti delle quote societarie
che avevano confidato nei risultati della revisione per effettuare l’acquisto [26].
Si discute se sia possibile affermare anche la responsabilità degli organi di vigilanza, gli
“administrative bodies” che nel nostro sistema, in quanto “autorità amministrative indipendenti”,
potrebbero essere esonerate per il fatto che la disciplina che le istituisce e ne governa l’attività non è
diretta alla tutela dei risparmiatori bensì della trasparenza del mercato in generale. L’omissione nel
controllo del prospetto può comportare responsabilità della Consob? E l’omissione di controllo dei
bilanci delle società quotate in borsa può comportare responsabilità della Consob?
Le questioni che si affollano a questo riguardo sono molteplici, riguardando innanzitutto lo
scopo della norma violata, poi il tipo di danno subito dai risparmiatori, poi il nesso causale tra il
danno e l’omissione. In senso affermativo si è pronunciata una sentenza della corte di Cassazione,
che tuttavia non può essere considerata un leading precedent perché fondata su una fattispecie in cui
l’omissione di controllo dipendeva dalla intenzionale negligenza di alcuni componenti dell’organo di
controllo [27]. In applicazione del principio di responsabilità sancito dalla Suprema Corte, la Corte d’
Appello di Milano, nel giudizio di rinvio, ha precisato che “la responsabilità della pubblica
22
Cass. 19.9.2003,n. 13934, in Dir.banca e mercato fin., 2004, p. 291
Cass. 19.9.2003,n. 13934
24 App.Bari, 17.6.2002, in Dir.fall., 2002,II, 951
25 Trib.Foggia, 6.5.2002, in Dir.comm.int., 2003, p. 561, con nota di Franchi.
26 Cass. 18.7.2002,n. 10403, in Giur.comm., 2003,II 441 Trib.Milano, 21.10.1999, in Giur.it. 2000, 554;
App:Milano, 7.7.1998, in Giur.comm., 2000,II, 425
27 Cass. 3.3.2001,n. 3132
23
amministrazione per omissione colposa è configurabile allorché la legge obblighi la stessa a un
comportamento attivo, nella fattispecie, di vigilanza, desumibile dalla normativa (…) che configura
(….) un vero e proprio dovere di agire della Consob per impedire l’evento che si è concretizzato a
danno dei risparmiatori a causa dell’omissione di vigilanza dello stesso organismo di vigilanza”.
Anche se non esiste un incondizionato dovere della Consob di attivarsi sempre a protezione delle
posizioni giuridiche vantate da terzi, la corte ha precisato che la responsabilità di quest’organo è
fondata ove emergano, ictu oculi, elementi di sospetto sulla veridicità dei dati forniti dai proponenti
l’operazione finanziaria, alla luce di evidenti falsità rilevabili dai documenti depositati dall’emittente.
[28]
A questo punto entrano in gioco non solo le regole di diritto, ma anche le considerazioni di
analisi economica del diritto: in altri termini, come ripartire in modo razionale, ottimale, le risorse, i
danni e le sanzioni? Dobbiamo tener conto non solo dei danni risentiti dai risparmiatori –
distinguendoli comunque sempre nelle categorie di cui si accennava all’inizio – ma anche delle risorse
che, nel caso fossero attinte dalle casse pubbliche (come nel caso della responsabilità della Consob),
sarebbero sottratte agli altri risparmiatori e ad altri utilizzi. Ho molti dubbi che i rimedi di diritto
privato, e, in particolare i rimedi giudiziali, riescano da soli a risolvere i problemi esposti, che hanno il
loro versante di natura macroeconomica. Così come ho molti dubbi che una giurisprudenza erratica,
che ora ammette ora nega il risarcimento, possa costituire la risposta adeguata ai crack finanziari. Così
come ho molti dubbi che le sole regole affidate al mercato siano in grado di prevenire i crack
finanziari ( i casi sopra citati propenderebbero per la certezza del market failure). Diritto privato e
diritto pubblico, autodisciplina e controllo dei comportamenti e dei prodotti finanziari da parte degli
organi di vigilanza potrebbero continuare a costituire un adeguato quadro di misure per prevenire o
per curare queste evenienze. Ecco perché tanto ci aspettiamo dal legislatore, il cui ritardo non può
che aumentare la nostra inquietudine.
III
L’etica della professione forense
1. L’etica professionale
Sul piano teoretico si è accreditata l’idea che l’ etica professionale debba essere distinta dall’
etica generale. In questo senso i problemi enunciati sono sinteticamente riassunti in tre diversi
momenti: (i) i doveri additivi; (ii) le deroghe ammesse dalla condizione professionale; (iii) gli
imperativi morali dettati dalla coscienza professionale (Jackson, Duties and Conscience in Professional Practices,
in Matter of Breath.Foundations for Professional Ethics, a cura di De Stexhe e Verstraeten, Leuven, 2000, p.
241 ss.; nello stesso senso v.Boon e Levin, The Ethics and Conduct of Lawyers in England and
Wales,Oxford e Portland, 1999, p. 195 ss.). Ciascuna di queste dimensioni pone interrogativi a cui si
deve dare risposta. E la risposta, per il professionista, si rinviene nella legge e nei codici deontologici.
In questa prospettiva, appare corretto ritenere che il professionista debba osservare regole etiche
additive rispetto alla persona comune, che il professionista possa essere sollevato – in casi di
eccezione – dall’osservanza delle regole comuni, che il professionista non sia tenuto ad operare in
conflitto con la propria coscienza. In ogni caso, il professionista deve essere affidabile e quindi deve
agire secondo correttezza.
Le regole etiche – come peraltro le regole giuridiche – non sono scolpite sulla pietra, non
sono immutabili, sono sempre oggetto di interpretazione; insomma, come non si può ipostatizzare il
valore della “certezza del diritto”, così non si può mitizzare la “certezza dell’etica”. E’ in questa ansia
di ricerca e di tensione verso una morale professionale che siamo impegnati diuturnamente nello
28
App.Milano, 21.10.2003
svolgimento della nostra attività. In altri termini, le regole etiche sono proprie di un sistema culturale
e di un sistema giuridico in cui maturano e di consolidano.
E’ rilevante sottolineare che i principi che regolano il comportamento dell’avvocato
affondano nella storia le loro radici. John Baker, nel descrivere la storia del diritto inglese si riferisce
alla prassi forense come ad un “corpo di regole” parallelo a quello creato dal Parlamento e dalle corti,
separato da questo e osservato con continuità in Inghilterra dal Medio Evo ad oggi (Hazard e Dondi,
Legal Ethics. A Comparative Study, Stanford, 2004, p. 3; Brooks, Lawyers, Litigation and English Society since
1450, Londra, 1998). La costruzione di queste regole concerne sia la formazione, sia l’accesso
all’esercizio della professione, sia i campi di intervento, sia i rapporti con il cliente e con il giudice:
ovviamente si tratta di un percorso segnato dalla tipicità degli ambienti culturali e sociali in cui esso si
dipana (Padoa Schioppa, Italia ed Europea nella storia del diritto, Bologna, 2003, p. 310 ss.). Anche le
categorie di avvocati – e quindi le regole di appartenenza – cambiano a seconda degli ambienti: come
avviene per la distinzione tra barrister e solicitor, avocat e avoué, avvocato e procuratore.
Si può riscontrare tuttavia nell’ Europa occidentale una certa omogeneità di regole di
comportamento che si ispira ai principi di indipendenza, autonomia, correttezza e lealtà, rapporto
fiduciario con il cliente, segretezza, specchiatezza di costumi (Hazard e Dondi, op.cit., p. 43 ss.)
mentre negli Stati Uniti d’America già dall’ Ottocento si accredita l’idea che il rapporto abbia
eminentemente natura economica, sicché è ammesso il patto di quota lite (Friedman, Storia del diritto
americano, Milano, 1995). Queste regole appartengono ad un settore delle scienze sociali la cui
denominazione di “deontologia” sembra ascrivibile a Bentham, figurando nel titolo della sua opera
postuma Deonthology or the science of morality apparsa nel 1834. E dal punto di vista sociologico, esse
appartengono all’autodisciplina dei corpi professionali, in quanto conferiscono stabilità e
organizzazione al gruppo (Durkheim, Professional Etthics and Civic Morals, trad. ingl., Londra, 1957,
p.9).
2. La sorte delle regole deontologiche
Essendo nei tempi moderni queste regole collocate nell’ambito di sistemi giuridici che sono
organizzati mediante una gerarchia delle fonti, in ciascun sistema si è data risposta a tre interrogativi
fondamentali: (i) se queste regole rimangano sul piano etico, cioè metagiuridico o se siano inglobate
nel sistema giuridico, e, in questo caso, (ii) quale posto occupino nell’ambito della gerarchia, e (iii)
esse abbiano la medesima natura qualunque sia la professione esercitata, oppure le regole concernenti
la professione forense abbiano una loro specificità che incide sulla loro stessa natura giuridica.
Nell’esperienza inglese le regole riguardanti le professioni hanno una natura più ampia
rispetto alle regole giuridiche, esse variano a seconda delle professioni considerate, prescrivono
standard di comportamento. In ogni caso, sono norme che vincolano gli appartenenti alla categoria
professionale (Boon e Levin, op.cit., p. 9), ma le regole professionali che riguardano gli avvocati hanno
una loro propria specificità, che emerge sopratutto con l’emergere del capitalismo e dei sistemi
giuridici moderni incentrati sullo Stato (Boon e Levin, op.cit., p. 43). Il ruolo dell’avvocato è associato
alla amministrazione della giustizia e alla difesa dei diritti e quindi assurge ad un ruolo avente valore
costituzionale (op.cit.,p. 63 ss.).
Nell’Europa continentale, in molte esperienze Stato ha inglobato le regole deontologiche,
formulate con principi molto ampi ed elastici, nel suo proprio ordinamento. In Francia, ad es., questa
operazione è avvenuta molto in ritardo rispetto all’esperienza italiana, con la l. n. 71-1130 del 31.12.
1971, poi modificata nel 1990 e ancora nel 2004. Presso di noi, la prima legge professionale dello
Stato unitario risale, come è noto, al 1874 ( Cavagnari e Caldara, Avvocati e procuratori, voce del Dig.It.,
1893-1896, rist. a cura di G.Alpa, Bologna, 2004) ed è stata riformulata con r.d.l. 27.11.1993,n. 1578
(“Ordinamento della professione di avvocato”, conv. In l. 22.1.1934,n. 36, c.d. legge professionale, e
relativo reg. 22.1.1934,n.37). L’art.12 della l.p. dispone che gli avvocati “debbono adempiere al loro
ministero con dignità e decoro, come si conviene all’altezza della funzione che essi sono chiamati ad
esercitare nell’amministrazione della giustizia”; i Consigli dell’ordine “vigilano sul decoro dei
professionisti” (art.14); “gli avvocati che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della
loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”. Il
regolamento precisa le regole processuali concernenti il procedimento disciplinare presso gli Ordini e
presso il Consiglio nazionale forense.
Avverso le decisioni dei Consigli l’interessato e il p.m. presso la Corte d’Appello possono
proporre ricorso al CNF (art. 50 l.p.), il quale si pronuncia sul ricorso ex art. 54 l.p.; la procedura
dinanzi al CNF è disciplinata dal regolamento (art.47 ss.).
Avvero le decisioni del CNF gli interessati e il p.m. possono proporre ricorso alle Sezioni
unite della corte di Cassazione (ex art. 56 l.p. e art. 66 ss. del reg.) per: incompetenza, eccesso di potere,
violazione di legge. La formula corrisponde grosso modo ai nn. 2 (“violazione delle norme sulla
competenza”), 3 (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto”) 5 ( “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o
rilevabile d’ufficio”) di cui al c. 1 dell’art. 360 c.p.c. Quanto al vizio di “eccesso di potere” la Corte ha
precisato che tale motivo deve essere interpretato alla luce della natura giurisdizionale – e non
amministrativa – del CNF, e quindi deve essere inteso come “eccesso di potere giurisdizionale”, cioè
l’attribuzione all’organo giudicante di un potere che spetta invece al altro organo (Cass.SS.UU.,
24.8.1999,n. 598)
Ma occorre considerare che il CNF ha competenza anche nel merito e che può riformulare i
capi di incolpazione.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, al di là dei motivi di ricorso di
cui all’art. 360 c.p.c., è comunque proponibile ricorso alla Corte medesima sulla base dell’art. 111
Cost. (V. ad es., Cass. SS.UU. 23.3.2004,n. 5776).
3. La natura delle norme deontologiche
Secondo l’orientamento più recente della Suprema Corte nell’ambito della espressione
“violazione di legge” di cui al c.7 dell’innovato disposto dell’art. 111 Cost., deve essere ricompressa
anche la “violazione delle norme di codici deontologici degli ordini professionali trattandosi di norme
giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo ma che integrano il diritto soggettivo ai fini della configurazione
dell’illecito disciplinare” (Cass. SS.UU. n. 5576 del 2004, cit.).
Le argomentazioni utilizzate dalla Suprema corte per pervenire a detto risultato sono
molteplici. Si è ritenuto, per un verso, che le norme deontologiche discendono dall’ autonomia degli
Ordini (Cass. SS.UU., 12.3.2004,n. 5164). A cui la legge demanda un potere disciplinare che è
insindacabile dal giudice, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge (Cass. SS.UU.
11.3.2002,n. 3529); per altro verso, si è affermato che il controllo perviene alla ragionevolezza della
decisione, che altrimenti sfugge alla cognizione del giudice (Cass.SS.UU. 10.12.2001,n. 15601). Non è
pertanto possibile sindacare la sufficienza o la congruità della motivazione (Cass. SS.UU.,
10.12.2001,n. 15600). Solo nel caso di decisione non sostenuta da alcuna “ratio” o di motivazione
apparente, priva di ogni intrinseco fondamento, si giustifica il sindacato del giudice (Cass.SS.UU., n.
15660 del 2001, cit.).
Altre pronunce hanno invece considerato le regole recepite nel codice forense come principi
di natura consuetudinaria (Cass.SS.UU., 26.2.1999,n. 103). Ed altre ancora hanno qualificato le norme
deontologiche ( nel caso, previste dal codice applicato ai medici) come “precetti extragiuridici”, regole
interne alla categoria e non atti normativi (Cass.SS.UU., 10.2.2003,n. 1951, che riprende il dictum
espresso nella sentenza n. 3239 del 1993).
Diverse sono dunque le ragioni che fondano il valore delle regole deontologiche. Nella
rassegna delle argomentazioni, si possono elencare:
(i) l’argomentazione formale, che si affida alla legge professionale, in particolare agli artt. 54 e
56, che statuiscono il potere giurisdizionale del CNF;
(ii) l’argomentazione formale che richiama il precetto generale concernente l’esercizio della
professione forense, la quale deve conformarsi a dignità e decoro (art.12 l.p. cit.); in tal caso le decisioni
degli Ordini e del CNF non fanno che specificare l’illecito disciplinare riportandolo a fatti e
comportamenti che contravvengono la clausola generale;
(iii) l’argomentazione ermeneutica che equipara le regole come previste nei codici a “principi
generali”;
(iv) l’argomentazione ermeneutica che individua nelle regole norme consuetudinarie;
(v) l’argomentazione inerente al diritto privato di autodisciplina degli Ordini ( e del CNF) in
base alla quale gli iscritti alla categoria debbono osservare le regole che la categoria si è data
nell’ambito del proprio potere regolamentare (c.d. regolamenti privati).
Tuttavia:
- le argomentazioni sub (i) e (ii) potrebbero essere superate dalla modificazione legislativa
delle disposizioni invocate;
- l’argomentazione sub (iii) potrebbe essere superata dal disconoscimento del principio
generale;
- l’argomentazione sub (iv) potrebbe essere superata dal disconoscimento della norma
consuetudinaria;
- l’argomentazione sub (v) potrebbe essere superata da una legge che limitasse l’autonomia
privata degli ordini di professionali.
In più:
- l’argomentazione sub (iii) cristallizza le norme in quanto desunte per via logico-induttiva
dalle disposizioni che fondano i principi generali;
- l’argomentazione sub (iv) cristallizza le norme impedendo la modificazione dei codici che
non si limitassero a recepire la consuetudine, ma la innovassero.
4. Il fondamento del potere disciplinare.
Il discorso conduce dunque ad individuare il fondamento del potere disciplinare. A questo
riguardo si è puntualmente precisato che esso non è Extra-giuridico, ma tutt’al più extra-legislativo
(D’Angelo, La deontologia dell’avvocato, ne Le fonti di autodisciplina.Tutela del consumatore, del risparmiatore,
dell’utente, a cura di P.Zatti, Padova, 1996, p. 123), e conferito agli Ordini in ragione della tutela degli
interessi del cliente. In altri termini, riconoscendo tra le fonti del diritto anche le regole che
autonomamente si dànno le categorie professionali, il compito dell’organo disciplinare consiste
nell’applicazione del precetto legislativo formulato in una clausola generale ( “dignità e decoro”)
tipizzando il comportamento ritenuto illecito e sussumendolo nella clausola. E più di recente si è
sostenuto che occorre distinguere il fondamento del potere disciplinare che trova riferimento in una
disposizione di legge, dalla sua applicazione pratica a singole fattispecie, che invece è il risultato di un
procedimento ermeneutico (Perfetti, Le fonti della deontologia professionale. I rapporto tra le norme
dell’ordinamento professionale e quelle del codice deontologico, in corso di pubbl. su La nuova giur.civ.comm.,
2005).
Le argomentazioni inerenti la natura delle norme deontologiche si possono allora
circoscrivere a tre diverse alternative:
− la loro posizione in conformità al dettato legislativo, il che presuppone che la legge intesa in
senso formale attribuisca all’organo disciplinare il compito di dettare regole deontologiche; e,
se si vuole ampliare l’enunciato, in conformità a principi generali desumibili dal dettato
legislativo;
− la loro posizione in conformità a regole di comportamento osservate in via consuetudinaria;
− la loro posizione in virtù dell’autonomia privata di categoria.
Se queste premesse sono corrette, occorre inserire nel discorso una valutazione che inerisce
alla specificità del codice deontologico considerato: ad es., appartiene alla prima categoria il codice dei
notai, la cui legge professionale esplicitamente prevede il potere di dettare regole deontologiche;
appartiene alla terza categoria il codice di autodisciplina pubblicitaria ed i codici che altre categorie si
sono dati ( come Anasf e Assoreti); mentre alla categoria forense si applicano regole che la legge
genericamente riassume in una clausola generale e quindi sono desunte indirettamente da questa
(Perfetti, op.cit.).
Con riguardo alla categoria forense si potrebbe riprendere un principio che si rifà alle regole
consuetudinarie. In questo caso, la consuetudine appare doppiamente legittimante: del potere
normativo degli Ordini ( e del CNF), in quanto esercitato dia primi fin dal 1874 e dal secondo dalla
data della sua istituzione, nel 1926; dei singoli precetti enucleati e raccolti nel codice, in quanto
osservati e fatti osservare. In questo senso, il CNF avrebbe potere modificativo del codice in quanto
recepisce doveri deontologici di volta in volta emergenti dalla realtà sociale.
La deontologia forense, come sopra si è sinteticamente riportato, obbedisce, in ambito
europeo, a principi uniformi, salve le differenziazioni legate alla cultura e alle tradizioni delle singole
esperienze. La “europeizzazione” delle regole deontologiche, promossa dal CCBE, amplia la
prospettiva fin qui coltivata: le garanzie riconosciute in capo all’Avvocatura superano i confini
nazionali, e diventano dunque oggetto di una fonte superiore all’ordinamento nazionale, derivante dal
diritto comunitario.
Le regole deontologiche debbono essere conformi al diritto comunitario, non possono
costituire barriere nell’esercizio dell’attività professionale, ma al tempo stesso costituiscono un fattore
di qualità della prestazione professionale.
Occorre ancora rammentare che la giurisdizione esclusiva del CNF – anteriore alla normativa
costituzionale – non è stata posta in dubbio dalla giurisprudenza costituzionale.
E’ ovvio che questo discorso è circoscritto alla categoria forense, e alle funzioni
dell’avvocato, che sono correlate al diritto di difesa, riconosciuto non solo dalla Carta costituzionale
ma anche dalla Carta di Nizza incorporata nella Costituzione europea. Di qui dunque due
considerazioni consequenziali: il codice deontologico forense non può essere abrogato da norme (
anche primarie) del legislatore nazionale, in quanto esso afferisce alla normativa ( se si vuole
consuetudinaria) di fonte europea; né può essere “approvato” o sindacato da approvazioni
ministeriali, dal momento che l’atto amministrativo di riconoscimento deriverebbe da fonte inferiore
a quella su cui si fonda il codice, e non potrebbe che essere ricognitivo delle norme in esso contenute.