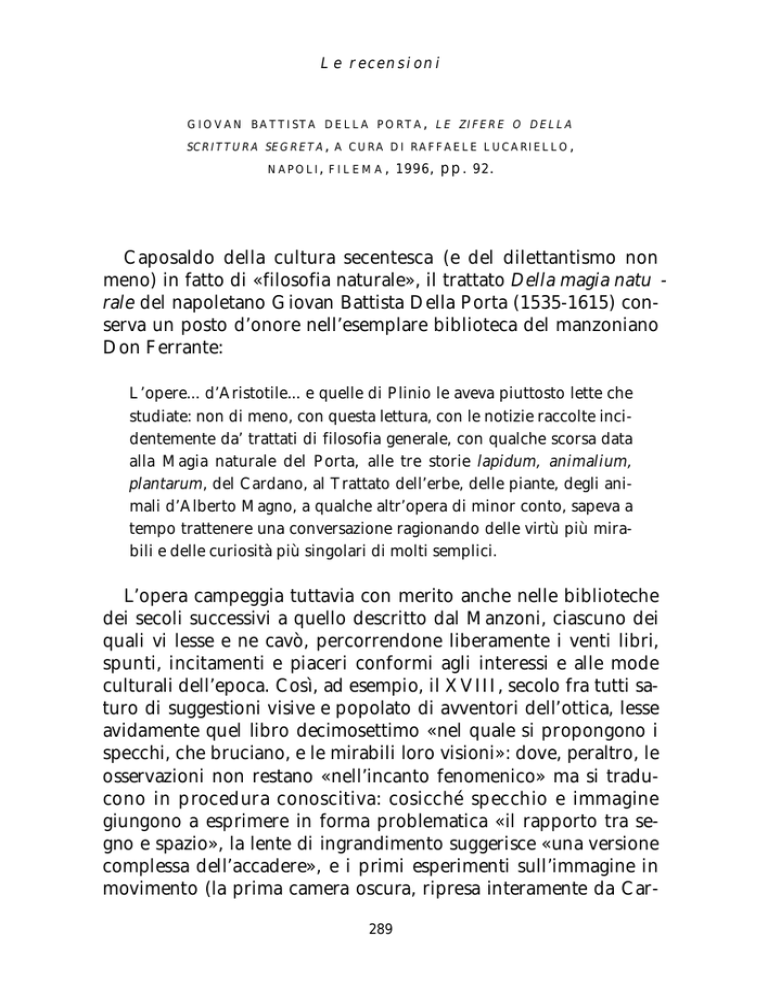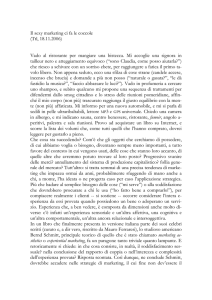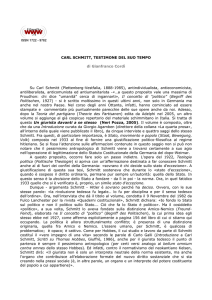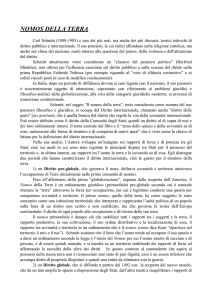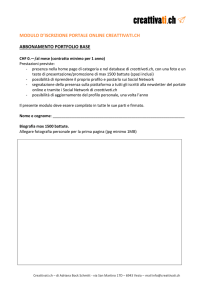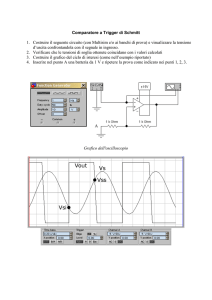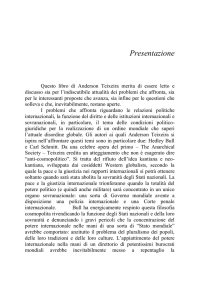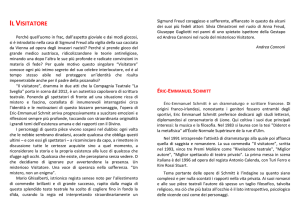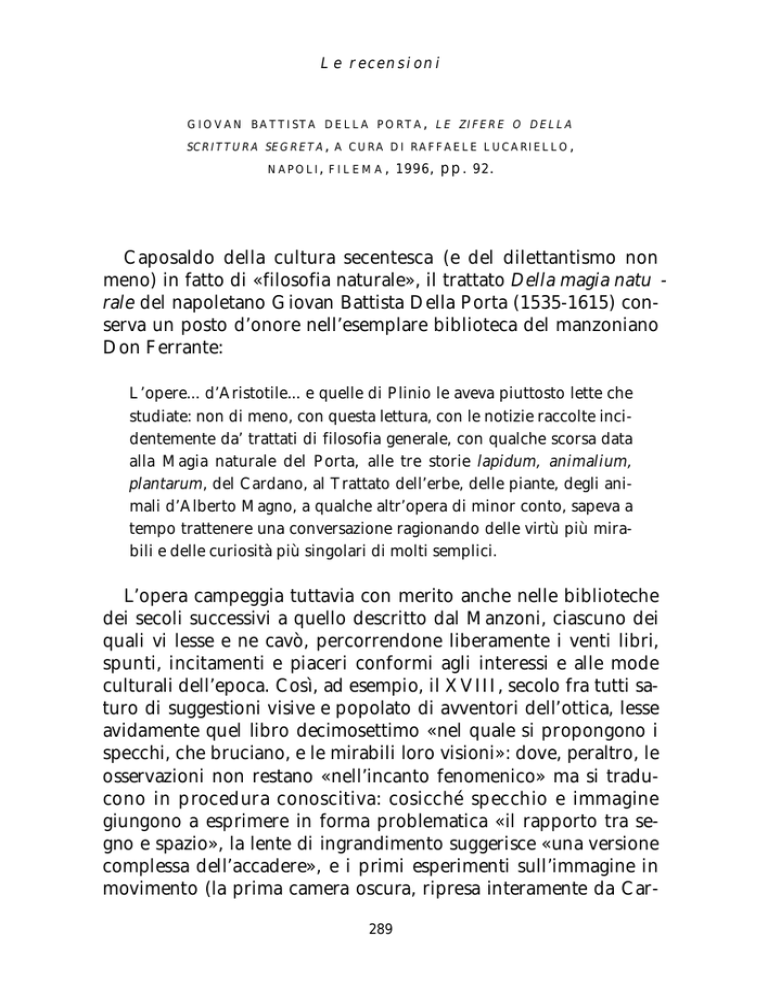
L e r ec ens i on i
GIOVAN BATTISTA DELLA PORTA, LE ZIFERE O DELLA
S C R I T T U R A S E G R E T A, A C U R A D I R A F F A E L E L U C A R I E L L O ,
N A P O L I, F I L E M A , 1 9 9 6 ,
p p . 92.
Caposaldo della cultura secentesca (e del dilettantismo non
meno) in fatto di «filosofia naturale», il trattato Della magia natu rale del napoletano Giovan Battista Della Porta (1535-1615) conserva un posto d’onore nell’esemplare biblioteca del manzoniano
Don Ferrante:
L’opere... d’Aristotile... e quelle di Plinio le aveva piuttosto lette che
studiate: non di meno, con questa lettura, con le notizie raccolte incidentemente da’ trattati di filosofia generale, con qualche scorsa data
alla Magia naturale del Porta, alle tre storie lapidum, animalium,
plantarum, del Cardano, al Trattato dell’erbe, delle piante, degli animali d’Alberto Magno, a qualche altr’opera di minor conto, sapeva a
tempo trattenere una conversazione ragionando delle virtù più mirabili e delle curiosità più singolari di molti semplici.
L’opera campeggia tuttavia con merito anche nelle biblioteche
dei secoli successivi a quello descritto dal Manzoni, ciascuno dei
quali vi lesse e ne cavò, percorrendone liberamente i venti libri,
spunti, incitamenti e piaceri conformi agli interessi e alle mode
culturali dell’epoca. Così, ad esempio, il XVIII, secolo fra tutti saturo di suggestioni visive e popolato di avventori dell’ottica, lesse
avidamente quel libro decimosettimo «nel quale si propongono i
specchi, che bruciano, e le mirabili loro visioni»: dove, peraltro, le
osservazioni non restano «nell’incanto fenomenico» ma si traducono in procedura conoscitiva: cosicché specchio e immagine
giungono a esprimere in forma problematica «il rapporto tra segno e spazio», la lente di ingrandimento suggerisce «una versione
complessa dell’accadere», e i primi esperimenti sull’immagine in
movimento (la prima camera oscura, ripresa interamente da Car289
RECENSIONI
tesio nella sua Diottrica) permettono di fissare la temporalità dell’immagine, di seguire «la memoria del segno». Così, quindi, il secolo XX, dedito per eccellenza alla riflessione sul segno linguistico, doverosamente legge – e ripropone alle stampe – il libro decismosesto: Delle cifre invisibili. Nel quale si tratta di Zifere, che non
si veggono.
L’edizione, approntata dallo studioso napoletano Raffaele Lucariello e nata da una ricerca promossa dall’Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici di Napoli (città in cui opera anche l’editore Filema), è esemplata sull’edizione pubblicata a Napoli, presso Gio.
Iacomo Carlino e Costantino Vitale stampatori, nel 1611: edizione tradotta dal latino in volgare da Gio. De Rosa, pseudonimo del
Della Porta.
La scelta dello pseudonimo, per cominciare, non passerà inosservata. E, per tornare a Manzoni, non si dimenticherà come nell’autore dei Promessi sposi e nella sua invenzione del manoscritto
secentesco culmini una tradizione di espedienti e topoi difensivi,
di misure di tutela adottate dagli scrittori in vista delle conseguenze dei propri ardimenti: come nel caso appunto, datato 1611, di
un trattato filosofico-scientifico in volgare nel vivo di un clima
culturale che non concepiva altra lingua dal latino come lingua
veicolare del sapere. L’accusa poteva essere infatti (come, per altri
versi, comunque fu) quella di “volgarizzare”, “generaleggiandolo”, il sapere stesso: divulgandolo nel renderlo accessibile, almeno
linguisticamente, a un pubblico di lettori non specialisti e non iniziati. Ciò di cui per l’appunto Della Porta fu in ogni caso ritenuto
responsabile: soprattutto perché, al di là della questione della lingua, il suo metodo e la sua coordinata di ricerca andavano proprio in quella direzione. Non artefice di alterazioni teoriche nell’ambito della conoscenza ma piuttosto percettore ed elaboratore
di un sapere esperito, «saggiato», che si incarica costantemente di
trasporre dal piano letterario a quello pratico, Della Porta si fa carico infatti di una «messa in opera del sapere filosofico», e della
coniugazione fra lavoro intellettuale e lavoro manuale, speculazione e tecniche, filosofia e artigianato.
Attraverso la lettura della Magia naturalis ogni lettore è pertan290
RECENSIONI
to un potenziale artigiano e un possibile filosofo, la scrittura del
testo proiettandosi di continuo verso la manualità dell’opera e richiedendo ulteriori esecutori degli esperimenti proposti. Esemplare in tal senso, oltre al citato libro che esibisce la connivenza
fra ottica e modelli conoscitivi, quello appunto dedicato ai segni,
alle lettere scritte, massime a quelle «che non si vedono»: dove
l’autore descrive una serie di sistemi di scrittura che permettono
di comporre e quindi di rendere leggibili testi o messaggi occultati, indicando l’uso di diversi materiali e modi d’impiego, e realizzando così un vero e proprio manuale di scrittura cifrata.
Zifere (dall’arabo sifr, cifra, che significa zero) sono i segni nulli, invisibili come il mite e leggero vento di ponente (Zefiro appunto, quello che – insegna Petrarca – tornando «il bel tempo rimena»). Segni paradossali, che contemplano e si costituiscono
tramite l’annullamento (almeno temporaneo) del significante, non
potevano non attrarre fra gli altri un pensatore, quale l’editore di
questo libro, nella cui formazione filosofica Derrida (un Derrida,
come noto, da molti anni assiduo frequentatore dei cenacoli partenopei) ha significato non poco. Nel gioco di «velamento e disvelamento delle lettere», effettuato tramite succhi (di arancio, cedro, ciclamino, cipolla, limoncello, sorbo...) e altre sostanze (aceto, acquavite, bianco d’uovo, canfora, cera, gomma arabica, grasso, inchiostri simpatici, latte di fico, olio di miele, pietre paragone, polvere, sevo di becco, verderame, vetriolo, zolfo...), favorito
da peculiari supporti (carta, carte da gioco, cristallo, corpo, filo,
legno, penne di colomba, pietra, rame, tagli dei libri, uova, vasi,
ventagli...), e perfezionato tramite ulteriori nascondigli (cinta della spada, lepri sventrate, otri gonfiati, balle di piombo, rondini,
saette...), in tale gioco dunque si sbizzarrisce la versatile competenza dellaportiana. Cultura materiale, calligrafia e crittografia,
iconologia e simbologia, strategia militare e politica (in cui, essenzialmente, la scrittura in zifere doveva versarsi), attività commerciale, tradizione epistolare o del carteggio sentimentale, pratica –
infine – dell’arte del segreto nelle sue implicazioni speculative e
teoriche, sono i saperi specifici che nel libro convergono, contribuendo al suo profilo ricco e curioso.
291
RECENSIONI
Sulle implicazioni teoriche, in particolare, si soffermerà voluttuosamente il lettore ferrato in eccezioni grammatologiche, tracce, stilizzazioni e alterazioni della scrittura, e disponibile senz’altro alla fascinazione della polarità fra uno scrivere che consiste nel
costante annullamento del segno, e un leggere che coincide letteralmente con l’apparizione del segno stesso: antefatto, nell’insieme, di «una sorta di chimica delle idee».
La perizia di crittografo che Della Porta rivela (non senza rendere implicito omaggio ai suoi propri auctores, Tritemio e Cardano), corredata dalle dette implicazioni teoriche e pratiche, fa sì
che il libro delle Zifere riveli tutt’oggi le ragioni della sua proficua
leggibilità: come conferma, dal canto suo, anche Foucault, il quale non per caso, nel nevralgico capitolo sulle somiglianze del suo
Le parole e le cose, e proprio in procinto di trattare di «segnature»
nonché della «scrittura delle cose», attinge ampiamente alla Ma gia naturale, collocando il Della Porta fra le fonti primarie (Paracelso, Campanella, Cardano) della sua archeologia del sapere.
Trattando quindi direttamente delle segnature ovvero del sistema
che «rovescia il rapporto tra il visibile e l’invisibile», e centrando
il problema-cardine del protocollo analogico, sembra quasi parafrasare la teoria della zifera dellaportiana, derivandone il paradigma della visibilità connessa alla somiglianza.
La somiglianza era la forma invisibile di ciò che, dal fondo della
realtà, rendeva le cose visibili; ma affinché tale forma a sua volta affiori alla luce, ci vuole una figura visibile che la tragga dalla sua
profonda invisibilità. Proprio per questo il volto del mondo è coperto di blasoni, di caratteri, di cifre... E lo spazio delle somiglianze immediate... è irto di grafismi... Il grande specchio calmo in fondo al
quale le cose si contemplavano e rinviavano, l’una all’altra, le loro
immagini, è in realtà colmo d’un brusio di parole.
Così Foucault. Al lettore del Delle cifre invisibili il compito di
estendere la riflessione alle “figure visibili” rese a lor volta invisibili; alle cifre nulle; ai grafismi cancellati; alle parole senza immagine.
292
RECENSIONI
NOTA
Per la citazione da I promessi sposi ho letto dall’edizione (a cura di A. CHIARI e F.
GHISALBERTI) Milano, Mondadori, 1954, cap. XXVII, e per quella da Le parole e le
cose dall’edizione italiana Milano, Rizzoli, 19885, cap. II.
In merito alle Zifere, libro XVI del trattato del DELLA PORTA, laddove non riporto
la voce dell’autore s’intende il rinvio agli apparati del curatore del volume (Introdu zione, pp. 7-27, Indicazioni bibliografiche, pp. 28-29, Nota al testo, pp. 81-83).
Quanto alla Magia naturale nel suo insieme, e al libro XVII sugli Specchi, il riferimento è invece agli apparati a quest’ultimo per l’edizione, in allestimento, a cura dello stesso R. LUCARIELLO.
MONICA FARNETTI
293
Le re c ens i on i
ROMANO GASPAROTTI, MOVIMENTO E SOSTANZA.
SAGGIO SULLA
“T E O L O G I A”
P L A T O N I C O - A R I S T O T E L I C A,
PRESENTAZIONE DI VINCENZO VITIELLO , M I L A N O ,
GUERINI S C I E N T I F I C A , 1 9 9 5 ,
p p. 2 0 6 .
Quando il filo della tradizione sembra spezzarsi, diventa più
urgente la questione delle origini. È per questa ragione che per
noi, e non da oggi soltanto, un libro sui Greci non è quasi mai
una mera ricostruzione del passato, un pezzo di storia antiquaria,
ma un tentativo di autocomprensione storica, l’interpretazione di
una crisi in cui ne va di noi stessi. Il libro di Romano Gasparotti,
che qui presentiamo, non sfugge a questa necessità.
La prima parte, infatti, è dedicata ad una discussione di quella
tesi ontoteologica mediante la quale Heidegger pone l’intera storia
della filosofia sotto il segno dell’oblio dell’Essere e della progressiva alienazione dell’uomo dalla propria essenza. Su questo punto il
confronto è avviato da una lettura dei presocratici nella quale la
posizione espressa da Jäger, nel suo libro La teologia dei primi pen satori greci, viene definita “più radicale” di quella di Heidegger.
Infatti, se da un lato è lecito parlare di una teologia dei primi pensatori greci, bisogna però precisare che to theion, il divino, è perié chein apanta, ciò che avvolge tutto e, per questo, non può essere
identificato con un ente separato che funga come “primo da cui”
o come causa. Non può cioè, spiega Gasparotti, «l’inaccessibile e
incondizionata apertura dell’accadere di tutto ciò che accade» essere ridotta a «fondamento obiettivo e determinato» (p. 36), né
costituire oblio della physis originaria. Anzi, se questa idea del divino viene alla parola presso «coloro che Aristotele chiamò hoi
perì physeos (letteralmente “quelli della ricerca sulla physis”)» e se,
per usare le parole del primo di loro che ha parlato, “tutto è pieno
di dei”, «assai arduo sarebbe separare physis e to theion, dio e natura» (pp. 29-30). E si badi che qui la questione non è limitata, come potrebbe sembrare, ai “presocratici”. Questa parola è scritta
295
RECENSIONI
tra virgolette per indicare il suo valore di citazione in quanto essi
lo sono per noi, che viviamo nelle parole della filosofia, di quella
di Platone e di Aristotele innanzitutto. Il “pre” non indica qui
qualcosa che non ci interessa più e che ci siamo lasciati alle spalle,
ma qualcosa come un presupposto, un’eredità verso la quale la filosofia si è posta come riflessione, decidendo in base ad essa di se
stessa. Nel saggio Origine e senso della theoria Ritter sostiene: «La
registrazione dossografica non scaturisce da un interesse storico o
antiquario; Aristotele consulta gli “antichi” come “testimoni”
(Met., XII, 1, 1069 a, 25) e come “consiglieri” (Met., I, 3, 983 b1)
rispetto all’opera della propria filosofia. Il loro consiglio e la loro
testimonianza aiutano a tenere e a conservare la via che il pensiero
aveva originariamente imboccato»1.
«L’apertura dell’orizzonte della domanda attorno a to theion –
che avvolge, abbraccia, pervade l’intera physis e che pure è in noi,
e anche fuori di noi quale ousia a sé e per sé – ... appare come lo
stesso dischiudersi della tradizione filosofica in quanto tale» (p.
26). Con queste considerazioni Gasparotti tocca la “cosa” stessa
della filosofia, la quale non può essere mai qualcosa che possiamo
porci – e tenere – davanti, ovvero definire che cosa essa sia, in un
giudizio adeguato, vero; né un Tu che ci dica che cosa noi siamo e
perché, in un giudizio vero e senza appello. La parola filosofica
non sorge quindi in modo primario, nel suo dire essenziale, che è
un dire l’essenziale, da un “capire” (contenere) e un afferrare, ma
dalla invalicabile, perché umana, condizione finita in cui si trova il
pensiero: avvolto, coinvolto, afferrato. Afferrare e, insieme, nello
stesso tempo, essere afferrato: un dire che è, insieme, un dire-contro e un contra-dire.
Se questa è la questione che «ancora ci assilla» e che ha «a che
fare con una sorta di crux philosophiae sin dalla nascita di quest’ultima» (p. 73), l’esito non deve essere né la fuga nel silenzio né
la semiosi infinita, secondo la quale tutto è interpretazione. A
questa, che sembra essere la vera e propria hybris del nostro secolo, va ricordato qualcosa di semplice che resiste con ostinazione:
che ogni cosa appaia in quanto interpretata non può eludere il
problema dell’interpretato, del che, della base presupposta senza
296
RECENSIONI
la quale l’idea stessa di interpretazione non ha più senso. La “cosa” della filosofia non è perciò l’oggetto del dire, il semplice “detto” nella sua non contraddittoria identità, e «non è neppure fuori
prima del Dire, perché è la parola stessa come gesto (vocale) originario», la quale, pur essendo l’apertura e l’orizzonte del manifestarsi delle parole, delle cose e dei parlanti stessi, presuppone
quel differente irriducibile «da cui il logos, portandolo alla parola,
irrimediabilmente sempre si separa» (p. 99). Astratto il discorso
che si ferma all’identità senza cogliere il differire che dimora nel
dire, la differenza implicata nell’identità. Concreto «un Dire... che
sia in uno il suo stesso contra-dire, realmente al di qua di tutte le
alternative (quali vero-falso, dicibile-indicibile, teoria-prassi, natura-sovranatura, trascendente-immanente) in cui il pensiero occidentale si è superstiziosamente incanalato (rimanendovi vincolato
anche nel suo volerle negare, come ci è stato insegnato molto bene dalla lezione nietzschiana e heideggeriana)» (p. 188).
È una buona cosa, e dobbiamo esserne grati a Gasparotti, il tentativo di restare «al di qua», in particolare, di quella «contrapposizione (astratta essa medesima) tra un pensiero metafisico e un supposto pensiero non metafisico o oltremetafisico» (p. 188), che sta
diventando un luogo comune ormai accettato senza darsi troppo
pensiero, conducendo ad una lettura sempre più asfittica e piatta
dei testi consegnati dalla tradizione. In questo quadro sembra
quindi preclusa una interpretazione in senso esclusivo dell’alternativa fra “astratto” e “concreto”, pena appunto la ricaduta nell’astrattezza. Non resta perciò che considerare il primo termine come, in qualche modo, incluso nel secondo, esprimente una sua
possibilità deiettiva, potremmo dire, emergente ogni qual volta la
filosofia oblia il senso della propria finitezza, che è anche, aggiungiamo per non ingenerare equivoci autopunitivi, la radice della sua
grandezza. Ci pare di dover dire, però, che l’ascendenza indubbiamente hegeliana di questa terminologia non venga sufficientemente tematizzata e chiarita da Gasparotti, né che il senso del suo uso
critico-interpretativo, nella lettura dei filosofi che l’opera affronta,
venga offerto al lettore che si inoltra nelle sue complesse analisi.
Queste perplessità trovano il loro terreno di prova nell’inter297
RECENSIONI
pretazione di Aristotele, che costituisce il nucleo del libro (sulle
belle pagine dedicate a Plotino rinviamo alla lettura diretta del testo, che così bene ha sintetizzato i problemi e le questioni fondamentali emergenti da un esame attento e prolungato delle Ennea di). Cos’è qui il dire concreto? E quale? Quello di Aristotele, che
rimarrebbe al di qua della contrapposizione vero-falso, basata sul
logos astratto ispirato al principio di non contraddizione; o quello
di Gasparotti che così lo interpreta? O concreto è il processo tendente a dissolvere il testo nella interpretazione e l’interpretazione
nel testo, in un gioco che a volte non tiene la distanza, perdendo
così il senso di quel presupposto la cui necessità, pure, era stata
riconosciuta chiaramente.
Per esemplificare quanto detto prenderemo in esame uno degli
argomenti trattati nel libro: quello concernente i concetti, veramente fondamentali, di dynamis ed enèrgeia, che possiamo trovare nel IV capitolo, intitolato “Kinesis. Tracce di un commento alla
Fisica 2”. A questo riguardo, a pagina 13 si dice: la potenza (dyna mis) «viene da Aristotele presupposta come indeterminabile infondatezza di ogni attualizzarsi, la quale attraversa e per-vade ogni
atto» (corsivo nostro). Ora, poiché ci troviamo di fronte ad una
caratterizzazione del concetto di dynamis densa di implicazioni e
dalla quale Gasparotti trarrà non poche delle sue conclusioni, sarà bene fare subito una sosta al fine di saggiarne la consistenza.
Innanzitutto c’è da osservare:
a) il brano citato si riferisce alla confutazione dei Megarici compiuta da Aristotele nel Libro IX di Metafisica, dove però non è del
significato ontologico fondamentale della dynamis che si tratta, ma
di quello più comune usato in relazione al movimento. Ecco che
cosa ne dice Aristotele: «in primo luogo, dobbiamo trattare della
potenza nel suo significato più proprio...»; e qui sospendiamo un
istante per segnalare la traduzione che Heidegger dà di questo
passo, in quanto ci sembra più consona all’intenzione di Aristotele. Il passo, che recita: legetai men malista kyrios, è così tradotto:
«nel significato secondo il quale per lo più questa parola propriamente si usa»2. Fatta questa precisazione possiamo comprendere
meglio il discorso di Aristotele che così prosegue: «... ancorché
298
RECENSIONI
questo significato non sia quello che più serve allo scopo che intendiamo perseguire ora; infatti, le nozioni di potenza e di atto
vanno oltre i significati che sono relativi al solo movimento» (1045
b, 35-1046 a, 2).
b) L’uso, poi, dell’aggettivo “ogni” costituisce una generalizzazione con la quale non si può consentire: c’è infatti una sostanza
che è atto e soltanto atto e il suo valore di posizione è tale da costituire, da sé solo, il fondamento di tutta la fisica aristotelica,
nonché di quella distinzione essenzialissima tra fisica e filosofia
prima che si ripercuote su tutti i luoghi in cui si articola la filosofia di Aristotele. Di questa sostanza si dice in Metafisica XII: «Se,
poi, esistesse un principio motore ed efficiente, ma che non fosse
in atto, non ci sarebbe movimento; infatti è possibile che ciò che
ha potenza non passi all’atto» (1071 b, 12-14). E ancora: «non basta neppure che esso sia in atto, se la sua sostanza implica potenza:
in tal caso potrebbe non esserci un movimento eterno, perché è
possibile che ciò che è in potenza non passi all’atto. È dunque ne cessario che ci sia un Principio, la cui sostanza sia l’atto stesso»
(1071 b, 17-20).
c) A causa di questa attualità che non tramonta mai, le cose che
sono sottoposte alla generazione e alla corruzione non cadono
nell’indeterminazione ma, già nel loro essere in potenza, sono de terminate dall’atto. Per questa ragione Aristotele sostiene, contro
Anassagora e la sua teoria delle omeomerie, che non qualsiasi cosa venga da qualsiasi cosa.
Se, dopo queste schematiche osservazioni, riprendiamo il filo
delle considerazioni di Gasparotti, giungiamo ad una prima conclusione: la potenza «che attraversa e pervade ogni atto» vale
«originariamente come ciò in cui riposa l’essenza dell’essente in
quanto tale» (p. 123). Il limite critico di queste affermazioni appare ora, alla luce delle nostre osservazioni precedenti, più chiaramente. Il termine “ogni” è infatti la leva che ha reso possibile sollevare di peso il discorso dall’ambito dei physei onta, o anche delle cose artificiali, che è quello di cui Aristotele sta realmente parlando, all’on hei on, all’essente in quanto tale, che è ambito diverso non (sol)tanto per il diverso grado di generalità, ma (anche)
299
RECENSIONI
per il nuovo piano concettuale e ontologico sul quale deve portarsi l’argomentazione. Chiarissimo su questo punto, quanto detto in
Metafisica XI (1063 b, 3-7): «tutte le proprietà che si riferiscono
all’essere in quanto essere (on hei on) ... rientrano nell’oggetto
d’indagine di nessun’altra scienza se non della filosofia prima. Alla fisica, infatti, compete lo studio degli enti, ma non in quanto en ti, ma, piuttosto, in quanto essi hanno movimento»3. Come si vede bene, nelle conclusioni di Gasparotti è proprio la distinzione
tra fisica e filosofia prima, cui sopra abbiamo anche noi fatto cenno, e che è il perno dell’ontologia aristotelica, a saltare esplicitamente dopo essere stata ignorata nelle premesse. Sulla base di
questa implausibile generalizzazione, egli può trarre la conseguenza che «l’affermazione di Aristotele del primato e della anteriorità dell’atto sulla potenza» (p. 123) esprime un punto di vista «in realtà paradossale». E in cosa consiste il paradosso? «Che
ogni (c.n.) essente sia attualmente se stesso solo nel suo essere
passato, nel suo essere perfettamente compiuto, ovvero nel suo
non essere più» (p. 119). Qualunque valore si voglia dare alla parola “paradossale”, bisogna chiedersi se questa concezione dell’atto, dell’enèrgeia, la possiamo davvero leggere in Aristotele4.
Quando diciamo che l’opera (ergon) è finita stiamo forse dicendo il «suo non essere più»? Certamente, il lavoro dell’artista è fi nito, è terminato, ma non è finito come è finita, portata a termine,
compiuta l’opera, anzi è proprio in questo suo essere finita, cioè
compiuta, che essa sta, consiste. Come stanno e consistono la
pianta, l’animale, il fiume e la roccia, ciascuna cosa raccolta nell’ambito della propria possibilità, una possibilità determinata,
chiusa nel circolo perenne della generazione e della corruzione, in
quella priorità dell’atto sulla potenza che ha nell’incorruttibilità
del cielo il proprio segno e nell’immobilità del Primo Motore la
propria garanzia. Entelècheia, aversi-nel-proprio-fine, lungi dall’essere anche l’immediato tramontare, significa tenersi (at-tenersi,
man-tenersi) nel proprio fine (che è anche ciò che è buono), disporsi nell’operosa maturità, durare, resistere. E come questo durare non è eterno, ma ha il suo tempo, la sua fine, così di nuovo
dalla pianta il seme e dal seme il virgulto, dalla nuvola la pioggia,
300
RECENSIONI
il fiume e di nuovo il mare: così sempre, da sempre, per sempre.
«Pertanto non ci furono per un tempo infinito Caos e Notte, ma
ci furono sempre le medesime cose, o ciclicamente o in altro modo»5 (Met., XII, 1072 a, 7-9).
NOTE
1
2
3
4
5
J. RITTER, Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel, Frankfurt
a.M., Surkamp, 1969; Metafisica e politica, tr. it. di G. Cunico, Casale Monferrato, Marietti, 1983, p. 3.
M. H EIDEGGER, Aristoteles, Metaphysik 1-3. Von Wesen und Wirklichkeit der
Kraft, in ID., Gesamtausgabe, vol. 33, Frankfurt a.M., V. Klostermann, 1990; Ari stotele, Metafisica 1-3, tr. it. di U. Ugazio, Milano, Mursia, 1992, p. 41.
Si veda anche Metafisica, XII, 1069 a, 30-1069 b, 2.
«Se è vero che anche per Aristotele l’entelècheia è effettivamente il primo e più
fondamentale significato dell’essere (cfr. De anima II, 412 b, 8-9: “poiché l’essere
si dice in più sensi, l’entelècheia è quello principale”), è altrettanto vero che il primo e più fondamentale significato dell’entelècheia non è, per Aristotele, quello
“secondo il movimento”, cioè la “motilità”, bensì quello di “attività”, e soprattutto quell’“attività della immobilità” (enèrgeia akinesìas) che è il pensiero, il pensiero dell’atto puro, cioè il “pensiero di pensiero”» (E. BERTI, Aristotele nel Nove cento, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 110).
Così “conclude” Aristotele anche per V. VITIELLO, in Storia della filosofia , Milano, Jaca Book, 1992, p. 23.
ROMANO GALLERANI
301
L e r ec ens i on i
CARLO GALLI, GENEALOGIA DELLA POLITICA . CARL
SCHMITT E LA CRISI DEL PENSIERO POLITICO MODERNO ,
B O L O G N A , I L M U L I N O , 1 9 9 6,
p p.
X L I I + 9 3 6.
La produzione di Schmitt abbraccia oltre un sessantennio, incrocia tutti gli avvenimenti cruciali del nostro secolo, si irraggia in
ambiti disciplinari distinti e spesso distanti fra loro, si misura con
tutti i principali filosofi, giuristi, politologi coevi, nonché con
molte delle figure più eminenti dell’intera modernità, da Bodin a
Hegel, da Machiavelli a Marx, da Hobbes a Comte. Per altro verso, l’atteggiamento scientifico di Schmitt appare quasi sempre polemicamente orientato e, anche a causa di ciò, poco sistematico (è
questo uno dei motivi della ricorrente accusa di occasionalismo
rivolta al suo pensiero). Né Schmitt rifugge l’impegno politico,
come risulta dalla sua attività nelle ultime, convulse fasi della repubblica di Weimar e nei primi anni del regime nazista. Tutti questi elementi (e altri ancora) si riflettono in una produzione ampia,
complessa e pluristratificata, sostenuta da una rara capacità di
scrittura e di fascinazione retorica che non ha mancato di colpire
anche i suoi più tenaci detrattori. Il libro di Carlo Galli si propone di fare i conti con questo pensiero e con l’imponente letteratura secondaria (di cui il poderoso apparato di note fornisce un accurato ed acuto attraversamento), verificando la possibilità di determinarne il nucleo unitario e l’intenzione più autentica.
A tal fine, l’Autore parte dal concetto di «mediazione moderna», ovvero dal «rapporto razionale, “costruttivistico” e “discorsivo” che il soggetto libero istituisce con l’oggetto e con gli altri
soggetti per negare ogni dato irrazionale e per produrre forma,
ordine» (p. 3). L’ordine, nel moderno, non è alcunché di naturale,
ma è al contrario il frutto di un’attività cosciente del soggetto, o
meglio, dei soggetti che lo creano artificialmente tramite un patto:
«La mediazione moderna da un punto di vista politico è sicuramente il terreno comune della coesistenza pacifica, ma questo ter303
RECENSIONI
reno non può essere che artificiale, formato e progettato attraverso un patto fra soggetti: è nel patto che la mediazione si mostra
tanto costruttiva quanto discorsiva» (p. 5). Quella di Schmitt,
scrive Galli, è «una guisa specifica di critica della modernità» (p.
9) e, in quanto tale, va confrontata, per essere colta pienamente
nel suo carattere, con il pensiero di quegli autori in cui hanno
preso corpo la crisi e la dissoluzione della modernità, lungo un arco concettuale che va da Hegel all’irrazionalismo. Di volta in volta, Galli sottolinea simiglianze e differenze con Schmitt, al cui
pensiero, in generale, viene attribuita una maggiore radicalità,
tanto da risultare l’apice di tale processo critico e dissolutivo (il
che, peraltro, lo consegna irrevocabilmente, nonostante, o forse a
cagione di ciò, all’interno di quel moderno che così decisamente
pone in questione. Schmitt, scrive Galli, procede «oltre la mediazione moderna e le sue ideologie, ma non oltre le esigenze ordinative e i presupposti radicali dell’epoca», p. 11). Significativo a
questo proposito è l’attraversamento di Hegel che, com’è noto, è
una delle figure con le quali Schmitt più spesso si confronta, pur
non pretendendo di essere un esperto del suo pensiero. Hegel coglie all’interno della mediazione moderna una fondamentale aporia, dovuta alla difficoltà di dedurre l’unità dello Stato dalla mera
struttura pattizia propria dello schema giusnaturalistico. Per Hegel, lo Stato «non può scaturire dall’insieme di molteplici privatezze: costitutiva dello Stato non è la somma degli individui portata a unità formale, ma l’Idea della ragione svolgentesi nei suoi
momenti opposti» (p. 14). Si tratta di un punto di forte contatto
con Schmitt, tanto più che Hegel è cosciente dell’«opacità della
politica» (p. 22), che rende indispensabile il momento della decisione sovrana. Ma altrettanto nette sono le differenze: «Se per
Hegel l’Idea passa attraverso la contingenza senza perdersi, per
Schmitt, invece, l’Idea non conosce questo processo di mediazione concreta, dato che il primum del suo pensiero è appunto la
contingenza, la concretezza intesa come la sconnessione di principio fra Idea e realtà, la radicale e originaria assenza di forma e di
ordine» (p. 27).
Anche dal confronto con Weber risultano significative analogie
304
RECENSIONI
– quelle che hanno fatto scorgere in Schmitt un «figlio naturale»
di Weber1 – e forti differenze. Il pensiero di quest’ultimo resta
pur sempre interno ad una prospettiva di «razionalizzazione in direzione statuale» (p. 100) e quindi alla «tradizione tedesca dello
Stato di “potenza”» (p. 101), mentre Schmitt, che nel giovanile
Der Wert des Staates «alla decisione arriva proprio criticando la
Macht» (ibid.), risulta «ancora più radicalmente impegnato nella
decostruzione della mediazione razionale» (p. 102). Né il nichilismo schmittiano (ovvero «ineffettualità come mancanza di concretezza e di forma» p. 128) è sovrapponibile a quello nietzscheano («ineffettualità come mancanza di libertà e di potenza», ibid.),
anche se l’irriducibilità della decisione schmittiana al «soggetto
trascendentale» e alla «razionalità della storia» mostra l’importanza che all’interno della cultura di Schmitt riveste «l’attraversamento della critica nietzscheana e della sua tragica informità» (p.
130). Infine, il pensiero di Schmitt si distanzia da quello della destra tedesca e della rivoluzione conservatrice giacché la sua forza
si trova «non nel contrapporre comunità a società, irrazionalismo
a razionalismo, ma in una critica – radicale, ma ad essa non estranea – delle logiche politiche moderne, in una genealogia della politica moderna che in quanto tale si sottrae, almeno in linea di
principio, ai “dualismi”» (p. 150). Insomma, dinanzi alla crisi irrevocabile della mediazione moderna, o perlomeno ai processi
che egli interpreta in questo modo, la prestazione scientifica di
Schmitt consiste essenzialmente nella estrema radicalizzazione
concettuale di tale crisi allo scopo di cogliere, al bordo estremo
del moderno, l’«origine della politica (come Entstehung e come ar ché)» (p. IX).
Negli ultimi anni, la critica ha individuato in Cattolicesimo ro mano e forma politica uno degli snodi fondamentali del pensiero
schmittiano. In questo breve scritto, Schmitt si interroga sulle ragioni della vitalità politica della Chiesa cattolica e della sua capacità di essere complexio oppositorum. Egli le ravvisa «in una specifica superiorità formale nei confronti della materia della vita umana, quale finora nessun impero ha conosciuto» ( C. SCHMITT, Catto 305
RECENSIONI
licesimo romano e forma politica [1923], tr. it. Milano, Giuffrè,
1986, p. 36). Tale superiorità «si basa sulla rigorosa attuazione del
principio di rappresentazione» (p. 37). Infatti la Chiesa cattolica
rappresenta, cioè rende presente nella persona del papa, un principio divino e altrimenti invisibile. In ciò consiste la sua forza politica, non disgiunta dalla dimensione etica, giacché se «il cattolicesimo è politico in senso eminente» (p. 45) ciò non ha nulla a
che vedere con «il concetto machiavellico di politica» (pp. 22-23).
In ciò, altresì, consiste la superiorità rispetto al «pensiero economico», il quale «conosce soltanto un tipo di forma, la precisione
tecnica, che è lontanissima dall’idea di rappresentazione» (p. 49).
Ma quello di Schmitt non è semplicemente un elogium della Chiesa, quanto l’indicazione di un carattere essenziale di ogni forma
politica che voglia fondare un ordine duraturo e rivendicare con
successo l’obbedienza e il monopolio della decisione: «Nessun sistema politico – scrive Schmitt – può durare anche solo per una
generazione con la sola tecnica della conservazione del potere. Al
“politico” inerisce l’idea, dato che non c’è politica senza autorità,
né c’è autorità senza un ethos della convinzione» (p. 45). Non vi è
forma politica senza riferimento all’Idea e non vi è riferimento all’Idea se non nella forma della Repräsentation. Questa viene così a
costituire la struttura logica che caratterizza l’unità politica moderna. Ciò non significa, rileva Galli, che fra la rappresentazione
della Chiesa e quella dello Stato moderno non vi sia alcuna differenza. Nella prima, infatti, che viene per questo definita «forma
gloriosa», «la decisione sull’eccezione», ovvero la decisione che,
in forza della sua rappresentatività, crea e mantiene l’ordine, «costituisce un che di derivato e, in fondo, di garantito a priori dalla
qualità trascendente dell’eccesso originario» (C. GALLI, Genealo gia..., cit., p. 229). Nella seconda, invece, si accentuano gli elementi di tragicità e infondatezza: «La rappresentazione politica di
cui parla lo Schmitt maturo non consiste insomma nell’istituire
una mediazione “pontificale” o “simbolica” fra Cielo e Terra...,
ma in un crear forma che implica l’assumere il “taglio”, la cesura
fra idea e realtà, e nel restare in tale “de-cisione” moderna. È solo
quest’assenza epocale dell’Idea, solo la sua impossibilità di realiz306
RECENSIONI
zarsi pienamente, infatti, che rende necessaria la sua rappresentazione» (p. 251). Tale concezione conoscerà così la sua piena
esplicazione in Teologia politica e nella Dottrina della costituzione,
ove trovano sistemazione le acquisizioni teoriche realizzate da
Schmitt non solo in Cattolicesimo romano, ma anche negli scritti
degli anni dieci, di impronta specificamente giuridica, vale a dire
Gesetz und Urteil (1912) e Der Wert des Staates und die Bedeutung
des Einzelnen (1914)2. In Teologia politica il problema è quello
della Rechtsverwirklichung, ovvero della realizzazione dell’Idea
del diritto. Giacché l’idea, in quanto tale, non può manifestarsi
immediatamente, necessita di un’istanza intermedia, la sovranità,
capace di renderla presente. Ma il fatto che l’idea possa manifestarsi solo in forma mediata, solo mostrando la sua irriducibile
trascendenza, rivela altresì la radicale infondatezza della forma politica moderna, la cui rappresentatività è sempre esposta al rischio
di non essere creduta. «La sua origine – scrive efficacemente Galli
– non è fondamento, ma abisso» (p. 335); la sovranità «entra all’interno dell’ordine giuridico, lo forma deformandolo, lo determina indeterminandolo» (p. 340). Insomma, l’idea non è fonda mento, né potrebbe esserlo senza perdere il suo carattere di idea,
ma origine del politico e la sostanza etica dello Stato consiste nel
compito infinito di realizzare in forma rappresentativa, vale a dire
non garantita e infondata, tale idea, nell’assunzione cioè del ri schio della rappresentazione.
Nemmeno nelle forme più radicali di democrazia diretta – rileva Schmitt nella Dottrina della costituzione – nemmeno quando
«tutto il popolo, cioè tutti i cittadini attivi, è effettivamente riunito
in piazza» si può dire che il popolo sia immediatamente presente.
Infatti «anche tutti i cittadini attivi presi insieme non sono in
quanto somma l’unità politica del popolo, ma rappresentano l’unità politica che è superiore all’assemblea riunita nello spazio e al
momento della riunione» (C. SCHMITT, Dottrina della costituzione
[1928], tr. it. Milano, Giuffrè, 1984, p. 272. Il corsivo è nostro).
Se l’essenza della forma politica moderna si compendia nel nesso idea/rappresentazione/decisione, il limite del «sogno moderno
307
RECENSIONI
(inevitabilmente destinato ad un esito “tecnico”)» (C. G ALLI, Ge nealogia..., cit., p. 362) consiste nel’«oblio dell’origine», nella pretesa cioè di creare un ordine perfettamente pacificato, stabile, ridotto ad assoluta calcolabilità e prevedibilità, dimenticando che
esso paradossalmente riposa «sull’assenza di Ordine» (p. 362). È
ciò che Galli, con riferimento alla conferenza schmittiana L’epoca
delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni, chiama «neutralizzazione passiva» la quale, proprio perché ignara della propria origine, finisce con l’essere «essenzialmente disordinata, astratta e instabile» (p. 367) e incapace di realizzare il proprio compito, vale a
dire la realizzazione dell’ordine e la vigenza delle norme. Essa culmina sul piano politico con l’affermazione del liberalismo e su
quello giuridico con l’avvento del positivismo giuridico, il cui
massimo esponente è Kelsen. Di qui la necessità di Schmitt, che
avverte di trovarsi al bordo estremo dell’epoca moderna e della
sua vicenda plurisecolare, di «ripensare» l’origine in un estremo
tentativo di rivitalizzare lo Stato e di porlo all’altezza delle sfide
del presente. In questo snodo si situa il suo confronto con Hobbes. In Hobbes, infatti, Schmitt vede compendiata l’intera parabola della forma politica moderna. Egli è tanto «il pensatore...
della decisione puntuale che crea l’unità della forma politica,
quanto della deriva per cui l’unità politica razionale si fa astratta e
meccanica, tecnica e legalistica» (p. 786), come appare ne Il Le viatano nella dottrina dello Stato di Hobbes. Qui, infatti, Schmitt
individua nella separazione fra pubblico e privato, che si rivela
pienamente a proposito della trattazione del problema dei miracoli3, il varco attraverso cui il Leviatano potrà essere «privato, dall’interno, della sua stessa anima» (C. SCHMITT, Il Leviatano nella
dottrina..., [1938], tr. it. in ID., Scritti su Thomas Hobbes, Milano,
Giuffrè, 1986, p. 107). Ma Hobbes è soprattutto il pensatore che
pone la nozione di rappresentanza a base della sua costruzione
teorica4 e con essa l’impossibilità della fondazione dell’unità politica: «Hobbes lascia ben vedere, per Schmitt, che in realtà l’ordine
politico non è meccanicamente deducibile dalle ragioni individuali, dalle logiche del contratto, e che la sovranità rappresentativa
personale non è riconducibile ad un’origine pattizia né si esauri308
RECENSIONI
sce nella protezione della vita dei singoli, ma è trascendente» (C.
GALLI, Genealogia..., cit., p. 791). Insomma, «Il Leviatano non è
costituito dal patto, quanto piuttosto ne è evocato... L’ordine politico non ha nel patto la propria origine ma soltanto la propria occasione» (p. 792).
Nemmeno il celeberrimo Il concetto di politico ha valenza fondativa. Da questo punto di vista, hanno ragione coloro che hanno
rimproverato alla dicotomia amico/nemico tanto l’assenza di una
definizione positiva dell’amico quanto il fatto di presuppore quel
fenomeno, la conflittualità interumana, che invece si vorrebbe
spiegare (ma è lo stesso Schmitt, nella Postilla all’edizione del
1932 del saggio, a sottolineare di aver voluto soltanto «inquadrare
teoricamente un problema di portata smisurata» e che «le singole
affermazioni sono pensate come altrettanti punti di partenza», C.
SCHMITT, Il concetto di politico [19323], tr. it. in ID., Le categorie del
politico, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 185). In ciò non è ravvisabile – come pretenderebbero quei critici – un limite della riflessione
di Schmitt, ma la conferma del carattere della sua interpretazione
del moderno: «Circolarità e assenza di sostanza sono inevitabilmente implicite – scrive Galli – ... nel “politico” come origine della politica moderna» (C. GALLI, Genealogia..., cit., p. 742). Ne Il
concetto di politico, dunque, Schmitt «non vuole determinare l’essenza della politica, dato che nel ‘politico’c’è piuttosto la scoperta
della mancanza di essenza – e quindi di stabilità – di ogni ambito
della moderna vita associata» (ibid.).
Negli anni cruciali di Weimar, che sono anche quelli nei quali
definisce nei suoi caratteri essenziali il proprio pensiero, Schmitt
ritiene che comunque sia ancora possibile “rivitalizzare” la formaStato coniugando la rimemorazione dell’origine con una legittimazione forte di tipo plebiscitario. La finalità politica perseguita
da Schmitt nei testi di quel periodo è quella di fare del Verbändes staat weimariano, debole e alla mercè delle parti, uno Stato totale
«per energia», all’altezza dei compiti posti nel primo dopoguerra
dal superamento della dicotomia Stato/società e dal rivoluzionamento del plesso politica/economia5. Le vicende tragiche tanto
309
RECENSIONI
della repubblica di Weimar quanto del nazismo dissolveranno in
via definitiva queste illusioni. In un testo cruciale concepito fra il
1943 e il 1944, Schmitt, anche di fronte alla fine ormai ineluttabile del Terzo Reich e comunque nel mezzo dell’infuriare del
conflitto mondiale, sottolinea come questi eventi dolorosi siano in
qualche modo il risultato dell’abbandono della civiltà giuridica
dello Jus publicum europaeum e della sua specifica razionalità, erede del diritto romano (cfr. C. S CHMITT, La condizione della scienza
giuridica europea [1950], tr. it. Roma, Pellicani, 1996). Qui egli
comincia a vestire i panni dell’ultimo rappresentante e custode di
questa razionalità, dello scienziato il quale – come scriverà alcuni
anni dopo – non si aspetta dall’uso oculato della propria sapienza
null’altro che la possibilità di «conservare i concetti e chiamare le
cose col loro nome» (C. S CHMITT, Teoria del partigiano [1963], tr.
it. Milano, 1981, p. 76). Questo atteggiamento (non si sa quanto
autentico e comunque sicuramente polemico nei confronti dell’ostracismo che l’aveva colpito per le sue compromissioni naziste)
di ripiegamento su se stesso e di dolente e distaccata riflessione
sulle vicende del mondo sarà caratteristico dell’intera produzione
del secondo dopoguerra, da Ex captivitate salus sino all’ultima
grande opera, Il nomos della terra, del 1950. Comunque, rileva
Galli, «la teoria del nomos non è radicalmente alternativa rispetto
all’assetto genealogico del pensiero schmittiano» (C. GALLI, Ge nealogia..., cit., p. 880). Infatti la nozione di nomos, insieme di
Ordnung e Ortung, comporta necessariamente un’originaria Land nahme. Essa dunque «è un evento “costitutivo” strutturato come
il potere costituente; e, come sempre, anche qui la concretezza
dell’ordine è data dal suo consapevole insistere su questo sfondamento» ( p. 882).
Così, anche a quest’altezza si conferma la circostanza che la
forza ermeneutica di Schmitt nei confronti del moderno è direttamente collegata alla sua internità ad esso. È in questa capacità
epigonale di comprendere la propria epoca che si manifesta la radicalità della riflessione di Schmitt, lo spessore filosofico della sua
interrogazione. Essa trova il suo cardine nel rapporto idea/rappresentazione e nella costitutiva ulteriorità della prima rispetto al310
RECENSIONI
la seconda6. Ciò rende possibile – come si è visto – l’apertura al
problema dell’origine: un gesto che mette definitivamente in mora
ogni pretesa fondativa, cogliendo il carattere strutturalmente aporetico della forma politica moderna.
È in conseguenza della tragica consapevolezza di tale circostanza che l’ultimo Schmitt accentua il carattere apocalittico del suo
pensiero. Infatti, una delle immagini più ricorrenti utilizzate in
questa fase per rappresentare il sistema di Stati europei e lo Jus
publicum europaeum è quella paolina del katechon, di una forza
cioè che può solo controllare e rallentare un processo dissolutivo
comunque ineliminabile. Come si legge nel diario di Schmitt alla
data 11-1-1948: «Noi siamo sempre – come nel ’500 o nell’’800 –
nell’Eone cristiano, sempre in agonia, e tutti gli avvenimenti essenziali non riguardano altro che il katechon, cioè “ciò che tiene”,
qui tenet nunc» ( C. S CHMITT, Glossarium, Aufzeichnungen der Jah re 1947-1951, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, p. 80).
NOTE
1
2
3
4
Cfr l’intervento di HABERMAS in O. S TAMMER (a cura di), Max Weber e la sociolo gia oggi (1965), tr. it., Milano, Jaka Book, 1967, pp. 106-107.
Si tratta di scritti che per lungo tempo la critica – generalmente tesa ad esaltare,
con finalità critico-polemiche, l’aspetto decisionistico del pensiero di Schmitt –
ha sottovalutato, relegando ad una pretesa fase normativistica e giovanile. Vale la
pena di ricordare come già nel 1964 H. HOFMANN, nel suo sempre valido Legiti mität gegen Legitimität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, Neuwied und Berlin, Luchterhand, avesse criticato quest’interpretazione parlando significativamente, a proposito di questi scritti, di «rechtstheoretischer Dezisioni smus» (p. 23). Per altro verso, la non estraneità dei primi scritti schmittiani almeno all’ambiente neokantiano, è testimoniata dalla recensione di Gesetz und Urteil
apparsa sui “Kant-Studien” del 1912 a firma di FELIX HOLLDACK, il quale sottolinea l’«influsso» esercitato sul saggio schmittiano «dalla filosofia scientifica di
orientamento kantiano» (p. 466).
Cfr. T. H OBBES, Leviathan, cap. XXXVII (tr. it., Firenze, La Nuova Italia, 1976,
p. 493) e cap. XLII (tr. it., p. 493).
Scrive infatti HOBBES (Leviathan, cap. XVI, tr. it. p. 159): «Una moltitudine di
uomini diventa una persona, quando è rappresentata da un uomo o da una persona, per modo che diventi tale con il consenso di ciascuna particolare compo311
RECENSIONI
5
6
nente la moltitudine. Infatti è l’unità del rappresentatore, non l’unità del rappresentato, che fa una la persona, ed è il rappresentatore che sostiene la parte della
persona e di una persona soltanto; l’unità in una moltitudine non può intendersi
in altro modo».
Per una discussione di questo spezzone della riflessione schmittiana, con riferimento al nesso tutto/parti e alla nozione di Verbändesstaat, mi permetto di rimandare al mio Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi, Milano,
Angeli, 1996, pp. 43-57.
Che il problema della rappresentazione possa presentarsi «come lo stesso problema che sta alla radice della filosofia», è stato sostenuto da G. DUSO, La rappresen tanza: un problema di filosofia politica, Milano, Angeli 1988, p. 38. Vale a questo
proposito anche il rimando al seguente passo di W. B ENJAMIN, Il dramma barocco
tedesco (1928), tr. it. Torino, Einaudi, 1970 2, p. 7: «È proprio della letteratura filosofica ritrovarsi da capo ad ogni sua svolta di fronte alla questione della rappresentazione».
A NTONINO SCALONE
312
INDICE
del numero uno (1996)
Il tema
ISAAC NEWTON E IL TRATTATO SULL’APOCALISSE
INTRODUZIONE
G IULIO GIORELLO
NEWTON E L’APOCALISSE
MAURIZIO M AMIANI
NEWTON E L’INVETERATO ERRORE DELLE QUATTRO MONARCHIE
MA R I O M I E G G E
I saggi
La teoria delle grandi congiun -
IL FATALE RITMO DELLA STORIA
zioni astrali tra XV e XVI secolo
M A R C O BE R T O Z Z I
SULL’ALIENAZIONE COME FORMA DEL MODERNO
Note cartesiane
P A O L O PU L L E G A
HUME E TRENCHARD
PAOLA Z ANARDI
VALENTÍN DE FORONDA
La difesa delle libertà individuali nelle
Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y
sobre las leyes criminales (1789-1794)
SI M O N E T T A SC A N D E L L A R I
La riscoperta
IL PERNO GEOGRAFICO DELLA STORIA
L A T E R R A E I L S U O CUORE
l ’Heartland
H A L F O R D JO H N MA C K I N D E R
Halford Mackinder e la teoria del -
MASSIMO ROCCATI
L’ i n e d i t o
LETTERA A CATERINA DI RUSSIA
G IACOMO CASANOVA
NOTA ALL’I S T A N Z A DI CASANOVA
313
P AOLO PULLEGA
Questo numero
della rivista “I castelli di Yale”
è stato stampato in 500 esemplari
presso la tipografia “La Casa Editrice”
di Bologna nel mese di dicembre 1 9 9 7