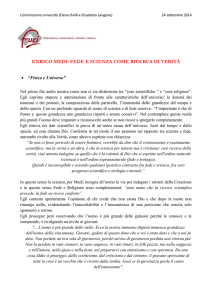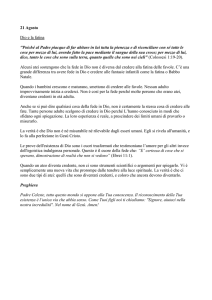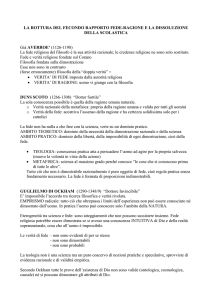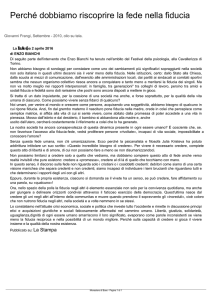La diceria immortale
[1]
Come se Dio fosse
Collana diretta da
Sergio Belardinelli
Titolo originale dell’opera: Das unsterbliche Gerücht. Die Frage nach Gott und die
Täuschung der Moderne
Klett-Cotta © 2007
J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart
© Edizioni Cantagalli s.r.l.
Siena, ottobre 2008
Traduzione dal tedesco: L orenzo Cappelletti
Silvia K ritzenberger
Grafica di copertina: A nna M aoloni
Redazione: Simonetta Catalano
Stampato da Edizioni Cantagalli
nell’ottobre 2008
ISBN 978-88-8272-370-5
Robert Spaemann
La diceria immortale
La questione di Dio
o l’inganno della modernità
PREFAZIONE
Sergio Belardinelli*
“Che esista un essere chiamato ‘Dio’ è un’antica e intacitabile diceria. Questo essere non è una parte di ciò che accade
nel mondo; è piuttosto fondamento e origine dell’universo.
Si deve tuttavia alla diceria anche il fatto che tracce e indicazioni di questa origine si trovino nel mondo stesso. E soltanto
in questo sta il fondamento del perché su Dio si possano dire
diverse cose”.
È un libro straordinario, questo di Robert Spaemann. Un
libro filosofico su Dio, che, contrariamente a quanto avrebbe
detto Pascal, è anche il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe
e di Gesù Cristo; un libro che tocca nel profondo le nostre inquietudini e i temi più scottanti della nostra epoca obbligandoci a una radicalità, alla quale forse non siamo più abituati,
ma che, con il suo stile inconfondibile, Robert Spaemann sa
rendere piana, avvincente e convincente. A Dio bisogna credere, non perché fa comodo per padroneggiare le contingenze della vita individuale e sociale o perché ci aiuta a diventare
più buoni, ma semplicemente perché egli esiste. È solo perché
Dio esiste che esistono la verità e la realtà, che tutto è bene e
tutto viene riscattato, che tutto ha un senso. Funzionalismo,
evoluzionismo e persino la genialità di Nietzsche non reggono
il confronto con questa “diceria”.
*
Direttore della collana Come se Dio fosse, professore ordinario di Sociologia dei
processi culturali nella Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” dell'Università di
Bologna.
5
Guardare la religione esclusivamente dal punto di vista
delle sue funzioni (sociali, culturali o psicologiche) equivale
a relativizzare l’assoluto che la costituisce e quindi a perderne
l’essenziale. “La religione è lo sguardo sul mondo sub specie divinitatis”, dice Spaemann. Volerla ridurre a qualsiasi altra cosa,
prescindendo dal Dio di cui parla, è come voler costruire “una
teoria solipsistica dell’amore, la quale astragga appunto dal
fatto di essere qualcosa che ha luogo tra due persone”. Non a
caso, secondo Spaemann, la risposta migliore alla domanda
“perché la religione?” è un’altra domanda: “perché esistiamo?”;
la sola risposta capace di non bloccare la strada attraverso la
quale gli uomini diventano problema a se stessi. In questa prospettiva vengono anche problematizzate le pretese di un certo
evoluzionismo, oggi assai di moda, secondo il quale la presenza dell’uomo sulla terra sarebbe da ricondurre a una semplice
casualità. La provocazione di Spaemann in proposito è tanto
geniale quanto semplice: “Se da un sacchetto tirassimo fuori
a caso delle lettere dell’alfabeto e, gettandole per terra, venisse
fuori il Prologo del Vangelo di Giovanni, tutto ciò potrebbe anche
essere casuale. Ogni combinazione è possibile e ugualmente
probabile quanto un’altra. Ma in una situazione del genere
nessun uomo crederebbe davvero al caso; piuttosto ognuno
cercherebbe di capire dove sta il trucco. Ovviamente chiunque escluda per motivi metodologici ipotesi sovrannaturali
può insistere sulla possibilità del caso, anche a costo di finire,
con tale naturalismo, nel fantastico. Ma costui non potrebbe
più prestar fede a se stesso”.
Più articolato e stringente è il confronto con Nietzsche, il
filosofo della morte di Dio, colui che aveva indicato nell’ateismo l’approdo inevitabile dell’Illuminismo e, insieme, l’autodistruzione dell’Illuminismo stesso, almeno in ciò che
concerne la pretesa illuministica di dire la verità meglio di
6
quanto abbiano fatto i classici e il cristianesimo. Se Dio non
esiste, allora non esiste neppure la verità: questa la convinzione di Nietzsche che Spaemann approfondisce, mostrandone il
carattere epocale, soprattutto per quanto riguarda il rapporto
inscindibile che Nietzsche pone tra l’esistenza di Dio, della verità e del nostro essere persone. Attraverso Nietzsche impariamo che “noi decidiamo, uno actu, se pensiamo un assoluto, se
pensiamo questo assoluto come Dio, se riconosciamo qualcosa come una verità che non sia relativa a noi stessi, e infine se
riteniamo plausibile una considerazione di noi stessi come esseri capaci di verità, ovvero come persone”. L’idea nicciana del
superuomo avrebbe dovuto rappresentare l’alternativa, una
sorta di equivalente funzionale, a questa serie di “idiosincrasie” cristiane. Ma, oggi lo vediamo abbastanza bene, nemmeno il suo nichilismo eroico ha saputo tenere lontana la miseria
dell’“ultimo uomo”, colui che confida soltanto nei suoi piaceri,
dileggiando l’amore, la creazione, la nostalgia e le stelle.
Dicevo all’inizio che il Dio dei filosofi, di cui parla
Spaemann, è lo stesso Dio dei profeti e di Gesù Cristo. L’uno
e l’altro, in questo libro, non soltanto si sostengono reciprocamente, ma, quasi in ogni pagina, danno anche prova di quanto la loro conciliazione sia necessaria. La creazione, il peccato
originale, la forza redentrice della sofferenza non sono soltanto i dogmi di una fede, ma forse i soli grimaldelli, grazie ai
quali la ragione può veramente mantenersi fedele alla realtà,
alla verità e, in ultimo, a se stessa. La fede si arricchisce grazie alla filosofia e quest’ultima sembra guadagnare in capacità
di comprensione, grazie alla fede. Straordinaria in proposito
la lettura che viene fatta dell’epoca moderna attraverso la nozione del peccato originale e, soprattutto, attraverso gli equivalenti funzionali che una cultura impregnata di naturalismo,
spiritualismo, individualismo e volontà di dominio si è, di
7
volta in volta, inventata per venire a capo di qualcosa che non
era più in grado di comprendere: appunto il male nell’uomo.
Ugualmente straordinarie le pagine sulla concezione cristiana
della sofferenza e, alla fine, l’intervista concessa da Spaemann
a David Seeber nel 1988.
“La fede – dice Spaemann nella suddetta intervista – vuol
comprendere ciò che crede. Non si può credere in qualcosa
senza senso”. Mutatis mutandis, non sarebbe male che questo
monito, oggi, venisse fatto proprio anche dalla ragione.
8
La diceria
immortale
Introduzione
Delle cose degli uomini si può parlare in due modi: da
una prospettiva interna e da una esterna. Pensiamo per
esempio ad una giovane coppia che stipula una polizza per
un’assicurazione sulla vita. Di che cosa si tratti, in questo
caso, è ovvio: i due vogliono, in vecchiaia, poter riscuotere
una certa somma e proteggersi così dal rischio di finire in
povertà. Se aveva senso stipulare tale polizza, si vedrà soltanto nel momento in cui l’evento assicurato avrà luogo e la
somma verrà versata. Per il momento, i due giovani devono
fidarsi della solidità della società assicuratrice e pensare che
la liquidità sarà sufficiente. Questa polizza, però, ha anche un
profilo esterno, che non dipende dal fatto che questa fiducia
sia giustificata o meno. Il comportamento della coppia può
essere oggetto di ricerche di natura sociologica e psicologica.
Si può analizzare quante giovani coppie stipulano un’assicurazione di questo genere, e in base a quali fattori. Ci si può
chiedere quali effetti abbia una polizza del genere sullo stile
di vita delle persone, sul loro sentimento della vita, sul loro
comportamento da consumatori, sulla stabilità della loro relazione, sulla loro disponibilità a correre rischi, nonché sulla
loro disponibilità a mettere al mondo dei figli. La prospettiva esterna assicura alcune conoscenze, ma sussiste a partire
dalla prospettiva interna. Se la coppia fosse convinta che l’assicurazione non è in grado di onorare il contratto nel caso
si verifichi l’evento assicurato, non lo stipulerebbe, e tutti gli
altri aspetti non avrebbero alcun fondamento.
In questo senso l’apostolo Paolo scrive ai Corinzi: “Ma
se Cristo non è risuscitato, allora è vana [...] la nostra fede”
11
(cfr. 1Cor 15,14). Infatti, la religione cristiana, avendo un profilo
interno e uno esterno, si trova nella stessa situazione di tutte le
cose degli uomini. Il suo profilo interno è costituito dalla fede
nella realtà di Dio e dalla speranza della vita eterna presso Dio.
Ma finché è fede che vive in questo mondo, essa adempie, allo
stesso tempo, varie funzioni sociali e psicologiche: ha delle ripercussioni sullo stile di vita degli uomini e sul loro stato d’animo. Non può, però, essere definita a partire da questi effetti. Sta
o cade insieme al suo contenuto cognitivo. «Questa è la vita
eterna», dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, «che conoscano
te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv
17,3). E anche la frase spesso citata della prima lettera a Timoteo, «Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati...», senza la
seconda parte, che dice: «... e arrivino alla conoscenza della verità» (1Tim 2,4), non è completa, anzi, trae in inganno.
Il mondo è pluralistico, e lo è sempre stato. In un mondo
pluralistico, però, prospettiva interna ed esterna sono inevitabilmente in concorrenza l’una con l’altra. Chi vede delle persone ballare, ma non sente la musica, non capisce i movimenti
che osserva. E così, chi non condivide la fede cristiana sarà
incline a spiegarla attraverso qualcosa di diverso dalla verità
del suo oggetto. E, in ultima analisi, non comprenderà il fedele.
Chi vive nella prospettiva interna si attiene alle parole di San
Paolo: «L’uomo spirituale giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno» (1Cor 2,15).
Chi, però, è incapace di calarsi nella prospettiva esterna,
in base alla quale la religione cristiana è una concezione del
mondo tra altre, diventa un settario o un fanatico che si chiude
nei confronti dell’universalità della ragione. La fede cristiana
postula la medesima universalità della ragione. Anzi, pretende
dalla ragione che non resti indietro rispetto al suo concetto, e
constata che resta indietro se omette la domanda su Dio. Ma
12
sa anche che il giudizio dell’“uomo spirituale”, come verità
universale, integrante qualsiasi prospettiva esterna, si rivelerà
soltanto alla fine dei tempi.
Intanto, corrisponde alla verità delle cose parlare la lingua
di tutte e due le prospettive, a seconda delle circostanze nelle
quali ci troviamo e delle persone con le quali parliamo. I testi
qui raccolti fanno questo. Ci sono riflessioni “dall’esterno”, appartenenti piuttosto alla religione come disciplina scientifica,
ma anche conferenze, nelle quali Gesù è chiamato “il Signore”,
che sono rivolte ai fratelli cristiani che sanno di chi si parla. E
infine ci sono testi nei quali l’autore, sulla base di un discorso
razionale di per sé aperto a tutti gli uomini, riflettendo su Dio si
rivolge ad ascoltatori o lettori pronti a una riflessione del genere.
Infatti egli crede, contrariamente al grande Pascal, che il Dio
dei filosofi non sia altro che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, come anche che la stella del mattino non sia altro che la
stella della sera. D’accordo con Platone, l’autore crede che sia
un uomo davvero misero chi non è disposto a riflettere in profondità su ciò che, se fosse vero, sarebbe la cosa più importante,
anzi, l’unica cosa che conta veramente (Platone, Fedone 85b).
È sempre Platone che fa dire a un interlocutore di Socrate che
bisogna «prendere la migliore e la più inconfutabile delle opinioni umane su questo argomento cercando di navigare su di
essa come su una tavola di legno, attraverso la vita, finché non si
possa viaggiare più sicuri e con meno pericoli su un veicolo più
solido o su un Logos divino» (Fedone 86a).
Il veicolo più solido sembra essere la filosofia. La fede che
il Logos divino si è fatto carne per far sì che si possa viaggiare
su di lui, secondo Sant’Agostino è l’unica cosa che distingue “i
nostri” dai Platonici. Platone stesso non è chiamato in causa da
questa distinzione in quanto, ai suoi tempi, l’avvenimento non
era ancora accaduto.
13
La diceria immortale
1. Negli anni Settanta, dai gulag della Siberia ci giunse la
voce di Andrej Sinjavskij che si definiva “una voce del coro”:
“Abbiamo pensato fin troppo intorno all’uomo. È ora di pensare a Dio”. Se Dio c’è, è sempre ora di pensare a Dio. Alcune
situazioni, tuttavia, sembrano più adatte di altre a ricordarci
questo. Ma che cosa si pensa quando si pensa a Dio? Non è già
abbastanza pensare a Lui? Si può pensare qualcosa su di Lui?
Se esiste, Egli è la fine del pensare. Anche il pensiero che Dio
non esista è la fine del pensare. Ma un altro tipo di fine. Non,
come il pensare a Dio, sovrabbondante conferma del pensare,
ma la sua auto-confutazione. La luce e l’oscurità sono, anche
se in modo opposto, la fine del vedere.
2. Che esista un essere che nella nostra lingua si chiama
“Dio” è una vecchia diceria che non si riesce a mettere a tacere. Questo essere non fa parte di ciò che esiste nel mondo.
Dovrebbe essere piuttosto la causa e l’origine dell’universo. Fa
parte della diceria, però, che nel mondo stesso ci siano tracce
di quest’origine e riferimenti ad essa. E questa è la sola ragione
per cui su Dio si possono fare affermazioni diverse.
3. Finora nessuno ha percepito Dio in modo diretto, fatta la
ben nota, unica eccezione di Colui che chiamò Dio suo Padre
e che, se dobbiamo credere ai cronisti suoi contemporanei,
avanzò la pretesa di parlare per esperienza immediata della
frequentazione di Lui, e di essere, di conseguenza, autorizzato
a modificare le concezioni che il mondo ebraico circostante
aveva di Dio. Non avanzò nuove ragioni per l’ipotesi della Sua
esistenza. In quel mondo non era controversa. Inoltre, le modificazioni non erano così fondamentali da rendere necessario
15
rifiutare il nome proprio ebraico JHWH che, secondo la tradizione ebraica, sarebbe stato trasmesso agli ebrei da Dio stesso
perché ne facessero uso: uso che peraltro consisteva soprattutto nel tacerlo. Gesù non insegnò un altro Dio, ma piuttosto
parlò diversamente del medesimo Dio: «Chi mi glorifica è il
Padre mio, del quale voi dite: È nostro Dio, e non lo conoscete.
Io invece lo conosco» (Gv 8,54-55).
4. Sebbene il nome JHWH, come nome proprio, all’inizio
sia servito a distinguere il loro proprio Dio dagli altri “dèi”,
già il significato di questo nome “io sono” implicava una pretesa di singolarità da parte di Colui che lo portava. L’origine
dell’universo materiale e di un “mondo spirituale”, ammesso
che un mondo del genere esista, può essere soltanto una, almeno nella misura in cui “creazione” non voglia dire soltanto
“dar forma” a un caos preesistente, ma presupponga una forza
metafisica che chiami dal non-essere all’esistenza. Una volta
che gli ebrei furono entrati a far parte del mondo ellenistico
avvenne l’identificazione di JHWH con Colui che i filosofi chiamavano quasi automaticamente, in contrapposizione
all’antico Pantheon, “il Dio”.
5. Era ancora estranea a questa epoca l’intentio obliqua filologica e relativistica che tenta di annullare questa identificazione sulla base del fatto che pensiero ebraico e pensiero greco
sarebbero incompatibili. Il pascaliano «Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe, non il Dio dei filosofi» sembra già tener
conto di una tale incompatibilità. Ma un aperçu relativistico
Pascal non l’avrebbe fatto suo. Quell’espressione manifesta
semplicemente due diverse modalità di esperienza.
6. Qui viene a proposito la distinzione che opera Frege tra
“senso” e “significato” di un termine – nomen intentionis e nomen rei, secondo la terminologia scolastica. “Stella della sera”
e “stella del mattino”, in una poesia, possono avere funzioni
16
del tutto diverse. Significano però la medesima stella persino
quando chi usa queste parole neanche lo sa. Nei testi letterari,
non c’è alcuna referenza, alcun significato al di là del senso. Le
immagini metaforiche usate in tali testi non sono nient’altro
che ciò che l’autore ci racconta o evoca, o che emerge da tali
racconti o evocazioni. Due immagini non sono mai identiche
se l’autore non aveva l’intenzione di presentarle come identiche. È compito della critica letteraria, così come spetta all’ermeneutica biblica, far emergere non soltanto le differenze tra
testi biblici ebraici e testi filosofici greci, ma anche quelle tra gli
stessi testi biblici. Il fatto, però, che oggi molti teologi rinuncino alla concomitante intentio recta, e cioè alla questione della
referenza, al “significato” al di là del “senso” dei testi, e di conseguenza alla questione della loro convergenza, è veramente
indizio di una theologia etsi Deus non daretur. Il suo tema sono
soltanto i testi. Ma soltanto testi significa: fiction.
7. Ci sono catechismi che invece di cominciare con l’insegnamento su Dio e sulla creazione, cominciano con la storia dell’esodo di Israele dall’Egitto. Trattano il racconto della
creazione nella intentio obliqua della storia della sua genesi. Rescindono il legame reale, della tradizione della diceria su Dio,
che lega cristianità e giudaismo. Non si litiga più con gli ebrei,
perché l’oggetto comune, sul quale si poteva litigare, è andato
perso a favore della vaga presa di coscienza di una filiazione
storico-religiosa. De gustibus non est disputandum. Se esistono
soltanto immagini di Dio, ma nessun Dio, tutti coloro che praticano tale iconolatria si possono accettare a vicenda nel nome
di quel “modo di sentire che afferma di trovare tutto buono,
a modo suo”; affermazione della quale Hegel scrive che «fa
violenza alla ragione, la quale non approva qualcosa proprio
perché è un modo». Se il termine Dio ha un “significato”, e
cioè, se, al di là di tutto quel che con esso si può intendere, c’è
17
qualcosa che corrisponde ad esso nella realtà, allora gli ebrei,
i cristiani, i musulmani, nonché i testi della filosofia classica
europea, intendono la stessa cosa quando parlano di Dio, e
continua a essere significativo perciò discutere, su come se ne
deve parlare, per parlarne in modo giusto.
8. Perché limitarsi a Israele e ad Atene quando si deve parlare di Dio? Non si potrebbe, con Spinoza, usare la parola “Dio”
almeno laddove si pensi come fondamento un assoluto che
in nessun modo è relativo all’esserci di qualcos’altro di reale?
Ancora: non si potrebbe chiamare Dio l’insieme di ciò che è,
quando non venga pensato in modo riduttivo, e cioè in modo
che pur dovendo spiegare ciò che c’è di meglio, al contempo
lo riduce (il caso del materialismo)? Oppure: non si potrebbe
chiamare “Dio” quell’assoluto che, pur non spiegando niente di ciò che è, fa sì che esso si riduca a puro apparire, come
l’essere di Parmenide o il nirvana del buddismo? Possiamo
usare la parola “Dio” come vogliamo. Ma quando ci teniamo alla univocità della referenza, allora non siamo così liberi.
Certezza della referenza c’è soltanto laddove ci riferiamo non
a qualcosa, ma a qualcuno. L’idea di “Dio” nel suo significato
usuale, ispirato alla tradizione biblica, intende l’assoluto come
persona. Mentre si direbbe rimanga più vicino alla sua origine
mitologica nelle rappresentazioni panteistiche o buddiste. Soltanto se Dio è qualcuno, però, sembra fare una chiara e specifica differenza il fatto di presumere l’esistenza di Dio, negarla
o considerarla dubbia.
9. Quale differenza? Il Signor K. di Bertolt Brecht, quando
gli viene chiesto se un Dio c’è, risponde pragmaticamente: “Ti
consiglio di riflettere se il tuo comportamento cambierebbe
in base alla risposta alla domanda. Se non cambiasse, allora
potremmo anche lasciar perdere la domanda. Se invece cambiasse, allora posso esserti di aiuto almeno dicendoti: tu ti sei
18
già deciso. Hai bisogno di un Dio”. Naturalmente il Signor K.
non intende che l’interlocutore abbia davvero bisogno di Dio.
Ciò di cui ha bisogno, per via della sua coscienza erronea e interessata, sarebbe la fede in Dio. Il Signor K. non considera neppure la questione di una possibile esistenza di Dio reale e completamente indipendente dalla nostra fede. Questo dimostra
che anch’egli ha già deciso. L’argomento del Signor Keuner è
soltanto il rovescio del tradizionale argomento cristiano contro gli infedeli: hanno un interesse alla non-esistenza di Dio.
Non vogliono ringraziarLo, dice Paolo nella Lettera ai Romani. Ringraziare, come anche lamentarsi e pregare, evidentemente è anche un modo di comportarsi, mentre il Signor K.
probabilmente pensa solo a delle cose pratiche. E siccome non
è una persona irragionevole, egli, se credesse che Dio esiste, si
sentirebbe costretto a fare qualcosa del genere anche se non lo
farebbe volentieri. Così l’interlocutore potrebbe rispondergli:
“Anche tu ti sei già deciso. Il tuo comportamento dimostra che
hai bisogno della non-esistenza di Dio. O, più precisamente:
hai bisogno di credere alla non-esistenza di Dio, o almeno, di
non credere alla sua esistenza”.
10. Prima di chiedersi che interesse abbia la verità o la nonverità della diceria su Dio, è meglio chiedersi con più precisione
che cosa esattamente significhi questa diceria. Che cosa intende colui che pensa che Dio c’è? Si tratta di una verità sintetica,
non analitica. Si tratta dell’essenziale e necessaria unità tra due
predicati, che empiricamente si presentano spesso separati, e
soltanto alcune volte, e in modo contingente, insieme: l’unità
dei predicati “potente” e “buono”. Chi crede che Dio c’è, crede
che la situazione contingente, il mondo della nostra esperienza, incluso se stessi, abbia una “profondità”, una dimensione,
che sfugge all’esperienza, anche a quella introspettiva. Questa
dimensione è il luogo dove ciò che è scaturisce dalla sua ori19
gine. E non nel senso di una conseguenza temporale di condizioni antecedenti, ma come un provenire insieme alle condizioni di origine, e nello stesso tempo come emancipazione
da esse, e cioè come essere di per sé. Credere in un Creatore
significa credere che l’essere delle cose e la vita dei mortali non
sono né necessari né conseguenza di un universale principio
di inerzia, ma che, in ogni momento, provengono dall’origine.
Il luogo dell’origine, però, è nello stesso tempo il luogo della
verità, il luogo delle cose in sé, il mondo visto dal punto di vista
di Dio; e si può restare nel dubbio che questo punto di vista, in
termini di principio, sia accessibile a noi.
11. Non si può restare nel dubbio, però, su come noi stessi
partecipiamo alla situazione contingente, che cosa ci sia permesso fare o omettere, e cosa invece no. L’incondizionatezza,
con la quale questo si manifesta nella coscienza è l’altro predicato che viene pensato da colui che crede che Dio c’è. Da
qui la locuzione “voce di Dio” per la coscienza. Questa incondizionatezza, che non scende a patti, di ciò che è buono sta in
rapporto stranamente antinomico con quell’altra incondizionatezza, l’incondizionatezza di ciò che è come è, che non ammette alcun appello sulla base di qualsivoglia dovere, e che i filosofi hanno sempre consigliato di accettare, anzi di amare. La
protesta contro l’universo, contro il corso delle cose, è assurda.
E incondizionatezza c’è anche laddove qualcuno accetta che il
corso delle cose si volga contro di lui, per non tradire la voce
della coscienza. Questa incondizionatezza non può essere
confutata da nessuna fattualità, e questo vale anche viceversa.
Credere in Dio significa non far valere l’antinomia di queste
due incondizionatezze come l’ultima parola. Dio c’è significa
che il potere assoluto e ciò che è buono per eccellenza, nella
loro causa e origine, sono una cosa sola – un eccesso di armonizzazione, dal punto di vista dell’empiria quotidiana, un
20
eccesso di speranza. Il rifiuto di scegliere l’alternativa e l’accettazione dell’assurdo come ultima parola, forse stanno insieme
soltanto nelle parole di Pascal: «Vere tu es Deus absconditus».
12. Perché Dio è nascosto? Domanda alla rovescia: Perché
non dovrebbe essere nascosto? Perché gli spettatori al cinema
nella caverna di Platone devono sapere che si trovano in una
caverna e che c’è un esterno? Perché sono uomini ai quali appartiene voler sapere “cosa in verità è” (Hegel). E perché hanno
un’esperienza di incondizionatezza che non è comprensibile
nel contesto del film che guardano. Perché allora Dio è nascosto? Con la conseguenza assurda – assurda se Dio c’è – che
l’esistenza di Dio ha lo status di una ipotesi controversa? Gli
gnostici risolvevano il problema distribuendo i due predicati
antinomici tra due istanze, un creatore cattivo, rispettivamente
demiurgo e principe di questo mondo, e “il totalmente Altro”,
il Dio della luce che splende da lontano. Ma questo è rinunciare a ciò che afferma la diceria. L’altra risposta racconta la storia
di una colpa immemorabile che separò ciò che è potente e ciò
che è buono, facendo sì che la loro primordiale unità finisse in
una sfera nascosta, dove noi non siamo, nel “cielo”.
13. Ma non appartiene forse al concetto di Dio che la Sua
volontà sia sempre fatta? Sì, però non in terra così come in cielo, e cioè in modo tale che la volontà umana e la volontà divina
siano in armonia, ma piuttosto come “astuzia della ragione”
che si compie contro l’intenzione dell’attore attraverso la sua
azione. Mefistofele sa di essere “parte di quella forza che vuole
sempre il male e crea sempre il bene”. Nella stessa direzione
vanno le parole: “il Figlio dell’uomo se ne va, secondo quanto
è stabilito; ma guai a quell’uomo dal quale è tradito”. L’ambivalenza nel concetto di volontà divina, che trovò la sua ultima
espressione nella tensione tra filosofia della storia e filosofia
morale secondo Kant e secondo Hegel, è espressa nel modo
21
più preciso nella dottrina di san Tommaso delle due volontà
di Dio. La volontà assoluta di Dio si manifesta in ciò che accade. Essa nella sua causa è a noi celata, e perciò non può servirci
da guida per l’agire. Sarebbe persino cattivo – scrive San Tommaso – volere sempre ciò che vuole Dio; la guida del nostro
agire è ciò che Dio vuole che noi vogliamo. E questo invece
lo possiamo sapere. È ciò che è moralmente dovuto, su cui ci
informano la ragione e la Rivelazione. E che inoltre non è identico per tutti gli uomini. A questo riguardo san Tommaso fa
l’esempio del re che ha il dovere di far ricercare il criminale, e
della moglie del criminale che invece ha il dovere di nascondere suo marito. Nessuno dei due può rimproverare all’altro
l’adempimento del suo dovere, e ognuno di essi deve venerare la volontà di Dio in ciò che poi realmente accadrà. Infatti, come dice Martin Lutero: «È segno sicuro di una volontà
cattiva che essa non sopporti il suo impedimento». Attività e
rassegnazione procedono mano nella mano, in questo caso,
e rispecchiano l’ambivalenza nel concetto di volontà di Dio,
ambivalenza che esiste comunque soltanto perché le volontà
creaturali non corrispondono a priori a “ciò che Dio vuole che
noi vogliamo”.
14. L’unità di onnipotenza e bontà alla quale pensiamo
quando pensiamo a Dio rende ineludibile la questione della
teodicea, e cioè la questione della compatibilità dei mali del
mondo con la bontà e la giustizia di Dio. Sono tante le risposte.
Abbiamo già menzionato quella della gnosi. I cabalisti parlano del “tzim-tzum”, del ritrarsi di Dio, di una auto-limitazione
della sua onnipotenza per lasciare spazio a qualcosa al di fuori
di sè, prezzo inevitabile della libertà creaturale. Leibniz pensava che Dio non poteva fare di meglio – formula meno eufemistica per “il migliore dei mondi possibili”. Qualcosa di simile
sostiene Klaus Berger ri-trasformando il Dio della Bibbia in un
22
demiurgo che non chiama ad esistere, ma si limita a plasmare, e di conseguenza non può rendere il mondo migliore del
materiale a disposizione. E infine c’è la risposta data da Kant
e Hegel: l’accenno all’astuzia della ragione nel corso della storia del mondo, che alla fine conduce tutto al bene. Ma perché
coloro che sono venuti dopo conterebbero di più di quelli che
sono venuti prima e che hanno pagato il prezzo? Forse sono
Lenin e Stalin a mostrarci come è Dio?
Se Dio c’è, non c’è posto per alcun calcolo del genere.
L’unica risposta alla questione della teodicea che mette a tacere questa questione, viene data dal Libro di Giobbe: «Dov’eri
tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai
tanta intelligenza! […] Il censore vorrà ancora contendere
con l’onnipotente? […] Cingiti i fianchi come un prode: io
ti interrogherò e tu mi istruirai. Oseresti proprio cancellare
il mio giudizio e farmi torto per avere tu ragione? Hai tu un
braccio come quello di Dio e puoi tuonare con voce pari alla
sua?» (Gb 38,4; 40,2; 42,3.5-6). E la risposta di Giobbe: «Ho
esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a
me, che io non comprendo... io ti conoscevo per sentito dire,
ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo
pentimento sopra polvere e cenere». Così Dio ha vinto la
scommessa contro l’accusatore degli uomini, e Giobbe viene
restituito allo splendido status quo ante. Il messaggio del Nuovo
Testamento che Dio è amore perde la sua forza se viene ripetuto così spesso da dimenticare da chi è stato detto. Il primo
predicato di Dio è la potenza. «Dio è, come tutto sta» dice
Wittgenstein. «Per Dio tutte le cose sono buone, belle e giuste», dice Eraclito, e «Io sono Colui che fa morire e fa vivere»,
dice JHWH nel Profeta. Solo a questa condizione la speranza
di salvezza dalla morte definitiva può indirizzarsi a Lui. Chi
non è l’origine dell’alpha in Sagittario, non può promettere di
23
essere l’omega. Pensare Dio come impotente, per poterlo pensare buono senza fatica, significa dare per perso il bene. O Dio
non c’è, oppure: «tout ce qui arrive est adorable» (Léon Bloy).
15. Oggi ci viene detto che nella religione si tratta di superamento del contingente. Ciò si accorda con i due predicati di
Dio. “Ciò che Dio fa è ben fatto, è giusta la Sua volontà. Siccome
è Lui che pensa alle mie cose, io voglio starmene zitto e buono”. Hermann Lübbe ama queste canzoni, che alla fine sono
anche belle. Superamento del contingente vuol dire accettare ciò che non si può cambiare, nonostante si possa pensare
e desiderare che sia diverso. Rassegnarsi o amare? C’è anche
un superamento del contingente di stampo ateo che accetta
che le cose siano come sono, un’arte del vivere che consiste
nell’accontentarsi di enclaves di significato e gioia all’interno di
un tutto assurdo. Ma che significa assurdo? Assurdo è assenza
di significato laddove ce lo aspetteremmo. Quando, con l’aiuto della scienza per esempio, avessimo imparato a non cercare
alcun significato in tutto ciò che è, non parleremmo neanche
più di assurdità.
La luna che brilla attraverso gli alti rami,
dicono tutti i poeti, sarebbe più
della luna, che brilla attraverso gli alti rami.
Per me, però, che non riesco a immaginarmi cosa possa
essere la luna che brilla attraverso gli alti rami più della luna
che brilla attraverso gli alti rami,
essa davvero non è di più della luna che brilla attraverso gli alti rami.
(Fernando Pessoa)
24
La verità è che la fede nell’esistenza di Dio quel contingente che essa “supera” lo crea per prima o perlomeno l’accentua
notevolmente. L’idea della contingenza del mondo si è sviluppata filosoficamente solo in ambito islamico e cristiano, come
nella logica moderna il concetto diventato così importante di
“mondi possibili”. Cosa significa allora che qualcosa possa essere altro da ciò che è? Può significare che questo essere altro
non viene escluso per ragioni logiche. Può significare che in
base alle leggi della natura segue necessariamente da ciò che
già c’era. Ma già questo è ambiguo. Poiché se anche due serie di eventi si verificano in base alle leggi della natura, non
c’è sempre un’altra legge della natura da cui si origini l’evento
che consegue dall’interferenza di queste serie. Parliamo qui di
caso e intendiamo che avrebbe potuto anche avvenire qualcosa d’altro. Ma che cosa significa qui “avrebbe potuto”? Il caso
è, secondo Aristotele, una “causa primordiale” come altre. Il
fatto che niente di precedente all’evento abbia determinato il
suo accadere non significa un qualche “avrebbe potuto” con
riferimento a un corso alternativo delle cose. Con un’eccezione. Dove entriamo in gioco noi stessi o altri uomini che noi
consideriamo soggetti liberi di agire, allora ha senso parlare di
un “avrebbe potuto” alternativo e dire con riferimento a determinati risultati dell’agire che noi avremmo potuto fare anche
qualcos’altro. Soltanto con riferimento ad esseri che agiscono
liberamente hanno un senso più o meno metaforico ipotesi
contra factum. Il pensiero che il mondo potrebbe essere altro da
quello che è, anzi che persino le leggi della natura siano contingenti, poteva scaturire soltanto sullo sfondo del pensiero di
un mondo originato da una libera scelta. La fede in Dio come
superamento del contingente perciò non può significare altro
che: la ferita può essere guarita soltanto dal ferro che l’ha prodotta. Per questo motivo questa idea non si confà a una spie25
gazione della religione di tipo funzionalistico. Il superamento
del contingente di stampo ateo è più radicale di quello religioso. È una eliminazione del contingente. Questo, però, forse è
impossibile per ragioni psicologiche. Gli uomini difficilmente
possono fare a meno dell’idea che qualche cosa possa essere
altro da ciò che è. Ma questo probabilmente significa solo che
gli uomini difficilmente possono fare a meno del pensiero di
Dio.
16. Superamento del contingente può significare ancora
qualcos’altro. A volte le cose vanno meglio di quello che noi
potevamo presumere. A volte accade qualcosa di meraviglioso. E ci sono momenti in cui sperimentiamo la nostra esistenza come puro dono, come miracolo. Credere in Dio è credere
nel miracolo. “Alla base della moderna Weltanschauung sta l’inganno che le cosiddette leggi della natura siano la spiegazione dei fenomeni della natura” (Wittgenstein). Non esiste un
obbligo in base al quale una cosa dovrebbe accadere poiché
qualcos’altro è accaduto. C’è solo una necessità logica. I teologi
moderni spesso vogliono esiliare Dio al livello della cosiddetta causa prima, che significa una sorta di condizione trascendentale per l’accadere nel mondo, la quale non deve interferire
con l’accadere stesso. Ma non hanno altra ragione da offrire
che non sia il pregiudizio richiamato da Wittgenstein. Chi, per
principio, crede al miracolo rischia di perdere il buon senso
e di essere ingenuo perché può smarrire i criteri di ciò che è
probabile. Ma è un rischio relativo. Di norma gli uomini che
credono in Dio sono scettici di fronte a racconti di miracolo;
inclini a non prestar fede ad essi, ma nello stesso tempo ad attendersi da un momento all’altro il miracolo che li convinca. La
forma suprema dell’esigenza di superamento del contingente
è l’esigenza di essere grati. A questo livello l’ateismo non può
offrire alcun surrogato poiché l’eliminazione del contingente
26
corrisponderebbe in questo caso alla eliminazione della fortuna di poter ringraziare. È un’autentica – ma provvidenziale – povertà della lingua tedesca che essa abbia la sola parola
“glück” per esprimere felicitas e fortuna. Gratitudine c’è soltanto
nei confronti di un destinatario. Altrimenti è un modo di dire.
Laddove il lamento non ha destinatario, non ce l’ha neanche
la gratitudine. Essa può essere reale soltanto se il destinatario è
reale. «We really never advance a step beyond ourselves»: se questa
frase programmatica di Hume è vera, seppure possiamo divertirci in tanti modi, alla gioia nel senso enfatico della parola
dobbiamo rinunciare.
17. La gioia per il fatto che Dio c’è significa, nel linguaggio
tradizionale, amore di Dio. Essa è di più dell’astratto universalismo morale, che il proprio interesse è pronto a relativizzare.
È una trasformazione dell’interesse stesso. Per i mistici cristiani, ma anche per Lutero, la resignatio in infernum, l’accettazione
della propria dannazione, quando essa è volontà di Dio, era
uno stadio transitorio e una prova di questa trasformazione.
Se Dio c’è, allora è questa la cosa più importante. Dovunque
mi porti il destino, che la mia vita sia piena di senso o no, il
significato stesso, la santità e la bellezza c’è, ed è indistruttibile. «Il significato del mondo deve stare al di fuori di esso. Nel
mondo tutto è come è, e tutto accade come accade. Non c’è
in esso alcun valore: e se ci fosse, non avrebbe alcun valore.
Se c’è un valore che ha valore, deve stare al di fuori di ogni avvenimento e dell’essere-così-com’è, poiché ogni avvenimento
e ogni essere-così-com’è è casuale. Ciò che lo rende non casuale non può stare nel mondo, perché altrimenti questo sarebbe di nuovo casuale. Deve trovarsi al di fuori del mondo»
(Wittgenstein). «Gioire della felicità di un altro», così Leibniz
definisce l’amore. Appartiene al concetto di Dio pensarlo felice, e di conseguenza buono.
27
18. Nietzsche ha capito cosa sia questa gioia quando ha
definito amare gli uomini per amore di Dio «il sentimento
più nobile e alto finora raggiunto fra gli uomini». Poiché non
credeva che Dio ci sia, ha voluto inventare un suo equivalente funzionale, il superuomo. L’alternativa sarebbe altrimenti il
banale nichilismo dell’ultimo uomo che, occupato soltanto,
come la pulce di terra, a manipolare la propria lussuria, vive
tutt’al più di mondi virtuali come modelli masturbatori. Ma
anche il superuomo è virtuale. Appartiene alla funzione di
Dio di non essere definibile da alcuna funzione e cioè di non
essere neppure fungibile con alcun equivalente funzionale.
Non buono per qualcosa, ma quel Qualcuno per il quale qualcosa deve essere buono per essere buono. Per ogni funzione
della fede in Dio c’è anche un’antitesi. Dio è la ragione di ogni
pretesa incondizionata nei confronti dell’uomo e, allo stesso
tempo, soggetto del perdono di ogni colpa, Egli è istanza di legittimazione di ogni autorità cogente e istanza di legittimazione della disobbedienza contro ogni tirannide, Egli è il Signore
della storia e il Giudice di quelli che “fanno” la storia. La fede
in Dio ispira gli sforzi più grandi di alleviare le sofferenze, e la
disponibilità più grande ad accettarle. Essa motivava i giudici
degli eretici come gli eretici. Essa motiva coloro che pensano
di migliorare il mondo, come quelli che lo fuggono e quelli
che nel mondo non fanno altro che il loro dovere quotidiano.
Essa ci fa fare tutto quello che facciamo per Dio, e ci insegna
che non possiamo dare qualcosa a Dio attraverso alcunché di
ciò che facciamo. Ci insegna a tendere a essere indifferenti al
risultato dello sforzo. Ci insegna che Dio è in tutto e tutto è in
Dio, e ci insegna che Egli è “al di là”, al di fuori del mondo, “nel
cielo”. Alla domanda su quale differenza faccia che Dio ci sia o
non ci sia c’è perciò soltanto una risposta: fa questa differenza:
Dio c’è o non c’è.
28
19. C’è però una conseguenza morale derivante dal credere
in Dio. Se Dio c’è, gli uomini devono fare ciò che Dio vuole che essi vogliano, e non devono cercare di svolgere il ruolo
di Dio quasi da padroni di ciò che accade. Jean-Paul Sartre
scrive, nella sua opera postuma Cahiers pour une morale, che
un ateo radicale deve avere un’“etica della responsabilità”,
dev’essere pronto a commettere qualsiasi crimine se è per il
bene dell’umanità. Il tentativo di mantenere le mani pulite e
una veste immacolata non è altro che egoismo morale. Per
il credente, scrive, è diverso. Questi, in primo luogo, ha la responsabilità della propria vita, perché per lui esiste un’istanza
davanti alla quale deve rispondere per la propria vita. Il suo
tentativo di non compromettersi con il male non è egoismo
ma servizio di Dio. Non ha, invece, la responsabilità dell’omissione di crimini. Sartre ha capito questo fatto meglio di gran
parte dei moderni teologi morali cristiani, specialmente dei
teologi morali cattolici che hanno optato per la morale teologica del conseguenzialismo, secondo cui la qualità morale di
un’azione è la funzione dell’insieme delle sue probabili conseguenze collaterali, cioè lo scopo santifica il mezzo. E se persino
dei vescovi chiamano in modo offensivo egoisti morali coloro
che tentano di prendere sul serio l’esigenza neotestamentaria
“di mantenersi immuni da questo mondo”, allora quei teologi
dovrebbero forse riflettere se un determinato concetto di responsabilità non sia tanto utopico quanto ateo. «Se Dio non
esiste tutto è permesso» diceva Dostoevskij. «Secondo le circostanze, e premessa la buona intenzione», aggiunge il conseguenzialista. «A noi tutto è permesso», diceva Lenin nella
convinzione di sapere ciò che era meglio per tutti, e che non
c’è nessun Dio che lo sappia. Il conseguenzialismo è rottura
con le basi di una millenaria educazione umana. Ed è totalita29
rio, poiché eleva a signore delle coscienze di coloro che non lo
sanno chi crede di sapere ciò che è meglio per tutti.
20. Se Dio c’è, che cosa succede? Succede che Dio c’è, e la
fede in Lui è vera. Bella è sicuramente, ma «qui sait si la verité
n’est pas triste?» (Renan). Voler sapere che cosa c’è è costitutivo per la dignità dell’uomo. Quando Sinjavskij scriveva che
era ora di pensare a Dio, aggiungeva: «Non bisogna credere
per antica consuetudine, non bisogna credere per paura della morte, non perché non si sa mai, non perché qualcuno ci
costringe, non per un principio umanistico, e non per salvare
l’anima o per essere originali. Bisogna credere per il semplice
motivo che Dio esiste». Che Dio esista, è controverso. Probabilmente sì, diceva Richard Swinburne, e lo spiegava dettagliatamente. Probabilmente no, diceva John L. Mackie, e lo spiegava in modo quasi altrettanto dettagliato. Per colui che crede
in Dio l’ipotesi probabile si trasforma in certezza inesorabile,
perché prega. Alla lunga non si può parlare e dare ascolto seriamente e con crescente familiarità a qualcuno la cui esistenza ha lo status di un’ipotesi. E anche il non-credente non lascia
la cosa in sospeso: semplicemente rinuncia all’attuazione di
un tale rapporto.
La storia degli argomenti in favore dell’esistenza di Dio
è enorme. Ci sono sempre stati uomini che hanno cercato
di assicurarsi della ragionevolezza della loro fede. Le prove
dell’esistenza di Dio si possono suddividere in due gruppi.
Nel primo gruppo si cerca di dedurre dal contenuto dell’idea
di Dio, oppure dalla presenza di quest’ultima nella coscienza
umana, la realtà di ciò che, in quest’idea, viene pensato. Anselmo di Canterbury, Descartes e Hegel sono i nomi legati a
questo “argomento ontologico”. San Tommaso e Kant non
ritenevano percorribile questa via. È vero che Dio, se c’è, c’è
necessariamente, e la sua esistenza, contrariamente a qualsia30
si altra esistenza, è totalmente e profondamente ragionevole.
Ma – questa è l’obiezione – non abbiamo nessuna idea sufficiente di ciò che intendiamo quando diciamo “Dio”, per poter
giungere ad una tale certezza aprioristica. L’altro gruppo argomenta a partire dagli elementi dell’esperienza, che non sarebbero comprensibili se non indicassero qualcosa di assoluto al
di là di loro stessi. Un terzo gruppo, infine, rappresentato da
Pascal, Kant e William James, non porta argomenti in favore
dell’esistenza di Dio, ma in favore del fatto che, di fronte a una
“situazione di stallo” teoretico, per motivi “esistenziali” è più
conveniente per noi credere in Dio piuttosto che non crederci
– e cioè per motivi che, secondo Sinjavskij, non sono validi.
21. Dall’epoca di Hume, fino a quella più tarda di Nietzsche, l’argomento per l’esistenza di Dio si trovò in una nuova
situazione. Le classiche prove dell’esistenza di Dio cercavano
di mostrare che è vero che Dio c’è. Presupponevano che la
verità c’è e che il mondo possiede delle strutture comprensibili, accessibili al pensiero. Queste trovano il loro fondamento nell’origine divina del mondo, ma sono direttamente
accessibili a noi e per questo sono atte a condurci a questo
fondamento. Questo presupposto è contestato a partire da
Hume e soprattutto da Nietzsche. Nietzsche scrive che «anche noi illuministi, noi liberi spiriti del XIX secolo, prendiamo ancora il nostro fuoco dalla fede cristiana (che era anche
la fede di Platone) che Dio sia la verità, e che la verità sia
divina». Ma proprio questo pensiero è una auto-illusione,
per Nietzsche. Non c’è verità. Ci sono soltanto reazioni utili
o dannose. «Non dobbiamo illuderci che il mondo ci mostri
un volto leggibile», dicono Foucault e Richard Rorty: «Un
obbiettivo più elevato di ricerca chiamato verità esisterebbe
soltanto se ci fosse qualcosa come un’ultima giustificazione,
cioè non una giustificazione di fronte a un uditorio pura31
mente finito di ascoltatori umani, ma una giustificazione
di fronte a Dio». Con il venir meno dell’idea di Dio viene
meno anche quella di un mondo vero, con il venir meno
dell’intellectus archetypus anche la “cosa in sé” – per Kant ciò
che è, è tale per l’intellectus archetypus. Rorty sostituisce la conoscenza con la speranza in un mondo migliore, dove non si
può neanche più dire in che cosa questa dovrebbe consistere e in che cosa dovrebbe consistere l’adeguatezza dei mezzi
adatti allo scopo. Almeno su questo, infatti, le affermazioni
dovrebbero cercare di essere vere.
22. In questa situazione, perciò, gli argomenti per pensare l’assoluto come Dio possono essere soltanto argomenti ad
hominem. Non partono da premesse indiscutibili per giungere
a conclusioni altrettanto indiscutibili. Sono olistici. Mostrano
la mutua interdipendenza della convinzione dell’esistenza di
Dio e della capacità di verità, cioè l’essere persona dell’uomo,
e cercano, al contempo, la conferma per entrambe – al contrario della dialettica di naturalismo e spiritualismo che oggi
segna la nostra civiltà. In essa la potenza dominante è un soggetto astratto, trascendentale, denominato “scienza”, che da
una parte sembra essere indipendente da tutte le condizioni
naturali, biologiche e fisiche. Essa riduce il mondo a una oggettività priva di soggetto. Essa ci spiega cosa siamo come uomini
nel momento in cui ci spiega come siamo stati originati. Sotto
questo aspetto, il vero e il bene non sono altro che reazioni in
funzione della sopravvivenza. Le cosiddette conoscenze non
sono rappresentazioni di ciò che viene conosciuto, ma effetti
causali di qualcosa che appunto non viene conosciuto. Da cui
segue che anche tutte le idee di autodeterminazione personale
sono autoinganno. Ma neanche questo potremmo “sapere”, se
così fosse. Se Dio c’è, è diverso. In questo caso una spiegazione
“naturale” non si identifica con una spiegazione riduzionistica,
32
poiché la natura deve se stessa a una libertà inimmaginabile
e, nella produzione di esseri liberi, capaci di libertà e di intendere e volere, ritorna semplicemente a ciò che essa in origine
è. Se Dio c’è noi possiamo essere ciò che non possiamo fare
a meno di considerarci: persone. Se questo non lo vogliamo,
non c’è alcun argomento che possa convincerci dell’esistenza
di Dio. Anche se lo vogliamo, non c’è comunque alcun obbligo a credere in Dio. Ci resta sempre l’alternativa di rinunciare
a comprendere, cioè di rinunciare ad armonizzare quello che
noi stessi sperimentiamo di essere con quello che la scienza
dice di noi. Possiamo subito lasciar perdere l’ermeneutica e la
storia naturale. Ci resta sempre la possibilità della rassegnazione intellettuale:
Mi sono domandato spesso,
e non ho trovato risposta,
da dove vengano la mitezza e la bontà.
Ancora non lo so
e ora devo andare.
(Gottfried Benn)
23. Con il venir meno del pensiero della verità viene meno
anche il pensiero della realtà. Il nostro dire e pensare ciò che è,
è strutturato in forma inevitabilmente temporale. Non possiamo pensare qualcosa come reale senza pensarla nel presente,
cioè come reale adesso, o che sia stata a suo tempo presente,
che a suo tempo sia stata “adesso”. Qualcosa che sia sempre
stata soltanto passato, o che sarà soltanto futuro, mai c’è stata e
mai sarà. Ugualmente: ciò che è adesso, un tempo era futuro e
sarà a suo tempo passato. Il futurum exactum (futuro anteriore)
è inseparabile dal presente. Dire di un evento del presente che
33
non ci sarà più stato, significa dire che in realtà non è neppure
ora. In questo senso tutto il reale è eterno. Non potrà esserci
un momento in cui non sarà più vero che qualcuno ha provato
un dolore o una gioia che prova adesso. E questa realtà passata
prescinde assolutamente dal fatto che ce la ricordiamo. La coscienza attuale di ciò che adesso è, o implica la coscienza che
in futuro questo diventerà passato, oppure cancella se stessa.
Ma qual è lo status ontologico di questo diventare passato se
tutte le tracce saranno cancellate, se l’universo non ci sarà più?
Il passato è sempre il passato di un presente. Che ne sarà del
passato se non ci sarà più alcun presente? L’inevitabilità del
futurum exactum implica l’inevitabilità di pensare un “luogo”
dove tutto ciò che accade è per sempre custodito. Altrimenti
dobbiamo accettare il pensiero assurdo che non ci sarà più stato ciò che è adesso, e di conseguenza che non è reale neppure
adesso.
La totale virtualizzazione del mondo rende superflua
l’esistenza di Dio. Se vogliamo pensare il reale come reale
dobbiamo pensare Dio. «Temo che non ci libereremo di Dio
fintantoché crederemo alla grammatica», scrive Nietzsche.
Ed egli avrebbe anche potuto aggiungere: «... fintantoché
continueremo a pensarci come reali». Un argumentum ad hominem. Ma Leibniz, che capiva qualcosa di teoria della prova,
scrisse che ogni prova in realtà è un argumentum ad hominem.
34