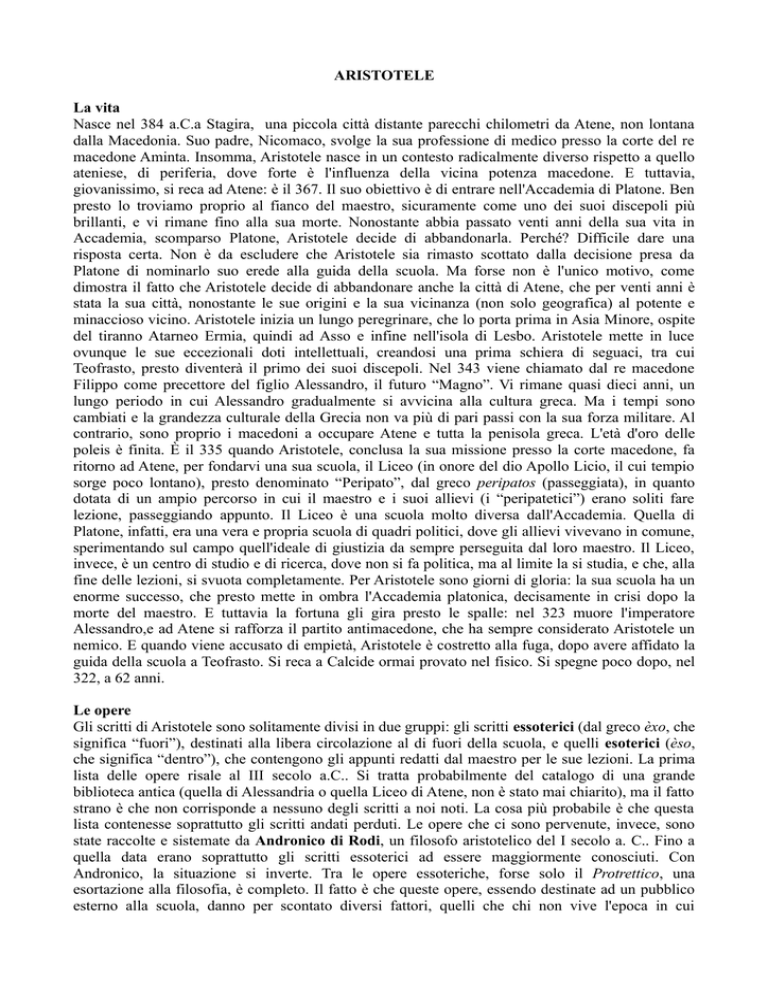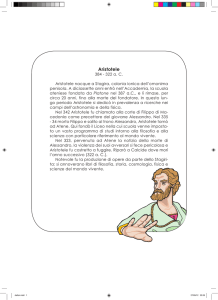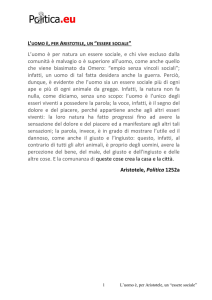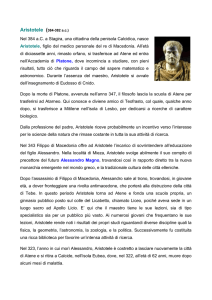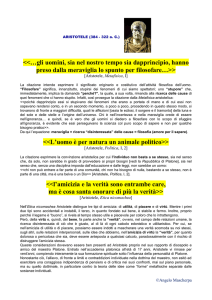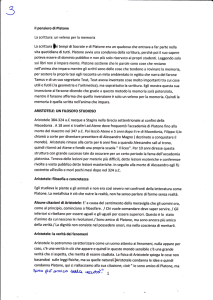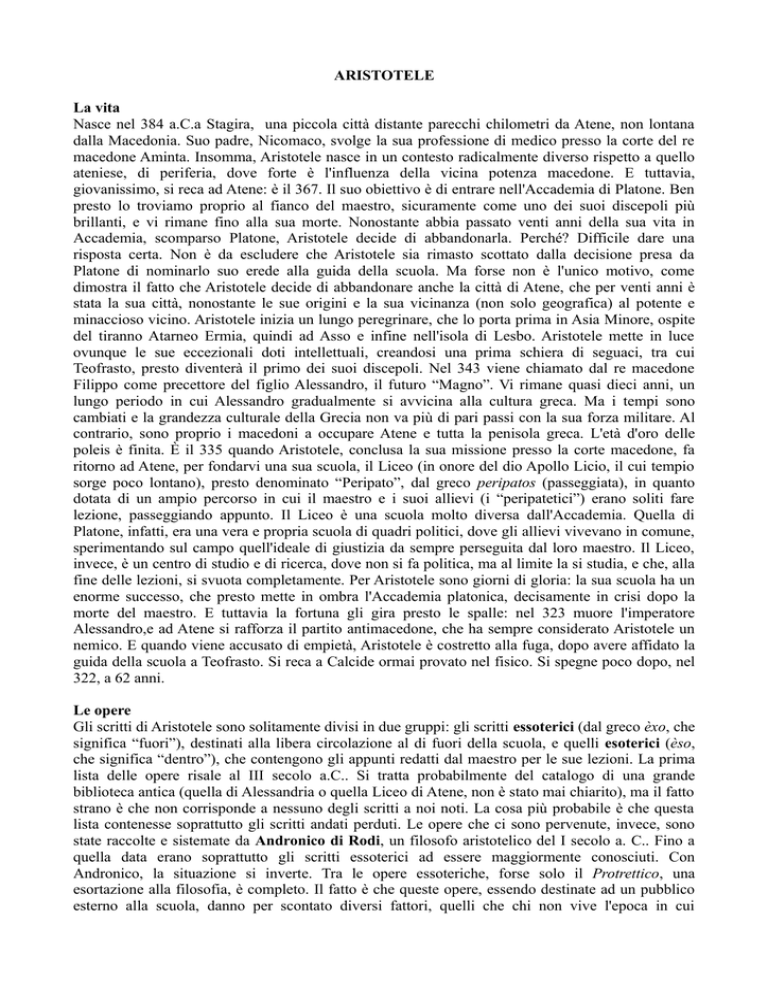
ARISTOTELE
La vita
Nasce nel 384 a.C.a Stagira, una piccola città distante parecchi chilometri da Atene, non lontana
dalla Macedonia. Suo padre, Nicomaco, svolge la sua professione di medico presso la corte del re
macedone Aminta. Insomma, Aristotele nasce in un contesto radicalmente diverso rispetto a quello
ateniese, di periferia, dove forte è l'influenza della vicina potenza macedone. E tuttavia,
giovanissimo, si reca ad Atene: è il 367. Il suo obiettivo è di entrare nell'Accademia di Platone. Ben
presto lo troviamo proprio al fianco del maestro, sicuramente come uno dei suoi discepoli più
brillanti, e vi rimane fino alla sua morte. Nonostante abbia passato venti anni della sua vita in
Accademia, scomparso Platone, Aristotele decide di abbandonarla. Perché? Difficile dare una
risposta certa. Non è da escludere che Aristotele sia rimasto scottato dalla decisione presa da
Platone di nominarlo suo erede alla guida della scuola. Ma forse non è l'unico motivo, come
dimostra il fatto che Aristotele decide di abbandonare anche la città di Atene, che per venti anni è
stata la sua città, nonostante le sue origini e la sua vicinanza (non solo geografica) al potente e
minaccioso vicino. Aristotele inizia un lungo peregrinare, che lo porta prima in Asia Minore, ospite
del tiranno Atarneo Ermia, quindi ad Asso e infine nell'isola di Lesbo. Aristotele mette in luce
ovunque le sue eccezionali doti intellettuali, creandosi una prima schiera di seguaci, tra cui
Teofrasto, presto diventerà il primo dei suoi discepoli. Nel 343 viene chiamato dal re macedone
Filippo come precettore del figlio Alessandro, il futuro “Magno”. Vi rimane quasi dieci anni, un
lungo periodo in cui Alessandro gradualmente si avvicina alla cultura greca. Ma i tempi sono
cambiati e la grandezza culturale della Grecia non va più di pari passi con la sua forza militare. Al
contrario, sono proprio i macedoni a occupare Atene e tutta la penisola greca. L'età d'oro delle
poleis è finita. È il 335 quando Aristotele, conclusa la sua missione presso la corte macedone, fa
ritorno ad Atene, per fondarvi una sua scuola, il Liceo (in onore del dio Apollo Licio, il cui tempio
sorge poco lontano), presto denominato “Peripato”, dal greco peripatos (passeggiata), in quanto
dotata di un ampio percorso in cui il maestro e i suoi allievi (i “peripatetici”) erano soliti fare
lezione, passeggiando appunto. Il Liceo è una scuola molto diversa dall'Accademia. Quella di
Platone, infatti, era una vera e propria scuola di quadri politici, dove gli allievi vivevano in comune,
sperimentando sul campo quell'ideale di giustizia da sempre perseguita dal loro maestro. Il Liceo,
invece, è un centro di studio e di ricerca, dove non si fa politica, ma al limite la si studia, e che, alla
fine delle lezioni, si svuota completamente. Per Aristotele sono giorni di gloria: la sua scuola ha un
enorme successo, che presto mette in ombra l'Accademia platonica, decisamente in crisi dopo la
morte del maestro. E tuttavia la fortuna gli gira presto le spalle: nel 323 muore l'imperatore
Alessandro,e ad Atene si rafforza il partito antimacedone, che ha sempre considerato Aristotele un
nemico. E quando viene accusato di empietà, Aristotele è costretto alla fuga, dopo avere affidato la
guida della scuola a Teofrasto. Si reca a Calcide ormai provato nel fisico. Si spegne poco dopo, nel
322, a 62 anni.
Le opere
Gli scritti di Aristotele sono solitamente divisi in due gruppi: gli scritti essoterici (dal greco èxo, che
significa “fuori”), destinati alla libera circolazione al di fuori della scuola, e quelli esoterici (èso,
che significa “dentro”), che contengono gli appunti redatti dal maestro per le sue lezioni. La prima
lista delle opere risale al III secolo a.C.. Si tratta probabilmente del catalogo di una grande
biblioteca antica (quella di Alessandria o quella Liceo di Atene, non è stato mai chiarito), ma il fatto
strano è che non corrisponde a nessuno degli scritti a noi noti. La cosa più probabile è che questa
lista contenesse soprattutto gli scritti andati perduti. Le opere che ci sono pervenute, invece, sono
state raccolte e sistemate da Andronico di Rodi, un filosofo aristotelico del I secolo a. C.. Fino a
quella data erano soprattutto gli scritti essoterici ad essere maggiormente conosciuti. Con
Andronico, la situazione si inverte. Tra le opere essoteriche, forse solo il Protrettico, una
esortazione alla filosofia, è completo. Il fatto è che queste opere, essendo destinate ad un pubblico
esterno alla scuola, danno per scontato diversi fattori, quelli che chi non vive l'epoca in cui
Aristotele scrive non può comprendere appieno. Tuttavia, nel complesso tratta di opere che non
mostrano quella rottura con Platone che diventa invece palese con le opere esoteriche. E sono
proprio queste ultime ad essere raccolte e divise da Andronico in cinque gruppi: 1) Logica; 2)
Fisica; 3) Metafisica (letteralmente “ciò che viene dopo la fisica”. Per Aristotele invece si tratta di
Filosofia Prima; Morale e Politica.
Il pensiero di Aristotele e quello di Platone
Non sono poche le differenze tra Aristotele e Platone. Innanzitutto, Aristotele appartiene alla
generazione successiva a quella di Platone e non nasce ad Atene, ma in una piccola città al confine
della Macedonia, dove il peso delle libertà politiche è infinitamente inferiore a quello che si
riscontra in Atene. Questi due elementi hanno sicuramente influito sul pensiero di Aristotele. Al
tempo di Aristotele, infatti, la crisi non solo di Atene ma di tutte le poleis greche è ormai
inarrestabile. È la Macedonia la forza regionale egemone, destinata ad occupare gran parte del
mondo allora conosciuto, compresa naturalmente la vicina Grecia. Tramonta l'autonomia delle
poleis e il peso che la politica aveva sui suoi cittadini. Le decisioni vengono prese altrove, in
Macedonia, che è tutt'altro che una polis: è un immenso impero. E a guidare questo impero è
proprio Alessandro, educato sin da giovane da Aristotele. La vittoria macedone, la conquista della
Grecia, facilita il ritorno di Aristotele nella città che lo ospitò per venti anni, tutti passati al fianco di
Platone. Ma le differenze, anche caratteriali, tra i due filosofi sono davvero troppe. Aristotele non
risparmierà anche dure critiche al maestro, attirandosi l'ira di non pochi contemporanei, che lo
accusano di essere un ingrato. A tutti questi risponde con una massima passata alla storia: “amicus
Plato, sed magis amica veritas”.
Raffaello, in uno dei suoi dipinti più famosi, La Scuola di Atene, mette ben in evidenza le differenze
tra i due filosofi: Platone ed Aristotele sono al
centro della scena (sullo sfondo gli altri filosofi
dell'antichità, tra cui l'oscuro Eraclito) ed
avanzano insieme. Ma mentre il primo indica il
cielo con il dito, Aristotele con la mano mostra il
piano. Due punti di vista inconciliabili dunque.
E infatti: il maestro ateniese ritiene che le verità
risiedano oltre il cielo, l'Iperuranio, mentre per
Aristotele occorre cercarle proprio in questo
mondo. Lo stagirita di certo non rinuncia alla
ricerca speculativa, ma rimane, per così dire,
sempre con i piedi ben piantati a terra. È un
ricercatore (come lo era suo padre, un medico),
nel senso moderno del termine, che compie
esperimenti di laboratorio, non mancando
tuttavia di offrire ai lettori una spiegazione il più
possibile universale della realtà. Non esistono
misteri in questo mondo e anche i problemi più
complessi possono trovare una soluzione
razionale. È la ragione, dunque, il perno di tutta
la speculazione aristotelica, come lo era, anche
se attraverso altre vie, per Platone. E tuttavia
Aristotele sostiene l'identità di pensiero e
linguaggio e dunque la validità della scrittura,
totalmente screditata, nonostante le sue capacità
letterarie, da Platone.
LE CATEGORIE
La dialettica era per Platone l'unico metodo valido per conseguire la conoscenza della realtà vera,
da cui dipendeva tutto il suo progetto etico e politico. Trattandosi sostanzialmente di una arte della
persuasione, la dialettica necessitava per gli accademici di un metodo corretto di argomentare. Ed è
probabile che proprio ad Aristotele Platone abbia affidato l'incarico di trovare tale metodo.
Insomma, lo stagirita si è occupato della dialettica non tanto nei suoi aspetti ontologici quanto
soprattutto linguistici e questo studio ha influenzato profondamente la sua filosofia e probabilmente
determinato la rottura con tutto l'ambiente platonico.
E tuttavia l'esistenza dei due piani della dialettica era presenta anche in Platone. Quando, per
esempio, si dice che l'idea della Quiete partecipa dell'idea dell'Identico ma non dell'idea del Moto, si
vuole affermare che sul piano del linguaggio la Quiete può essere detta identica (se ne può predicare
cioè l'identità) ma non può essere detta in moto (non se ne può predicare il moto). Ora, sapere
distinguere i rapporti di predicazione corretti da quelli scorretti è il primo passo per imparare a
costruire ragionamenti veritieri e dunque persuasivi. Ed è proprio a questo lavoro che il giovane
Aristotele si dedica nei primi anni della sua presenza ad Atene. Egli va alla ricerca delle possibili
connessioni dialettiche, che chiama “categorie”, cioè predicati. La parola greca categoria rimanda
al verbo kategorèo, frutto della composizione della preposizione katà con il verbo agorèuo. Katà ha
diversi significati, che tuttavia si riconnettono tutti all'idea di un moto, reale o figurato, in direzione
di un certo obiettivo: “verso”, “contro” eccetera. Per cui, poiché agorèuo significa “parlare”,
kategorèo significa “dire male di qualcuno”, vuoi semplicemente per biasimarlo, vuoi per accusarlo
in un contesto pubblico. Non a caso il sostantivo katègoros significa “accusatore”. E tuttavia, se si
elimina questa sfumatura negativa, il termine katègoreo significa semplicemente “dire” verso o in
relazione a qualcuno o qualche cosa. Ecco perché categoria si può tradurre in italiano come
“predicato”: predicare, nella sua accezione grammaticale, significa proprio dire qualcosa di
qualcosa d'altro. Ma la sfumatura ostile di katà non è andata perduta del tutto, come dimostra il
termine “accusativo” che ancora oggi designa uno dei casi contemplati dalle lingue declinabili.
Le categorie, dunque, hanno un evidente rapporto con le asserzioni, sui quali si fondano i
ragionamenti. Categoria è infatti “ogni termine detto senza connessione”, come per esempio
“uomo,” “animale”, “rosso”, “corre”, “in casa” eccetera. Poiché le proposizioni nascono unendo
questi termini, per esempio “uomo corre”, “cane abbaia” eccetera, la prima cosa che deve analizzare
chi vuole studiare le proposizioni sono proprio questi termini semplici: le categorie. La prima cosa
che si nota è che si tratta di “universali”, non indicando alcunché di preciso, non, per esempio, un
tale tipo di uomo o di cane. Si tratta grosso modo dei medesimi “concetti universali” di cui parlava
Platone, e tuttavia Aristotele nota come questi si differenzino non solo per l'ampiezza ma anche per
la qualità. Chiariamo meglio la questione. Prendiamo per esempio i due universali di “animale” e
“uomo”. È evidente la differenza di ampiezza: il primo è più esteso del secondo e lo contiene come
sua specie: tutti gli uomini sono animali ma non tutti gli animali sono uomini. Ma termini o
espressioni come “uomo”, “corre”, “rosso”, “in casa” eccetera presentano anche diversità
qualitative: “uomo” è una cosa o una sostanza, mentre “rosso” una qualità, “corre” una azione, “in
casa” un luogo eccetera. Ebbene, sostanza, qualità, azione, luogo, quantità eccetera sono altrettante
categorie. Secondo Aristotele esistono ben dieci categorie: sostanza, quantità, qualità, relazione,
luogo, tempo, stare, avere, agire, patire. Qualunque termine senza connessione deve appartenere
ad una di queste categorie. A ciascuna categoria è associata una diversa domanda. Per esempio, la
sostanza risponde alla fondamentale domanda “che cosa?”, la quantità alla domanda “quanto?”, la
qualità alla domanda “come?” eccetera. Le dieci categorie vengono denominati anche predicati
universali.
Torniamo però alla questione del rapporto tra “animale” e “uomo”. Entrambi appartengono alla
categoria di “sostanza”, la quale chiede molto semplicemente: “che cos'è?”. La risposta, in questo
cosa, è “o un uomo o un animale”. Ma i due termini, come si è detto, hanno diversa ampiezza.
Ebbene, per Aristotele il termine più ampio è il genere mentre quello meno ampio la specie:
“l'uomo è una specie del genere animale”. Ecco la prima distinzione, il primo passo da compiere per
rispondere alla domanda sulla sostanza. Ma l'analisi non si ferma certo qui. Ci sono, per esempio,
specie dell'uomo, come gli indoeuropei, gli asiatici eccetera, in relazioni alle quali il termine
“uomo”, che era specie di animale, diventa genere; così come ci sono generi dell'animale, come
“essere vivente”, in relazione ai quali il termine animale, che era genere di uomo, diventa specie. Si
crea in tal modo una colonna di termini ordinati dal meno generale al più generale, che stanno
l'uno all'altro in rapporto relativo di genere e specie. In cima a questa colonna sta il termine
provvisto di massima generalità, la sostanza appunto.
Non esistono termini più universali delle categorie: non è possibile cioè trovare un concetto
universale che colga una caratteristica comune di tutte le categorie nello stesso modo in cui il
termine “qualità” coglie la caratteristica comune di tutte le qualità. A dire il vero, però, un termine
più generale ci sarebbe, quello di “essere”, ma Aristotele scarta questa possibilità: l'essere non è
affatto un genere. Perché? Qui il discorso si fa decisamente più complesso e tuttavia è anche
facilmente intuibile: termini come i generi e le specie hanno la loro ragione d'essere nel fatto che
significano qualche cosa di determinata (dicono cioè di che genere o specie è una certa cosa). Se un
termine è sprovvisto di tale capacità non può evidentemente rappresentare un genere. Ed è questo il
caso del termine (generico) “essere”.
Pertanto le categorie indicano differenze originarie e irriducibili. Ben inteso, tali differenze
riguardano non solo il modo in cui noi parliamo delle cose, ma anche il modo in cui esse realmente
sono: le categorie individuano le caratteristiche originarie della realtà. Aristotele sostiene una
sostanziale omogeneità tra il mondo reale e i modi in cui gli enti provvisti di pensiero e linguaggio
lo nominano e lo descrivono. Questo naturalmente non significa che ogni pensiero o discorso sia
sempre vero, bensì che ogni errore può, in linea di principio, essere corretto, perché tra la realtà
delle cose e le nostre facoltà conoscitive non esistono ostacoli naturali.
Analizzando le varie categorie, Aristotele si accorge successivamente di un'altra importante
caratteristica: la categoria della sostanza è in più modi prioritaria rispetto alle altre. Ma che cosa
significa “sostanza”? Il termine deriva dal latino substantia, “ciò che sta sotto”, “sostrato”.
Aristotele però parla più precisamente di ousìa, un termine greco che rimanda ad un significato
meno complesso e che fa riferimento ai bei materiali, alle ricchezze, dunque che possiede una certa
consistenza. E tuttavia già con Platone il termine designa la vera realtà delle cose. Con Aristotele
questo termine subisce un'ulteriore modifica, presentandosi come essenza ovvero come quella cosa
che permane nonostante tutte le sue possibili trasformazioni. Ecco allora spiegata la sua priorità
rispetto a tutte le altre categorie. Rimanendo sul piano linguistico, se voglio costruire una frase
dotata di senso devo per forza ricorrere ad un soggetto. Posso affermare che “l'uomo corre”, non che
“rosso corre”. In questo caso la sostanza è il soggetto, ciò che dà senso alla frase. Dunque la
sostanza sorregge tutte le altre categorie, che si presentano come suoi predicati. Passando al piano
della realtà, le sostanze sono le cose che possono esistere di per sé, mentre le altre categorie sono
solamente suoi attributi o, come le chiama Aristotele, accidenti. L'uomo, dunque, esiste di per sé,
mentre il bianco solo come eventualmente sua qualità. La sostanza è essenza, sostrato o, meglio
ancora, ciò che permane nonostante tutte le possibili trasformazioni di una determinata cosa. Essere
bianchi, neri o rossi di pelle non modifica l'essere umano di un soggetto.
E tuttavia anche la categoria della sostanza ha una sua complessità. Se, infatti, scendiamo nella
colonna dei generi e delle specie, cioè verso il particolare, quale è il predicato ultimo che
incontriamo? Troveremo un termine che non è più generale, ma che nomina un particolare
individuo, per esempio “Socrate”. Ebbene, questo tipo particolarissimo di termine è l'unico che
possa presentarsi sempre come soggetto e mai come predicato, mentre “uomo” può essere sia
soggetto, per esempio “l'uomo è animale”, sia predicato, “Socrate è uomo”; non ha invece senso
dire “uomo è Socrate”. Ora, se la priorità della sostanza rispetto a tutte le altre categorie era data dal
fatto che questa è soggetto, il fatto che la sostanza individuale, cioè “Socrate”, sia “più soggetto”
della sostanza universale fonda la sua priorità nei confronti proprio di quest'ultima: infatti Aristotele
chiama la sostanza individuale (“Socrate”, “Platone” eccetera) sostanza prima e la sostanza
universale (“uomo”) sostanza seconda. Se si passa ancora una volta sul piano della realtà, ne
consegue che la sostanza esiste, per così dire, a maggior diritto delle altre categorie, ma che ciò vale
anche per la sostanza prima nei confronti di quella seconda: qualora non esistessero sostanze
individuali, come Socrate, non esisterebbero né gli attributi interni alla categoria della sostanza
(“uomo”, “animale” eccetera) né quelli esterni (“bianco”, “alto” eccetera). Dunque, l'aspetto
saliente della realtà da cui dipende tutto ciò che a vario titolo può essere detto reale è l'ente
individuale e questo rappresenta un salto notevole rispetto alla visione totalizzante della filosofia di
Platone, dove l'individuo scompariva davanti all'intero, come per esempio nello Stato ideale della
Repubblica. È dunque proprio a partire dallo studio della dialettica platonica, nel tentativo di
definirla nei suoi aspetti linguistici, che si consuma la rottura tra Aristotele e Platone. Per
quest'ultimo, infatti, l'aspetto determinante della realtà è dato dagli enti universali, cioè dalle idee,
non da quelli individuali: le cose sensibili sono quello che sono, sia pure in modo imperfetto, nella
misura in cui partecipano delle idee, che costituiscono la loro causa. Aristotele concorda nel ritenere
gli universali come unici oggetti della conoscenza intellettiva, ma questi esistono solamente come
attributi delle cose individuali e non viceversa. Dunque l'errore di Platone – sostiene Aristotele – sta
nell'avere dedotto dal principio ineccepibile secondo cui la vera conoscenza è quella dell'universale
la conseguenza erronea che ciò debba comportare l'esistenza dell'universale come oggetto
indipendente e superiore agli enti particolari, rovesciando il corretto ordine delle cose. Ben inteso,
anche per Aristotele la struttura piramidale va dal particolare all'universale, dal molteplice
all'unitario e tuttavia il processo di unificazione non supera mai le categorie: non esiste cioè il
genere dell'essere. Per Platone, al contrario, il processo è completo e porta ad un termine unitario e
supremo come l'idea del Bene. Aggiungendo che per Platone ciò che è uno e universale è essere a
maggior titolo di ciò che è particolare e molteplice, ne consegue che l'essere vero è uno e dunque
l'esistenza del molteplice, che è meno essere dell'uno, si può spiegare solo introducendo il nonoessere come causa, il che è assurdo, perché il non-essere non può essere causa di nulla, come
giustamente sostiene Aristotele.
La critica dello stagirita al maestro è, come si può notare, serrata e giunge al culmine con il famoso
argomento del terzo uomo. Perché Platone afferma che esistono le idee? Perché nota somiglianze
tra certe cose sensibili, ad esempio tra le cose belle, e ne deduce l'esistenza dell'idea della Bellezza.
Ma se l'idea della Bellezza esiste proprio come un oggetto, anch'essa sarà una “cosa bella”. Si crea
cioè, secondo Aristotele, un nuovo insieme di “cose belle”, comprendente sia le cose belle sensibili
sia quella “cosa bella” che è l'idea stessa della Bellezza. Ma se questo è vero – e logicamente lo è –
allora è necessario porre una terza bellezza (o una seconda idea di bellezza) per rendere ragione
della qualità della bellezza stessa, che è patrimonio comune delle cose belle sensibili e della (prima)
idea di Bellezza e così all'infinito.
Il discorso aristotelico culmina nella teoria della conoscenza. L'uomo come conosce quello che
circonda? Anche qui il salto rispetto a Platone è notevole. Lo stagirita sostiene infatti che tutto abbia
inizio con i sensi: sono loro a cogliere l'oggetto, trasmettendo un flusso di informazioni al cervello.
E tuttavia la conoscenza è per Aristotele sempre dell'universale e mai del particolare: occorre di
conseguenza cogliere la vera essenza delle cose, spogliare l'oggetto dei suoi aspetti accessori, dei
suoi “accidenti” per giungere all'universale. Che una determinata persona decida di colorarsi i
capelli di rosso o di azzurro, non ne cambia la sostanza. Nemmeno se, malauguratamente, dovesse
perdere una gamba o la vista. Ciò che fa di quella persona un soggetto unico tra quelli della sua
specie (quello degli esseri umani, che, in quanto tali, possiedono la ragione) sarà un determinato
carattere, una determinata personalità, taluni particolari che lo rendono, appunto, unico. Partendo
dalle considerazioni più generali, cioè, si vanno gradualmente eliminando gli accidenti fino a
giungere all'individuo concreto, alla sostanza prima. Il processo di “espoliazione” non è affatto
figurato. Se vogliamo individuare cosa fa di un uomo un uomo e di una donna una donna, dobbiamo
letteralmente spogliarli fino a metterne in luce i loro organi genitali (e, per Aristotele, come
vedremo, anche il loro potenziale produttivo).
LA LOGICA
Aristotele distingue le scienze in tre grandi gruppi: 1) Scienze teoretiche, che hanno per fine la
conoscenza e cioè Fisica, Filosofia Prima e Matematica; 2) Scienze pratiche, che hanno per fine
l'azione e cioè Etica e Politica; 3) Scienze Poietiche o produttive, che hanno per fine il produrre e
cioè Poetica, Retorica e tutte le tecniche artigianali. Come si vede, non compare la Logica. Come è
possibile che il filosofo che viene universalmente riconosciuto come il creatore della Logica non
consideri questa una scienza? Il fatto è che per Aristotele la scienza si rivolge a qualche cosa, a un
determinato genere di realtà, mentre la Logica non si rivolge a nulla, ma studia, in via preliminare, i
metodi e gli strumenti di cui le scienze si servono nel loro lavoro. Di qui il titolo di Organon, ossia
“strumento”, che è stato attribuito all'insieme degli scritti di logica. Insomma, la logica non è
scienza poiché è la condizione di ogni scienza possibile.
Della Logica fa parte anche la teoria delle Categorie, cioè lo studio degli elementi primi di un
discorso. Il passo successivo è costituito dallo studio delle proposizioni, i cui termini sono connessi
tra loro. Non tutte le proposizioni interessano la scienza, ma solamente le cosiddette asserzioni,
cioè quelle che affermano o negano un certo stato di cose e che dunque possono essere solamente o
vere o false. Le proposizioni non assertorie, come le domande, le preghiere, le esortazioni, non sono
soggette a tale criterio di verità/falsità e dunque non interessano la logica (e quindi nemmeno la
scienza). Le asserzioni si distinguono in base al duplice criterio della qualità e della quantità.
Secondo la qualità le asserzioni possono essere affermative o negative; secondo la quantità possono
essere universali (“tutti gli uomini sono mortali”), particolari (“qualche uomo è greco”), singolari
(“Socrate è mortale”). Ma le asserzioni singolari non interessano la scienza poiché non esiste
scienza degli enti individuali. Combinando i due criteri suddetti si originano dunque quattro tipi
diversi di proposizioni: universale affermativa (UA: “tutti gli uomini sono mortali”), universale
negativa (UN: “nessun uomo è mortale”), particolare affermativa (PA: “qualche uomo è greco”),
particolare negativa (PN: “qualche uomo non è greco”). Aristotele ha determinato le relazioni che
sussistono tra questi quattro generi di proposizioni, che verranno successivamente schematizzate
dalla logica medievale mediante il cosiddetto “quadrato degli opposti”:
UA
UN
CONTRARIE
possono essere entrambe false;
non possono essere entrambe vere
S
U
B
O
R
D
I
N
A
T
A
PA
CONTRADDITORIE
se UN è falsa PA è vera e viceversa;
se UA è falsa PN è vera e viceversa
S
U
B
O
R
D
I
N
A
T
A
CONTRARIE
possono essere entrambe vere;
non possono essere entrambe false
PN
Rapporto di contraddizione: se è vero che “tutti gli uomini sono mortali” (UA) allora è
necessariamente falso che “qualche uomo non sia mortale” (PN); se è vero che “tutti gli uomini non
sono immortali” (UN) allora è necessariamente falso che “qualche uomo è immortale”.
Rapporto di contrarietà: “tutti gli uomini sono mortali” (UA); “tutti gli uomini non sono mortali”:
possono essere entrambe false, ma non tutte e due vere; “qualche uomo è mortale” (PA); “qualche
uomo non è mortale” (PN): possono essere entrambe vere, ma non entrambe false
Rapporto di subordinazione: nell'affermazione “tutti gli uomini sono mortali” (UA) è compresa
l'affermazione “qualche uomo è mortale” (PA); nell'affermazione “tutti gli uomini non sono
immortali” (UN) è compresa l'affermazione “qualche uomo non è mortale” (PN).
La combinazione di più proposizioni in una argomentazione dà vita al sillogismo (dal greco syn,
“con”, e logismòs, “calcolo”, “ragionamento”): si tratta di un ragionamento in cui, date alcune
premesse, ne consegue con forza di necessità una conclusione, nella forma di una proposizione
assertoria. Il sillogismo-tipo studiato da Aristotele ha sempre due premesse, l'una chiamata
premessa maggiore e l'altra premessa minore. Le proposizioni a loro volta sono composte di
termini, che nel sillogismo formato da due premesse sono tre: soggetto, predicato e termine
medio. Quest'ultimo, di fondamentale importanza nella logica aristotelica, compare nelle premesse
ma scompare nella conclusione: è il mezzo mediante il quale il soggetto e il predicato vengono
collegati per dare origine all'asserzione conclusiva, come avviene nell'esempio che segue:
Tutti gli uomini sono animali
Tutti i greci sono uomini
Tutti i greci sono animali
Il termine “greci” è il soggetto, il termine “animali” è il predicato, mentre il termine medio è
“uomini”.
Aristotele distingue i sillogismi in tre figure, in base al fatto che il termine medio nelle due
premesse sia soggetto o predicato. L'esempio precedente è un sillogismo di prima figura in cui il
termine medio è soggetto nella premessa maggiore e predicato in quella minore. Nel sillogismo di
seconda figura, invece, il termine medio è predicato in entrambe le premesse, mentre nel
sillogismo di terza figura è in entrambe le premesse soggetto.
La validità di un sillogismo dipende dalla natura delle sue premesse. Nell'esempio precedente sia le
premesse sia le conclusioni sono proposizioni universali affermative. Quello che segue, invece, è di
natura ben diversa:
Qualche uomo è pittore
qualche uomo è greco
qualche greco è pittore
Si tratta di un sillogismo non valido, anche se le proposizioni sono vere. Infatti, è logicamente
possibile che nel gruppo particolare di uomini che sanno dipingere non sia compreso alcun greco. E
tuttavia il fatto che il sillogismo sia valido non significa ancora che le sue conclusioni siano vere. Se
le premesse sono false, infatti, il ragionamento risulterà necessariamente sbagliato. Occorre di
conseguenza distinguere tra la correttezza formale e la verità del contenuto di un sillogismo.
Aristotele afferma che il sillogismo è scientifico (o deduttivo) solo quando si basa su premesse,
ossia su asserzioni riguardo alla natura delle cose vere e prime. Vere e prime sono quelle
proposizioni le quali, in rapporto alle loro conseguenti, sono più universali e al tempo stesso
necessarie, perché ne individuano la causa. Quando diciamo, per esempio, che “il bosco è bagnato
perché ha piovuto”, indichiamo al tempo stesso un rapporto causale tra due eventi e un rapporto di
implicazione tra due proposizioni (la proposizione “ha piovuto” è prima in rapporto alla
proposizione “il bosco è bagnato”). E tuttavia il problema è come trovare le premesse prime. Non
aiuta certo ricavarle da un altro sillogismo, perché dovremmo dimostrare di nuovo la verità delle
sue premesse, innescando così un rimando all'infinito, uno sterile processo circolare. Occorrono
invece dei principi, i quali si dividono in principi propri di ciascuna scienza e principi comuni
a tutte le scienze o a più di una scienza (assiomi). I primi sono ipotesi e definizioni. Le ipotesi
costituiscono l'affermazione dell'esistenza degli oggetti di cui una scienza si occupa. Per tale motivo
non fanno parte della scienza vera e propria, ma si ricavano dall'evidenza. Ad esempio, l'ipotesi da
cui parte la fisica è che esistano sostanze mobili, ma la fisica prende questo dato dall'esperienza,
non ha il compito di dimostrarlo. Molto più importanti le definizioni, come per esempio “l'uomo è
animale razionale”. La definizione dice che cosa un oggetto veramente è, ossia la sua essenza,
menzionando il genere prossimo in cui esso rientra e poi la differenza che lo distingue dalle altre
specie appartenenti al medesimo genere: “l'uomo è animale (genere prossimo) razionale
(differenza specifica)”. Tanto il genere quanto la differenza specifica, così come il soggetto da
definire, sono termini universali. Ma poiché per Aristotele gli universali non esistono separatamente
dalla realtà sensibile, quale è il procedimento mediante il quale la mente umana perviene ad isolarli
e a riconoscerli? L'induzione. Si dice induzione qualunque processo che muova dal particolare
verso l'universale. Tutti gli animali sono dotati di sensazione e alcuni possiedono anche la memoria.
Ma mentre gli animali hanno solamente i ricordi singoli e disorganici, gli uomini sono in grado di
accumulare molti ricordi della stessa cosa per costituire l'esperienza, la quale, a sua volta, è la base
per la nascita del concetto universale. Se, per esempio, ho avuto più volte la sensazione del
“rosso”, la memoria mi permette di conservare e unificare questi ricordi in un unico concetto, il
“colore rosso” appunto. Le definizioni, dunque, dovrebbero rappresentare le premesse della scienza,
mentre il sillogismo la sua esecuzione. E tuttavia Aristotele non procede in questo modo. Egli usa
regolarmente non già il sillogismo scientifico ma il sillogismo dialettico, che, a differenza del
primo, si fonda su premesse non vere e prime ma solamente probabili: gli èndoxa. Con questo
termine lo stagirita indica le opinioni già espresse da altri uomini che meritano di essere prese in
considerazione o perché largamente sostenute o perché accolte dalle persone più autorevoli. La
ragione che spinge Aristotele a sostenere questo tipo di ragionamento, in luogo di quello scientifico,
dipende probabilmente dal fatto che all'atto pratico è davvero impossibile reperire premesse che
siano davvero vere e prime. Questo è il limite della deduzione, che si ripercuote su tutto il metodo
induttivo. Se possediamo premesse assolutamente vere, potremmo ricavarne deduttivamente delle
conclusioni da esse implicati, che arricchirebbero la nostra conoscenza della realtà. Poiché,
viceversa, ciò non accade, siamo costretti a dipendere totalmente dall'esperienza. E tuttavia
l'esperienza per Aristotele è rappresentata da tutto il materiale già raccolto ed elaborato in forma di
proposizioni particolarmente autorevoli, gli èndoxa appunto. Ma torniamo ai sillogismi.
È possibile raffigurarli graficamente (come in figura 1) tenendo sempre ben presente che esistono
solo quattro tipi di proposizioni valide e cioè:
Universale affermativa (A) “Tutti i P sono Q” (“Ogni P è Q”)
Universale negativa (E) “Tutti i P non sono Q” (“Nessun P è Q”)
Particolare affermativa (I) “Qualche P è Q” (“Esiste un P che è Q”)
Particolare negativa (O)“Qualche P non è Q”(“Esiste un P che non è Q”)
Negli ultimi due ultimi casi si sono evidenziati con dei punti neri alcuni elementi che appartengono
agli insiemi. Va infatti tenuto presente che, in generale, può anche verificarsi il caso in cui l’insieme
dei P o l’insieme dei Q (o entrambi) risultino vuoti (può infatti non esserci alcun individuo che
verifica la proprietà P o la proprietà Q).
Definizione 1: Un sillogismo è un’inferenza costituita da due premesse e una conclusione le quali
sono tutte e tre proposizioni di uno dei quattro tipi evidenziati in precedenza. Le due premesse
devono avere una proprietà in comune e nella conclusione figurano le altre due proprietà presenti
nelle premesse. Un esempio di sillogismo in cui le premesse e la conclusione sono tutte e tre
universali affermative è il seguente:
Tutti i liguri sono italiani
Tutti gli italiani sono europei
Tutti i liguri sono europei
Qui intervengono tre proprietà (“essere ligure”, “essere italiano”, “essere europeo”, che indichiamo
con P, Q, R rispettivamente) di cui una (“essere italiano”), detta termine medio, è comune alla due
premesse e le altre due intervengono ciascuna in una sola delle due premesse e nella conclusione
(anche nel seguito indicheremo Q la proprietà comune alle due premesse e P e R le altre due, che
figurano nella conclusione). Un sillogismo è corretto se e solo se la conclusione è conseguenza
logica delle premesse, ossia se la verità delle premesse implica quella della conclusione (non può
darsi il caso che le premesse siano vere e la conclusione falsa). La correttezza del sillogismo può
essere dimostrata utilizzando ancora una volta i diagrammi. Rappresentiamo in uno stesso
diagramma gli insiemi P, Q, R dei liguri, degli italiani e degli europei in modo che siano verificate
le premesse (ossia con l’insieme P contenuto nell’insieme Q e l’insieme Q contenuto nell’insieme
R):
Ne segue che l’insieme dei P è contenuto nell’insieme degli R. In altri termini, rappresentando le
due premesse si ottiene una rappresentazione della conclusione. Quindi, dalla verità di “Tutti i P
sono Q” e “Tutti i Q sono R” segue quella di “Tutti i P sono R”, e il sillogismo è corretto.
L’inferenza è corretta anche se non vi sono oggetti che soddisfano le proprietà P, Q, R.
Il metodo dei diagrammi è applicabile a (quasi) tutti i sillogismi. Vediamone alcuni.
Esempio 1:
Nessun Q è P
Tutti gli R sono Q
Nessun R è P
Graficamente:
di conseguenza:
Il sillogismo è anche questa volta corretto.
Passiamo a due esempi più complessi:
Esempio 2a:
Tutti i Q sono P
Qualche R è Q
Qualche R è P
Esempio 2b:
Nessun Q è P
Qualche R è Q
Qualche R non è P
Graficamente:
Anche in questo caso si tratta di sillogismi corretti.
Esempio 3.
Tutti i P sono Q
Qualche R è Q
Qualche R è P
In questo caso il sillogismo non è corretto. Infatti:
Dalla ipotesi che l’insieme P è contenuto in Q e che R interseca Q non segue che R interseca P. Per
esempio, dall'affermare che “Tutti gli uomini portano i pantaloni” e che “Qualche donna porta i
pantaloni” non segue affatto che “Qualche donna è uomo”.
Esempio4:
Tutti i Q sono P
Tutti i Q sono R
Qualche R è P
Non è un sillogismo corretto:
In questo caso occorre non lasciarsi trarre in inganno dalla figura (a dimostrazione del fatto che
questo metodo non è infallibile): Q è infatti contenuto sia in P, sia in R, ma questo non implica che
P e R si intersechino. Infatti Q può anche essere vuoto. Ad esempio, sono vere entrambe le
proposizioni “Tutti i liguri nati a Torino sono alti” e “Tutti i liguri nati a Torino sono bassi” in
quanto non esiste alcun ligure nato a Torino (si ricordi che un condizionale con antecedente falso è
vero e quindi sono entrambe vere: “Per ogni x, se x è un ligure nato a Torino, allora x è alto” e “Per
ogni x, se x è un ligure nato a Torino, allora x è basso). Tuttavia da esse non si può dedurre “Vi è
qualcuno che è alto e basso”, che è evidentemente falsa.
Ricapitolando, il sillogismo non è mai vero né mai falso, ma solamente o corretto o scorretto, ha,
dunque, una validità solamente formale. Per esempio, il sillogismo che segue è corretto dal punto
di vista formale, ma non ovviamente dal punto di vista reale:
Gli asini hanno le ali
Marco è un asino
Marco ha le ali
E' evidente, in questo caso, l'errore di avere scelto delle premesse non vere. E tuttavia il discorso, il
ragionamento, è comunque formalmente corretto, come anche quello che segue:
Tutti i camini fumano
Mio nonno fuma
Mio nonno è un camino
Vi sono alcune ragioni che determinano un risultato “cattivo” o inadeguato:
1. Premesse false
Se le premesse sono false (come nei due esempi precedenti), anche un ragionamento formalmente
corretto non potrà mai giungere ad una conclusione vera e fondata. Di fronte ad un argomento
dubbio, perciò, dovremo valutare sempre con cura il valore di verità delle sue premesse. Non di
rado nei ragionamenti alcune premesse rimangono implicite, cioè non vengono espresse. In questo
caso, prima di procedere con l’analisi, sarà necessario rendere esplicite tutte le premesse.
2. Inferenze errate
Un argomento, pur partendo da premesse vere, non ci condurrà ad una conclusione valida se
contiene delle inferenze errate, cioè se non rispetta le leggi fondamentali della logica. Dovremo
quindi assicuraci che il passaggio dalle premesse alla conclusione sia corretto e ben giustificato.
3. Argomento inappropriato o emozionale
Un buon argomento, corretto e con premesse vere, potrebbe essere comunque inadeguato al
contesto, cioè dimostrare una conclusione che non è rilevante in riferimento al tema di cui si sta
discutendo; oppure, invece di coinvolgere la nostra sfera razionale, potrebbe far leva sulle nostre
reazioni emotive.
Entriamo nel particolare e vediamo quali sono gli errori più comuni nella formulazione di un
sillogismo.
Argomenti fallaci nell'espressione
a)
Ambiguità semantica (equivocazione)
Si tratta dell'attribuzione di differenti significati ad un medesimo termine. Come per esempio
quando affermiamo che:
Tutto ciò che corre ha i piedi, il tempo corre, il tempo ha i piedi
E' evidente in questo caso l'errata attribuzione sia della “corsa” applicata al tempo (si tratta ifnatti di
un modo dire, di un detto popolare) sia il fatto che tutto ciò che corra sia necessariamente dotato di
“piedi”.
b)
Ambiguità sintattica (anfibolia)
L'ambiguità può riguardare non solo una singola parola ma una intera frase. Per esempio,
l'espressione “desidero la prigione dei miei nemici” non è affatto chiara. Che cosa si desidera
effettivamente, la prigione in cui sono rinchiusi i miei nemici oppure vedere i miei nemici in
prigione? Simili ambiguità possono portare a ragionamenti fallaci come quello che segue:
Tutto ciò che è di Luca è da lui posseduto; questo disco è di Luca; questo disco è posseduto da
Luca
c)
Vaghezza
Un termine è vago quando non presenta confini precisi circa il suo significato. Nella vita di tutti i
giorni questo non è un problema: si usano comunemente termini come “ricco” o “povero” senza
preoccuparsi di stabilire con precisione quale sia la soglia per essere incluso nel primo o nel
secondo insieme. Ma nel sillogismo questo porta a non pochi problemi, come mostra l'esempio che
segue:
Un singolo chicco di grano non è un mucchio e se io aggiungo a qualcosa che non è un mucchio un
solo chicco di grano non posso ottenere un mucchio e così se ne aggiungo un altro eccetera.
d)
Accenti o enfasi
Tale fallacia si ottiene quando si sottolinea, evidenzia, cela o nasconde un termine o parte di una
frase, suggerendo una interpretazione della proposizione diversa dal suo significato letterale.
Prof, io questa volta ho studiato
Argomenti razionalmente irrilevanti
Sono quegli argomenti che, invece di dimostrare la veridicità o la falsità di una tesi, spingono ad
accettarla o a rifiutarla facendo leva sulle nostre emozioni. Si tratta di argomenti molto diffusi, sia al
tempo di Aristotele sia (o forse anche più) oggi.
a)
Argumentum ad verecundiam (appello all'autorità)
Si fa appello al timore reverenziale (verecundiam) nei confronti dell'autorità. Di per sé il ricorso ad
una autorità non costituisce una fallacia – d'altro canto lo stesso Aristotele fonda i sillogismi sugli
èndoxa – ma in questo caso l'errore sta nel ricorso ad una autorità non appropriata. È un argomento
tornato molto di moda nella nostra società.
•
•
La tv ha detto che la criminalità è in aumento; quindi sono falsi i dati che indicano
esattamente il contrario
Ieri quel noto politico ha sostenuto che la teoria evoluzionistica di Darwin è errata, quindi
sono tutti da buttare i libri che ne sostengono la validità
Nel primo caso la fallacia sta nel ricorrere ad un mezzo, quello televisivo, che non rappresenta una
autorità in quel campo, che dovrebbe essere di competenza del ministero degli Interni o delle forze
di polizia o degli studiosi del settore. Anche nel secondo caso si ricorre ad una autorità in modo
inappropriato: il fatto di essere politico non garantisce di per sé la validità di un argomento, come
invece dovrebbe accadere con i libri scritti da esperti del settore.
b) Argumentum ad populum (appello alla maggioranza)
In una società massificata come la nostra è forse l'argomento che va per la maggiore. È il noto
ricorso al si dice:
•
•
•
Se così tante persone credono all'esistenza di Dio, allora sarà vero
Se la maggioranza degli Stati americani ricorre alla pena di morte, significa che è efficace
E' noto a tutti che il cibo italiano è migliore
c)
Argumentum ad baculum (ricorso alla paura)
Per convincere qualcuno della validità di una tesi si fa spesso ricorso ad una minaccia, lo si
spaventa o si ricorre addirittura alla forza (Baculum significa non a caso “bastone”).
•
•
Hai visto cosa succede a chi la pensa come te?
È necessario affermare l'esistenza di Dio, altrimenti non sarebbe possibile alcuna legge
•
morale e la vita degli uomini scivolerebbe nel caos
Se riconosciamo le coppie di fatto, dove andremo a finire? Nessuno avrà più voglia di fare
figli e così la nostra civiltà scomparirà
La prima affermazione è piuttosto ricorrente: si spaventa chi ha una posizione ben precisa (una idea
politica, religiosa, una visione del mondo piuttosto fuori dagli schemi solitamente) paventando le
più nefaste conseguenze, dall'isolamento alla punizione, passando dal carcere o addirittura alla
morte. Chi parla non necessariamente condanna tali posizioni, ma di fatto le depotenzia, invitando
l'interlocutore ad abbandonarle.
La seconda è anch'essa tornata molto di moda (la frase è stata pronunciata in un programma
televisivo da un politico italiano): si presuppone che solo chi crede in dio possegga una morale tale
da potere evitare il caos, dimenticando, per esempio, le innumerevoli guerre di religione che ancora
oggi insanguinano il mondo.
La terza affermazione (anch'essa pronunciata da un politico nel corso di una trasmissione televisiva
– e questo conferma il legame tra questo argomento e i precedenti) sottintende che chi non si sposa
non ha alcuna intenzione di fare figli. Si tratta naturalmente di un grossolano errore: non è la
certificazione del matrimonio ad aumentare la fertilità delle coppie (per non parlare della felicità),
come mostrano gli indici demografici delle metropoli occidentali, dove le coppie di fatto sono di
numero superiore a quelle “ufficiali”, tutti in sensibile aumento.
d)
Argumentum ad hominem (contro la persona)
In questo caso è l'interlocutore in quanto tale, come persona, ad essere contestato. Si tratta di un
attacco diretto, personale.
•
•
Non ha alcun senso parlare con te della guerra in Iraq: si sa che sei un pacifista sfegatato
Non ha alcun senso parlare con te della pace: si sa che sei un guerrafondaio sfegatato
e) Argumentum ad hominem “tu quoque” (“proprio tu!”)
E' una variante della precedente. Si nega la validità di una posizione denunciando lacoerenza
dell'interlocutore.
•
•
Il mio medico sostiene che devo smettere al più presto di fumare. Parla proprio lui, che si
fuma un pacchetto al giorno di sigarette!
I miei genitori non vogliono che torni tardi la sera. Parlano proprio loro, che quando erano
giovani sono scappati di casa
Argomenti logicamente scorretti
Si tratta di argomenti che, pur non facendo appello a fattori emozionali, presentano tuttavia qualche
“errore”. Si tratta, più precisamente, di “fallacie argomentative”
a)
Petitio principii
Consiste nell'assumere nelle premesse (implicitamente o esplicitamente) la tesi che si intende
dimostrare. Ma in tal modo non si dimostra proprio nulla.
•
•
•
Dio esiste perché lo dice la Bibbia e la Bibbia non può mentire perché è stata scritta da
Dio, che essendo buono non mente mai
Marta mi ha detto che sono la sua migliore amica. Sono sicura che sia vero, in quanto
nessuna ragazza mentirebbe alla sua migliore amica
Se duplicare i Cd non fosse illegale, allora non sarebbe proibito dalla legge
b)
Ignoratio elenchi
Si presenta quando un argomento proposto, pur presentando premesse vere, giunge a conclusioni
che nulla hanno a che fare con ciò di cui si sta discutendo: si tratta cioè di un argomento non
appropriato al contesto (detta anche “conclusione non pertinente”). In sostanza, un simile
argomento prova qualcosa di diverso da ciò che si vuole dimostrare
I calciatori italiani sono i migliori al mondo. Lo dimostra il fatto che vengono pagati molto di più
di quelli di altri campionati
c)
Uomo di paglia
Si tratta di una variante della precedente, che si presenta spesso quando in un dibattito qualcuno
cerca di confutare il proprio interlocutore distorcendo la sua posizione, rendendola agli occhi dei
presenti assurda.
•
•
Tu dici di volere ridurre le spese militari. Ma ti rendi conto? In un simile contesto
internazionale rischiamo di essere invasi in ventiquattro ore!
Vuoi che gli immigrati possano votare? E così poi la violenza dilagherà in tutto il paese!
Anche in questo caso si tratta di atteggiamenti piuttosto diffusi. Non si nega la validità delle
posizioni espresse (da entrambi gli interlocutori), ma si distorce il la posizione di uno dei due,
modificandone il senso.
d)
Argumentum ad ignoratiam
Un altra fallacia molto comune: si sostiene la validità di una tesi semplicemente perché, fino ad ora,
non è stata ancora confutata.
•
•
Quell'uomo politico è sicuramente una persona onesta: non ha mai ricevuto una
comunicazione giudiziaria!
Gli extraterrestri esistono, come dimostra il fatto che nessuno è riuscito a smentirne
l'esistenza
e)
Falsa disgiunzione o falso dilemma
Ancora una fallacia molto comune: si presentano come alternative due o più opzioni, costringendo
l'interlocutore a sceglierne una. La fallacia consiste nel fatto che la scelta è obbligata. In realtà le
opzioni sarebbero molte di più, ma chi mette in atto tale atteggiamento le nasconde più o meno
consapevolmente.
•
•
Non abbiamo scelta: o riduciamo le spese per scuola o sanità o il deficit pubblico si
ingrosserà a dismisura
Vogliamo schierarci o no per la difesa delle radici cristiane dell'Europa o vogliamo invece
consegnare il continente ai musulmani?
Si tratta in entrambi i casi di argomenti tratti da trasmissioni televisive nostrane dunque reali.
Nel primo caso la scelta appare davvero obbligata: chi rischierebbe la bancarotta dello Stato? E
tuttavia ci sono altre opzioni, volutamente (in questo caso) nascoste. Nello specifico caso italiano a
cui l'esempio si riferisce, si potrebbe combattere l'evasione fiscale, che costa alle casse dello Stato
circa 200 miliardi di euro ogni anno, vale a dire quanto cinque finanziarie.
Nel secondo caso si potrebbe naturalmente rispondere che le radici dell'Europa risiedono soprattutto
nei principi di tolleranza che si sono imposti nel tempo proprio contro l'intolleranza religiosa delle
varie componenti della cristianità oppure che il cristianesimo, nelle sue tante sette, può essere
interpretato come tolleranza, solidarietà ed amore del prossimo.
f)
Questione complessa o domanda composta
E' il converso della fallacia precedente. Per costringere l'interlocutore ad accettare la propria tesi, la
si presenta come indissolubilmente congiunta ad un'altra che gode di ampia condivisione (ennesimo
ricorso all'argumentum ad populum).
•
•
Sei favorevole alla tolleranza religiosa e quindi anche alle vignette contro l'Islam o il Papa?
Il poliziotto chiese: “dove hai messo la refurtiva”?
Il primo argomento è naturalmente mal posto. Sostenere la validità della tolleranza religiosa non
significa necessariamente difendere chi sbeffeggia le religioni.
Nel secondo caso si presuppone che l'interlocutore abbia effettivamente rubato qualche cosa prima
che tale reato venga dimostrato.
g)
Composizione
La fallacia di composizione si presenta quando si attribuisce al tutto una proprietà che appartiene
solo ad una parte oppure ad un singolo elemento che ne fa parte.
•
•
•
E' noto che i rom rubano. Dunque i rom sono un popolo di ladri
Tutti i pezzi di legno che compongono questa chitarra sono di qualità; quindi questa
chitarra è senza dubbio di qualità
Gli atomi sono invisibili; i gatti son fatti di atomi; i gatti sono invisibili
La proposizione che più di tutte mostra la fallacia di tale argomento è sicuramente il secondo. Il
fatto che un chitarra sia stata creata con ottimo legno non implica affatto che sia anche di ottima
qualità. In questo caso si salta un passaggio fondamentale: il lavoro. Tutti i pezzi della chitarra,
infatti, potrebbero esser stati assemblati in maniera non impeccabile.
h)
Divisione
E' speculare rispetto alla fallacia precedente. In questo caso, infatti, le proprietà che appartengono al
tutto vengono applicate alle parti o ai singoli.
•
Gli Indiani d'America stanno scomparendo. Tu sei un Indiano d'America. Tu stai
scomparendo
Le poste italiane sono allo sfascio. Inevitabile, dato che tutti i postini sono degli sfaticati
•
•
In questo caso l'espressione più esaustiva è la prima, un sillogismo formalmente corretto ma che
porta a conclusioni errate anzi assurde.
La seconda è una fallacia piuttosto comune: posto infatti che sia vero che tutti i postini siano degli
sfaticati (il che è comunque impossibile da dimostrare), le poste italiane non si esauriscono nel
lavoro dei postini
Alcune regole per un corretto sillogismo
In linea di massima (ma non necessariamente), per un corretto sillogismo, occorre seguire queste
poche regole per evitare di cadere nelle fallaci argomentative e in altri errori.
1.
Devono essere presenti solamente tre termini (premessa maggiore, premessa minore e
termine medio)
2.
Il termine medio e la premessa maggiore devono essere distribuiti in modo uguale nelle
premessa come nelle conclusioni1
1 Un termine è distribuito in una proposizione quando ciò che viene detto si riferisce a tutti gli oggetti indicati da quel
termine. Prendiamo l'asserzione: “Tutti gli S sono P”. Il termine S è distribuito, in quanto l'enunciato dice qualcosa
che vale per tutti gli S. Il termine P, invece, non lo è, poiché non stiamo prendendo in considerazione tutti gli P, ma
3.
Il termine medio non deve mai essere presente nella conclusione
4.
Il termine medio deve essere distribuito in almeno una delle due premesse
5.
Da due premesse negative non segue alcuna conclusione
6.
Da due premesse affermative segue una conclusione affermativa
7.
Da due premesse particolari non segue alcuna conclusione
8.
Se una delle premesse è negativa, la conclusione dovrà essere negativa; se una delle
premesse è particolare, la conclusione dovrà essere particolare.
Conclusioni
Il metodo ordinario utilizzato dalla scienza prenderà le mosse da una serie più o meno accurata di
descrizioni dell'esperienza (gli èndoxa), per poi ragionarvi sopra con lo scopo di decidere quali sono
le migliori, ossia quelle che più difficilmente possono essere confutate dal ragionamento. Tale
metodo è evidentemente più debole di quello deduttivo utilizzato dal sillogismo scientifico, perché
né le premesse di partenza (èndoxa) né le conclusioni raggiunte possono essere considerate vere in
modo assoluto. Ma in certi casi consegue un altissimo valore dimostrativo. Ciò accade in particolare
quando su un dato problema si riesce a individuare la rosa completa delle possibili soluzioni e si
perviene ad escluderle tutte tranne una. In questo caso la proposizione che esprime questa soluzione
può ritenersi praticamente dimostrata. Non sembrerà strano, sulla base di quanto detto, che l'unico
vero ambito di applicazione del sillogismo scientifico sia quello delle scienze matematiche, ossia
quel settore di ricerca i cui oggetti sono sprovvisti di materia e l'induzione non è di nessuna utilità.
Per esempio, per stabilire con certezza assoluta che 2+2=4 non c'è alcun bisogno di raccogliere un
numero illimitato di casi, perché la necessità del risultato è ben visibile anche in una singola
operazione.
Sembra assodato che Aristotele prevedesse di utilizzare il procedimento deduttivo come strumento
di controllo ed insegnamento. Una volta che la scienza ha elaborato dialetticamente i suoi contenuti,
può essere utile verificare la tenuta del quadro complessivo che ne risulta, mostrando che le
conoscenze raggiunte si implicano logicamente l'una con l'altra. Inoltre, presentare la materia in
questa forma organica e strutturata è molto efficace nel momento in cui non si tratta più di edificare
la scienza, ma di insegnarla. La dialettica, dunque, è per Aristotele il metodo ordinario di quasi tutte
le scienze. Ma il suo significato ed il suo uso sono ancora più ampi: in generale è chiamato
dialettico qualunque ragionamento diverso da quello deduttivo. In questo senso Aristotele a volte
sembra considerare dialettico anche il ragionamento induttivo e in generale chiama dialettiche tutte
le forme argomentative che coinvolgono più generi, mentre il sillogismo scientifico si muove
sempre all'interno di una stessa colonna, articolata in generi e specie. Questo è il motivo per cui la
dialettica è l'unico procedimento adatto a dimostrare gli assiomi, ossia quei principi che sono
comuni a più scienze, o a anche a tutte. Un caso tipico di principio di quest'ultimo genere è il
cosiddetto principio di non contraddizione. Pur non essendo possibile dimostrare questo principio
sillogisticamente, si può tuttavia difenderlo in modo dialettico, cioè a partire dall'opinione di chi lo
nega e metterne in luce la inconsistenza. Chi dice qualcosa, infatti, pensa evidentemente che ciò che
dice abbia un ben preciso significato, distinto da altri. Se dico che “Socrate è seduto”, ammetto
implicitamente che “Socrate non è più in piedi”. L'atto stesso di pronunciare una affermazione
provvista di significato implica dunque che chi parla accetti il principio di non contraddizione. Chi
lo nega, di conseguenza, dovrebbe limitarsi a stare zitto. Ma chi evita di usare il linguaggio rinuncia
in pratica alla sua umanità.
solo una parte di essi, quelli che fanno parte di S.
LA FISICA
Secondo Aristotele, conoscere una certa cosa significa individuarne le cause, intese propriamente
come condizioni che ne rendono possibile l'esistenza. Lo stagirita ne individua quattro: causa
materiale, causa formale, causa efficiente, causa finale. La materia è ciò di cui una cosa è fatta,
mentre la forma è la configurazione che possiede. Prendiamo l'esempio di una statua: la sua materia
sarà il marmo, mentre la forma la figura; la causa efficiente è il principio motore che l'ha prodotta,
cioè lo scultore, mentre la causa finale è il fine per cui è stata realizzata. E tuttavia Aristotele tende
sostanzialmente ad unificare causa formale e causa finale, soprattutto negli esseri viventi. Mentre
infatti la causa finale della statua potrebbe essere un uso esterno (una dedica a qualche dio), la causa
finale di un essere vivente è la piena e completa realizzazione della sua forma (causa formale).
Anche in questo caso il distacco da Platone è totale: per Aristotele infatti non esiste una causa finale
unica per tutte le cose (come il Bene di Platone) né la causa finale ha un significato transitivo. Per
esempio, la causa finale per cui esiste un maiale, non transita affatto in un'altra specie (come l'uomo
che se ne ciba) ma permane nella specie stessa: lo scopo sarà quello di produrre un esemplare della
specie “maiale” il più possibile adeguato alla sua forma naturale. Una impostazione che finisce per
interessare tutta la natura (cioè tutti gli esseri viventi) La finalità percepibile nella natura, dunque,
non dipende affatto dalla provvidenza cosciente di una mente divina, come per Platone, bensì è una
qualità propria della natura in quanto tale.
Le quattro cause spiegano le cose in base alle condizioni e ai motivi per cui esse sono divenute
quello che sono e non altro. Il concetto di causa, dunque, implica quello di mutamento. D'altro
canto, il corrispondente termine greco aitìa, rimanda a significati come “autore”, “responsabile”,
“colpevole”. Noi tendiamo ad identificare come causa di una certa cosa l'evento che le ha dato
origine, ma per Aristotele questa non è che una delle cause, quella motrice. Per capire meglio il
pensiero dell'autore, occorre dunque integrare il concetto di “causa” con quello di “condizione”: ha
natura di causa non solo ciò che attivamente produce qualche cosa ma anche tutto ciò che
costituisce una condizione senza la quale una certa cosa non esisterebbe o non si produrrebbe.
Esistono per Aristotele quattro diversi generi di mutamento, distinguibili in base ad altrettante
categorie: secondo la sostanza, generazione e corruzione (se una cosa si modifica quanto alla sua
sostanza, vuol dire che non sarà più quella sostanza che era), secondo la quantità, aumento e
diminuzione, secondo la qualità, alterazione (come quando un colore impallidisce al sole),
secondo il luogo, spostamento locale.
Per spiegare la natura del mutamento Aristotele introduce due fondamentali termini: materia e
forma, corrispondenti a due delle cause sopra menzionate, e potenza e atto. Ciascuna sostanza
fisica è infatti composta di una materia e di una forma (che nella Filosofia Prima verrà chiamata
sinolo). Quando in una sostanza qualche cosa muta, essa viene in possesso di una forma che prima
non aveva. Ad esempio, lo scultore che modella una statua introduce nella materia del marmo una
forma nuova: il marmo è materia in rapporto alla forma che assumerà poi. Il blocco di marmo,
tuttavia, non è semplice materia priva di forma, perché una sua certa forma (sia pure grezza) la
possiede già. Per questo Aristotele dice che il mutamento avviene non dalla materia alla forma bensì
dalla privazione alla forma. Il blocco di marmo grezzo, infatti, può diventare statua perché è privo
della forma della statua. In ogni mutamento sono presenti tre termini: un sostrato (o soggetto) che
permane durante il processo, pur mutando una sua caratteristica, e due principi contrari: la
privazione, ossia la mancanza di una determinata forma, e la forma stessa, che il sostrato acquisisce
durante il mutamento. Per esempio: Socrate (sostrato), pur restando Socrate, passa da non musico
(privazione) a musico (forma). Il concetto di privazione rimanda in qualche modo al non-essere,
ma non si tratta di una nozione negativa. Infatti non tutti i soggetti hanno tutte le possibili
privazioni. Socrate è un non-musico diversamente da come lo è un gatto, perché egli può diventare
un musico, mentre per un gatto è impossibile. Perciò la privazione mostra anche, in positivo, ciò che
una cosa può diventare. L'insieme di tutte le privazioni inerenti ad un soggetto indica allora ciò che
un oggetto è in potenza, ossia tutte le caratteristiche che esso al momento non possiede ma che
potrebbe possedere in atto. Socrate non-musico è Socrate musico in potenza, mentre Socrate
musico è Socrate musico in atto. È bene tenere presente che per Aristotele l'atto è sempre anteriore
alla potenza. A prima vista sembrerebbe proprio il contrario: nel tempo, infatti, prima viene Socrate
non-musico (potenza) e poi Socrate musico (atto). E tuttavia il passaggio dalla potenza all'atto è
possibile solo se l'atto, sia dal punto di vista logico sia da quello reale, esiste anteriormente alla
potenza. Socrate non potrebbe diventare musico se la forma del musico non esistesse già in atto da
qualche parte (ad esempio nel maestro che gli insegna la musica). Allo stesso modo è vero che la
forma di un uomo si aggiunge in un secondo tempo a ciò che era l'uomo in potenza (il seme
fecondato); ma ciò non sarebbe possibile se la forma dell'uomo non fosse già presente in atto nei
suoi genitori. Qui, molto probabilmente, agisce nell'autore un retaggio della dottrina platonica della
realtà. È vero che le forme non sono separate e che la realtà prima è l'individuo. E tuttavia è la
forma a determinare la materia, la quale di per sé è pura indeterminatezza.
Per capire come è fatta la realtà occorre individuarne gli elementi primi. È vero che la natura è fatta
di materia, ma la materia, intesa come ciò che è privo di qualunque forma, è un concetto teorico e
non esiste in quanto tale. Infatti, ogni cosa, anche la più elementare, è già composta di una materia e
di una forma. Ciò vale anche per i quattro elementi primi, che Aristotele non fa che ricavare dalla
tradizione presocratica: si tratta di terra, acqua, aria, fuoco. E tuttavia l'autore ritiene che possano
anche trasformarsi l'uno nell'altro. A questi quattro elementi sono associate le qualità del freddo, del
caldo, del secco e dell'umido. La caratteristica principale degli elementi consiste nella tendenza a
muoversi verso il proprio luogo naturale. Si tratta di un movimento rettilineo, che va dall'alto
verso il basso per i due elementi più pesanti, terra e acqua, e dal basso verso l'alto per quelli più
leggeri, aria e fuoco. Quattro elementi e relativi moto rettilinei compongono il mondo sublunare,
vale a dire tutto ciò che esiste dalla Luna (esclusa) fino a noi. Ma quale è il luogo naturale di
ciascuno degli elementi? Per rispondere a questa domanda Aristotele ricorre ad esperimenti
squisitamente visivi. In sostanza, prendiamo due elementi e mettiamoli a confronto. Per determinare
quale tra l'acqua e la terra sia l'elemento più pesante basta gettare un pezzo di terra in un laghetto e
notare come questo finisca per posarsi sul fondo. Dunque la terra è più pesante dell'acqua. Ora
mettiamo a confronto aria e acqua, prendendo una cannuccia, immergendola nel solito laghetto e
soffiandoci dentro: le bolle d'aria salgono in superficie. Dunque l'aria è più leggera dell'acqua.
Rimane da stabilire quale, tra l'aria e il fuoco, sia l'elemento più leggero. Proviamo ad accendere un
fuoco e noteremo come questo tenda a salire verso l'alto, vincendo, per così dire, la resistenza
dell'aria. Dunque il fuoco è l'elemento più leggero di tutti, seguito da aria, acqua e fuoco. Questi i
luoghi naturali. La terra tenderà a collocarsi al centro. Su di lei poggerà uno strato d'acqua (gli
oceani), sopra il quale si estende uno strato d'aria (l'atmosfera). Il confine ultimo del mondo
sublunare è rappresentato dallo strato di fuoco. Dopodiché si passa in una regione totalmente
diversa, quella occupata dai corpi celesti. Aristotele ritiene che in questa zona non vi sia alcun
mutamento: tutto permane in eterno. Di conseguenza, non vi sarà alcun movimento rettilineo bensì
un solo movimento circolare; né sarà possibile riscontrare la presenza dei quattro elementi
precedenti, poiché questi si muovono di moto verticale. L'elemento che ruota in eterno è un altro,
l'etere, una sostanza trasparente che riempie per intero lo spazio celeste, formato da una serie di
sfere inserite l'una nell'altra. Ogni sfera si muove compatta insieme al suo pianeta. Quella che segue
è l'immagine che si ricava dalla visione aristotelica dell'universo:
La terra, dunque, è al centro dell'universo, ferma, immobile: tutto gli ruota attorno (moto circolare
eterno sopralunare). Si tratta di un universo finito, ai cui confini dimorano gli dèi. È il cosiddetto
sistema geocentrico, che verrà successivamente sistemata dall'astronomo Tolomeo: sistema
aristotelico-tolemaico. Un universo qualitativamente diviso in due settori nettamente distinti,
dunque: il sistema terrestre è soggetto al divenire, mentre quello sopralunare è eterno. Una visione
che si imporrà nel mondo occidentale piuttosto rapidamente e resisterà fino al secolo XVI. Perché
così a lungo? Una prima ragione è di tipo religiosa. Il cristianesimo in un primo tempo vede nella
filosofia greca un pericolo se non addirittura una vera e propria eresia (e infatti chiuderà tutte le
scuole filosofiche greche). Rimarrà nella storia la nota e polemica affermazione del teologo
cristiano Tertullino: “credo perché è assurdo”. Insomma, il pensiero razionale, non potendo
accettare né i misteri né tanto meno i dogmi della Chiesa è potenzialmente demoniaco. E tuttavia in
un secondo tempo la Chiesa comprende il valore della filosofia, soprattutto per chiarire le basi della
teologia cristiana ed imporle alle non poche “sette” ribelli. Ebbene, la visione dell'universo di
Aristotele e Tolomeo si sposa con il racconto biblico, con la centralità della terra, dimora di
quell'uomo creato ad immagine e somiglianza di dio. Ma anche con il dualismo qualitativo: dopo la
caduta, l'uomo vive nel peccato, dilaniato, per così dire, dal divenire, corrotto insomma, mentre il
cielo continua ad essere puro, eterno, immutabile. E tuttavia difficilmente la Chiesa (o le varie
chiese cristiane) sarebbero riusciti ad imporre una tale visione se questa non si fosse presentata
assolutamente valida dal punto di vista dei nostri sensi. L'uomo nota che sono gli astri a muoversi e
non la terra sui cui poggia i piedi. Oggi, dopo la rivoluzione astronomica del Cinquecento e del
Seicento e le conquiste spaziali, a nessuno verrebbe in mente di difendere tale sistema. Ma allora e
almeno fino alla scoperta del telescopio i partigiani del sistema eliocentrico (cioè con il sole al
centro e la terra e tutti gli altri pianeti in movimento più o meno circolare attorno all'astro) venivano
considerati dei visionari se non, come purtroppo troppo spesso è accaduto, degli eretici e come tali
perseguitati.
Sempre nei libri di Fisica, Aristotele si occupa anche dei concetti di spazio e di tempo. A dire il
vero, il filosofo non parla mai di spazio bensì di luogo, definendolo come “limite del corpo
contenente”. Che significa? Prendiamo un qualsiasi oggetto. Ebbene, il luogo è lo spazio interno
delimitato dai suoi contorni. Dunque, per Aristotele lo spazio è sempre connesso ai corpi che lo
occupano, anche se questo può essere occupato da corpi diversi, per esempio da liquidi differenti
contenuti nel bicchiere. Non ha dunque senso chiedersi in quale luogo si situi l'universo, perché non
esiste un corpo più ampio che lo contenga. Di conseguenza, dove non ci sono corpi non c'è
nemmeno lo spazio: il vuoto non esiste. Ma allora come spiegare il movimento? Come è possibile
che un corpo si sposti da un luogo all'altro se vive in un “tutto pieno”? Il moto – risponde Aristotele
– si spiega con la tensione degli elementi a raggiungere la loro condizione propria. In uno spazio
vuoto come quello di Democrito, per esempio, del tutto indeterminato, non ci sarebbe nessun ordine
naturale, nessun alto e basso assoluti, nessun punto di riferimento: non ci sarebbe modo di spiegare
perché un oggetto sta fermo in un luogo piuttosto che in un altro o perché si muove proprio (e
sempre) in una certa direzione. Nell'universo “pieno” di Aristotele, invece, tutto è assolutamente
limitato, nel mondo sublunare come in quello sopralunare.
Per quanto concerne il tempo, Aristotele lo definisce come la misura del movimento secondo il
prima e il poi. Di conseguenza, il tempo non è affatto assoluto, come d'altro canto lo spazio, poiché
è relativo ai corpi che vi si muovono: senza il movimento, il tempo non sussisterebbe. Ancora una
volta in senso comune interviene a sostenere (e in qualche modo determinare) le teorie scientifiche
dello stagirita: come l'uomo della strada vede il sole girare intorno alla Terra e non il contrario, così
conta il tempo a partire dal movimento del sole stesso o attraverso lo scorrere (il movimento) della
sabbia in una clessidra o delle lancette in un orologio. E tuttavia la definizione afferma che il tempo
è “misurante” e non “misurato”. Se il moto fosse la misura del tempo, sarebbe un aspetto del tempo,
così come le misure di un tavolo sono uno degli aspetti del tavolo. E le misure di una cosa,
ovviamente, non esistono indipendentemente dalla cosa a cui ineriscono. Ma per Aristotele ciò che
esiste in modo indipendente è proprio il moto, non il tempo, di conseguenza il moto è misurato e il
tempo è la sua misura, o, meglio ancora, il tempo è uno dei modi di cui noi possiamo misurare il
moto e cioè quello che prende in considerazione il prima e il poi. Facciamo un esempio: se io dico
che un treno che giunge a Milano da Roma ha compiuto circa 650 chilometri, questa sarà la misura
del suo moto secondo la distanza (lo spazio). Se invece dico che ha impiegato 5 ore, allora ho
misurato il suo movimento secondo il prima e il poi: alle ore 10 era a Milano, alle ore 15 a Roma. Si
potrebbe anche dire che il tempo è una successione di attimi e in quanto tale riproducibile
graficamente, come una successione di “punti-attimo”. Non è quello che fa Aristotele, ma è
innegabile che la sua visione del tempo rappresenti una rivoluzione in un mondo, come quello
greco, ancorato ai miti della circolarità, dell'eterno ritorno. La successione di punti attimo – come
vedremo qualitativamente differenti gli uni dagli altri – è un altro elemento che le religioni
monoteiste accettano. Se il mondo tende verso dio, allora ogni istante sarà in qualche modo
migliore di quello che l'ha proceduto. Ma anche in questo caso non è solamente la religione a
determinare il successo di una simile concezione, ma tutta la cultura. L'idea di progresso, su cui la
nostra civiltà (occidentale) si è fondata e, seppure con qualche pericolosa incrinatura, continua a
fondarsi, è tipicamente aristotelica, poiché “tende” verso qualcosa di migliore, di perfetto. Dunque,
questo mondo è in qualche modo “perfettibile”.
La Psicologia
Con il termine “natura”, Aristotele intende soprattutto gli esseri viventi. È vero che chiunque abbia
in sé il principio del movimento, compresa la quiete che, per definizione, risiede nel proprio luogo
naturale, è in quanto tale vivente e tuttavia quelli dotati di movimento, per così dire, lo sono di più.
Infatti, gli esseri viventi propriamente detti possiedono anche il loro fine, inteso come culmine dello
sviluppo organico. In poche parole, anche nella filosofia di Aristotele si parla di anima, di ciò che
dà vita ai corpi, e lo studio dell'anima, in greco psyche, è propria della Psicologia, che è una branca
della Fisica. Il rapporto tra anima e corpo è il medesimo che lega forma e materia. L'anima, infatti, è
la forma di cui il corpo è materia, mentre l'essere vivente è la sostanza (o sinolo) che risulta dalla
loro composizione. Insomma, l'anima è l'atto (o entelèchia, dal greco en, che significa “in”, tèlos,
“fine”, e èchein, “avere”: letteralmente “avere un fine dentro”) di un corpo organico che ha la vita
in potenza. Siamo di fronte ad una concezione profondamente diversa da quella di Platone. Per il
filosofo ateniese, infatti, l'anima, come risulta dal fatto che è immortale, è qualcosa di differente dal
corpo che la contiene, mentre per lo stagirita questa potrà vivere sempre e solo con il corpo di cui è
la forma, poiché la forma è sempre inseparabile dalla sua materia. Dunque – con una sola eccezione
che si vedrà in seguito – l'anima non è affatto immortale e tanto meno risulterà disponibile per
la reincarnazione, cioè non potrà mai diventare forma di un altro corpo. L'anima rappresenta la
vita e di conseguenza chi ne è sprovvisto non rientra nella categoria degli esseri viventi.
L'anima ha tre funzioni: quella vegetativa (riproduzione e nutrimento), che è comune a tutti gli
esseri viventi, quella sensitiva, presente in tutti gli esseri animali, e quella razionale, presente
solamente negli uomini. Alle ultime due funzioni sono associati, rispettivamente, la conoscenza
sensibile e la conoscenza intellettiva. Gli organi di senso sono infatti in grado di riconoscere negli
oggetti le forme ad essi adeguate (per esempio gli occhi i colori, l'udito i suoni e l'olfatto gli odori),
dunque sono potenzialmente in grado di riceverle. Le forme sensibili a loro volta sono conoscibili
in potenza: le forme sono infatti sempre presenti nella materia e possono essere riconosciute solo
quando il senso le estrae da essa. La conoscenza sensibile si genera quando ciò che è conoscente in
potenza (l'organo di senso) è ciò che è conoscibile in potenza divengono, rispettivamente,
conoscente e conosciuto in atto. Questo avviene mediante un contatto tra l'organo di senso e la cosa
percepita, vuoi diretto (come il tatto) vuoi attraverso un mezzo materiale (le cose si vedono
attraverso il mezzo dell'aria). Dunque, organo di senso e forma sensibile, pur essendo cose distinte,
durante il processo cognitivo concorrono a realizzare il medesimo atto. L'immaginazione
(phantasia) è il punto di collegamento tra il senso e l'intelletto. L'intelletto può pensare solo
attraverso immagini. E qui il discorso si complica. Esistono anche in questo caso delle forme
intellegibili (laddove prima esistevano solamente forme sensibili) ed esiste un intelletto potenziale
(laddove prima si parlava solamente di sensi): un intelletto capace, almeno in potenza, di accogliere
tutte quelle forme. L'intelletto potenziale e le forme intellegibili sono, rispettivamente, conoscente e
conoscibile in potenza. La conoscenza si sviluppa quando questa doppia potenzialità si trasforma in
atto. Ma in questo caso la simmetria si rompe, poiché Aristotele introduce (a complicare il tutto) un
secondo intelletto, l'intelletto attivo (o anche intelletto produttivo), che ha il compito di condurre il
processo proprio dalla potenza all'atto. Questa ulteriore differenziazione darà vita ad una ampia
discussione che a tutt'oggi si può dire non ancora conclusa. L'intelletto attivo viene paragonato da
Aristotele alla luce che trasforma i colori in potenza in colori in atto, rendendoli in tal modo visibili.
Questa immagine ricorda molto da vicino l'idea del Bene di Platone, che dà conoscibilità e vita alle
cose. L'elemento platonico viene tuttavia inserito nel più ampio discorso sugli universali (le forme
intellegibili): la conoscenza umana è sempre un processo induttivo, che passa attraverso
l'immaginazione. Ma il problema permane: solo qualcosa che è già in atto, infatti, può realizzare un
passaggio dalla potenza all'atto. Ecco perché a bisogno di un intelletto attivo: all'idea che vuole la
conoscenza delle forme intellegibili passare attraverso l'intelletto potenziale con un procedimento
che parte dal basso (induttivo) si oppone dunque l'idea secondo cui la vera causa di questa
conoscenza è un intelletto separato, che non ha alcun contatto con la materia. Facciamo un
esempio. Se vedo il rosso, la mia sensazione si sviluppa immediatamente, anche se è la prima volta
che vedo quel colore. Se il mio intelletto conosce invece una forma intellegibile, come quando dico
“questa cosa è un gatto”, allora devo già in qualche modo possedere nel mio cervello la nozione di
che cosa si quella forma (la forma universale intellegibile del gatto), altrimenti la conoscenza non
può prodursi. Platone era giunto a proporre la dottrina della reminiscenza proprio per spiegare come
sia possibile riconoscere gli universali nel sensibile. Aristotele, naturalmente, non può accettare
questa tesi e tuttavia sostiene i presupposti che l'hanno generata: la conoscenza sensibile è passiva e
per questo ha bisogno solo di due termini: la forma sensibile e l'organo che la riceve. Ma la
conoscenza intellettiva è attiva e come tale ha bisogno di altro: di una forma intellegibile, presente
nelle cose, di una funzione intellettuale passiva che la riceve, cioè l'intelletto passivo, e di una
funzione intellettuale attiva che produce il riconoscimento della forma medesima, l'intelletto attivo.
Ma anche in questo caso le cose non sono così semplici. Infatti Aristotele definisce l'intelletto attivo
come immortale ed eterno. Se si trattasse di una funzione dell'anima umana, allora saremmo
autorizzati a pensare che un parte del nostro animo non morirà mai. E tuttavia così si
contravverrebbe la regola aristotelica secondo cui la forma è sempre inseparabile dal corpo di cui è
forma. Un ulteriore problema è dato dal fatto che Aristotele sostiene che l'intelletto attivo pensa
sempre, non ad intermittenza per così dire, ed è difficile capire come un tale comportamento si
adatti all'essere umano. È per questo motivo che non pochi pensatori hanno interpretato l'intelletto
attivo come un ente divino, unico e identico in tutti gli uomini, i quali conoscono le forme
intellegibili per suo tramite. Ancora una volta la religione, dunque, non solo cristiana, ma anche
ebraica e musulmana (civiltà in cui il pensiero greco non viene mai censurato, ma, anzi, coltivato).
E tuttavia – come si è detto - la questione è ancora oggi aperta.
Gli esseri viventi
Le opere dedicate agli esseri viventi rappresentano il grosso degli studi fisici. Aristotele è un vero
biologo, anzi il primo biologo nel senso moderno del termine, che osserva, indaga, ordina,
classifica. Peccato che allo stagirita – come a tutta la scienza del tempo – manchi l'ausilio di una
tecnica efficiente, di una strumentazione adeguata.
Mentre Teofrasto si occupa del mondo vegetale, Aristotele si dedica a quello animale. Anche il
mondo degli esseri viventi è composto dai quattro elementi, che esistono in natura sia allo stato
puro sia sotto forma di composti. E tra le varie forme di composti c'è anche quella in cui gli
elementi si fondono compiutamente dando origine ad una nuova sostanza. Si tratta degli omeomeri
(parti uguali), poiché quando vengono divisi tutte le loro parti conservano caratteristiche uguali a
quelle dell'insieme di partenza. Prendiamo un bicchiere e versiamoci dentro una eguale quantità di
acqua e di vino. Se divido in due il contenuto del bicchiere non mi ritrovo con un mezzo bicchiere
di acqua e un mezzo bicchiere di vino, ma con due mezzi bicchieri contenenti una miscela di acqua
e di vino. Negli esseri viventi le parti omeomere sono dette tessuti (ad esempio il legno delle piante
o la carne degli animali) e dall'unione di diversi tessuti si generano gli organi (foglie, polmoni,
muscoli). Dunque il vivente è composto sia di parti non omeomere sia di parti omeomere: il fegato è
parte dell'organismo ma non è parte omeomera rispetto all'intero mentre una parte del fegato è
omeomera rispetto al suo intero più prossimo. Si viene in tal modo a creare una scala naturale di
tutti i viventi ordinata secondo gradi di perfezione dal più semplice al più complesso, in base alla
quantità e alla qualità di organi e funzioni che ciascun vivente possiede. Agli ultimi posti di questa
scala troviamo insetti e molluschi, mentre al vertice mammiferi come cani e cavalli; in cima,
naturalmente, l'essere umano. Questo finalismo spiega il rapporto che sussiste tra gli organi e le
loro funzioni: la natura dell'organo si spiega con la sua funzione e non viceversa. Alla tesi di
Anassagora secondo cui l'uomo è il più sapiente dei viventi perché possiede le mani, Aristotele
replica che è vero l'esatto contrario. Poiché l'uomo è un essere intelligente, ha bisogno delle mani
come strumento per le sue attività ed è esattamente per questo motivo che le possiede. Per lo stesso
motivo si oppone ad Empedocle, secondo cui c'è un tempo in cui le cose si producono in modo del
tutto disordinato e un tempo in cui si genera l'ordine. Per Aristotele, invece, la natura possiede un
ordine intrinseco, come appare dal fatto che gli esseri eventi si producono sempre o quasi sempre
allo stesso modo: da un embrione fecondato si genera un individuo del tutto simile ai suoi genitori.
Le malformazioni per Aristotele sono solamente eccezioni.
Un altro principio della biologia aristotelica è la scoperta della analogia nei vari viventi tra gli
organi e le rispettive funzioni, una sorta di embrionale anatomia comparata. Egli si è accorto, per
esempio, che le branchie dei pesci svolgono la medesima funzione dei polmoni dei mammiferi. Se
avesse con coerenza proseguito su questa linea, Aristotele sarebbe giunto, con parecchi secoli di
anticipo, a sostenere la teoria evoluzionistica. Perché non lo fa? Perché rimane sempre fedele ad una
delle sue tesi più importanti, quella che vuole la natura di qualunque essere vivente sempre
determinata dalla sua forma: il fine di ogni creatura vivente è sempre quello di realizzare la forma
nel modo più perfetto possibile. Da un uovo di una gallina nascerà sempre una gallina, da un
embrione di una scimmia sempre una scimmia. Insomma, gli esseri viventi furono, sono e saranno
sempre i medesimi. La forma non si modifica mai né si sviluppa: lungi dal pervenire ad una teoria
evoluzionistica, Aristotele sostiene con forza la fissità delle specie.
LA FILOSOFIA PRIMA
In un celebre passo del VI libro della Metafisica Aristotele scrive che se esiste qualcosa di eterno,
immobile e separato, allora lo studio di questo oggetto non potrà spettare alla fisica (che si occupa
di sostanze mobili) bensì ad una altra scienza, la Filosofia Prima. Di conseguenza, la Fisica si
trasformerebbe in Filosofia Seconda. E tuttavia questo oggetto esiste davvero e il filosofo se ne
rendo conto proprio studiando il mondo fisico, il quale richiede sempre una causa che tuttavia non è
affatto fisica. Come abbiamo visto, per la Fisica esistono tre generi di sostanze: sostanze materiali
corruttibili (il mondo sublunare) e sostanze materiali incorruttibili (i corpi celesti). E tuttavia,
proprio per le ragioni di cui sopra, Aristotele è costretto ad ammettere l'esistenza di sostanze
immateriali incorruttibili. Ma come facciamo a sostenere che esistono sostanze che non
percepiamo con i nostri sensi? Per rispondere a questa domanda occorre partire ancora una volta dal
moto. Il moto è eterno, non ha cioè né un inizio né una fine. Si tratta di una necessita concettuale.
Come spiega molto chiaramente nella Fisica, un inizio ed una fine di un moto sono moto anch'esse:
se fermo il moto di una palla con la mano, questo atto è a sua volta un movimento, nello specifico
della mia mano. Per cui possono avere un inizio ed una fine i moti particolari, ma il moto generale è
eterno. Di conseguenza, tutto il cosmo fisico è eterno. E il moto dipende a sua volta da una
sostanza che si muove. Perciò, se il moto è eterno deve esistere una sostanza che si muove
eternamente. Questa sostanza esiste, come abbiamo visto, è l'etere. I corpi terrestri possono
alternativamente essere mossi o restare fermi, a seconda che la loro potenzialità si realizzino o no. I
corpi celesti, al contrario, realizzano costantemente, senza interrompersi mai, l'unica potenzialità di
cui dispongono, ossia quella di muoversi localmente di moto circolare uniforme. Potrebbe dunque
sembrare che i cieli siano la causa sufficiente per spiegare l'eternità del moto: in questo caso la
ricerca delle cause del movimento si concluderebbe nella Fisica. Ma non è così. E tuttavia il
movimento dei cieli è sempre un passaggio dalla potenza all'atto e la considerazione che la loro
potenza si traduce sempre in atto non esclude che ciò, in un dato momento, possa accadere: non c'è
nessuna necessità che una potenza si traduca in atto. Ma l'eternità del moto è sempre necessaria, per
cui la possibilità che il moto si fermi deve essere esclusa in modo assoluto. Per tale motivo
Aristotele ritiene che l'unica causa sufficiente per spiegare l'eternità del moto sia una sostanza che è
solo atto (atto puro), la quale è totalmente priva di materia e di potenza e dunque assolutamente
immutabile: il primo motore immobile. A differenza dei cieli, il motore immobile è
necessariamente eterno ed è dunque l'unica causa sufficiente per spiegare la necessaria eternità del
moto. Il motore immobile è causa finale. “Egli muove – scrive Aristotele – come essendo amato”.
Che cosa significa? Partiamo dal principio che il motore immobile è la sostanza fra tutte più
perfetta. Tutti gli altri enti, di conseguenza, si muovono verso di lui, tentano di imitare, nei limiti del
possibile, l'immobilità del principio. Meglio ci riescono i cieli, il cui moto circolare uniforme è il
più prossimo alla immobilità. Dunque il motore immobile è la causa finale diretta del primo cielo, il
più esterno, e causa finale indiretta di tutti gli altri gradi di realtà. Questo modo di essere causa
sembra l'unico compatibile con il fatto che il motore immobile non può muovere attivamente per
contatto, non avendo infatti materia alcuna. Ma poiché il motore immobile è atto, anzi atto puro,
deve avere una certa attività. E tuttavia, poiché l'unica attività che si può esercitare senza materia è
pensare, ne consegue che il primo motore è essenzialmente pensiero. Ma di che cosa? Essendo un
ente perfetto, non potrà ma rivolgere il proprio pensiero ad altro da sé: se pensasse alle cose
inferiori, penserebbe a ciò che è indegno di lui, di cui non ha affatto bisogno. Dunque, il motore
immobile è pensiero di pensiero. Oltre a ciò, il motore è anche vita perfettamente felice, insomma
si tratta di un dio e questo spiega i numerosi tentavi di conciliare la filosofia prima aristotelica con
le tre grandi religioni monoteiste. E tuttavia le religioni lo considerano soprattutto come causa
efficiente: se dio è causa finale, infatti, risulta oggetto passivo di amore e di imitazione da parte di
altri enti, ma non è soggetto di alcun sentimento e di alcuna attività. Un dio causa efficiente, al
contrario, è un dio che si dà da fare per mettere in moto il mondo, che ha interesse per questo
mondo. E tuttavia di questo presunto amore nei confronti del mondo, quanto meno nei testi
aristotelici che ci sono pervenuti, non c'è alcuna traccia.
Ma lo studio del motore immobile, che, in quanto scienza di dio si configura come Teologia, non
esaurisce la Filosofia Prima. Anzi, il grosso dei libri di Metafisica ha per oggetto lo studio
dell'essere, cioè della cosa più generale di tutti. E in effetti Aristotele definisce la Filosofia Prima
come “scienza dell'essere in quanto essere” (cioè ontologia). Ma di che cosa si occupa
effettivamente tale scienza? Soffermiamoci sull'affermazione precedente e soprattutto
sull'espressione “in quanto”. Se invece dell'essere in quanto essere parliamo dell'essere in quanto
animato, la scienza che lo studia sarà la Fisica, anzi la zoologia. “In quanto animato” significa
operare una netta cesura nella realtà, separando gli enti animati da quelli che non lo sono. Ma allora
che genere di taglio effettua Aristotele quando parla di “essere in quanto essere”? Due sono i
possibili ambiti di ricerca: 1) quello delle caratteristiche che appartengono agli enti per il solo fatto
di esistere e che dunque sono comuni a tutte le cose; 2) quello delle caratteristiche che possono
appartenere solo all'essere genericamente preso. Determinazioni come l'uno e il molteplice o
l'identico e il diverso sono comuni a tutte le cose, perché di ogni cosa si può dire che è una,
molteplice, identica e diversa, mentre “animale” o “uomo” si predicano solo di alcuni enti. Dunque,
tali determinazioni appartengono all'essere in quanto essere. Quanto al secondo caso, Aristotele
allude in primo luogo alle categorie. La categoria di quantità, per esempio, non riguarda tutto
l'essere (perché esistono anche sostanza, qualità eccetera) ma è una determinazione dell'essere
interamente preso e non di uno o più enti particolari. È infatti proprio dell'essere e non di un altro
soggetto essere originariamente diviso secondo le categorie. Questi, dunque, sono gli ambiti di
ricerca della Filosofia Prima che studia “l'essere in quanto essere”. E tuttavia rimane un problema,
che riguarda la possibilità stessa di questa scienza. Se l'essere non è un genere, pare impossibile
parlarne in modo univoco e dunque non potrà essere studiato da una sola scienza. La scienza che
studia l'animale “cane”, ad esempio, è una scienza unica perché il concetto di cane si applica a tutti i
cani con lo stesso significato. Non ci sarà invece una scienza unica per studiare il cane come
animale e il cane come costellazione, poiché “cane” ha qui due differenti significati, nel primo caso
la scienza relativa sarà la zoologia nel secondo l'astronomia. Riguardo all'essere sembra che valga lo
stesso principio. Anzi, Aristotele dice che non solo l'essere ma anche le altre nozioni generali si
dicono in vari modi, secondo le diverse categorie: il significato di “uno”, per esempio, cambia a
seconda che il termine sia riferito alla sostanza o alla qualità.
Aristotele risolve il problema spiegando che il temine “essere”, pur avendo diversi significati, non è
però solamente equivoco (come cane in quanto animale e cane in quanto costellazione), perché tutti
i vari modi in cui si dice hanno un legame che li tiene assieme. Questo legame è la sostanza, dalla
quale tutti gli altri in varia misura dipendono. Aristotele stesso ci aiuta con un esempio. Prendiamo
il termine “sano”. Noi diciamo sano un uomo che è in salute, ma anche un cibo. È dunque evidente
che “sano” ha due diversi significati. Ma entrambi i significati si riferiscono alla salute (il cibo sano
serve alla salute dell'uomo). Perciò, pur rimanendo vero che “sano” non è un genere unico, è anche
vero che spetterà ad una scienza unica, quella che studia la salute, stabilire quando un uomo e un
cibo sono sani. Allo stesso modo ci sarà una sola scienza che studia l'essere e sarà appunto la
scienza che studia la sostanza. Insomma, la Filosofia Prima è studio della sostanza e il primo
problema è quello di definire precisamente il temine in questione: che cosa può essere detto
sostanza in senso primario? Da scartare subito, ovviamente, la materia, perché qualità essenziale
della sostanza è la determinatezza, mentre la materia ne è totalmente sprovvista. Non rimane che la
forma. E tuttavia tale scelta sembra smentire una delle tesi delle categorie, dove la sostanza prima
era il singolo individuo, composto di materia e forma. Ma la contraddizione non è così grave come
sembra. Se i termini da scegliere sono l'individuo (per esempio Socrate) e l'universale (uomo) è
chiaro che la preferenza deve essere accordata all'individuo. Infatti l'affermazione secondo cui
l'universale è sostanza è caratteristica dei platonici e nella Metafisica Aristotele, per marcare bene la
distanza, la respinge con decisione (mentre nello studio delle Categorie aveva ammesso che fosse
sostanza seconda). Se invece si tratta di stabilire che cosa fa sì che l'individuo sia una sostanza,
allora il primato deve essere dato alla forma. È infatti la forma, che coincide con l'essenza di
ciascuna cosa, ciò che fa sì che quella cosa sia precisamente quella che è. Dunque, la sostanza in
senso primario è la forma. È chiaro però che tale forma sarà inerente a ogni singolo individuo e
perciò sarà cosa diversa dall'universale. Non a caso Aristotele si serve spesso dell'esempio
dell'anima: è l'anima, ossia l'anima propria di ciascuno, la forma di un individuo e non un universale
come “uomo” o “animale”.
Alla base di questa trattazione c'è un problema filosofico di primaria importanza. Aristotele, a
differenza di Platone, ritiene che l'essere vero sia l'individuo. E tuttavia continua a ritenere, con
Platone, che si ha conoscenza solo dell'universale. Pare dunque che ciò che Aristotele identifica
come l'essere in senso primario sia anche non conoscibile. Ma questo non è accettabile dallo
stagirita, che intende rimarcare le differenze con il maestro. Aristotele è dunque costretto a cercare
una via mediana, quella in cui l'individuo diventi conoscibile, partecipando in qualche modo
all'universale, senza tuttavia rompere la gerarchia secondo cui la sostanza è l'individuo e non
l'universale. Questa via mediana è data, appunto, dalla forma. La forma di ciascun individuo è in
parte caratteristica di quell'individuo e in parte è comune a tutti gli individui della stessa specie.
Sarà dunque possibile conoscere un individuo sulla base delle caratteristiche universali inerenti alla
sua forma: ad esempio, sapendo che la forma di Socrate è un'anima parzialmente identica a quella di
Platone, allorché vengo a conoscere che cos'è l'anima conoscerò, in qualche modo, anche Socrate e
pure Platone. Insomma, la conoscenza dell'universale porta a conoscere come è fatta la realtà in cui
viviamo e non un mondo diverso e superiore come l'iperuranio. I caratteri universali, a differenza di
quanto sosteneva Platone, sono attributi di questa realtà e non esistono di per sé. Ma per stabilire
questo era necessario dimostrare che l'universale non è sostanza.
L'ETICA E LA POLITICA
L'etica
Anche per Aristotele come per gran parte del pensiero greco classico etica e politica sono
strettamente connessi: l'etica è in un certo qual modo una parte del più ampio complesso della
politica, perché l'uomo realizza compiutamente se stesso, il suo fine, anche quelle etico, solamente
all'interno di una comunità. Non è un caso, allora, che la celebre affermazione che “l'uomo è un
animale politico” si ritrovi sia nella Politica sia nell'Etica Nicomachea.
Il Bene è l'idea guida di tutto il discorso etico-politico di Aristotele: qualunque azione deve
necessariamente tendere al bene. Dunque si tratterà in primo luogo di dare una definizione di bene,
quanto meno di quello umano. Poiché spesso certi beni sono desiderati solo come mezzo per
procurarsene degli altri, il bene umano in senso assoluto e generale sarà un bene fine a se stesso, che
si desidera in quanto tale. Lo scopo principale dell'etica, dunque, sarà quello di stabilire quale è
questo bene.
Ma prima occorre fare una premessa metodologica: la scienza etica non può procedere nel modo
rigoroso delle matematiche, ma deve accontentarsi di una certezza più debole. Potrebbe sembrare
una premessa inutile, perché in realtà Aristotele non usa il metodo deduttivo in nessun caso,
nemmeno in fisica, preferendo in sua vece la dialettica. In realtà egli vuole qui sottolineare il fatto
che l'etica soffre di una debolezza tutta sua: mentre gli enti naturali hanno comportamenti quasi
sempre uniformi e regolari, lo stesso non si può dire degli uomini, che possono decidere
spontaneamente come comportarsi. Se dunque anche l'etica è una scienza (e su questo Aristotele
non ha dubbi), essa non solo userà come tutte le altre scienze il metodo dialettico, ma anche il rigore
dimostrativo di questo metodo sarà comparativamente ridotto.
Siamo più o meno tutti d'accordo oggi nel definire cosa sia il bene umano: vita buona o felicità.
Ebbene, entrambi questi termini traducono il greco eudaimonìa, anche se il primo, vita buona,
sembra leggermente più appropriato. Infatti per Aristotele la felicità non è un sentimento interiore di
contentezza, magari temporaneo, ma un modo costante di agire e di vivere. E la vita buona in che
cosa consiste concretamente? Per Platone tutto ruotava intorno al significato di bene in sé, cioè
dell'idea iperuranica di bene. Una volta colto il significato, questo diveniva il metro di giudizio per
le cose terrene, per promuovere il bene umano appunto. Ma Aristotele scarta questa possibilità. A
suo parere, infatti, non esiste la nozione di un unico bene valido in tutti i casi, perché il bene si dice
(esattamente come l'essere) in tutti i modi in cui si dicono le categorie: per esempio, Dio è un bene
nell'ordine della sostanza, mentre la virtù lo è nell'ordine delle qualità. Si tratta naturalmente di due
significati di “bene” differenti. Anche in questo caso lo stagirita critica duramente Platone: la sua
idea di “bene assoluto”, oltre ad essere assolutamente irreale, è anche infeconda, non accresce cioè
la conoscenza dell'uomo circa il concetto di bene. Occorre dunque rimaner con i piedi ben piantati a
terra, partire cioè dalle cose che gli uomini considerano buone e poi selezionare quel bene che è fine
a se stesso più di tutti gli altri. Applicando rigidamente il metodo dialettico, Aristotele fa avanzare la
sua ricerca esaminando alcuni èndoxa riguardo la vita buona: c'è chi pone il fine della sua vita nel
piacere, chi nell'onore, chi nella conoscenza. Per stabilire chi ha ragione occorre capire meglio quali
di questi fini rispetti di più la natura umana. Ora, poiché la natura dell'uomo è la sua razionalità, la
vita migliore sarà quella di chi esercita la ragione, la quale a sua volta deve essere esercitata
secondo virtù (aretè). Siamo di fronte ad una vita di pura ricerca, dunque, ad una vita
contemplativa. Ma se il fine di ogni uomo è quello di raggiungere la felicità, ne consegue che la
vita contemplativa è anche quella che porta il massimo grado di felicità.
E tuttavia l'etica si presenta necessariamente anche sotto forma di azioni: esiste cioè una vita attiva
e non solo puramente contemplativa. Eccoci allora alla prima suddivisione, quella tra virtù
dianoetiche e virtù etiche. Dianoetico deriva da diànoia, che significa pensiero e la massima virtù
dianoetica è, appunto, la vita contemplativa. Ma le virtù etiche? Naturalmente anche queste avranno
a che fare con la razionalità, in quanto essenza dell'essere umano. Ma come stabilire quale è il
comportamento eccellente? Qui Aristotele suggerisce un metodo piuttosto sbarazzino e tuttavia
anche piuttosto efficace: il giusto mezzo. Ogni virtù etica è il punto medio tra due estremi, che,
presi isolatamente, risultano pessimi. Per esempio, tra la temerarietà e la codardia, entrambi deleteri,
la via di mezzo è rappresentata dal coraggio. Accanto al coraggio troveremo poi la gentilezza, la
cortesia, la modestia eccetera, i quali si configurano tutti come “termini medi” tra due estremi.
Per quanto concerne invece le virtù dianoetiche, posto che la base, la condizione necessaria è
rappresentata dalla vita contemplativa, questa si può esplicitare in vari modi. Nell'arte, per esempio,
nella saggezza (phrònesis) e nella sapienza (sophia). La differenza tra gli ultimi due modi, che
rappresentano il meglio delle virtù, è di fondamentale importanza per capire l'etica aristotelica. Da
un punto di vista molto generale, sapienza e saggezza rappresentano rispettivamente il sapere
teorico e il sapere pratico. La sapienza, infatti, coincide con la pura attività di ricerca che costituisce
il modo più elevato (e quindi virtuoso) di esercitare la ragione. La saggezza, invece, è una forma di
intelligenza che regola i comportamenti pratici soprattutto in relazione con le virtù etiche. La
saggezza non stabilisce i fini dell'azione morale, bensì i mezzi: essa è “la capacità di deliberare bene
in rapporto alla felicità”, stabilisce cioè il modo corretto in cui compiere le azioni in vista di una
finalità giù data (la felicità). Saggio è infatti colui che si deve prendere a modello quando si tratta di
decidere, caso per caso, in che cosa consiste il giusto mezzo. Dunque, la saggezza è un sapere
sempre orientato all'azione e dunque si dispiega soprattutto in rapporto alle virtù etiche. Ma per
Aristotele anche l'esercizio della teoria è, rigorosamente parlando, un'azione e dunque anche la
sapienza avrà bisogno della saggezza. È la saggezza, infatti, che permette di deliberare circa il modo
in cui la sapienza può essere conseguita. Ecco perché Aristotele afferma che “in un senso la
sapienza è superiore alla saggezza, ma in un altro senso vale l'inverso”. La sapienza è superiore
perché costituisce l'obiettivo più alto che l'uomo può realizzare e dunque è il fine di tutta la vita
etica. La saggezza è superiore, viceversa, nel senso che senza di essa la sapienza non potrebbe
essere realizzata. Si tratta – continua il filosofo – dello stesso rapporto che intercorre tra medicina e
salute: la salute è superiore alla medicina perché è il fine di questa scienza, ma al tempo stesso ne
dipende, perché senza la medicina la salute non potrebbe essere conseguita. Riassumendo, la
sapienza dà origine alla vita contemplativa, mentre la saggezza alla vita attiva.
La politica
“L'uomo è un animale politico”: questa è una delle più note affermazioni di Aristotele, che dà il
senso a tutta l'opera. La forma più piccola di comunità politica è l'òikos. Generalmente tale termine
viene tradotto con “famiglia”, sebbene vi corrisponda solo in parte. Più precisamente, si tratta di una
azienda agricola famigliare, in cui vivevano normalmente i cittadini di buona nascita e possidenti,
composta non solo da genitori e figli, dunque, ma anche da schiavi domestici, servi rurali e animali
da lavoro. Anche qui l'intento polemico nei confronti di Platone è evidente. Il filosofo di Atene,
infatti, aveva costruito il suo stato ideale proprio sulla base dello smantellamento della struttura
dell'òikos, quanto meno per quanto riguarda le classi superiori. Aristotele, invece, pone tale
istituzione alla base dello Stato: la famiglia – sebbene nella forma allargata – è una vera e propria
esigenza per l'uomo, un fatto naturale. E, sempre parlando della famiglia, Aristotele attacca un altro
pilastro della politica platonica, il cosiddetto femminismo. Nella famiglia l'unico soggetto provvisto
di tutti i diritti, infatti, è il maschio adulto e libero, nel suo triplice ruolo di marito, padre e padrone.
La superiorità nei confronti dei figli maschi è che questi ultimi non hanno ancora sviluppato in
modo completo la loro ragione. Le donne, invece, hanno sì diritto alla libertà pari a quella dei
maschi ma non possiedono affatto l'attitudine al comando. Di conseguenza, in famiglia obbediranno
ciecamente al marito e non potranno partecipare alla vita pubblica. Infine gli schiavi: quasi come
fossero degli eterni bambini, questi uomini non saranno mai in grado, per difetto naturale, di
scegliere da sé i propri fini. La schiavitù, dunque, si configura come una condizione necessario al
loro stato di esseri inferiori.
Per Aristotele l'unico modo naturale per produrre ricchezza è l'agricoltura. Poiché però – come
aveva messo in luce già Platone – in una società complessa si creano eccedenza di beni e
specializzazione dei compiti, saranno anche necessari il commercio e il denaro come unità di misura
degli scambi. Aristotele approva tuttavia solo quelle forme di economia terziaria che possono essere
utili all'ottimale distribuzione dei beni, biasimando invece le attività finalizzate al solo accumulo
della ricchezza: il denaro è mezzo ed è del tutto innaturale considerarlo come un fine a sé stante. La
diffidenza (se non addirittura l'ostilità) verso una libera economia di mercato avvicina il pensiero di
Aristotele a quello di Platone. E tuttavia le ragioni non sono economiche né politiche, ma
filosofiche ed etiche. Entrambi, infatti, ritengono che la vita davvero buona e degna di essere vissuta
non passa attraverso l'accumulazione di beni materiali.
Lo Stato che Aristotele continua sempre a identificare con la pòlis nonostante la sua fine e il trionfo
dell'impero macedone, si sviluppa dall'unione di più famiglie in villaggi e dalla successiva unione di
più villaggi. Riguardo alle forme di costituzione, Aristotele da un lato prende le distanze dal Platone
della Repubblica, avvicinandosi invece a quello del Politico e delle Leggi, opere sicuramente pià
realistiche. Abbiamo sei tipologie di governo, distinte secondo il numero dei governanti e articolate
in coppie a seconda che tali governanti agiscano a beneficio della comunità o proprio. Nell'ordine si
tratta di: monarchia e tirannia, aristocrazia e oligarchia, politèia e democrazia. La migliore di
queste è la pòliteia, cioè la forma “buona” di democrazia, quella cioè in cui i governanti agiscono a
beneficio della comunità. Ma le cose stanno realmente così? È Aristotele un fautore della
democrazia (un altra differenza, radicale, con Platone?). Formalmente parlando nella politèia
possono accedere a turno alle cariche pubbliche tutti i cittadini maschi, liberi e maggiorenni; la
condizione per esercitare la politica è la capacità di comandare e di obbedire. Nella pratica però,
Aristotele ammette che abbiano più titolo a governare coloro che godono di una posizione sociale
più elevata e di migliori qualità intellettuali. Infatti l'esercizio della vita pubblica è un modo per
realizzare la virtù ed è chiaro che possono raggiungere meglio questo fine coloro che sono più dotati
sia materialmente sia spiritualmente. Questa disparità, inoltre, è conforme al principio della
giustizia distributiva, secondo il quale chi “vale” di più è giusto che abbia di più. Infine non non a
tutti gli uomini deve essere concessa la facoltà di accedere alle cariche pubbliche, ma solo a quelli
che non devono preoccuparsi delle necessità giornaliere. Insomma, si tratta di un mix tra
democrazia ed aristocrazia, anzi, per restare fedeli alla visione etica di Aristotele, ad una via di
mezzo tra le due opzioni. D'altro canto, il governo della pòliteia è nelle mani dei “migliori”, che in
greco si traduce con àristoi. E i filosofi? Quale è il ruolo di questa classe che Platone aveva messo
al vertice del suo stato ideale? Quando verrà il loro turno governeranno lo Stato, risponde
Aristotele. Insomma, nessun privilegio: un conto è il politico un altro è il filosofo.
Ma la caratteristica che più di ogni altra convince Aristotele della validità della pòliteia risiede nella
sua stabilità. A differenza delle altre due forme “buone” di governo, aristocrazia e monarchia,
infatti, è la meno soggetta a mutamenti traumatici, alla rivoluzione. E la rivoluzione trova terreno
fertile nelle diseguaglianze, nella polarizzazione sociale, cioè in quei sistemi dove a fronte di una
minoranza di ricchi si staglia una maggioranza di disperati. Ebbene, la pòliteia ha il merito di
presentare un sistema sociale sostanzialmente omogeneo: né troppo ricchi né troppo poveri. Ancora
una volta una posizione mediana, dunque, la sola in grado di evitare pesanti rotture rivoluzionarie. A
tal proposito Aristotele è molto chiaro: “tutti accetteremmo che fosse uno solo a governare se egli
avesse più virtù di tutti gli altri messi insieme: sarebbe il miglior governo, ma è puramente. astratto.
Nella politeia , per quanto la maggior parte delle persone abbia virtù mediocri, tutto sommato
mettendole insieme qualcosa si ottiene: messi insieme non saranno gran ché, ma insieme
riusciranno a far funzionare il governo”. Chiarite le caratteristiche della pòliteia, perché, allora, la
sua degenerazione sia chiama “democrazia”? La democrazia, secondo Aristotele, è speculare alla
tirannide: se lì domina l'interesse di un singolo monarca, qui quello di una singola classe sociale,
quella dei poveri. Insomma, oggi la si potrebbe definire, più propriamente, “demagogia”.
POETICA E RETORICA
Tra le scienze produttive e poietiche rientrano sia la poetica sia la retorica, poiché hanno entrambe
lo scopo di produrre un determinato oggetto: si tratta di composizioni poetiche e di discorsi
persuasivi.
Aristotele considera la poesia come imitazione della natura e come tale applica il modello biologico
e finalistico desunto dalla realtà naturale. Le forme poetiche si sviluppano come le forme naturali
verso la massima perfezione consentita al loro genere. In questo senso Aristotele considera come
esemplare la tragedia attica del V secolo, in particolare Sofocle ed Euripide, in quanto punto più
alto di una lenta evoluzione. L'idea di riservare un'opera apposita alla poetica obbedisce al bel noto
principio aristotelico secondo cui gli ambiti della realtà sono differenti per natura e dunque
necessitano di trattazioni specifiche. Anche qui è nettamente percepibile la differenza con Platone,
che aveva fortemente limitato l'autonomia delle espressioni poetiche, mettendole al servizio
dell'etica e della politica. Ben inteso, Aristotele non intende la poetica come totalmente
indipendente e separata dalla filosofia. Egli infatti si preoccupa soprattutto di mettere in luce il ruolo
ausiliario che la poesia tragica ed epica può svolgere nella comprensione razionale della realtà. La
natura di questo ruolo può essere capita mediante il confronto con la storia. La storia, secondo
Aristotele, è meno filosofica della poesia, in quanto si limita a narrare fatti contingenti e particolari.
La poesia, al contrario, si colloca dal punto di vista dell'universale ed è proprio questo aspetto ciò
che la rende feconda sul piano conoscitivo. Ma in che senso la poesia ha un rapporto con
l'universale? Nella poesia tragica ed epica sono messi in scena personaggi provvisti di un
determinato carattere, che danno origine a sequenze di azioni corrispondenti. Ora, sia il carattere sia
le azioni manifestano strutture paradigmatiche e in un certo senso ripetibili. Achille, per esempio, è
il tipo ideale del guerriero forte, orgoglioso e irascibile, mentre l'azione in cui è coinvolto è
indicativa di come possono svolgersi in generale i fatti in tutti i casi analoghi. Perciò, sempre
ammesso che il poeta abbia correttamente imitato la natura, Aristotele può ritenere a ragione che lo
studio della poesia aiuti a comprendere meglio la condizione umana. Ma la poesia è importante
anche sul piano etico. Aristotele afferma infatti che spettatori e lettori di opere epiche e tragiche
possono conseguire una sorta di “purificazione”, in greco catarsi, mediante i sentimenti di pietà e di
paura che il testo poetico suscita in loro. La catarsi ha l'effetto di trasformare la pietà e la paura in
qualcosa di diverso da ciò che si prova quando ci si identifica con i personaggi. Subentra, in altre
parole, un certo distacco, per mezzo del quale il lettore-spettatore sospende il suo coinvolgimento
emotivo e giunge a valutare razionalmente le azioni che vede, così da potere evitare, nel caso che
gli si presenti una situazione analoga, di compiere gli stessi errori.
Aristotele stabilisce anche delle regole per la poetica, le regole delle tre unità: di tempo, di luogo e
di azione. L'azione di un'opera (drammatica) deve svolgersi nel medesimo luogo, avere una durata
non superiore a quella di un giorno solare e dipanare il filo in una singola e compatta vicenda. La
tragedia greca rispetta sicuramente le due prime unità, ma soprattutto per l'arretratezza delle
tecniche di allestimento. Per quanto concerne l'unità di azione, invece, non si può dire che sia stata
sempre rispettata. Basti pensare ad alcune tragedie di Euripide, nelle quali sarebbero presenti
episodi collaterali non bene integrati nella trama principale. E comunque le tre regole aristoteliche
si applicano, secondo Aristotele, solo alla tragedia greca e non costituiscono norme universalmente
valide. La lotta contro queste regole, condotta con forza nel corso del secolo XIX, ha aperto le porte
al Romanticismo moderno.
La retorica è un'arte che ha sempre attratto Aristotele, sin da giovanissimo, quando lavorava come
dialettico nell'Accademia. La retorica e la dialettica hanno in sostanza lo stesso fine, quello di
individuare argomenti persuasivi su qualche tema. Mentre Platone aveva in un certo senso
incorporato la retorica nella dialettica, Aristotele ritiene necessario tenere distinte le due discipline.
Per il maestro ateniese, infatti, l'oggetto della conoscenza filosofica esisteva in una dimensione
separata da quella sensibile ed è dunque necessario persuadersi e persuadere gli altri che tali oggetti
esistano davvero. Per il discepolo di Stagira, invece, questa separazione non esiste per cui è
possibile distinguere tra una dialettica che persuade in modo dimostrativo, avvicinandosi nel
contempo alla scoperta della verità, e la retorica, che invece ha proprio e solo lo scopo di
persuadere. Insomma – come scrive l'autore – la retorica è lo specchio della dialettica, più o meno
come il risvolto di un vestito: essa si serve di strumenti analoghi, ma più deboli, nella misura in cui
il suo fine è meno ambizioso. Al sillogismo dialettico corrisponde l'entinema, all'induzione
l'esempio. L'entinema è un sillogismo in cui una o più premesse vengono lasciate implicite con lo
scopo di ottenere una migliore efficacia persuasiva. È facile persuadere un uditorio composto da un
pubblico generico accostando in modo intuitivo alcune proposizioni, mentre la disamina dell'intero
procedimento argomentativo susciterebbe problemi che in quel contesto non possono essere risolti.
L'esempio, invece, si differenzia dall'induzione perché prende in esame non molti casi, ma solo uno
e cerca di suscitare la persuasione mediante la particolare evidenza o forza emotiva del caso che si è
scelto di presentare. Aristotele distingue la retorica in tre grandi generi: deliberativo (in politica),
giudiziario (nei processi) ed epidittico (negli encomi).