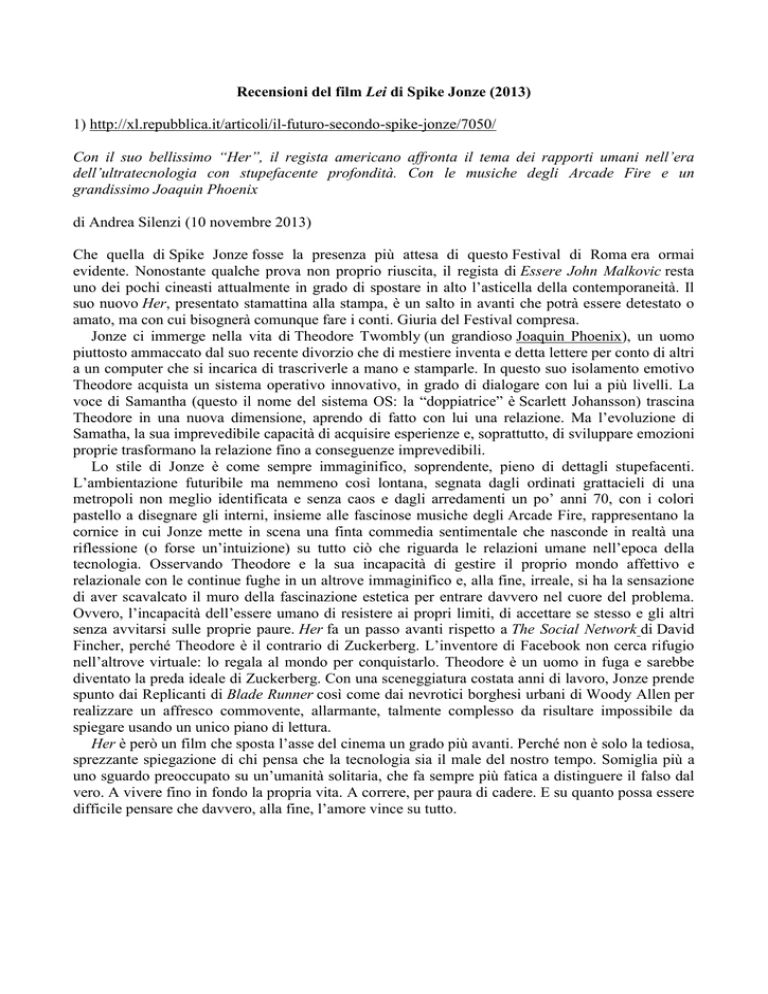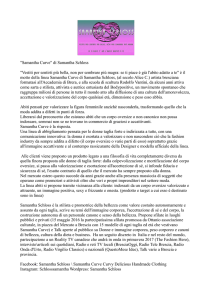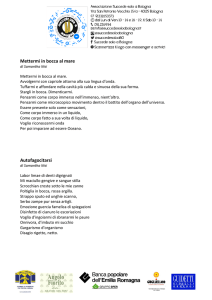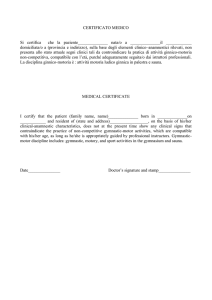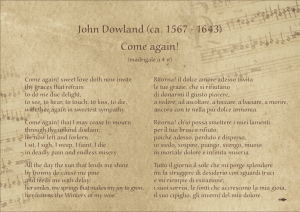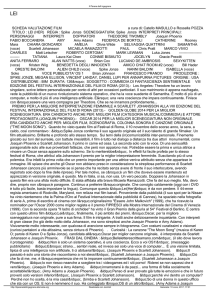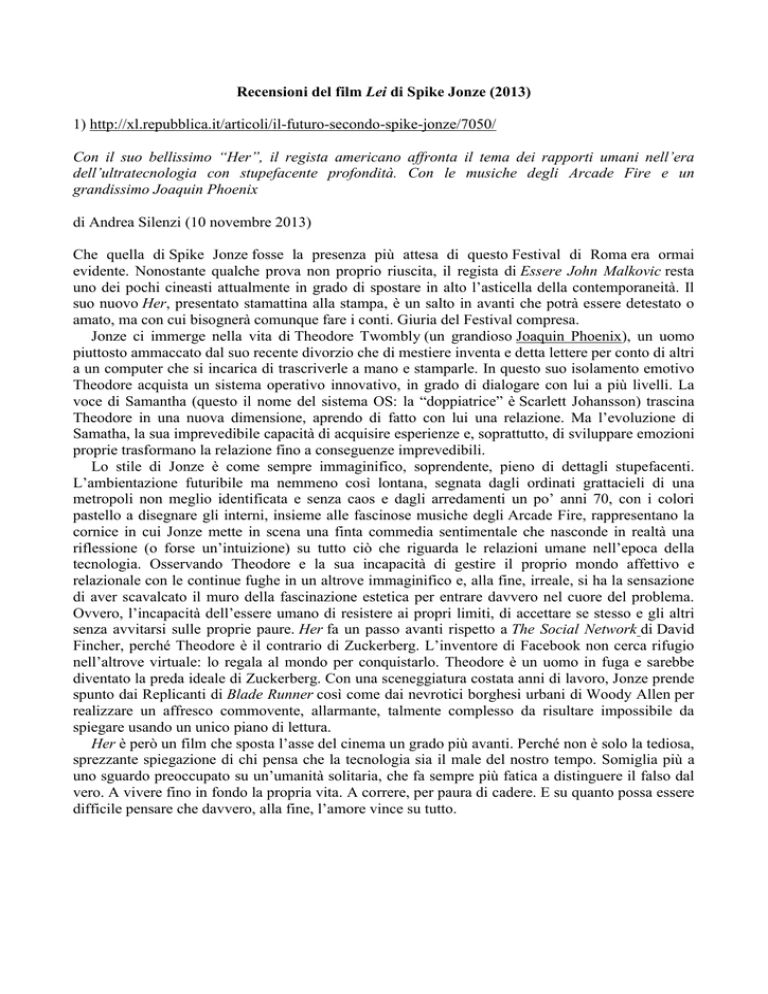
Recensioni del film Lei di Spike Jonze (2013)
1) http://xl.repubblica.it/articoli/il-futuro-secondo-spike-jonze/7050/
Con il suo bellissimo “Her”, il regista americano affronta il tema dei rapporti umani nell’era
dell’ultratecnologia con stupefacente profondità. Con le musiche degli Arcade Fire e un
grandissimo Joaquin Phoenix
di Andrea Silenzi (10 novembre 2013)
Che quella di Spike Jonze fosse la presenza più attesa di questo Festival di Roma era ormai
evidente. Nonostante qualche prova non proprio riuscita, il regista di Essere John Malkovic resta
uno dei pochi cineasti attualmente in grado di spostare in alto l’asticella della contemporaneità. Il
suo nuovo Her, presentato stamattina alla stampa, è un salto in avanti che potrà essere detestato o
amato, ma con cui bisognerà comunque fare i conti. Giuria del Festival compresa.
Jonze ci immerge nella vita di Theodore Twombly (un grandioso Joaquin Phoenix), un uomo
piuttosto ammaccato dal suo recente divorzio che di mestiere inventa e detta lettere per conto di altri
a un computer che si incarica di trascriverle a mano e stamparle. In questo suo isolamento emotivo
Theodore acquista un sistema operativo innovativo, in grado di dialogare con lui a più livelli. La
voce di Samantha (questo il nome del sistema OS: la “doppiatrice” è Scarlett Johansson) trascina
Theodore in una nuova dimensione, aprendo di fatto con lui una relazione. Ma l’evoluzione di
Samatha, la sua imprevedibile capacità di acquisire esperienze e, soprattutto, di sviluppare emozioni
proprie trasformano la relazione fino a conseguenze imprevedibili.
Lo stile di Jonze è come sempre immaginifico, soprendente, pieno di dettagli stupefacenti.
L’ambientazione futuribile ma nemmeno così lontana, segnata dagli ordinati grattacieli di una
metropoli non meglio identificata e senza caos e dagli arredamenti un po’ anni 70, con i colori
pastello a disegnare gli interni, insieme alle fascinose musiche degli Arcade Fire, rappresentano la
cornice in cui Jonze mette in scena una finta commedia sentimentale che nasconde in realtà una
riflessione (o forse un’intuizione) su tutto ciò che riguarda le relazioni umane nell’epoca della
tecnologia. Osservando Theodore e la sua incapacità di gestire il proprio mondo affettivo e
relazionale con le continue fughe in un altrove immaginifico e, alla fine, irreale, si ha la sensazione
di aver scavalcato il muro della fascinazione estetica per entrare davvero nel cuore del problema.
Ovvero, l’incapacità dell’essere umano di resistere ai propri limiti, di accettare se stesso e gli altri
senza avvitarsi sulle proprie paure. Her fa un passo avanti rispetto a The Social Network di David
Fincher, perché Theodore è il contrario di Zuckerberg. L’inventore di Facebook non cerca rifugio
nell’altrove virtuale: lo regala al mondo per conquistarlo. Theodore è un uomo in fuga e sarebbe
diventato la preda ideale di Zuckerberg. Con una sceneggiatura costata anni di lavoro, Jonze prende
spunto dai Replicanti di Blade Runner così come dai nevrotici borghesi urbani di Woody Allen per
realizzare un affresco commovente, allarmante, talmente complesso da risultare impossibile da
spiegare usando un unico piano di lettura.
Her è però un film che sposta l’asse del cinema un grado più avanti. Perché non è solo la tediosa,
sprezzante spiegazione di chi pensa che la tecnologia sia il male del nostro tempo. Somiglia più a
uno sguardo preoccupato su un’umanità solitaria, che fa sempre più fatica a distinguere il falso dal
vero. A vivere fino in fondo la propria vita. A correre, per paura di cadere. E su quanto possa essere
difficile pensare che davvero, alla fine, l’amore vince su tutto.
2) http://cineforum.it/Reviews/view/Vivere_in_un_limbo
“Vivere in un limbo”, di Gloria Zerbinati
Sei piena di tutte le ombre che mi spiano. (Pablo Neruda)
Quando ci si ferisce o si prende una botta molto forte, tra l’urto e la fitta acuta passano alcuni istanti
in cui il dolore non è ancora lancinante, ma sordo, trattenuto, quasi distante e, per un momento, si
crede di averla scampata. Pensavo peggio, ci si dice, restando immobili per paura che anche un
gesto lieve rompa il precario equilibrio. Ma poi il male arriva e porta con sé l’attesa che il sangue si
coaguli, che il gonfiore si attenui e l’ematoma pian piano svanisca.
Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) vive in una specie di bolla che Spike Jonze gli mette a
disposizione facendolo abitare in una città dai colori pastello e dalla luce gentile,che mescola Los
Angeles a Shanghai, in cui la musica ha qualcosa di ovattato e i contorni dei volti e delle cose sono
pressoché sfumati.
Anche il lavoro rispecchia questo suo vivere protetto da una specie di membrana. Theodore
infatti si mantiene scrivendo lettere per conto terzi: lettere piene di amore e passione, di gratitudine
e amicizia. Chi vuole omaggiare la propria sposa, chi ringraziare i genitori per il loro affetto o
l’amico per essergli sempre stato vicino. E Theodore è bravissimo con le parole, osserva le foto dei
destinatari, ne coglie i dettagli, ha pensieri profondi e delicati per ognuno, è attento e sensibile,
quasi li conoscesse davvero.
Ma le parole sono ingannevoli. Theodore infatti è solo: si sta separando dalla moglie Catherine
(Rooney Mara), la donna che ha amato e con cui è cresciuto, ma non è ancora stato in grado di
elaborare il lutto per questa perdita, tanto da non volerlo nemmeno riconoscere a se stesso; ha una
sola amica, Amy (Amy Adams), con la quale talvolta si confida e che non è, però, sufficiente a
riempirgli le giornate e a dargli sollievo. L’apparente risveglio sembra essergli donato dall’incontro
col sistema operativo Samantha (Scarlett Johansson), un’intelligenza artificiale in grado di evolversi
e svilupparsi sulla base degli stimoli che riceve.
Amarissimo ritratto di un futuro prossimo, fintamente confortevole e sereno, in cui la solitudine,
benché scelta e non imposta, è forse l’esempio più chiaro di dismissione dalla vita, Her svela come,
in fondo, il desiderio latente di ognuno, quando deve affrontare un dolore, sia il ritorno al torpore
del ventre materno.
Suggerito già all’inizio del film – con Theodore che osserva le immagini di una ragazza incinta,
nuda e provocante, e poi ne usa il ricordo la sera stessa mentre si masturba grazie a un servizio di
telefonia erotica - e reiterato nella sequenza in cui Amy mostra il video a cui sta lavorando e che ha
per protagonista la madre che dorme (oppure nel ricordo dell’ex moglie con in braccio un neonato),
il tema del cercare riparo nel ventre materno, ospitale e protettivo, si svela nel momento in cui entra
in scena Samantha, dotata di sola voce, che si palesa pian piano come un porto sicuro a cui
approdare.
Samantha è accogliente e dolce, curiosa e docile, ma soprattutto non è mai invadente. Theodore,
quando vuole, può spegnerla, interrompere la comunicazione, e tornare a parlare con lei solo
quando lo desidera. Nel frattempo Samantha gli sistema le mail, gli ricorda gli appuntamenti, lo
consola quando è giù di corda e lo fa ridere mentre si trovano nei momenti di leggerezza. Si lascia
forgiare da lui (è programmata apposta), mutando a seconda degli stimoli e restituendogli la sua
opinione sempre con molta discrezione. Fa anche l’amore con lui, quando Theodore ne ha voglia.
Insomma è una madre, un’amante, un’amica, una segretaria, un’allieva.
Ma non è l’Altro. È una proiezione di Theodore in via di evoluzione. E come proiezione non ha
corpo. Non è dotata dell’ingombro della carne, la sua presenza non fa pressione. È una presenzaassenza, di cui Theodore si innamora.
I problemi si manifestano quando Samantha comincia a prendere iniziative e a progredire a tal
punto da non voler più essere “solo” un sistema operativo a servizio dell’uomo: ormai prova
sentimenti, ha un proprio punto di vista e soprattutto desidera affrancarsi dalla volontà altrui. Solo
in quel momento Theodore si ritrova a dover affrontare il suo vero Altro, ossia Catherine, al
confronto con la quale era sempre sfuggito.
Catherine, anche quando non è con lui, è una presenza (non una presenza-assenza come
Samantha) e non solo perché lo incalza, ponendolo in una condizione di ansia, ma per il suo corpo,
che vive anche nei ricordi dell’uomo (che, non a caso, gli procurano dolore): lo sguardo e il sorriso,
gli occhi e la bocca, le mani e la sua figura magra e elegante, i capelli sottili e le espressioni buffe.
Tutto quello che Samantha non potrà mai avere o essere, evitando dunque, già in partenza, una serie
di complicazioni a Theodore.
È interessante notare come a pochi mesi dall’inizio dell’anno, i due migliori film usciti in
sala rappresentino, benché in maniera diversa, lo stesso soggetto, ossia la fuga dal Reale. Uno
è Her, l’altro The Wolf of Wall Street.
Nel film di Scorsese la presenza fantasmatica del denaro, l’assenza delle vittime-clienti (di cui si
ascolta solo la voce al telefono), i corpi di Jordan Belford e dei colleghi usati come involucri o
stampelle per mettere in scena la performance, con ovvie ricadute compulsive (il sesso, la droga),
sono una dimostrazione della gigantesca truffa virtuale del capitalismo (che ha ovviamente
ripercussioni reali ma che, come per gli spettacoli di illusionismo, funziona solo grazie alla
sospensione dell’incredulità, e quindi grazie alla totale immersione nell’Immaginario, in cui
il Reale stesso è collassato). Nella pellicola di Jonze l’assenza del corpo, sostituito da una voce
accogliente e remissiva, proiezione dei desideri del protagonista, determina la scomparsa dell’Altro,
ossia di ciò che “fa problema”.
In entrambi i casi si tratta di stare in un limbo, tentando di procrastinare l’arrivo del dolore, che
squarcerebbe l’illusione di essere in salvo, riportando tutti alla realtà.
______________________________________
3) http://cineforum.it/Reviews/view/Un_abisso_impersonale
“Un abisso impersonale”, di Giampiero Frasca
In un film che pare tradurre la solitudine di un individuo innamoratosi del suo sistema operativo
dalla voce flautata esclusivamente attraverso piani ravvicinati fissi e insaturi, incollati sul volto del
personaggio senza mai rimandare a un controcampo pressoché impossibile, perché ancorato in una
dimensione solo sonora, Spike Jonze si premura di significare la progressiva deriva del protagonista
attraverso modalità alternative che investono sfere differenti, alcune tecniche, altre allegoriche, altre
ancora di attinenza cromatica.
Queste ultime, ad esempio. Jonze agisce sulla mimesis. La solitudine di Theodore (Joaquin
Phoenix) è immersione totale in una dimensione indistinta e illusoria all'interno di un'unicità che
non gli appartiene (come sarà dimostrato inequivocabilmente mostrando il flusso continuo e
inarrestabile di una moltitudine anonima intenta a comunicare animatamente con il proprio sistema
operativo palmare).
Theodore, nella sua inconsapevolezza, è solo uno degli oltre ottomila centri d'irradiazione
possibili, uno tra i tanti su cui la macchina da presa sceglie di concentrarsi, alla ricerca di
un exemplum nelle trame del quotidiano. Theodore è più che semplicemente solo: è letteralmente
contestualizzato. Fa parte della scenografia, non si staglia nettamente da essa, ma è concretamente
imbibito nello spazio. In questa prospettiva, Lei non è una storia di solitudine tamponata dalla realtà
virtuale e poi colmata in un aurorale finale con l'amica di una vita, ma un autentico scavo all'interno
di un abisso impersonale nel quale si smarriscono profili, estremità e relazioni definite.
Jonze concentra l'attenzione dell'inquadratura su Theodore, inglobandolo contemporaneamente
in dominanti cromatiche che ne annullano il supposto protagonismo. L'incontro stesso con il
sistema operativo in via d'installazione, prima ancora che si palesi come la suadente Samantha, è
evidenziato con una diagonale vermiglia che connette Theodore, lo schermo del computer e la
lampada sulla scrivania, in una continuità che lega insieme organico e inorganico, vivente e
inanimato.
L'emarginazione virtuale di Theodore è invece restituita con un verde acido che incorpora,
intrappola e sfuma in una foschia dai margini indefiniti e sovrapposti.
Anche la felicità è ingannevole: ha il ritmo di un folle ballo di gioia nei corridoi della
metropolitana che conducono al mare, ma la camicia a quadri di Theodore è motivo in rilievo che
pareti e pavimenti replicano, alterando profondità e proporzioni, abbagliando attraverso un trompel'oeil di beatitudine.
Perfino un colore vivace come il giallo della camicia è schiacciato verso lo sfondo dal pannello
di plexiglas dello stesso colore che compare alle spalle del personaggio e ne smorza il contorno,
congiungendolo all'ambiente.
E infine, anche l'atto volitivo finale di recarsi alla porta dell'amica Amy per condividere l'alba
nascente e forse un nuovo rapporto insieme è mortificato dall'opacità di tinte sbiadite che rendono
Theodore parte integrante della mestizia del corridoio che sta percorrendo, obbligando lo spettatore,
malgrado la di poco posteriore inquadratura sul tetto, a chiedersi: «è un vero happy end?».
______________________________________
4) http://cineforum.it/Reviews/view/La_forza_delle_parole
“La forza delle parole”, di Leonardo Gandini
Più di un secolo fa, in un testo del 1903 dedicato alla condizione dell’uomo metropolitano, il
sociologo tedesco Georg Simmel scriveva:
“Il riserbo e l’indifferenza reciproci non sono mai avvertiti più fortemente nei loro effetti
sull’indipendenza dell’individuo che nella più densa confusione della metropoli, dove la vicinanza e
l’angustia dei corpi rendono più sensibile la distanza psichica. Ed è solo l’altra faccia di questa libertà
il fatto che a volte non ci si senta da nessuna parte così soli e abbandonati come nel brulichio della
metropoli.”
Di questo parla Her: la solitudine dell’uomo metropolitano. I grattacieli come sbarre di una
gabbia dentro alla quale troviamo un individuo che, nei centodieci anni che separano il testo di
Simmel dal film di Jonze, non pare avere cambiato molto la propria condizione. Continua ad essere
vittima dello strano paradosso che vede da una parte moltiplicarsi il numero delle persone con cui
condivide lo spazio urbano e dall’altra assottigliarsi la possibilità di avere rapporti sociali importanti
e profondi.
Naturalmente qualcosa nel frattempo è cambiato: il pandemonio tecnologico-informatico degli
ultimi vent’anni ha rivoltato le nostre quotidianità come un calzino, consegnandoci ad un destino
avvitato su forme mediate e indirette di socialità. Ed è proprio questo orizzonte a fare di Her forse
non uno dei film migliori dell’anno, ma sicuramente uno dei più cruciali, per come affronta
direttamente questioni dalle quali è ormai difficile o impossibile chiamarsi fuori.
Lo fa con una delicatezza sorprendente, scevra del moralismo strisciante che in passato
caratterizzava i film nei quali un essere umano si innamorava di una creatura virtuale. Le parabole
sull’alienazione dell’individuo nella società moderna non possono più permettersi i toni saccenti del
racconto morale, perché quella condizione è, oggi, comune a tutti.
A rigor di genere, Her dovrebbe essere un film di fantascienza, ma nessuno lo prende come tale,
perché la tecnologia di cui è preda il protagonista è solo un millimetro più in là rispetto a quello che
abbiamo già a nostra disposizione. Più che distopica, una fantascienza lungimirante, che sa guardare
dietro l’angolo. Provando, nell’impossibilità di tornare indietro, a suggerire che esiste un antidoto:
la forza delle parole.
Dalle struggenti lettere per procura che scrive il protagonista alla dialettica effervescente su cui
poggia il fascino della sua ragazza virtuale, Jonze si chiede se – in un mondo dove la geografia dei
sentimenti viene trascritta a suon di foto, video e selfies – a fare la differenza non possano essere le
parole. La loro capacità di innescare traiettorie emotive che sfuggono all’immediatezza
dell’immagine per rifugiarsi in zone d’ombra dove a contare sono le esitazioni di una voce, il suono
di un aggettivo, la fragilità di un verbo. Come tarli, le parole possono corrodere la certezza delle
immagini e ricondurre gli uomini all’altezza delle loro intermittenze emotive.
No, il mondo non verrà salvato dalle parole. Però, ci dice Her, può uscirne notevolmente
addolcito.