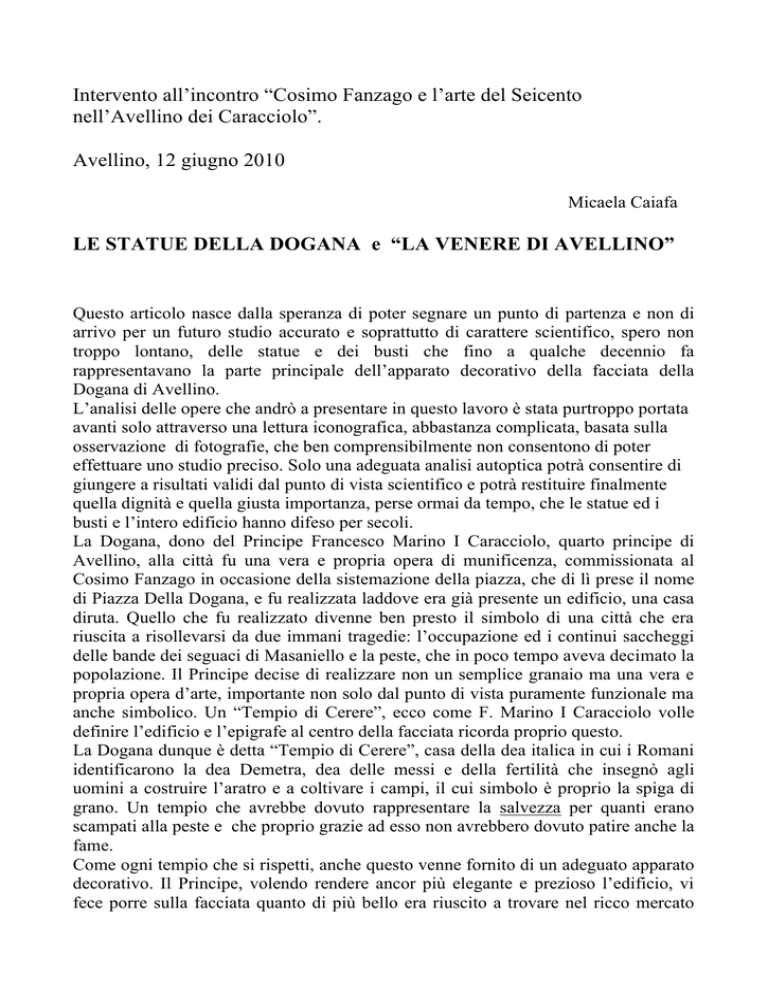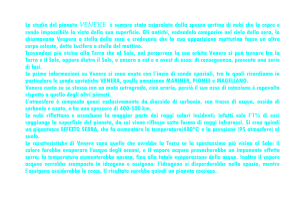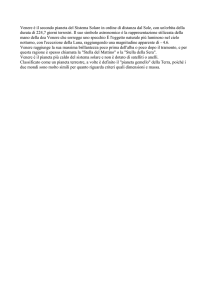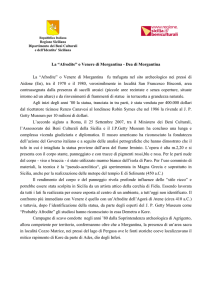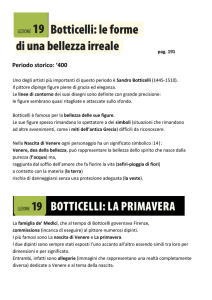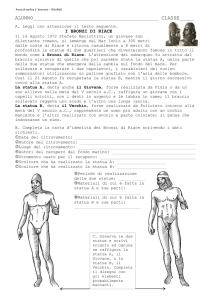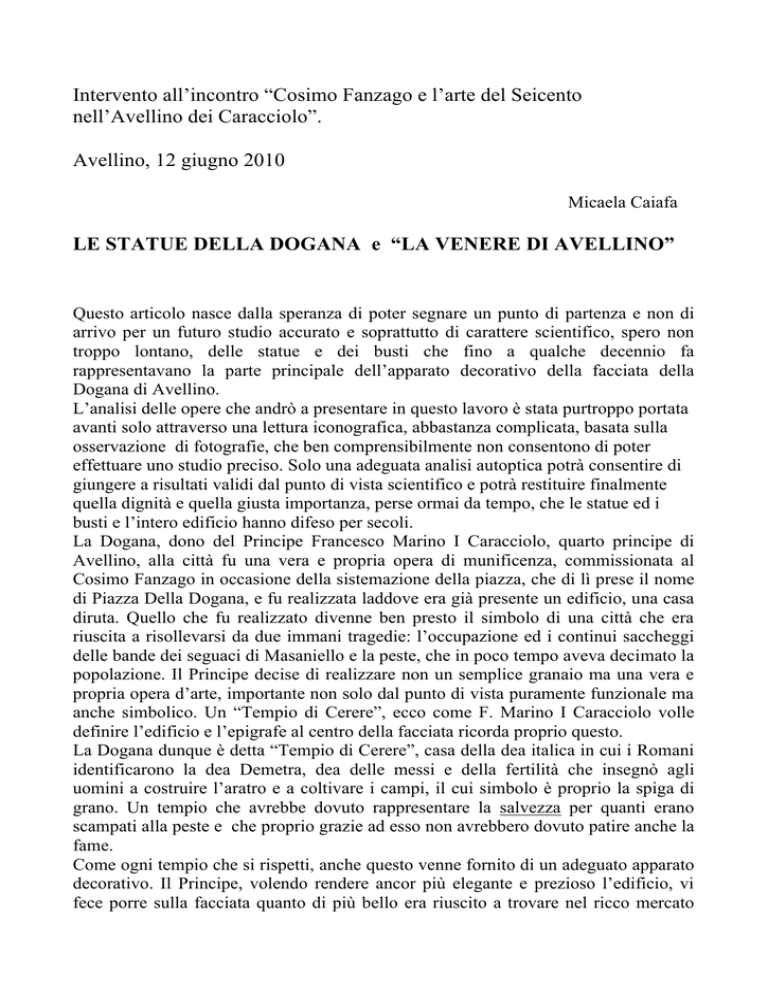
Intervento all’incontro “Cosimo Fanzago e l’arte del Seicento
nell’Avellino dei Caracciolo”.
Avellino, 12 giugno 2010
Micaela Caiafa
LE STATUE DELLA DOGANA e “LA VENERE DI AVELLINO”
Questo articolo nasce dalla speranza di poter segnare un punto di partenza e non di
arrivo per un futuro studio accurato e soprattutto di carattere scientifico, spero non
troppo lontano, delle statue e dei busti che fino a qualche decennio fa
rappresentavano la parte principale dell’apparato decorativo della facciata della
Dogana di Avellino.
L’analisi delle opere che andrò a presentare in questo lavoro è stata purtroppo portata
avanti solo attraverso una lettura iconografica, abbastanza complicata, basata sulla
osservazione di fotografie, che ben comprensibilmente non consentono di poter
effettuare uno studio preciso. Solo una adeguata analisi autoptica potrà consentire di
giungere a risultati validi dal punto di vista scientifico e potrà restituire finalmente
quella dignità e quella giusta importanza, perse ormai da tempo, che le statue ed i
busti e l’intero edificio hanno difeso per secoli.
La Dogana, dono del Principe Francesco Marino I Caracciolo, quarto principe di
Avellino, alla città fu una vera e propria opera di munificenza, commissionata al
Cosimo Fanzago in occasione della sistemazione della piazza, che di lì prese il nome
di Piazza Della Dogana, e fu realizzata laddove era già presente un edificio, una casa
diruta. Quello che fu realizzato divenne ben presto il simbolo di una città che era
riuscita a risollevarsi da due immani tragedie: l’occupazione ed i continui saccheggi
delle bande dei seguaci di Masaniello e la peste, che in poco tempo aveva decimato la
popolazione. Il Principe decise di realizzare non un semplice granaio ma una vera e
propria opera d’arte, importante non solo dal punto di vista puramente funzionale ma
anche simbolico. Un “Tempio di Cerere”, ecco come F. Marino I Caracciolo volle
definire l’edificio e l’epigrafe al centro della facciata ricorda proprio questo.
La Dogana dunque è detta “Tempio di Cerere”, casa della dea italica in cui i Romani
identificarono la dea Demetra, dea delle messi e della fertilità che insegnò agli
uomini a costruire l’aratro e a coltivare i campi, il cui simbolo è proprio la spiga di
grano. Un tempio che avrebbe dovuto rappresentare la salvezza per quanti erano
scampati alla peste e che proprio grazie ad esso non avrebbero dovuto patire anche la
fame.
Come ogni tempio che si rispetti, anche questo venne fornito di un adeguato apparato
decorativo. Il Principe, volendo rendere ancor più elegante e prezioso l’edificio, vi
fece porre sulla facciata quanto di più bello era riuscito a trovare nel ricco mercato
antiquario dell’area napoletana e flegrea:sei statue, quattro busti e due grandi leoni
accovacciati, quest’ultimi inseriti nei due angoli inferiori della facciata, in posizione
speculare.
Queste opere erano collocate sulla facciata come se fossero organizzate secondo dei
veri e propri registri decorativi. Sul tetto piano dell’edificio, a mò di acroteri, vi erano
la statua del Pothos e la statua della Niobide; sotto di esse, nella parte superiore della
facciata, in due nicchie vi erano rispettivamente la statua di Venere Anadiomene e la
statua di Marino I Caracciolo, poste in posizione simmetrica l’una all’altra e rispetto
all’epigrafe centrale. Questo stesso spazio è scandito da quattro tondi nei quali erano
collocati i busti di altrettanti uomini illustri di potere dell’antichità, rappresentanti di
una politica illuminata: da sinistra, per chi guarda, Augusto, Adriano, Pericle ed
Antonino Pio.
La parte inferiore della facciata è caratterizzata da cinque ampie arcate di cui quella
centrale costituisce l’ingresso dell’edificio ed è affiancata, nella parte superiore, da
due piedistalli sormontati, ciascuno, da una statua, a sinistra, per chi guarda, quella di
Diana e a destra quella di un giovane, L’Efebo.
Come già detto in precedenza, la mancanza dell’autopsia delle statue rende difficile
qualsiasi tipo di studio su di esse. Qui mi limiterò a portare avanti alcune ipotesi che,
sempre tenendo conto della sola visione fotografica, ritengo, almeno per ora,
sostanzialmente valide.
Le statue del Pothos, della Niobide e della Venere Anadiomene sono molto
probabilmente copie romane di originali greci, mentre quelle di Diana e dell’Efebo,
nonché di Marino I Caracciolo, sono quasi certamente di epoca seicentesca. Per ciò
che concerne i busti quello di Adriano, di Augusto e di Antonino Pio sono ascrivibili
con probabilità all’epoca barocca, mentre quello di Pericle è di datazione incerta o
comunque presenta la base ed il busto forse seicenteschi e la testa probabilmente di
epoca romana ( II sec. d.C.). Infine i grandi leoni, che sorreggono con le zampe
anteriori ciascuno uno stemma, sono stati eseguiti nel ‘600.
Partendo ancora una volta dall’attico analizziamo brevemente le statue, focalizzando
l’attenzione su quella della Venere.
La statua del Pothos, acefala purtroppo, a sinistra per chi guarda, rappresenta la figura
di un giovane in posizione stante, su una base parallelepipeda. Il corpo è
abbandonato, sostenuto dal solo tirso dionisiaco, con le gambe incrociate e la testa
leggermente piegata. È molto probabilmente una copia romana di I-II sec. d.C.
ispirata all’originale modello greco, ben più famoso, il Pothos di Skopas, grande
scultore ed architetto di IV sec. a.C. che ebbe grande influenza sull’arte ellenistica,
inventore dello stile patetico, così chiamato per il pathos (sentimento) espresso dai
volti e dai corpi delle sue opere. Il giovane è la personificazione del desiderio
amoroso inquieto e commosso verso l’oggetto lontano. Appare nel corteo di Afrodite
(Venere), di cui è figlio, accanto ai fratelli Eros e Himeros. Và detto che solo
recentemente si è riconosciuto nella statua il Pothos, dato che in passato si pensava ad
Apollo. In realtà l’equivoco è ricorrente anche da parte di esperti, basti pensare alla
statua di Pothos conservata ai Musei Capitolini restaurata come Apollo Citaredo.
Anche nell’edificio avellinese forse si è verificato tale equivoco: l’intento era
probabilmente quello di porre una statua di Apollo e dunque solo per caso è stata
posta quella del Pothos. Ma non dimentichiamo però il rapporto tra il Pothos e
Venere, qui sottolineato anche dalla corrispondenza spaziale.
Sempre sull’attico vi era la statua di Niobide. La scultura, acefala, rappresenta una
figura femminile in posizione stante, vestita con un lungo chitone che avvolge il
corpo carnoso e ne lascia intravedere il volume. Ispirata ad archetipi del tardo
classicismo greco è databile al I-II sec. d.C. Niobide è, secondo la mitologia greca, la
figlia maggiore di Niobe, regina di Tebe, sposa di Anfione, da cui ebbe sette figli
maschi e sette figlie femmine. Fiera della sua prole osò paragonarsi a Latona,
ritenendosi addirittura superiore ad ella. Ciò scatenò l’ira della titanessa che da Zeus
aveva avuto solo due figli: Apollo ed Artemide (Diana). Furono proprio i suoi figli a
vendicare l’onta subita uccidendo, con le loro frecce, tutti i figli di Niobe, che dopo
l’eccidio decise di lasciare Tebe e di rifugiarsi dal padre sul monte Sipilo dove fu
trasformata in una pietra da Zeus, mosso a pietà. Da allora quella pietra versa lacrime
che alimentano un ruscello che scende nella piana sottostante.
Passiamo ora al registro decorativo superiore della facciata tralasciando per un
momento la statua della Venere.
A destra dell’epigrafe vi è la statua del Principe Marino I Caracciolo, certamente
un’opera del ‘600, attribuita da alcuni allo stesso Cosimo Fanzago per la sua
pregevole fattura e rarità. Rappresenta il Principe come un condottiero; a capo
scoperto, indossa un’armatura finemente lavorata ed impugna con la mano destra, ora
mancante, la grande asta da cavalleria, mentre la sinistra risulta poggiata sul fodero
della spada che manca sia dell’elsa che della parte inferiore. Sulla base a sinistra è
poggiato l’elmo del condottiero. Oltre gli intenti commemorativi qui si vuole esaltare
la figura del grande uomo politico, paragonato non a caso a grandi uomini di potere
dell’antichità. Nel solco proprio di questi predecessori illustri, il Principe
promuoveva la sua figura come quella del “buon uomo di potere “ : è un atto di
autocelebrazione e di propaganda politica. Infatti sempre in questo registro decorativo
vi sono i quattro tondi in cui compaiono busti di uomini del passato che hanno
incarnato l’ideale del “buon governo”. Da sinistra, per chi guarda, nel primo tondo vi
era Augusto, primo imperatore romano, padrone assoluto dello Stato romano dal 31
a.C. al 14 d.C. Il busto è di tipo loricato, cioè armato di lorica, leggera corazza dei
soldati romani,e la testa ritrae l’imperatore in età adulta.
Segue il busto di Adriano, successore di Traiano, imperatore dal 117 al 138 d.C.,
ricordato per la sua grande cultura e per gli sforzi nella risoluzione dei problemi
interni che opprimevano l’impero. Anche qui il busto è loricato ma con gorgoneion
centrale e il mantello rigirato che poggia sulla spalla sinistra.
Il terzo tondo accoglie il busto di Pericle, figura principale della scena politica
ateniese a partire dal 461 a.C.. Come detto prima, qui la testa forse è di II sec. d.C.,
mentre il busto di tipo loricato è del ‘600. Elemento caratterizzante è l’elmo corinzio,
appoggiato sul capo e non indossato completamente, come tipico dell’iconografia del
personaggio, con barba folta e in atteggiamento severo.
Infine il quarto busto è quello di Antonino Pio, anch’esso raffigurato barbato.
Imperatore dal 138 al 161 d.C., nel segno della continuità con Adriano, è ricordato
per il suo impero tranquillo e sereno.
Al registro decorativo inferiore appartengono le statue di Diana e dell’Efebo.
La prima, acefala, raffigura una giovane fanciulla in posizione stante con la gamba
destra leggermente avanzata, il braccio sinistro steso lungo il corpo ed il destro
mancante. Indossa un lungo chitone ed una sopravveste cinta alla vita e che lascia
scoperto un seno e la spalla sinistra. La faretra sul retro è sorretto da una cinghia che
attraversa diagonalmente il busto. È una statua quasi certamente seicentesca;
nell’iconografia classica, infatti, Diana è similmente abbigliata ma non presenta il
seno scoperto, caratteristica questa, invece, dell’iconografia dell’Amazzone.
Diana (Artemide, sorella di Apollo) è la divinità della caccia, che protegge gli uomini
dalle belve e che spesso è identificata come divinità protettrice della fertilità.
L’ultima statua è quella dell’Efebo che presenta diverse problematiche. È abbastanza
evidente, a mio parere, anche solo dalla fotografia che la statua sia priva di una
generale armonia compositiva; sembra che sia stata assemblata con diversi pezzi. La
testa è decisamente sproporzionata rispetto al resto del corpo. Tutta la figura gravita
sulla gamba sinistra, dietro cui si nota un puntello a forma di tronco di cono. È forse
di epoca seicentesca ma davvero è difficile poter affermare qualcosa di più.
Probabilmente è proprio nell’Efebo, giovane che simboleggia la bellezza e la
giovinezza maschile, la forza ed il vigore, che la figura di Apollo, in giovane età è
raffigurato.
La Venere.
Concentriamoci ora sulla statua della Venere che merita un’attenzione particolare.
È vero che la statua non proviene da Avellino ( Pescatori riporta parte di un
documento in cui si sottolinea che la statua apparteneva al Museo Spatafora di Napoli
fino al 1589, poi da qui passò al Duca di Caiavano a Chiaia e nel 1640 fu venduta al
Principe di Avellino) ma la sua presenza sulla facciata della Dogana di Avellino non
è un caso.
Occupa una posizione di rilievo essendo posta simmetricamente a quella di Marino I
Caracciolo ed indicando così un particolare rapporto con essa.
Prima di tutto ritengo necessario partire da una nozione storica importantissima ai fini
della comprensione del perché della presenza di tale statua.
Nel territorio della tribù irpina degli Abellinates fu dedotta la colonia romana di
Abellinum, anche se l’epoca di fondazione non è precisabile con certezza. Diverse
sono le ipotesi. Si potrebbe pensare ad una deduzione graccana: il programma
coloniale di Caio Gracco, a seguito dell’affermazione della legge agraria del 123 a.C.,
Lex Sempronia, prevedeva un’intensa attività di riorganizzazione fondiaria anche nel
territorio irpino, dove molte sono le testimonianze, tra cui tracce di centuriazione
riconosciute da Johannowski nella piana di San Michele di Serino. In tale quadro
storico ben si ascriverebbe a deduzione graccana anche la colonia di Abellinum che
fu denominata “Colonia Veneria Livia Augusta Alexandriana”, titolatura nota da una
tarda iscrizione del 240 d.C.
Il titolo Veneria richiamerebbe l’uso di attribuire alle nuove deduzioni coloniali
graccane o di ispirazione graccana i soprannomi di divinità come Minervia, Neptunia,
Iunonia, etc…, al fine di distinguerle dalle altre.
Ma Veneria, è giusto ricordarlo, andrebbe bene anche per una deduzione sillana, in
quanto Venere era la divinità personale di Silla: basti pensare a Pompei ( con cui
Avellino, tra l’altro, ha uno stretto legame, come sottolinea il Prof. Camodeca) detta
Colonia Cornelia Veneria. Inoltre resta dubbio se la fioritura di Abellinum nella
prima età augustea sia indice di un intervento coloniale augusteo ( l’attributo Livia è
del tutto incerto sia per lettura che per significato). Comunque se si accettano i dati
del Liber Coloniarum bisogna ammettere una deduzione che se non sillana deve certo
cadere tra Cesare ed Augusto. Allo stato attuale della documentazione si potrebbe
preferire l’ipotesi di una fondazione graccana, anche se è opportuno ribadire la
mancanza di elementi per un giudizio definitivo come ricorda Camodeca.
Ci piace pensare che la colonia di Abellinum volle porsi sotto la protezione di Venere
madre, dea non solo della bellezza e dell’amore ma anche della fecondità e delle
fertilità, perché il luogo stesso dove sorgeva aveva un fascino speciale e
rappresentava la ricchezza stessa della natura. Di questo era convinto anche Scipione
Bella Bona, primo grande storiografo di Avellino di metà ‘600, e di questo
certamente era convinto anche il Principe Francesco Marino I Caracciolo quando
decise di far collocare la statua di Venere in posizione preminente. Venere diviene il
simbolo di Avellino. Venere rappresentava la cittadinanza tutta di Avellino, con cui il
Principe instaurò un rapporto tanto importante da essere paragonato a quello
matrimoniale.
La statua della Dogana è acefala,nuda, coperta solo da un panno all’altezza del pube e
priva di entrambe le braccia, copia romana di I-II sec. d.C.. L’iconografia è quella
propria della Venere Anadiomene , dal greco ảναδύοµαι = emergo, sorgo dalle onde,
uno dei tanti appellativi dato alla dea e con allusione alla sua nascita dalle onde del
mare.
L’eccezionalità della nostra statua sta nell’appartenere ad una tipo statuario di cui
abbiamo importanti esempi sparsi nel mondo. Tale rappresentazione iconografica trae
origine da un quadro di Apelle, pittore ufficiale della corte macedone della fine del
IV sec. a.C., oggi perduto ma ricordato da Plinio il Vecchio nella sua N.H. con
aneddoto relativo all’uso di Campase, amante di Alessandro Magno, come suo
modello. Questo quadro sarebbe stato acquisito da Augusto a Coo e portato a Roma.
Sarebbe però da attribuire a Vespasiano la diffusione del soggetto in età Flavia ( I
sec. d.C.) soprattutto testimoniato dal ritrovamento di diversi esempi ascrivibili a tale
periodo e dall’uso diffuso a Pompei nella decorazione delle abitazioni private e degli
edifici pubblici. Ricordiamo a tale proposito modelli anche più noti come la Venere
Landolina di Siracusa, la Venere di Venafro, la Venere di Sinuessa, la Venere di Alba
Fucens, fino ad arrivare molto lontano con la Venere di Nisa, cittadella di epoca
partica del Turkmenistan.
Venere incarna l’ideale della bellezza femminile e del nudo femminile e in epoca
romana il maggior numero di riproduzione appartiene ai sec. II e I a.C., in cui è viva
la tradizione scopadea e prassitelica: non è concepibile infatti tralasciare un
riferimento alla Afrodite Cnidia di Prassitele (IV sec. a.C.). Il motivo fu ripreso con
varianti relative fino all’Ellenismo. Gli artisti successivi si trovarono di fronte ad
interpretazioni diverse di questo prodotto iniziale: siamo nel tardo Ellenismo,
momento a cui si può riferire la Venere di Siracusa. La statua di Avellino presenta un
modellato carnoso in cui si notano la morbidezza e la rotondità delle parti nude, un
panneggio mosso ed elaborato, artificioso, realizzato come una svela svolazzante
sospinta da un forte vento, in netto contrasto con le gambe ben levigate , che rende
l’idea del movimento, seppure la statua sia stante, proprio nel momento dell’uscita
dalle acque.
L’assenza della testa non permette ulteriori confronti come ad es. è possibile per la
Venere di Venafro che richiama proprio nella capigliatura l’Afrodite Capitolina, in
cui ritorna il motivo ideale prassitelico della dea al bagno.
Venere (venus,eris = bellezza) é l’appellativo che i Romani diedero alla dea greca
Afrodite, dea della bellezza e dell’amore spirituale e sensuale, inteso anche come
attrazione delle varie parti dell’universo tra di loro per conservare e procreare. Due
sono le versioni riguardante la sua nascita. Secondo Omero era figlia di Zeus e Dione
e fu sposa, spesso infedele, di Efesto, dio deforme del fuoco e fabbro
dall’indiscutibile bravura. A detta di Esiodo, invece, Venere emerse dalla spuma del
mare, in una giornata di primavera, la stagione che dà avvio al ciclo della vita sulla
terra e nel mare, e fu portata dagli Zefiri prima a Citera e poi da lì su una conchiglia
fu trasferita sull’isola di Cipro. Dalle due isole le derivano gli appellativi di Ciprigna
e di Citerea. Le era sacra la colomba. Dalla sua unione con Ares, dio della guerra
(Marte dei Romani), nacque Eros, che simboleggia l’amore fisico, Himeros che
simboleggia il desiderio dell’altra persona dinanzi agli occhi, Pothos l’oggetto
lontano e infine Anteros che punisce chi non ricambia l’amore. Da un mortale,
Anchise, Venere ebbe il figlio Enea, eroe troiano che, fuggendo da Troia in fiamme
col padre e il figlio Iulo, giunge in Italia dove proprio i discendenti di Iulo daranno
origine alla grandezza di Roma. Sfortunato invece fu l’amore per il giovane e
bellissimo Adone che morì ucciso da un cinghiale; dal suo sangue nacquero gli
anemoni rossi.
Messaggio nascosto delle statue
L’importanza dell’apparato decorativo della Dogana di Avellino risiede non solo nel
valore delle singole statue ma anche nel messaggio che il Principe ha affidato ad esse.
Infatti possiamo leggere le statue in un modo nuovo non come semplici elementi
ornamentali ma come parti di un unico messaggio poste lì con un intento preciso.
Apollo nel mito non era solo il dio della bellezza, dei vaticini, del sole ( identificato
con Elio) ed il dio di tutto ciò che era soggetto alle regole del ritmo e dell’armonia (
musica, canto, poesia). Nella tradizione classica Apollo era anche la divinità che dava
la morte agli uomini con i suoi dardi ed insieme a sua sorella Diana, dardi che
provocavano anche le pestilenze. Ma, secondo l’ambivalenza tipica di tante figure
mitologiche, Apollo era anche il dio della guarigione, che trasmise ad Asclepio, suo
figlio, l’arte della medicina, dunque colui che allontana il male.
La presenza di Apollo è evocata nella Dogana, oltre alle statue, forse equivocate,
anche dalla statua di Niobide, ovvero una delle figlie di Niobe uccisa proprio dai figli
di Latona. Non è un caso che anche Diana ( Artemide) sia presente nell’apparato
statuario dell’edificio.
La città un giorno fu colpita a morte dal male della peste che decimò i suoi figli,
come i figli di Niobe trafitti dai dardi di Apollo e Diana.
Il Principe di questa città decise di costruire un tempio-granaio perché dopo la
pestilenza i suoi figli e la città tutta, risorta e rinata, non venga colpita dalla fame e vi
ha posto a guardia proprio quegli dei che avevano seminato il flagello, in funzione
apotropaica.