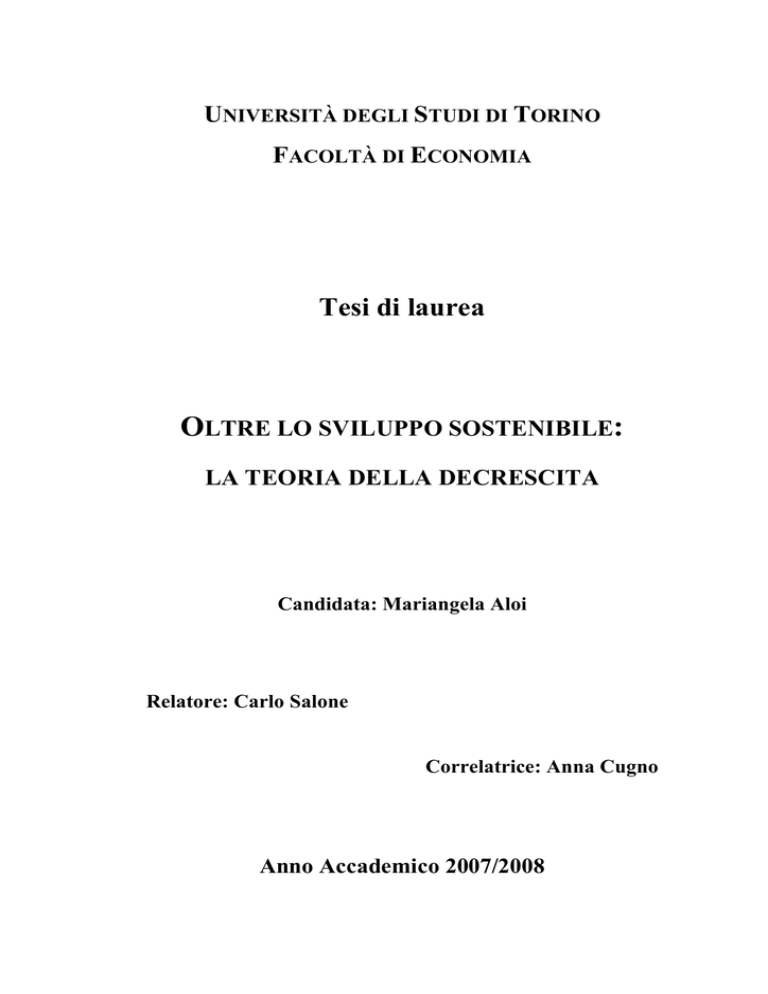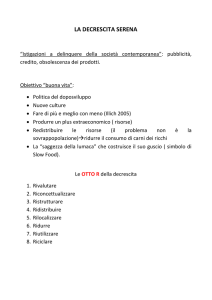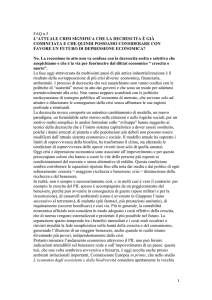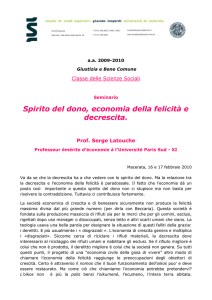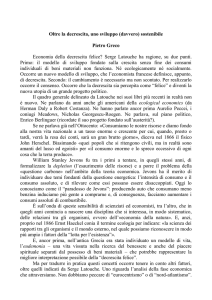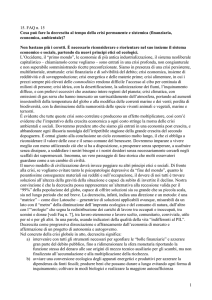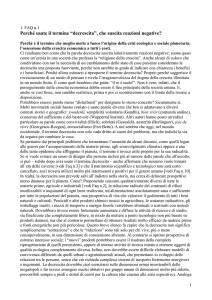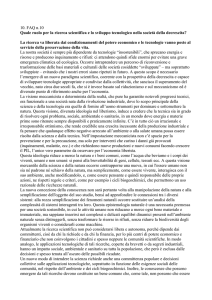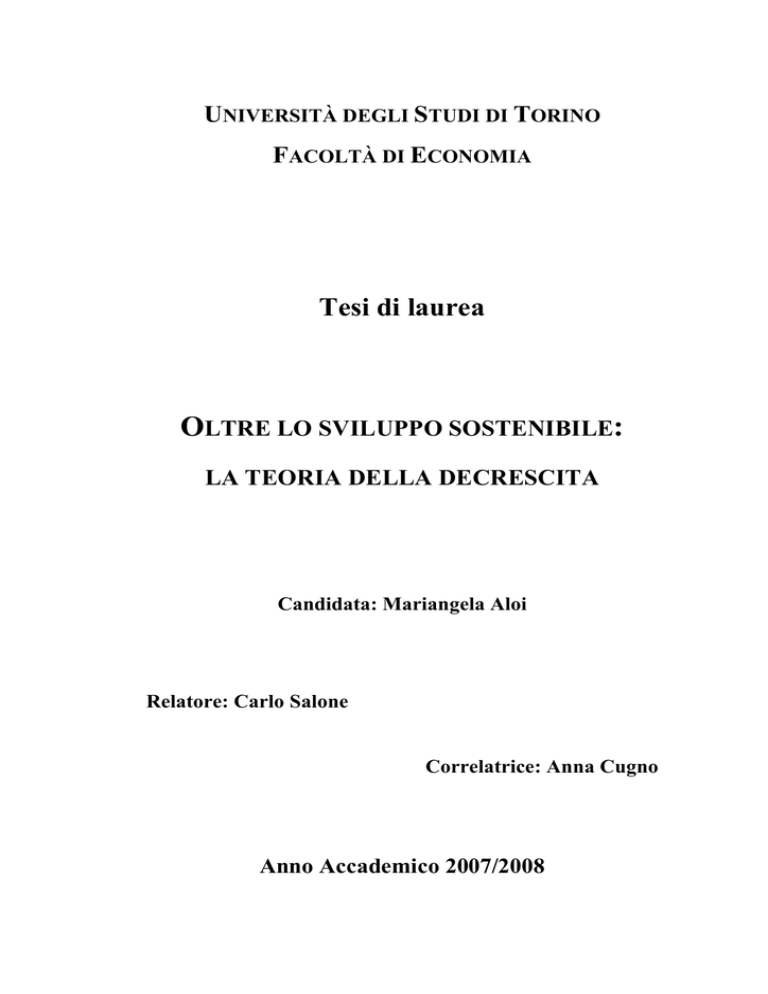
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTÀ DI ECONOMIA
Tesi di laurea
OLTRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE:
LA TEORIA DELLA DECRESCITA
Candidata: Mariangela Aloi
Relatore: Carlo Salone
Correlatrice: Anna Cugno
Anno Accademico 2007/2008
INDICE
INTRODUZIONE
LO SVILUPPO
5
10
1.1 L’evoluzione del termine sviluppo nel pensiero umano
13
1.2 Il termine sviluppo nella scienza economica
16
1.3 Lo sviluppo nel secondo dopoguerra
19
1.3.1 Gli anni ’50 e ’60: la Teoria della crescita e la Teoria dello sviluppo
21
1.3.2 Gli anni ’70: il Terzomondismo
25
1.3.3 Gli anni ’80: la Teoria dell’aggiustamento strutturale
28
1.3.4 Dagli anni ’90: lo Sviluppo umano
31
1.4 Fallimento del progetto
I LIMITI DELLO SVILUPPO
34
39
2.1 L’esaurimento delle risorse naturali e il problema ambientale
39
2.2. La teoria economica delle risorse naturali
43
2.3 Il rapporto del M.I.T.
46
2.4 Il rapporto Brundtland e il concetto di sostenibilità
48
2.5 I limiti sociali
53
2.6 La misura dello sviluppo
58
LA BIOECONOMIA DI GEORGESCU-ROEGEN
64
3.1 Un economista eretico
64
3.2 Le leggi della termodinamica
66
3.3 Un nuovo paradigma
70
3.4 La teoria bioeconomica
76
3.4.1 Stock, flussi e teoria della produzione
79
3.4.2 Il problema energetico e il problema materiale
83
3.5 Il programma bioeconomico
89
3.6 La critica allo stato stazionario
92
3.7 L’etica bioeconomica
96
2
DALY E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
99
4.1 Mondo vuoto e mondo pieno
102
4.2 Lo stato stazionario
106
4.2.1 Definizioni
106
4.2.2 Mezzi e fini
109
4.2.3 Limiti alla possibilità della crescita
110
4.2.4 Limiti economici
111
4.3 Lo sviluppo sostenibile
113
4.3.1 I limiti etico-sociali alla crescita
113
4.3.2 Utilità e throughput
115
4.3.3 La scala dello sviluppo sostenibile
117
4.3.4 Consumo e valore aggiunto
118
4.3.5 Strumenti per lo sviluppo sostenibile
121
4.3.6 Istituzioni per lo sviluppo sostenibile
123
4.4 Comunità di comunità
126
4.4.1 L’importanza della comunità
126
4.4.2 I Paesi in via di sviluppo
129
UNO SVILUPPO DIVERSO: LA DECRESCITA
133
5.1 La ricerca di un’alternativa
136
5.2 Che cos’è la decrescita
139
5.3 Il programma delle “otto R”
141
5.3.1 Rivalutare
141
5.3.2 Riconcettualizzare
142
5.3.3 Ristrutturare
143
5.3.4 Ridistribuire
145
5.3.5 Rilocalizzare
146
5.3.6 Ridurre
147
5.3.7 Riutilizzare/Riciclare
148
5.4 La critica allo sviluppo sostenibile
150
5.5 I consumi
155
5.6 Riscoprire il locale
162
5.6.1 La decrescita per il Sud del mondo
166
3
I LABORATORI DELLA DECRESCITA
169
6.1 Reti e Distretti di economia solidale
172
6.2 Gruppi di Acquisto Solidale
178
6.3 Bilanci di giustizia
184
6.4 CAmbieReSti?
190
6.5 Luci e ombre del consumo critico
195
6.6 L’altra rete
200
CONCLUSIONI
La comunità e il territorio
BIBLIOGRAFIA
203
204
214
4
INTRODUZIONE
La recente crisi economica ha chiamato direttamente in causa il sistema
capitalistico. Sui giornali sono apparsi titoli che annunciano l’imminente fine del
capitalismo e la società si è trovata di fronte ai limiti di un sistema che ha fatto
proprio lo slogan della “crescita per la crescita”. Nei giorni seguenti al tracollo
delle borse, economisti e politici si sono affrettati a rassicurare la popolazione
circa la capacità del sistema di uscire da questo periodo difficile. Eppure appare
evidente che qualcosa nel progetto della società di mercato non ha funzionato. I
limiti più evidenti riguardano l’incapacità del sistema di mercato di gestire la
questione ambientale. Nonostante le resistenze da parte di molti, la crisi
ambientale risulta ormai un’evidenza incontestabile, tuttavia la gravità e
l’ampiezza della situazione e le strategie adeguate ai fenomeni in atto non sono
ancora elementi acquisiti in modo concorde.
Gran parte di tali diversità e difficoltà dipendono dalle differenti visioni del
mondo, punto di partenza per ogni tipo di indagine scientifica o intellettuale. Le
contraddizioni della globalizzazione (continua tensione tra globale e locale,
evidenza delle disuguaglianze tra le diverse parti del mondo, contrasto tra la
ricchezza del Nord e la miseria del Sud, l’emergere della crisi ambientale)
rendono evidente la mancanza di una direzione condivisa.
Il dibattito intorno allo sviluppo, che non è riuscito fino a oggi a colmare l’enorme
divario tra i Paesi occidentali e il resto del mondo, come si prefiggeva, si va
delineando attorno a due questioni: privilegiare il mercato globale o privilegiare le
comunità umane. Esse sono frutto di due diversi approcci alla concezione del
mondo e della scienza: il riduzionismo individualista e meccanicista e l’approccio
della termodinamica e della teoria dei sistemi.
Il modello newtoniano ha dominato per lungo tempo il pensiero umano
influenzando tutte le scienze, economia compresa. Affrontare le sfide attuali
richiede però un mutamento profondo, a partire dall’identificazione della
complessità sistemica del mondo in cui viviamo. La coscienza dei limiti fisici del
5
pianeta passa dalla comprensione delle complesse interazioni che legano elementi
materiali ed esseri viventi all’interno del sistema Terra.
L’individualismo metodologico, frutto del paradigma riduzionista e meccanicista,
è stato la base della scienza economica, portando a tre credenze erronee:
–
l’uomo è signore e padrone del suo ambiente;
–
viviamo su un pianeta dalle risorse infinite;
–
il mercato e la tecnologia creeranno sempre delle valide alternative.
Dal punto di vista pratico, questo si è tradotto in una ricerca continua di crescita:
della produzione, dei consumi e della ricchezza.
La visione termodinamica e sistemica, al contrario, ha sottolineato come la Terra
sia essenzialmente un sistema chiuso dalle risorse limitate, il che implica
l’impossibilità fisica della crescita illimitata. Inoltre, la complessità degli
ecosistemi e l’articolato sistema di retroazioni che determinano il funzionamento
dell’ambiente naturale, rendono inutili quegli interventi che non tengono conto
delle connessioni tra i sistemi e che si presentano come soluzioni per un solo
aspetto della questione.
La persistenza dell’approccio riduzionista non riesce a cogliere i problemi della
complessità. Emerge la necessità di un cambiamento del paradigma che consenta
di affrontare non solo i problemi ambientali, ma anche i problemi sociali causati
dall’economia della crescita. Anche nelle economie occidentali cresce il malessere
riguardo a una società che indebolisce sempre di più i legami sociali, rende
frenetici i ritmi di vita e attira in un vortice le identità di consumatori e cittadini.
La sensazione di “aver oltrepassato il limite” permea di incertezza la visione del
proprio futuro, aumentata dalle notizie contraddittorie che ogni giorno
commentano la situazione ambientale. Fioriscono testi che elogiano la lentezza,
che osano parlare contro il dogma del progresso e riscoprono i benefici di uno
stile di vita più sobrio e frugale. L’attenzione verso l’ambiente assume un
carattere sempre più pervasivo all’interno della società e del mercato, e alcuni
consumatori iniziano a prendere coscienza del proprio agire di consumo come
strumento per manifestare i propri valori e i propri orientamenti economici.
Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare l’emergere di un modo diverso di
intendere e vivere l’economia. Si sente sempre più spesso parlare di sobrietà, di
6
lentezza, di riscoperta delle relazioni umane. Al tempo stesso si avverte la
necessità di rimediare alle ambivalenze del progresso, che ha determinato anche
effetti quali il problema ambientale e l’esistenza di popolazioni che ancora vivono
ai limiti della sussistenza. La decrescita e l’economia solidale sono un modo per
rispondere a queste questioni, in una critica sistematica all’economia mainstrem,
che passa attraverso la proposta di stili di vita e di consumo diversi.
Le società più avanzate appaiono, paradossalmente, sempre più vulnerabili e
incapaci di agire alle avversità. In qualche modo, l’uomo ha perso il controllo
della tecnostruttura che lo sovrasta, diventando sempre più dipendente dalle
strutture esterne e dalla tecnologia. Riappropriarsi della capacità di fare (e non
solo di consumare) e riappropriarsi del tempo sono due punti cardine della
decrescita. L’opposizione allo sviluppo e alla società della crescita passa
attraverso la proposta di una nuova comunità, basata sulla sobrietà e sulla
convivialità, realizzata grazie alla presa di coscienza, da parte dei cittadini, che la
crescita non è socialmente, fisicamente e moralmente sostenibile.
Questo lavoro è articolato in sei capitoli, attraverso i quali si vuole ripercorre la
storia delle idee che possono ricondursi a una critica della crescita, partendo
dall’esposizione del concetto di sviluppo e del progetto che, dagli anni ’50, ha
influenzato gran parte della politica economica internazionale.
Il primo capitolo inquadra il tema dello sviluppo come paradigma che ha guidato
le politiche economiche, in particolare verso il Sud del mondo, dal secondo
dopoguerra a oggi. Il concetto di sviluppo risulta indissolubilmente legato al
concetto di crescita: il problema redistributivo a livello mondiale è stato affrontato
partendo dal presupposto che una torta più grande può sfamare più persone, senza
tenere in conto il fatto che le fette continuano a essere di dimensioni differenti. Il
progetto sviluppista non è riuscito a raggiungere l’obiettivo di elevare le
popolazioni del Sud ai livelli di vita occidentali; tuttavia è riuscito a diffondere il
sogno della crescita in tutto il globo, spazzando via altre forme di sviluppo, altri
tipi di economia, estranei al sistema capitalistico, ma derivanti dalla tradizione e
dal saper fare locale, che rappresentavano la vera risorsa dei Paesi in via di
sviluppo.
7
Il secondo capitolo è dedicato ai limiti dello sviluppo: in primo luogo i limiti fisici
e ambientali, messi in evidenza negli anni ‘70 dal rapporto del Club di Roma ed
emersi con sempre maggiore gravità negli ultimi anni. L’esaurimento delle
risorse, i cambiamenti climatici, la perdita della biodiversità sono alcuni degli
aspetti del problema ambientale che si manifestano a livello globale. L’economia
ha
sistematicamente
ignorato
l’ambiente
all’interno
dei
suoi
modelli,
considerando le risorse infinite e l’inquinamento un’esternalità. Il capitolo
presenta anche i limiti di natura sociale: le disparità evidenti tra Nord e Sud sono
accompagnate sempre più spesso da differenze anche all’interno degli stessi Paesi
occidentali, tanto che emerge sempre più spesso una forbice tra l’aumento del Pil
e la percezione di benessere dei cittadini. La corsa incessante verso la crescita
porta alla disgregazione dei rapporti sociali e alla perdita del saper fare che, anche
nei Paesi occidentali, rappresentano le vere risorse dei territori.
Nei capitoli successivi vengono presentati alcuni autori che, in modo diverso,
hanno cercato di uscire dal paradigma sviluppista per concentrarsi su un tipo
diverso di sistema economico. Il terzo capitolo è dedicato a un economista
definito “eretico” dai suoi contemporanei: Nicholas Georgescu-Roegen. Egli
introduce nell’analisi economica le conseguenze della teoria termodinamica, per
giungere alla formulazione di una nuova teoria: la bioeconomia. Essa modifica il
modo di concepire il processo economico di sviluppo, facendo emergere una
nuova visione dei rapporti tra l’insieme degli esseri viventi (compreso l’uomo con
la propria tecnologia) e la biosfera. Estremamente critico nei confronti
dell’economia
mainstream
ed
estremamente
pessimista
circa
il
futuro
dell’umanità, Roegen è stato ignorato dal mondo accademico. La sua teoria,
decisamente radicale, è il primo approccio teorico alla decrescita: egli, infatti, non
solo critica la crescita ma, in base alle leggi della termodinamica, considera
insostenibile anche uno stato stazionario.
Il quarto capitolo presenta il pensiero dell’economista Herman Daly. I suoi scritti
sono conosciuti soprattutto per il sostegno al concetto di sviluppo sostenibile.
Riprendendo le critiche alla crescita di Roegen, Daly propone di ripensare lo
sviluppo economico tenendo conto delle componenti ambientali e sociali fino a
quel momento tralasciate dalla teoria economica mainstream. Egli non si pone al
8
di fuori dell’economia capitalista, ma si propone di colmare le lacune e gli errori
di questo sistema. La sua ricetta per realizzare un’economia più giusta e più
sostenibile è il raggiungimento di uno stato stazionario, ovvero un’economia che
smette di crescere per mantenere livelli di sfruttamento delle risorse compatibili
con la loro rigenerazione. A questo si accompagna una riforma sociale che vede
nella riscoperta della comunità la chiave per rendere lo stato stazionario una scelta
volontaria e non un’opzione imposta dall’alto.
I contributi di Roegen e di Daly, sebbene presentino elementi di contrasto, in
particolare sul concetto di sviluppo sostenibile, permettono di comprendere gli
attuali movimenti che si collocano nel panorama della critica al modello di
sviluppo. Le esperienze sono molteplici e variegate. Si è scelto di concentrare
l’analisi su quei movimenti che, partendo dalla consapevolezza dei limiti del
pianeta, concentrano la loro attenzione sulla sobrietà. Nel quinto capitolo si
espone la teoria della decrescita, in particolar modo attraverso i contributi di
Latouche. La decrescita allude sul piano economico a una riduzione complessiva
delle quantità fisiche prodotte e delle risorse impiegate, ma va intesa in un senso
molto più ampio: si configura, infatti, come una vera e propria rivoluzione sociale,
culturale e politica, che può essere messa in atto attraverso una trasformazione
dell’immaginario collettivo. Per quanto possa sembrare utopica, la decrescita
rappresenta già una realtà per alcuni gruppi di persone che hanno scelto un diverso
modo di consumare. Nel sesto capitolo, attraverso la descrizione di alcune
esperienze pratiche, si cerca di capire quali sono le motivazioni che spingono le
persone a scegliere uno stile di vita fuori dalle logiche comuni, mettendo in atto
un ripensamento dei valori che guidano il proprio agire.
L’ultimo capitolo, infine, vuole essere un tentativo di individuare nella comunità
locale la scala di riferimento per questi movimenti e il nodo attraverso il quale può
nascere una rete più ampia che, coordinando le diverse esperienze, permetta loro
di ampliarsi senza perdere i propri valori etici e allo stesso tempo rappresenti una
concreta possibilità di mettere in atto un’economia altra, inserita nel contesto del
doposviluppo.
9
Capitolo 1
LO SVILUPPO
La parola sviluppo è ormai entrata nel vocabolario collettivo e il suo suono
riecheggia spesso nei discorsi politici ed economici come panacea per risollevare
le sorti dell’umanità. In realtà il termine sviluppo è nato di recente, ed è ormai
opinione comune fare riferimento alla data del 20 gennaio 1949: in occasione del
tradizionale “Discorso sullo stato della Nazione” il presidente degli Stati Uniti,
Harry Truman, inaugura ufficialmente l’era dello sviluppo.
“In quarto luogo dobbiamo lanciare un nuovo programma che sia
audace e che metta i vantaggi del nostro progresso scientifico e
industriale al servizio del miglioramento e della crescita delle regioni
sottosviluppate. Più della metà delle persone di questo mondo vive in
condizioni prossime alla miseria. Il loro nutrimento è insoddisfacente.
Sono vittime di malattie. La loro vita economica è primitiva e
stazionaria. La loro povertà costituisce un handicap e una minaccia,
tanto per loro quanto per le nazioni più prospere. Per la prima volta
nella storia l’umanità è in possesso delle conoscenze tecniche e
pratiche in grado di alleviare la sofferenza di queste persone. […] Io
credo che noi dovremmo mettere a disposizione dei popoli pacifici i
vantaggi derivati dalla nostra riserva di conoscenze tecniche al fine di
aiutarli a realizzare la vita migliore alla quale essi aspirano. E, in
collaborazione con altre nazioni, noi dovremmo incoraggiare
l’investimento di capitali nelle regioni dove lo sviluppo manca. […] Il
vecchio imperialismo – lo sfruttamento al servizio del profitto
straniero – non ha niente a che vedere con le nostre intenzioni. Quel
che prevediamo è un programma di sviluppo basato sui concetti di un
negoziato equo e democratico.”1
1
H. S. Truman, Inaugural address, 20.01.1949, in Documents on American Foreign Relations,
Princeton University Press, Connecticut 1967
10
E’ in questo discorso che, per la prima volta, appare il termine sottosviluppo e
questa innovazione terminologica finirà per influenzare profondamente anche il
significato del concetto “sviluppo”.
Definire la parola sviluppo non è un esercizio facile. Essa, infatti, ha ormai
assunto una dimensione semantica enorme, che evoca una pluralità di immagini
distinte.
Nella lingua italiana il termine sviluppo denomina una modificazione quantitativa
che avviene nel tempo in seguito a un graduale avanzamento per stadi intermedi
da un livello all’altro. Se è semplice applicare questo concetto a un’entità
empirica, ad esempio un essere vivente, le cose si complicano quando si passa a
fenomeni e azioni umane. Nessuno ha mai visto culture, società ed economie
crescere e svilupparsi nello stesso modo in cui possiamo dire di vedere questi
fenomeni in piante, animali o in un’opera in costruzione. Eppure, questo concetto
viene utilizzato in larga misura proprio dalle scienze sociali per descrivere i
mutamenti che sono osservabili nel progredire della storia umana.
Sempre più legato a discordi economici, nel linguaggio corrente e nella sua
accezione più ampia “sviluppo” descrive un processo attraverso il quale vengono
liberate le potenzialità di un oggetto o di un organismo, fino a raggiungere la sua
forma naturale, completa, definitivamente evoluta. Il suo impiego classico è il
campo della biologia, dove spesso è usato come sinonimo di evoluzione. Questo
implica l’associazione automatica del concetto di sviluppo all’idea del tempo e del
cambiamento, in un senso positivo di accrescimento e di miglioramento. Per
questo il concetto di sviluppo ha avuto un successo così evidente negli ultimi 50
anni, a scapito di altri termini che potevano essere scelti per descrivere la ricerca
continua del benessere dell’umanità, quali civiltà, occidentalizzazione o
liberazione. Ha prevalso il termine sviluppo perché, come suggeriste Rist (1996),
esso presenta diversi vantaggi: la provenienza dal linguaggio scientifico
garantisce una certa rispettabilità, evoca immagini di evoluzione e presume lo
svolgimento favorevole del processo auspicato; si collega a una tradizione di
pensiero, che risale al mito, che ne garantisce la legittimità e la riconoscibilità.
Quest’ultimo aspetto non è di secondaria importanza: chiunque, per lo meno nel
11
mondo occidentale, sentendo pronunciare la parola sviluppo comprende
immediatamente di cosa si sta parlando, si può dialogare su un substrato
linguistico comune che permette la piena comprensione e la possibilità di
confrontarsi su un campo condiviso e riconosciuto.
Lo sviluppo è diventato, così, un termine comodo per descrivere sia il
cambiamento sociale che il cambiamento economico che da esso deriva, rendendo
entrambi così simili a dei fenomeni naturali da trasformare lo sviluppo in una
meta necessaria e inevitabile. Dall’ambito biologico vengono anche mutuate
quattro caratteristiche fondamentali dello sviluppo:
–
la direzionalità: lo sviluppo procede lungo una strada chiaramente
tracciata;
–
la continuità: lo sviluppo non fa salti;
–
la cumulatività: nello sviluppo ogni nuova tappa dipende dalla precedente,
in una progressione che porta a uno stato di compimento;
–
l’irreversibilità: superata una tappa, lo sviluppo non torna indietro e non
regredisce a una condizione precedente.
Come osservato in precedenza, se dal punto di vista biologico non è possibile
opporre delle critiche a questa impostazione, diversa è la questione quando si
osservano i fenomeni storici e sociali; eventi come il crollo dell’Impero Romano
dimostrano che la Storia non rispetta la linearità e l’irreversibilità dello sviluppo.
12
1.1 L’evoluzione del termine sviluppo nel pensiero umano
Analizzando l’evoluzione del pensiero umano, almeno per quanto riguarda la
tradizione occidentale, si può far risalire l’idea di “sviluppo come progresso”
all’epoca illuminista. Nei secoli precedenti, infatti, il pensiero aristotelico prima e
quello cristiano legato alla visione di S. Agostino poi, dominano nettamente la
scena, con interpretazioni della Storia e del divenire molto diverse da quelle
attuali.
Secondo la tradizione mitologica greca e la filosofia di Aristotele, le
trasformazioni del mondo si spiegano mediante una successione di età ("Æä<gH),
designate metaforicamente con i metalli che simboleggiano la loro perfezione:
oro, argento, bronzo, ferro. Ogni età è caratterizzata da un momento di crescita,
apogeo e quindi di declino, e ogni periodo rappresenta un passaggio a un livello di
benessere, conoscenza e ricchezza inferiore a quello precedente. La storia viene
quindi vista non come un progresso, bensì come un inevitabile declino verso
l’imbarbarimento: ciò che nasce, cresce e raggiunge la maturità, in un perfetto
parallelismo con la vita umana, poi non può che corrompersi e morire, in un
perpetuo ricominciamento.
Il pensiero filosofico di Sant’Agostino si forma in un contesto storico instabile,
nel quale il destino dell’Impero Romano sembra ormai segnato, situazione che
accredita l’idea che il mondo si trovi al termine di un ciclo e che la fine della
potenza imperiale sia l’evoluzione naturale di un’età che giunge al suo termine. In
questo contesto, Agostino si trova a dover conciliare la visione aristotelica con la
teologia cristiana, e ci riesce applicando gli elementi costitutivi del ciclo (crescita,
apogeo, declino) alla totalità della storia umana, rappresentando, di fatto, la storia
come un’unica età destinata, dopo la comparsa di Cristo, all’inevitabile fine del
mondo e al giudizio universale.
L’eredità agostiniana viene accolta e sfruttata per tutto il Medioevo e anche il
risveglio del Rinascimento, con la riscoperta dell’Antichità, si inserisce nello
stesso paradigma: gli antichi sono modelli da imitare, perché il processo storico,
lungi da portare un progresso e un’evoluzione qualitativa, trascina l’umanità verso
13
un ineluttabile declino. L’idea di sviluppo oggi diffusa non potrebbe essere più
lontana da questa visione.
Qualcosa inizia a cambiare con l’illuminismo, quando l’idea delle “magnifiche
sorti e progressive” si diffonde tra gli accademici e la ragione diviene lo
strumento con il quale contrastare il declino e illuminare di luce nuova il destino
dell’umanità. L’Antichità non è più il passato glorioso del genere umano, ma il
serbatoio da cui attingere per aumentare le nostre conoscenze:
“Una mente ben coltivata è, per così dire, composta di tutte le menti
dei secoli precedenti; è un’unica mente che si è coltivata per tutto
quel tempo. Così l’uomo che ha vissuto dall’inizio del mondo fino ad
ora ha avuto la sua infanzia in cui si è occupato soltanto dei bisogni
più pressanti della vita, la sua giovinezza in cui è riuscito abbastanza
bene nelle cose dell’immaginazione, come la poesia e l’eloquenza, e
in cui ha anche iniziato a ragionare, ma con meno solidità che ardore.
Egli è ora nell’età virile, in cui ragiona con più forza e più lumi che
mai […]. Sono costretto ad ammettere che l’uomo non vedrà mai la
vecchiaia; sarà sempre egualmente capace […] cioè […] gli uomini
non degenereranno mai e le vedute sane di tutte le buone menti che si
succederanno si cumuleranno sempre tra di loro.”2
Con lo sviluppo della scienza nel XVII secolo, la cultura europea acquista
coscienza del progresso e della possibilità di un processo infinito di miglioramenti
e avanzamenti. Nasce così l’idea dello sviluppo come capacità intrinseca
dell’umanità di progredire e crescere, sia dal punto di vista culturale che dal punto
di vista economico: prende forma l’idea che esista una storia naturale
dell’umanità, cioè che lo sviluppo delle società, delle conoscenze e della ricchezza
corrisponda a un principio naturale e autodinamico, che fonda la possibilità di una
grande narrazione, potenzialmente senza limiti. Questo concetto si ritrova in tutte
le scienze umane e viene ripreso anche dalla neonata scienza economica; non a
caso, il titolo del testo fondatore dell’economia è “Indagine sulla natura e sulle
2
B. Le Bovier de Fontanelle, 1688, Poésies pastorales avec un Traité sur la nature de l’èglogue et
une Digression sul les Anciens Poëtes & Modernes, Van Dole e Foulque, La Haye
14
cause della ricchezza delle nazioni”3: il progresso della prosperità si presenta
come un ordine di cose imposto dalla necessità e promosso dalle inclinazioni
naturali dell’uomo. L’ordine delle cose, cioè il progresso, si dispiega come una
necessità naturale che niente può arrestare e lo sviluppo diventa non più una
scelta, ma la finalità e la fatalità della Storia. La tendenza al progresso è
connaturata nell’uomo; non è dunque la sua natura a mutare, ma è l’accumularsi
dell’esperienza che gli permette di progredire illimitatamente in un tempo che non
conosce decadenza o fine.
Il
nuovo
paradigma
sarà
completato
nel
XIX
secolo
sotto
forma
dell’evoluzionismo sociale. Adattando la teoria darwiniana alla società, si
diffonde nell’immaginario collettivo l’idea di un cammino evoluzionistico della
specie umana, in cui il progresso, sociale ed economico, diventa il fine ineluttabile
da perseguire come processo naturale della Storia. Possono esserci ritmi diversi,
ma ogni nazione e ogni popolo giungerà necessariamente a uno sviluppo simile a
quello dei Paesi occidentali; l’epoca che vede affermarsi l’idea moderna di
progresso è la stessa che è dominata dall’eurocentrismo e che assiste alla
diffusione della distinzione tra i paesi arretrati e primitivi e l’Europa avanzata e
civile che, forte del proprio vantaggio economico, darà inizio alla corsa
colonialista di sfruttamento dei paesi africani e asiatici.
In questa evoluzione, lo sviluppo si è legato indissolubilmente alle parole
progresso, miglioramento, maturazione e all’idea di crescita economica; è
diventato un metro per misurare il grado di civiltà, termine di paragone per
analizzare lo stato economico e sociale dei paesi del mondo, ma soprattutto è
diventato un modello da seguire e da imitare.
3
A. Smith, 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
15
1.2 Il termine sviluppo nella scienza economica
La diffusione dell’espressione “sviluppo economico” è abbastanza di recente.
L’attenzione degli economisti, prima della seconda guerra mondiale, era, infatti,
più orientata sull’ottima allocazione delle risorse in un dato momento piuttosto
che sul loro accrescimento. Dopo il secondo conflitto mondiale, i termini “crescita
economica” e “sviluppo economico” prendono spazio nella scienza economica e
danno vita a due distinte famiglie di teorie. Generalmente, quando si parla di
crescita, si fa riferimento ai paesi che hanno un reddito procapite superiore a un
certo livello (i Paesi industrializzati) e ai modelli che definiscono le condizioni
che permettono a un sistema economico di raggiungere il più elevato tasso di
aumento del reddito. La parola sviluppo è invece riferita, in genere, ai paesi con
livelli di reddito inferiori (i Paesi del Terzo Mondo); lo sviluppo consiste proprio
nel processo che porta alla variazione di questa grandezza verso livelli superiori,
connotando il passaggio dalla condizione di Paese sottosviluppato a quella di
Paese sviluppato.
La dicotomia sviluppo/sottosviluppo, però, non è una semplice distinzione
quantitativa: essa implica anche un giudizio di valore nel modo in cui vengono
contrapposte due realtà, le economie avanzate e le economie arretrate, e nel
significato di sviluppo non come semplice mutamento, ma come progresso e
avanzamento verso il meglio.
I principali significati che il termine sviluppo assume nella scienza economica si
possono sintetizzare, in tre categorie: la crescita, la trasformazione strutturale, il
miglioramento del benessere collettivo o della qualità della vita (Volpi, 2003).
L’idea di sviluppo come crescita è sicuramente la più diffusa, perché utilizza delle
grandezze misurabili e visibili, che consentono di percepire l’andamento
dell’economia. L’indice utilizzato per misurare la crescita è il Pil; tale indice è
diffuso e utilizzato in tutte le statistiche internazionali, consentendo così un
confronto semplice e immediato tra i paesi del mondo. Come è noto, il prodotto di
un paese è la somma dei valori aggiuntivi nei vari settori, ovvero l’incremento di
valore conferito a ogni bene o servizio in ogni fase della sua produzione, al lordo
dell’ammortamento corrispondente al valore di capitale fisso usato nella
16
produzione. Il Pil (prodotto interno lordo) descrive il prodotto dei fattori, anche
stranieri, localizzati nel paese.
La rilevazione di questo indice presenta alcuni problemi, che hanno rilevanza
diversa nei diversi paesi, e dei quali occorre tenere conto soprattutto quando si
effettuano confronti internazionali. Il Pil riesce, infatti, a rilevare gran parte
dell’economia di un paese, ma tralascia una serie di beni e servizi prodotti da
quella che viene chiamata economia sommersa, quelli che sono consumati dai
produttori stessi e i prodotti del lavoro domestico. Non tiene conto, in sostanza, di
tutte le unità produttive informali che sfuggono al mercato ufficiale, ma che,
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, rappresentano una grande fetta
dell’economia nazionale. Dal punto di vista teorico, però, questo strumento è
perfettamente coerente con le premesse: se lo sviluppo è sinonimo di crescita,
allora tutto ciò che esula dal mercato è irrilevante e non è necessario tenerne conto
per misurare l’avanzamento di un paese.
L’esperienza storica mostra che a una crescita della produzione elevata e
prolungata per un rilevante periodo di tempo si accompagnano mutamenti nella
sua composizione, nei rapporti tra i fattori che la determinano, nei comportamenti
dei soggetti, ovvero in quella che si può chiamare struttura economica di un paese.
Variano i prodotti, le tecniche e l’organizzazione della produzione, e questi
cambiamenti, a loro volta, influenzano i rapporti sociali e le istituzioni del paese.
Quando gli economisti parlano di cambiamenti strutturali, si intende di solito il
passaggio da un’economia tradizionale, dove le attività prevalenti sono
l’agricoltura e l’artigianato, le tecniche produttive sono semplici, l’impiego di
capitale è modesto, la produttività del lavoro e il reddito procapite sono bassi e il
risparmio è decisamente ridotto, a un’economia moderna, come quella che
caratterizza i paesi con un livello di reddito più elevato. Il concetto di sviluppo
prevede quindi un’evoluzione, per le nazioni sottosviluppate, verso un’economia
prospera che provochi, all’interno del paese, un mutamento strutturale in grado di
modificare la società e renderla simile a quella dei Paesi occidentali.
Crescita del prodotto nazionale, modernizzazione delle istituzioni e sviluppo
economico sono concetti ai quali viene associato un valore positivo. Per un
singolo individuo, o per una famiglia, questi tre elementi rappresentano
17
sicuramente un miglioramento. Quando, però, vengono valutati su di una
collettività possono sorgere dei problemi. E’ facile osservare che generalmente un
maggior prodotto non si distribuisce nella stessa misura tra i cittadini, generando
delle disuguaglianze. In sostanza, il Pil non è in grado di dire nulla sulla
distribuzione del reddito. Gli economisti che ritengono il Pil un indice inadeguato
per misurare il grado di sviluppo propongono di integrare questo indicatore con
altri indici, riferiti, direttamente o indirettamente, agli obiettivi sociali che il
maggior reddito dovrebbe permettere di raggiungere. Il problema si pone allora
nel momento in cui, considerando l’economia un mezzo rispetto a dei fini, occorre
definire i fini rilevanti che essa dovrebbe raggiungere perché si verifichi un
aumento nel benessere collettivo e nella qualità della vita.
18
1.3 Lo sviluppo nel secondo dopoguerra
Dal punto di vista storico, l’economia dello sviluppo si concretizza dopo la
seconda guerra mondiale, in seguito al già citato discorso del 1949 del presidente
degli USA. Questo introduce, per la prima volta in modo formale, il termine
sottosviluppo, creando un confronto inevitabile con lo sviluppo e quindi con i
paesi che di questo sviluppo sono i modelli; a partire da essi si genereranno una
serie di politiche e di teorie volte a eliminare il divario e a permettere alle
popolazioni dei Paesi sottosviluppati di raggiungere il benessere dell’Occidente.
In realtà, se il discorso di Truman formalizza per la prima volta in un documento
ufficiale l’idea di sviluppo e sottosviluppo (documento che verrà poi tradotto in
una serie di politiche mirate a diffondere il modello occidentale), l’idea della
superiorità del modello economico europeo e americano era già diffusa, di fatto,
dall’epoca coloniale. L’influsso del positivismo evoluzionista, infatti, dava una
giustificazione paternalistica al colonialismo: se i popoli colonizzati vivono in uno
stato naturale e primitivo che deve evolvere nella civiltà, i colonizzatori hanno il
compito di diffondere la civiltà occidentale e di sostenere questo processo. Lo
sviluppo, infatti, non è un evento che avviene per caso, ma il risultato naturale del
percorso umano, che può essere accelerato dalle nazioni che si trovano ai livelli
superiori del processo. Il presidente Truman sottolinea, nel suo discorso,
l’estraneità degli Stati Uniti all’approccio colonialista, nella logica del libero
mercato, ma, di fatto, inaugura una nuova stagione imperialista, dove il controllo
non passa più attraverso l’apparato amministrativo e lo sfruttamento economico,
ma si esplica attraverso l’imposizione di un modello, lo sviluppo, proprio della
cultura occidentale, ma spesso estraneo ai paesi nei quali viene esportato.
Non si cerca di spiegare le ragioni del sottosviluppo, ma solo di colmare il divario
esistente tra i Paesi sviluppati e i Paesi sottosviluppati; il mondo non viene
considerato una struttura nella quale le nazioni dipendono e si influenzano le une
con le altre, ma come una collezione di paesi individuali, ognuno con la propria
parabola sottosviluppo/sviluppo, che deve necessariamente essere intrapresa. La
dicotomia tra Paesi sviluppati e Paesi sottosviluppati obbliga all’intervento: se lo
sviluppo è un fine ineluttabile e benefico, allora occorre uno sforzo collettivo e
19
mondiale da parte dei Paesi sviluppati per colmare il divario e permettere a tutta la
popolazione mondiale, in tempi rapidi, di vivere e godere dei benefici della
crescita economica.
Dal discordo del presidente Truman, lo sviluppo è stato inteso come un grande
progetto di trasformazione capitalistica della società che, partendo dagli USA e
dall’Europa, doveva riguardare tutto il mondo. Il progetto prevedeva il diffondersi
delle tecnologie dai Paesi sviluppati a quelli meno prosperi, al fine di ridurre la
loro miseria e povertà, povertà che è considerata una minaccia, non solo per le sue
vittime, ma anche per i Paesi occidentali. Si tratta di un progetto generoso, frutto
di un impasto culturale che, in uno spirito tipicamente americano, mescola
insieme ideali e senso degli affari:
“[…] tutti i paesi, ivi compreso il nostro, approfitteranno largamente
di un programma costruttivo che permetterà di meglio utilizzare le
risorse umane e naturali del mondo.”4
Occorre ricordare il contesto storico in cui nasce l’idea di questo progetto. I primi
anni del dopoguerra vedevano un’Europa in ginocchio, la guerra aveva distrutto
non solo le città ma anche molte delle speranze, alla luce del genocidio ebreo e
delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Occorreva lo slancio di un paese
giovane e poco toccato dalla guerra per rilanciare la corsa e riaccendere le fantasie
progressiste. Gli Stati Uniti sono i candidati ideali: il loro suolo è stato solo
sfiorato dalla guerra, alle loro spalle ci sono “solo” una guerra civile e lo
sterminio dei pellerossa, nulla a confronto con le secolari guerre di religione
dell’età pre-moderna e con le due guerre mondiali che hanno, nel giro di 40 anni,
devastato l’Europa.
Gli Stati Uniti si fanno carico della rinascita economica europea e della diffusione
di una nuova speranza progressista e sviluppista, che, dal vecchio continente, deve
diffondersi nel resto del mondo.
4
H. S. Truman, Inaugural address, cit.
20
1.3.1 Gli anni ’50 e ’60: la Teoria della crescita e la Teoria dello sviluppo
Nel secondo dopoguerra, grazie anche alla nascita delle organizzazioni
internazionali, il progetto per lo sviluppo può avere inizio. La presa di coscienza
dell’enorme divario economico tra i vari paesi del mondo (fondamentalmente tra
le ex colonie – il Sud – e gli ex Paesi colonialisti – il Nord) porta alla luce i grossi
problemi che affliggono le Nazioni sottosviluppate: basso livello di reddito,
problemi di carestia, fame o malnutrizione, limitato accesso all’acqua potabile,
scadenti sistemi pubblici di istruzione e sanità. Uno dei problemi fondamentali
che caratterizza questi paesi è la mancanza di solide strutture e istituzioni
nazionali, legittimate e riconosciute dalla maggioranza della popolazione. I popoli
del Sud hanno spesso percepito lo sviluppo economico come un mezzo per
raggiungere lo sviluppo politico e per creare una forte sovranità, un’indipendenza
politica e un’identità culturale che potesse riscattarli dagli anni di sfruttamento
coloniale.
Gli anni ’50, sul piano della politica internazionale, furono sicuramente dominati
dalla guerra fredda. Giocata dalle intellighenzie dell’Occidente sul piano
diplomatico, essa si giocò in modo molto più concreto nei Paesi del Terzo Mondo,
che furono spartiti tra le due potenze in gioco e divennero campo di prova per
testare la loro potenza e influenza sul mondo.
I diretti interessati, sull’onda del processo di decolonizzazione, iniziarono a
pretendere di inserire nell’agenda delle organizzazioni internazionali le proprie
rivendicazioni. Il Sud del mondo, tuttavia, è un insieme molto eterogeneo, in cui
si trovano paesi relativamente ricchi, come i produttori di petrolio, e nazioni
estremamente povere, come gli stati sub-sahariani. Ciò nonostante, essi hanno
cercato, nel corso degli anni, di costruire alleanze e condurre azioni politiche
comuni per poter meglio influenzare il sistema internazionale, nonché per creare
una certa resistenza unitaria nei confronti di quello che è percepito come il
dominio culturale ed economico dell’Occidente. La prima tappa di questo
percorso storico è stata la Conferenza Afro-asiatica di Bandung, in Indonesia, nel
1955, che rappresentò il primo passo verso l’unificazione dei Paesi decolonizzati.
Il risultato concreto della conferenza fu la creazione, nel 1961 (sotto la guida di
leader storici del Terzo Mondo come Nehru per l’India, Tito per la Yugoslavia,
21
Sukarno per l’Indonesia e Nasser per l’Egitto), del Movimento dei paesi non
allineati.
Sebbene queste nazioni insistano con forza sul principio di autodeterminazione
del proprio destino, al tempo stesso esse prendono come modello lo stesso
sviluppo proposto dall’Occidente, e rivendicano l’opportunità di raggiungere lo
stesso livello di benessere dei Paesi industrializzati. I Paesi in via di sviluppo
rivendicano la propria autonomia, ma riconoscono nello sviluppo economico,
nella produzione e nell’accumulazione fondata sugli investimenti privati e
sull’aiuto esterno, la soluzione alla loro arretratezza economica, aderendo di fatto
al modello economico occidentale.
Gli anni ’50 e ’60 vedono nascere molte istituzioni dedicate allo sviluppo dei
Paesi del Terzo Mondo (ad esempio l’UNCTAD, United Nation’s Commission on
Trade and Development, che doveva servire come una piattaforma per il dialogo
tra Sud e Nord) e il Gruppo dei 77 (nell’ambito dell’Assemblea Generale
dell’ONU, che doveva rappresentare i paesi del Sud presso l’UNCTAD) e si
moltiplicano gli interventi tecnici e finanziari per creare nel Sud lo stesso
miracolo avvenuto nel XVIII secolo in Europa.
La tesi dominante in questo periodo è la teoria della crescita, anche conosciuta
come teoria della modernizzazione. L’analisi fornita dai teorici della crescita
sostiene che la convergenza dei Paesi del Sud deve seguire lo stesso percorso di
sviluppo intrapreso dai Paesi dell’Occidente. Per raggiungere la “modernità”, il
Sud deve passare da una società agraria, tradizionale e preindustriale, a una
società moderna e industriale, basata sui consumi di massa. Occorre creare
ricchezza che possa essere consumata, dare vita a settori industriali efficienti e
produttivi. In quest’analisi, di cui Rostow è l’autore più eminente, la mancanza di
sviluppo deriva dalle stesse politiche economiche adottate dai Paesi arretrati, che
non si sono dimostrati in grado di gestire le loro economie in modo efficiente:
manca una base produttiva, capitalistica e tecnologica, e mancano le strutture
istituzionali in grado di supportare lo sviluppo economico. Le radici del
sottosviluppo sono quindi endogene, non esogene, e non dipendono dal sistema
economico internazionale. La teoria della crescita pone inoltre l’accento sul
cosiddetto trickle down effect (letteralmente “effetto gocciolamento”), secondo il
22
quale una crescita imponente a livello mondiale si ripercuote comunque anche sui
Paesi meno sviluppati, che possono approfittare di “gocce” di ricchezza mondiale.
La soluzione fornita dalla teoria della crescita al problema dello sviluppo si
sostanzia in una ricetta tipicamente liberista: un mercato libero dall’intervento
statale, investimenti nei settori moderni (agricoltura intensiva orientata verso i
mercati internazionali e settore industriale), apertura al mercato internazionale.
Nel saggio di Rostow del 1960, intitolato The Stage of Economic Growth: A NonCommunist Manifesto, l’autore individua il percorso esatto che un paese deve
seguire per raggiungere la modernità. E’ un percorso a stadi, in cui il processo è
univoco e irreversibile, e conduce necessariamente allo sviluppo e alla crescita
economica:
–
I fase, società tradizionale pre-newtoniana: caratterizzata dalla scarsità e
dalla presenza di barriere mentali che non permettono il pieno sviluppo,
perché ancora l’umanità non si è resa conto di poter conoscere il mondo
tramite il linguaggio matematico e la scienza;
–
II fase, pre-condizioni per il decollo: fase transitoria in cui i concetti di
scienza moderna iniziano a essere tradotti in nuove funzioni di produzione.
I nuovi stimoli possono anche provenire dall’esterno, ad esempio da Paesi
colonizzatori, che diffondono un nuovo sapere;
–
III fase, il decollo: si afferma la cultura dell’accumulazione capitalistica,
che consente un aumento diffuso dei redditi e dei risparmi; i valori
tradizionali lasciano il posto alla cultura capitalista;
–
IV fase, la spinta alla maturità: la produzione diventa sempre più moderna
ed efficiente, con un uso intensivo delle tecnologie; l’economia mostra di
essere in grado di produrre tutto ciò che essa vuole produrre;
–
V fase, il consumo di massa: tipico del fordismo americano, i redditi
consentono di incrementare i consumi e la crescita diventa auto-sostenuta.
Tutta la popolazione può beneficiare di un buon tenore di vita e, attraverso
il processo politico, le società possono allocare più risorse al welfare e alla
sicurezza.
L’idea principale della teoria di Rostow è che il modello evolutivo dell’Europa
Occidentale e degli Stati Uniti possa valere per tutti i paesi: seguendo il percorso
23
indicato dall’autore, e confidando nel commercio internazionale, tutti i paesi
possono raggiungere il grado di sviluppo dei Paesi industrializzati. Nella realtà
questo processo non si è verificato; al contrario il divario è aumentato, per cui i
Paesi più ricchi hanno visto i propri redditi crescere rapidamente nel boom degli
anni ’60, mentre per i Paesi poveri la crescita è stata decisamente più contenuta.
La distribuzione ineguale della crescita economica ha portato studiosi ed
economisti alla ricerca di altre teorie e modelli alternativi di sviluppo.
Gli economisti dello sviluppo hanno analizzato il sistema economico mondiale in
modo diverso dai loro colleghi della teoria della crescita, aggiungendo un fattore
che questi ultimi hanno trascurato: la distribuzione della ricchezza. Per questi
studiosi lo sviluppo non può avvenire a scapito dell’uguaglianza. La situazione
che si presenta ai loro occhi negli anni ’50 viene spiegata con l’incapacità dei
Paesi del Sud del mondo di integrarsi nel sistema economico mondiale. Due sono
gli assunti fondamentali dell’economia dello sviluppo: in primo luogo i Paesi
sottosviluppati sono fondamentalmente diversi dai Paesi occidentali; in secondo
luogo, l’origine del sottosviluppo non va cercata nell’incapacità o nell’inefficienza
delle Nazioni arretrate, ma in fattori al di fuori del loro controllo.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, l’immediata implicazione è che lo sviluppo
dei Paesi non industrializzati deve seguire una strada diversa da quella dei Paesi
del Nord. Le economie del Terzo Mondo sono caratterizzate da condizioni
particolari che non consentono la riproduzione tout court dello sviluppo
occidentale. Il secondo assunto vede nelle sfavorevoli ragioni di scambio che
hanno contraddistinto i commerci degli Stati meno sviluppati (residuo dell’epoca
coloniale) la causa della loro arretratezza. Il commercio internazionale, al
contrario della teoria della crescita, rappresenta un ostacolo allo sviluppo del Sud
del mondo. L’unica soluzione per questi paesi è l’adozione di misure
straordinarie: in primo luogo, serve uno Stato forte e interventista che sia in grado
di gestire e controllare direttamente l’economia nazionale, in modo da superare i
fallimenti del mercato. Lo Stato deve diventare imprenditore e consentire lo
sviluppo di una forte struttura industriale, al riparo di alte barriere doganali
(questa sarà la base teorica della strategia di sostituzione delle importazioni). In
secondo luogo, basandosi su un ottimismo antropologico, i teorici sviluppisti
24
sottolineano l’importanza dei paesi ricchi: per agevolare lo sviluppo dei Paesi del
Sud serve una generosa assistenza da parte della comunità internazionale,
attraverso investimenti diretti a questi paesi.
1.3.2 Gli anni ’70: il Terzomondismo
Sul finire degli anni ’60 e nel corso della prima metà degli anni ’70 si diffonde un
atteggiamento ottimistico per quanto riguarda la possibilità di crescita economica
dei Paesi in via di sviluppo; ottimismo che prende spunto dagli ottimi risultati
raggiunti, in termini di crescita economica, da parte di alcuni (pochi) Paesi del
Sud del mondo, interessati da flussi di capitali privati a prezzi di mercato che
consentono loro di incrementare considerevolmente i tassi di crescita e i
rendimenti sugli investimenti.
E’ il caso delle cosiddette quattro tigri asiatiche: Hong Kong, Corea del Sud,
Singapore e Taiwan. La crescita economica di questi paesi, iniziata negli anni ’70,
ma continuata per un ventennio, ha incuriosito molti studiosi, perché un simile
fenomeno non si era mai verificato prima.
Il modello politico - economico di questi paesi si basa sia su presupposti liberali
(il commercio come motore della crescita), sia su basi mercantilistiche (uno Stato
interventista che controlla l’economia). Il processo di sviluppo è avvenuto in
diverse fasi: dapprima lo Stato ha sostenuto fortemente lo sviluppo di un settore
manifatturiero efficiente; successivamente si incoraggia l’esportazione di beni di
consumo durevoli, eliminando alcune barriere doganali, sempre con l’appoggio
dello Stato; infine, si avvia l’espansione delle industrie a maggiore intensità
tecnologica e contemporaneamente lo Stato promuove alti livelli di risparmio e
alti livelli di investimento, garantendo il capitale fisico, finanziario e umano
necessario per uno sviluppo durevole.
L’atteggiamento ottimistico si trasforma in attesa verso i possibili successi di altre
Nazioni in via di sviluppo: è l’America Latina a finire sotto i riflettori, nella
speranza di una replica del successo del cosiddetto Polo confuciano. Tuttavia,
questa non darà i risultati sperati. In quest’area del mondo, i paesi hanno deciso di
adottare una politica basata sulla sostituzione delle importazioni: tale politica si
25
concretizza nello sviluppo dell’industria manifatturiera nazionale, sostituendo i
prodotti che prima venivano importati con prodotti locali. Per ottenere questo
effetto è necessario alzare forti barriere doganali. In sostanza, nelle prime fasi le
strategie sono simili a quelle seguite dalle tigri asiatiche, ma in un secondo stadio
i paesi latinoamericani si sono allontanati dal percorso tracciato per mantenere una
politica protezionistica e chiusa nei confronti del mercato globale, che ha finito
col danneggiare queste economie, soprattutto perché è mancato il re-investimento
del capitale acquisito.
Si sviluppa in questo periodo una nuova sensibilità negli studiosi che porta a
osservare il problema del sottosviluppo dal punto di vista dei paesi che ne sono
protagonisti. Se fino a questo momento le teorie per lo sviluppo si erano
concretizzate nei ricchi Paesi occidentali, dagli anni ’70 sono gli stessi intellettuali
dei Paesi in via di sviluppo che contribuiscono al dibattito sulla possibilità della
crescita economica diffusa.
Ancora una volta i riflettori sono puntati sull’America Latina, dove si sviluppa la
cosiddetta Teoria della dipendenza, frutto dell’evoluzione del pensiero sviluppista.
Come gli economisti dello sviluppo, anche i dependentistas sostengono che lo
sviluppo dei Paesi del Sud non possa avvenire seguendo lo stesso percorso scelto
dai Paesi occidentali. Tuttavia, essi hanno una visione più scettica della volontà
dei Paesi del Nord di assumere un ruolo di guida e sostegno nello sviluppo del
Sud. Facendo riferimento alla critica neomarxista delle relazioni internazionali, la
loro critica principale riguarda i meccanismi di dipendenza che lo sviluppo
capitalistico nei Paesi del Nord crea nei confronti dei Paesi del Sud. Il
sottosviluppo, in sostanza, sarebbe la diretta conseguenza della struttura
economica internazionale. Il libero scambio porta allo sviluppo di relazioni del
tipo centro-periferia, dove il Nord, forte della propria ricchezza economica, è in
grado di esercitare un potere economico, politico e culturale sul Sud, che è legato
a questa dipendenza.
Le soluzioni presentate dai dependentistas si dividono in due tipi di approcci: uno
più moderato, che ammette la possibilità di uno sviluppo mantenendo, in parte, le
relazioni di dipendenza con l’esterno, e uno più radicale, che auspica un netto
taglio ai rapporti con l’economia capitalista a favore di una cooperazione tra i
26
Paesi sottosviluppati, per implementare, anche dal punto di vista politico, una
società socialista.
Anche per la diffusione di queste nuove prospettive, gli anni ’70 passano alla
storia come quelli del rafforzamento dei Paesi del Sud. Il clima culturale,
d’altronde, crea un terreno fertile alle rivendicazioni di questi popoli, in seguito a
due avvenimenti molto importanti: la rivoluzione culturale cinese del 1967 e il
movimento del ’68. Un numero crescente di persone, anche nei Paesi sviluppati,
comincia a movimentarsi a favore delle richieste dei popoli del Sud, basando il
proprio discorso su un semplice assunto, sul quale faranno leva anche i teorici
della dipendenza: non basta palliare gli effetti del sottosviluppo, occorre agire
all’origine, ricercare e correggere le sue cause. Il dibattito si focalizza verso gli
elementi che in seguito saranno chiamati fattori strutturali e istituzionali,
spostando così l’attenzione verso le problematiche più direttamente connesse alla
povertà e allontanandosi dai temi macroeconomici che avevano dominato
l’economia dello sviluppo nelle due decadi precedenti.
Gli anni ’70 vedono così la nascita dei movimenti terzomondisti: anche al Nord si
comincia a dubitare che crescita e prosperità possano essere mantenute, in
particolare dopo la pubblicazione del rapporto Meadows, che per la prima volta
rende pubblici i “limiti della crescita”, e con il verificarsi della crisi petrolifera.
Nel 1974 i Paesi del Terzo Mondo, in una sessione straordinaria dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite da loro richiesta, proclamano la Dichiarazione
relativa all’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale. Scopo
della dichiarazione è quello di rivendicare un nuovo ordine economico fondato
sull’equità, sull’eguaglianza sovrana, sull’interdipendenza, sull’interesse comune
e sulla cooperazione tra tutti gli stati, per correggere le ineguaglianze e rettificare
le ingiustizie, eliminare il fossato che divide i Paesi sviluppati e i Paesi in via di
sviluppo e assicurare la pace e la giustizia per le popolazioni presenti e future.
I Paesi in via di sviluppo richiedono nuove forme di cooperazione, alla luce delle
interdipendenze che i fatti economici del decennio hanno rivelato, nuove regole
del gioco che permettano anche a loro di vincere la scommessa della crescita e
dello sviluppo. Nonostante si faccia riferimento a un nuovo ordine, gli strumenti
richiesti per ottenere il cambiamento sono sempre gli stessi: crescita economica,
27
espansione del commercio internazionale e aumento dell’aiuto economico da parte
dei Paesi occidentali. In realtà, invece di contrastare il modello capitalistico,
questa rivendicazione dei Paesi in via di sviluppo non fa che rafforzarlo: quello
che in concreto si chiede è una maggiore integrazione dei mercati periferici nel
sistema, al fine di garantirne la crescita continua. Ma questo, lungi dal ridurre la
distanza tra centro e periferia, non fa che aumentarla, garantendo mercati più ampi
al Nord del mondo attraverso l’erogazione di prestiti, l’iniezione di investimenti,
la possibilità di inviare tecnologie e nuovi prodotti nel Sud del mondo, che vede
così aumentare la propria dipendenza.
In realtà, l’approccio del Nuovo ordine economico internazionale non ha vita
lunga: in primo luogo la crisi petrolifera ha diminuito di molto le potenzialità di
aiuto dei Paesi occidentali e, in seconda battuta, la proposta dei Paesi in via di
sviluppo presuppone di ridurre di molto l’ingerenza politica nei loro paesi da parte
del Nord del mondo, questione che viene sicuramente poco apprezzata da questi
ultimi. Questa è stata anche una delle ragioni per cui, negli stessi anni, prende
piede la Teoria dei bisogni fondamentali, proposta da Robert McNamara di fronte
al Consiglio dei governatori della Banca Mondiale nel 1972. L’idea è molto
semplice: le priorità dello sviluppo devono essere definite a partire prima di tutto
dai bisogni fondamentali dell’uomo, quali cibo, riparo, ambiente sano, lavoro e
istruzione. Questo modello consente alla Banca Mondiale di dribblare il problema
dell’ingerenza negli Stati del Sud, intervenendo per motivi umanitari proprio in
quei settori che garantiscono comunque un controllo sullo Stato, e di ottenere allo
stesso tempo l’approvazione delle organizzazioni non governative che si
occupano di sviluppo.
1.3.3 Gli anni ’80: la Teoria dell’aggiustamento strutturale
Le difficoltà dei Paesi del Sud di convergere e sostenere alti livelli di crescita
economica è scoppiata nel suo aspetto più devastante nel 1982, quando il Messico
si è trovato di fronte a una crisi finanziaria che il sistema economico
internazionale non è stato in grado di gestire seguendo le politiche tradizionali. La
crisi (conosciuta come la crisi del debito) si è diffusa poi dal Messico in quasi tutti
28
i Paesi non industrializzati. Le radici della crisi sono da ricercare negli shock
petroliferi del 1973 e del 1979, che, causando forti disavanzi nella bilancia dei
pagamenti dei Paesi del Sud, li costringe a ricorrere a forti indebitamenti con le
banche dei Paesi ricchi. La decisione delle Federal Reserve di alzare i tassi di
interesse sui prestiti, per sconfiggere l’elevato tasso di inflazione che sta
minacciando
l’economia
statunitense,
rende
la
situazione
sempre
più
insostenibile: per i Paesi del Terzo Mondo gli interessi sui prestiti diventano
praticamente impossibili da pagare. In un certo senso, questa crisi diffusa segna il
fallimento della strategia della sostituzione delle importazioni e dell’approccio che
ha accreditato allo Stato una significativa importanza (come agente che prendeva i
prestiti). Alla fine del decennio, con il crollo del Muro di Berlino e la
disgregazione dell’URSS, crolla anche l’idea che uno Stato interventista possa
produrre crescita e progresso.
Il contesto della crisi del debito ha agevolato l’ascesa del neoliberismo e del suo
successivo trionfo. La rinascita di questo approccio segnala un ritorno ai principi
di base della teoria della crescita, accompagnato da un durissimo attacco contro
l’approccio keynesiano e contro l’economia dello sviluppo, accusati di aver fallito
nelle loro ricette per la crescita e di essere causa dell’attuale situazione.
Secondo il nuovo approccio, la teoria economica è una sola. In altre parole,
l’economia deve essere percepita come una scienza universale, applicabile a tutte
le società. L’enfasi viene posta sulla razionalità degli individui, sul principio di
utilità marginale e sull’importanza dei prezzi relativi, stabiliti con il meccanismo
di domanda e offerta. Secondo i teorici neoliberisti, il sottosviluppo è il risultato
dell’intervento pubblico: essi sottolineano non i fallimenti del mercato, ma quelli
dello Stato, a cui imputano la responsabilità dei tassi di inflazione eccessivamente
alti e gli enormi debiti pubblici. Secondo la teoria neoliberista, lo Stato dovrebbe
fare affidamento sui fondamenti del mercato, senza alterare artificialmente i prezzi
e aprendo il mercato alla concorrenza internazionale. Tali politiche furono
effettivamente messe in pratica, negli anni ’80, da Ronald Reagan negli USA e da
Margaret Thatcher in Gran Bretagna.
Nel contesto della grave crisi internazionale, l’approccio neoliberista avvia una
nuova strategia per risolverla: di fronte al disordine monetario occorre
29
“aggiustare” le economie e in particolare risanare le bilance dei pagamenti,
operando mirate riforme strutturali. L’approccio prende corpo quando, nel 1985,
James Baker, Ministro del tesoro USA, lancia la dottrina dell’aggiustamento
strutturale: secondo tale dottrina, un paese debitore che richiede l’assistenza del
Fondo monetario internazionale o della Banca mondiale, deve prima impegnarsi a
realizzare diverse riforme macroeconomiche, soprattutto nel settore pubblico, per
ridurre il peso dello Stato nell’economia.
Tali interventi, in paesi dalla struttura sociale debole, portano spesso a
conseguenze devastanti sulla popolazione: nel nome del liberismo, lo Stato è
costretto a operare tagli consistenti nel settore dell’istruzione, della sanità e del
welfare, a sfavore dei settori più deboli di nazioni già provate dalla povertà diffusa
(Stiglitz, 2002).
Dalla fine degli anni sessanta, il dibattito sul Terzo Mondo costituiva in larga
misura
una
prerogativa
degli
intellettuali
di
sinistra:
la
critica
all’occidentalizzazione, considerata responsabile degli insuccessi dello sviluppo si
accompagnava alle proposte di uno sviluppo autocentrato e alla difesa delle
popolazioni indigene.
Con la crisi degli anni ottanta e con il perseguire del successo delle tigri asiatiche,
il liberismo torna in auge, accusando il terzomondismo di vittimizzare il Sud e
accusare il Nord, senza portare a risultati concreti. Il problema dello sviluppo
viene integrato nell’economia ordinaria e smette di essere un’emergenza; i
programmi per lo sviluppo vengono sostituiti dagli aiuti umanitari e dagli
interventi delle organizzazioni non governative.
Un nuovo aspetto dello sviluppo emerge negli anni ’80, quello ambientale, portato
alla luce dei riflettori con la pubblicazione del rapporto Bruntland, stilato nel 1987
da una commissione di specialisti dell’ambiente. Questo documento ha il merito
di aver prodotto un inventario quasi esaustivo dei problemi che minacciano
l’equilibrio ecologico del pianeta: deforestazione, degrado dei suoli, effetto serra,
buco dell’ozono, demografia, catena alimentare, approvvigionamento idrico,
energia, urbanizzazione, estinzioni, protezione dell’oceano e dello spazio. La
commissione Bruntland ha il compito di mettere in evidenza i diversi modi in cui
le Nazioni ricche come quelle povere recano danni all’ambiente; occorre
30
conciliare due nozioni antitetiche: il problema ecologico e il diritto allo sviluppo.
Se, infatti, gran parte del danno ambientale deriva dallo sviluppo industriale, la
crescita dei Paesi in via di sviluppo non può che peggiorare la situazione; d’altra
parte le Nazioni più povere, proprio perché meno sviluppate, hanno meno risorse
da destinare alla protezione ambientale e allo stesso tempo reclamano il loro
diritto a uno sviluppo pari a quello occidentale.
Nasce così il concetto di “sviluppo sostenibile”, definito dalla Commissione come
sviluppo che permette di soddisfare i bisogni presenti senza compromettere le
necessità future.
Si possono dare due interpretazioni di sviluppo sostenibile: la prima mette al
centro l’ecologia e presuppone uno sviluppo che permetta di non giungere al
termine delle risorse naturali, riducendo la produzione a un volume sopportabile
per l’ambiente; la seconda interpretazione mette al centro l’economia, confidando
in uno sviluppo sostenibile che significhi sviluppo durevole, universale ed eterno.
Questa seconda interpretazione non fa che riprendere l’idea che lo sviluppo sia
essenzialmente crescita economica, una crescita senza limiti che manca di
considerare tutti i fattori non mercantili che caratterizzano la vita umana e del
pianeta.
1.3.4 Dagli anni ’90: lo Sviluppo umano
Negli anni novanta, il concetto di sviluppo viene associato all’aggettivo “umano”.
Lo sviluppo non è più visto in un’ottica puramente economica, ma ridimensionato
a misura d’uomo, prendendo in considerazione la speranza di vita, la possibilità di
istruirsi, l’accesso a risorse che permettano di condurre una vita conveniente e
dignitosa. Dal 1990 l’ONU, tramite l’UNDP (United Nations Development
Programme), pubblica annualmente un rapporto sulla dimensione umana dello
sviluppo. Il Rapporto sullo sviluppo umano è il risultato di una forte presa di
coscienza e della riscoperta di un dato essenziale: l’uomo è il fine ultimo dello
sviluppo, non un mezzo per creare ricchezza e crescita economica. Nell’ottica di
questi rapporti, se la crescita del Pil è considerata obiettivo intermedio e
indispensabile, diventa di fondamentale importanza studiare il modo in cui questa
31
crescita, in società differenti, si traduca – o manchi di tradursi – in sviluppo
umano. In questa prospettiva si colloca la necessità di un migliore rapporto tra
crescita economica e sviluppo umano, rapporto che non va considerato
automatico. Nonostante molti sostengano che l’indice sviluppato nei rapporti di
sviluppo umano non cambi radicalmente la posizione di un paese nella classifica
mondiale, tale indice aiuta a ridefinire un ordine di priorità nella spesa pubblica.
Infatti, l’esperienza insegna che raggiungono un livello accettabile di sviluppo
umano quei paesi che destinano mediamente il 20% della loro spesa pubblica al
soddisfacimento dei bisogni più basilari dello sviluppo umano (servizi sociali
come l’istruzione elementare e l’assistenza medica di base). È in quest’ottica che i
Rapporti dell’UNDP hanno cercato di indicare strategie politiche adeguate per
l’attuazione degli auspicati cambiamenti. Le considerazioni degli economisti sui
mezzi necessari a raggiungere elevati standard di crescita hanno offuscato il fatto
che l’obiettivo principale dello sviluppo è quello di offrire vantaggi alle persone,
non solo in termini di crescita del reddito. Naturalmente, tra i vari fattori che
migliorano il livello di vita delle persone, vi è anche un reddito maggiore ma,
come si sostiene nel Rapporto sullo sviluppo umano del 1991, “il reddito non è la
somma totale della vita dell’uomo”. Perciò, sostiene lo stesso Rapporto, “lo
sviluppo umano è un processo di ampliamento delle scelte delle persone e del
livello di benessere da loro raggiunto”.5 Le tre opzioni considerate essenziali per
lo sviluppo umano sono: 1) la possibilità di condurre una vita lunga e sana, 2) la
possibilità di acquistare conoscenze e 3) l’accesso alle risorse necessarie per
condurre una vita dignitosa. Nell’analisi condotta dall’UNDP vengono
subordinate alla disponibilità di questi requisiti minimi tutte le altre opzioni che
possono migliorare la qualità della vita. Lo sviluppo umano, comunque, non si
ferma a questa prima sintetica definizione. Una più ampia definizione comprende
una serie di opzioni aggiuntive quali la libertà politica, economica e sociale, la
garanzia dei diritti umani, la possibilità di essere creativi o produttivi e di godere
di autostima. Da quest’analisi deriva che il reddito è solo una delle tante
componenti o opzioni che le persone dovrebbero avere. Analizzando l’esperienza
di diversi paesi è possibile osservare come non esista un collegamento automatico
5
UNDP, 1991, “Rapporto sullo sviluppo umano n. 2”, Rosenberg & Sellier, Torino
32
tra crescita economica e sviluppo umano. Il rapporto tra queste varianti si trova
nel fatto che persone istruite e in buona salute possono, attraverso un’occupazione
produttiva, contribuire maggiormente alla crescita economica. In quest’ottica, la
crescita economica rimane di fondamentale importanza: “se il fine dello sviluppo
non è la crescita, l’assenza di crescita spesso ne rappresenta la fine”.6 Tuttavia,
essa non deve essere considerata come un mero incremento contabile, ma deve
possedere delle caratteristiche che la rendano più a misura d’uomo. Una crescita è
auspicabile se è:
–
partecipata, cioè se lascia ampi margini all’iniziativa individuale e
coinvolge il maggior numero di persone possibile;
–
ben distribuita, in modo che i vantaggi raggiungano tutti i membri della
collettività (equità intra-generazionale);
–
sostenibile, cioè che l’aumento della produttività odierna non infici la
produttività futura (equità inter-generazionale).
Ciascun paese avrà la propria strategia d’azione per implementare lo sviluppo
umano, ma il principio di fondo sarà uguale per tutti: mettere le persone al centro
dello sviluppo e concentrarsi sulle loro necessità e sul loro potenziale.
6
UNDP (1991), cit.
33
1.4 Fallimento del progetto
Nonostante numerose teorie e svariati tentativi di ridurre la miseria e la povertà
che affliggono il Terzo Mondo, la situazione odierna non è rosea. La scommessa
dello sviluppo, resa ancora più appetibile dalla globalizzazione, non ha portato i
frutti sperati. La povertà, negli ultimi due decenni, è aumentata. Circa il 40% della
popolazione del pianeta vive in povertà (un numero aumentato del 36% rispetto al
1981), mentre un sesto – vale a dire più di 877 milioni di persone – vive in
estrema povertà (il 3% in più rispetto al 1981). La situazione più grave si registra
in Africa, dove la percentuale di popolazione che vive in estrema povertà è
aumentata dal 41,6% del 1981 al 46,9% del 2001. Considerando la crescita della
popolazione questo significa che le persone che vivono in estrema povertà sono
quasi raddoppiate, da 164 a 316 milioni (Stiglitz, 2006).
Quali sono le ragioni che hanno portato al fallimento di questo progetto grandioso
e a prima vista benefico per l’umanità? Il punto di partenza per capire la
situazione odierna è la profonda estraneità ambientale, economica, culturale e
sociale delle realtà in cui lo sviluppo voleva essere implementato. I fautori dello
sviluppo hanno dimenticato di considerare le profonde differenze che
caratterizzano i paesi e le culture del mondo, appiattendo le nazioni sul modello
dell’utilitarismo occidentale.
Per prima cosa, occorre considerare l’Europa. Non è un caso che lo sviluppo
capitalistico sia nato nel vecchio continente: sono state le condizioni istituzionali e
ambientali a permettere la rivoluzione industriale e lo straordinario sviluppo delle
nazioni europee. Esse hanno potuto contare, per la propria modernizzazione, su
un’incomparabile posizione di dominio commerciale e militare sul resto del
mondo: le materie prime del globo intero erano a disposizione della nascente
industria di pochi paesi, a prezzi irrisori.
L’Europa ha potuto contare su una situazione climatica e ambientale che, in gran
parte del resto del mondo, costituisce invece un ostacolo pesantissimo alla crescita
economica di tipo capitalistico. Il clima temperato, le piogge ben distribuite nel
corso dell’anno, ricchi corsi d’acqua facilmente sfruttabili, la preziosa alternanza
delle stagioni, terreni non facilmente erodibili per effetto del disboscamento: tutte
34
queste condizioni hanno costituito un mix vantaggioso che difficilmente si ritrova
nei Paesi del Sud del mondo. Basta pensare all’esempio dei suoli: in Europa, nel
corso dei secoli, milioni di ettari sono stati sottratti a boschi e foreste e trasformati
in fertili campi; nei Paesi del Sud del mondo, molto spesso le aree disboscate si
trasformano rapidamente in lande aride e sterili, lasciando spazio all’avanzare del
deserto.
Le differenze non si fermano qui. Tra Nord e Sud, è stato l’ambiente più
vantaggioso quello che ha anche ricevuto maggior tutela e protezione. In Europa,
una tradizione giuridica antica ha salvaguardato l’interesse pubblico e tutelato, da
un lato, le popolazioni dai potenziali danni delle alterazioni ambientali, dall’altra,
ha protetto l’ambiente stesso, conservando foreste e boschi. Naturalmente, anche
nel vecchio continente l’impatto antropico ha prodotto e sta producendo danni
rilevanti, ma essi sono comunque frutto di un compromesso continuo tra
l’interesse pubblico – tutelato dalle municipalità e dagli Stati centrali – e quello
delle imprese. La società civile è riuscita a imporsi per controllare, in qualche
modo, la salubrità e la bellezza del suo territorio, affinché esso non venisse
sfruttato a soli fini economici, ma conservasse le sue caratteristiche di vivibilità.
Questo aspetto è del tutto assente nei paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America
Latina. Le culture indigene, che pure guardavano alla natura come a un mondo
sacro, non sono state in grado di proteggere e sottrarre le risorse naturali al
saccheggio secolare delle potenze coloniali, nessuna tradizione giuridica le ha
protette e anzi, esse sono diventate le miniere per lo sviluppo dell’Occidente.
Esiste ancora un terzo aspetto su cui occorre riflettere. Lo sviluppo capitalistico
europeo, sebbene si sia manifestato in modo dirompente con la rivoluzione
industriale, è in realtà frutto di un processo secolare, che ha preparato il terreno a
una rivoluzione non solo economica, ma anche sociale. Le istituzioni erano pronte
ad accogliere il capitalismo, perché esso è il frutto di una cultura e di una struttura
sociale che si sono sviluppate in secoli di storia; la rivoluzione industriale si è
modellata su scenari ambientali e su stratificazioni culturali che ne hanno attutito
e diluito l’impatto.
Nei Paesi del Sud del mondo, dove lo sviluppo è stato imposto, non si è avuta una
crescita simultanea delle istituzioni sociali: le nazioni, già gravate dallo
35
sfruttamento di secoli di colonizzazione, sono state costrette ad accettare
programmi di sviluppo capitalistico che non sono conseguenza del lungo corso
dell’evoluzione storica delle loro terre e del loro popolo, che non hanno nessun
legame con il loro passato, ma che sono studiate a Washington, negli uffici della
Banca mondiale o del Fondo monetario internazionale, a volte nei consigli di
amministrazione di potenti società transnazionali. Questi nuovi centri di potere
sono del tutto estranei alla storia e alla cultura dei paesi dove pretendono di
imporre i loro programmi di sviluppo e non tengono in alcun conto, né sono
disposti ad attendere, l’evoluzione storica naturale delle economie locali. Ma lo
sviluppo è molto spesso totalmente estraneo a questi contesti, prova ne è il fatto
che molte culture non europee non hanno una parola che possa tradurre questo
concetto: una tribù della Guinea equatoriale utilizza un termine che significa allo
stesso tempo crescere e morire; in Ruanda la parola è composta a partire da un
verbo che significa “spostarsi senza alcuna direzione particolare”; per la tribù
degli Wolof sviluppo viene tradotto come “la voce del capo”, mentre la
traduzione forse più eloquente per esprimere l’estraneità del termine sviluppo
nella propria cultura è rappresentata dalla locuzione utilizzata dagli Eton del
Camerun: “il sogno del bianco”.
Per l’Occidente, invece, la problematica dello sviluppo è iscritta molto
profondamente nell’immaginario collettivo, tanto che l’idea di progresso e di
crescita economica si sono diffusi ovunque come un’anticipazione di un futuro
necessariamente migliore, grazie all’aumento costante dei beni. Molto del
successo della parola sviluppo è dovuto all’invenzione del suo concetto opposto,
sottosviluppo,
creando
una
dicotomia
bene/male
che
ha
portato
alla
stigmatizzazione di ogni tipo di economia che non si basasse sul neoliberismo e
sulla crescita continua di beni e ricchezza.
Il paradigma dello sviluppo si è trasformato in una credenza, elemento centrale di
una religione moderna che fonda il suo credo sulla crescita infinita (Rist, 1997).
Come spiega Durkheim: “la religione è una cosa eminentemente sociale. Le
rappresentazioni religiose sono rappresentazioni collettive che esprimono realtà
36
collettive”;7 si tratta cioè di visioni della realtà, accettate a livello collettivo,
comprese da tutti e facenti parte dell’immaginario di un’intera cultura. Il filosofo
elimina dalla definizione tutti i riferimenti al soprannaturale, al mistero, alla
divinità, interpretando le religioni per quello che emerge dall’osservazione della
loro pratica: credenze, miti, comunità. La religione diventa il fatto di credere, per
un determinato gruppo sociale, a certe verità indiscutibili, che determinano
comportamenti che garantiscono la coesione sociale.
Nonostante sia opinione comune considerare la società moderna come diversa
dalle precedenti, estranea alle visioni fideistiche e profondamente secolarizzata e
razionale, Rist sostiene che ogni società sia fondata su credenze e tradizioni di
natura differente da quelle del passato, ma dotate della stessa forza attrattiva e
pervasiva. Le realtà ecclesiali hanno effettivamente perso il monopolio
nell’ambito delle credenze condivise, ma esse non sono scomparse: sono
semplicemente migrate verso altri ambiti, da sempre definiti profani. Le credenze
si situano al di là di ogni contestazione, e per questo non vanno confuse con
l’ideologia: quest’ultima, infatti, può essere discussa, mentre una credenza è una
certezza collettiva, considerata vera in modo diffuso.
Lo sviluppo, sinonimo di crescita economica, può essere annoverato tra le
credenze moderne, tanto che cinquant’anni di fallimenti nella ricerca della sua
realizzazione non hanno scalfito la sua forza, e oggi il concetto di sviluppo è
mondialmente diffuso, anche nei paesi dove ancora non si è realizzato. La fede
nella crescita considera l’aumento di utilizzo delle risorse al Nord come una
soluzione per la povertà del Sud: il Sud può crescere solo se può esportare verso i
mercati del Nord e se può ricevere dal Nord forti investimenti. Ma il Nord può
fornire investimenti e importare dal Sud solo se cresce a sua volta.
Tuttavia, nel corso degli anni, il progredire della crescita economica in Occidente
e la lenta adeguazione dei Paesi in via di sviluppo hanno portato alla ribalta un
altro problema legato allo sviluppo. Dopo la constatazione che i numerosi sforzi
per diffondere l’industrializzazione e la ricchezza nel Terzo Mondo non stanno
ottenendo i successi sperati, ha cominciato a diffondersi anche l’idea che lo
7
Durkheim E., Le forme elementari della vita religiosa, 1912, citato in Rist G., 1996, Lo sviluppo.
Storia di una credenza occidentale, Torino, Bollati Boringhieri
37
sviluppo abbia, anche per i Paesi occidentali, dei limiti, legati alle risorse naturali
e alla disgregazione sociale prodotta dal consumismo e dal mito della crescita.
38
Capitolo 2
I LIMITI DELLO SVILUPPO
2.1 L’esaurimento delle risorse naturali e il problema ambientale
Il problema del possibile esaurimento delle risorse ha iniziato a meritare
l’attenzione di esperti e dell’opinione pubblica soprattutto a partire dagli anni ‘70,
quando la crisi petrolifera e la crescente degradazione dell’ambiente, sia a livello
locale sia a livello planetario, hanno cominciato a mostrare i loro effetti.
Il dibattito si concentra sulle ipotesi relative alle entità delle varie risorse e porta a
risultati molto differenti, in base al diverso peso che i vari studiosi danno alle
potenzialità del progresso tecnologico, alla capacità dell’ecosistema di sopportare
l’attività antropica, portando a una contrapposizione tra “ottimisti” e “pessimisti”.
Con il termine risorse naturali si è soliti indicare l’insieme di tutte le materie
prime presenti in natura, potenzialmente utilizzabili dall’uomo per produrre merci
che soddisfino le sue necessità e i suoi desideri. Questa definizione, tra le più
ampie di questo termine, comprende sia le risorse economicamente sfruttabili con
le tecnologie disponibili, sia quelle che potrebbero diventarlo in seguito a
mutamenti economici o tecnologici. Tra le risorse, così definite, occorre anche
annoverare i cosiddetti “servizi ecologici essenziali”, ovvero quei servizi
immateriali (e difficilmente quantificabili) che la natura ci offre gratuitamente,
quali il clima, il patrimonio naturalistico, il ciclo dell’acqua, la regolazione della
composizione dell’atmosfera, che permettono la vita sulla Terra e supportano le
attività umane.
Le risorse naturali vengono distinte in due gruppi: le risorse non rinnovabili, che
sono non naturalmente riproducibili, anche se molte possono essere in diversa
misura riciclate, e le risorse rinnovabili, che si possono riprodurre secondo i loro
cicli naturali. Questa distinzione è fatta su tempi umani, per cui tra le risorse non
rinnovabili si annoverano, oltre ai minerali, anche i combustibili fossili che, pur
essendo di natura organica e quindi riproducibili, lo sono solo in tempi geologici,
inutili all’uomo. Sono invece considerate risorse rinnovabili la terra coltivabile, il
39
clima, le risorse idriche, l’energia solare. Questi elementi condizionano, insieme
ai cicli biologici di riproduzione e di crescita, la disponibilità delle altre risorse
rinnovabili, data da tutte le sostanze di origine animale e vegetale. Occorre
sottolineare che, a parte l’energia solare, che costituisce un flusso pressoché
inesauribile, anche le risorse rinnovabili non sono disponibili in quantità infinite:
il loro uso o prelievo indiscriminato ne può pregiudicare la qualità (e quindi
l’utilità) o mettere in serio pericolo i cicli di riproduzione (come dimostrano le
estinzioni).
La consapevolezza che, essendo la Terra un mondo finito (o un sistema chiuso),
tutte le risorse sono limitate è un’acquisizione abbastanza recente. In passato il
nostro pianeta sembrava talmente vasto, rispetto alle necessità e alle esigenze
della popolazione umana, da non destare preoccupazioni per l’eventuale
esaurimento delle materie prime; il concetto di scarsità veniva quindi inteso
soprattutto in termini relativi. E’ con la rivoluzione industriale e con l’aumento
esponenziale della popolazione che il mondo sembra diventare sempre più
piccolo.
Il dibattito sulla scarsità assoluta delle risorse porta inevitabilmente a domandarsi
se, e fino a quando, lo sviluppo economico è compatibile con i limiti fisici e
ambientali del nostro pianeta, ma porta anche a chiedersi rispetto a quale modello
di sviluppo è lecito parlare di scarsità delle risorse. Ancora una volta, anche in
questo contesto, parlare di sviluppo e dei suoi limiti significa riferirsi a una
concezione tipicamente occidentale e storicamente collocabile dopo la rivoluzione
industriale. Un dibattito di questo tipo sarebbe stato impensabile in epoche o
contesti culturali pre-industriali dove, come visto in precedenza, dominavano
ideologie mistiche, sorrette da elaborazioni dottrinarie di carattere teologico. Allo
stesso modo, la problematica dei limiti dello sviluppo, risulta abbastanza estranea
alle popolazioni del Sud del mondo che in realtà subiscono, sul loro territorio, una
situazione dovuta allo sfruttamento delle risorse a favore dell’Occidente. Infatti, il
modello di sviluppo a cui ci si riferisce è ancora, nonostante le possibili aperture
agli aspetti qualitativi, strettamente correlato al progresso e al successo
economico, visti come obiettivi fondamentali della società. Questi obiettivi non
40
sono stati raggiunti da gran parte della popolazione umana, tuttavia il problema
ambientale è ormai un problema globale.
Oltre all’esaurimento delle risorse, lo sviluppo deve fare i conti con un sempre
crescente inquinamento che colpisce il pianeta sia a livello locale e settoriale che a
livello globale.
I diversi settori che compongono l’economia hanno differenti impatti
sull’ambiente, ma nessuno sfugge a questa prerogativa: ogni attività umana
influisce sullo stato di salute della Terra.
Il settore agricolo causa in particolare tre generi di problemi: riduzione della
capacità produttiva futura del terreno, inquinamento delle falde acquifere per l’uso
massiccio di pesticidi e fertilizzanti, progressiva erosione dei suoli e diminuzione
della biodiversità a causa dell’agricoltura estensiva.
L’attività industriale produce effetti su tutti i settori ambientali: aria, acqua,
produzione di rifiuti e rumore. Nei Paesi industrializzati, nonostante le attività
siano più numerose, le tecnologie e la diffusione della sensibilità rispetto ai
problemi ambientali hanno in parte limitato l’impatto delle attività produttive
sugli ecosistemi. Nei Paesi in via di sviluppo, invece, la rincorsa del modello
occidentale, senza gli opportuni aggiustamenti, rende l’impatto ambientale molto
più elevato sia in termini di inquinamento che in termini di esaurimento delle
risorse.
Il settore energetico, sia nella fase di produzione che nella fase di consumo, rivela
un impatto ambientale potenzialmente molto elevato. In particolare, la
combustione delle fonti energetiche causa emissioni in atmosfera di agenti
inquinanti quali l’anidride carbonica, gli ossidi di azoto, le polveri sottili e metalli
pesanti. Strettamente correlato al settore energetico è il settore dei trasporti. Se nei
Paesi occidentali si stanno introducendo strumenti di varia natura per limitare gli
effetti dell’inquinamento atmosferico derivanti dalle emissioni dei mezzi di
trasporto, anche in questo caso i Paesi in via di sviluppo contribuiscono in
maniera massiccia all’inquinamento, soprattutto perché in questi paesi non sono
ancora diffuse delle tecnologie in grado di abbattere le emissioni.
La diffusione del modello occidentale nei Paesi in via di sviluppo sta rendendo il
problema dell’inquinamento sempre più serio. Mentre nei Paesi industrializzati la
41
sensibilità verso l’ambiente è sempre in aumento e le aziende tendono a mostrare
un volto sempre più “verde”, nei Paesi in via di sviluppo le problematiche sociali
gravi e la necessità di inseguire la crescita portano a trascurare il problema
ecologico. Questo si traduce in un inquinamento massiccio delle nuove aree
industrializzate e un continuo deterioramento della qualità e della quantità delle
risorse naturali. I Paesi in via di sviluppo non hanno, in questo momento, né
l’incentivo, né la tecnologia, né le risorse per intervenire in ambito ambientale.
Tuttavia, il patrimonio ecologico non è infinito e, nonostante dimostri di
possedere un’eccellente capacità di adattamento e di reazione, è pur sempre una
risorsa limitata, ma indispensabile per la vita umana.
42
2.2. La teoria economica delle risorse naturali
La storia economica dei secoli precedenti alla rivoluzione industriale evidenzia
come la disponibilità di terra arabile costituisse uno dei principali vincoli alla
crescita della popolazione. Lo sviluppo delle città, delle attività manifatturiere e
commerciali era direttamente correlato alla produttività agricola, legata al lento
progredire delle tecniche di coltivazione e limitata dall’estensione delle terre
coltivabili. Per questi motivi, i primi pensatori economici non ebbero difficoltà a
dedicare spazio, nei loro trattati, alle risorse naturali, e in particolare alla terra
coltivabile.
Per i fisiocrati, la terra è l’origine del sovrappiù economico: solo l’attività agricola
consente di produrre fisicamente nuovi elementi nel mondo dei beni. Il prodotto
netto può essere considerato come l’energia biologica, ovvero quell’energia che
muove gli uomini e gli animali e che le piante immagazzinano sfruttando l’energia
solare tramite la fotosintesi clorofilliana. I fisiocrati vedono nella prosperità
dell’agricoltura la ricchezza di una nazione, ma questo non può essere interpretato
come un’idea di limite della crescita, soprattutto perché non è presente, in questi
autori, il concetto di accumulazione del prodotto netto e l’idea stessa di sviluppo
economico.
Sono gli economisti classici, con l’elaborazione del principio dei rendimenti
decrescenti e della teoria della rendita differenziale, a individuare nei limiti
produttivi della risorsa terra un vincolo allo sviluppo economico. Mentre Smith
insisteva sulla producibilità pressoché assoluta, senza limiti, di merci e mezzi di
produzione e Malthus prospettava la scarsità assoluta delle risorse agricole
rispetto all’incremento della popolazione, Ricardo formulò la teoria della scarsità
relativa. Il fenomeno dei rendimenti decrescenti è definito come il principio
secondo cui, col progredire della coltivazione, la produzione agricola diviene via
via più dispendiosa, questo a causa del limite quantitativo dei terreni coltivabili,
ma anche per la differente qualità nella fertilità dei terreni. Questo concetto può
essere esteso a tutte le risorse naturali: man mano che una materia prima viene
utilizzata, sarà necessario cercare altre fonti, spesso più costose, così come con
l’incremento della popolazione è necessario iniziare a sfruttare terreni sempre
43
meno fertili, con una diminuzione dei rendimenti. La possibilità di contrastare la
tendenziale caduta del saggio di profitto è individuata nella meccanizzazione e nel
miglioramento tecnologico.
Gli economisti classici pensavano che l’economia sarebbe giunta naturalmente a
uno stato stazionario, con salari a livello di sussistenza e il sovrappiù totalmente
destinato ai proprietari terrieri in forma di rendita, senza che restasse nulla per il
profitto del capitalista e quindi nessuna motivazione per ulteriore crescita. Questo
punto di arrivo era temuto dalla maggior parte degli economisti classici (ma anche
dai pensatori attuali) come la fine del progresso, mentre J. S. Mill rappresentava
all’epoca la voce fuori dal coro. L’economista inglese, infatti, non condivide il
pessimismo dei suoi contemporanei e predecessori, ma anzi auspica questo stato,
riconoscendo che una condizione stazionaria del capitale e della popolazione non
implica affatto uno stato stazionario del progresso umano, perché, in effetti, vi
sarebbe una maggiore possibilità di perfezionare l’arte della vita, se le menti
umane non fossero più assillate dalla gara per la ricchezza.
Con la rivoluzione industriale l’idea di uno stato stazionario viene relegata in
soffitta. L’economia neoclassica, con la sua teoria soggettivista del valore, ha
spostato l’attenzione dalle risorse e dal lavoro verso l’utilità, lo scambio e
l’efficienza. I fattori fisici sono stati spinti sullo sfondo. A differenza degli
economisti classici, la teoria economica standard attuale parte da parametri non
fisici (tecnologia, preferenze, distribuzione del reddito sono presi come dati) e
indaga il modo in cui le variabili fisiche, e cioè le quantità di beni prodotti e di
risorse utilizzate, devono modificarsi per soddisfare un equilibrio (o un tasso di
crescita di equilibrio) determinato da quei parametri non fisici. Le condizioni
qualitative, non fisiche, sono date e le grandezze quantitative, fisiche, vi si devono
adattare. Nella teoria neoclassica tale “aggiustamento” comporta quasi sempre
crescita economica.
C’è un semplice schema che permette di comprendere la differenza tra la teoria
neoclassica e gli economisti che parlano di stato stazionario, tornato oggi alla
ribalta a causa del problema ambientale sempre più evidente: l’economia può
essere rappresentata come una scatola, un quadrato etichettato “economia” con
una freccia in entrata etichettata “input” e una freccia in uscita etichettata
44
“output”. Questa è la visione standard dell’economia, un mondo a se stante, senza
rapporti con il sistema che la contiene. Esiste un modo differente di vedere
l’economia, che consiste in un semplice gesto: tracciare intorno al quadrato
“economia” un quadrato più grande, etichettato “ambiente” che comprenda anche
le frecce di input e output. Il significato è semplice, ma comporta una visione
delle cose estremamente differente: l’economia è un sottoinsieme dell’ambiente e
dipende da esso sia come fonte di input di materie prime che come bacino
ricettivo per gli output di rifiuti.
45
2.3 Il rapporto del M.I.T.
Nel 1970, il Club di Roma affidò a J. Forrester e D. Meadows, entrambi studiosi
di dinamica dei sistemi del Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), il
compito di elaborare uno studio per estrapolare il futuro andamento dello sviluppo
economico mondiale alla luce delle crescenti interdipendenze e interazioni di
cinque fattori critici: l’aumento della popolazione, la produzione di alimenti,
l’industrializzazione, l’esaurimento delle risorse naturali e l’inquinamento. Con
uno staff di ecologisti, demografi ed economisti, chiamato System Dynamics
Group, venne elaborato un modello, presentato con il titolo “The Limits to
Growth”.
Lo studio parte dal presupposto che la crescita della popolazione mondiale e lo
sviluppo economico-industriale si basano sulla disponibilità di fattori materiali, i
quali possono essere limitati dalla dinamica degli altri tre fattori analizzati: la
produzione di alimenti, l'esaurimento delle risorse naturali e l'inquinamento.
Certamente non si dimentica l'esistenza di fattori sociali, i quali non sono
comunque suscettibili di stima o previsione e quindi non inseribili in un modello.
In apertura, lo studio offre una panoramica della situazione dei vari fattori:
all’epoca della realizzazione dell’indagine il quadro mondiale era il seguente. A
partire dal 1650 la popolazione del pianeta è aumentata in maniera esponenziale e
nel 1970 ammontava a 3,6 miliardi, con la tendenza a crescere a un tasso del 2,1%
annuo. La produzione mondiale mostra una crescita ancora più rapida di quella
della popolazione, ma questo sviluppo è concentrato nei Paesi già industrializzati,
al contrario di quanto avviene per la crescita demografica. La superficie di terra
coltivabile in tutto il globo ha un’estensione massima di 3,2 miliardi di ettari;
anche supponendo di quadruplicare la produttività agricola e di limitare che le
città sottraggano spazio ai terreni coltivabili, la continua crescita della
popolazione porterà, nel 2100 a scontrarsi con questo limite. Lo stock di capitale
necessario alla produzione di alimenti deve aumentare, ma è strettamente legato
alla disponibilità di materie prime non rinnovabili. Il rapporto stima, utilizzando i
dati del Bureau of Mines degli Usa sulle riserve allora conosciute, la durata
prevedibile di alcune materie prime, ipotizzando un tasso di consumo costante.
46
Gli studiosi erano però consapevoli che lo scenario più probabile deve prevedere
una crescita esponenziale dei consumi. Anche considerando la scoperta di nuovi
giacimenti, fino a quintuplicare le riserve allora conosciute, tutte le risorse non
rinnovabili sembravano destinate a esaurirsi entro un secolo, anche considerando
l’effetto del prezzo come regolatore della scarsità di tali materie prime. Per quanto
riguarda l’ultimo aspetto, l’inquinamento, si evidenzia come esso sia strettamente
legato all’aumento della popolazione e dei consumi. Inoltre la pericolosità del
fenomeno risiede nell’impossibilità di prevedere quale sia il limite degli
ecosistemi nel sopportare il peso dell’inquinamento, fino ad arrivare a un punto di
irreversibilità del fenomeno.
Dopo il quadro generale, il rapporto sviluppa un modello in cui vengono messe in
luce le interdipendenze dei vari fattori tra di loro, in modo da poter prevedere le
possibili evoluzioni future a livello mondiale. Le relazioni riguardano aspetti
economici, socio-psicologici e ambientali. Emergono vari scenari che cambiano in
base alle differenti ipotesi iniziali, che hanno in comune l’esaurimento delle
risorse naturali e il conseguente arresto della crescita economica. Il modello
prospetta la necessità di ridurre, a partire dagli anni ’70, la crescita della
popolazione e dei consumi, per evitare il collasso e stabilizzare la situazione
economica a uno stato stazionario.
Il rapporto del M.I.T. ebbe un grande successo, in particolare grazie agli
avvenimenti storici che si verificarono di lì a pochi anni: la prima crisi petrolifera
del 1973 fu vista da molti come l’avverarsi delle previsioni di Meadows e
Forrester. Per contro, la reazione da parte degli economisti fu decisamente critica.
Il modello fu definito neo-malthusiano e poco attento allo sviluppo tecnologico,
con ipotesi forzate e poco realistiche. Ma è in particolare il ruolo della tecnologia
che sta a cuore agli studiosi di scienze economiche: lo sviluppo scientifico, infatti,
viene interpretato come possibilità reale di superare i limiti fisici delle risorse e
dell’inquinamento, in quanto permetterebbe di trovare nuovi giacimenti, di
sostituire le risorse più scarse, di ovviare al problema ambientale con soluzioni
adatte ad abbattere l’inquinamento.
47
2.4 Il rapporto Brundtland e il concetto di sostenibilità
Nel 1983 le Nazioni Unite convocano una Commissione mondiale per l’Ambiente
e lo Sviluppo, nell’ambito dell’United Nations Environment Programme. La
commissione era stata creata per affrontare la crescente preoccupazione circa
l’incalzante deterioramento dell’ambiente umano e delle risorse naturali e le
conseguenze di tale deterioramento sullo sviluppo economico e sociale. Insieme
alla Conferenza di Rio del 1992, il rapporto della Commissione, conosciuto come
Rapporto Brundtland dal nome della sua presidente, Gro Harlem Bruntdland,
rappresenta una delle tappe fondamentali per prefigurare delle politiche mondiali
verso uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.
Il rapporto della commissione viene pubblicato nel 1987 con il titolo “Our
Common Future” ed è definito da molti come il primo documento in cui appare il
concetto di sviluppo sostenibile. In effetti, nel testo si trova una definizione di
sviluppo sostenibile, così enunciata:
“Il genere umano ha tutti i mezzi per assicurare uno sviluppo
sostenibile,
per
rispondere
ai
bisogni
del
presente
senza
compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i
loro. La nozione di sviluppo sostenibile implica certo dei limiti.
Tuttavia, non si tratta di limiti assoluti, ma di quelli che impone lo
stato attuale delle nostre tecniche e dell’organizzazione sociale,
nonché dalla capacità della biosfera di sopportare gli effetti
dell’attività umana. Ma noi siamo capaci di migliorare le nostre
tecniche e la nostra organizzazione sociale in modo da aprire la
strada ad una nuova era di crescita economica. La Commissione
ritiene che la povertà generalizzata non sia una fatalità. Ora, la
miseria è un male in sé, e lo sviluppo sostenibile significa la
soddisfazione dei bisogni elementari di tutti e, per ciascuno, la
possibilità di aspirare ad una vita migliore. Un mondo che permette la
48
povertà endemica sarà sempre soggetto a catastrofi ecologiche e
altre.”8
La definizione, diventata poi la più diffusa e condivisa, è apparentemente
intuitiva, ma in realtà nasconde implicazioni molto importanti dal punto di vista
economico.
In primo luogo essa introduce il tema della sostituibilità tra fattori di produzione.
La produzione di beni e servizi in un paese è resa possibile dall’uso di fattori di
produzione fisici (il capitale rappresentato dalle macchine), umani (la forza
lavoro) e ambientali (le risorse naturali). Le proporzioni tra questi elementi
possono variare in maniera considerevole fra i paesi, e per uno stesso paese nel
corso degli anni. Essi dipendono da molteplici aspetti; la dotazione naturale, la
tecnologia, il livello di sviluppo, i costi dei vari fattori. La possibilità per le
generazioni future di soddisfare i propri bisogni dipende dalla disponibilità di un
capitale composito come composito è il capitale che questa generazione usa.
Sulla base delle sostituibilità tra i fattori ruotano le varie definizioni di sviluppo
sostenibile che sono state concepite nel corso degli anni. Esistono almeno quattro
posizioni sul tema della sostenibilità: sostenibilità molto debole, sostenibilità
debole, sostenibilità forte e sostenibilità molto forte. Le differenze si basano sul
grado di sostituibilità che viene attribuito alle varie forme di capitale. Nella
prospettiva della sostenibilità molto debole le preoccupazioni ambientali, pur
presenti all’interno delle politiche di sviluppo, non costituiscono in nessun modo
un vincolo per il perseguimento di queste ultime. Al contrario, nella prospettiva
della sostenibilità molto forte, le preoccupazioni relative alla sostenibilità
ambientale costituiscono la condizione necessaria per tutte le altre politiche.
Occorre inoltre introdurre altri due concetti: il capitale naturale critico, cioè il
livello minimo necessario alla riproducibilità del sistema biologico e la capacità di
carico (carrying capacity), ovvero quanto può crescere una risorsa nel suo sistema
vitale, il numero massimo di individui che un ecosistema può sopportare. I diversi
concetti di sostenibilità valutano in modo differente questi due elementi di soglia,
8
Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, 1988, Il futuro di noi tutti / Rapporto della
Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, Bompiani, Milano
49
che comportano, ovviamente, una diversa possibilità di sfruttamento delle risorse
naturali.
Il concetto di sostenibilità debole considera sempre possibile la sostituibilità tra
capitale naturale e capitale artificiale, tanto che definisce sostenibile un modello
che garantisce uno stock di capitale (naturale + artificiale) non decrescente nel
tempo.
Il concetto di sostenibilità forte, al contrario, considera impossibile una
sostituzione completa tra capitale naturale e capitale artificiale, ad esempio per
quel che riguarda il mantenimento dei servizi ecologici vitali (come la fotosintesi),
così che la sostenibilità viene definita come il mantenimento non decrescente
dello stock di capitale naturale.
Un secondo concetto che può essere derivato dalla definizione di sviluppo
sostenibile del rapporto Brundtland è quello di equità. Anche in questo caso è
possibile fare una distinzione:
–
equità intragenerazionale, sia a livello locale che internazionale, implica la
parità di accesso alle risorse (ambientali o meno) da parte di tutti i cittadini
del pianeta, senza distinzioni rispetto al luogo in cui vivono;
–
equità intergenerazionale significa invece pari opportunità fra successive
generazioni.
Il rapporto della Commissione mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo pone
l’accento su altri due elementi: il concetto di bisogni primari e l’idea di un limite
allo sviluppo.
I bisogni sono visti soprattutto in relazione alla componente più povera
dell’umanità: le popolazioni del Terzo Mondo devono essere messe in condizione
di soddisfare i bisogni primari dell’uomo. Riprendendo in parte la teoria dei
bisogni fondamentali proposta da McNamara, si condivide l’idea che non è
possibile proporre un modello di sviluppo a una popolazione che non è in grado di
sfamarsi.
Il concetto dei limiti, invece, riprende in parte il rapporto del club di Roma, ma in
maniera meno drastica: pur riconoscendo che lo stato della tecnologia e
dell’organizzazione sociale impongono dei limiti alla capacità dell’ambiente di
soddisfare i bisogni presenti e futuri, tuttavia il rapporto Brundtland non disegna
50
uno scenario di collasso del sistema, ma propone lo sviluppo sostenibile come
modello da seguire per garantire la sostenibilità del sistema.
Il rapporto Brundtland propone tre misure concrete. La prima consiste nel
produrre di più consumando di meno attraverso il riciclaggio, l’efficienza
energetica e l’innovazione tecnologica. La seconda misura riguarda l’arresto
dell’esplosione demografica. La terza consiste nella redistribuzione della
ricchezza dai Paesi industrializzati al Terzo Mondo.
Il concetto di sostenibilità elaborato dalla commissione delle Nazioni Unite è stato
definito come antropocentrico: al centro della questione non viene, infatti, posto
l’ecosistema, e quindi la conservazione e il benessere di tutte le specie viventi, ma
piuttosto l’uomo e la sopravvivenza di tutte le generazioni future.
In seguito il concetto è stato ampliato. Nel 1991 la World Conservation Union
definisce lo sviluppo sostenibile come “un miglioramento della qualità della vita,
senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa
dipende”. Nello stesso anno Herman Daly propone alcune condizioni generali per
garantire uno sviluppo sostenibile, come verrà meglio specificato nel quarto
capitolo.
Nel 1994 l’ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) ha
fornito un ulteriore ampliamento del concetto: “Sviluppo che offre servizi
ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza
minacciare l’operabilità dei sistemi naturali e sociali da cui dipende la fornitura
di tali servizi”. Le dimensioni ambientali, economiche e sociali sono quindi viste
come tre elementi strettamente correlati, e tali legami non possono essere ignorati
da qualsiasi politica che voglia indirizzare lo sviluppo nella direzione della
sostenibilità.
Nel 2001 l’Unesco ha allargato ancora il concetto di sviluppo sostenibile,
indicando che “la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la
biodiversità per la natura (…) la diversità culturale è una delle radici dello
sviluppo inteso non solo come crescita economica, ma anche come mezzo per
condurre un’esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale,
morale e spirituale”.
51
Il concetto di sviluppo sostenibile è quindi un concetto molto ampio, che
abbraccia tutta la sfera umana: dall’economia alla politica, dall’ambiente alle
dinamiche sociali. Non è possibile, cioè, scindere la sostenibilità in reparti stagni e
intervenire solo su alcuni settori: è necessario un cambiamento globale che
comprenda anche la componente etica. Proprio questo fatto, però, cioè la vastità
del suo significato, ha indotto alcuni studiosi a criticare il concetto di sviluppo
sostenibile: un campo troppo vasto viene visto come uno svuotamento di
significato del concetto, poiché dà la possibilità di fornire interpretazioni molto
differenti, a volte anche in contrasto tra loro; interpretazioni che si traducono poi
in azioni di diversa natura e orientamento, che vengono tutte giustificate
ponendosi sotto l’ampio ombrello dello sviluppo sostenibile. Inoltre, i concetti di
sviluppo sostenibile non si pongono al di fuori del paradigma della crescita, ma
sono in armonia con il pensiero economico mainstream. Questo approccio viene
aspramente criticato in particolare da quegli studiosi (inseriti nei movimenti che
fanno capo alla teoria della decrescita che saranno trattati nel capitolo quinto) che
ritengono impensabile che uno sviluppo economico basato su continui incrementi
di produzione di merci possa essere in sintonia con la preservazione dell’ambiente
e con un armonico sviluppo della società umana.
52
2.5 I limiti sociali
I limiti fisici del pianeta non possono essere considerati i soli ostacoli al
perseguimento dello sviluppo economico così come fino a oggi è stato presentato.
Esistono anche dei limiti sociali allo sviluppo, che implicano l’assunzione della
tesi secondo cui l’economia non può essere una scienza amorale, ma deve fare i
conti con metri di giudizio e con valutazioni etiche.
Oltre al filone di ricerca che individua nella limitata disponibilità delle risorse
fisiche un ostacolo alle possibilità di uno sviluppo illimitato, negli anni ’70, con
Fred Hirsch, si inaugura un nuovo approccio, che identifica nel contesto sociale i
limiti a una crescita continua. L’argomentazione di Hirsch si articola attorno a due
problemi principali:
–
una quota importante e crescente del prodotto reale delle economie
occidentali consiste in beni e servizi “posizionali” (piuttosto che
“materiali”), la cui offerta non può essere di molto aumentata;
–
il perseguimento del proprio interesse da parte dei singoli, da cui dipende
l’efficienza dell’economia di mercato, indebolisce inevitabilmente i
vincoli etici che tengono insieme la società.
L’economia materiale è definita come l’output riconducibile all’aumento continuo
di produttività per unità di input di lavoro: con l’aumento della meccanizzazione e
della tecnologia l’output non perde la sua qualità. L’economia posizionale, invece,
riguarda quei beni che possono definirsi scarsi in senso sociale e che sono soggetti
ad affollamento e congestione quando il loro uso diventa più intensivo ed esteso.
Chi consuma beni posizionali percepisce una diminuzione della qualità correlata
all’aumento della loro produzione e alla diffusione del loro impiego.
Mentre l’accesso ai beni materiali, volti cioè a soddisfare i bisogni fondamentali, è
una funzione del reddito assoluto, così che esso aumenta con lo sviluppo
economico, l’eccesso ai beni posizionali è una funzione del reddito individuale
relativo a quello degli altri, sicché esso non aumenta con lo sviluppo economico.
Con l’aumento del reddito e della disponibilità economica diventa importante la
propria posizione nei confronti di coloro che ci stanno attorno. Ne deriva che la
soddisfazione non è data tanto dal consumo di un prodotto, ma dal confronto tra le
53
nostre possibilità di consumo e quelle dei nostri vicini. Lo stesso vale per il
reddito: non è importante in modo assoluto il nostro livello di reddito, quanto
piuttosto la differenza tra la nostra retribuzione e quella dei nostri colleghi. Con le
parole di J. S. Mill “Gli uomini non desiderano essere ricchi, ma essere più ricchi
degli alti uomini”9.
Dal momento che la lotta per le quote relative è un gioco a somma zero, è chiaro
che la crescita aggregata non può aumentare il benessere aggregato. Nella misura
in cui il benessere dipende da posizioni relative, la crescita non è in grado di
aumentare il benessere dell’aggregato. Essa è soggetta a una sorta di trappola
autodistruttiva.
Il risultato è una frustrazione dello sviluppo reale. L’offerta di beni posizionali,
quelli cioè che possono soddisfare il bisogno di consumo dell’uomo moderno, non
può essere aumentata oltre un certo livello. Essi, infatti, sono soggetti a quella che
Hirsch chiama congestione: l’uso di tali beni da parte di un numero sempre
maggiore di persone influisce, in negativo sulla loro qualità. Il fatto che i beni e i
servizi posizionali dipendano, per loro natura, dal reddito e dallo status sociale
relativo, comporta, inoltre, diseconomie esterne nel loro consumo (qualcuno ci
deve perdere se tu ci guadagni) ed esclude ogni ottimizzazione, favorendo anzi
sprechi e distorsioni.
Il successo dello sviluppo economico nel soddisfare, nei decenni trascorsi, la
domanda di beni materiali ha esaltato oltre misura le motivazioni individuali
orientate al mercato e al perseguimento dell’interesse individuale, facendole
dilagare oltre i limiti etici entro i quali erano state a lungo contenute. Gli
individui, secondo Hirsch, hanno perso i freni che li spingevano ad arrestarsi dal
perseguire il proprio interesse nel caso in cui esso mostrasse conseguenze sociali
indesiderabili.
L’enorme sviluppo economico visto fino a oggi, non è stato in grado di distribuire
in modo egualitario i beni e i servizi di cui godono da sempre le classi privilegiate.
L’accesso a un certo tipo di beni, che si possono definire beni di lusso, si è
ampliato di molto, ma l’élite si permette, oggi, beni ancora più irraggiungibili. Il
fatto che sia più facile raggiungere con poco sforzo beni che prima erano tabù per
9
Citato in Hirsch F., 1981, I limiti sociali dello sviluppo, Milano, Bompiani
54
un certo tipo di classe di reddito, non produce comunque soddisfazione, perché il
confronto con gli altri individui porta a desiderare beni posizionali sempre
maggiori.
Ancora una volta lo sviluppo si scontra con il problema della scarsità: non un
limite fisico, ma l’impossibilità oggettiva di garantire a tutti il massimo. “Lo stato
liberale delle opportunità individuali appare oggi in una prospettiva assai più
limitata. Le sue attrattive in se stesse non sono diminuite. Ciò che occorre
ridimensionare è la possibilità di distribuirle a tutto il popolo” (Hirsch, 1981).
Occorre costruire una nuova morale in cui i valori dell’altruismo mostrino i limiti
entro i quali deve muoversi l’azione economica motivata dalla ricerca
dell’interesse individuale. Tra lo Stato e il mercato, emerge l’elemento etico come
fattore autonomo e irriducibile di integrazione della società. Deve emergere,
sempre secondo la visione di Hirsch, un’etica che veda nell’interesse collettivo un
fine a cui deve tendere l’interesse individuale, in modo che si ottengano risultati
migliori proprio orientando verso il sociale il proprio agire. Questo non richiede,
secondo l’autore, un cambiamento della natura umana, ma semplicemente un
cambiamento delle convenzioni e degli atteggiamenti. Nella scala delle priorità
sociali la crescita dovrebbe essere sostituita da altri obiettivi.
Quanto emerge da questa analisi è una discrepanza tra l’aumento della ricchezza e
la soddisfazione dei consumatori. Chiaramente questo aspetto dello sviluppo ha
un senso solo nei Paesi industrializzati, ma può fornire un’indicazione anche per i
Paesi in via di sviluppo. L’aumento dei consumi non è sempre indice di un
miglior livello di benessere, tanto che non mancano le analisi economiche che
indicano come l’aumento di reddito non corrisponda a un uguale aumento della
felicità (fig. 1), così come espresso nel cosiddetto paradosso di Easterlin.
55
Figura 1
La ragione è sempre la stessa: la percezione della nostra felicità non avviene a
livello assoluto ma sempre in riferimento al momento contingente e al paragone
con le persone che ci sono intorno. Con l’aumento del reddito, infatti, aumentano
anche le aspirazioni e di conseguenza gli individui sono indotti a richiedere
continui e più intensi piaceri per mantenere lo stesso livello di soddisfazione.
Da queste analisi emerge che il problema dello sviluppo, inteso come pura
crescita economica, può essere soggetto a molte critiche. Da un lato, i limiti fisici
impongono un freno alla produzione e al consumo, che stanno raggiungendo
dimensioni esagerate. Dall’altro, come mostrato nelle pagine precedenti,
emergono anche delle difficoltà sociali, legate all’insoddisfazione crescente che
nei Paesi industrializzati colpisce buona parte della popolazione.
E’ impossibile, in questo contesto, escludere l’etica dall’economia. Le scelte
economiche implicano delle conseguenze sulle generazioni future e sulle altre
specie viventi che devono essere considerate. La critica al paradigma della
crescita accusa i suoi sostenitori di non aver tenuto conto della distruzione di
habitat e dell’estinzione di molte specie animali, di non tenere conto dei bisogni
delle generazioni future, come se esse non avessero la necessità di utilizzare le
risorse terrestri, e di non essere stati in grado di migliorare le condizioni di vita
delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.
56
Nei capitoli che seguono, si andranno ad analizzare i contributi di diversi autori
nel proporre una differente idea di sviluppo, legata non alla crescita economica e
all’aumento del Pil, ma all’aspetto qualitativo dell’economia. Per fare ciò è
necessario partire dal presupposto che l’economia non può essere considerata una
scienza pura e isolata. Essa è espressione dell’attività umana e in quanto tale non
può essere slegata da tutto ciò che riguarda l’uomo: l’ambiente naturale in cui
vive, i rapporti sociali, la psicologia degli individui, le tradizioni e le culture che
determinano certe visioni del mondo e certi modi di consumo.
In particolare l’economia non può essere considerata una scienza universale: essa
deve adattarsi alle culture locali e alle differenti situazioni storiche e sociali.
Un’analisi globale delle problematiche legate allo sviluppo deve poi concentrarsi
sulle opportunità che nascono localmente per affrontare i limiti che emergono da
una visione del mondo legata alla semplice crescita quantitativa. La critica al
paradigma sviluppista, nelle sue varie forme, ha un punto costante: lo sviluppo
qualitativo e a misura d’uomo non può essere una ricetta universale da applicare
indiscriminatamente a tutti i popoli della terra, ma deve nascere e crescere
dall’interno di ogni comunità.
Prima di passare all’analisi dei vari contributi teorici, occorre ancora analizzare in
che modo viene quantificato lo sviluppo e quali conseguenze ha questa
misurazione sulle politiche economiche legate alla crescita.
57
2.6 La misura dello sviluppo
Il concetto di sviluppo è strettamente correlato alla sua misurazione, in modo
particolare quando il termine è utilizzato come sinonimo di crescita economica.
Negli anni ’40, per evitare di farsi cogliere impreparati da un’eventuale crisi,
com’era successo nel 1929, gli Stati Uniti mettono a punto un sistema di misura
della produzione aggregata adatto a valutare la situazione economica dei paesi.
Dal 1977 il Pil (Prodotto interno lordo) diventa l’aggregato base raccomandato
dall’ONU per la contabilità nazionale.
Il Pil viene considerato, anche a livello sociale e politico, il parametro principale
su cui valutare l’andamento di un paese, sotto tutti i punti di vista: la vitalità
economica, il successo delle politiche economiche, il benessere e la felicità dei
cittadini.
Il Pil è il valore di mercato di tutti i beni e i servizi finali prodotti da un paese
entro un determinato periodo di tempo, che di norma corrisponde all’anno, e nel
tempo ha perso la sua connotazione di aggregato di dati imparziale ed è diventato
la misura del successo di un paese. Il prodotto interno lordo può essere calcolato
con diversi metodi: quello del valore aggiunto, quello del reddito o quello della
spesa. Nel primo caso si da rilievo al fatto che il contributo delle imprese
all’incremento della produzione è pari al valore aggiunto che esse incorporano nel
prodotto, cioè il valore della produzione al netto dei beni intermedi impiegati per
ottenerla. Nel secondo caso, si rimarca il fatto che il valore aggiunto deve essere
ripartito tra i soggetti coinvolti nella produzione, sotto forma di salari e di profitti.
Il terzo metodo coinvolge consumatori e imprese, indicando come reddito e
profitti si trasformano in consumi delle famiglie e in investimenti da parte delle
imprese. In sintesi, il Pil rappresenta la ricchezza prodotta da un paese.
Nessuno oggi sostiene che il Pil sia un indicatore perfetto. Anche i suoi sostenitori
ammettono che l’indicatore non può misurare la salute dei cittadini, o il livello
dell’istruzione; tuttavia, è diffusa l’idea secondo cui un paese con un Pil elevato
garantisce livelli di vita migliori, nonostante l’indicatore non consideri molte delle
attività non contabilizzabili. La critica più comune rivolta al Pil è proprio questa: è
un indice che non è in grado di misurare tutta una serie di fattori, che sono invece
58
determinanti nella vita delle persone. Alcuni sono fattori in qualche modo
economici, come i lavori domestici o gli scambi di servizi che avvengono
all’interno della famiglia; altri sono fattori immateriali, che non possono essere
ridotti a quantificazioni numeriche, perché la loro natura è qualitativa e sociale,
più che economica. Tuttavia, questi possono definirsi difetti interni, cioè limiti
propri dello strumento, che possono in qualche modo venire migliorati, cercando
di inserire qualche correzione e qualche adattamento.
Le critiche più severe, in realtà, sono rivolte all’interpretazione data al Pil. Gli
autori che criticano l’economia dello sviluppo vedono nel Pil, considerato come
indice incontestato del successo economico e come indicatore della felicità di un
paese, lo strumento che permette di continuare a presentare la crescita come
necessaria e indiscutibile. D’altro canto, se il Pil può essere definito soprattutto
consumo, allora è chiaro che la proposta degli obiettori della crescita non può che
essere in netto contrasto con questo indicatore.
Lo sviluppo economico definito dal Pil prescinde da due elementi importanti:
l’aspetto qualitativo (quali sono le produzioni e i consumi che hanno generato il
Pil) e l’aspetto della sua ripartizione (in che modo la crescita del Pil si distribuisce
tra i cittadini).
Tutti gli autori che verranno affrontati nei capitoli seguenti hanno mostrato scarsa
propensione a considerare il Pil una corretta misura del benessere reale; tale
indicatore, in realtà, risulta, soprattutto per gli obiettori della crescita, uno
strumento che distorce la percezione e gli incentivi a un corretto uso delle risorse
e un equilibrato modello di consumo.
Nonostante le differenze nel pensiero degli economisti eterodossi che criticano lo
sviluppo e la crescita, la critica al Pil pare una costante che riesce ad accomunare
tutti questi autori. Se il Pil rappresenta la misura della crescita e, lontano da essere
un indicatore neutrale, influenza la percezione e gli incentivi che vanno nella
direzione dello sviluppo, è chiaro che una critica del paradigma sviluppista non
può accettare che il livello di ricchezza e benessere di una popolazione sia affidato
a un indicatore tanto controverso.
Bisogna riconoscere che il Pil ha dei meriti notevoli. E' una di quelle misure
aggregate senza le quali chi si occupa di orientare le politiche economiche si
59
troverebbe sperduto in un mare di singoli dati non organizzati, e non sarebbe in
grado di stabilire e raggiungere degli obiettivi economici. La rappresentazione di
un fenomeno attraverso un unico indicatore presenta l’innegabile vantaggio di
essere facilmente comunicabile e utilizzabile per immediati confronti nel tempo e
nello spazio. Ma è fuorviante attribuire al Pil anche la funzione di misuratore del
benessere e considerare l’aumento del Pil assolutamente necessario per la felicità
dei cittadini.
Le critiche mosse verso il Pil riguardano in gran parte le componenti dell’azione
umana che, sebbene fondamentali nello sviluppo della società, non vengono colte
da questo indicatore. In primo luogo, il fatto che una certa quantità di merci sia
stata prodotta non significa che tutti abbiano accesso a questi beni e che siano in
condizione di usarli per migliorare la propria esistenza. Una nazione non dovrebbe
limitarsi a promuovere la crescita economica, sulla base della convinzione che
questa porterà benefici a tutta la popolazione, ma distribuire in modo equo le sue
risorse in modo che la crescita sia indirizzata al benessere collettivo. Della
distribuzione delle risorse e del fatto che qualcuno sia privato di cibo, acqua,
alloggio, vestiario, sanità e istruzione, il Pil non dice assolutamente nulla. Per
questo può essere utile, nel cercare di analizzare il grado di sviluppo di una
nazione, implementare i dati sulla crescita economica con quelli sulla
distribuzione del reddito e sulla povertà, i cui indicatori più usati sono l'indice di
Gini e lo Human Poverty Index (HPI).
L'indice di Gini è in grado di esprimere in termini percentuali il grado di
concentrazione del reddito, quindi la ripartizione della ricchezza all'interno di una
collettività. L'HPI è stato elaborato dall'ONU per misurare il grado di povertà di
una nazione. Per i Paesi in via di sviluppo si calcola in base ad aspettativa di vita,
analfabetismo, mancato accesso all'acqua potabile, denutrizione infantile e
numero di redditi inferiore al dollaro al giorno. Per i Paesi industrializzati, invece
dell’accesso all'acqua e della denutrizione infantile, si calcola l'esclusione sociale,
misurata
dalla
disoccupazione
di
lungo
periodo,
mentre
al
posto
dell'analfabetismo completo si misurano le forme di scarsa alfabetizzazione.
Se il benessere di un paese si può definire nella misura in cui la sua popolazione
può soddisfare le proprie esigenze, allora occorre tener conto anche dei fattori
60
sociali e culturali che, in gran parte del mondo rendono ancora difficile parlare di
parità tra uomo e donna, e che determinano discriminazioni verso alcuni settori
della società. La misura delle disparità di sesso, religione, etnia può essere
verificata utilizzando le misure già esistenti e applicandole separatamente, ad
esempio, alla parte femminile e a quella maschile della società, o alle diverse
etnie.
Il difetto maggiore del Pil, tuttavia, è quello di non essere in grado di distinguere
tra i beni e i mali che una società produce. L'acquisto da parte di un governo
autoritario di armi da usare contro i propri cittadini allo scopo di mantenere il
potere, la spesa bellica di una nazione in guerra, i costi che alcune famiglie si
trovano a dover sostenere per curare un proprio componente affetto da una nevrosi
o dipendente da droga, non sono certo sintomi di benessere per una società.
Eppure contribuiscono all'incremento del Pil. In altre parole esso è un indicatore
che dà lo stesso significato alla spesa per la costruzione di una scuola e allo stesso
importo speso per produrre delle armi. Più in generale, si può dire che il Pil è
indifferente rispetto alla destinazione ultima della produzione: se un imprenditore
produce qualcosa che si rivela completamente inutile, e quindi rimane invenduto e
diventa solo un rifiuto da smaltire, il buonsenso ci dice che c'è stato uno spreco, il
Pil che c'è stato un contributo alla crescita economica.
Esistono poi dei beni che hanno un valore, ma non un prezzo di mercato: sono, in
modo particolare, i beni ambientali, come la qualità dell’aria o la presenza di
boschi, e i beni relazionali, come la qualità dei rapporti famigliari e il tempo speso
per noi stessi. "Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della
qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. […] Non
comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari,
l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non
tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di
noi. Il Pil non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra
saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al
nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna
di essere vissuta", affermò Robert Kennedy nel 1968, in un discorso nel quale
criticava l'idea di crescita economica fine a sé stessa:"Non troveremo mai un fine
61
per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del
benessere economico, nell’ammassare senza fine beni terreni"10, sottolineò in
quell'occasione.
La consapevolezza dell'entità che il problema ambientale ha raggiunto rende
ormai chiaro come non si possa continuare a misurare la ricchezza delle nazioni
solo sulla base della crescita economica, senza calcolare il deprezzamento del
capitale naturale che essa provoca, cioè i danni all'ambiente e il consumo di
risorse ambientali non rinnovabili.
Herman Daly, oltre a offrire una critica della contabilizzazione del benessere, nel
1989 ha messo a punto, con John Cobb, un nuovo indicatore: l’ISEW (Index of
Sustainable Economic Welfare, Indice del benessere economico sostenibile).
L'ISEW calcola lo sviluppo di una nazione in termini economici, come il Pil, ma
comprende, oltre agli elementi positivi che lo fanno aumentare, elementi negativi
che gli vengono sottratti. Hanno segno positivo la spesa privata per consumi e
investimenti, la spesa pubblica "buona" (quella per la sanità, per le infrastrutture,
per l'istruzione e per l'ambiente) e il lavoro domestico, mentre vengono sottratti i
danni ambientali, l'esaurimento di risorse non rinnovabili, la perdita di zone umide
e di terreni agricoli, le spese per la sicurezza, i costi connessi a urbanizzazione,
pendolarismo e incidenti stradali, il grado di iniquità nella distribuzione dei
redditi. Un indicatore come questo consente di capire meglio quanto è efficace la
nostra organizzazione della produzione, tenendo anche conto dei costi ambientali
e sociali. Ma non ci dice se l'ecosistema sia in grado di sostenere questa
organizzazione, o se la pressione sulle risorse e sull'ambiente risulti troppo forte e
destinata a determinare effetti catastrofici nel lungo termine.
E' invece significativo da questo punto di vista l'Ecological Footprint (Impronta
Ecologica), indice basato specificamente sulla sostenibilità ambientale, che
calcola l'area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria per
rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e per assorbire i rifiuti
corrispondenti.
E’ evidente che l’inadeguatezza del Pil comincia a essere avvertita anche dalle
istituzioni. A livello di singole nazioni ci sono ancora molti passi da fare, ma
10
Discorso sul Pil pronunciato da Robert Kennedy nel 1968 presso l’Università del Kansas, fonte:
www.depiliamoci.it
62
alcune istituzioni internazionali cominciano ad affiancare al Prodotto interno
lordo altri indicatori che tengono conto delle variabili sociali. Dal 1990 l'ONU, nei
suoi rapporti annuali sullo sviluppo, calcola lo Human Development Index (HDI)
di ogni nazione, un indice di sviluppo basato su reddito, speranza di vita e livello
di istruzione. Per quanto non risulti esente da difetti, visto che non tiene conto
dello stato dei beni ambientali e che le variabili che comprende sono tutte legate
ad aspetti individuali, trascurando la dimensione sociale dello sviluppo, l'HDI ha
il vantaggio di presentarsi come un indice semplice e comprensibile a tutti e
quindi in grado di avere impatto sull'opinione pubblica.
Sebbene gli economisti siano concordi nell’affermare che il Pil non è una misura
esaustiva e che non può essere considerato un sinonimo di benessere, perché non è
a questo scopo che è stato creato, tuttavia l’opinione pubblica e la politica
economica sembrano continuamente confondere il Prodotto interno lordo con la
felicità: nel nostro immaginario, ma anche nei fatti, il Pil pro capite è fortemente
legato al livello di vita e all’ammontare dello stipendio. Anche per questo motivo,
l’idea di una diminuzione del Pil, come quella proposta dalla teoria della
decrescita, genera il panico tra la popolazione, che paragona questa situazione a
un impoverimento generale con la conseguente perdita di benessere.
In realtà, proprio perché il Pil non è in grado di misurare tutte le componenti che
concorrono nella realizzazione della felicità e del benessere dei cittadini, si può
pensare a un’economia che, riscoprendo alcuni valori relazionali e sociali (che
non possono essere contabilizzati), permetta un miglioramento della qualità della
vita senza pretendere di rincorrere la crescita del Pil: in altre parole, dando più
spazio e peso alla qualità piuttosto che alla quantità.
63
Capitolo 3
LA BIOECONOMIA DI GEORGESCU-ROEGEN
3.1 Un economista eretico
Nicholas Georgescu-Roegen, nato a Costanza, in Romania, nel 1906, è
considerato il fondatore di un campo di studi interdisciplinare, a cavallo tra
l’economia e l’ecologia, noto oggi con il nome di ecological economics, ma che
egli definiva bioeconomia. Fu sicuramente un autore originale ed eclettico, che
non trovò molto favore in ambito accademico, per la sua profonda revisione dei
fondamenti epistemologici dell’economia mainstream. Introducendo le scienze
della natura, e in particolare la termodinamica e la biologia, nell’ambito
economico, egli ha elaborato una nuova dottrina che ha posto sistematicamente in
evidenza i limiti naturali della crescita economica, ponendo in primo piano il
vincolo dell’entropia.
Nicholas Georgescu-Roegen crebbe in Romania durante i difficili anni della prima
guerra mondiale. Gli eccellenti risultati ottenuti nelle migliori scuole del paese lo
avvicinarono fin da bambino alla matematica e gli valsero una borsa di studio per
la Sorbona a Parigi, dove conseguì con i più alti onori un dottorato in statistica
matematica. La borsa di studio venne rinnovata per due anni di specializzazione
post-dottorato a Londra, con Karl Pearson, che avrà un’influenza fondamentale
nell’avvicinarlo alle scienze sociali.
Nel 1934 si trasferì negli Stati Uniti come Visiting Rockfeller Fellow a Harvard,
dove, sotto l’influenza di Joseph Schumpeter, divenne un economista. Due anni
più tardi tornò a servire il proprio paese natale con incarichi sia accademici che di
governo, fra i quali quello di segretario generale della Commissione rumena per
l’Armistizio del 1944-45. Da questa posizione difese, benché con scarso successo,
gli interessi della Romania dalle arbitrarie violazioni della Convenzione
dell’Armistizio compiute dai rappresentanti dell’Unione Sovietica. Era inoltre
stato presidente dell’Associazione rumena di amicizia con gli Stati Uniti e
64
membro del Consiglio Nazionale del Partito contadino: ce n’era abbastanza
perché il regime comunista decidesse di volere la sua testa.
All’inizio del 1948 riuscì a lasciare il paese, insieme alla moglie, nascosto in un tir
straniero. Nel corso dello stesso anno ritornò a Harvard e, nel 1949, accettò un
incarico alla Vanderbilt University di Nashville, dove rimase per ventisette anni,
fino al pensionamento e dove visse fino alla morte giunta nel 1994.
Georgescu-Roegen fornì all’economia numerosi e diversi contributi, che possono
tuttavia essere schematicamente divisi in due categorie: una parte del suo
pensiero, quella relativa all’esordio come matematico ed economista, include
scritti fondamentali sulla teoria del consumatore e della scelta individuale, su
misurabilità, aspettative, teoria della produzione, analisi input-output (o analisi
delle interdipendenze settoriali) e sviluppo economico. Fu un pioniere della
matematica economica, ma era comunque inserito nel canale dell’economia
mainstream. Negli scritti più recenti, tuttavia, si può riscontrare nel suo pensiero
economico un’onda rivoluzionaria e sicuramente fortemente critica rispetto
all’economia neoclassica, fino a elaborare una critica epistemologica ai suoi
fondamenti, con ampie incursioni nelle scienze naturali.
Il primo allontanamento dalla tradizione neoclassica può essere ritrovato nel
volume del 1966 Analytical Economics, nel quale è possibile ritrovare tutti i
principali filoni in cui è scomponibile il pensiero di Georgescu-Roegen: teoria del
consumatore, teoria della produzione, economia agraria ed, infine, teoria
bioeconomica, la vera novità del suo pensiero, che dal 1971 diventerà il tema
principale di tutti i suoi scritti. Base di questa nuova teoria economica sono la
termodinamica e l’entropia.
65
3.2 Le leggi della termodinamica
Georgescu-Roegen, nelle sue opere, specialmente in quelle posteriori al 1970,
sostiene che qualsiasi scienza che si occupa del futuro dell’uomo, come la scienza
economica, non può procedere senza tenere conto dell’ineluttabilità delle leggi
della fisica, che governano la vita sulla Terra. Tra queste, un ruolo di primaria
importanza è rivestito dalle leggi della termodinamica.
La prima legge della termodinamica, detta anche legge di conservazione della
materia e dell’energia, afferma che:
“in tutti i sistemi isolati materia ed energia rimangono costanti”.
La seconda legge fondamentale della termodinamica, o legge dell’entropia, può
esser enunciata nel seguente modo:
“in ogni processo termodinamico che porti da uno stato di equilibrio
a un altro, l’entropia del sistema e dell’ambiente o rimane immutata o
aumenta”.
Gli scienziati hanno riflettuto a lungo sul significato e sulle implicazioni di questi
due principi, ma in realtà essi erano già ben radicati nella cultura popolare, nella
forma di intuizioni date dall’osservazione della vita comune. Entrambi i principi
possono essere espressi da un’unica frase: l’energia totale dell’universo è costante
e l’entropia totale è in continuo aumento. Questo significa che è impossibile
creare o distruggere energia, ma è possibile trasformarla da una forma all’altra.
Ciò è importante se si considera che ogni cosa è costituita da energia; forma,
struttura e movimento di ogni entità sono soltanto materializzazioni di energia, più
o meno concentrata e in trasformazione. Un essere umano, un’automobile o un
filo d’erba sono forme di energia trasformatasi da uno stato a un altro. Quando
un’automobile viene rottamata, o il filo d’erba muore o viene mangiato da qualche
animale, l’energia che incorporavano non scompare, viene semplicemente
restituita in qualche modo all’ambiente, sotto forma diversa.
Il primo principio della termodinamica non pone particolari problemi all’attività
umana, ma occorre tenere conto anche della legge dell’entropia. Pensando a un
pezzo di carbone che brucia, è possibile osservare che l’energia in esso contenuta
non si dissolve nella combustione, ma si converte in calore e viene dispersa nelle
66
molecole di anidride carbonica, anidride solforosa e negli altri gas nell’atmosfera.
Per quanto non si sia persa energia nel processo, non è possibile bruciare una
seconda volta il pezzo di carbone. La spiegazione di questo fenomeno si trova nel
secondo principio della termodinamica, il quale afferma che ogni volta che una
certa quantità di energia viene convertita da uno stato a un altro si ha una
penalizzazione, che consiste nella perdita di utilità da parte dell’energia, come se
essa degradasse da uno stato di ordine a uno stato di disordine, che rende l’energia
non più disponibile. La misura di questa perdita di utilità viene chiamata entropia
e può essere definita come misura della parte di energia che non può più essere
trasformata in lavoro. Un aumento di entropia significa diminuzione dell’energia
disponibile. Ogni volta che avviene qualcosa nel mondo una certa quantità di
energia si degrada e diventa non più disponibile per un lavoro successivo.
Nell’universo l’entropia tende continuamente verso un massimo, ossia a un livello
di equilibrio in cui non esistono più livelli differenti di energia. Infatti, quando
esistono differenze di livello energetico, queste tendono sempre a pareggiarsi. Un
esempio intuitivo è rappresentato da un attizzatoio appena tolto dal fuoco: quando
un ferro rovente viene esposto all’aria, si nota subito che esso si raffredda e che
l’aria circostante si riscalda, finché entrambi raggiungono la stessa temperatura. A
quel punto, però, l’attizzatoio non è più in grado di eseguire un lavoro utile e, per
essere riscaldato una seconda, volta sarà necessario utilizzare nuova energia.
Se si accetta l’affermazione secondo cui tutto è energia, è chiaro che l’entropia
riguarda anche i beni materiali. La Terra, infatti, è un sistema chiuso, ossia un
sistema che può scambiare con l’ambiente solo energia: il nostro pianeta riceve
energia dal sole, ma la materia utilizzabile è solo quella già presente sotto forma
di risorse naturali e beni materiali (gli apporti di meteoriti e polveri cosmiche
possono essere considerati residuali e ininfluenti). Questo significa che ogni uso
che si fa della materia implica un suo decadimento a forme disperse e non più
utilizzabili, o meglio riciclabili, ma solo a costo di un enorme uso di energia.
La legge dell’entropia stabilisce che tutta l’energia esistente in un sistema isolato
tende a portarsi da una situazione di ordine a una di disordine. Lo stato di entropia
minima, quello in cui le concentrazioni sono maggiori e l’energia utilizzabile è
massima, è anche lo stato di maggior ordine e, al contrario, lo stato di entropia
67
massima, in cui l’energia utilizzabile è stata completamente dissipata e dispersa, è
anche quello di maggior disordine. Per contrastare l’entropia è necessario
apportare materia ed energia nel sistema. Si deve mettere in evidenza che ogni
volta che si contrasta l’aumento di entropia in un ambito ristretto, lo si può fare
solo aumentando l’entropia globale dell’ambiente circostante, perché ogni volta
che si fa qualcosa si dissipa una certa quantità di energia che diventa poi
completamente inutilizzabile per gli impieghi successivi.
Georgescu-Roegen propone, per rappresentare il sistema Terra alla luce delle
leggi della termodinamica, l’immagine di una clessidra. La sabbia contenuta nella
clessidra rappresenta la materia-energia che, come in ogni clessidra ben costruita,
resta sempre costante: questo spiega la prima legge della termodinamica. La
sabbia scorre sempre dalla metà superiore alla metà inferiore; rispetto alle
clessidre comuni, però, la sabbia cambia di qualità. Quella contenuta nella parte
superiore è dotata di utilità, quella nella parte inferiore, invece, è ormai
inutilizzabile. Inoltre, la clessidra non può mai
essere capovolta. Queste due caratteristiche
esprimono la seconda legge della termodinamica.
Questa clessidra rappresenta in sistema isolato,
cioè un sistema che non può scambiare né
energia, né materia con l’esterno. Si è detto, però,
che la Terra è un sistema chiuso, cioè può
scambiare con l’esterno energia. Per rappresentare
in modo adeguato questa caratteristica, Roegen
aggiunge alla clessidra un anello circolare, come
rappresentato in fig. 2.
Alla luce delle leggi della termodinamica,
Figura 2
La clessidra termodinamica –
sistema chiuso
Georgescu-Roegen riscrive la teoria economica,
mettendo in evidenza come la produzione abbia
dei limiti fisici che non possono essere ignorati,
con la conseguenza che la crescita economica e materiale è destinata a diminuire
necessariamente, perché prima o poi diminuiscono le quantità di energia e di
68
materia disponibili per la produzione delle cose necessarie ai bisogni,
continuamente crescenti, degli esseri umani.
69
3.3 Un nuovo paradigma
Georgescu-Roegen inizia, alla fine degli anni sessanta, a lavorare a un nuovo
edificio teorico, alternativo all’economia standard, con l’obiettivo di rivedere i
fondamenti epistemologici della scienza economica.
I concetti chiave su cui egli fonda il proprio pensiero partono dalla distinzione tra
concetti dialettici e concetti aritmomorfici, da cui derivano diversi modi di fare
scienza. E’ opportuno definire cosa si intende con queste espressioni.
Un concetto aritmomorfico è un concetto che possiede gli attributi del discreto,
ossia è un concetto rigorosamente definito. Esempi classici di concetti
aritmomorfici sono i numeri naturali, mentre i computer sono ottimi esempi di
sistemi basati su una logica aritmomorfica: tutta l’informazione da essi contenuta
è costruita sulla distinzione tra zero e uno. Caratteristica peculiare dei concetti
aritmomorfici è la possibilità di distinguerli nettamente uno dall’altro; in altre
parole essi non hanno confini sfumati e non si sovrappongono. Per queste loro
caratteristiche i concetti aritmomorfici sono fondamentali nell’ambito dell’attività
scientifica, in quanto base della logica.
Un concetto dialettico, al contrario, non possiede confini rigidamente determinati,
ma è delimitato da una penombra entro la quale si sovrappone il suo opposto.
Caratteristica essenziale è che a essi non è possibile applicare il principio
fondamentale della logica, cioè il principio di non contraddizione. Questo
afferma, come è noto, che B non può essere contemporaneamente A e non A.
Viceversa, per i concetti dialettici, può accadere che B sia al tempo stesso parte di
A e di non A. Questa particolarità di giungere a sovrapporsi con il proprio opposto
deriva dall’elasticità dei confini semantici dei concetti dialettici. Sebbene non
siano discreti, i concetti dialettici sono tuttavia distinti: quello che li differenzia
dai concetti aritmomorfici è che, mentre i concetti dialettici sono separati dal loro
opposto da una penombra, nel caso dei concetti aritmomofici la separazione è data
da uno spazio vuoto.
La scienza classica, o teoretica, basata sul meccanicismo, si fonda sui concetti
aritmomorfici, in quanto è costituita da proposizioni descrittive logicamente
ordinate; questo crea un edificio scientifico in cui ogni preposizione è legata a
70
qualche altra secondo una connessione logica di tipo deduttivo. Questo permette
alla scienza teoretica di giungere a conclusioni univoche.
La connessione logica, tuttavia, non può trattare qualunque tipo di preposizione,
in modo particolare quando si tratta di comportamenti umani e di scienze sociali.
In sostanza, quando si tratta di occuparsi di concetti dialettici, la logica deduttiva
della scienza teoretica non permette di cogliere le possibili sfumature del contesto.
Ma Georgescu-Roegen offre un’ulteriore critica ai concetti aritmomorfici: essi
non sono in grado di spiegare il cambiamento, l’evoluzione e la trasformazione, in
quanto essi sono sempre uguali a se stessi e non prevedono sfumature.
Questa critica diventa fondamentale quando si parla di scienza economica. La
storia della scienza in Occidente mostra come questa abbia continuamente
aspirato a indossare una divisa teoretica, sin da quando Aristotele diede alla
conoscenza una struttura logica, mostrandone i vantaggi. La scienza economica
non si è sottratta a questa tentazione, le opere di Walras e di Jevons in questo
senso sono molto eloquenti11, così come il concetto di Homo oeconomicus,
perfettamente razionale, è fondato sui principi deduttivi della logica e su concetti
aritmomorfici. In un qualsiasi manuale di economia, il processo economico è
rappresentato come un processo circolare, all’interno di un sistema chiuso e
autosufficiente, in cui la domanda crea una produzione di pari ammontare. A essa
corrisponde un reddito che, distribuito alle famiglie, alimenta nuova domanda, in
un processo circolare e ricorsivo virtualmente illimitato e, comunque, sempre
uguale a se stesso. In altre parole, il modello con cui comunemente si rappresenta
il sistema economico non contiene al suo interno alcun principio che ne possa
spiegare la trasformazione. Il fondamento principale dell’economia di mercato è
l’idea che, comunque si muovano le curve di domanda e offerta, il mercato ritorni
sempre nella stessa posizione di partenza, non appena si verificano degli
aggiustamenti. Il processo economico diventa in sostanza un pendolo, che oscilla
regolarmente avanti e indietro: esso non rivela in alcun modo il passaggio del
tempo.
E’ su questo punto che si inserisce la critica di Georgescu-Roegen alla scienza
economica neoclassica: essendo basata essenzialmente su concetti aritmomorfici,
11
Come nota Georgescu, Jevons parlò esplicitamente dell’economia come “meccanica dell’utilità
e dell’interesse particolare”.
71
essa non è in grado di spiegare il proprio cambiamento; una cosa sempre uguale a
se stessa, come un concetto aritmomorfico, non può spiegare la propria
evoluzione. Questo limite è considerato dall’economista rumeno molto
importante, in quanto i fenomeni di cui si occupa la scienza economica sono
soggetti a trasformazioni molto rapide, dato che riguardano fenomeni umani e
tecnologici. Il processo economico è dominato dall’evoluzione e dalla crescita
organica, la meccanica può solo cambiare le quantità, ma non il carattere delle
forze.
Un altro aspetto dell’economia standard criticato dall’economista rumeno è
l’assunzione secondo la quale tutte le imprese sono identiche. Questo implica che
l’economia neoclassica è totalmente incapace di spiegare quali imprese dovranno
ritirarsi dal mercato se la domanda si riduce in modo massiccio, ma riesce solo a
indicare quante usciranno dal mercato. Questo limite scompare se le imprese
vengono valutate qualitativamente, cioè dotate di differenti attributi, in senso
darwiniano. Questo permette di spiegare i risultati della concorrenza tra le
imprese. Anche Schumpeter, da cui Roegen trae ispirazione per questi
ragionamenti, mostra un’evidente analogia tra lo sviluppo economico e
l’evoluzione biologica, indicando nelle innovazioni il corrispondente economico
di ciò che le mutazioni sono per la biologia.
Secondo Georgescu-Roegen, alla base di ogni fenomeno evolutivo ci sono
concetti dialettici e non vi è dubbio che, rovesciando il ragionamento, i concetti
dialettici esistono proprio in quanto i fenomeni reali, e in particolare quelli legati
alle scelte e ai bisogni umani, sono in continua trasformazione.
Georgescu-Roegen non nega l’importanza della logica e della metodologia
deduttiva; tuttavia egli ritiene che sia possibile ragionare correttamente anche con
i concetti dialettici, i quali si producono inevitabilmente dal cambiamento del
reale con cui l’economista, in quanto studioso delle realtà umane e sociali, viene
necessariamente a contatto. Egli propone un’epistemologia che integri la logica
formale all’argomentazione dialettica, consapevole che quest’ultima, per quanto
non possieda i medesimi attributi di verificabilità della prima, risulta essenziale, in
quanto portatrice di modalità conoscitive differenziali e, in questo senso, preziose
e insostituibili.
72
Tra gli autori che influenzarono il pensiero di Georgescu-Roegen e contribuirono
a mantenere una concezione evolutiva, organicistica e interdisciplinare della
scienza e della filosofia, concezione in cui si inserisce perfettamente la teoria
economica del nostro, sicuramente occorre citare Henri Bergson12 e Alfred North
Whitehead13.
E’ la concezione bergsoniana del tempo che ispirerà l’economista rumeno, che
distingue il tempo della coscienza, o assoluto (T), dal tempo della fisica e della
meccanica (t). Quest’ultimo è considerato un’astrazione, non è il tempo reale ma
una successione di istanti “statici” tutti uguali tra loro, indifferenti alla natura
qualitativa dei fatti in essi contenuti. Il tempo della coscienza, quello reale, invece,
rappresenta il tempo concretamente vissuto dalla coscienza, a livello psichico.
Non c’è soluzione di continuità tra gli stati della coscienza: essi si compenetrano
dando vita a un amalgama in continua evoluzione, sono un concetto dialettico.
Quando si ha a che fare con fenomeni connessi alla vita, così come sono i
fenomeni economici nella concezione di Georgescu-Roegen, il tempo come
successione di istanti aritmomorfici non è in grado di spiegare l’evoluzione del
sistema.
Il contributo di Whitehead al pensiero di Roegen si inserisce nello stesso ambito.
Per il filosofo inglese la realtà è un processo. Un processo implica una durata e
porta con sé qualche cambiamento. Nessuna durata è distinta in modo discreto da
quella che la precede o che la segue, così come nessun evento può essere separato
completamente dagli altri. Ognuno di essi è circondato da contorni sfumati, cioè
dalla penombra, nel senso roegeniano, dei concetti dialettici.
Questa concezione relazionale ed evoluzionistica della scienza si trova in aperto
contrasto con il meccanicismo newtoniano e con buona parte degli sviluppi che
saranno portati avanti dai neopositivisti, approccio abbracciato totalmente dalla
teoria economica neoclassica.
Molto del pensiero di Roegen è conseguenza delle sue conoscenze in fisica,
chimica e biologia, che egli inserisce nella sua critica all’economia standard.
La critica fondamentale che Georgescu-Roegen rivolge agli economisti
neoclassici è quella di aver derivato la propria epistemologia direttamente dalla
12
13
H. Bergson autore de L’evoluzione creatrice, 1907, Parigi
A. N Whitehead, autore di Scienza e filosofia, 1948, Milano
73
fisica, senza curarsi delle profonde differenze che intercorrono tra le scienze della
vita e quelle della materia. La filosofia della scienza generalmente adottata dalla
comunità scientifica, e dagli economisti in particolare, si è così ridotta a un
“elogio della scienza teoretica” (Some Orientation Issue in Economics, 1966)14.
Tuttavia, solo alcuni campi all’interno della fisica (in particolare la meccanica
classica) si adattano perfettamente al modello aritmomorfico della scienza
teoretica. Al di fuori della fisica, e soprattutto nell’ambito delle scienze umane,
per ricorrere al paradigma teoretico si è costretti a ricorrere a forzature molto
evidenti. Una di queste è l’impossibilità di misurare tutte le variabili di un
fenomeno sociale, che è intrinsecamente un elemento qualitativo, non misurabile.
Una seconda forzatura è il deduttivismo meccanicistico: man mano che aumenta
la complessità dell’organizzazione degli elementi di una struttura non è più
possibile ridurre la struttura stessa alla somma delle sue componenti; un uomo, ad
esempio, non è solo un ammasso di cellule, come una società non può essere
definita come una semplice somma di individui. L’organizzazione complessa
porta un contributo di novità alla struttura che non può essere definito da nessuno
schema aritmomorfico.
Il paradigma meccanicistico prevede la reversibilità degli eventi, ma in realtà i
fenomeni sociali e biologici non possiedono questa caratteristica, perché la loro
componente essenziale è la capacità di evolvere. Questo significa anche che la
storia passata ha un’importanza fondamentale nei processi umani, biologici e
termodinamici: un evento accaduto non può essere annullato, non si può mai
tornare alle condizioni di partenza, e questo è valido per le società umane, per la
vita e per l’entropia.
Gli strumenti metodologici introdotti da Georgescu-Roegen, in particolare il
riconoscimento attribuito ai concetti dialettici e alla legge di entropia,
costituiscono la base per una rappresentazione del sistema economico mediante
modelli di tipo evolutivo - funzionale. Ciò ha due importanti conseguenze. Da un
lato implica una riabilitazione delle istituzioni come espressione sociale e
antropologica e come contorno in cui si manifestano i fenomeni economici;
dall’altro il riconoscimento del ruolo della storia economica permette di valutare
14
Citato in Bonaiuti M., 2001, La teoria bioeconomica, Roma, Carocci Editore
74
l’evoluzione del processo economico. Se l’impiego prevalente, da parte
dell’economia mainstream, di concetti aritmomorfici porta a conclusioni teoriche
tendenzialmente universali e valide per ogni società, l’impiego di strumenti
descrittivi dialettici consente di rivalutare la storia e operare un distinguo di
carattere istituzionale, sociale e antropologico, funzionale all’elaborazione di
teorie economiche diverse per contesti culturali diversi.
Nella concezione epistemologica dell’economista rumeno, il sistema economico è
rappresentato come un sistema aperto. L’epistemologia meccanicista porta invece
a considerare il sistema economico come un sistema isolato e circolare. In realtà, i
confini della scienza economica sono penombre in movimento, dove l’economico
si mescola con il politico, il sociale e con l’ambiente naturale.
75
3.4 La teoria bioeconomica
Georgescu–Roegen presenta per la prima volta un quadro completo della sua
teoria bioeconomica all’Università dell’Alabama, il 3 dicembre del 1970 nella
Distingushed Lecture n. 1, elencando a sostegno della sua tesi tre punti
fondamentali:
–
esiste una forte parentela fenomenologica tra il processo economico e il
dominio biologico;
–
il processo economico costituisce un superamento evolutivo della biologia
che caratterizza la specie umana;
–
occorre riconoscere che la biologia e l’economia si distinguono dagli altri
domini della natura in quanto entrambe sono governate specificamente
dalla legge di entropia, senza la quale esse non potrebbero essere
compiutamente spiegate.
Come accennato nei paragrafi precedenti, la legge di entropia è alla base del
pensiero economico di Georgescu-Roegen e, allo stesso tempo, è il concetto che
determinò la prima breccia apertasi, nel corso del diciannovesimo secolo,
nell’ordine determinista della fisica classica e nel paradigma meccanicistico. Il
secondo principio della termodinamica che definisce l’entropia, accennato da
Carnot, ma formulato più compiutamente da Clausius nel 1850, afferma che in
ogni produzione di lavoro mediante calore una parte dell’energia impiegata passa
da una forma disponibile a una non disponibile. L’entropia è, quindi, un processo
di degradazione, che in un sistema isolato tende necessariamente verso un
massimo. Secondo Georgescu-Roegen, la legge di entropia si applica direttamente
ai processi di produzione che utilizzano energia, ossia al motore stesso del
processo industriale.
La Terra è un mondo limitato sia energicamente che materialmente, in cui ogni
attività economica comporta inevitabilmente una possibilità in meno per il futuro.
La legge di entropia si presenta, nel pensiero di Roegen, come la base fisica del
valore economico. L’intera vita economica si alimenta di bassa entropia, sia dal
punto di vista energetico (tutte le fonti energetiche come carbone, petrolio, uranio,
ecc. sono fonti di bassa entropia, di energia libera) che materiale (tutte le materie
76
prime adatte alla lavorazione come i metalli, il legno, i minerali ecc., in quanto
strutture ordinate, sono fonti a bassa entropia). In questo senso, la termodinamica
ci mostra quale sia la vera fonte del valore d’uso: la condizione necessaria, ma
non sufficiente, perché una cosa sia utile è che possieda bassa entropia.
L’entropia, essendo alla base della scarsità, diventa per Georgescu-Roegen il
substrato fisico del valore economico. Per quanto necessaria, tuttavia, l’entropia
non è sufficiente a determinare il valore economico: il vero prodotto del processo
economico è il “flusso immateriale del godimento della vita” che, essendo alla
base della domanda, risulta complementare all’entropia nella determinazione del
valore economico.
L’applicazione della seconda legge della termodinamica al processo economico,
oltre ad avere conseguenze ecologiche (legate all’esaurimento delle risorse e
all’emissione di inquinanti) comporta significative mutazioni epistemologiche. Il
processo economico, infatti, nella teoria di Roegen, è considerato un processo
orientato nel tempo, in cui, cioè, non è possibile un ritorno alle condizioni iniziali.
Tradizionalmente, invece, il processo economico è rappresentato come un
processo circolare in cui tutto sembra sostanzialmente riproducibile all’infinito.
La critica di Roegen all’economia neoclassica è indirizzata soprattutto al fatto che
essa ha ignorato le determinanti fisiche sottostanti al processo economico,
sostenendo la visione di un sistema economico chiuso e di un processo circolare,
mentre dovrebbe essere inteso come un processo unidirezionale.
In base al primo principio della termodinamica l’uomo non è in grado di produrre,
né di distruggere, materia ed energia. La domanda che si pone l’economista
rumeno è allora: che cosa fa il processo economico? La letteratura neoclassica
tralascia questa domanda fondamentale, offrendo solo casuali osservazioni circa il
fatto che l’uomo può produrre solo utilità. Per rispondere a questa domanda
Roegen esamina l’evento economico dal punto di vista puramente fisico,
osservando che esso è un processo, circoscritto cioè da un confine, attraverso il
quale materia ed energia si scambiano con il resto dell’universo materiale fisico.
A questo punto la risposta è semplice: il processo economico, materiale, “non
produce e non consuma materia-energia, ma soltanto la assorbe e la espelle, il
tutto ininterrottamente” (Georgescu-Roegen, 1970).
77
L’economia, certo, non è un fatto puramente fisico: occorre, infatti, sottolineare
che c’è differenza tra ciò che entra e ciò che esce dal processo economico, una
differenza che deve essere valutata soprattutto dal punto di vista qualitativo.
Tuttavia, anche il processo economico sottostà alle leggi della fisica, per cui la
differenza qualitativa può essere osservata in termini di entropia: le preziose
risorse naturali che entrano nel processo economico sono energia-materia a bassa
entropia, mentre gli scarti senza valore che vengono espulsi sono materia-energia
ad alta entropia.
La seconda legge della termodinamica può trarre in inganno. Osservando i
prodotti dell’industria e le creature viventi, sembra che sia possibile sfuggire alla
legge entropica. Un esempio può essere utile a comprendere meglio questo
passaggio. Qualsiasi essere vivente, su archi temporali di breve periodo, riesce a
mantenere immutata la propria entropia, non procede inevitabilmente verso il
disordine, se non quando cessa la vita. L’uomo è l’esempio più straordinario di
questo fenomeno: per mantenere bassa la propria entropia ricorre all’uso della
tecnologia e delle risorse naturali, trasformandole in funzione della propria
esistenza. Tutti gli organismi viventi si adoperano per mantenere costante la
propria entropia, ma questo non significa che essi sfuggano alle leggi della
materia. Per ottenere questo scopo, infatti, essi traggono materia ed energia a
bassa entropia dall’esterno. Ma considerando il sistema nel suo complesso, cioè
l’organismo più il suo ambiente, l’entropia totale non resta invariata, ma aumenta:
è vero, infatti, che l’organismo mantiene stabile la sua entropia, ma a scapito
dell’uso di energia e materia provenienti dall’esterno. Lo stesso si può dire dei
manufatti e dei prodotti industriali: l’entropia del rame metallico è più bassa del
minerale all’origine del processo di raffinazione, ma questo non significa che
l’attività produttiva sfugga alla seconda legge della termodinamica: la raffinazione
del minerale, con l’utilizzo di energia e materia, causa un aumento più che
equivalente dell’entropia nell’ambiente circostante.
In termini di entropia, in qualsiasi impresa biologica o economica essa è sempre
maggiore del prodotto e qualsiasi attività ha inevitabilmente per risultato un
deficit. La scarsità, intesa in senso ricardiano, è legata, secondo GeorgescuRoegen, non alle materie prime, quanto alla bassa entropia. E’ questa che
78
diminuisce con il procedere del tempo e con il perpetuarsi delle attività umane;
nel corso del tempo è l’utilità delle risorse che diventa sempre più scarsa,
rendendole di fatto inutilizzabili.
Questa osservazione chiarisce la critica all’idea di economia come processo
circolare: il processo economico è saldamento legato a dei vincoli materiali che lo
rendono irreversibile e unidirezionale.
3.4.1 Stock, flussi e teoria della produzione
Se ci guardiamo attorno, possiamo renderci conto che siamo circondati da
un’infinita quantità di energia potenziale, in particolare quella solare, unico
apporto esterno al sistema Terra. Nella realtà, gran parte di questa energia, libera e
a bassa entropia, è per noi inutilizzabile, dato che l’energia del sole è diffusa, non
localizzata e non immagazzinabile. Questo rende l’apporto energetico solare
importante, dal punto di vista biologico, come essenziale per la vita, ma
relativamente poco sfruttabile a livello economico, soprattutto se si confrontano le
enormi potenzialità con il minimo sfruttamento che si riesce a fare di questa
risorsa.
Georgescu-Roegen distingue l’energia libera di cui l’uomo può disporre in due
fonti distinte: la prima fonte è uno stock, rappresentato dalle risorse minerarie
presenti sulla terra; la seconda è un flusso, quello delle radiazioni solari
intercettate dalla Terra.
La differenza tra le due fonti è essenziale: l’uomo ha un controllo quasi completo
sulla dotazione terrestre di risorse naturali, mentre ha pochissimo controllo sulle
radiazioni solari, che non possono essere immagazzinate, come non è possibile
sfruttare ora il flusso del futuro. I giacimenti di carbone, per esempio, sono un
fondo nel senso che è possibile utilizzarli tutti oggi, oppure nel corso dei secoli.
Al contrario, è impossibile usare una qualunque porzione di un flusso futuro di
radiazione solare, né è possibile immagazzinarlo e utilizzarlo tra un secolo;
inoltre, questo flusso è fuori dal controllo umano, non è possibile agire in alcun
modo sulla quantità di energia solare che riceveranno le generazioni future.
Rispetto alle risorse naturali, invece, la priorità del presente rispetto al futuro e la
79
degradazione entropica fanno sì che le generazioni future dipendono interamente
da quanta dote terrestre è stata consumata dalle generazioni precedenti.
In sostanza, le riserve minerarie utilizzate in passato rappresentano consumi in
meno che vengono permessi ai nostri discendenti, mentre, per quel che riguarda le
risorse biologiche, il flusso di energia solare garantirà comunque il nascere di
vegetali e animali (inquinamento e alterazioni climatiche permettendo).
L’economista sottolinea, inoltre, la differenza quantitativa tra i due tipi di energia:
il flusso di radiazioni solari, oltre a essere praticamente illimitato, è, oggi, 13.500
volte superiore alla domanda di energia dell’intero pianeta, pari a 178 x 1012 kW;
tuttavia esso rappresenta una forma di energia rarefatta, che ne rende difficile lo
sfruttamento. Lo stock di materiale terrestre, al contrario è limitato e non regge il
confronto con la straordinaria quantità di energia solare; tuttavia esso è
disponibile, concentrato e relativamente facile da sfruttare. Il fatto che sia limitato,
però, porta Roegen a dubitare fortemente che uno sviluppo come quello da lui
osservato negli anni ’70 possa continuare ancora per molto.
E’ l’energia terrestre a essere scarsa eppure, nel modello economico attuale, è la
più utilizzata e la più economica, in quanto il prezzo dell’energia non riflette,
come dovrebbe, la scarsità di tali risorse.
Tutte le creature viventi utilizzano per le loro attività quotidiane organi che sono
parte della loro struttura biologica, per sopravvivere utilizzano materiale biologico
(vegetali ed esseri viventi), sostanzialmente sfruttando la sola energia solare, ossia
l’unica risorsa illimitata presente sulla Terra. Attraverso l’evoluzione e le
mutazioni, le specie hanno adattato le loro strutture endosomatiche ai fini a esse
più congeniali. L’uomo è un’eccezione: oltre a sviluppare i propri attrezzi
endosomatici, egli è arrivato a utilizzare ogni tipo di strumento di cui non è dotato
dalla nascita. Oltre all’evoluzione biologica endosomatica si è assistito a
un’evoluzione esosomatica, che ha reso l’uomo padrone della Terra ma, al tempo
stesso, l’ha reso dipendente da un’altra forma di energia, più limitata e meno
disponibile: quella delle risorse naturali, lo stock di materia contenuto nelle
viscere della Terra.
La distinzione tra stock e flussi permette a Roegen di formulare una teoria
alternativa della produzione, critica rispetto alla tradizionale teoria neoclassica
80
della produzione. Come è noto, la teoria standard è basata su una funzione
aggregata del tipo:
Q = f (K, R, L)
dove K rappresenta lo stock di capitale, R le risorse naturali ed L l’offerta di
lavoro. Essendo una funzione del tipo Cobb-Douglas, essa assume implicitamente
che sia possibile produrre qualsiasi output Q riducendo a piacimento le risorse
naturali R, purché venga aumentato sufficientemente lo stock di capitale secondo
l’espressione:
R = Q/KL.
In sostanza, si ipotizza la perfetta sostituibilità tra risorse naturali e capitale
prodotto dall’uomo.
Secondo Georgescu-Roegen, tale assunzione viola le leggi della termodinamica,
in particolare la prima, poiché non viene rispettato il bilancio dei materiali:
sarebbe come dire che, se la teoria della produzione è considerata una ricetta, è
possibile, riducendo la quantità di farina e di uova, cuocere una torta più grande
semplicemente utilizzando un forno di dimensioni maggiori, oppure due cuochi al
posto di uno.
Nella teoria neoclassica della produzione un fondo ha la caratteristica di entrare e
uscire dal processo senza modificare la sua efficienza. I fattori di produzione
dell’economia classica, cioè lavoro, capitale e terra in senso ricardiano,
rappresentano le usuali tipologie di fondo, poiché, al termine del processo
produttivo, essi conservano le medesime condizioni con le quali sono entrati. Per
mantenere queste condizioni, un certo ammontare di capitale e lavoro deve essere
impiegato per riportare il fondo alle condizioni iniziali.
Un elemento di flusso, viceversa, è qualcosa che, attraversando il confine del
processo, viene utilizzato dagli elementi fondo; pertanto non può uscire dalla
produzione senza modificare le sue caratteristiche. Le risorse naturali e i prodotti
intermedi costituiscono le usuali tipologie di flusso in ingresso nel processo
produttivo, mentre in uscita troviamo prodotti finiti e scarti.
Ciò che è importante sottolineare è che non vi è sostituibilità tra fattori flusso e
fattori fondo. La produzione, infatti, è in realtà la trasformazione di risorse in
prodotti dotati di utilità e in prodotti di scarto. Lavoro e capitale sono gli agenti di
81
trasformazione e le risorse, a bassa entropia energetica/materiale, sono ciò che
viene trasformato.
Questo significa che non è possibile, riducendo la quantità di farina, produrre uno
stesso numero di pizze semplicemente aumentando il numero di pizzaioli o di
forni. In altre parole, è possibile sostituire facilmente un elemento di fondo con un
altro elemento di fondo, o un elemento di flusso con un altro elemento di flusso,
ma la relazione tra flussi e fondi è sostanzialmente una relazione di
complementarietà e non di sostituibilità. Questa implicazione deriva dal bilancio
dei materiali definito nella prima legge della termodinamica.
Tuttavia, anche la seconda legge, la legge dell’entropia, ha delle conseguenze
importanti sulla teoria della produzione. Come si è visto, essa implica
un’inevitabile degradazione della materia/energia in input e un’altrettanto
inevitabile produzione di scarti. Inoltre, nel modello roegeniano, anche i fattori
fondo sono soggetti al medesimo processo di logoramento: un tornio, ad esempio,
entra in buone condizioni nel processo produttivo, ma dopo un certo tempo l’uso
l’avrà sicuramente logorato. Per riportare i fattori fondo alle condizioni iniziali
sarà necessario un certo ammontare di energia e materia. La sostenibilità del
processo produttivo dipende dalla presenza costante di flussi di materia ed energia
destinati al mantenimento dei fondi. Il processo produttivo si presenta così come
un rapporto di natura circolare e sistemica che discende direttamente
dall’applicazione delle leggi della termodinamica al processo economico.
Nell’economia standard, il problema delle risorse naturali viene spesso liquidato
sostenendo che la tecnologia sarà in grado di sostituire qualsiasi tipo di capitale
naturale: intese come terra ricardiana, le risorse naturali sono perfettamente
sostituibili con capitale e lavoro. L’economista rumeno inserisce, invece, una
netta distinzione tra il capitale naturale e il capitale realizzato dall’uomo, negando
qualsiasi possibilità di sostituzione tra le due forme di capitale. Occorre, però, fare
una precisazione: Roegen parla di produzione in termini rigorosamente fisici,
mentre gli economisti neoclassici si riferiscono alla produzione in termini di
valore. Il valore implica i prezzi e questi ultimi l’utilità associata a determinati
beni o servizi. Questo porta la questione della sostituibilità/complementarietà su
un piano totalmente differente. Mentre Georgescu-Roegen fa riferimento alle
82
possibilità di sostituzioni fra capitale naturale e capitale manufatto per produrre
uno stesso bene, gli autori neoclassici fanno riferimento alle possibilità di
sostituzione che si presentano per produrre un determinato livello di benessere. Le
possibilità di sostituzione che la tecnologia offre, fra una forma di capitale e
un’altra, sono presenti solo se si ragiona in termini di utilità, mentre sono assai più
limitate se si tratta di produrre un certo bene, in termini fisici.
Inoltre, diventa importante la scala di riferimento: a livello di mercato e di
industria le possibilità tecnologiche sono più diffuse grazie alla potenzialità di
combinazione tra diverse risorse e prodotti intermedi. Tuttavia, se si estende la
scala all’economia intesa come un tutto, le possibilità di sostituzioni si riducono
drasticamente: il capitale manufatto, per la sua realizzazione, richiede l’uso di
risorse naturali, che, secondo la teoria di Roegen, sono limitate e soggette alla
legge entropica.
Esistono inoltre una serie di servizi ecologici, come i cicli naturali, la fotosintesi,
il mantenimento dell’atmosfera, che sono garantiti solo dalle risorse naturali, e
non possono essere sostituiti artificialmente.
3.4.2 Il problema energetico e il problema materiale
Georgescu-Roegen sviluppa la sua teoria economica in un contesto internazionale
molto particolare. Gli anni ’70 sono caratterizzati dalle crisi petrolifere che, per la
prima volta, cambiano la percezione della popolazione rispetto alle risorse
energetiche. Considerate fino al quel momento un bene abbondante e a basso
costo, petrolio e affini avevano permesso uno sviluppo industriale senza
precedenti. Gli shock petroliferi del 1973 e del 1979, misero in luce, invece, la
scarsità di queste risorse e la precarietà delle economie occidentali, strettamente
vincolate alla disponibilità energetica.
Alla luce della teoria bioeconomica, anche il problema energetico può essere
interpretato in un modo diverso rispetto all’economia tradizionale. L’uomo da
sempre ha cercato fonti di energia che gli permettessero di utilizzare nel modo
migliore i vari attrezzi esosomatici da cui è sempre più dipendente. Secondo
Roegen, due furono le tappe fondamentali nel progresso energetico: la scoperta
83
del fuoco e l’invenzione della macchina termica. Entrambe le tappe hanno
permesso di migliorare la qualità dell’energia a disposizione. Il controllo del
fuoco (conversione di energia chimica dei materiali in calore) ha consentito
all’uomo non solo di riscaldarsi e di cuocere i cibi, ma soprattutto di fondere e
forgiare i metalli, cuocere i mattoni, realizzare ceramica e calce.
L’invenzione della macchina termica, avvenuta alla fine del XVII secolo a opera
di Thomas Savery e Thomas Newcomen, consentì all’uomo di effettuare una
nuova conversione qualitativa: da potere calorifico a energia meccanica. La
macchina termica è alla base della macchina a vapore che consentirà la
rivoluzione industriale.
Caratteristica comune di fuoco e macchina termica è la possibilità di dare inizio a
una serie di reazioni a catena: come dalla piccola fiamma di un fiammifero è
possibile bruciare un’intera foresta, così da una macchina termica e un po’ di
carbone si può estrarre altro carbone e altri minerali per fabbricare diverse
macchine termiche che a loro volta possono produrre alti manufatti e altre
macchine termiche.
L’abbondanza apparente dei combustibili fossili che ha permesso lo sviluppo
dell’Occidente, secondo l’economista rumeno, ha nascosto agli studiosi la natura
entropica dell’energia, cioè l’inevitabile percorso verso la degradazione
dell’energia disponibile. Quello che si prospetta è una scarsità sempre più
evidente di risorse, che va affrontata, secondo Roegen, in un modo totalmente
differente da quanto fatto finora.
Poiché la Terra è un sistema chiuso, essa ha la possibilità di ricevere energia
dall’esterno, in particolare energia solare. Questo apporto ha consentito lo
sviluppo di quello che Georgescu-Roegen chiama “dogma energetico”: le teorie
secondo le quali solo l’energia conta, in quanto sarebbe possibile, con
un’adeguata quantità di energia, sfruttare e riciclare completamente qualsiasi
materia, in quanto quest’ultima può sostanzialmente essere ridotta a energia in
potenza. Il dogma energetico, criticato dall’economista, considera importante, dal
punto di vista umano, la sola energia netta, ovvero l’energia che resta al netto di
quella utilizzata per produrla; con un esempio, se per estrarre 10 tonnellate di
petrolio serve l’equivalente di 1 t di petrolio greggio, l’energia netta che ne risulta
84
è l’equivalente di 9 tonnellate di petrolio. In realtà, in questo bilancio energetico è
necessario inserire anche l’energia consumata per produrre o ripristinare tutte le
parti materiali utilizzate durante il processo. In sostanza, occorre tenere conto
anche della materia netta. Nel dogma energetico, però, la materia non viene
considerata, in quanto essa può essere completamente riciclata; non vi è perciò
nessuna necessità di inserire altra materia all’interno del processo. Presa alla
lettera, questa posizione energetica significa che tutto il pianeta potrebbe essere
conservato intatto per sempre.
Georgescu-Roegen non è d’accordo con questa posizione; la critica più forte è
indirizzata all’idea di riciclaggio completo della materia. Nell’universo non c’è
creazione di materia a partire dalla sola energia, almeno non in proporzioni
minimamente significative, mentre quantità enormi di materia sono convertite
continuamente in energia. L’idea di un riciclaggio completo della materia parte
dall’analogia con i cicli naturali, dove elementi come l’ossigeno, l’azoto e
l’anidride carbonica vengono riciclati da processi naturali mossi dall’energia
solare. Nella realtà, la quantità di sostanze chimiche in questione è talmente alta
che il deficit entropico diventa visibile solo su periodi molto lunghi. In effetti, ad
esempio, parte dell’anidride carbonica finisce sotto forma di carbonato di calcio
negli oceani, mentre il fosforo degli innumerevoli scheletri di pesci morti
tendenzialmente resta disperso sul fondo degli oceani.
L’idea di riciclaggio completo viene spesso spiegata con l’analogia di una collana
di perle: si sostiene, infatti, che è sicuramente possibile riunire tutte le perle di una
collana spezzata. Per scoprire l’errore, secondo Georgescu-Roegen, occorre
cambiare scala: se è relativamente semplice raccogliere tutte le perle cadute sul
pavimento di una stanza, diventa assai più complicato se le stesse perle sono state
sciolte in un acido e poi disperse nell’oceano. Anche disponendo di tutta l’energia
disponibile, ci vorrebbe un tempo estremamente lungo e pressoché infinito per
rimettere insieme tutte le perle. Eppure questo è esattamente ciò che accade alla
maggior parte della materia: essa si disperde nell’ambiente in particelle
infinitesime a causa dell’uso, della legge dell’entropia e dell’attrito.
Il dogma energetico tende a ignorare il problema dell’attrito, eppure esso risulta
fondamentale per capire effettivamente quale sia il bilancio effettivo di materia ed
85
energia al termine di un qualsiasi processo. Infatti, qualsiasi evento vi sia in corso,
esso non può evitare di fare i conti con l’entropia e con l’attrito. Ogni materiale,
anche il più resistente, deve fare i conti con un inevitabile logoramento. La teoria
termodinamica, inizialmente, ha aggirato il problema inserendo come ipotesi la
tesi secondo cui un movimento sia reversibile se la sua velocità è
infinitesimamente piccola. Si parla di movimento reversibile perché, in
termodinamica, questo significa riportare qualcosa alle sue condizioni originarie,
esattamente quello che dovrebbe fare un riciclaggio completo. Il problema è che
una velocità infinitesimamente piccola significa un tempo infinito per compiere
un movimento: l’infinito, però, è estraneo alle logiche umane. Quindi, sostiene,
Roegen, forse sulla carta è anche possibile ipotizzare il riciclaggio completo, ma
nella realtà non esistono eventi totalmente reversibili.
Se questo è vero per la materia, il concetto assume ancora più significato applicato
all’energia: l’energia disponibile non può essere trasformata completamente in
lavoro utile, parte di essa viene sempre trasformata in calore irrecuperabile.
Il problema è che esistono, nella fisica, numerose imperfezioni che non
permettono la reversibilità di un evento: oltre all’attrito, occorre considerare che
non esistono materiali perfettamente elastici, o perfettamente isolanti, o
perfettamente conduttori. La materia è continuamente modificata e dispersa e, a
causa dell’entropia, diventa sempre meno disponibile per gli scopi umani.
Il dogma energetico sostiene che la dissipazione può essere completamente
corretta purché l’energia disponibile sia sufficiente. Eppure anche il riciclaggio ha
bisogno di una struttura materiale per essere effettuato e, poiché non esistono
strutture materiali eterne, questi strumenti verranno consumati e dovranno essere
sostituiti con altri. A conti fatti, il bilancio del riciclaggio sarà sempre in deficit:
per riciclare una certa quantità di materia è comunque necessario utilizzare molta
energia e altro materiale rispetto a quello che viene riciclato.
Un altro importante problema legato alla materia e all’energia riguarda la
disponibilità e la possibilità d’uso. Sia la materia che l’energia sono presenti in
quantità grandi sulla terra, ma non sempre in forma disponibile: dell’energia
solare si è già detto, riferendosi ai problemi di cumulabilità e sfruttamento della
stessa, ma esistono anche altre forme di energia difficilmente utilizzabili. Uno
86
degli esempi più eclatanti è l’enorme riserva di energia termica contenuta negli
oceani (il differenziale di temperatura tra le acque profonde e la temperatura
ambiente): c’è chi ha stimato che questa energia valga addirittura 20 volte il
fabbisogno energetico dell’umanità, ma pur essendo molta in quantità, è assai
povera in qualità; dal punto di vista tecnologico non è di nessuna utilità e non è
sfruttabile.
Anche per quanto riguarda la materia esistono le stesse difficoltà: attraverso la
legge entropica, grandi quantità di materia aumentano continuamente la loro
entropia riducendo la loro utilità. La materia aggiunge un ulteriore elemento di
criticità: essa, infatti, è estremamente eterogenea e difficilmente si trova allo stato
puro. Questo implica delle difficoltà sia a monte che a valle: al momento
dell’estrazione servirà tanta più energia tanto più la materia è eterogenea e lo
stesso varrà al momento del riciclaggio.
La conclusione a cui giunge Georgescu-Roegen è che, se tra energia e materia, a
livello assoluto, è la materia a essere scarsa, dato che l’energia teoricamente
giunge sulla Terra dall’esterno, allora non è possibile basare il proprio modello di
sviluppo solo sull’energia. L’ipotesi che sia possibile creare della materia con
l’energia (ad esempio attraverso un riciclo completo), non è sostenibile per i
motivi di cui sopra. Anche l’idea che la scarsità di risorse naturali possa essere
sostituita dal capitale ha pochi fondamenti. Come descritto nel paragrafo
precedente, fondi e flussi non possono essere sostituiti e inoltre i fondi hanno
bisogno di un continuo flusso di manutenzione per essere mantenuti costanti.
La conseguenza più intuitiva è che le scelte economiche non possono basarsi solo
su una valutazione energetica: non sempre la tecnologia migliore è quella che
utilizza meno energia. E’ importante valutare la tecnologia anche dal punto di
vista materiale, sia rispetto alla materia usata per la produzione vera e propria, sia
rispetto alla materia che serve da supporto fisico per l’impiego di energia in quel
determinato processo.
La critica di Georgescu-Roegen colpisce anche l’energia solare: essa, infatti, viene
considerata un’energia non vitale. Per tecnologia vitale l’economista intende una
tecnologia in grado di sopravvivere da sé, ovvero, una volta nata da una
tecnologia precedente, deve essere in grado di mantenersi. L’esempio citato da
87
Roegen va indietro nel tempo: i primi martelli di bronzo furono forgiati con
martelli di pietra, ma, nell’era successiva, tutti i martelli di bronzo vennero
costruiti con martelli di bronzo. La debolezza dell’energia solare sarebbe tutta qui:
all’epoca di Roegen l’energia accumulata da un collettore solare non permetteva
di costruire un altro collettore solare, era ancora un’energia “parassitaria” della
tecnologia già esistente.
L’analisi di Georgescu-Roegen risulta piuttosto impietosa rispetto alle future sorti
dell’umanità. Egli, infatti, denuncia lo scarso interesse da parte del mondo
accademico alle problematiche legate al problema energetico e alla scarsità delle
risorse naturali. L’uomo è ormai schiavo delle strutture esosomatiche, create
dall’illusoria abbondanza di combustibili fossili nell’età dell’oro del secondo
dopoguerra. Lo sviluppo umano reso possibile da quelli che l’economista chiama
i doni di Prometeo I (il controllo del fuoco) e Prometeo II (la macchina termica),
può continuare solo con l’avvento di un Prometeo III, che doni all’umanità una
nuova tecnologia in grado di garantire un’energia autoperpetuantesi. Nel
frattempo, la sola strategia ragionevole indicata da Roegen è solo quella di
accumulare il più grande vantaggio temporale possibile nell’attesa di questo
incerto Prometeo III, riducendo il più possibile lo spreco di energia e materia in
prodotti e attività assolutamente superflui.
88
3.5 Il programma bioeconomico
Quasi duecentocinquanta anni fa Smith sintetizzava con una metafora geniale lo
spirito del liberismo: ogni individuo, perseguendo il proprio interesse auto
interessato, è spinto da una mano invisibile a promuovere un fine che non era
previsto dalle sue intenzioni, ossia a favorire il bene della collettività. Tuttavia,
seguendo le linee tracciata da Georgescu-Roegen appare evidente che agendo
all’interno di un sistema limitato, l’irreversibile processo di degradazione
entropica implica l’inadeguatezza del criterio di razionalità basato sulla pulsione
egoistica individuale. Il punto di conflitto è la pulsione egoistica stessa, che spinge
l’economia verso la crescita continua della produzione e dei consumi. La teoria
bioeconomica insegna che, in primo luogo, nonostante l’implementazione di
nuove tecnologie riduca sempre di più gli sprechi, è impossibile sostituire le
risorse in via di esaurimento con nuove risorse; in secondo luogo, mostra come le
leggi della termodinamica indichino che il consumo assoluto, nel sistema Terra,
non può che aumentare. In sostanza: un sistema fisicamente limitato non è
compatibile con la crescita illimitata.
Se le cause della rivoluzione industriale e dell’utilitarismo economico che l’hanno
animata sono storiche e non naturali, ciò che ha funzionato per il passato non
necessariamente funzionerà anche per il futuro. E’ in questa osservazione che si
può individuare l’essenza della critica evoluzionistica roegeniana. Il cambiamento
è indissolubilmente legato alla Storia, esso modifica il ruolo e il significato dei
concetti a seconda dell’evoluzione del contesto: i principi di razionalità che si
sono dimostrati vincenti in un’epoca possono non essere più validi in un periodo
successivo. Così, mentre agli albori della società industriale l’egoismo del birraio
e del macellaio era funzionale all’innescarsi del processo di accumulazione,
l’egoismo utilitaristico dell’uomo contemporaneo comporta una diffusione del
consumismo e una crescente pressione sugli ecosistemi.
Georgescu-Roegen, nel 1975, propone, in un articolo pubblicato su The Southern
Economic Journal, un programma bioeconomico minimale in otto punti15.
15
N. Georgescu-Roegen, 1975, Energy and Economics Myths, in “The Southern Economic
Journal, XLI, 3, pubblicato anche in N. Georgescu-Roegen, 1998, Energia e miti economici,
Bollati Boringhieri, Torino.
89
La prima preoccupazione dell’economista è quella di abolire la produzione di tutti
gli armamenti bellici. La critica alla produzione di prodotti assolutamente
superflui che si incrocia spesso negli scritti dell’autore, si associa alla convinzione
che nulla possa essere più sprecato di una produzione destinata alla distruzione.
Le Nazioni sviluppate, che coincidono con le maggiori produttrici di armamenti,
potrebbero così destinare una grande quantità di forza produttiva verso altri
settori, senza far abbassare il tenore di vita nei paesi stessi. Inoltre, considerazione
non di poco conto, la conseguente proibizione della guerra, o meglio
l’impossibilità di metterla in atto senza strumenti, eliminerebbe moltissime morti
inutili.
Il secondo punto analizza la possibilità di destinare le forze produttive liberate
dall’industria bellica all’aiuto delle Nazioni in via di sviluppo, per permettere alle
popolazioni di questi paesi di raggiungere in tempi brevi un tenore di vita buono.
L’autore precisa nel suo articolo che il livello di vita a cui bisogna puntare è un
livello “buono” e non “lussuoso”: l’idea di sviluppo presente nel pensiero di
Roegen non è quella di esportare il modello occidentale di produzione e consumo
in tutto il resto del mondo, ma quello di garantire a tutta la popolazione del mondo
una vita dignitosa, garantendo al tempo stesso la sopravvivenza del sistema Terra.
Come in tutte le ricette per lo sviluppo, anche il programma bioeconomico
prevede una riduzione della popolazione. Il livello di popolazione ottimale
previsto dall’economista è quello in cui l’alimentazione possa essere
adeguatamente fornita dalla sola agricoltura organica. Per agricoltura organica,
Roegen intende un’agricoltura che non debba essere alimentata da materia ed
energia esterne, ma che sia in grado di autoriprodursi.
Occorre ridurre, come quarto punto, ogni tipo di spreco legato all’energia, almeno
fino a che non si sia sviluppata una tecnologia che ci permetta di utilizzare
appieno l’energia diretta del sole o la fusione nucleare. Lo spreco di energia,
infatti, non fa che accelerare l’aumento dell’entropia del sistema.
Il quinto punto è dedicato a quella che Georgescu-Roegen chiama “passione
morbosa per gli oggetti stravaganti”: uno degli esempi più amati dall’autore è
l’automobilina da golf, elevata a icona dell’inutilità di certi prodotti. La
produzione di tali beni è ovviamente subordinata alla domanda dei consumatori; il
90
cambiamento deve quindi partire da loro, evitando l’uso di tali beni inutili, che
altro non fanno se non consumare inutilmente materia preziosa.
Un’altra mania del consumatore occidentale viene analizzata nel sesto punto:
quella di ridurre sempre di più la durata del ciclo di vita dei prodotti.
L’economista rumeno considera un “crimine bioeconomico” azioni quali
acquistare un’auto nuova ogni anno o arredare la casa ogni due anni. Meglio,
invece, prolungare la vita dei prodotti finché sono ancora effettivamente
utilizzabili, al fine, ancora una volta, di evitare inutili sprechi. Roegen sottolinea
che sono i consumatori che devono essere rieducati a un diverso consumo, perché
solo in questo modo, con un cambiamento della domanda, anche i produttori
saranno costretti a modificare le caratteristiche dei loro prodotti, concentrandosi in
particolare sulla durabilità.
Il settimo punto, strettamente collegato al precedente, prevede una progettazione
che renda i beni riparabili: in questo modo si allunga la vita dei prodotti,
risparmiando denaro, materia ed energia.
Infine, Roegen propone di liberarci da quella che lui chiama “la circumdrome del
rasoio: radersi più in fretta il mattino per avere più tempo a lavorare a una
macchina che rada più in fretta, per poi avere più tempo per lavorare a una
macchina che rada ancora più in fretta e così via ad infinitum” (GeorgescuRoegen, 1982). L’obiettivo dell’uomo non deve essere quello di produrre sempre
di più per aumentare infinitamente i consumi, ma deve essere quello di godersi la
vita. Una vita buona, sostiene l’autore, è quella in cui una quantità considerevole
di tempo è trascorsa in modo intelligente.
Il programma bioeconomico impone un cambiamento radicale nelle abitudini del
genere umano, per lo meno di quella parte che vive nei Paesi industrializzati. Lo
stesso Roegen era molto scettico circa la possibilità che la sua proposta diventasse
popolare. In effetti, trent’anni dopo la pubblicazione di questo scritto, non ci sono
state inversioni di rotta nelle abitudini di consumo, tanto che le problematiche
presentate da Georgescu-Roegen sono ancora attuali.
91
3.6 La critica allo stato stazionario
Occorre sottolineare come, data la loro natura estremamente eterodossa, le teorie
dell’economista rumeno non furono accolte con entusiasmo dagli ambienti
accademici, nonostante risalgano a quegli anni gli studi che per primi indicarono
nell’esaurimento delle risorse il futuro limite per lo sviluppo economico. Essi
indicavano nello stato stazionario la soluzione per evitare il collasso del sistema.
Georgescu-Roegen, invece, fu critico anche nei confronti dei sostenitori dello
stato stazionario e questo, in un periodo in cui questa tesi era sposata e sostenuta
da molti studiosi, non giovò certo alla popolarità del nostro.
Secondo l’economista rumeno, il cambiamento, in tutte le sue forme, rappresenta
da sempre la massima sfida per ogni studioso. Allo stesso tempo, però, diventa
l’elemento più scomodo e imbarazzante per chiunque voglia definire una società
ideale. Ecco perché fin dall’antichità, lo stato stazionario ha offerto un tranquillo
rifugio per la mente di ogni pensatore. Già Platone e Aristotele, nei loro trattati di
politica indicavano nella popolazione stabile e nell’attenzione a evitare bruschi
cambiamenti le basi per le loro comunità ideali. In effetti, se si è in grado di
prevenire un cambiamento, è possibile assicurare una stabilità sociale permanente
e, quindi, una società che si avvicina il più possibile all’immortalità, come
sognava Platone.
Come visto nei paragrafi precedenti, Georgescu-Roegen si è preoccupato
tantissimo del cambiamento, per esso ha introdotto nell’economia tutti quei
fattori, tipici della biologia, che permettono di seguire l’evoluzione dei processi.
Anche per questo motivo, l’ipotesi di uno stato stazionario come salvezza
ecologica lascia l’economista piuttosto dubbioso e critico.
Roegen è ben consapevole dell’impossibilità di continuare a percorrere la strada
tracciata dall’economia occidentale, alla luce delle evidenze termodinamiche che
impediscono, di fatto, una crescita infinita. Tuttavia, proprio la seconda legge
dell’entropia porta l’autore a proporre una critica fisica all’idea di sviluppo
sostenibile basata sullo stato stazionario.
Il punto di partenza, ancora una volta, risiede nella legge entropica. GeorgescuRoegen propone un modello fondi-flussi per analizzare il ruolo dell’energia e
92
della materia nel processo economico, dimostrare come uno stato stazionario non
sia fisicamente sostenibile e proporre una quarta legge della termodinamica.
Il modello, in figura 3, rappresenta la circolazione globale dei flussi tra l’ambiente
e il processo economico. Questo viene diviso in sei sottoprocessi aggregati: la
produzione di energia controllata (per esempio l’elettricità), la produzione di
materia controllata (tutta la produzione di beni intermedi), la produzione di
capitale
Ambiente
cE
cM
K
C
R
d’esercizio,
Hh
la
eE
produzione di beni
eM
di
cE
consumo,
l’industria
del
riciclaggio
e
l’economia
cM
domestica.
K
C
questo
In
processo
economico
si
osservano
rGJ
due
flussi primari in
entrata, l’energia e
dE
la materia tratte
dall’ambiente; in
dM
uscita si hanno i
W
flussi
rappresentati
Figura 3
Circolazione globale dei flussi tra l’ambiente e il processo economico
cE: produzione di energia controllata
cM: produzione di materia controllata
K: produzione di capitale d’esercizio
C: produzione di beni di consumo
R: industria di riciclaggio
Hh: economia domestica
eE: energia tratta dall’ambiente
eM: materia tratta dall’ambiente
dE: energia dissipata
dM: materia dissipata
W: scarti
rGJ: garbojunk
finali,
dall’energia
dissipata,
dalla
materia dissipata e
dagli
scarti.
Energia dissipata
e materia dissipata
rappresentano
risorse
non
più
93
utilizzabili perché ormai ad alta entropia; ne sono un esempio il calore che si
disperde nelle conversioni di energia o i frammenti microscopici di acciaio che un
coltello perde durante l’uso. Esempi di scarti sono invece la roccia frantumata o le
scorie nucleari.
Ogni attività economica produce garbojunk, neologismo coniato dallo stesso
Roegen, formato dalle parole garbage, rifiuto, e junk, cosa inutile. Essi non sono
né materia dissipata, né rifiuto, ma materia utilizzabile che, tuttavia, non si
presenta sotto forma per noi utile. Esempi sono bottiglie rotte, vecchi giornali,
abiti usati. L’industria del riciclaggio è in grado di riciclare solo garbojunk,
poiché la materia dissipata è non riciclabile. L’industria del riciclaggio ricicla tutta
la garbojunk, compresa quella prodotta da lei stessa, così che non esiste un flusso
in uscita di questo genere.
Il diagramma dei flussi rivela alcuni concetti importanti. In primo luogo, nessun
sistema economico può sopravvivere senza un apporto continuo di energia, ma
anche di materia: questo ha un’implicazione fondamentale circa le tesi che
sposano l’idea di stato stazionario. Se la Terra è un sistema chiuso, cioè riceve
dall’esterno solo energia, ma non materia, questo significa che è impossibile
costruire un sistema chiuso allo stato stabile. Anche se tutti i rifiuti venissero
riciclati completamente, la dissipazione dell’energia impedirebbe comunque ai
fondi del capitale di restare costanti.
In secondo luogo, Georgescu-Roegen giunge a formulare la quarta legge della
termodinamica: in un sistema chiuso, l’entropia della materia deve tendere verso
un massimo. Se le leggi classiche della termodinamica prendono in
considerazione solo l’energia, con l’enunciazione di questa quarta legge
l’economista ribadisce ancora una volta come sia la materia il nodo con cui deve
fare i conti il processo economico. La materia, finita, rende impossibile pensare a
uno sviluppo infinito.
Per la maggior parte della sua storia l’umanità ha vissuto in una situazione
sostanzialmente stazionaria, ma la rivoluzione industriale e il successivo sviluppo
hanno aumentato a dismisura il prelievo di risorse materiali: prima o poi, Roegen
ne è convinto, l’Occidente si dovrà scontrare con un’accessibilità decrescente
della materia-energia di cui ha bisogno.
94
La trappola epistemologica nella quale sono caduti i fautori di uno stato
stazionario, secondo Georgescu-Roegen, è quella di presupporre che uno stato
stabile possa permette il mantenimento costante del capitale naturale. Esso in
realtà non si autoproduce, almeno non a livello globale, in quanto ogni nuova
forma di vita e ogni nuovo prodotto non significano altro che un aumento
dell’entropia in qualche parte del sistema.
L’idea di stato stazionario è una delle soluzioni proposte da chi si ritiene
sostenitore di uno sviluppo sostenibile. Questo concetto, secondo Roegen, è un
concetto appoggiato da molti perché si presta a essere interpretato in molti modi
differenti, tanto da diventare, alla fine, privo di un significato forte. Non è un caso
che il concetto sia sposato da correnti di pensiero nettamente diverse e che l’idea
di sostenibilità venga associata alle impostazioni più disparate.
Il futuro prospettato da Georgescu-Roegen non è certamente roseo. Tuttavia, egli
propone di affrontare l’invitabile lotta contro l’entropia seguendo una nuova etica.
95
3.7 L’etica bioeconomica
La teoria bioeconomica non è, per Georgescu-Roegen, solo un criterio economico,
ma un approccio diverso ai problemi delle tensioni tra gli esseri umani.
L’ineguaglianza è la causa di tali tensioni. Le differenze, nel mondo naturale sono
normali e invitabili. Tuttavia, l’uomo ha sviluppato una forma di ineguaglianza di
natura totalmente differente: l’ineguaglianza sociale, causata dalla differenza
economica tra i vari gruppi sociali.
La singolarità umana dipende dal fatto che essa, unica tra tutte le specie, ha
seguito un’evoluzione esosomatica: l’uso e la produzione di quelli che possono
essere definiti prolungamenti degli arti endosomatici hanno consentito uno
sviluppo senza precedenti. Questa caratteristica peculiare ha avuto, però, due
conseguenze negative.
La prima viene definita dall’economista rumeno “assuefazione alle comodità”, e
fa riferimento a quanto già citato nei paragrafi precedenti: l’uomo produce e
consuma molto più di quanto sarebbe necessario e molto più di quanto la natura
finita delle risorse naturali potrebbe permettere.
La seconda conseguenza è stata quella di creare il conflitto sociale. Possedere o
meno degli strumenti esosomatici (non sempre oggetti materiali: nel caso della
schiavitù, ad esempio, uomini sono stati utilizzati come strumenti esosomatici da
altri uomini), significa avere una determinata posizione nella società. E’ nata così
la suddivisione del lavoro in base alle professionalità e la divisione tra lavoro
produttivo e lavoro improduttivo, che è la causa dei conflitti sociali tra le classi.
Secondo Roegen, il conflitto sociale non potrà essere appianato finché il nostro
modo di vita dipenderà dalla produzione e dall’uso di strumenti esosomatci. I
modelli economici che utilizzano tasse, sussidi e trasferimenti non sono adeguati a
prevenire la violenza del conflitto sociale, poiché essa è iscritta nel modo di vita
esosomatico. I soli strumenti per prevenire il peggioramento sono di tipo politico,
e devono assicurare la libertà di critica e il diritto di approvare o rifiutare con il
voto i governanti e le loro scelte. E’ chiaro che la popolazione deve essere a
conoscenza della situazione e deve prendere coscienza della finitezza del pianeta.
96
L’idea di crescita industriale come cura per i mali e le diseguaglianze umane è
considerata, dall’autore, un mito da cui occorre liberarsi: la crescita fine a se
stessa non può che aumentare il conflitto sociale sia all’interno della società
occidentale, sia tra la minoranza ricca e la maggioranza povera dell’umanità.
Roegen considera la suddivisione tra primo e terzo mondo come una divisione
esosomatica in razze all’interno della specie umana. La differenza non sta nella
cultura, nel colore della pelle o nelle tradizioni: è il diverso uso degli attrezzi
esosomatici che crea la diversità. La prova, secondo l’economista, si troverebbe
nell’analisi dei risultati degli aiuti finanziari che gli Usa hanno speso dal secondo
dopoguerra fino agli anni ’70. Gli Stati Uniti hanno indirizzato i loro contributi sia
verso l’Europa Occidentale e il Giappone (attraverso il Piano Marshall), sia verso
i Paesi del Terzo Mondo (tramite i vari piani di sviluppo promossi dalle Nazioni
Unite). Ebbene, i risultati sono stati nettamente diversi: nel primo caso l’obiettivo
è stato pienamente raggiunto, nel secondo, in particolare nei paesi più bisognosi, il
risultato è stato vicino allo zero nonostante lo sforzo compiuto. La spiegazione,
per Roegen, consiste nel fatto che Europa e Giappone appartengono alla stessa
specie esosomatica degli Usa, mentre i Paesi meno sviluppati appartengono a una
specie esosomatica diversa. Gli Stati Uniti fornivano la tecnologia necessaria alla
ripresa, ma una tecnologia importata dall’estero, se non è compatibile con la
propria struttura esosomatica, non può essere implementata con successo.
In sostanza, lo sviluppo nei Paesi sottosviluppati può avvenire solo se ricerca e
sviluppo si occupano di migliorare il livello esosomatico dei Paesi sottosviluppati
e non di esportare la tecnologia creata per una struttura esosomatica differente.
Inoltre, data la finitezza degli ecosistemi, le Nazioni più sviluppate dovrebbero
ridimensionare il loro livello di benessere, eliminando il superfluo, in modo da
liberare risorse per un adeguato sviluppo dei Paesi più poveri.
Occorre un cambiamento di valori sia nei Paesi occidentali che in quelli
sottosviluppati: i primi devono rinunciare a tutto quello che affossa la vita sotto
una montagna di gadget inutili, i secondi devono riconoscere l’illusione nascosta
nella mania della crescita e impegnarsi per ridurre in modo cospicuo la
popolazione.
97
Quello che prospetta Georgescu-Roegen sono una politica e un’economia
indirizzate verso un desviluppo dei Paesi sviluppati, inteso come processo di
liberazione dell’uomo dall’ossessione per l’accumulazione dei beni materiali
tipica della civiltà industriale e conseguenza del sistema capitalistico. Se la società
a crescita illimitata è un’illusione, e altrettanto illusoria è la prospettiva di una
società stazionaria, quello che occorre è un radicale rinnovamento dei
comportamenti di consumo e un cambiamento dei modi di produzione, del
mercato e dunque dei rapporti di produzione. Non può essere il mercato a
risolvere i problemi di natura bioeconomica, né può affrontare le prospettive che
essa apre, dato che esse sfuggono alla logica dell’economia capitalista. Occorre
una nuova etica e un nuovo modello di consumi, che molti, oggi, chiamano
decrescita.
98
Capitolo 4
DALY E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Le teorie di Georgescu-Roegen sono state riprese, per essere rielaborate, da
Herman Daly, classe 1938, suo allievo e fondatore dell’Ecological Economics,
corrente economica che basa le sue teorie sullo stato stazionario e sullo sviluppo
sostenibile. I rapporti con Roegen non sono stati sempre felici, anzi le lettere tra i
due testimoniano come l’economista rumeno fosse in disaccordo profondo con le
tesi che la nuova teoria economica andava sviluppando; infatti, quando nel 1989
Daly inizia la pubblicazione della rivista “Ecological Economics”, diventata poi
punto di riferimento nel nuovo ambito disciplinare, Georgescu-Roegen non fa
parte del comitato scientifico della rivista. I principali motivi di scontro tra i due
economisti sono da ricercare nell’idea di stato stazionario. Come visto nel capitolo
precedente, Roegen giunge a criticare la possibilità di sostenere uno stato
stazionario, in quanto reputa impossibile un completo riciclaggio della materia,
che può evolvere solo da una situazione di maggiore disponibilità a una situazione
di minore disponibilità.
La visione di Daly è più ottimista e fortemente basata sull’idea della necessità e
sostenibilità di uno stato stazionario; egli deriva le sue teorie dalla bioeconomia di
Roegen, ma segue un approccio diverso: mentre l’economista rumeno rifiuta in
modo netto l’economia standard, riscuotendo in questo modo scarsi consensi e
molte critiche, Daly parte dall’analisi dell’economia neoclassica e sviluppa la sua
teoria all’interno di essa, criticando, anche in modo importante, alcuni assunti, ma
senza rifiutare il metodo economico mainstream. Egli, infatti, non vuole creare
una nuova teoria economica, ma trovare le lacune che essa incorpora e colmarle.
Herman Daly, laureato presso la Vanderbilt University di Nashville, diventa
professore associato presso la Louisiana State University nel 1968 dove insegna
fino al 1988. Durante la sua esperienza alla LSU è stato anche Visiting Professor
di economia presso l'Università degli Studi di Ceará, Brasile (1968), dove è
tornato nel 1983 e ha osservato dal vivo le distorsioni delle politiche di sviluppo; è
stato ricercatore associato all'Università di Yale (1969-70) e Visiting Fellow
99
presso il Centro per le Risorse e Studi Ambientali della Australian National
University (1980). Dal 1988 al 1994 è stato Senior Economist nel Dipartimento
Ambiente della Banca Mondiale, dove ha introdotto le teorie sullo sviluppo
sostenibile e ha tentato di applicarle nelle politiche di sviluppo promosse dalla
Banca Mondiale nei Paesi in via di sviluppo. Dal 1994 è Senior Research Scholar
presso la School of Public Affairs della University of Maryland. Nel 1996, oltre al
Right Livelihood Award, Daly ha ricevuto il Premio Heineken Environmental
Science rilasciato dalla Reale Accademia delle Arti e delle Scienze dei Paesi
Bassi.
Il pensiero di Herman Daly si sviluppa a partire dal concetto di “fallacia della
concretezza mal posta”, consistente nel considerare reali, al posto degli oggetti
concretamente percepiti, le astrazioni fisico-matematiche e i concetti teoricooperativi della scienza. L’economista fa proprio un concetto sviluppato da
Whitehead, e lo utilizza per criticare l’impostazione, che egli considera
dogmatica, della scienza economica mainstream. Gli economisti neoclassici,
secondo Daly, hanno fatto della scienza economica una disciplina che è rimasta
chiusa nelle università, i cui teoremi e leggi, frutto di un’astrazione, vengono
applicati tout court al mondo reale, senza operare gli opportuni aggiustamenti nel
passaggio dall’astrazione alla realtà.
Gli errori che emergono da questa discrepanza vengono analizzati da Daly per
giungere a formulare una teoria economica in cui la principale dimenticanza
dell’economia standard, l’ambiente, entra a pieno titolo come attore attivo del
processo economico. La consapevolezza di vivere in un mondo dotato di risorse
finite porta l’economista a riscoprire la teoria di stato stazionario, già proposta da
J. S. Mill, per perfezionarla e applicarla al concetto di sviluppo sostenibile. Fatto
proprio l’insegnamento di Georgescu-Roegen ed eliminatone i tratti più estremisti,
Daly giunge a formulare una nuova idea di sviluppo, utile sia per i Paesi
occidentali che per i Paesi in via di sviluppo, in cui economia e ambiente non sono
due mondi separati, ma un unico sistema integrato.
La teoria di Daly si può riassumere in tre critiche all’economia neoclassica che
possono essere definite, usando la terminologia di Whitehead, nel seguente modo:
100
1. fallacia ecologica: il processo economico non può essere chiuso tra
processo e consumo, ma occorre considerare l’economia come un
sottoinsieme di un sistema più grande, l’ambiente, che ha risorse finite;
2. fallacia sociale: l’uomo è stato ridotto a Homo eoconomicus, eliminando
tutte le motivazioni non economiche e i rapporti di interdipendenza,
escludendo la dimensione sociale dei rapporti umani dal contesto
economico;
3. fallacia morale: sotto forma di Pil si pretende di misurare il benessere; in
realtà questo indice, che viene presentato come imparziale, incorpora
giudizi politici ed esprime una realtà distorta, senza tener conto dei valori
del tempo e della società.
101
4.1 Mondo vuoto e mondo pieno
Riprendendo la teoria della produzione sviluppata da Georgescu-Roegen, Daly
sostiene la necessità di riconsiderare lo spazio dentro al quale opera il sistema
economico. La macchina economica non viaggia, infatti, in uno spazio vuoto, ma,
come ogni altro processo sulla Terra, è sottoinsieme di uno spazio più grande: il
sistema ambiente.
Poiché l’economia neoclassica considera il processo economico un sistema
isolato, senza prendere in considerazione l’ambiente, Daly propone di adottare
una nuova visione. “Il mutamento di visione necessario consiste nel rappresentare
la macroeconomia come un sottoinsieme aperto di un ecosistema naturale non
illimitato (l’ambiente), anziché come un flusso circolare isolato di valore di
scambio astratto, non vincolato da equilibri di massa, entropia ed esauribilità. Il
flusso circolare del valore di scambio è un’astrazione utile, […] ma getta
un’ombra impenetrabile su tutte le relazioni fisiche tra la macroeconomia e
l’ambiente” (Daly, 2001).
Il vero problema, allora, diventa la relazione del sottosistema rispetto al suo
insieme superiore e, soprattutto, le dimensioni che il sottosistema assume nei
confronti dell’insieme che lo sostiene. Se, infatti, materiale ed energia che
permettono il processo economico provengono dall’insieme ambiente, allora sarà
importante sapere quali sono le sue dimensioni.
Lo schema proposto in figura 4 può essere utile per comprendere meglio il
problema.
La scala dell’ecosistema rimane costante a causa delle leggi termodinamiche, già
viste nel capitolo precedente. Il sottoinsieme economico, invece, può crescere o
contrarsi, variando le sue dimensioni. Quello che è avvenuto, a partire dalla
rivoluzione industriale, è una transazione da un mondo relativamente “vuoto”,
dove l’economia aveva proporzioni molto limitate rispetto all’ambiente, a un
mondo “pieno”, dove le proporzioni del mondo economico sono cresciute in
modo esponenziale, occupando gran parte dello spazio naturale. Se nel passato il
fattore limitante era rappresentato dal capitale di produzione umana, oggi il fattore
limitante è diventato il capitale naturale residuo.
102
Mondo “pieno”
Mondo “vuoto”
Ecosistema
S
Ecosistema
S
M
M
M
Economia
Economia
E
E
M
E
E
Capitale di produzione umana
Capitale naturale
S = Energia solare
M = Materia
E = Energia
Figura 4 – Mondo pieno e
mondo vuoto
L’idea che le risorse naturali siano dei doni gratuiti deve essere riconosciuta come
falsa. Se è vero, infatti, che il costo in situ delle materie prime è stato storicamente
considerato pari a zero, tuttavia questa valutazione ha sempre omesso di
considerare il costo di reintegrazione di tali risorse, indispensabile per mantenere
inalterato il servizio reso da esse. Il concetto di servizio viene derivato dalla
definizione di reddito elaborata da Fisher: il flusso di servizi che in un
determinato periodo di tempo viene reso dallo stock di capitale. E’ inteso come un
reddito psichico, ovvero come il benessere, soggettivo, ottenuto tramite i servizi
diretti al soddisfacimento dei bisogni. I servizi sono resi dallo stock e
dall’ecosistema naturale. Lo stock comprende la scorta totale di tutti i beni di
produzione e di consumo, in sintesi le persone fisiche e le loro estensioni
materiali, e può essere definito come l’insieme di tutti gli oggetti atti a soddisfare i
bisogni umani e soggetti a un rapporto di proprietà. Lo stock di prodotti manufatti
103
richiede throughput per la sua manutenzione, ovvero un flusso entropico di
materia ed energia che proviene da fonti naturali, attraversa tutta l’economia
umana e torna nell’ambiente sotto forma di scarti. Esso è necessario per la
conservazione dello stock e determina un consumo delle risorse naturali. Il
throughput, così come definito da Boulding nel 1966, è un costo, che
generalmente non viene considerato nell’economia neoclassica, ma che
rappresenta, invece, un elemento essenziale nella determinazione delle dimensioni
del sottoinsieme economico. “Il servizio (reddito psichico netto) è il beneficio
finale dell’attività economica. Il throughput (un flusso fisico di entropia) è il costo
finale” (Daly, 1981).
I problemi da risolvere a livello macroeconomico a questo punto diventano tre:
l’allocazione, la distribuzione e la scala. Essi non possono essere risolti
completamente dal mercato, perché, sostiene Daly, essi non riguardano solo il
sottoinsieme economico, ma la sua relazione con l’insieme superiore, l’ambiente,
trascurato nelle teorie standard.
“Il mercato funziona solo nei confini del sottoinsieme economico, dove fa
un’unica cosa: risolve il problema allocativo fornendo l’informazione e gli
incentivi necessari. Fa quell’unica cosa molto bene. Quello che non fa è risolvere i
problemi della scala e della distribuzione ottimali” (Daly, 2001).
In un mondo pieno, come quello attuale, definire le dimensioni della scala diventa
un problema fondamentale. Se il mondo è sempre più “pieno”, allora occorre
valutare fino a che punto l’insieme ambiente è in grado di sostenere e mantenere
questo livello. L’allocazione ottimale di una data scala del flusso di risorse fra usi
diversi all’interno di un’economia rappresenta un problema microeconomico; ben
altra cosa è stabilire la scala ottimale dell’intera economia rispetto all’ecosistema
(questione macroeconomica). Daly spiega la differenza con un esempio nautico:
“Il problema dell’allocazione micro è analogo a quello di distribuire in modo
ottimale un dato peso a bordo di un’imbarcazione. Una volta che la distribuzione
ottimale del peso sia stata determinata, rimane la questione del peso complessivo
che è costretta ad imbarcare. La scala ottima assoluta di carico è conosciuta, nella
terminologia nautica, come linea di Plimsoll, o linea di galleggiamento a pieno
carico. Quando l’acqua raggiunge la linea di Plimsoll l’imbarcazione è piena, ha
104
raggiunto la sua massima capacità portante, oltre la quale non è più sicura.
Ovviamente se il peso è distribuito male il livello dell’acqua raggiungerà la linea
di Plimsoll più in fretta. Tuttavia, man mano che il carico aumenta, l’acqua
raggiungerà la linea di Plimsoll, anche se il peso è stato distribuito in modo
ottimale. Imbarcazioni il cui carico è distribuito perfettamente affonderanno
comunque sotto un peso eccessivo – anche se può darsi che affondino in modo
ottimale! […] Il compito principale della macroeconomia ambientale è delineare
un’istituzione economica analoga alla linea di galleggiamento a pieno carico, per
evitare che il peso – la scala assoluta – dell’economia faccia affondare la nostra
arca biosferica” (Daly, 2001). Questa lunga citazione è una sintesi perfetta del
pensiero di Daly: l’obiettivo è fissare un limite da non superare, in altre parole,
giungere a uno stato stazionario.
105
4.2 Lo stato stazionario
4.2.1 Definizioni
Lo stato stazionario, per Herman Daly, non è solo un concetto economico, ma una
visione che abbraccia tutte le componenti umane, incluse l’etica e la morale.
Nei libri di testo, l’economia è definita come scienza che studia l’allocazione di
mezzi scarsi fra fini alternativi, dove lo scopo dell’allocazione è la
massimizzazione del raggiungimento di quei fini. In sintesi, l’economia consiste
nel modo di agire migliore con le risorse che si hanno a disposizione. “Ma non
viene considerata l’intera gamma dei fini e dei mezzi; gli economisti non parlano
del Fine ultimo, neppure dei mezzi primari. L’attenzione degli economisti è
completamente concentrata sul campo medio di tale spettro, allocando mezzi
intermedi dati (lavoro, prodotti) per il raggiungimento di determinati fini
intermedi (cibo, benessere, istruzione)” (Daly, 1981).
Rispetto all’economia della crescita, seguita dagli economisti neoclassici,
l’economia di stato stazionario implica una trasformazione della visione del
mondo che analizzi le anomalie teoretiche e morali dell’economia standard e
mostri i fallimenti pratici nei quali essa è incorsa.
Occorre, innanzitutto, definire che cosa si intende per economia della crescita e
per economia di stato stazionario. “Il termine crescita, […] si riferisce a un
aumento nella scala fisica del flusso materia/energia che sostiene le attività
economiche di produzione e di consumo di beni. In un’economia di stato
stazionario il volume di risorse messe in lavorazione è costante, sebbene la sua
allocazione tra usi alternativi sia libera di variare in risposta al mercato” (Daly,
2001).
Un’economia di crescita presuppone risorse infinite. Come si è già avuto modo di
vedere nei capitoli precedenti, l’insieme delle materie prime presenti sul pianeta è
invece finito. La legge di entropia fa il resto: le risorse naturali sono
continuamente trasformate in scarti ad altra entropia, non più utilizzabili.
L’illusione di una crescita illimitata è data dalle caratteristiche degli stock
terrestri, che possono essere struttati più rapidamente, con prezzi bassi che
distorcono le informazioni circa la scarsità. Il sistema economico attuale è
106
dipendente da risorse scarse, invece che da quelle abbondanti, e il sistema
produttivo si muove tra l’impoverimento delle risorse naturali a monte e
l’inquinamento dell’ambiente a valle.
La crescita è un aumento quantitativo: essa si riferisce alla scala fisica della
produzione e del consumo; implica, infatti, maggiori livelli di beni e servizi
prodotti e maggiori livelli di consumo. Il miglioramento qualitativo nell’impiego
di una data scala di produzione fisica, che può risultare da un avanzamento
tecnologico, da un migliore utilizzo delle risorse, si può chiamare “sviluppo”.
Questa è la principale differenza tra un’economia stazionaria e un’economia di
crescita: quest’ultima, come dice il nome stesso, tende alla crescita quantitativa,
l’economia di stato stazionario, al contrario, non può crescere, ma può svilupparsi.
Nella teoria di Daly, il sottoinsieme economico deve comportarsi allo stesso modo
del suo insieme maggiore, il pianeta: la termodinamica insegna che la materia non
può essere creata, né distrutta, di conseguenza la Terra non può crescere come
massa. Lo stesso fa l’economia in stato stazionario: essa si assesta a un
determinato livello di uso delle risorse (analogo alla linea di Plimsoll sulle navi),
tale per cui il throughput sia in grado di mantenerle costanti nel tempo.
L’economia di stato stazionario è quindi un’economia che mantiene stock costanti
di persone e prodotti, conservati a livelli desiderati e sufficienti, con bassi
throughput, cioè con il minore flusso possibile di materia ed energia dal primo
all’ultimo stadio del consumo. Nella teoria di Daly, tutto ciò che ha una natura
fisica non può crescere illimitatamente ed è sottoposto a dei limiti naturali che non
possono essere valicati in alcun modo.
L’economia di stato stazionario non significa l’annullamento del progresso
umano. Se ciò che ha una natura fisica deve essere mantenuto costante in quanto
limitato, tutto ciò che non ha natura materiale può e deve crescere: la cultura,
l’eredità genetica, i principi etici, ma anche la tecnologia relativa, la forma e la
composizione dello stock complessivo di prodotti non devono essere mantenuti
costanti, così come può e deve variare la distribuzione tra la popolazione.
Le due componenti fisiche dell’economia sono le persone e i prodotti. Esse
devono essere conservate in modo costante: questo significa che sono necessarie
107
comunque nuove nascite e nuova produzione per compensare le inevitabili morti e
il deprezzamento fisico dei prodotti.
Per quanto riguarda la componente demografica, Daly è fautore di una riduzione
massiccia della popolazione soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove i tassi di
crescita sono più elevati. L’economia di stato stazionario prevede un numero di
nascite pari a quello delle morti a un tasso piuttosto basso che alto, così che la
speranza di vita sia abbastanza elevata. Analogamente, la produzione di nuovi
prodotti deve uguagliare il deprezzamento a bassi livelli, così che la durata o
longevità dei prodotti sia più elevata. La creazione di nuovi prodotti implica un
esaurimento crescente delle risorse. Il deprezzamento implica la creazione di
scorie fisiche che devono essere restituite all’ambiente sotto forma di rifiuti e
inquinamento. Esaurimento e inquinamento risultano dei costi che devono essere
minimizzati per ogni dato livello di stock.
L’economia di stato stazionario rappresenta anche un superamento dell’idea di
Pil. Esso, infatti, è l’indice usato per misurare la crescita economica, valutata in
termini di flussi fisici. In altre parole, si può definire il Pil come una misura del
throughput. Ma se lo stato stazionario è definito in termini di stock costanti (una
grandezza misurata in un istante di tempo, come le scorte dei beni) allora il Pil,
definito in termini di flussi (una grandezza misurata in un intervallo di tempo,
come le vendite annuali) è logicamente irrilevante per lo stato stazionario. Tanto
più che il Pil, nella misura in cui riflette il throughput, massimizza quello che
nello stato stazionario viene considerato un costo che, al contrario, andrebbe
minimizzato: lo stato stazionario cerca di mantenere uno stock desiderato con un
throughput minimo, il che presuppone una diminuzione del Pil, evento temuto
nell’economia di crescita, ma perfettamente accettabile nell’economia di stato
stazionario.
108
4.2.2 Mezzi e fini
Sebbene oggi l’idea di stato stazionario suoni strana e lontana dalla realtà
dell’economia, essa non rappresenta una novità. In realtà, per circa il 99% della
sua esistenza, l’uomo ha vissuto in una condizione molto vicina allo stato
stazionario. “Solo negli ultimi 200 anni la crescita è stata tale da essere avvertita
nell’arco della vita di un singolo individuo e solo negli ultimi quaranta anni ha
assunto una priorità fondamentale ed è diventata realmente esplosiva. A tempi
lunghi, la stabilità è la norma e la crescita rappresenta l’eccezione” (Daly, 1981).
Secondo Daly, l’economia, che si occupa di fini e di mezzi, si è concentrata solo
sul campo medio dei mezzi-fini, tralasciando quelli che si trovano agli estremi.
Ipotizzando un continuo dei mezzi e dei fini (fig. 5), in cui ogni categoria
intermedia è un fine rispetto a quelle situate più in basso e un mezzo per
raggiungere quelle più in alto, l’economista pone alla base la fisica con i mezzi
primari (materia ed energia a
bassa entropia). I mezzi intermedi
Religione
Fine ultimo (?)
sono i prodotti e il lavoro: i mezzi
primari, attraverso la tecnologia
Etica
Fini intermedi
(ricchezza, benessere,
istruzione, ecc)
(ordinamento)
dell’uomo e della natura sono
trasformati in prodotti e lavoro. I
mezzi
Economia
intermedi,
l’economia,
Tecnologia
(dell’uomo e
della natura)
Mezzi intermedi
(prodotti, lavoro)
Fisica
portano
tramite
al
raggiungimento di fini intermedi,
rappresentati dalla ricchezza, dal
Mezzi primari
(materia-energia a
bassa entropia)
benessere, dall’istruzione, ecc.
Esiste
ancora
un
livello
successivo che porta al Fine
ultimo: esso riguarda la sfera
Figura 5 – Dai mezzi
primari al Fine ultimo
dell’etica e della religione, che
per Daly assume un valore molto
importante.
Secondo l’economista, la teoria neoclassica si è concentrata solo sulla parte
intermedia dello spettro, tralasciando mezzi e fini assoluti che si trovano agli
109
estremi e presupponendo, in modo errato, che la relatività e le possibilità di
sostituzione tra fini alternativi e mezzi scarsi che si trovano nella parte centrale
fossero rappresentativi dell’intero spettro.
“Possiamo definire la crescita economica in questo contesto come la conversione
di mezzi sempre più primari in mezzi sempre più intermedi allo scopo di
soddisfare fini sempre più intermedi, qualunque essi siano. Il processo è concepito
di durata infinita” (Daly, 1981). Tuttavia, questa concezione deve essere rivalutata
alla luce dell’intero spettro dei mezzi e dei fini: “La natura del Fine Ultimo limita,
infatti, la desiderabilità di una continua crescita economica, mentre la natura dei
mezzi primari ne limita la possibilità” (Daly, 1981).
4.2.3 Limiti alla possibilità della crescita
Dei limiti fisici si è già detto nei capitoli precedenti. Daly riprende
sostanzialmente la teoria di Georgescu-Roegen basata sulle leggi della
termodinamica. L’economista sottolinea la dipendenza dell’attuale sistema
economico dalle risorse più scarse piuttosto che da quelle abbondanti. Inoltre,
l’uomo ha forzato fino ai limiti gli equilibri ecologici della biosfera. I cicli naturali
sono stati sovraccaricati, mentre la produzione di nuovi materiali per i quali non
esistono cicli naturali sta producendo quantità di scorie che non possono essere
assorbite. E’ molto recente la notizia che l'Earth Overshoot Day16, ovvero il
giorno in cui il consumo di risorse da parte dell’uomo supera il naturale
rinnovamento delle stesse, è stato anticipato, nel 2008, al 23 settembre. Nel 1961
metà Terra bastava per soddisfare tutte le necessità umane, nel 1986 la specie
umana ha iniziato a utilizzare più risorse di quelle offerte dalla capacità biofisica
del pianeta, ma in quell’anno il gong era suonato il 31 dicembre. Da allora la
scadenza si è anticipata un po’ tutti gli anni, fino ad arrivare a settembre in
quest’ultimo anno.
16
L’Earth Overshoot Day viene calcolato ogni anno dal Global Footprint Network, associazione di
ricerca che si dedica alla misurazione delle risorse: quante ne restano, chi e come le usa. Inoltre,
l’associazione calcola l’Impronta ecologica dell’umanità (ovvero la sua necessità di campi,
pascoli, foreste, aree di pesca e spazio per infrastrutture), e la confronta con la biocapacità globale
(ovvero la capacità degli ecosistemi appena citati di produrre risorse e assorbire rifiuti).
110
I limiti biofisici vengono affrontati dalla teoria neoclassica attraverso le
esternalità. Tutti i fenomeni che non rientrano nel modello del flusso circolare
vengono internalizzati adottando questo strumento creato ad hoc. Un ulteriore
espediente è quello di appellarsi alle infinite risorse della tecnologia e
dell’ingegno umano. Si ritiene, cioè, di poter trovare delle soluzioni tecnologiche
o dei sostituiti per ogni risorsa scarsa, come una forza dinamica in grado di
perpetuare all’infinito la crescita, compensando lo sfruttamento e l’inquinamento
dell’ambiente. La risposta di Daly a queste argomentazioni deriva ancora una
volta dalla teoria termodinamica: nessun capitale artificiale può essere prodotto
senza l’utilizzo di capitale naturale, come nessun miglioramento tecnologico può
essere sfruttato senza energia. Essendo complementari, infine, capitale artificiale e
capitale naturale non possono essere sostituiti l’uno con l’altro.
Se le leggi della termodinamica sono fondamentali per definire i limiti della
crescita economica, tuttavia non bisogna, secondo Daly, cadere nella tentazione di
fare dell’entropia il metro per misurare il valore delle merci. Nonostante la bassa
entropia sia una condizione necessaria perché ogni cosa abbia un valore, tuttavia
essa non è una condizione sufficiente. I valori relativi sono e devono comunque
essere determinati dalla domanda e dall’offerta e la bassa entropia non può essere
valutata tutta allo stesso modo, ma in base al suo uso: non si può paragonare il
consumo di energia come combustibile al consumo di energia come cibo per gli
esseri umani.
4.2.4 Limiti economici
Secondo Daly, tuttavia, i limiti a una crescita illimitata sono soprattutto di tipo
economico. Considerando un semplice grafico costi/benefici, risulta evidente che
non è necessario che i benefici marginali vadano a zero, né che i costi marginali
crescano all’infinito, per trovare una giustificazione alla necessità di fissare un
limite alla crescita: basta che essi siano uguali.
Fini e mezzi non vengono raggiunti e consumati in modo casuale: prima vengono
soddisfatti i fini più urgenti e fondamentali, utilizzando i mezzi più accessibili.
Questo ragionamento porta ad avere benefici marginali decrescenti e costi
111
marginali crescenti. In qualche punto essi si intersecano: fino a quel punto ci
troviamo nella fascia intermedia dello spettro mezzi-fini, in cui sono applicabili i
concetti economici; oltre questo equilibrio, i costi marginali sono maggiori dei
benefici. In un grafico costi/benefici, la distanza tra le curve di costo totale e
beneficio totale indica il beneficio netto. Seguendo il grafico, la crescita ha senso
solo fino al punto in cui questa distanza è massima, ovvero dove i costi marginali
e i benefici marginali si eguagliano: esso rappresenta il limite economico alla
crescita, oltre al quale il beneficio netto diminuisce, fino ad assumere segno
negativo. Questo tipo di ragionamento viene sviluppato quotidianamente nella
microeconomia, ma è trascurato dalla teoria macroeconomica. In sostanza, a
livello macro sembra non esistere un problema di scala. Questa anomalia deriva,
secondo l’interpretazione di Daly, dalla visione preanalitica della teoria
neoclassica: considerare l’economia un sistema isolato, trascurando l’esistenza
dell’ambiente.
Dalla teoria dello stato stazionario, con le sue implicazioni ambientali ed etiche,
Daly sviluppa il concetto di sviluppo sostenibile.
112
4.3 Lo sviluppo sostenibile
4.3.1 I limiti etico-sociali alla crescita
Il concetto di sviluppo sostenibile è strettamente collegato all’idea di Fine ultimo
e ai limiti etico-sociali che Daly segnala rispetto alla crescita. Del Fine ultimo,
legato alla visione religiosa dell’economista, si parlerà in seguito. Egli propone
però almeno quattro proposizioni che limitano la desiderabilità della crescita dal
punto di vista morale.
1. La desiderabilità della crescita finanziata attraverso la riduzione del
capitale geologico è limitata dal costo imposto alle generazioni future.
Tale assunto è alla base del concetto di sviluppo sostenibile. Come già
definito nel secondo capitolo, lo sviluppo sostenibile si basa su un’idea di
equità intergenerazionale. Ogni utilizzo di capitale naturale oggi determina
una minore possibilità di utilizzo dello stesso in futuro. Nell’economia
standard l’equilibrio tra costi e benefici presenti e futuri viene raggiunto
tramite l’applicazione di un tasso di sconto. Il tasso di sconto
intertemporale è un artificio numerico per esprimere un giudizio di valore
sul futuro. Ovviamente più il futuro è lontano, meno sarà il suo valore. Più
alto è il tasso di sconto, più corto è l’orizzonte temporale oltre il quale il
futuro non conta. “Forse un principio più acuto […] per equilibrare
presente e futuro potrebbe essere che i bisogni essenziali del presente
dovrebbero sempre avere la precedenza su quelli futuri, ma i bisogni
essenziali futuri dovrebbero avere la precedenza sui lussi eccessivi del
presente” (Daly, 2001).
2. La desiderabilità della crescita finanziata attraverso il processo di
appropriazione degli habitat è limitata dall’estinzione o riduzione nel
numero delle specie non umane sensibili il cui habitat sparisce. La teoria
standard sulle risorse rinnovabili può prevedere anche l’estinzione di una
specie, se questo evento risponde a un comportamento massimizzante di
mercato. Dal punto di vista ambientale, tuttavia, ogni estinzione
rappresenta una perdita irreversibile di biodiversità. Questa, inoltre, è
essenziale per mantenere attivi i cicli naturali che garantiscono i servizi
113
ecologici essenziali, senza i quali sarebbe impossibile la vita sulla Terra.
Oltre al valore strumentale che le altre specie hanno per noi, Daly
sottolinea la necessità di riconoscere a ogni essere vivente un valore
intrinseco come esseri sensibili, probabilmente non coscienti, ma che
posseggono comunque un diritto al proprio spazio e alla propria
sopravvivenza.
3. La desiderabilità della crescita è limitata dai suoi stessi effetti distruttivi
sul benessere. I bisogni assoluti non sono insaziabili: una volta soddisfatti,
difficilmente si trasformano in un desiderio ancora più grande. I bisogni
relativi, invece, sono insaziabili. La loro soddisfazione dipende, infatti,
dalla possibilità di sentirsi in qualche modo superiori agli altri. Se il mio
stipendio aumenta, ma quello del mio collega aumenta di più, il mio
bisogno di ricchezza non sarà soddisfatto, anzi sarà frustrato dal confronto
con chi mi sta accanto. L’aumento di reddito nei Paesi ricchi non fa che
aumentare a dismisura i desideri, ma allo stesso tempo aumenta anche
l’insoddisfazione, perché raggiunto un obiettivo se ne proporrà
immediatamente un altro ai nostri occhi, più ambizioso e che consente di
raggiungere una maggiore considerazione all’interno della società. Questo
processo, come si è visto in precedenza, non aumenta però la felicità; al
contrario, esso è una sorta di trappola autodistruttiva che si autoalimenta,
producendo insoddisfazione e malessere all’interno della società.
4. La desiderabilità della crescita aggregata è limitata dagli effetti corrosivi
sugli standard morali che derivano da quegli stessi comportamenti che
promuovono la crescita, come la glorificazione dell’interesse individuale e
una visione del mondo scientistica-tecnocratica. La crescita illimitata è
guidata, secondo Daly, dall’egoismo e dal desiderio del possesso, e
stimolata oltre misura dalla pubblicità, che fa nascere bisogni superflui e
inutili. Si è sviluppata una società basata sul consumismo e supportata, a
livello
dell’offerta,
dallo
scientismo
tecnocratico
che
proclama
l’inesauribilità delle risorse. Una visione del mondo che “presenta seri
difetti. Come programma di ricerca è molto efficace nel promuovere
potere e controllo, ma come visione del mondo non lascia alcuno spazio
114
agli obiettivi, e ancor meno alla distinzione tra obiettivi sensati o meno.
[…] Un potere crescente in assenza di scopi definiti porta a una crescita
incontrollata fine a se stessa, con effetti devastanti sull’ordine morale e
sociale così come su quello ecologico” (Daly, 2001).
4.3.2 Utilità e throughput
L’approccio proposto dall’economista va dalla critica all’economia della crescita
alla proposta di un nuovo tipo di visione del mondo, basata sullo sviluppo
sostenibile e sullo stato stazionario. Il concetto di sviluppo sostenibile, come visto
nel secondo capitolo, ha diverse sfaccettature e viene utilizzato in più contesti, a
volte contrastanti tra loro. La visione di Daly esce dal binario dell’economia
tradizionale, basato sull’utilità, per imboccare una strada che descriva in modo
completo il processo economico, compreso l’ambiente naturale all’interno del
quale esso si sviluppa.
La definizione più diffusa di sviluppo sostenibile è quella che sostiene la necessità
di evitare il decrescere dell’utilità per le generazioni future, in modo che il futuro
offra almeno lo stesso livello di benessere che esiste nel presente. Per Daly,
invece, lo sviluppo sostenibile è strettamente connesso con il concetto di
throughput, cioè deve cercare di evitare il decrescere del flusso fisico entropico
che dalla fonte naturale si immette nell’economia e da lì fa ritorno all’ambiente.
Ciò che deve restare costante è il capitale naturale, in modo che nel futuro restino
accessibili, almeno al livello del presente, le risorse e le prestazioni biofisiche che
l’ecosistema ci fornisce.
Il throughput rappresenta il flusso metabolico attraverso il quale viviamo e
produciamo. La sua introduzione nella teoria economica non è un modo per
ridurre l’economia alla fisica, ma serve a riconoscere i vincoli che le leggi fisiche
esercitano su di essa. Sostenibile non significa eterno: la sostenibilità consiste nel
rendere il giusto riconoscimento alle istanze di durata nel tempo e di giustizia
intergenerazionale, senza per questo ignorare l’esistenza della mortalità e della
finitezza. In vista della sostenibilità, si rende necessario valorizzare la parte
115
rinnovabile del throughput e provvedere alla distribuzione della parte non
rinnovabile a un numero più elevato di generazioni.
Daly non nega il valore del concetto utilità, che risulta necessario per stabilire le
condizioni preliminari in funzione delle quali deve essere costruito lo sviluppo
sostenibile: la qualità della vita deve essere valutata in modo da garantire non solo
la longevità, ma anche il benessere.
La locuzione sviluppo sostenibile è, però, composta da due parole: sostenibile, di
cui si è spiegato il significato, e sviluppo. Nella teoria economica lo sviluppo è
indicato semplicemente come crescita del Pil, un indice di valore che comprende
sia gli effetti delle variazioni del throughput che gli effetti delle variazioni
dell’utilità. Daly definisce invece lo sviluppo come “aumento dell’utilità per unità
di throughput”, distinguendolo dalla crescita, definita come “aumento di
throughput complessivo”.
Il concetto di sviluppo legato al Pil è spesso giustificato come speranza per i Paesi
in via di sviluppo: la crescita può consentire che parte dell’incremento finisca
nelle tasche dei Paesi più poveri. Secondo questa visione, i benefici della crescita
si riversano su tutti, anche sui più poveri, come un’alta marea in grado di sollevare
tutte le barche.
Daly critica questa visione di sviluppo, puramente legata a un aumento
quantitativo del Pil. Esso, infatti, risulta spesso distorto a causa della sua stessa
natura: nella contabilità nazionale il consumo di throughput che deriva dalla
produzione, ma anche, ad esempio, dalle spese difensive per risolvere i problemi
legati all’inquinamento, viene considerato allo stesso modo, cioè viene sommato
come incremento del prodotto interno lordo. E’ chiaro, allora, che esso non può
essere un indice adeguato per valutare lo sviluppo.
D’altro canto, Daly sostiene che la crescita può risultare antieconomica. Egli non
nega che esista un legame tra crescita e benessere, così come appoggia l’idea che
“più crescita è meglio di meno crescita, almeno fino a un certo punto” (Daly,
2007). Tuttavia, il problema sta nel capire se la sola crescita basti a garantire
l’aumento della ricchezza netta: è possibile, cioè, che la crescita del throughput
comporti un aumento dell’indigenza, piuttosto che della ricchezza? L’economista
osserva che, nel processo economico, l’impoverimento si accumula sia a monte
116
che a valle: come impoverimento delle risorse dove esso ha inizio, come
inquinamento dove il processo termina. Inserire il concetto di throughput
nell’economia significa capire che la povertà ha origine dallo stesso processo che
genera ricchezza. Quando la crescita del throughput consuma risorse più
velocemente di quanto produce ricchezza siamo di fronte a una crescita
antieconomica. Lo sviluppo sostenibile ha come scopo evitare che la crescita sia
antieconomica, calmierandola a livelli sostenibili per l’insieme bioeconomico.
E’ molto più probabile che la crescita si riveli antieconomica nei Paesi
occidentali, dato che in essi la crescita riguarda bisogni relativi, che difficilmente
riescono ad apportare nuovo benessere reale, mentre nei Paesi in via di sviluppo la
crescita è spesso economica, almeno quando permette di aumentare il consumo di
beni primari e di soddisfare i bisogni assoluti, apportando un effettivo
miglioramento nel livello di vita della popolazione.
Tuttavia, Daly sottolinea come le organizzazioni internazionali che si occupano di
sviluppo siano abbastanza restie a concentrare il loro intervento nella direzione di
una riduzione della crescita antieconomica nei Paesi ricchi per far spazio a una
crescita economica nei Paesi più poveri. Al contrario, il pensiero più diffuso
ritiene che solo una rapida crescita dei Paesi occidentali possa permettere lo
sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo, garantendo loro un mercato più ampio per i
loro prodotti: in altre parole credono in uno sviluppo fondato sulle esportazioni e
sugli investimenti occidentali nei Paesi più poveri. Ancora una volta questa
visione pecca di una lacuna fondamentale, cioè l’ambiente naturale, che impone
dei limiti allo sviluppo: è necessario dimensionare il processo economico a una
scala sostenibile per l’ambiente che lo contiene.
4.3.3 La scala dello sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile si propone come obiettivo quello di definire la scala
ottimale del processo economico, partendo dalla considerazione che il processo
economico è un sottoinsieme aperto di un sistema globale chiuso e limitato. Il
problema non è di semplice soluzione. Quantificare l’esatta scala ottimale del
processo economico richiede conoscenze non certo facili da reperire. Anche per
117
questa ragione, il problema è stato semplicemente ignorato dalla scienza
economica tradizionale, in due modi: considerando il sottoinsieme economico
come infinitesimamente piccolo rispetto al sistema globale, oppure, all’opposto,
considerando l’economia come perfettamente sovrapposta al sistema globale. Nel
primo caso, la scala è irrilevante; nel secondo caso, se l’economia include tutto, il
problema della scala scompare. “Questi due estremi corrispondono alla vivace
distinzione di Boulding fra l’economia del cowboy e l’economia dell’astronauta.
Il cowboy delle praterie sconfinate basa la sua sussistenza su una produzione in
cui la materia prima passa linearmente dalla fonte allo scarico finale, senza
necessità di riciclare alcunché. L’astronauta nella sua piccola capsula vive
all’interno di cicli di materiali serrati e con feedback immediati, tutti sottoposti a
totale controllo e orientati alle sue necessità. Per il cowboy la scala è trascurabile,
per l’astronauta la scala coincide con il tutto. […] In ciascuno di questi due casi
estremi l’unico problema è l’allocazione. La scala è irrilevante” (Daly, 2001).
Daly chiama la situazione attuale economia dell’elefante nella cristalleria: le
dimensioni dell’elefante diventano fondamentali per evitare di distruggere tutto
ciò che gli sta intorno. Il mercato, da sé, non è in grado di fissare i limiti della
scala, perché opera all’interno del sottoinsieme economico. E’ necessario un
intervento esterno, che determini la capacità dell’ecosistema di sostenere l’impatto
delle attività economiche e che limiti queste ultime a un livello tale per cui
l’economia si assesti a uno stato di mantenimento e non di crescita.
4.3.4 Consumo e valore aggiunto
La dimensione della scala del sistema economico presuppone alcune analisi sul
concetto di consumo e di valore aggiunto. Daly indica, infatti, due azioni che
vanno intraprese per indirizzare il sistema mondo verso uno sviluppo sostenibile:
occorre ridimensionare consumi e popolazione. I due obiettivi corrispondono alla
differente situazione dei Paesi mondiali: se per i Paesi del Sud del mondo è
assolutamente necessario ridurre la popolazione, in modo da riportare il numero di
esseri umani a un livello sostenibile per l’ambiente, il Nord, dal canto suo, deve
118
sforzarsi per diminuire il consumo pro capite, in modo da ridurre l’impatto
antropico sulle capacità di rinnovamento del capitale naturale.
Per quel che riguarda il consumo, è bene soffermarsi ad analizzare cosa si intende
per consumo, e quali siano le differenze tra la teoria neoclassica e la proposta di
Daly. Ricordando le leggi di conservazione dell’energia e della materia, e la
conseguente impossibilità di consumare le componenti materiali di cui sono fatte
le merci, si può ricondurre il consumo al concetto di valore aggiunto. Marshall
definisce la produzione una riorganizzazione di materia che fornisce utilità e il
consumo uno stravolgimento di materia che ne distrugge l’utilità. L’utilità,
aggiunta nella produzione e distrutta dal consumo, viene chiamata dagli
economisti valore aggiunto. Solo il valore aggiunto può essere consumato, perché
esso è l’unica cosa che può essere prodotta. Nella visione neoclassica, questa
analisi porta a considerare la crescita come illimitata: il valore aggiunto può essere
aggiunto e consumato in un circuito infinito. Quello che gli economisti
tradizionali non fanno è parlare del supporto su cui in valore viene aggiunto:
considerando le risorse naturali come un insieme omogeneo e indifferenziato di
componenti elementari e indistruttibili, la materia risulta poco interessante e
irrilevante nell’analisi economica mainstream. Ma, osserva Daly, il valore non
può essere aggiunto al nulla.
In realtà, la materia su cui si attua l’operazione di aggiunta di valore è molto
importante. Innanzitutto, la materia non è omogenea: la capacità di incorporare
valore aggiunto non è uniforme per ogni tipo di elemento naturale. Infatti, non
tutta la materia è riconosciuta e utilizzata come risorsa: in genere, viene presa in
considerazione quella parte che consente di aggiungere valore con un dispendio
minimo di energia. Quello che cambia la predisposizione della materia a essere o
meno materia prima è il valore che la natura, prima dell’uomo, ha aggiunto a essa.
La tradizione economica considera le materie prime un dono gratuito della natura;
occorre, invece, rendersi conto che più alto è il sussidio che la natura ha fornito,
maggiore è la possibilità per l’uomo di sfruttare tale risorsa. Finora, questo si è
tradotto in prezzi bassi e in un maggior sfruttamento della materia prima, con il
rischio del suo esaurimento. Daly propone, invece, di riconoscere il valore
aggiunto già presente nelle risorse e mostrarlo attraverso un corretto sistema dei
119
prezzi, per smettere di “minimizzare la dipendenza dell’attività economica dalle
risorse e dal sistema naturale che le genera, e [di] esagerare l’importanza relativa e
l’indipendenza del contributo umano” (Daly, 2001).
Grazie all’apporto naturale, l’economia ha potuto crescere in rapporto
all’ecosistema, in maniera tale da alterare lo schema della scarsità: un tempo, la
possibilità di aggiungere valore era limitata dalla scarsità degli agenti di
trasformazione (capitale e lavoro), oggi l’aggiunta di valore è limitata dalla
disponibilità di risorse naturali adatte a ricevere il valore aggiunto.
La crescita fisica del sottoinsieme economico comporta una trasformazione di
capitale naturale in capitale artificiale, cioè una perdita di servizio, fornito dal
capitale naturale, in cambio di nuovi servizi, offerti dal capitale artificiale.
Occorre valutare se la perdita è compensata dai nuovi servizi offerti dai manufatti.
Secondo Daly, più aumenta la scala del sottoinsieme economico più aumentano i
costi rispetto ai benefici: i benefici diminuiscono perché i bisogni essenziali sono
già stati soddisfatti, mentre i costi aumentano perché le risorse migliori e più
accessibili sono state utilizzate per prime e in seguito restano le meno
economiche. La scala ottimale del sottoinsieme economico, adatta a supportare
uno sviluppo sostenibile, è rappresentata dal punto in cui benefici e costi
marginali si eguagliano. Raggiunta questa scala non si produce più per la crescita,
ma per il mantenimento: “Un’economia matura, come un ecosistema maturo,
passa da un regime di efficienza nella crescita (la massimizzazione della
produzione per unità di stock di biomassa) a un regime di efficienza nel
mantenimento (la massimizzazione del reciproco, ossia la quantità di biomassa
mantenuta per unità di nuova produzione). La produzione è il costo di
mantenimento dello stock e dovrebbe pertanto essere minimizzata” (Daly, 2001).
120
4.3.5 Strumenti per lo sviluppo sostenibile
Le due definizioni di sviluppo sostenibile più utilizzate vengono denominate
sostenibilità debole e sostenibilità forte. La prima considera sostenibile uno
sviluppo che mantiene uno stock di capitale (naturale + artificiale), non
decrescente nel tempo. Essa implica la perfetta sostituibilità del capitale naturale
con il capitale artificiale. La seconda definizione considera sostenibile uno
sviluppo che mantiene uno stock naturale non decrescente nel tempo. Come visto
in precedenza, Daly assume come vera la seconda definizione, sostenendo
l’ipotesi che capitale naturale e capitale artificiale siano tra loro complementari.
Se i fattori sono complementari, allora il fattore la cui offerta è scarsa sarà quello
che limita lo sviluppo. Seguendo la logica economica tradizionale, Daly propone
di massimizzare la produttività del fattore limitante e di investire in esso per
aumentarne l’offerta. “Non si tratta di una ‘nuova economia’ ma di un
comportamento nuovo, coerente con la ‘vecchia economia’, in un mondo in cui
prevale un nuovo modello di scarsità” (Daly, 2001).
Investire in capitale naturale significa essenzialmente permettere alla risorsa di
conservarsi. E’ un tipo di investimento sostanzialmente passivo, che si può
operare sulle risorse naturali rinnovabili. Prelevando il raccolto sostenibile si
permette alla risorsa di rigenerarsi, in quanto il prelievo sarà pari alla sua capacità
di ricrescita. In questo modo, la risorsa è mantenuta costante nel tempo e si
investe nella sua conservazione. Questo comporta, per gran parte delle risorse, una
diminuzione del loro consumo.
Per quanto riguarda le risorse non rinnovabili, la loro quantità può solo essere
consumata, non è possibile farla aumentare (se non in tempi geologici inutili per
l’uomo), neppure annullando del tutto il loro uso. L’unico intervento possibile
sulle risorse non rinnovabili è un miglioramento nell’efficienza del loro utilizzo. I
proventi derivati dalle risorse non rinnovabili andrebbero divisi in due parti: una
parte di reddito, e una parte di capitale da reinvestire nelle risorse rinnovabili per
farle crescere e consentire una produzione di reddito anche nel momento in cui le
risorse non rinnovabili andranno a esaurirsi. “Sebbene non sia possibile investire
in risorse non rinnovabili, possiamo gestire il loro utilizzo in modo da (i)
aumentare gli investimenti passivi diretti in risorse rinnovabili e (ii) aumentare gli
121
investimenti attivi indiretti rivolti ad aumentare la produttività delle risorse
naturali e quindi a facilitare una riduzione del loro consumo” (Daly, 2001).
Per ridurre il volume delle risorse naturali necessarie a mantenere un determinato
livello di benessere, Daly propone due ordini di investimenti: il controllo
demografico e l’aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse, sia naturali che
artificiali. L’efficienza con cui si utilizzano le risorse dipende da due fattori: il
valore dei servizi che otteniamo per unità di capitale artificiale (Ka) e il valore dei
servizi che sacrifichiamo per unità di capitale naturale (Kn) perso come risultato di
questa conversione. Tale rapporto può essere scorporato in quattro componenti,
per mezzo della seguente identità:
servizi
ottenuti
da Ka
servizi
da Kn
sacrificati
servizi
ottenuti
da Ka
x
=
stock
di Ka
(I rapporto)
risorse totali
impiegate nella
produzione
stock
di Ka
x
stock
di Kn
x
risorse totali
impiegate nella
produzione
stock
di Kn
(II rapporto)
(III rapporto)
servizi
da Kn
sacrificati
(IV rapporto)
Ciascun termine dell’identità rappresenta una dimensione dell’efficienza. Il primo
rapporto rappresenta l’efficienza dello stock di capitale artificiale nel fornire
servizi all’essere umano; essa dipende dall’efficienza tecnica di progettazione,
dall’efficienza economica che deriva dall’allocazione, a seconda delle preferenze
tra gli individui, e dall’efficienza distributiva. La teoria tradizionale, basata
sull’efficienza paretiana, tiene separati i concetti di efficienza e di distribuzione.
In un mondo non affollato si può effettivamente tralasciare l’aspetto distributivo,
ma in un mondo soggetto a limiti, tutti i miglioramenti che possono derivare da
aumenti di efficienza vanno tenuti in considerazione. In sintesi, il primo rapporto
misura l’intensità del servizio reso, per unità di tempo, dallo stock di capitale
artificiale.
Il secondo rapporto descrive l’efficienza nel mantenimento dello stock di capitale
di produzione umana. Esso misura il numero di unità di tempo durante cui lo
stock può fornire un determinato servizio. Dato che il capitale artificiale è una
trasformazione del capitale naturale, allungare la durata di vita dei prodotti
122
consente di aumentare il tempo di impiego di capitale naturale in essi incorporato,
consentendo di risparmiare sull’estrazione di altre materie prime.
Il terzo rapporto riflette l’efficienza nella crescita del capitale naturale nel
generare un incremento nello stock, utilizzabile nel consumo. Esso dipende dal
tasso di rigenerazione della risorsa. La scelta dovrebbe, quindi, cadere su quelle
materie prime che hanno tassi di crescita più rapidi.
Il quarto rapporto rappresenta l’efficienza nel ruolo ecologico; esso misura la
quantità di capitale naturale utilizzato nel processo produttivo (sia come risorsa
che come ricettacolo di scarti) per ogni unità degli altri servizi ecologici essenziali
che vengono in tal modo perduti. L’obiettivo deve essere quello di minimizzare la
perdita dei servizi dell’ecosistema quando una risorsa viene utilizzata per
ricavarne input da destinare ai processi produttivi.
Dei vari rapporti, sicuramente il quarto è stato tralasciato più spesso
dall’economia neoclassica. Lo sviluppo sostenibile presuppone, invece, di tenere
sullo stesso piano i quattro rapporti di efficienza, al fine di giungere a definire una
scala ottimale del sottoinsieme economico che possa continuare a vivere senza
soffocare l’ecosistema.
4.3.6 Istituzioni per lo sviluppo sostenibile
Daly propone tre istituzioni per sostenere uno sviluppo sostenibile. Non sono
istituzioni rivoluzionarie, ma poggiano sui pilastri dell’economia tradizionale: i
prezzi e la proprietà privata. Tuttavia, l’estensione di tali elementi a settori
generalmente non considerati dall’economia ne fa degli strumenti non
convenzionali.
Le tre istituzioni proposte da Daly derivano dalla definizione stessa di stato
stazionario: stock costanti di persone e prodotti, mantenuti a un livello sufficiente
e opportunamente scelto, con il minimo tasso di throughput. Servono quindi:
a) un’istituzione per stabilizzare la popolazione (licenze di nascita
trasferibili);
b) un’istituzione per stabilizzare lo stock di prodotti
e mantenere il
throughput sotto i limiti ecologici (quote di sfruttamento);
123
c) un’istituzione distributiva che limiti la disuguaglianza nella ripartizione
degli stock tra la popolazione.
L’istituzione più controversa è sicuramente la prima. Essa consiste nel fornire a
ogni individuo una o più licenze di nascita (decise a livello statale), in numero
uguale per ogni essere umano. Solo in possesso di tale licenza è possibile avere un
figlio. Le licenze possono essere comprate e vendute, affinché gli individui
possano seguire i loro desideri di procreazione, ma in modo connesso alla reale
possibilità di mantenere i figli. In questo modo, si può attuare una riduzione della
popolazione senza imporre un numero massimo di figli a famiglia. Le critiche a
tale prospettiva sono parecchie e Daly ne è consapevole. “C’è una certa riluttanza
ad accoppiare il denaro e la riproduzione; sembra, in qualche modo, di profanare
la vita. Eppure la vita è associata, in senso fisico, a risorse che diventano sempre
più scarse e quest’ultime sono associate al denaro. […] Riconoscere francamente
che la riproduzione deve essere considerata da qui in avanti un diritto scarso serve
ad affrontare logicamente il problema della migliore distribuzione di quel diritto,
del se, e come, permettere una riallocazione volontaria” (Daly, 1981).
La seconda istituzione è già stata attuata e riguarda le quote di sfruttamento. La
logica è la stessa che governa il protocollo di Kyoto: il governo mette all’asta
delle quote di sfruttamento delle risorse scarse, determinando a priori la quantità
che è possibile utilizzare. In seguito le quote possono essere vendute e comprate
sul mercato. Tale sistema permette di limitare il throughput a livello globale e
rappresenta una misura più semplice del controllo dell’inquinamento, che impone
costi maggiori ed è più difficile da quantificare, presupponendo la conoscenza
delle curve di domanda.
La terza istituzione è un’istituzione distributiva. Essa ha come obiettivo la
diminuzione della disuguaglianza nei redditi e nella ricchezza degli individui.
Daly propone di fissare dei limiti minimi e massimi di reddito e un tetto massimo
di ricchezza, e di attuare una riforma fiscale che sposti l’imposizione dal valore
aggiunto al consumo di risorse naturali. I limiti massimi e minimi al reddito
dovrebbero state all’interno di un intervallo definito, ad esempio il reddito
massimo dovrebbe stare entro dieci volte il reddito minimo. Tale limite permette
di controllare anche la ricchezza e rimuove molti incentivi all’adozione di pratiche
124
monopolistiche. L’equità derivata da questa misura permetterebbe anche una
riduzione dei consumi non necessari. “Senza una grande concentrazione nella
ricchezza e nel reddito i risparmi sarebbero minori e costituirebbero, realmente,
una rinuncia al consumo piuttosto che un surplus residuo dopo aver raggiunto la
sazietà. Ci sarebbe una minore pressione espansionistica da parte di grosse
quantità di surplus alla ricerca di nuovi sentieri di crescita esponenziale che
portano o alla crescita in termini fisici o all’inflazione, o a entrambi” (Daly,
1981).
Il secondo aspetto dell’istituzione distributiva viene chiamata da Daly “riforma
fiscale ecologica”. Una parte di tassazione sul reddito andrebbe mantenuta, con
una pressione maggiore sui redditi molto elevati e forme di sussidi per i redditi
molto bassi. Ma la parte più consistente del gettito andrebbe ricavata imponendo
tasse sull’impiego di materia ed energia. In questo modo si andrebbe a tassare non
il valore aggiunto, ma ciò che fino a oggi è stato considerato un dono gratuito
della natura, andando a correggere le distorsioni nei prezzi e limitando allo stesso
tempo lo sfruttamento eccessivo di risorse scarse.
E’ chiaro che tali istituzioni non sono facilmente attuabili, ma anche condivisibili.
Il processo verso uno sviluppo sostenibile, basato su un’economia in stato
stazionario, non può essere attuata attraverso un’imposizione dittatoriale, ma solo
con un cambiamento nella mentalità e nella concezione del ruolo dell’uomo
all’interno dell’economia e dell’ambiente naturale. In sostanza, un piano di
riforme di questo tipo deve essere accettato dalla popolazione. Daly è consapevole
che un tale programma può essere messo in atto solo con un cambiamento nel
sistema dei valori, in caso contrario le istituzioni non funzionerebbero. “Uno stato
stazionario fisico, se vale la pena viverci, richiede assolutamente una crescita
morale. […] Cambiamenti istituzionali sono necessari, ma non sufficienti. Anche
la crescita morale è necessaria ma non sufficiente. Insieme sono sia necessarie che
sufficienti, ma i cambiamenti istituzionali hanno un’importanza relativamente
minore rispetto ai cambiamenti dei valori morali” (Daly, 1981).
125
4.4 Comunità di comunità
4.4.1 L’importanza della comunità
Nella teoria di Daly, una delle critiche più importanti è rivolta all’astrazione
dell’Homo oeconomicus. Soggetto della teoria economica, egli rappresenta il
comportamento economico basato sulla piena razionalità e sull’individualismo
metodologico. L’economista non critica la validità dell’Homo oeconomicus
nell’analisi economica, anzi, condivide gli aspetti che riguardano l’utilità e il
consumo, e lo ritiene un ottimo strumento. Quello che manca all’Homo
oeconomicus è la percezione del mondo che gli sta intorno, soprattutto del resto
dell’umanità. “Ciò che è precluso all’Homo oeconomicus è la preoccupazione per
le soddisfazioni o le sofferenze che non si manifestano come attività di mercato.
[…] L’Homo oeconomicus non conosce né benevolenza né malevolenza, ma solo
indifferenza” (Daly, 1994). Eppure, gran parte della soddisfazione umana deriva
dalla propria posizione relativa nella società. Inoltre, la dottrina economica
presuppone una caratteristica fondamentale di questo soggetto: il desiderio
insaziabile di merci, l’esistenza di nuovi beni e nuovi desideri bramati in una
quantità sempre maggiore. Secondo Daly, tale caratteristica non è propria
dell’uomo reale: se così fosse, non sarebbe necessaria la pubblicità per stimolare
nuovi desideri. E’ piuttosto un modo per plasmare gli individui alle ipotesi del
sistema.
L’Homo oeconomicus si scontra spesso con la realtà e in effetti, afferma Daly,
dovrebbe essere solo uno strumento di astrazione, mentre è stato preso dagli
economisti come modello reale del comportamento economico. L’Homo
oeconomicus ha desideri illimitati, ma non ha una scala di valori indipendente
dalla forza di tali desideri. Per questo, in genere, l’economia tradizionale rifiuta
ogni genere di giudizio di valore ed è favorevole a una teoria amorale; ne deriva
che le decisioni di politica economica, prese seguendo tale dottrina, risultano
frutto di modelli matematici, piuttosto che derivare dall’osservazione della realtà.
La visione di Daly presuppone, invece, un’economia morale, in cui i valori,
riconosciuti e accettati dalla comunità, vengano utilizzati come metro per le scelte
economiche. Il riferimento è all’etimologia della parola economia: essa deriva dal
126
greco οÆκονοµία, che significa “amministrazione della casa, dell’economia
famigliare”. Essa privilegia una prospettiva di lungo periodo e prende in
considerazione costi e benefici per l’intera famiglia o comunità. L’oggetto
privilegiato è il valore d’uso e non il valore di scambio astratto: esso è concreto,
ha una dimensione fisica e si riferisce a un desiderio che può essere
oggettivamente soddisfatto. Al contrario, il valore di scambio è assolutamente
astratto e porta all’accumulazione illimitata.
L’Homo oeconomicus, nella teoria di Daly, si trasforma in un uomo nella
comunità. L’uomo non è individualista per natura, ma ha un’origine sociale: le
persone sono costruite dalle loro relazioni reciproche. Il sistema economico deve
garantire, oltre a beni e servizi, una struttura che protegga i rapporti sociali
costitutivi della comunità.
In una comunità le persone sono legate da relazioni intrinseche che definiscono
l’identità personale. Mentre la società è basata su rapporti contrattuali e giuridici
di tipo impersonale, una comunità nasce come aggregazione spontanea in base a
relazioni di parentela, vicinato, tradizioni e cultura comune. La comunità è
plurale, non chiusa e omogenea: le persone che la formano hanno un’identità
comune a dispetto delle differenze, hanno coscienza della propria comunità e
partecipano insieme al compito di dare forma alle più ampie aggregazioni di cui
sono membri. “Una società non dovrebbe essere chiamata comunità a meno che
(1) i suoi membri possano partecipare ampiamente alle decisioni che governano la
loro vita, (2) la società nel suo complesso si assuma degli obblighi verso i propri
membri, e (3) tra questi obblighi sia compreso il rispetto per le diverse
individualità dei membri stessi” (Daly, 1994).
Le comunità non devono necessariamente avere dimensioni ridotte: anche uno
stato nazionale può essere una comunità. “Un’economia nazionale al servizio
della comunità sarà quindi un’economia di relativa autosufficienza. Questo non
deve suonare come una condanna del commercio, ma piuttosto della dipendenza
dal commercio, specialmente quando un paese non può partecipare alla
definizione dei rapporti di scambio” (Daly, 1994).
Le comunità di cui parla Daly devono avere una forte base locale, basata sul
potere condiviso e sulla capacità di operare insieme per il benessere della
127
comunità. Gli Stati possono, quindi, essere indicati come comunità di comunità: la
comunità locale diventa la base del processo di identificazione e la partecipazione
alla sua gestione diventa fondamentale sia per dare maggior rilievo alle decisioni
locali, che per designare rappresentati che partecipino alle decisioni prese ai livelli
superiori.
Oltre a una spinta al locale, Daly sottolinea l’importanza di strumenti
sovranazionali in grado di gestire i problemi globali, come quelli ambientali. Non
può essere solo l’economia a internazionalizzarsi, perché, in questo modo, essa
sfugge da ogni tipo di controllo: essa deve essere soggetta a qualche tipo di
supervisione. In realtà, Daly auspica un decentramento economico, verso il livello
locale, che porti con sé anche un decentramento politico. Tuttavia, gli attuali
problemi ambientali richiedono un intervento globale.
L’idea di attuare un tale progetto sociale si scontra con la critica che il nemico
principale della comunità è il desiderio di potere. “Se il paradigma basato sul
primato dell’individualismo dovesse cedere il passo a un paradigma comunitario,
cambierebbe il modo di intendere il potere. Naturalmente è fuori questione che
esistano relazioni di dominio, e che non basti modificare le idee per mettervi
termine. Ma un diffuso riconoscimento sociale del fatto che la ricerca del dominio
non porta a ottenere il potere che si desidera potrebbe aprire la strada a un
riorientamento della volontà di potere sufficientemente ampio da determinare un
mutamento dei rapporti sociali” (Daly, 1994).
Che cosa può effettivamente portare gli uomini a un cambiamento di prospettiva e
di valori? Per rispondere a questa domanda occorre riprendere un concetto
introdotto all’inizio di questo capitolo, quello di Fine ultimo. L’azione umana non
deve fermarsi alla limitata visione dei propri fini intermedi, ma deve spingersi
oltre. Il Fine ultimo può fornire le indicazioni etiche e morali per indirizzare le
politiche economiche verso un obiettivo che non sia fine a se stesso, ma che
permetta uno sviluppo sostenibile dell’intero sistema biofisico. L’idea di
comunità, allora, si allarga per diventare un concetto che “abbraccia tutti i popoli,
gli altri animali, tutti gli esseri viventi e la terra intera” (Daly, 1994). Questa
totalità, per Daly, è rappresentata da Dio: “Qualsiasi altra cosa Egli sia, Dio è
anche a totalità in cui tutto confluisce. La diversità delle parti interconnesse della
128
biosfera contribuisce alla ricchezza della totalità che è la vita divina” (Daly,
1994). Tendere a uno stato stazionario, che permetta uno sviluppo sostenibile
significa allora prendersi cura di ciò che Dio ha donato agli uomini. “Siamo
creature dotate di creatività, ma anche soggette a limiti, e abbiamo un impegno
con il nostro Creatore a prenderci cura del creato, a mantenere intatta la sua
capacità di sostenere la vita e la ricchezza” (Daly, 2001).
Ciò che deve cambiare è il principio organizzatore fondamentale, da cui
discendono l’etica e la morale che guidano le azioni umane. “Quest’etica è
suggerita dai termini ‘sostenibilità’, ‘sufficienza’, ‘equità’, ‘efficienza’. […] Per
raccogliere l’insieme [di questi] valori […] in una sola frase, propongo la
seguente: Dobbiamo lottare per una ricchezza pro capite sufficiente,
efficientemente preservata e allocata, ed equamente distribuita, per il massimo
numero di persone che possono essere sostentate nel tempo in queste condizioni”
(Daly, 2001).
4.4.2 I Paesi in via di sviluppo
Il concetto di sviluppo sostenibile è utile anche per i Paesi in via di sviluppo. E’
chiaro che, presupponendo lo stato stazionario come condizione per uno sviluppo
limitato a una scala sufficiente e sostenibile dall’ecosistema, sono gli Stati
supersviluppati quelli che devono, per primi, modificare il loro sistema
economico, riducendo i consumi e limitando la domanda di risorse. I Paesi più
poveri hanno la necessità, in prima battuta, di ridurre l’aumento demografico e, in
secondo luogo, di rivedere le loro aspettative di crescita. Questo non nel senso che
essi non debbano raggiungere un livello di benessere sufficiente, ma occorre,
anche per i Paesi occidentali, ridimensionare il livello di ricchezza e di consumo
di risorse, poiché se tutta la popolazione mondiale mirasse a raggiungere i livelli
di consumo degli Stati Uniti, non basterebbero quattro pianeti per soddisfare le
richieste dell’umanità. Un simile programma si scontra, sia nei Paesi sviluppati
che nelle Nazioni del Terzo mondo, con l’esistenza di conflitti di classe all’interno
delle nazioni stesse. La crescita demografica dei Paesi sottosviluppati consente
alle élite di tali nazioni di avere a disposizione una gran quantità di manodopera a
129
basso costo, utile anche ai Paesi occidentali. In questi ultimi, d’altro canto, la
crescita è utilizzata come buon sostituto della redistribuzione dei redditi. Ancora
una volta un cambiamento di rotta può avvenire solo con un ripensamento della
scala dei valori.
Le politiche promosse dalle istituzioni internazionali a favore dello sviluppo dei
Paesi del Terzo Mondo si sono basate spesso sull’aggiustamento17: dei prezzi, per
internalizzare le esternalità; delle condizioni macroeconomiche, per eliminare le
distorsioni; dei mercati, per integrare il paese nel commercio internazionale. Gli
aggiustamenti sono le condizioni necessarie per ottenere i prestiti dalla Banca
Mondiale. Le misure di aggiustamento operano principalmente in termini di
allocazione, senza considerare la scala e la distribuzione, questioni in primo piano
nello sviluppo sostenibile. Se l’aggiustamento dei prezzi e delle condizioni
macroeconomiche sono compatibili con lo sviluppo sostenibile, Daly critica
invece il ricorso a un libero mercato globalizzato per aiutare i Paesi
sottosviluppati a uscire dalla loro situazione di insostenibilità sociale. Egli
individua cinque punti di conflitto tra le due visioni:
1. la correzione dei prezzi per internalizzare i costi ambientali si annulla se le
aziende del paese entrano in commercio con quelle di altre nazioni che non
applicano la stessa politica. Se le relazioni avvenissero a livello di paese e
non di imprese, il paese che ha scelto di internalizzare i costi esterni
potrebbe limitare il volume e la composizione dei propri scambi
internazionali per non penalizzare le proprie imprese e, al tempo stesso,
trarre vantaggio dall’opportunità di acquistare prodotti a prezzi che sono,
in realtà, al di sotto del costo pieno. Si tratta di una politica che mira a
proteggere non un’industria inefficiente, ma un’efficiente politica di
internalizzazione dei costi ambientali;
2. una distribuzione più equa non è compatibile con la libertà di movimento
di capitali. Finché l’ampia offerta di manodopera nei Paesi sottosviluppati
consentirà di avere lavoro a basso costo, il capitale si sposterà verso questi
paesi, per ricercare un vantaggio assoluto: i salari tenderanno a livellarsi
verso il basso, mentre il rendimento del capitale sarà sempre maggiore. La
17
Vedi cap. 1.3.3: Gli anni ’80: la Teoria dell’aggiustamento strutturale
130
prospettiva neoclassica dell’aggiustamento prevede che, nel lungo periodo,
l’enorme aumento di produttività, derivata dal libero scambio, faccia
assestare i salari su livelli elevati. I limiti fisici del pianeta, e quindi la
questione della scala, impediscono che sia ecologicamente possibile
sostenere un aumento di produzione tale da arrivare a un aumento
sufficiente dei salari;
3. il libero scambio e la mobilità dei capitali contribuiscono fortemente alla
disgregazione sociale della comunità. La globalizzazione, che mette sul
mercato l’offerta di lavoro di tutto il mondo, porta le imprese a cercare il
vantaggio del costo minore, piuttosto che la salvaguardia del benessere dei
propri concittadini. “Quando la classe capitalistica dice alla classe
lavoratrice: ‘Ci dispiace, dovete competere per il vostro posto di lavoro e il
vostro salario con i poveri di tutto il mondo – il fatto che siamo
concittadini non genera alcun obbligo da parte nostra nei vostri confronti’,
effettivamente non rimane un granché del senso di comunità. […] La vera
via per una comunità internazionale è quella di una federazione di
comunità – comunità di comunità - e non la distruzione delle comunità
locali e nazionali al servizio di un unico mondo cosmopolita di manager
finanziari fuori da ogni controllo, che costituiscono non una comunità, ma
solo una coalizione di interessi di breve periodo interdipendente,
reciprocamente vulnerabile e instabile” (Daly, 2001);
4. il libero scambio ha interferito con la stabilità macroeconomica, rendendo
possibili enormi squilibri nei trasferimenti di capitale, con il risultato di
debiti impossibili da ripagare che, di fatto, aggravano, invece di
migliorare, la situazione dei Paesi in via di sviluppo. I tentativi di saldare i
debiti conducono a uno sfruttamento eccessivo delle risorse e a deficit di
bilancio colmati con la creazione di moneta che causa spinte
inflazionistiche, svalutazioni monetarie e speculazioni;
5. la questione della scala non è considerata nella teoria del libero scambio.
Quest’ultimo consente di allentare i vincoli ecologici a livello locale, ma
solo a scapito di un peggioramento della situazione a livello globale. Ogni
paese tenta, infatti, di vivere al di sopra della propria portata ecologica,
131
portando all’esterno i costi ambientali correlati. Questo risulta possibile
solo se esistono paesi disponibili a mantenere la loro scala molto al di
sotto della propria possibilità e ad accettare il peso dei costi ambientali
delle altre nazioni. Significa creare nazioni di serie A e nazioni di serie B,
concedere ad alcuni paesi il diritto di crescere e negarlo agli altri. Questo è
ciò che sta accadendo, in effetti. Lo sviluppo sostenibile ritiene questa
situazione economicamente ed eticamente inaccettabile.
Quello a cui anche i Paesi più poveri devono puntare è lo sviluppo e non la
crescita. Il concetto di crescita sostenibile è un paradosso che serve solo a creare
confusione. La crescita si riferisce solo ad aumenti quantitativi, lo sviluppo
riguarda, invece, il cambiamento qualitativo, la realizzazione di una potenzialità,
la transizione verso uno stato superiore o più compiuto. “Uno sviluppo
sostenibile, uno sviluppo senza crescita, non implica la fine delle scienze
economiche – al contrario, l’economia come disciplina diviene ancora più
importante. Ma è l’economia raffinata e complessa del mantenimento, del
miglioramento qualitativo, della condivisione, della frugalità, e dell’adattamento
ai limiti naturali. E’ un’economia del meglio, non del più grande” (Daly, 2001).
132
Capitolo 5
UNO SVILUPPO DIVERSO:
LA DECRESCITA
Il dibattito sulle critiche allo sviluppo e alla crescita ha portato, in questi ultimi
anni, alla nascita di un filone di pensiero radicale e alternativo che va sotto il
nome di “decrescita”. Si può sintetizzare la storia di questo movimento a partire
da due approcci: da un lato, la critica ecologica all’insostenibilità del sistema
economico capitalista, di cui si occupa in particolare Mauro Bonaiuti, a partire
dalla teoria bioeconomica di Georgescu-Roegen; dall’altro, lo sviluppo della
critica storica, economica e sociale allo sviluppo, condotta in modo particolare da
Serge Latouche e dal MAUSS (Movimento antiutilitarista nelle scienze sociali).
Sebbene la sua formulazione compiuta sia abbastanza recente, l’idea di decrescita
è in realtà già stata formulata a partire dalla fine degli anni ’60: l’evidente
fallimento dei programmi di sviluppo per il Sud del mondo portano a una critica,
da parte di molti autori come Andrè Gorz, François Partant, Jacques Ellul,
Cornelius Castoriadis e Ivan Illich, dell’idea di Homo oeconomicus per le sue
implicazioni sulla società e sulle relazioni umane. La società dei consumi, con le
sue basi fatte di progresso, scienza e tecnica, già in quegli anni non soddisfa le
aspettative di una rinascita del Sud e di un reale benessere al Nord, sfociando
nella ricerca di un doposviluppo.
La critica sociale è stata integrata con la questione ecologica: la presa di
coscienza, da parte della maggioranza della popolazione, della questione
ambientale, ha aggiunto al problema una nuova dimensione poiché, oltre a non
essere desiderabile, la crescita non è neppure sostenibile. La teoria bioeconomica
di Georgescu-Roegen rappresenta il primo approccio sistematico al problema,
proponendo un’economia che esca dal sistema della crescita per adeguarsi alla
biosfera.
La corrente di pensiero che, dagli anni ’60, si riferisce al doposviluppo ha
prodotto una serie di riflessioni critiche sui presupposti dell’economia e sui
fallimenti politici dello sviluppo. La ricerca di un’alternativa allo sviluppo ha
133
portato alla nascita del movimento Incad (Rete internazionale per la costruzione di
un’alternativa allo sviluppo), rete che pone al centro della sua analisi la messa in
discussione dello sviluppo stesso, cercando una strada che porti all’uscita
dall’economicismo e dalla crescita. Il concetto di decrescita si inserisce in questo
filone, che procede a una vera e propria decostruzione del pensiero economico,
rimettendo in causa le nozioni di povertà, bisogni, consumi e crescita.
Negli ultimi anni, il tema della decrescita ha avuto un rimbalzo mediatico molto
forte, tanto fare il suo ingresso anche sulla scena politica: prima in Italia, nel
2006, con l’elezione a deputato di Paolo Cacciari18 e con Maurizio Pallante19
consigliere del ministro per l’Ambiente durante il governo Prodi, e poi in Francia,
in particolare sostenuta da Yves Chocet dei Verdi.
Il successo della parola decrescita può essere ricondotto a quattro crisi che oggi
colpiscono il sistema mondiale: la crisi del clima, la crisi sociale con l’aumento
delle diseguaglianze, la crisi politica con una crescente disaffezione dei cittadini
all’amministrazione della cosa pubblica, la crisi dell’essere umano con la
sensazione diffusa di perdita di senso dell’esistenza.
Sebbene la decrescita venga spesso ridotta a una semplice diminuzione dei
consumi e degli sprechi, in realtà il movimento degli “obiettori della crescita” si
pone come obiettivo una vera e propria rivoluzione della cultura e degli stili di
vita.
Nell’analisi che segue, prenderò in considerazione soprattutto gli scritti di
Latouche, in quanto a lui va il merito di aver formalizzato i diversi contributi che
vanno nella direzione della decrescita. Il movimento della decrescita, infatti, è
formato da una serie di esperienze, studi, percorsi, approcci di vita che è difficile
limitare entro uno stesso contenitore teorico.
E’ inoltre interessante sottolineare come alcune esperienze di consumo alternativo
e di stili di vita differenti, messi in atto, già da tempo, da gruppi di cittadini, siano
coerenti con le ipotesi e le proposte avanzate dalla decrescita, per cui, anche senza
aderire formalmente alla teoria degli obiettori della crescita, portano avanti un
18
Autore di “Pensare la decrescita. Sostenibilità ed equità” edito da Cantieri Carta/Edizioni Intra
Moenia, 2006.
19
Autore di “La decrescita felice. La felicità non dipende dal Pil” edito da Editori Riuniti, 2005
134
processo di ristrutturazione della società perfettamente in linea con quello
auspicato dai teorici della decrescita.
In che modo è possibile definire la decrescita? E’ improprio parlare di teoria della
decrescita, mentre ha molto più senso definirla un movimento. Non esiste, infatti,
un modello di decrescita e le proposte e considerazioni che vengono fatte in
questo campo sono frutto più del confronto tra le esperienze che dell’analisi
scientifica. Latouche definisce la decrescita “uno slogan politico con implicazioni
teoriche, […] un ‘termine esplosivo’ […] che cerca di interrompere la cantilena
dei ‘drogati’ del produttivismo. […] Decrescita è semplicemente uno slogan che
raccoglie gruppi e individui che hanno formulato una critica radicale dello
sviluppo e interessati a individuare gli elementi di un progetto alternativo per una
politica del doposviluppo. Decrescita è dunque una proposta per restituire spazio
alla creatività e alla fecondità di un sistema di rappresentazioni dominato dal
totalitarismo dell’economicismo, dello sviluppo e del progresso” (Latouche,
2007).
135
5.1 La ricerca di un’alternativa
Da dove deriva questa tensione della società nel ricercare stili di vita alternativi e
in opposizione al sistema corrente? I capitoli precedenti hanno evidenziato come,
nel corso degli anni, sia emersa in modo sempre più evidente la difficoltà della
convivenza tra capitalismo e ambiente, a discapito di quest’ultimo. Inoltre, le
disuguaglianze sociali, lungi dallo scomparire, si sono accentuate, assumendo un
certo peso anche nei Paesi sviluppati.
Proprio in questi paesi si è diffusa l’idea di aver in qualche modo superato dei
limiti, dal punto di vista ambientale, ma non solo, come dimostra l’acceso
dibattito sulle questioni etiche. L’aumento dello spazio occupato dalle attività
umane, invece di creare solidità all’interno della società (un maggiore controllo
sul mondo), ha prodotto una crescente incertezza, derivante dalla complessità
sociale e dalla difficoltà di reperire informazioni certe e non contrastanti sui
fenomeni che oggi interessano il mondo, in particolare dal punto di vista
ambientale.
La situazione si traduce in una difficoltà sempre maggiore nell’interpretare quale
sia il percorso migliore per affrontare il mondo, ma allo stesso tempo crea la
convinzione che il sistema attuale non sia assolutamente la soluzione adatta, ma
anzi sia la causa stessa del problema. Bauman identifica tre tipi di incertezza che
caratterizzano l’uomo moderno:
–
l’incertezza fisica, che deriva dalla paura per la propria incolumità fisica e
per la propria salute, in rapporto a fattori che il soggetto individua come
pericolosi nell’ambiente;
–
l’incertezza cognitiva, che è legata alla difficoltà di tenere sotto controllo e
verificare le informazioni che giungono al soggetto;
–
l’incertezza esistenziale, infine, che riguarda le ideologie e le credenze del
soggetto, e rivela una debole visione metafisica del futuro, evidenziando
una difficoltà nell’inquadrare in una visione complessiva i continui
cambiamenti che si verificano intorno al soggetto.
La società tende a disgregarsi in nuclei sempre più piccoli e instabili: i gruppi si
sganciano da precisi ordini gerarchici, ma non possono sottrarsi alla necessità di
136
instaurare e mantenere rapporti con gli atri. Si crea una società modulare, in cui le
gerarchie si appiattiscono e le relazioni si fanno più discontinue e frammentarie. I
punti di riferimento cambiano continuamente, aumentando l’incertezza.
Di fronte a questa situazione, è possibile individuare una particolare forma di
risposta che Giorgio Osti definisce “nuovo ascetismo”. I rimedi per arginare le
quattro crisi che la società attuale sta affrontando sono da cercare nella
semplificazione. “Il caos è legato a una deriva morale dell’uomo moderno. […]
L’individualismo senza freni produce sfruttamento dei più deboli e distruzione
dell’ambiente. […] La radice della questione è dunque culturale: viene rintracciata
in quella rivoluzione che ha posto l’uomo al centro dell’universo; ha secolarizzato
ogni credenza in forme trascendenti e limitanti la sua capacità di azione. La
relazionalità con gli Altri, con il cosmo, con gli esseri viventi è stata gravemente
menomata per affermare un soggetto padrone del proprio destino. […] La risposta
è una riduzione dei consumi e dei ritmi di vita, una maggiore attenzione all’altro
da sé, compresa la natura” (Osti, 2006).
Si sono andati sviluppando, in questi ultimi anni, una serie di movimenti che, in
prima istanza, mirano a un diverso approccio al consumo, ma in realtà
rappresentano un modo diverso di affrontare l’aspetto economico nella propria
vita. I gruppi di acquisto solidale, i movimenti a favore del consumo critico, le
campagne a favore della riduzione degli sprechi energetici, sono fenomeni che,
oltre a scongiurare l’esaurimento delle risorse naturali, mirano anche a diminuire
il senso di esaurimento dello spazio-tempo a disposizione degli esseri umani e a
ridurre l’incertezza, attraverso la semplificazione delle organizzazioni e delle
pratiche di vita.
La definizione di nuovo ascetismo parte dall’etimologia del termine: esso deriva
dal greco –Fi0F4H, cioè esercizio. Esso indica una selezione delle relazioni nel
consumo di beni materiali, una condotta di vita regolata, uno sforzo costante al
perfezionamento di sé, un riferimento a valori assoluti. Le nuove forme di
ascetismo non sono indirizzate all’isolamento e alla solitudine, ma si traducono
invece in gruppi di individui che, consapevolmente, scelgono di indirizzare il
proprio stile di vita secondo una precisa etica e seguendo determinati valori
morali. Questa nuova forma di ascesi non è, quindi, vista in senso di
137
mortificazione dell’uomo e delle sue pulsioni, o come sacrificio: è intesa invece
come una scelta consapevole e condivisa, volta a ricreare quei rapporti umani che
la società dei consumi tende a sopprimere. E’ la ricerca di un’altra società.
La società della decrescita si può inscrivere in questo contesto: uscire
dall’immaginario dello sviluppo e del consumismo consente agli obiettori della
crescita di trasformare la società per creare un significativo e diffuso aumento del
benessere, materiale e mentale, senza distruggere l’ecosistema.
138
5.2 Che cos’è la decrescita
La decrescita è un movimento, complesso e articolato, che si sviluppa a partire da
pratiche concrete, in primo luogo la riduzione dei consumi. Esso si inserisce,
come già accennato, nel filone del doposviluppo e, in questo senso, rappresenta
anche una critica alle politiche di esportazione del modello occidentale nei Paesi
del Sud del mondo. Tuttavia, la critica si concentra particolarmente sulle società
più sviluppate e sull’ipercosumismo che le caratterizza.
Debitore dei contributi di autori come Georgescu-Roegen, il movimento della
decrescita fa proprie tutte le critiche concernenti la finitezza del pianeta e ai limiti
fisici dell’economia della crescita, ma si pone in netto contrasto con l’idea di
sviluppo sostenibile, sostenuta da Daly, come si vedrà nei prossimi paragrafi.
Se la crescita è il totem dell’economia, parlare di decrescita significa prima di
tutto mettere in discussione la centralità dell’economico nell’immaginario
collettivo e iniziare a pensare a un’altra società, attraverso una trasformazione
complessiva della struttura sociale, politica ed economica.
La decrescita non si presenta come un modello compiuto, ma mantiene un’anima
plurale e multidimensionale, per cui ogni territorio, ogni cultura può esprimersi in
forme e modi diversi.
Si possono individuare quattro livelli sui quali agisce la decrescita: quello
dell’immaginario, quello economico, quello sociale e quello politico.
A livello dell’immaginario è necessaria una trasformazione ampia dei valori. Essi
hanno carattere sistemico, per cui influenzano e sono influenzati dalle istituzioni,
dalla tecnologia, dell’economia. In una prospettiva sistemica non ha senso
chiedersi se debbano cambiare prima le istituzioni o i valori: è chiaro che entrambi
devono modificarsi e che gli uni sostengono e accompagnano la trasformazione
dell’altro.
A livello economico decrescita significa, innanzitutto, la riduzione delle
dimensioni delle grandi organizzazioni, dei sistemi di trasporto, delle tecnocrazie.
Queste dimensioni sono connesse ai volumi dei mercati e la decrescita si propone
di spostare il baricentro dall’economia dei mercati globali a quelli regionali e
locali, rilocalizzando l’economia.
139
Il terzo livello, quello sociale, presuppone di raggiungere la sostenibilità sociale in
termini di equità, giustizia e pace. I comportamenti aggressivi sono utili solo in
contesti espansivi, in un contesto non espansivo, come quello attuale, sono molto
più utili i comportamenti cooperativi e non predatori. La decrescita, attraverso il
progressivo aumento della domanda di beni relazionali, favorisce lo sviluppo di
un’economia solidale e sociale.
Il quarto livello è quello degli assetti politici. La decrescita mira, attraverso il
ridimensionamento
delle
dimensioni
di
imprese,
istituzioni
e
mercati,
all’affermarsi di una politica partecipata e conviviale, in modo da offrire a sempre
più persone una migliore qualità della vita, in organizzazioni sociali ed
economiche non disumanizzanti, ma al contrario portatrici di senso.
Il progetto della decrescita implica il rinascimento di una società autonoma ed
economa. Autonoma nel senso forte, etimologico, di società che si dà le sue leggi,
come reazione all’eteronomia della mano invisibile del mercato e ai diktat della
tecnologia e della scienza sulla società contemporanea. Economa nel senso di una
ri-educazione al risparmio e alla sobrietà. Lo slogan degli obiettori della
decrescita è “fare di più e meglio con meno”, nel senso di privilegiare un
approccio economico basato sulla qualità, piuttosto che sulla quantità.
L’idea guida è quella di ridurre ciò che diminuisce il benessere dell’uomo e del
pianeta, arrivando a creare degli spazi di libertà.
140
5.3 Il programma delle “otto R”
Realizzare una società della decrescita presuppone come primo passo, secondo
Serge Latouche, la necessità di abbandonare le pratiche insensate della crescita e
dei suoi effetti negativi e, come secondo passo, l’attuazione di circoli virtuosi per
un cambiamento radicale della prospettiva e della visione economica.
L’economista francese propone un programma basato su “otto R”: rivalutare,
riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare,
riciclare.
L’implementazione di questi otto cambiamenti, tra loro interdipendenti e che si
rafforzano reciprocamente, permette di innescare un processo di decrescita serena,
conviviale e sostenibile, in risposta all’attuale sistema caratterizzato da una serie
di “sovra”: sovrasviluppo, sovraconsumo, sovraproduttività, sovracomunicazione,
sovraindebitamento, sovrabbondanza, ecc…
5.3.1 Rivalutare
Significa rivedere i valori in cui si crede e in base ai quali si organizza la propria
vita. E’ impossibile, infatti, immaginare cittadini che vivano in una società della
decrescita, ma che rimangano condizionati da un immaginario legato allo stile di
vita della società dei consumi. La decrescita presuppone un profondo
cambiamento del sistema di valori su cui si fonda la società umana.
L’immaginario dominante è sistemico, cioè i valori attuali sono suscitati e
incoraggiati dal sistema stesso e a loro volta cotribuiscono a rafforzarlo. Occorre,
quindi, agire su ciò che sta dietro al sistema e attribuire nuovi significati al tempo,
alla vita, allo spazio. I valori da rivendicare, quelli che devono avere la meglio su
quelli diffusi nell’odierno sistema, sono indicati dallo stesso Latouche:
"l’altruismo
dovrebbe
prevalere
sull’egoismo,
la
collaborazione
sulla
competizione sfrenata, il piacere del tempo libero e l’ethos del gioco
sull’ossessione del lavoro, l’importanza della vita sociale sul consumo illimitato,
il locale sul globale, l’autonomia sull’eteronomia, il gusto della bella opera
sull’efficienza produttivistica, il ragionevole sul razionale, il relazionale sul
141
materiale, ecc.” (Latouche, 2008). La necessità è quella di modificare la visione
predatoria, che il capitalismo persegue nei confronti della natura, con un
atteggiamento più armonioso e complementare con l’ecosistema.
5.3.2 Riconcettualizzare
Significa modificare il contesto concettuale ed emozionale di una situazione, o il
punto di vista secondo cui essa è vissuta, così da mutarne completamente il senso.
In particolare, vanno ridefiniti i concetti di povertà e ricchezza, di scarsità e
abbondanza. L’economia attuale, infatti, trasforma l’abbondanza naturale in
scarsità, creando artificialmente mancanza e bisogno, attraverso la mercificazione
della natura. Il cambiamento dei valori, definito nel paragrafo precedente, porta a
una diversa visione del mondo, i cui elementi vanno ridefiniti e ridimensionati.
Il cambiamento non può essere imposto, né è facile cambiare volontariamente il
proprio immaginario, che accompagna ogni essere umano fin dalla nascita. Alla
base di questa volontà devono esserci una riflessione profonda e il desiderio di
mettere in atto un tale cambiamento. I valori dominanti nella società odierna sono
condivisi da tutti, non esistono sostanziali distinzioni di classe, ceto, età. La
cultura del povero e quella del ricco seguono praticamente gli stessi valori,
soprattutto nell’ambito dei consumi, seguendo una sorta di pensiero unico.
L’economia è vista universalmente come una funzione fondamentale nello
sviluppo dell’umanità dell’uomo; spesso è vista come sinonimo di progresso.
Uno
dei
punti
fondamentali
su
cui
deve
concentrarsi
l’azione
di
riconcettualizzazione è il consumo. Latouche riprende la nozione di consumo
sviluppata da Berthoud. Egli rifiuta la crematistica, ovvero la scienza economica
che tratta la ricchezza in quanto tale, per riscoprire un’economia fatta di
reciprocità e di dono. Per Berthoud, il vero consumo consiste nell’uso
parsimonioso di una serie di ricchezze di proprietà del soggetto, in vista della
felicità e in armonia con se stesso. Il consumo diventa frutto della relazione con
l’altro, perché ricevere dei beni significa soprattutto riceverli all’interno di una
cultura e di un mondo. La riscoperta dei beni relazionali, a discapito dei soli beni
materiali, è uno dei punti di forza della decrescita. Il piacere del consumo non
142
deriva dall’accumulo di beni materiali, ma dalle relazioni che l’esperienza di
consumo permette di avere con gli altri individui.
L’ideologia del sistema attuale è diffusa, secondo Latouche, soprattutto dal
sistema pubblicitario. Come osserva Castoridias, però, il pensiero unico non è
frutto di un’imposizione totalitaria, ma è ciò che la gente vuole. Il sistema, in
qualche modo, si autoalimenta in un processo circolare, per cui crea le condizioni
che portano a questa situazione e, allo stesso tempo, viene rafforzato e consolidato
dai comportamenti degli individui che appoggiano i valori che lo caratterizzano. Il
progresso, la crescita, il consumo sono ormai parte della vita e dell’immaginario.
Ma non sono più scelte consapevoli: esse vengono cercate per abitudine, per
assuefazione o per adeguamento, e abbandonare tali “pratiche” non risulta un
atteggiamento naturale, come poteva esserlo nel passato, ma deve essere frutto di
una precisa volontà. La soluzione è creare una rete di controinformazione che
permetta di uscire da questo circolo vizioso, per mettere in atto una
decolonizzazione dell’immaginario.
5.3.3 Ristrutturare
Il cambiamento dei valori deve essere seguito da un adeguamento delle strutture
produttive, dei modelli di consumo, delle strutture sociali, degli stili di vita. Il
cambiamento, infatti, non può avvenire all’interno di una società della crescita.
L’economia della crescita è il nodo su cui si instaura la questione. La critica degli
autori che propongono la decrescita, infatti, non si concentra tanto sul capitalismo,
quanto piuttosto su un’economia che pone alla base della sua realizzazione
l’accumulazione di capitali e beni materiali. Essi sottolineano come sia stato
possibile realizzare un’economia della crescita anche nelle società socialiste. Il
paradigma della crescita è, infatti, stato appoggiato, in modo diverso, ma con gli
stessi risultati, sia dalle economie di mercato sia dalle economie pianificate:
entrambe sostengono l’idea del produttivismo, dello sfruttamento della natura per
rispondere alla domanda e si propongono di soddisfare il benessere sociale
attraverso aumenti illimitati della capacità produttiva. Il principio della crescita
non è messo in discussione dalla teoria marxista: si rovescia lo status degli aventi
143
diritto alla ripartizione dei suoi frutti, ma non se ne mette in discussione l’essenza.
La decrescita implica, invece, una diminuzione dell’accumulazione, ma non si
accontenta di rallentarla, presuppone di rovesciare il concetto per creare un nuovo
modo di produzione. Quello che è mancato, nella teoria marxista e nel socialismo
reale, è stata una riflessione sulla questione ecologica.
E’ opportuno, a questo punto, aprire una parentesi sui rapporti tra capitalismo e
decrescita. Come già accennato, la decrescita non è un’opposizione al capitalismo,
quanto al sistema basato sull’accumulazione e sulla crescita. In questo senso,
poiché una società della decrescita opta per una riduzione dello sfruttamento,
dell’accumulazione e della spoliazione, non può che essere in contrasto con il
capitalismo, che fa di questi elementi delle caratteristiche prioritarie della sua
natura. Il rapporto tra capitalismo e decrescita è, dunque, complesso, poiché non si
tratta solo di contestare le pratiche economiche, ma lo spirito stesso della società
capitalista.
Tuttavia, i teorici della decrescita non negano l’importanza di alcune istituzioni,
diventate caratterizzanti del sistema capitalistico, ma che in realtà hanno una
natura più sociale che economica. Latouche porta come esempio le società
africane, dove esistono strutture che possono essere chiamate mercato, moneta o
retribuzione salariale, ma che tuttavia non possono certo chiamarsi istituzioni
capitaliste. “Questi rapporti ‘economici’ non sono dominanti né nella produzione,
né nella circolazione di ‘beni e servizi’ e, soprattutto, questi aspetti non sono
articolati in modo tale da ‘fare sistema’. […] Il sistema di pensiero e di valori di
queste società è così poco colonizzato dall’economia che fanno economia senza
saperlo” (Latouche, 2007). Le istituzioni che sono diventate tali con il
capitalismo, non devono essere confuse con la sua essenza.
E’ possibile pensare a un’uscita dal capitalismo? La risposta è sicuramente
negativa, nel senso che non si può immaginare una totale abolizione del mercato,
dei capitalisti, della proprietà privata o della moneta. La società finirebbe nel caos.
Neppure si può realisticamente pensare a una rivoluzione in nome della decrescita
che, in tempi brevi, modifichi un sistema e crei un nuovo immaginario.
La soluzione è, quindi, quella di non rinunciare alle istituzioni del capitalismo, ma
di collocarle all’interno di un’altra logica, guidata dai principi della società della
144
decrescita. E’ difficile, infatti, implementare una società complessa, senza avere
degli strumenti che coordinino e regolino gli scambi. La moneta, ad esempio,
intesa come strumento di scambio e di attribuzione di valore, ha un ruolo
importantissimo. Gli obiettori della crescita non giudicano negativamente lo
strumento, ma l’uso che se ne fa, in questo caso quello di veicolo per
l’accumulazione del capitale.
Si tratta, però, di convertire, oltre gli strumenti, anche l’apparato produttivo.
Questa è riconosciuta come una delle fasi più delicate del passaggio da una società
capitalista a una società della crescita, perché va a intaccare il cuore del sistema.
Latouche propone degli esempi pratici di conversione produttiva: ad esempio la
conversione delle industrie automobilistiche in industrie di componenti per la
cogenerazione di energia. E’ difficile dire se una tale operazione sia fattibile: i
problemi che emergono non sono tanto a livello tecnologico. Ancora una volta,
l’elemento chiave è la volontà di realizzare una società diversa.
5.3.4 Ridistribuire
Il concetto può essere sintetizzato nello slogan “predare meno, piuttosto che dare
di più”. La redistribuzione deve riguardare l’eccesso alle risorse e un’equa
distribuzione della ricchezza tra tutti gli abitanti del pianeta, tra le classi e tra le
generazioni, in modo da assicurare a ogni individuo un lavoro e un livello di vita
dignitoso.
Il problema ridistributivo può essere analizzato su più piani.
Innanzi tutto vi è un problema di rapporti Nord/Sud. Lo sfruttamento operato dai
Paesi occidentali nei confronti del Sud del mondo determina un immenso debito
ecologico ed etico nei confronti di queste popolazioni. La redistribuzione e
l’assolvimento del debito contratto nel corso dei secoli possono partire solo da un
ridimensionamento della classe consumatrice mondiale, in modo da limitare la
predazione di risorse naturali nei Paesi in via di sviluppo.
La redistribuzione riguarda poi l’uso delle risorse naturali. Anche in questo caso,
sono stati piuttosto i Paesi occidentali ad avvantaggiarsi della possibilità di
usufruire di materie prime a bassissimo costo, riducendo i Paesi in via di sviluppo
145
a miniere per prelevare risorse e a discariche per disfarsi dell’enorme quantità di
rifiuti prodotti. Occorre garantire a tutti la stessa possibilità di accesso a queste
risorse.
Uno dei problemi fondamentali riguarda i suoli, in una duplice accezione: come
terreno per le attività agricole e come paesaggio. In entrambi i casi è necessario
ripensare all’uso della terra. La ripartizione dei suoli è un problema che tocca da
vicino gli agricoltori del Sud del mondo, che devono confrontarsi con le colture
estensive che limitano il loro accesso alla terra, oltre che con la sempre più rapida
erosione e desertificazione dei terreni agricoli. Nel Nord, il cambiamento deve
riguardare piuttosto la qualità dei suoli, intesi come paesaggi da preservare dalla
cementificazione e dall’inquinamento.
Latouche, appoggiando le proposte degli ecologisti, parla anche di una
ridistribuzione del lavoro, sotto due punti di vista: da una parte prospetta una
diminuzione delle ore di lavoro, nell’ottica di riduzione di produzione e consumi e
per favorire lo sviluppo di rapporti umani piuttosto che economici; dall’altra,
auspica lo sviluppo di professioni verdi, quali possono essere quelle legate alle
energie rinnovabili, nell’ottica di una ristrutturazione del sistema produttivo.
5.3.5 Rilocalizzare
In opposizione all’attuale tendenza alla globalizzazione e alla delocalizzazione
produttiva, la teoria della decrescita propone di tornare a concentrare produzione e
consumo a livello locale. Questo permette, innanzitutto, di evitare i costi
ambientali ed economici legati ai trasporti e, in seconda battuta, di creare una
comunità che sviluppi una politica, una cultura e un senso della vita ancorati al
territorio, piuttosto che proiettata a una scala globale ma indeterminata. Il locale
deve tornare a essere il punto di riferimento per lo sviluppo della società: i bisogni
locali devono essere soddisfatti localmente, attraverso produzioni che avvengono
sul territorio, finanziate dai risparmi raccolti localmente. La società della
decrescita lascia ampio spazio anche all’autoproduzione, nell’ottica della
riduzione dei rapporti di mercati superflui. Rendendo sempre più stretta la
relazione tra cittadini e territorio, si raggiunge una nuova consapevolezza del
146
potere delle proprie azioni e delle proprie decisioni all’interno del sistema
economico e sociale. La società della decrescita, infatti, può essere implementata
solo attraverso una scelta volontaria e consapevole. Tale scelta può essere
effettuata solo in un contesto di doposviluppo, ed è proprio la spinta locale che
può permettere di uscire dall’impasse dello sviluppo, poiché crea una collettività
cosciente delle proprie scelte. Non si tratta di sviluppare tante piccole realtà
slegate dal contesto globale, ma di procedere a una riappropriazione del territorio
in chiave sistemica, sviluppando una rete di esperienze che possano pian piano
risanare il deserto prodotto dalla globalizzazione.
5.3.6 Ridurre
La parola “riduzione” è quasi un sinonimo di decrescita. Tuttavia, ridurre non
significa continuare a svolgere le stesse attività solo riducendo le quantità. Si
tratta di diminuire l’impatto complessivo delle attività umane sul pianeta, il che
presuppone un cambiamento di stile di vita più radicale di una semplice riduzione
dei consumi. Latouche parla di riduzione nell’uso e nella produzione di “prodotti
tossici”, inteso in senso lato: sono tossici tutti quei prodotti e quelle attività che
hanno un impatto sull’ecosistema, ma anche sul sistema uomo, comprese
pubblicità, armamenti ed energia nucleare. La critica di Latouche è
particolarmente severa nei confronti della pubblicità; citando Besset egli afferma:
“il sistema pubblicitario si impadronisce della strada, invade lo spazio collettivo –
depauperandolo – si appropria di tutto ciò che ha una vocazione pubblica. […]
L’aggressione avviene a ogni livello. La pubblicità ci segue continuamente
producendo inquinamento mentale, visivo e sonoro” (Latouche, 2007)20. L’indice
degli obiettori della crescita è puntato contro il sovraconsumo e contro lo spreco
dilagante nelle società occidentali.
La riduzione deve poi riguardare in modo particolare i trasporti e i consumi di
energia, attraverso la riduzione degli sprechi energetici e lo sviluppo delle energie
rinnovabili.
20
Besset J.-P., 2007, La scelta difficile. Come salvarsi dal progresso senza essere reazionari, Bari,
Dedalo; citato da Latouche in “La scommessa della decrescita”.
147
Ma la riduzione concerne anche il mondo del lavoro. Secondo le tesi di Latouche,
per assicurare a tutti un impiego soddisfacente è necessario ridurre le ore di
lavoro. Non tutti i teorici della decrescita condividono l’assunto secondo il quale
una società della decrescita porta necessariamente a una diminuzione del lavoro.
Esistono, infatti, almeno quattro fattori, che spingono in direzioni opposte: da un
lato, la rilocalizzazione delle attività e la fine dello sfruttamento del Sud, insieme
alla diminuzione della produttività conseguente all’abbandono del modello termoindustriale, favoriscono un aumento delle ore di lavoro; dall’altra, la creazione di
posti di lavoro per tutti quelli che lo desiderano e il cambiamento degli stili di
vita, con l’eliminazione dei bisogni inutili, portano a una diminuzione della
quantità di lavoro.
Diminuire le ore di lavoro, oltre a consentire a un maggior numero di individui di
partecipare alla produzione, significa riproporre il lavoro come valore e
permettere di riconquistare il proprio tempo. Lavorare per poche ore al giorno
consente di dedicare più tempo ad altre attività, favorendo la realizzazione degli
individui non come strumenti della produzione e come consumatori, ma
soprattutto come persone e come cittadini.
5.3.7 Riutilizzare/Riciclare
La società della decrescita impone un atteggiamento diverso nei confronti delle
cose. La società dei consumi rende i prodotti deteriorabili e obsoleti dopo
pochissimo tempo. Per gestire il problema ambientale è necessario modificare
questa continua tendenza al nuovo, allungando la durata di vita dei prodotti e
sviluppando una cultura del riciclo, che consenta una netta diminuzione
dell’impatto antropico sull’ecosistema.
Le abitudini del consumismo hanno fatto dimenticare la cultura della riparazione e
del riutilizzo che era invece pratica diffusa fino a qualche generazione fa. Il
settore industriale ha le sue colpe, poiché molti dei prodotti oggi sul mercato sono
semplicemente irreparabili, sono cioè creati per non durare e per essere sostituiti
al minimo guasto. Il riutilizzo è, quindi, strettamente legato alla ristrutturazione
148
del sistema produttivo e, ancora una volta, a una ridefinizione dei valori che
guidano l’economia.
Il riciclaggio, per gli obiettori della crescita, diventa una sorta di obbligo morale
nei confronti dell’ambiente, ma anche delle popolazioni del Sud che subiscono lo
sfruttamento delle risorse sul loro territorio.
Anche il riciclaggio rientra in un riassestamento dei modi produttivi. Per essere
riciclate, le merci devono essere prodotte con certi criteri che facilitino
l’operazione di smaltimento al termine del loro ciclo di vita. Alcuni esempi
virtuosi provengono dalle aziende stesse. La Xerox, azienda specializzata nella
produzione di fotocopiatrici, dal 1990 concepisce l’assemblaggio dei suoi prodotti
in modo che le componenti possano essere facilmente riciclabili al termine della
vita della macchina. L’azienda stessa riutilizza gran parte dei pezzi per la
produzione di nuove macchine.
149
5.4 La critica allo sviluppo sostenibile
Il concetto di sviluppo sostenibile era già stato criticato da Georgescu-Roegen,
come un ossimoro svuotato di significato. I fautori della decrescita riprendono
questo giudizio, estendendo la critica a tutti i tipi di sviluppo. Negli anni, a partire
dalla definizione di sviluppo sostenibile fornita dal rapporto Bruntland, si sono
moltiplicati i “tipi” di sviluppo da implementare per migliorare la situazione della
numerosa umanità costretta alla povertà nei Paesi in via di sviluppo.
La principale critica mossa al concetto di sviluppo sostenibile riguarda la sua
stretta relazione con la crescita. A dispetto dell’interpretazione di Daly, Latouche
ritrova nella sostenibilità gli stessi elementi che la decrescita vuole cancellare. E’
l’attaccamento al concetto di sviluppo che deve essere trasformato, in quanto
proprio lo sviluppo sarebbe la causa delle stesse problematiche che vorrebbe
risolvere.
Gli obiettori della crescita storcono il naso di fronte al consenso unanime che lo
sviluppo sostenibile ha riscontrato sia nel mondo degli affari che nel settore
umanitario. Il concetto è valido sia nell’orientamento realista del mondo degli
affari che in quello associativo e degli intellettuali umanisti. Questo è possibile
perché la parola sostenibile viene interpretata in modi differenti dai due
orientamenti: da un lato si traduce in uno sviluppo durevole, cioè la speranza che
questo tipo di sviluppo possa protrarsi all’infinito; la questione ambientale viene
affrontata semplicemente in termini di immagine, introducendo l’approccio
environmental friendly all’interno del sistema di produzione. Nel secondo caso, lo
sviluppo viene concepito come la possibilità, per i Paesi in via di sviluppo, di
raggiungere un benessere e un livello di vita soddisfacente, senza porsi troppi
interrogativi sulla compatibilità dei due obiettivi, sviluppo e ambiente.
Il tutto è giocato sull’ambiguità nell’uso di termini come compatibilità e
sostenibilità, la cui differenza, per quanto sottile, è importantissima. L’ambiguità
insita nell’uso alternativo che si fa dei due termini, infatti, permette di concepire
prima lo sviluppo e poi di renderlo sostenibile, attraverso le diverse forme di
compatibilità ambientale.
150
Insomma, lo sviluppo sostenibile diventa un concetto di moda, ma con scarsi
contenuti, utile per continuare a sostenere il paradigma della crescita, guarnendolo
con nuovi aggettivi. Così, i fallimenti delle politiche sviluppiste hanno portato a
un proliferare di nuovi tipi di sviluppo: lo sviluppo autocentrato, umano,
partecipativo, equo, locale, l’ecosviluppo, l’etnosviluppo e l’endosviluppo. In
realtà, però, non si mette mai in discussione il vero problema, cioè
l’accumulazione capitalista.
Latouche considera lo sviluppo, allo stesso tempo, un pleonasmo e un ossimoro.
“Pleonasmo perché lo sviluppo è già di per sé una self-sustaining growth
(‘crescita autosostenuta’) secondo la definizione di Walt Rostow. Ossimoro
perché lo sviluppo, in realtà, non è né sostenibile né durevole” (Latouche, 2008).
Il problema non sta tanto nell’aggettivo che a esso viene affiancato, quanto nello
stesso concetto di sviluppo: “Lo sviluppo è una parola tossica, quale che sia
l’aggettivo che gli viene applicato” (Latouche, 2008). E’ vero, infatti, che la
sostenibilità risulta un concetto positivo: essa prevede che le attività umane non
incidano sull’ambiente in modo da oltrepassare la capacità dell’ecosistema di
rigenerarsi. Tuttavia, il significato storico dello sviluppo ha preso strade
decisamente lontane da questo criterio. Si è tradotto in una mercificazione del
rapporto tra uomo e natura, con quest’ultima considerata una risorsa da sfruttare,
valorizzare e da cui trarre profitto. Aggiungere alla parola sviluppo il termine
sostenibile non serve, quindi, a mettere in discussione lo sviluppo esistente e fino
a oggi implementato, ma semplicemente a concepirlo in un’accezione ecologica.
Le analisi che calcolano l’impronta ecologica dei paesi dimostrano che l’attuale
sfruttamento delle risorse non è compatibile con una sola Terra. I Paesi
occidentali stanno vivendo al di sopra delle loro risorse. I teorici della decrescita
sostengono che a questo punto la sola crescita zero non è abbastanza. Pensare a
un’economia in stato stazionario non basterebbe a rimediare al danno: anche
mantenendo la produzione e la popolazione al livello attuale, la Terra non sarebbe
in grado di sopportare l’impatto delle attività umane.
Il concetto di sostenibilità deve essere rapportato alla riproduzione sostenibile.
Questa era la base del rapporto natura – uomo nei secoli precedenti: l’uso delle
risorse, fino al XVIII secolo, era limitato alla potenzialità rigeneratrice della
151
natura. Difficilmente lo sfruttamento superava la capacità dell’ecosistema di
continuare a riprodursi. Anche se nel Sud del mondo è ancora possibile ritrovare
artigiani e contadini che vivono in armonia con il loro ambiente, che conoscono i
suoi ritmi e che propongono comportamenti sostenibili, oggi non sarebbe più
possibile, agli attuali livelli di sfruttamento e consumo, anche ipotizzando una
crescita nulla, implementare una riproduzione sostenibile.
Questa è la critica che gli obiettori della crescita rivolgono ai sostenitori dello
sviluppo sostenibile. “Se siamo a Roma e dobbiamo andare a Torino in treno e per
sbaglio abbiamo preso la direzione di Napoli, non basta rallentare la locomotiva,
frenare o fermarsi, bisogna scendere e prendere un altro treno nella direzione
opposta” (Latouche, 2007). Mettere in pratica la decrescita si inserisce
esattamente in questa prospettiva: occorre cambiare la rotta, non solo rallentare la
nostra velocità.
Tuttavia, il rapporto tra sviluppo sostenibile e decrescita non può essere liquidato
con una sentenza di incompatibilità totale. Nel capitolo dedicato a Herman Daly, è
stato possibile osservare come l’economista inglese proponga anch’egli una
trasformazione della società. La sua proposta non si ferma all’ambito economico:
è necessario raggiungere uno stato stazionario per non oltrepassare i limiti del
pianeta, ma allo stesso tempo è necessario mettere in atto un ripensamento dei
valori e della società. L’idea di “comunità di comunità”, presentata da Daly come
la possibilità di affrontare in modo partecipato e sostenibile la sfida dello
sviluppo, non è molto lontana dal concetto di rilocalizzazione presentato da
Latouche nel programma delle “otto R”. Anche Daly critica fortemente gli aspetti
dello sviluppo che hanno portato all’attuale situazione di emergenza ambientale e
sociale.
Si tratta quindi solo di una divergenza terminologica? A un’analisi più
approfondita l’ambiguità del dibattito rimane sullo sfondo, ma è forse possibile
tracciare alcune linee di chiarimento. E’ chiaro che lo sviluppo sostenibile
proposto da Daly non è lo stesso sviluppo reale che domina il pianeta da due
secoli. E’ uno sviluppo diverso, ma che, nonostante le critiche apportate al
sistema, si inserisce ancora nel paradigma capitalista. La società della decrescita,
invece, auspica l’uscita da questo sistema.
152
Il concetto di sostenibilità, infatti, può essere inteso in due modi diversi: da una
parte, una sostenibilità che i fautori della decrescita definiscono contraddittoria e
che si riferisce a una tecnocrazia ecologica (cioè amministrare i livelli di
inquinamento e di degrado accettabili, in un contesto capitalista); dall’altr, la
sostenibilità rappresenta “una possibile porta per uscire dalla cornice ideologica in
cui
si
trova
la
cultura
occidentale
ancora
religiosamente
aggrappata
all’immaginario della crescita e dello sviluppo” (Deriu, 2005).
In questa seconda accezione, la sostenibilità è approvata dalla teoria della
decrescita, in quanto non apparentata con il termine sviluppo e connotata da
alcuni elementi differenti rispetto a quella presentata da Daly.
Lo sviluppo sostenibile riconosce l’esistenza di limiti alla crescita. Tuttavia questo
non è sufficiente: occorre soprattutto cambiare la visione che l’uomo ha di sé e del
suo rapporto con la natura. Occorre, quindi, rimettere in discussione il rapporto tra
uomo e natura, affrontando la questione ecologica non in termini di interventi ad
hoc, ma in maniera sistemica, in modo da influire sulle nostre azioni a monte. La
teoria della decrescita percepisce l’individuo inserito all’interno di un ambiente
che non è qualcosa di differente da sé, ma parte dell’individuo stesso, in una
concezione che fa dell’uomo e dell’ambiente un unico ecosistema. Non considera,
quindi, gli ecosistemi come elementi depurati dalla presenza antropica, ma come
frutto dell’interrelazione tra individui e ambienti. Questa visione olistica permette
di affrontare la questione ambientale non come un’esternalità da minimizzare, ma
come un elemento da tenere in conto normalmente nell’azione umana, in quanto
costitutiva dell’uomo stesso.
L’ecologia diventa, quindi, non una nuova sensibilità, di moda nel mondo attuale:
si vuole recuperare la sensibilità ecologica tipica delle società tradizionali, che
esprimevano un’organizzazione ordinata e armonica delle relazioni con
l’ambiente.
Questa
concezione
appare
in
netto
contrasto
con
l’idea
antropocentrica di uomo dominatore della natura, diffusa con il capitalismo: la
decrescita recupera una visione in cui la natura viene riconosciuta e rispettata
come elemento fondamentale per la vita umana.
L’enfasi posta dallo sviluppo sostenibile rispetto ai diritti delle generazioni future
viene affiancata, nella visione della decrescita, a un riconoscimento delle
153
generazioni passate. La modernità tende a considerare in modo negativo e
riduttivo il passato, poiché si basa su una fede nel progresso infinito. Riconoscere
e rivalutare il rapporto con le generazioni passate, attraverso la riscoperta di stili
di vita davvero sostenibili, rappresenta uno dei modi per mettere in atto la società
della decrescita. Tutto questo senza eliminare con un colpo di spugna la
modernità, ma con la consapevolezza che l’attuale modello non è riproducibile
all’infinito e con la creazione di una nuova società.
L’attenzione alla produzione e allo sviluppo sostenibile deve essere sostituita con
la riaffermazione della centralità della riproduzione e rigenerazione come
condizioni della sostenibilità, così com’era naturale nelle società tradizionali. E’
chiaro che non è possibile cancellare due secoli di società della crescita. La
necessità di un nuovo paradigma condiviso, di un differente sistema di valori che
apra le porte a forme di organizzazione sociale differente, presuppone una
rivoluzione dell’immaginario che non è contemplata nel concetto di sviluppo
sostenibile di Daly che, nonostante ponga l’accento sulla necessità di un
cambiamento, non si spinge a suggerire una completa uscita dal modello
capitalistico occidentale.
154
5.5 I consumi
La società odierna è stata definita da Baudrillard “società dei consumi”, mentre
più recentemente Bauman ha coniato un appellativo per descrivere l’ultima
evoluzione umana: Homo consumens.
I consumi hanno da tempo preso una strada autonoma rispetto alla produzione:
non è il valore d’uso o l’utilità che fa di un bene un prodotto di consumo, ma il
suo significato simbolico, che permette di instaurare un dialogo con la società e di
lanciare precisi segnali alle persone che incontriamo.
Se la produzione e il consumo servono a soddisfare i bisogni degli individui, è
logico pensare a un flusso di informazioni che dal consumatore, attraverso il
mercato, arriva al produttore e a un flusso inverso di prodotti che dal produttore,
attraverso il mercato, arrivano al consumatore per soddisfare le sue esigenze.
Tuttavia, oggi, il flusso informativo si realizza piuttosto nel senso opposto: dal
produttore le informazioni, attraverso il mercato, giungono al consumatore, che a
questo punto mette in atto le sue dinamiche di consumo, in modo spesso
inconsapevole. Il termine consumismo nasce per indicare la ricerca di felicità
attraverso l’accumulazione di beni di consumo. La produzione di massa permette
l’aumento del tenore di vita di strati sempre più larghi di popolazione, cresce la
capacità di spesa, ma questa stessa crescita desta anche reazioni di delusione e di
critica, come se, nonostante la possibilità di soddisfare un numero sempre
maggiore di desideri, questi ultimi si rivelino, in realtà, illimitati e non
soddisfabili. L’aumento dei consumi, e la conseguente crescita del Pil, non si
sono, quindi, tradotti in un aumento del benessere esistenziale e della felicità.
Sono nati nuovi strumenti di consumo, che facilitano lo scambio e creano nuovi
rapporti tra gli individui, ma anche rispetto alle cose. Molti dei luoghi in cui oggi
trascorriamo il nostro tempo sono diventati strumenti di consumo: non solo i
centri commerciali e i negozi, ma anche i parchi a tema, le navi da crociera, gli
stadi, gli uffici postali, le università e i musei. Si è modificata la natura dei
rapporti sociali: si tratta sempre più di “interazioni con le cose e non con gli altri
esseri umani; […] si cerca di massimizzare il contatto senza mediazione tra
155
consumatori e merci e sevizi” (Ritzer, 1996), in modo che gli individui non siano
spinti a far altro che non sia la soddisfazione dei loro desideri.
D’altro canto, un’economia improntata sulla crescita non può che volere questo,
che i desideri siano illimitati per continuare a perpetuare all’infinito il consumo.
In questo modo, gli individui darebbero senso alla propria vita attraverso i
consumi. Il sistema odierno spinge gli individui verso consumi sempre più
ingenti, creando nuovi bisogni (attraverso la pubblicità), rendendo i prodotti non
riparabili e obsoleti dopo pochissimo tempo, cavalcando delle mode decisamente
effimere. D’altro canto, il consumatore è perennemente insoddisfatto, poiché
l’insoddisfazione è il motore stesso del sistema: “Occorre sempre eliminare
qualcosa, e bisogna farlo in fretta” (Bauman, 2007), perché l’economia deve
crescere a ritmi sempre più vertiginosi.
“Un sistema economico fondato sulla crescita ha bisogno di esseri umani appiattiti
sul consumismo, che nell’atto di acquistare acquietano le proprie esigenze
affettive e trovano la propria realizzazione esistenziale, altrimenti non
susciterebbero la domanda crescente necessaria ad assorbire l’offerta crescente di
merci e il meccanismo della crescita si incepperebbe” (Pallante, 2005). La catena
è chiara: acquistare più merci e servizi significa incentivare la produzione, che
vuol dire più lavoro, più redditi ai lavoratori e alle loro famiglie che quindi
possono acquistare più merci e servizi; i quali a loro volta richiedono merci,
materiali ed energia.
Dove è andata a finire la libertà, se il sistema ci “costringe” a consumare sempre
di più, indicandoci anche in quale direzione devono andare i nostri consumi? In
realtà, il consumo viene percepito come espressione della libertà individuale.
L’offerta di prodotti è talmente ampia che nessuno, in un centro commerciale, può
dire di sentirsi obbligato a consumare. Tuttavia, se il consumo rappresenta un
dialogo con la società e un messaggio per gli individui, in particolare per il gruppo
a cui vogliamo appartenere, allora il discorso diventa più complicato. Si è liberi di
scegliere, “ma la scelta in quanto tale – […] – non è in discussione, dato che è
esattamente ciò che si deve fare e che non si può in alcun modo evitare di fare, se
non si vuole rischiare l’esclusione” (Bauman, 2007). La scelta e la libertà
diventano, per il consumatore, la stessa cosa, poiché è attraverso il consumo che si
156
esprime il proprio essere e la propria appartenenza, come cittadini, alla società dei
consumi (si pensi agli inviti a consumare rivolti dalle istituzioni stesse, come la
campagna televisiva di qualche anno fa che recitava “l’economia gira con te”).
La società dei consumi e della crescita ha bisogno di prodotti dalla vita breve e di
mode sempre nuove. Ma ha anche bisogno di nuovi strumenti di consumo che
accompagnino il consumatore nel suo percorso e lo spingano a mettere in atto ciò
per cui tali strumenti sono stati creati: aumentare le probabilità di consumo. La
pubblicità, attraverso le immagini e i suoni, i luoghi stessi di consumo attraverso
colori e luci, creano lo spettacolo, cioè il modo per attrarre, in un’opera di
reincanto, il maggior numero di persone e per indurle a spendere. Baudrillard ha
sostenuto che viviamo in una società della “simulazione”, in cui gran parte di ciò
che ci circonda è fittizio, irreale e artificiale. “La società dei consumatori ha
bisogno, per funzionare adeguatamente, di ricoprire con un velo di ipocrisia la
differenza tra le convinzioni popolari e la realtà della vita dei consumatori. […]
Oltre a essere un’economia basata sull’eccesso e sullo spreco, il consumismo è
anche un’economia dell’inganno. Solo che l’inganno, e con esso l’eccesso e lo
spreco, non si manifestano come sintomi di qualcosa che non funziona, ma al
contrario come segni di buona salute e ricchezza e come una promessa per il
futuro” (Bauman, 2007).
La pubblicità è forse lo strumento che più di ogni altro incarna questo aspetto. La
pubblicità celebra la figura del “prodotto-eroe”, lanciando un chiaro messaggio: il
consumo è la soluzione a tutti i problemi. Al tempo stesso, riduce e
destrutturalizza i temi d’attualità della vita sociale culturale o politica in una
semplificazione che si traduce in disinteresse da parte dei cittadini. Il discorso
pubblicitario, attraverso la retorica dell’associazione, manipola la realtà attraverso
le immagini e riduce i valori a segni. I simboli diventano patrimonio collettivo,
mentre la solidità dei valori si perde in un caleidoscopio di immagini.
L’onnipresenza quantitativa del fenomeno pubblicitario ha determinato anche un
modo diverso di imporre i modelli su una società sempre più vulnerabile a ogni
stimolo esterno. E’ ormai un discorso dominante, per cui il modello non viene
imposto con “fate così”, ma reso reale da un “tutti fanno così”; non si mostra
“quello che devi essere”, ma si rivela “ecco ciò che tu sei”.
157
Il consumismo ha serie conseguenze anche sulle relazioni umane, disgregando i
rapporti e sostituendo il contatto con l’altro con il contatto con le merci. “Esposti
al bombardamento incessante della pubblicità, per effetto delle tre ore di
televisione che guardano, in media, ogni giorno (pari a metà del loro tempo
libero), i lavoratori sono persuasi ad avere ‘bisogno’ di un maggior numero di
cose. Per comprare ciò di cui, a questo punto, hanno bisogno, servono loro dei
soldi. E per guadagnarseli, lavorano più a lungo. Ma dato che stanno sempre più
fuori casa, cercano di rimediare alla propria assenza facendo dei regali costosi ai
famigliari. In altre parole materializzano il proprio amore. E il ciclo continua”
(Hochschild, 2003)21. La convivenza con gli altri diventa sempre più difficile e il
crescente distacco emotivo porta a una sempre minore capacità di gestire i
conflitti.
Nella moderna società dei consumi non esiste più un gruppo di riferimento: è stato
sostituito da quello che Bauman chiama sciame. “Essi si radunano e si disperdono
a seconda delle occasioni, spinti da cause effimere e attratti da obiettivi mutevoli.
Il potere di seduzione degli obiettivi mutevoli è generalmente sufficiente a
coordinare i loro movimenti rendendo superfluo ogni ordine dall’alto” (Bauman,
2007). Lo sciame non ha gerarchia e non segue dei leader: la sicurezza si ritrova
nei numeri, nella presenza di così tanti individui che seguono uno stesso obiettivo.
Poiché l’attività di consumo è essenzialmente un’azione solitaria, lo sciame è una
formazione più vantaggiosa del gruppo. Essa tuttavia non crea unità, ma
disgregazione, perché i legami sono del tutto occasionali e superficiali.
La proposta della decrescita contiene una forte critica nei confronti dell’Homo
consumens e del sistema che induce a consumare sempre più materia ed energia,
senza aumentare il benessere reale. L’imperativo “consumare” presenta, infatti,
una serie di inconvenienti che di solito vengono ignorati dai fautori della crescita.
Si ritiene che i consumi sostengano la crescita delle economie domestiche. Grazie
alla globalizzazione, le merci acquistate sono prodotte ovunque nel mondo e
incorporano materiale e lavoro che sempre più raramente sono della stessa
nazionalità del consumatore: non è detto che, consumando, si contribuisca alla
21
Hochschild A. R., 2003, The Commercialization of Intimate Life, Berkeley, University of
California Press, citato in Bauman, 2007, Homo consumens
158
crescita economica del proprio paese, anzi, se si favoriscono economie straniere, è
probabile che questo avvenga a discapito dell’occupazione e dei redditi nazionali.
Lo stesso fatto, l’internazionalizzazione delle merci, fa sì che il settore dei
trasporti sia oggi tra i più inquinanti. Dall’analisi dei flussi di trasporto tra le
nazioni emergono dei fatti decisamente curiosi: che senso può avere un flusso di
camion tra le valli alpine che trasporta acqua imbottigliata in Francia sul mercato
italiano e acqua imbottigliata in Italia sul mercato francese? Analizzando il
percorso dei beni di consumi emergono assurdi viaggi di prodotti che potrebbero
essere realizzati e consumati localmente.
Oltre all’inquinamento dovuto ai trasporti, ogni bene di consumo si traduce
sempre più velocemente in un rifiuto. La società dei consumi, poi, fatta di
apparenza e simulazione, fa degli imballaggi e delle confezioni un ulteriore
meccanismo di attrazione del consumatore, aumentando ancora di più i prodotti di
scarto. Con una riduzione dei consumi e lo sviluppo locale dei prodotti è possibile
ridurre questi inconvenienti.
La riduzione dei consumi non deve essere un semplice fatto quantitativo: non è
sufficiente ridurre la quantità di beni acquistati, occorre cambiare il modo di
consumo. Pallante si pone il problema della sostituzione dei consumi. Diminuire il
denaro destinato all’acquisto di beni superflui o che è possibile autoprodurre crea
del risparmio aggiuntivo. Ora, se questo viene usato per comprare un’altra merce,
che prima non si riusciva a comperare, è chiaro che questo comportamento non va
nella direzione della decrescita, poiché si sostituisce soltanto una merce con
un'altra, senza andare a incidere sul bilancio globale dei consumi. I risparmi
possono anche essere depositati in banca: anche in questo caso le banche useranno
quel denaro per incrementare i loro investimenti, inserite nello stesso sistema
produttivo della crescita. L’unica possibilità di far decrescere il prodotto interno
lordo è non utilizzare il denaro risparmiato, ma, sostiene Pallante “è un’idea
talmente stupida…” (Pallante, 2005). Egli individua, infatti, una quarta ipotesi,
che è quella in linea con la teoria della decrescita: il denaro risparmiato consente
di lavorare di meno per dedicare più tempo alle esigenze spirituali, alla famiglia,
alle relazioni umane, alla cultura.
159
Strettamente legato a questo discorso è quello relativo all’autoproduzione. Oltre
alla sobrietà, ovvero la riduzione delle merci che comportano utilità decrescenti e
disutilità crescenti, generano un forte impatto ambientale e ingiustizie sociali, è
necessario mettere in atto l’autoproduzione, ovvero la sostituzione delle merci con
i beni. Le merci sono tutti quei prodotti che vengono scambiati con il denaro. Non
sempre esse generano utilità, per lo meno a livello globale: passare un’ora in coda
con la propria automobile aumenta il consumo della merce carburante, ma genera
una disutilità che si traduce in inquinamento ambientale. I beni sono invece quei
prodotti che non vengono necessariamente scambiati sul mercato, ma generano
sempre utilità, in quanto nella loro definizione è insita una connotazione
qualitativa che manca, invece, al concetto di merce. L’autoproduzione e gli
scambi non mercantili, basati sulla reciprocità e sul dono, permettono di ridurre
l’impatto sull’ambiente, di diminuire il prodotto interno lordo e di riscoprire il
piacere del fare e del donare.
Alcuni fautori della decrescita propongono quella che viene definita “semplicità
volontaria”, cioè la scelta consapevole di uno stile di vita sobrio e conviviale. In
realtà, altri sono coscienti del fatto che il rapporto con il consumo ha radici
profonde, che abbiamo ereditato e interiorizzato. Non si tratta semplicemente di
educare il comportamento o colpevolizzare la corsa all’acquisto. L’uomo
occidentale dipende dal consumo in termini materiali, psicologici e identitari. La
strada verso un rapporto più equilibrato con le cose e con il consumo è più simile
a un disapprendimento, a una disintossicazione. Il cambiamento non avviene a
livello individuale, di ogni singola persona, è invece qualcosa che si sviluppa nelle
relazioni e nell’interazione tra più soggetti. Si devono creare (o ricreare) forme di
socialità che escano dalla coazione del consumo, che siano estranee alle logiche
mercantili e rafforzino invece le identità e la sicurezza, ricreando delle certezze.
La decrescita, applicata agli stili di vita e di consumo, è diminuire la spinta
all’accumulo, limitare, selezionare, liberarsi da fardelli e bisogni inutili, sia
concreti che psicologici. Il consumatore è bombardato continuamente da stimoli
emotivi e da offerte di oggetti, tanto che le menti sono intossicate e non possono
farne a meno. Ma più stimoli e più oggetti significano più attenzione, più tempo
consumato, più spazio ingombrato, più rifiuti, più investimento energetico. Si
160
moltiplicano le contromisure per rimediare ai danni che il sistema stesso crea,
aumentando lo spreco di materiali, tempo ed energia.
Manca, nella maggioranza delle persone, la consapevolezza delle cause del
malessere diffuso della società: si percepisce che si è andati troppo oltre, ma
tornare indietro pare impossibile, soprattutto perché l’assuefazione alla crescita fa
sì che il termine decrescita evochi immagini di grigiore, austerità e stenti. Per
proporre una società della decrescita occorre, quindi, tenere conto di questi fattori,
poiché imporre o anche solo proporre un ridimensionamento dei consumi, della
produzione e del lavoro, nell’attuale sistema, non ha alcun senso: la società non è
pronta e non ha gli strumenti per accettare un simile cambiamento. Imparare a
governare la decrescita significa tenere in considerazione anche i lati psicologici
della questione, modellando nuovi comportamenti in cui si possa intravedere la
convenienza per l’individuo, che lo rassicuri e lo incoraggi verso il
ridimensionamento.
161
5.6 Riscoprire il locale
Uno dei punti fondamentali del programma delle "otto R" prevede di rilocalizzare
consumi e produzione. La globalizzazione non è riuscita a ridurre le differenze e
le ingiustizie, tanto meno ha portato a un migliore rapporto tra gli individui,
nonostante oggi sia possibile conoscere le usanze e i modelli di vita di tutte le
popolazioni mondiali. Il distacco dal territorio ha causato disagi sociali (ad
esempio a causa della delocalizzazione di attività produttive verso nazioni con un
più basso costo del lavoro) e relazionali poiché, in un mondo sempre più globale,
l’uomo moderno rischia di perdersi e vedere annullata la sua identità.
“L’integrazione
astratta
dell’umanità
in
un
tecno
cosmo,
attraverso
l’onnimercificazione del mondo e la concorrenza generalizzata, avviene a prezzo
di una desocializzazione concreta e di una decomposizione del legame sociale”
(Latouche, 2005).
L’internazionalizzazione della produzione e dei consumi, come già visto nei
paragrafi precedenti, ha inoltre causato l’aumento di rifiuti, inquinamento e
sfruttamento delle risorse.
Il concetto di “locale” rimanda immediatamente all’immagine di un legame con il
territorio e con i patrimoni in esso presenti, patrimoni materiali, culturali e
soprattutto relazionali. Questa ricchezza va riscoperta e valorizzata.
Il locale si inserisce nel dibattito della decrescita in due modi: da un primo punto
di vista, la riduzione dei consumi si traduce necessariamente nella scelta di
prodotti realizzati localmente, per accorciare al massimo la filiera e ridurre inutili
viaggi della merce. Anche la scelta dell’autoproduzione va in questo senso:
evitare di acquistare quei beni che è possibile produrre da sé riduce a livello locale
molte
transazioni
che
altrimenti
avverrebbero
probabilmente
a
livello
transnazionale.
Il secondo aspetto è quello relazionale: riappropriarsi del proprio territorio rende
necessario sviluppare una serie di relazioni sociali, che altrimenti non
esisterebbero, e consente di realizzare una rete di rapporti che contribuisce a
creare e valorizzare il territorio.
162
Latouche è molto severo nei confronti dello sviluppo locale. Egli sostiene che
come ogni altra forma di “sviluppo aggettivato”, lo sviluppo locale non fa altro
che dare un vestito nuovo al paradigma della crescita. Gli esempi che porta a
supporto della sua tesi sono raggruppabili sotto il titolo di “localismo
eterodiretto”, cioè politiche che di locale hanno solo il nome, ma che in realtà
sono frutto di una combinazione distorta di “territori senza potere” e “poteri senza
territorio”. Sono un esempio di questo tipo di sviluppo locale le politiche che si
traducono in concorrenza tra i territori non per offrire eccellenze e qualità, ma per
garantire “il minor offerente fiscale, sociale, ambientale e [il] miglior offerente
economico (in termini di sovvenzioni)” (Latouche, 2007). In questo senso è vero
che “i patrimoni locali sono depredati” e che “le iniziative, la creatività locale […]
sono deviate, strumentalizzate, marginalizzate secondo la logica dell’economia e
dello sviluppo” (Latouche, 2007).
Tuttavia, il mio percorso di studi non mi permette di valutare lo sviluppo locale in
termini così negativi. Il centro della questione è terminologico: le tesi di Latouche
criticano ogni tipo si sviluppo, perché esso è visto nell’ottica della crescita e
dell’accumulazione capitalistica. Eppure, nella pratica, è possibile osservare
esempi di sviluppo locale che hanno contribuito alla creazione di quella rete di
valori condivisi e di scambi relazionali che sono l’obiettivo della società della
decrescita. Ciò che divide gli approcci di sviluppo locale dagli approcci della
decrescita è l’accettazione o meno dell’attuale società della crescita. Le politiche
di sviluppo locale, messe in atto dalle istituzioni, sono chiaramente inserite nel
sistema della crescita, e come tali non possono che implicare scelte che sono in
contrasto con quelle di una società della decrescita.
Tuttavia, il movimento della decrescita non può prendersi il merito di essere
l’unico modello in grado di riattivare quei percorsi sociali che permettono a un
territorio di essere vivo, consapevole e attivo. Lo sviluppo locale presuppone la
presenza di attori collettivi, sociali, che riconosco di avere un’identità specifica e
distinta. Il senso di appartenenza che lega questi soggetti li rende in grado di
attuare un processo di cooperazione per sviluppare interessi comuni che, come
conseguenza, consentono al territorio di instaurare un processo di produzione e
autoriproduzione di se stesso. Il processo diventa irreversibile, poiché
163
l’autorganizzazione ha interrotto la linearità: in questo modo i vantaggi derivati
dallo sviluppo mantengono una buona capacità di permanenza nel tessuto socioeconomico. Lo sviluppo locale criticato da Latouche sembra corrispondere di più
a quello che porta a una semplice valorizzazione del territorio. Può sembrare una
semplice diatriba sui termini, ma in realtà i due approcci portano a risultati
nettamente distinti. Se il processo di sviluppo locale non si realizza appieno,
oppure se le forze in gioco non sono in grado di attivare il tessuto relazionale e le
potenzialità del territorio, allora si riscontra un semplice tentativo di
valorizzazione del territorio, tradotto nella risposta passiva alla domanda globale.
In questo caso si possono riscontrare dei punti di contatto con la critica di
Latouche, nei suoi riferimenti ai processi di concorrenza al ribasso.
Ma come si traduce, praticamente, il suggerimento verso la rilocalizzazione?
Rilocalizzare significa, in prima battuta, produrre e consumare localmente. Questo
consente di diminuire i costi di trasporto, in primo luogo, e quindi l’inquinamento;
ma significa anche riscoprire l’autoproduzione, limitando gli sprechi e
contribuendo alla decrescita dell’economia. L’autoproduzione, inoltre, è uno dei
mezzi per riscoprire il contatto e l’appartenenza al territorio. Conoscere e sentire
proprio il territorio porta a sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità
nei suoi confronti.
“Di fronte alla ‘topogafia’ della ‘cosmopoli’, ovvero alla bulimia di un modello
urbano centralizzato che divora lo spazio, è importante lavorare per sostenere una
‘rinascita dei luoghi’ e la territorializzazione. Bisogna reagire contro la ‘lobotomia
dello spirito locale’ che segna la rottura con l’ambiente in cui si vive” (Latouche,
2007). Le attività produttive locali, che comprendono sia la creazione di merci
attraverso l’artigianato locale e le piccole industrie, sia una serie di servizi alla
popolazione come le attività culturali e ricreative, la cura dell’ambiente, la
manutenzione urbana, favoriscono lo sviluppo di relazioni di scambio non
mercantili, ma basate sulla reciprocità e sulla fiducia; “in altri termini
consent[ono] la creazione di spazio pubblico come autoriconoscimento del
patrimonio comune da mettere in valore” (Magnaghi, 2000). Questo tipo di
ragionamento non è così lontano dalla definizione di sviluppo locale.
164
Nel modo in cui lo sviluppo locale definisce i concetti di capitale sociale e
capitale naturale è possibile riscontrare molti punti di contatto. Le teorie sullo
sviluppo locale attribuiscono un’importanza fondamentale al capitale sociale che,
ancorato al territorio, si può denominare “capitale sociale territoriale”. Esso
consente di individuare la rete di relazioni, soprattutto sociali, ma anche
economiche, che si sviluppa in un determinato territorio. Quando i teorici della
decrescita parlano di riscoprire i benefici dei rapporti conviviali e di sviluppare le
relazioni a livello locale, in fondo si riferiscono alla valorizzazione del capitale
sociale presente in un determinato territorio. Il capitale sociale territoriale, d’altro
canto, fa riferimento anche al capitale naturale presente nel territorio: esso è inteso
non come materia prima, ma come attore a tutti gli effetti del processo di sviluppo
locale e come tale viene gestito in modo sostenibile.
La rilocalizzazione consente al territorio di tornare a essere un soggetto attivo e
protagonista nei processi economici e sociali, un attore a cui vengono riconosciute
le
caratteristiche
di
soggetto
vivente
ad
alta
complessità.
“[La
riterritorializzazione] è un processo complesso e lungo che riguarda la costruzione
di una nuova geografia, fondata sulla rivitalizzazione dei sistemi ambientali e
sulla riqualificazione dei luoghi ad alta qualità dell’abitare come generatori di
nuovi modelli insediativi capaci di rivitalizzare il territorio dalle ipotrofie della
megalopoli. Questo processo non può avvenire in forme tecnocratiche, esso
richiede nuove forme di democrazia che sviluppino l’autogoverno delle comunità
insediate, poiché riabilitare e riabituare i luoghi significa nuovamente prendersene
cura quotidianamente da parte di chi ci vive, con nuove sapienze ambientali,
tecniche e di governo” (Magnaghi, 2000).
Rilocalizzare, allora, significa anche auspicare a una trasformazione sul piano
politico. La globalizzazione ha fatto sì che il livello locale perdesse fascino e
interesse: limitare la propria azione a un territorio ristretto soffoca l’individuo che
vede di fronte a sé il mondo intero. I luoghi devono ritrovare il loro significato e
riappropriarsi della capacità di dare significato. La costruzione di economie locali
e di comunità politiche locali non rappresenta una forma di autarchia, né significa
creare dei microcosmi chiusi. Al contrario, essa rappresenta “un nodo all’interno
di una rete di relazioni trasversali non gerarchiche e solidali nell’obiettivo di
165
sperimentare pratiche di rafforzamento dell’esercizio della democrazia in grado di
resistere alla dominazione liberista” (Latouche, 2007) e al mercato unico.
L’attenzione al locale è giustificata dalla consapevolezza, da parte dei teorici della
decrescita, che il cambiamento non può che partire dal basso. E’ inimmaginabile
un processo di decrescita che parta dalle istituzioni, poiché esse si fondano su
quello stesso sistema che dovrebbero eliminare. A livello locale, invece, è
possibile realizzare dei cambiamenti, anche importanti, come dimostrano gli
esempi che saranno presentati nel prossimo capitolo, poiché si attivano sul piano
del concreto vissuto dai cittadini. La presa di coscienza delle contraddizioni locali
si può risolvere agendo a livello locale e concreto con azioni che vanno nella
direzione di un cambiamento del sistema, a favore di una riappropriazione degli
spazi e del tempo. A livello locale, poi, è anche possibile creare dei contatti con
gli altri movimenti che rientrano nel filone del doposviluppo: “Si tratta di mettere
in relazione la protesta sociale con la protesta ecologica, con la solidarietà verso
gli esclusi del Nord e del Sud, e con tutte le iniziative associative che vanno nel
senso di una rivitalizzazione del locale, per articolare resistenza e dissidenza e
giungere in definitiva a una società autonoma che partecipi alla decrescita
conviviale” (Latouche, 2007).
5.6.1 La decrescita per il Sud del mondo
La rivoluzione industriale, che ha portato a uno sviluppo senza precedenti
dell’Occidente, è avvenuta a scapito dei Paesi del Sud del mondo, utilizzati come
miniere e come fornitori di mano d’opera. In un certo senso, i vincoli della natura,
da cui l’uomo ha avuto la sensazione di liberarsi con lo sviluppo, sono in realtà
stati esportati verso le periferie del pianeta.
Gli obiettori della decrescita sono spesso accusati di rifiutare la possibilità di una
vita migliore per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Pensare di far
decrescere i consumi di queste nazioni pare effettivamente un controsenso. Il
progetto della decrescita prevede, in realtà, forme differenti di attuazione in base
ai contesti locali. La riduzione dell’impronta ecologica deve essere messa in atto
dai Paesi occidentali: essi, infatti, sono responsabili del superamento dei limiti
166
fisici del pianeta. La decrescita nel Sud si può organizzare cercando di creare un
circolo virtuoso, come per il programma delle "otto R", a partire da altri
presupposti: se per i Paesi sviluppati si parla di ridurre, riconcettualizzare e
riciclare, per i Paesi più poveri si può parlare di rompere, riannodare, recuperare,
reintrodurre.
Tuttavia, seppure in maniera diversa, questi aspetti riportano a un obiettivo
comune con i Paesi occidentali: rompere con il paradigma della crescita. Questo
significa in primo luogo, per i Paesi del Terzo Mondo, rompere con la dipendenza
culturale ed economica rispetto al Nord. Le produzioni, che oggi sono destinate ai
mercati occidentali, dovrebbero invece essere sostituite da colture locali in grado
di sostenere la popolazione.
Anche per queste popolazioni l’obiettivo più ambizioso è quello di mettere in atto
una decolonizzazione, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista
culturale. Il secondo capitolo ha messo in evidenza come siano molto rare le voci
fuori dal coro, anche nei Paesi in via di sviluppo: le politiche implementate per
migliorare la situazione di questi paesi si sono mosse sempre nel binario della
crescita. “I popoli devono riprendere il filo della loro storia interrotta dalla
colonizzazione, dallo sviluppo e dalla globalizzazione e devono riappropriarsi
della propria specifica identità culturale. […] Reintrodurre i prodotti specifici
dimenticati o abbandonati e i valori ‘antieconomici’ legati alla propria storia è
parte di questo programma così come recuperare tecniche e abilità tradizionali”
(Latouche, 2007).
Esistono delle forme di scambio e di organizzazione sociale che non possono
essere inserite nella realtà dello sviluppo capitalistico. Esse si sono sviluppate
soprattutto nelle periferie del mondo, dove lo sviluppo non è riuscito a penetrare.
Queste pratiche consistono nell’implementazione di quella che è stata definita
economia informale, ossia quelle pratiche economiche che non rientrano nelle
consuete abitudini di mercato, ma che consentono di realizzare una vita dignitosa,
favoriscono lo sviluppo di relazioni e la creazione di un tessuto sociale solido e
attivo. Ogni luogo, compresi i Paesi più poveri, possiede un patrimonio culturale e
sociale che la globalizzazione e la corsa allo sviluppo hanno spesso rovinato.
Questo perché gli aiuti internazionali tendono a formalizzare tutta la complessità
167
dell’economia informale che, in realtà, è la più vitale. Essendo fondata sulle
conoscenze e sulle capacità presenti sul territorio, l’economia informale può
garantire una riproduzione nel tempo e un’adattabilità al contesto in cui è
implementata. La proposta della decrescita presuppone di far rivivere, dove sono
state soffocate, tutte quelle pratiche di scambio e di produzione che, prima della
necessità di intervento manifestata dai Paesi occidentali, consentivano al Sud del
mondo di sopravvivere. Queste popolazioni erano povere, ma nel senso che
disponevano di minori mezzi e minori beni di consumo rispetto all’Occidente, ma
esse riuscivano a sopravvivere in un modello economico sostenibile. Oggi, molte
di quelle popolazioni, in particolare in Africa, non riescono a sopravvivere, perché
la volontà di adeguare le strutture economico-sociali all’Occidente ha distrutto le
tradizionali forme di comunità presenti in questi territori.
Così come nei Paesi occidentali, anche nei Paesi in via di sviluppo la via per la
decrescita passa dal risveglio del locale, per cogliere sul territorio, nell’ambito del
concreto, le forze che possono consentire di instaurare un livello di vita
soddisfacente e dignitosa.
Sia al Nord, come al Sud, i circoli virtuosi delle “otto R” devono intrecciarsi tra
loro: ridurre e ridistribuire, nei Paesi ricchi, si traduce in una restituzione a favore
dei Paesi in via di sviluppo, che possono così mettere in atto un processo di
rinnovamento e ristrutturazione delle pratiche economiche a favore di una
comunità più locale e più consapevole.
168
Capitolo 6
I LABORATORI DELLA DECRESCITA
Quest’ultimo capitolo si propone l’obiettivo di analizzare alcuni esperimenti
concreti orientati all’uscita dalla logica sviluppista, a favore di un orientamento
più sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Le esperienze di seguito
riportate non si rifanno esplicitamente alla teoria della decrescita: alcune sono nate
prima, altre partono da ispirazioni diverse, ma tutte si inseriscono nel binario del
doposviluppo e tutte presentano forti analogie con le pratiche proposte dalla
decrescita.
Si noterà che le varie esperienze hanno tutte carattere locale: di fronte alla
deframmentazione della globalizzazione e all’annullamento dell’identità nel
globale, è a partire dal basso e dalla ricerca di aggregazioni fisiche di persone che
è possibile mettere in atto una reazione a un contesto che non riesce più a
soddisfare i desideri sociali dei cittadini.
Le “buone pratiche”, come le definisce Tonino Perna, sono uno strumento che
permette alla collettività di uscire dallo schema classico Stato-Mercato, per
costruire un’altra cittadinanza e un’altra economia. Molte delle esperienze si
inseriscono nel movimento del consumo critico, volto a creare dei consumatori
consapevoli e attenti all’impatto ambientale e sociale dei propri comportamenti.
Prendendo spunto dai quattro principi di comportamento economico indicati da
Polanyi (amministrazione domestica, reciprocità, redistribuzione e mercato), si
può dire che il consumo critico, o consumo solidale, tende a riportare in auge i tre
comportamenti che il mercato ha reso periferici. In particolare, la redistribuzione e
la reciprocità diventano fondamentali nella scelta dei prodotti e dei fornitori,
mentre l’amministrazione domestica, intesa come la produzione svolta per il
proprio uso e per il sostentamento del proprio gruppo, diventa uno strumento
alternativo di uscita dal mercato, per dimostrare la propria alterità rispetto al
modello dominante.
L’emergere di queste esperienze dimostra una sensibilità diffusa verso le
problematiche sociali e ambientali che l’attuale modello di produzione e di
169
consumo creano sia nella propria nazione che nei Paesi in via di sviluppo.
Tuttavia, è difficile catalogare sotto una singola voce le miriadi di esperienze che
si rifanno a questo modo di intendere il consumo e l’economia. Il panorama è
decisamente variegato. Occorre sottolineare, infatti, come le scelte di consumo
possano svolgersi tranquillamente a livello individuale, rendendole difficili da
individuare e analizzare. Molte sono però le persone che, condividendo una stessa
etica nei confronti del consumo, si riuniscono formando gruppi locali che
permettono il confronto e la crescita, sia a livello individuale sia a livello
collettivo. In alcuni casi, i gruppi sono riusciti a creare delle reti più o meno
articolate, a livello nazionale, che diventano punti di riferimento per tutte le
persone che decidono di partecipare a un diverso stile di vita.
Nonostante le differenze e le peculiarità di ogni gruppo e di ogni associazione, è
possibile individuare due elementi cardine di questo modo diverso di fare e vivere
l’economia: la contrapposizione all’economia mainstream attualmente dominante
e il radicamento nel tessuto sociale. E’ un movimento che, spesso sottotraccia, sta
agitando le società industrializzate. Non si può certo definire una teoria
economica nuova, ma è sicuramente un movimento della società civile che
rivendica un altro modo di fare economia. In parte, questi movimenti sono
debitori della tradizione mutualistica sviluppatasi a cavallo tra Otto e Novecento,
quando i lavoratori iniziarono ad aggregarsi contro il potere dei padroni per far
nascere le prime organizzazioni sindacali e le prime cooperative sociali. Ma
mentre questi movimenti nascevano dalla necessità concreta di autodifesa nei
confronti di un capitalismo aggressivo che non contemplava il concetto di welfare,
e poco per volta sono stati istituzionalizzati, come organizzazioni, all’interno dello
stesso sistema capitalistico, gli attuali movimenti di altro-consumo si rivelano più
disgregati e più ostili all’integrazione all’interno del sistema attuale e si rivelano
ancora abbastanza deboli nella capacità di incidere sul piano globale degli scambi
commerciali. La frammentazione delle esperienze rischia di essere un ostacolo
all’opportunità di un’azione concreta, e non solo ideale, per trasformare la società.
“La transizione va immaginata su più livelli: da un lato la creazione di spazi
economici anticapitalisti, dall’altro una lotta quotidiana di contaminazione del
sistema. Questo sforzo di radicale cambiamento è possibile solo a due condizioni:
170
la convergenza di tendenze ‘eretiche’ presenti in ambiti diversi della società; la
capacità di soddisfare - con nuove risposte – bisogni e aspettative di ampie fasce
della popolazione” (Guadagnucci, 2007).
L’utopia concreta di cui parla Latouche è, quindi, già in atto in alcune esperienze
che qui di seguito si andranno a illustrare. Il rischio di questi movimenti è quello
di venire assorbiti dal sistema dominate: a tale proposito le posizioni sono
differenti, poiché alcuni autori, come Zamagni, sostengono che questo può avere
un positivo effetto di contaminazione del sistema attuale, mentre altri, come
Latouche, sperano di un’autonomia e in un’uscita dal sistema di mercato
capitalista. Attualmente, i vari movimenti che si ispirano alla critica dello
sviluppo e all’economia solidale si muovono ancora in un ambiente di nicchia,
anche se cominciano a formarsi e a crescere delle reti che mettono in connessione
i vari gruppi e stabiliscono dei legami che rafforzano reciprocamente le varie
attività, aumentandone anche la visibilità a livello nazionale e globale.
171
6.1 Reti e Distretti di economia solidale
Le Reti di economia solidale si muovono proprio nella direzione di mettere in
connessione le varie esperienze che, in Italia, si sviluppano nella prospettiva di
costruire un’economia altra.
Il percorso verso la costruzione di Reti di economia solidale nel nostro Paese
prende avvio in modo esplicito il 19 ottobre 2002 a Verona, nel corso di un
seminario sulle “Strategie di rete per l’economia solidale” promosso dal Gruppo
di lavoro tematico “Impronta Ecologica e Sociale” della Rete di Lilliput22 e
preparato insieme a diverse realtà italiane di economia solidale. Nel corso del
seminario le numerose persone e realtà convenute hanno deciso di iniziare un
viaggio collettivo: è stato creato un gruppo di lavoro su base volontaria e
informale, che ha proposto alcuni documenti di riferimento sui principi e sugli
obiettivi delle Reti di economia solidale e che costituisce un luogo di confronto, di
scambio e di sintesi delle diverse esperienze e realtà.
Il primo passo ha portato alla definizione della “Carta per la Rete italiana di
economia solidale”, presentata per la prima volta nel maggio 2003 alla fiera
Civitas di Padova. Nella Carta si riassumono le caratteristiche delle esperienze di
economia solidale e si lancia la proposta di attivare i “Distretti di economia
solidale” (DES), laboratori in cui sperimentare la strategia delle reti a partire dalle
esigenze e dalle caratteristiche dei territori. L’attivazione di questi Distretti ha il
fine di verificare nel concreto, a partire dalla dimensione locale, l’efficacia della
strategia delle reti e della democrazia partecipativa applicata all’economia, così da
consentire la valutazione, e poi la diffusione, di queste esperienze.
Il ruolo specifico della Rete di economia solidale è quello di sviluppare
un’economia “liberata”, equa ed etica, al servizio delle persone. Essa è dunque
aperta a collaborare con tutte le altre reti e gli altri soggetti che condividono tale
prospettiva o che intervengono sul terreno dell’autosviluppo locale, equo e
22
La Rete di Lilliput nasce nel 1999 con l’obiettivo di far interagire e collaborare le miriadi di
esperienze locali che in Italia cercano di lottare contro le disuguaglianze nel Mondo. Oggi la Rete
prosegue il suo impegno nella proposta di cambiamento delle regole che governano le istituzioni
finanziarie e i commercio internazionale, promuove un cambiamento negli stili di vita e nella
gestione del territorio e si impegna nello sviluppo di un’economia basata sulla giustizia e sulla
solidarietà
172
sostenibile. Infatti, la Rete non propone delle regole di adesione, ma riunisce
diverse esperienze e diversi approcci. L’organizzazione in una rete consente ai
diversi attori di “conoscersi e farsi conoscere, aiutare e farsi aiutare, innescare
processi economici nuovi, coordinati e partecipati e diffonderli, nella convinzione
che ciò potrà portare giovamento a tutti i soggetti coinvolti oltre che al contesto
sociale ed ecologico in cui essi operano.” 23
Il processo di costruzione della Rete di economia solidale, come già accennato, ha
mosso i primi passi con la proposta e l’avvio dei Distretti di economia solidale,
che sono la sperimentazione della strategia delle reti sul territorio. La costruzione
dei Distretti parte dalle diverse realtà che già operano nei territori, come ad
esempio i gruppi di acquisto solidali, le botteghe del mondo, le realtà della finanza
etica e del turismo responsabile, i piccoli produttori biologici, le cooperative
sociali e le cooperative che offrono servizi e beni di consumo, artigiani,
commercianti, lavoratori autonomi, associazioni e gruppi informali che
condividono i principi dell’economia solidale. I prodotti e i servizi non disponibili
all’interno di un distretto vengono scambiati, a livello paritario, con gli altri
distretti o con altre realtà di economia solidale presenti nel territorio.
I DES in Italia sono ormai diciotto e nel 2003 è nato DESTO, il Distretto di
economia solidale di Torino. Creare un Distretto di economia solidale significa
mettere in relazione le diverse realtà presenti sul territorio, in un tipo di rete che
non sia solo informativa, ma anche economica. Questo significa che i diversi nodi
della rete (produttori, distributori, consumatori) cercheranno, per quanto possibile,
di rifornirsi gli uni dagli altri, portando ad attivare dei circuiti sia di fiducia che
economici, per sostenere le realtà aderenti.
La creazione di un Distretto di economia solidale vuole sviluppare tre obiettivi
principali:
–
rafforzare le realtà di economia solidale che vi aderiscono attraverso una
promozione comune verso l’esterno;
–
favorire le realtà di economia solidale attraverso strumenti comuni di
gestione (ad esempio per la logistica o lo scambio di informazioni);
23
Carta della Rete italiana di economia solidale, marzo 2007.
173
–
mostrare come la costruzione del Distretto di economia solidale possa
rappresentare un vantaggio per tutti nella costruzione di un’economia
alternativa.
I principi ispiratori dei DES sono contenuti nella Carta dei principi della Rete e
corrispondono ai seguenti elementi caratterizzanti:
–
nuove relazioni tra i soggetti economici, basate su principi di reciprocità e
cooperazione;
–
giustizia e rispetto per le persone, espressi in base alle condizioni di
lavoro, alla salute, alla formazione, all’inclusione sociale, alla garanzia dei
beni essenziali;
–
rispetto dell’ambiente in termini di sostenibilità ecologica;
–
partecipazione democratica;
–
disponibilità di entrare in rapporto con il territorio attraverso l’espressione
di un progetto locale condiviso;
–
disponibilità di entrare in relazione con le altre realtà dell’economia
solidale condividendo un percorso comune;
–
impiego degli utili per scopi di utilità sociale.
I vari principi si possono sintetizzare in tre filoni: dal punto di vista sociale i
rapporti tra i soggetti si ispirano ai principi di cooperazione e reciprocità. I
Distretti sono, infatti, formati da imprese, consumatori, risparmiatori, finanziatori
e lavoratori che, abbracciando lo stesso orizzonte etico, partecipano al processo
economico, impegnandosi a realizzare gli scambi prevalentemente all’interno del
Distretto stesso, garantendo tuttavia la pluralità dell’offerta e delle forme di
scambio.
Dal punto di vista dello sviluppo territoriale, i DES si prefiggono l’obiettivo di
valorizzare le peculiarità del luogo, viste come ricchezze (stock) da accrescere e
non come flussi di risorse da sfruttare ai fini del profitto. Il territorio non va
inteso, però, come un sistema chiuso, ma come un sottoinsieme di un più vasto
sistema economico e sociale.
Dal punto di vista della sostenibilità, i DES si muovono nella direzione di
dell’equità sociale e dei limiti ecologici. Per minimizzare l’impatto umano sul
174
sistema ambiente è possibile individuare dei tetti massimi di reddito e produzione,
in modo da ridurre l’impronta ecologica del Distretto.
I DES applicano il metodo della partecipazione attiva dei vari attori coinvolti alla
definizione delle modalità concrete di gestione dei processi economici propri del
distretto, al fine di realizzare i principi fondamentali.
La realizzazione dei Distretti locali permette, dal punto di vista sociale, di attivare
legami di fiducia sul territorio e, dal punto di vista economico, di chiudere
localmente i cicli di produzione e consumo, diminuendo l’impatto ambientale;
inoltre, aumentando la conoscenza tra le diverse realtà, pone le basi per la
costruzione di una progettualità locale di trasformazione del territorio.
L’opinione pubblica sta dimostrando un’accresciuta sensibilità ai temi
dell’economia solidale e del consumo critico: questo rappresenta sicuramente un
vantaggio per i Distretti, che si inseriscono in una realtà non ostile, anzi spesso si
sviluppano a partire da realtà che già sperimentano un altro modo di fare
economia. Attraverso i DES, è possibile coagulare tra loro le diverse energie
disperse, aumentare le dinamiche relazionali e promuovere la partecipazione di
nuovi aderenti.
Tuttavia esistono anche delle criticità. La stessa realtà multipla, infatti, rende
difficile creare una rete compatta e riconoscibile. Dalle relazioni annuali della
Rete emerge che proprio la realizzazione di una struttura di relazioni più formali
risulta essere la parte più complicata da mettere in pratica. Questi molteplici
gruppi, che a livello informale riescono a creare relazioni basate sulla fiducia e
sulla reciprocità, riescono con qualche titubanza a replicare la cosa a scale
maggiori, al fine di realizzare una Rete più strutturata e incisiva a livello
nazionale. Questo si concretizza nella difficile interazione tra i soggetti dei
Distretti e gli attori istituzionali, oltre che nella debolezza dei circuiti economici,
che raramente sono stabili. L’esistenza, all’interno di uno stesso Distretto e fra più
DES diversi, di esperienze differenti, fa sì che non esista un unico orizzonte
economico condiviso e che le possibili sinergie virtuose tra i diversi settori siano
limitate.
Tuttavia, quello che si sta delineando all’interno dei Distretti di economia solidale
e nella Rete è un’esperienza, seppure impegnativa, molto importante e
175
significativa. L’economia solidale (che rappresenta la base comune di tutte le
esperienze che sono inglobate nella Rete), intrattiene rapporti con tutte e tre le
sfere di scambio sociale individuate da Laville: l’economia di mercato, il settore
pubblico e la sfera tradizionale. I soggetti dei DES, per quanto in misura ridotta e
seguendo determinate regole etiche, realizzano comunque i loro scambi sul
mercato; nonostante il baricentro economico sia spostato dalle realtà globali a
quelle locali e nonostante il fatto che allo scambio siano affiancate varie forme di
reciprocità, non si può, oggi, immaginare una forma di economia solidale che non
intrattenga rapporti con il mercato.
Inoltre, l’economia solidale collabora con il settore pubblico, poiché da questo
riceve spesso sovvenzioni e incentivi; lo Stato, poi, contribuisce a definire la
cornice istituzionale nella quale opera l’economia solidale. Esistono esempi di
istituzioni impegnate in prima persona nello sviluppo di Reti di economia solidale,
come nel caso dell’esperienza veneziana CAmbieReSti?.
Infine, l’economia solidale si rapporta in modo particolare con il settore sociale.
Da questo non solo trae le risorse, in termini di impegno volontario, ma con esso
condivide quella cultura di relazioni di reciprocità che ne costituisce il tratto
dominante. “In questa sfera gli individui si sentono persone, scambiandosi beni
scambiano significati, e quindi senso, motivazione, qui prendono la parola,
discutono, partecipano, decidono” (Bonaiuti, 2006).
Il mercato in cui si muove l’economia della Rete e dei Distretti solidali si
differenzia dal mercato globale. Quest’ultimo è, infatti, assolutamente
spersonalizzato; questa caratteristica, oltre ad aver favorito gli scambi, ha portato
con sé alcune conseguenze negative, prima fra tutte la mercificazione dei rapporti
sociali. Al contrario, l’economia solidale si muove in un contesto più simile ai
mercati tradizionali, ai bazar africani. A differenza di molti altri termini
economici, Bonaiuti sottolinea come il concetto di mercato sia comune a
moltissime culture. Nel significato di piazza, agorà, il mercato è un’istituzione che
si è sviluppata anche al di fuori del contesto capitalistico, e che rappresenta per
molte culture il luogo di incontro, in cui lo scambio non ha solo valore
economico, ma anche relazionale ed è il luogo per ritrovare parenti e amici e per
annunciare pubblicamente avvenimenti importanti e scambiarsi informazioni. Il
176
mercato è quindi inteso prima come istituzione sociale, e poi come istituzione
economica.
Le esperienze che si concentrano nella Rete di economia solidale e che si
esplicano in una pluralità di concretizzazioni diverse cercano di recuperare questo
significato di mercato.
177
6.2 Gruppi di Acquisto Solidale
I Gruppi di acquisto solidale (Gas) sono uno degli strumenti che permettono di
mettere in atto la creazione di un DES. In realtà, la nascita dei Gas è antecedente
alla volontà di riunire le varie esperienze in una Rete, ma fa parte della
molteplicità di modi in cui la società civile ha cominciato a esprimere il suo
disaccordo con il sistema economico mainsteam.
Far parte di un Gas significa provvedere all’acquisto di beni e servizi cercando di
mettere in atto una concezione più umana dell’economia, mettendo in primo piano
le reali esigenze dell’uomo, ma anche dell’ambiente. I Gas sono gruppi di
famiglie e singoli che si riuniscono e adottano una comune politica di consumo,
indirizzata alla scelta (su base collettiva) di prodotti e fornitori, secondo criteri
etici condivisi. A differenza dei semplici gruppi di acquisto, che puntano sul
risparmio agendo su grandi quantitativi, i Gas aggiungono un attento esame della
provenienza del prodotto e analizzano cosa c’è dietro il bene acquistato, dal punto
di vista ambientale, sociale ed economico.
Il primo Gruppo di Acquisto Solidale nasce a Fidenza nel 1994. Nel novembre
dello stesso anno, il gruppo si presenta così: “Non intaccheremo i fondamenti
dell’economia capitalista e del libero mercato (libero per chi?), ma per ciò che ci
riguarda testimoniamo che è possibile affermare principi di solidarietà anche a
livello economico. Gruppo di acquisto solidale, sempre più spesso solo ‘Gas’, è il
nostro nome. […] Il gruppo è solidale:
–
tra noi soci perché ci impegniamo in base alle disponibilità a titolo
gratuito;
–
con i produttori che ci forniscono i prodotti biologici;
–
con l’ambiente perché la scelta del biologico, del prodotto di stagione,
permette il rispetto dell’equilibrio ambientale;
–
anche con il Sud del mondo, con chi è sfruttato e inquinato per mandarci
pesche e ciliegie a Natale.
Il gruppo si è costituito da pochi mesi, su alcune semplici idee di fondo:
–
acquisto di alimenti di qualità biologica garantita;
–
direttamente dai produttori, con vantaggio economico reciproco.
178
Non abbiamo spaccio, non abbiamo magazzino, non facciamo alcun ricarico sui
prezzi, perciò ciascuno è coinvolto nell’organizzazione degli acquisti, in
solidarietà con gli altri […].
In conclusione questa iniziativa, partita con scopi principalmente legati
all’alimentazione, ha già favorito una presa di coscienza del fatto che, nel piccolo
villaggio che è ormai il mondo, stare bene o è per tutti o è per nessuno”.24
La spinta a creare un modo diverso di consumare deriva da un incontro del 1993
svoltosi all’Arena di Verona, organizzato dai Beati costruttori di Pace, dal titolo
“Quando l’economia uccide…bisogna cambiare”. Da questa esperienza nascono
diversi gruppi di consumo critico, tra cui anche il movimento Bilanci di Giustizia
che sarà trattato nel terzo paragrafo.
I gruppi di acquisto solidale partono da una riflessione sull’insostenibilità sociale
e ambientale del modello di vita occidentale e cercano una strada per attuare nel
concreto un’obiezione al sistema capitalista e al mercato, senza dover rinunciare
all’esigenza di consumare prodotti di qualità. Il primo settore a cui si rivolgono i
Gas è quello alimentare, ma oggi i consumi gestiti attraverso i gruppi si sono
estesi a molti altri settori. Contattando direttamente i produttori, e instaurando con
essi un rapporto di conoscenza, fiducia e amicizia, gli appartenenti a un Gas
rispondono a diverse esigenze: personali, sociali ed economiche. Le persone
trovano occasioni di relazione e percepiscono la sicurezza di acquistare prodotti
sani e di qualità; i piccoli produttori possono sfruttare un canale alternativo al
mercato tradizionale, con l’opportunità di sfuggire alle logiche della grande
distribuzione. Produttori e consumatori si ritrovano accomunati da uno stesso
sentire: la volontà di ridurre l’impatto sull’ambiente e sulla società (anche quelle
più lontane), senza dover rinunciare a prodotti gustosi e sani, ma che racchiudono
in sé un significato.
La conoscenza diretta del produttore diventa una garanzia di qualità e le relazioni
che si instaurano funzionano anche come indiretto controllo sul rispetto delle
condizioni a cui implicitamente sottostanno tutti i membri del Gas. “Il ciclo corto
promosso dai Gas riporta l’economia al livello delle relazioni, cortocircuitando le
reti lunghe e anonime del supermercato mondiale. A questo livello di rapporto
24
Testo di presentazione del primo Gas italiano di Fidenza, citato in Valera L., Gas. Gruppi di
Acquisto Solidali.
179
diretto tra i produttori e i consumatori è possibile stabilire alleanze che saldano i
legami sul territorio e attivano circuiti di fiducia. E questi circuiti ‘caldi’ possono
dare rifugio a chi si trova espulso dalle regole della concorrenza” (Valera, 2005).
Dal punto di vista pratico, i Gas funzionano come nodo nella catena del
commercio. Per evitare le logiche della grande distribuzione e per avere la
sicurezza di poter controllare l’origine dei prodotti che si intendo acquistare, i Gas
hanno rapporti direttamente con i produttori. Durante le riunioni, che in media si
svolgono mensilmente, vengono proposti prodotti e produttori disponibili a
entrare nella rete dei Gas. Solitamente esiste un referente per ogni tipo di prodotto
che si occupa di raccogliere gli ordini, contattare il fornitore, definire i prezzi,
ricevere le consegne e distribuirle tra i gasisti. Far parte di un Gas implica un
impegno notevole in termini di tempo, per questo i vari ruoli sono spesso
assegnati a rotazione e in ogni caso il gruppo funziona solo se c’è la
collaborazione e la disponibilità da parte di tutti gli aderenti. Ogni Gas ha le
proprie regole e segue un differente modello organizzativo, modellato su misura
in base alle esigenze e alle competenze degli aderenti. In genere, il referente che
segue il prodotto in tutti i suoi passaggi è la modalità più diffusa. Altri gruppi
preferiscono suddividersi i compiti in base alle fasi (dall’informazione su prodotti
e produttori alla consegna). Spesso i gruppi di acquisto solidale si appoggiano a
botteghe del commercio equo e solidale e aderiscono o promuovono iniziative a
carattere solidale o ambientale.
La scelta dei prodotti è il cuore dell’attività dei Gas, poiché attraverso essa si
esplica il concetto di equità e solidarietà che muove gli aderenti ai gruppi. Alcuni
dei criteri più comunemente adottati per scegliere i prodotti sono:
–
piccoli produttori: sono spesso realtà che nonostante la qualità delle loro
merci non riescono ad affermarsi nel sistema della grande distribuzione
poiché non riescono a offrire grossi quantitativi. I piccoli produttori
possono essere conosciuti di persona, instaurando relazioni di fiducia e,
aspetto non meno importante, lavorano di solito impiegando più
manodopera che capitale: l’acquisto dei loro prodotti quindi finanzia
l’occupazione più che gli azionisti;
180
–
prodotti biologici: sono quei prodotti coltivati senza l’uso di pesticidi,
diserbanti e fertilizzanti chimici. L’agricoltura basata sull’uso di questi
prodotti è altamente inquinante e ad alto consumo di energia. Rivolgersi al
biologico significa ridurre l’impatto ambientale dei prodotti agricoli,
diminuire i rischi per la salute e riscoprire la stagionalità dei cibi;
–
prodotti locali: i vantaggi derivano principalmente dall’abbattimento dei
costi di trasporto e dall’effetto inquinante dei lunghi viaggi che spesso i
prodotti fanno prima di arrivare nelle case dei consumatori. La merce,
viaggiando di meno, arriva più fresca e richiede l’uso di meno conservanti.
Inoltre, la scelta di prodotti locali favorisce la conoscenza diretta con i
produttori, instaurando relazioni durature e stabili che consentono la
nascita di una rete non solo economica, ma anche sociale, che si instaura
sul territorio;
–
prodotti realizzati in condizioni di lavoro dignitose: se la corsa alla
riduzione dei costi produce rapporti di lavoro al limite dello sfruttamento e
della denigrazione della persona, i gruppi di acquisto solidale scelgono
prodotti realizzati senza sfruttamento per difendere la regolamentazione
del mercato del lavoro e la dignità della persona;
–
prodotti realizzati da cooperative sociali o da chi lavora con persone
svantaggiate: si premia l’attività di chi promuove la dignità e l’autonomia
di tutte le persone e si introducono nel mercato i soggetti che per vari
motivi sono di solito marginalizzati o esclusi.
L’obiettivo di un Gas non è solo quello di “ordinare, ritirare e pagare”, ma quello
di creare un gruppo di persone che hanno in comune determinati valori etici e che,
nella partecipazione condivisa e nella reciprocità esprimono il loro dissenso verso
il sistema dominante. L’aggettivo solidale, che distingue i Gas dai semplici gruppi
di acquisto, definisce il fatto di “riconoscersi parte di una comunità umana che
travalica confini e culture, e rivendica come precisa responsabilità di ciascuno la
disponibilità a farsi carico delle disuguaglianze che la affliggono” (Valera, 2005).
Ma la solidarietà si manifesta anche tra i membri del gruppo, nell’accezione di
forma di affinità ideologica ed emotiva basata sull’esistenza di interessi comuni
181
che, di conseguenza, genera la capacità di prestarsi reciproca assistenza e si
manifesta nella condivisione di impegni e di responsabilità.
La partecipazione è un fattore fondamentale, perché permette di creare i legami di
cui il gruppo ha bisogno per restare attivo. Tuttavia, non sono escluse forme di
partecipazione passiva, che prevedono solo il ruolo di acquirente e non
organizzativo. “Ricostruire relazioni collettive, favorire il confronto di idee, la
partecipazione diretta all’attività del gruppo, lo scambio di esperienze tra i
componenti, sono utili strumenti per determinare le scelte comuni attraverso il
consenso e non secondo il principio della maggioranza. [… ] Siamo per
l’autogestione perché crediamo nell’organizzazione non gerarchica, basata sulla
rotazione degli incarichi, rifiutiamo così di delegare ad altri la responsabilità delle
nostre decisioni; vogliamo sperimentare l’autorganizzazione sociale e l’autotutela
per tradurre le nostre idee in azioni e comportamenti coerenti”.25
Aderire a un Gruppo di acquisto solidale significa rivedere i propri consumi e
quindi il proprio stile di vita. Il cambiamento riguarda innanzitutto il tipo di
prodotti che vengono acquistati e, in seconda battuta, comporta un ripensamento
critico dell’utilità o meno dei prodotti che si vanno ad acquistare.
Anche il rapporto con i produttori è decisamente diverso rispetto a quello che si
sviluppa nel tradizionale sistema economico: sono spesso i consumatori che,
attraverso vere e proprie ricerche, contattano i produttori che, a volte, entrano essi
stessi a far parte del Gas. La dinamica della pubblicità, fondamentale nella società
dei consumi, viene completamente superata e sostituita dalla fruizione di
esperienze dirette del prodotto e di chi lo produce, attraverso la conoscenza
personale tra consumatore e produttore. Il produttore è spesso chiamato a fornire
informazioni che non aveva preventivato di mettere sul mercato, come le modalità
di pagamento di eventuali dipendenti o a quale banca si appoggia per finanziare
l’attività. Lo scambio non si riduce ai prodotti, ma si allarga alle esperienze e alla
conoscenza, fino al confronto tra le scelte di vita e alla condivisione negli ambiti
della resistenza civile e politica.
I Gas rappresentano uno strumento di contrasto alle logiche del consumismo e
un’alternativa concreta al sistema di relazioni umane proposto dalla società
25
Manifesto del Gas Coala, citato da Valera (cit.)
182
capitalista, e come tali si presentano nella società. Pur essendo delle nicchie, i
Gruppi di acquisto solidale non rappresentano, infatti, degli universi chiusi e
isolati, ma interagiscono attivamente sia sul mercato (gli acquisti sono il fulcro
della loro attività) che sulla scena sociale e politica, dimostrandosi dei laboratori
di pensiero critico. “Chi partecipa a un Gas è una sorta di obiettore di coscienza.
Sfugge alle costrizioni dell’iperconsumo e recupera in tutti i suoi risvolti
l’autonomo uso del proprio tempo” (Guadagnucci, 2007).
183
6.3 Bilanci di giustizia26
Il movimento Bilanci di Giustizia nasce nel 1993, a Verona, in occasione del
quinto raduno del movimento “Beati i costruttori di pace”. I soggetti di questo
movimento sono le famiglie, come microunità di consumo. L’obiettivo della
campagna è quello di controllare i consumi della propria famiglia al fine di ridurli
e riorientarli, seguendo un preciso indirizzo etico. Al termine di ogni mese, le
famiglie compilano un dettagliato bilancio delle proprie spese, riepilogato al
termine di ogni anno. Il bilancio non resta privato, ma viene inviato alla segreteria
nazionale, che provvede a stilare un rapporto annuale e a produrre circolari
periodiche, inviate a tutte le famiglie, che consentono di mantenere i contatti con
il resto dell’organizzazione.
La rete dei “bilancisti” aderisce al consumo critico e alla finanza alternativa,
poiché l’orizzonte etico in cui si muove è quello di “combattere l’invadenza e lo
strapotere della razionalità economica a partire dal carrello del supermercato e
dallo sportello di una banca”.
I bilanci famigliari sono divisi in due voci distinte: “consumi usuali” e “consumi
spostati”. La prima voce si riferisce ai consumi tradizionali, che sono cioè gli
stessi che si effettuavano prima di aderire alla rete dei bilancisti. La seconda voce,
invece, si riferisce ai consumi fatti dopo una scelta guidata da criteri di eticità e
sostenibilità ambientale, e corrisponde al cambiamento nelle abitudini della
famiglia. I dati dimostrano che si può “spostare”, o perlomeno ridurre,
praticamente ogni tipo di consumo. Esempi che vanno in questa direzione sono la
scelta di prodotti biologici, l’utilizzo di oggetti riciclati o riparati al posto di
oggetti nuovi, l’affidamento dei propri risparmi a banche etiche o a cooperative. I
migliori risultati nel cambiamento dei consumi (vedi tabella 1)27 si riscontrano nel
settore alimentare (oltre il 40%), in quello dei beni durevoli (35%) e nel capitolo
igiene (quasi il 40%).
Il confronto con i dati dei consumi tradizionali dimostra che le famiglie che
aderiscono al movimento Bilanci di giustizia riescono a ridurre gran parte dei
26
Dove non indicato diversamente, le citazioni di questo paragrafo sono tratte dal sito
www.bilancidigiustizia.it .
27
Fonte: Campagna Bilanci di Giustizia, Rapporto 2007
184
consumi: “Secondo l’ultimo rilevamento, dell’estate 2006, una famiglia bilancista
consuma il 20% in meno della media nazionale; i consumi di energia elettrica
sono inferiori del 49%, quelli di acqua del 49% e il ‘tasso si motorizzazione’ è di
46 auto ogni 100 persone contro un dato nazionale di 59 su 100” (Guadagnucci,
2007). Anche i dati relativi al 2007 vanno in questa direzione (tabella 2)28.
Tabella 1 – Percentuale di consumo spostato* per capitolo di spesa
Tabella 2 – Consumi medi mesili individuali dei bilancisti a confronto con i relativi valori nazionali
28
Fonte: Campagna Bilanci di Giustizia, Rapporto 2007.
185
Le scelte dei bilancisti si dirigono verso particolari settori del mercato, che
possono essere sintetizzati dal termine “consumo critico”: mercato equo-solidale,
biologico, preferenza dei produttori locali. L’attenzione viene rivolta anche alla
trasformazione dei prodotti, scegliendo articoli che hanno subito pochi passaggi,
ad esempio pane e marmellata al posto di una merendina confezionata.
L’unica voce in cui i consumi dei bilancisti non sono inferiori a quelli medi
rilevati dall’Istat è quella relativa al divertimento e alla cultura. La riduzione dei
consumi, a quanto pare, non corrisponde quindi a una vita “meno vissuta”,
segnata da austerità e rinunce, ma si configura piuttosto come un’esistenza più
sobria, ma accompagnata da un’elevata qualità della vita. “E’ anche per questo
che si può dire che le loro scelte non sono orientate al risparmio in sé, ma a uno
spostamento da consumi ‘spreconi’ di risorse naturali verso consumi immateriali
che non pesano sull’ambiente. Insomma, l’impronta ecologica dei bilancisti è
sicuramente inferiore alla media degli italiani e le scelte dei bilancisti sono
orientate verso un risparmio significativo e sistematico delle risorse naturali”.29
Uno dei meccanismi più utilizzati per diminuire consumi e impatto ambientale è il
ricorso all’autoproduzione. Questa è molto diffusa tra i bilancisti, in modo
particolare nel settore alimentare. Attraverso coltivazione e allevamento è
possibile ricavare gran parte degli alimenti necessari per la famiglia. Il passaggio
all’autoproduzione è in aumento negli ultimi anni, anche grazie alle esperienze e
alle conoscenze che vengono messe in rete tra i membri del movimento.
Questo è uno degli aspetti più interessanti del fenomeno: il gruppo Bilanci di
Giustizia non si limita a raccogliere i bilanci mensili delle famiglie. Dato che il
percorso da affrontare non è semplice, poiché presuppone un cambiamento
profondo delle abitudini e degli stili di vita, la forza del movimento risiede nel
sostegno reciproco che gli aderenti offrono agli altri bilancisti. Essendo sparsi in
tutta Italia, essi si muovono in rete, attraverso internet, e favoriscono la nascita di
gruppi locali in cui le famiglie possono confrontarsi e consigliarsi: “In questo
modo, nel corso del tempo sono riusciti a formare un corpus di esperienze, e
anche di elaborazioni, che oggi costituiscono un prezioso patrimonio culturale per
il movimento del consumo critico” (Guadagnucci, 2007).
29
Campagna Bilanci di Giustizia, Rapporto 2007
186
La scelta di aderire al movimento Bilanci di Giustizia si ripercuote anche sulla
mobilità. Poche sono ancora le famiglie che non possiedono un’auto (5%), mentre
sono il 50% le famiglie, anche numerose (la media di componenti del nucleo
famigliare è 3,6), che decidono di possedere una sola auto. Il risultato è che il
tasso di motorizzazione risulta pari a 393, del 37% inferiore rispetto al dato medio
nazionale pari a 620.
La scelta di questo stile di vita determina per molti la conseguente riduzione delle
ore di lavoro. I due fattori sono concatenati tra loro: da un lato, la scelta di un
modo diverso di consumare presuppone minori spese che consentono di dedicare
meno ore al lavoro, dall’altro, il maggior tempo libero permette di dedicarsi ad
attività di autoproduzione che consentono di acquistare meno merci sul mercato.
Nel rapporto annuale del 2007 si legge: “Insomma lavorare molto non lascia il
tempo per le cose importanti. O forse le cose importanti non si trovano
essenzialmente nel lavoro retribuito”.
Come per la decrescita, la critica rivolta a chi fa questo tipo di esperienza riguarda
il livello di reddito, come se scelte di vita differenti ed estranee alle logiche di
mercato fossero possibili solo per ricchi. Un confronto effettuato in occasione
della redazione del rapporto per l’anno 2007 tra i redditi medi nazionali e i redditi
dei bilancisti mostra che questi ultimi sono nella media per quanto riguarda i
redditi singoli, mentre stanno al di sotto della media nazionale man mano che
aumenta il nucleo famigliare (tabella 3)30.
Tabella 3 – Reddito famigliare annuo lordo
Componenti nucleo
BDG 2007
ISTAT 2003*
SCOST.
1
20.588
20.948
-2%
2
27.755
35.181
-21%
3
38.776
50.773
-24%
4
42.254
58.863
-28%
5 o più
39.862
60.340
-34%
Totale
36.750
39.319
-7%
*ISTAT 2003 Nord-Est a prezzi 2007
NOTA: I dati ISTAAT sono del 2003 aggiornati al 2007 in base all’inflazione 2003-2007 e trasformati in
reddito lordo aumentando il valore ISTAT fornito al netto di un valore medio di tasse del 25%
30
Fonte: Campagna Bilanci di Giustizia, Rapporto 2007.
187
La povertà viene calcolata dall’Istat non in base al reddito, ma in base ai livelli di
spesa. In questo senso, poiché tutti i bilancisti riducono i loro consumi, molti
rischiano di essere collocati al di sotto della soglia di povertà. Andando ad
analizzare i livelli di reddito, ci si accorge che con l’aumento del nucleo
famigliare il livello di reddito scende al di sotto della media nazionale. Molte
famiglie bilanciste hanno volontariamente ridotto il proprio reddito, ad esempio
diminuendo le ore di lavoro. Ma si può anche vedere la cosa da un altro punto di
vista: la riduzione dei consumi può aver permesso, a queste famiglie, di ridurre il
reddito, perché non hanno la necessità di avere guadagni elevati per mantenere il
loro livello di vita; una”piccola grande rivoluzione”, come viene definita nel
rapporto 2007: “Sembrerebbe vero che scegliere come e quanto consumare è
possibile e che questo dà la libertà di scegliere quindi quanto lavorare”.31 D’altro
canto, viene da chiedersi se possedere o meno un’auto, non acquistare dal
verduriere, ma autoprodursi insalata e zucchine, cucire da sé i propri vestiti,
facendo spendere di meno, significhi essere più ricchi o più poveri. Le famiglie
che adottano questo stile di vita si dichiarano più ricche, intendendo come
ricchezza la riscoperta di alcuni valori e piaceri che si erano persi: la condivisione,
il tempo da dedicare alla famiglia e alla cultura, il lavoro manuale, la solidarietà.
Certo è che, nell’attuale sistema economico e con gli attuali parametri, valutare
questo modo alternativo di vivere risulta molto difficile, poiché esce dalle logiche
capitaliste e di mercato. Tuttavia, questa esperienza rappresenta un modo di
mettere in pratica l’utopia concreta dell’uscita dal paradigma dominante per
cercare di mettere in atto un’economia più giusta e sostenibile. I bilancisti hanno
preso coscienza del fatto che l’economia non deve essere identificata con la realtà,
e che questa non si può ridurre alla sola economia. “L’economia esercita oggi un
ruolo mitico. Il mito è ciò che crediamo senza nemmeno esserne coscienti; […]. I
bilancisti sono persone che hanno preso coscienza di questo ‘mito’, lo hanno
guardato e osservato a partire dalla loro esperienza concreta. Hanno analizzato i
propri bisogni a partire dai propri consumi. E con questo sguardo consapevole
praticano scelte di libertà: scelgono, ad esempio, di limitare il ruolo del mercato e
del sistema economico nella propria vita, con le scelte di autoproduzione, di
31
Campagna Bilanci di Giustizia, Rapporto 2007
188
relazioni significative, di ospitalità e di sostegno reciproco, dando maggiore
spazio ai ‘beni non economici’ che soddisfano bisogni importanti come le
relazioni, la spiritualità, la formazione, il silenzio”.32
Le famiglie bilanciste tengono a sottolineare che aderire a Bilanci di Giustizia non
significa rinunce o sacrifici: le scelte derivano da un’analisi critica dei propri
consumi, che ha fatto capire come questi non corrispondano in molti casi a dei
reali bisogni umani. Non si nega la propria identità di consumatori, ma la si vive
in modo responsabile e consapevole, esercitando il proprio “potere del
consumatore” per mettere in atto una scelta in contrapposizione con l’economia
capitalista.
Si può notare una certa corrispondenza tra le scelte dei bilancisti e quelle delle
famiglie che fanno parte di un Gas. In effetti, i consumi di entrambi i gruppi si
spostano in sostanza verso i prodotti biologici, quelli del commercio equo solidale
e hanno una predilezione per i prodotti locali: insomma, appartengono entrambi a
quel settore che può essere riassunto dal termine “consumo critico”. Le differenze
riguardano piuttosto il modo di condividere questa esperienza: i Gas sono gruppi
di persone che decidono insieme cosa acquistare e da chi; i bilancisti mantengono
l’autonomia sui propri consumi, ma si impegnano a rendere conto delle proprie
spese per vivere insieme un’esperienza di consumo differente. Bilanci di giustizia
ha una formalizzazione ancora più leggera rispetto a quella dei Gas, poiché non
c’è la necessità di avere un coordinamento per gli acquisti.
Tuttavia, in entrambi i casi, le relazioni con gli altri membri del gruppo sono
fondamentali, sia per dare più senso alla propria scelta, sia per mettere in rete le
conoscenze e le capacità al fine di migliorare insieme. I bilancisti si muovono
nella direzione di creare una comunità di persone caratterizzata dalla sobrietà e da
una certa rettitudine morale (molti gruppi bilancisti hanno, infatti, ispirazione
cattolica).
32
Campagna Bilanci di Giustizia, Rapporto 2007
189
6.4 CAmbieReSti?
L’iniziativa CAmbieReSti?
(acronimo
di
consumi,
ambiente,
risparmio
energetico, stili di vita) si differenzia dalle due precedenti perché non nasce dalla
volontà dei cittadini, ma su proposta di un’istituzione pubblica. Il progetto è stato
promosso dall’Assessorato all’ambiente del Comune di Venezia e finanziato dal
Ministero per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio, nell’ambito dei bandi di
attivazione di Agende 21 locali nel 2002.
Il progetto, partito nel settembre del 2004 e concluso a febbraio 2006, si è
articolato in tre fasi:
1. nella prima fase, durata sei mesi, è stata sviluppata la co-progettazione con
tutti i partner del progetto, attraverso l’attivazione di tavoli di discussione.
Seguendo i principi dell’Agenda 21 sono state definite le “regole del
gioco”. Questa prima fase ha visto anche l’avvio della campagna
informativa con la raccolta delle prime adesioni;
2. la seconda fase è stata quella attuativa: dal 1 marzo del 2005, per dieci
mesi, è stata avviata la vera e propria sperimentazione con l’adesione di
1250 famiglie;
3. l’ultima fase è stata dedicata alla valutazione del progetto e
all’elaborazione finale dei dati, per giungere a un giudizio sull’esperienza.
Il progetto ha avuto come obiettivo quello di coinvolgere i cittadini nella
sperimentazione di nuovi stili di vita più equi, solidali e rispettosi dell’ambiente,
attraverso il riorientamento dei consumi, il rafforzamento dei legami comunitari e
il recupero delle relazioni non mercantili. Il progetto CAmbieReSti? rappresenta
uno dei pochi esempi di consumo critico incoraggiato da un’istituzione pubblica.
Il progetto non si basa su strumenti coercitivi per raggiungere gli obiettivi di una
sostenibilità sociale e ambientale ma, come accade nei gruppi autonomi di
cittadini, si concentra sull’aspetto educativo e relazionale. La novità sta, quindi,
non nel metodo, ma nel fatto che “un’amministrazione pubblica entra nel sancta
sanctorum dei consumi privati e cerca di modificarli […] Non si limita, cioè, a
fare campagne di stampo pubblicitario né alle consuete azioni nelle scuole, ma
forza in una determinata direzione i consumi delle persone” (Osti, 2006).
190
Le famiglie coinvolte nel progetto sono state invitate a rivedere i propri consumi
definendo un nuovo paniere di beni e servizi, in base a una consapevole scelta di
ciò che realmente serve al proprio benessere, coniugando la propria qualità della
vita con il rispetto dell’ambiente e della giustizia verso i popoli dei Sud del
mondo. Oltre alle famiglie, sono stati coinvolti altri numerosi partner, Enti
istituzionali, società di natura economica, movimenti e associazioni, che hanno
collaborato a vario titolo, attraverso contributi economici, servizi, consulenze
tecniche, idee e progettualità.
La fase di sperimentazione ha visto come protagoniste assolute le famiglie. I
nuclei, distribuiti su tutto il territorio comunale, sono stati suddivisi in 49 gruppi
locali. Il percorso, di dieci mesi, è stato seguito con due modalità: la
partecipazione assidua ai gruppi locali che si riunivano mensilmente, oppure la
fruizione in modo libero e autonomo degli strumenti, pratici e informativi, messi a
disposizione dal progetto. CAmbieReSti?, infatti, è stato concepito come un
percorso formativo e informativo con due obiettivi: da un lato focalizzare
l’attenzione sugli impatti globali delle scelte individuali, attraverso un processo di
conoscenza e corresponsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti; dall’altro,
stimolare l’acquisizione di “buone pratiche” e di modi diversi di consumare,
legando la scelta individuale del consumatore informato e consapevole a
comportamenti collettivi alternativi, per costruire scambi meno iniqui e meno
nocivi, e per riscoprire il valore della sobrietà e della sufficienza. Nessuna
famiglia è stata obbligata a partecipare a incontri e iniziative: l’unico impegno
richiesto è stato la compilazione di questionari e la lettura periodica dei propri
contatori.
I gruppi locali, che si sono incontrati una volta al mese, sono stati il punto di
riferimento per le famiglie aderenti al progetto. All’interno dei gruppi i
partecipanti hanno potuto trovare assistenza e supporto per controllare
l’andamento dei cambiamenti effettuati. Il ruolo dei gruppi mensili non è stato
tanto quello della formazione e dell’educazione ambientale, ma piuttosto quello di
creare dei momenti di riflessione, degli spazi di condivisione di idee, esperienze,
buone pratiche, proposte. Si è trattato, in altre parole, di uno spazio per creare
delle relazioni sociali tra persone accomunate dagli stessi interessi e dagli stessi
191
obiettivi; un modo per incontrare persone che condividono la stessa critica al
sistema in vigore e che, insieme, trovano più forza e più incentivi per modificare il
proprio stile di vita e di consumo. Inoltre, i gruppi locali hanno permesso di
mettere in piedi una rete sociale che, al termine della fase di sperimentazione, ha
saputo riorganizzarsi per proseguire il cammino intrapreso in una forma
autogestita e autonoma, senza il bisogno di un sostegno dell’amministrazione
pubblica.
Parallelamente ai gruppi locali, sono stati organizzati incontri tematici con esperti
(forniti dagli altri partner del progetto) per fornire un percorso educativo e
formativo di approfondimento e riflessione sui vari temi affrontati da
CAmbieReSti?. Questo tipo di incontri mirava anche a soddisfare una richiesta
pratica di informazioni e nozioni tecniche necessarie per mettere in atto azioni
concrete di cambiamento. Gli incontri sono stati, infatti, di due tipi: alcuni hanno
avuto uno sviluppo più teorico, altri sono stati strutturati come laboratori per
coinvolgere i partecipanti in attività manuali. I temi affrontati sono stati
molteplici: dal risparmio energetico alla bioedilizia, dal risparmio idrico
all’alimentazione e alla mobilità sostenibile, e ancora ai rifiuti, al turismo
responsabile, alla finanza etica, alla medicina naturale, al rispetto dei diritti degli
animali, per finire con il consumo critico e il commercio equo solidale. Si è fatto
esplicito riferimento ai principi di sobrietà e di decrescita, proponendo esperienze
di autoproduzione.
L’interfaccia tra le famiglie e l’amministrazione cittadina è avvenuta tramite la
creazione di sportelli denominati StilInfo, aperti a Venezia e a Mestre. Essi sono
stati il supporto logistico e informativo per le famiglie aderenti, ma anche
contenitori e motori di ricerca di informazioni, approfondimenti tematici,
opportunità di agevolazioni e incentivi.
Il progetto CAmbieReSti? ha voluto sostenere parallelamente la creazione di una
Rete di economia solidale tra produttori e consumatori, considerata fondamentale
perché la consapevolezza della necessità di un altro consumo si traducesse poi in
pratiche reali. Al progetto hanno aderito alcune aziende biologiche, panificatori,
produttori di pannelli solari, botteghe del commercio equo e solidale, associazioni
per il turismo responsabile, ecc. Tutti hanno sottoscritto i principi dell’altra
192
economia (ecosostenibilità, cooperazione, trasparenza, predilezione di prodotti
locali, ecc.) e si sono impegnati a intraprendere qualche azione concreta (prezzi
trasparenti, vendita diretta, laboratori per le famiglie, ecc).
I partner del progetto, oltre a fornire le loro conoscenze tecniche, hanno
contribuito alla distribuzione di incentivi e agevolazioni, soprattutto al fine di far
conoscere meglio alle famiglie partecipanti prodotti e servizi già facilmente
accessibili sul territorio. Sono state distribuite lampadine a basso consumo,
riduttori di flusso per l’acqua, copie di varie riviste riguardanti argomenti legati
alla sostenibilità ambientale e sociale (ad esempio Altreconomia, Gaia e Aam
TerraNuova), miniguida per il compostaggio domestico, carrellini porta-rifiuti,
borsa in tela per la spesa, abbonamenti per l’autobus urbano, buoni per l’utilizzo
del servizio di car-sharing, analisi della qualità dell’acqua domestica e controlli
sull’efficienza energetica dell’abitazione. Inoltre, i soggetti che hanno aderito alla
Rete di economia solidale si sono impegnati a garantire servizi o agevolazioni
particolari per le famiglie partecipanti, ad esempio sconti sulle merci, corsi e
laboratori, consulenze.
CAmbieReSti? ha messo in moto una dinamica relazionale e creativa tra le
persone. E’ cresciuta la consapevolezza rispetto alle proprie responsabilità verso
l’ambiente e la società. Il progetto è stato soprattutto un impegno educativo e
formativo, mostrando come la conoscenza sia il vero motore del cambiamento.
Il bilancio dell’esperienza contiene diverse sfaccettature. Per misurare il
cambiamento degli stili di vita e dei consumi è stato elaborato un “eco-punteggio”
che ha rivelato dati incoraggianti: sono diminuiti gli acquisti di beni usa e getta
con un contemporaneo aumento dei prodotti con pochi imballaggi; i consumi di
prodotti equo solidali sono aumentati, come pure quelli di prodotti biologici e di
detersivi non tossici; si sono diffusi i riduttori di flusso per i rubinetti e le
lampadine a basso consumo. In alcuni settori, tuttavia, i cambiamenti sono stati
ridotti, in particolare per quanto riguarda i mezzi di trasporto, la gestione del
denaro e il compostaggio degli scarti della cucina. Inoltre emerge, dalle interviste
ai partecipanti, che l’esperimento è stato soddisfacente e stimolante, ma che
l’iniziativa pare isolata e incapace di produrre un impatto significativo. Questo fa
intendere che la Rete di economia solidale sia ancora tutta da costruire.
193
L’amministrazione comunale, pur essendo il soggetto promotore dell’iniziativa,
non è stata immune da critiche, anzi: durante la fase di sperimentazione, con una
lettera aperta, alcune famiglie hanno espresso il loro disappunto per una gestione
della cosa pubblica che ritenevano lontana dai parametri e dalle logiche che la
stessa amministrazione intendeva sviluppare con CAmbieReSti?.
Tuttavia, l’esperienza non è certo stata fallimentare: ha aumentato la
consapevolezza dei cittadini rispetto alle tematiche del consumo critico; ha creato
dei legami relazionali che in alcuni casi si sono trasformati nella volontà di dare
vita a Gruppo di acquisto solidale; è stata replicata in altre città come Piacenza,
Colorno, Biella e Campobasso e ha dato vita, a Venezia, a un secondo progetto.
Si tratta di “Cambieresti? Energia 300X70”, un progetto che ha coinvolto 300
famiglie nella riduzione dei consumi domestici da riscaldamento a 70 Kw/h/a.
CAmbieReSti? è stato definito da Guadagnucci “un laboratorio di democrazia”: “è
stata un’esperienza che ha messo in moto risorse umane e competenze altrimenti
non disponibili a impegnarsi in un progetto di trasformazione sociale: il Comune è
diventato protagonista di una sperimentazione che non avrebbe potuto avvenire
senza la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini” (Guadagnucci, 2007).
194
6.5 Luci e ombre del consumo critico
Gli esempi riportati in questo capitolo mostrano un atteggiamento differente
rispetto al tradizionale modo di intendere i consumi, e in particolare si rivelano
come una reazione alla società dei consumi e alla mercificazione dei rapporti.
Si è detto che queste esperienze possono rientrare nel contesto del consumo
critico, ovvero quei comportamenti di consumo che prevedono la consapevolezza,
da parte del consumatore, che il proprio atto d’acquisto non è un gesto neutrale,
ma produce conseguenze a livello ambientale, sociale e politico. Quello che la
società dei consumi rende un atto privato diventa, nel caso del consumo critico, un
atto pubblico, una testimonianza delle proprie convinzioni e dei propri valori. A
livello di numeri, il peso economico dei consumi critici è ancora poco rilevante;
assume, però, sempre maggior peso il suo significato simbolico: in altri termini,
essi non funzionano solo come strategia exit – defezione dal mercato tradizionale
o rifiuto di alcune merci – ma soprattutto come voice, ovvero come protesta
simbolica. Diventano quindi importanti non solo i consumi in se stessi, ma anche
le cornici e i contesti in cui vengono effettuati. Riunirsi in Gruppi di acquisto
solidali o prendere parte a un progetto come CAmbieReSti?, concorre a creare un
tappeto diffuso di individui che operano in modo alternativo al mercato. Infatti, il
consumo critico viene in qualche modo sempre più appoggiato anche dalle
imprese, che sull’onda della popolarità di questi comportamenti, pubblicizzano i
loro prodotti rimarcando sempre più i comportamenti virtuosi dal punto di vista
ambientale e sociale.
Le cause della scelta del consumo critico possono essere di duplice natura: si può
avere a cuore la propria salute e la qualità delle merci acquistate; o si può
consumare alternativo per esprimere sentimenti politici. In questa seconda
accezione si ritrovano gli obiettori della crescita. Anche a livello delle esperienze
citate in questo capitolo, occorre sottolineare che, pur ottenendo come risultato
una decrescita dei consumi e del Pil, non tutti gli attori sono pienamente
consapevoli di questa conseguenza politica. Tuttavia, non bisogna neppure
dimenticare che consumare in un modo diverso non è mai una scelta casuale, ma
corrisponde sempre a una presa di coscienza da parte del consumatore. Questa può
195
riguardare i problemi ambientali, i problemi sociali, la disuguaglianza tra Nord e
Sud, o tutte queste cose insieme come per chi abbraccia la filosofia della
decrescita.
In un contesto politico in cui le ideologie sono sempre più deboli e l’individuo è
diventato il centro di tutto l’agire, riunirsi in gruppi e cercare l’appoggio di una
collettività rappresenta il modo per ritrovare il contatto e il confronto con gli altri.
Attraverso la condivisione con gli altri si rende meno astratto il proprio agire.
I consumatori critici sono consapevoli della debolezza del singolo e delle azioni
parcellizzate, tuttavia, attraverso il micro-cambiamento è possibile criticare il
sistema partendo proprio dalle forme promosse dal liberismo, cioè il consumo,
attraverso la difesa dei beni pubblici e la riappropriazione del tempo, denunciando
le alienazioni contemporanee.
Il tipo di consumatore che emerge da queste esperienze ha caratteristiche diverse
da quello evidenziato dalle teorie della società dei consumi. Là dove queste
descrivono un individuo egoista e razionale, che basa il proprio comportamento
sul calcolo economico e sulla soddisfazione edonistica, si sostituisce un individuo
che pensa al proprio interesse e benessere, ma associando lo stesso pensiero anche
verso la collettività e verso l’ambiente. Il consumo diventa una risorsa identitaria,
un momento di autorealizzazione che si concretizza in un consumo responsabile
ma gradevole, che permette non solo di soddisfare i propri bisogni, ma soprattutto
di esprimere le proprie convinzioni e la propria partecipazione in prima persona
alle problematiche sociali e ambientali.
Vengono così ribaltate le teorie classiche del consumatore, che lo descrivono o
come schiavo delle merci, o come padrone del mercato: il consumatore critico è
consapevole e in grado di esercitare pressioni politiche più che economiche. La
sovranità del consumatore non emerge come risultato della “mano invisibile”
dell’adagio smithiano, ma può emergere solo se ognuno si fa carico delle
conseguenze etiche, sociali e ambientali delle proprie scelte. “In opposizione al
modello liberale, il modello critico della sovranità è definito meno dall’autonomia
individuale e più dalla capacità di riconoscere le interdipendenze, di affrontare un
dialogo, mettersi in gioco a partire dall’idea che le interconnessioni tra attori non
196
solo sono inevitabili, ma sono anche, potenzialmente, la fonte principale di senso
e del piacere che deriva dal mondo degli oggetti” (Sassatelli, 2008).
Ai soggetti che praticano il consumo critico vengono attribuite delle responsabilità
e dei doveri in quanto consumatori, e ai consumatori viene attribuito il potere di
agire eticamente e politicamente. In realtà, le stesse responsabilità sono affidate
anche a tutti gli altri soggetti, ma molti non ne sono consapevoli; le persone che
praticano un consumo diverso, invece, hanno sviluppato questa consapevolezza e
il loro impegno diventa una testimonianza nella società.
La scelta di uno stile di vita diverso da quello proposto dalla società, frutto di una
ricerca e di nuova conoscenza, non è percepito come un obbligo o come una
riduzione della libertà. Al contrario, essa rappresenta una libertà di scelta
all’interno di vincoli, ambientali e sociali, che sono scelti e fissati dall’individuo
stesso, in base alle proprie convinzioni morali. I vincoli vengono tracciati
attraverso le relazioni personali che permettono di reperire informazioni e di
conoscere le merci. Dietro alle scelte di consumo effettuate, infatti, si cela un
processo di ricerca e di apprendimento che emerge chiaramente nelle indagini
condotte dai Gas. La merce non viene acquistata per quello che è, ma per cosa c’è
dietro e per il valore etico che essa incorpora.
Il consumo ha rappresentato, nei primi anni del capitalismo, una valvola di sfogo
dal lavoro; in tempi più recenti viene giustificato da retoriche più edonistiche e
autoriferite. Oggi, in seguito alla produzione di massa basata sulla gerarchia e sul
controllo, il capitalismo ha recuperato e internalizzato concetti quali la flessibilità
e la creatività, mostrando prodotti con un’immagine di autenticità che la
massificazione aveva cancellato. Eppure esso rischia di fa saltare gli stessi valori
di cui si è appropriato, promuovendone la mercificazione e il disincanto. Chi si
oppone a questa evoluzione propone allora di recuperare tali valori fuori dal
consumismo, attraverso competenze informali e interstiziali.
Si può allora parlare di edonismo frugale: “Le narrazioni che contribuiscono a
consolidare l’edonismo frugale fanno riferimento al principio […] del ‘poco ma
buono’: recuperano essenzialmente l’idea che per consumare ci voglia tempo; che
per ‘gustare appieno’ le proprie scelte occorra sviluppare una relazione con le
cose fondata anche sul ‘recupero delle relazioni’ (di produzione, scambio e
197
consumo) che le accompagnano, anziché sulla loro rimozione o mascheramento”
(Sassatelli, 2008). La sobrietà diventa quindi non una semplice riduzione dei
consumi, ma controllo degli sprechi e selezione delle giuste alternative: non un
consumo ridotto, ma un consumo migliore.
Si è detto più volte che il consumo critico rappresenta anche una scelta politica.
Sotto questo punto di vista emergono diverse problematiche. Le scelte alternative
al sistema dominante presentano come punto di forza il fatto che il cambiamento
si possa esprimere attraverso azioni individuali che non devono aspettare il
cambiamento, più lento e difficile, delle istituzioni. Essendo una scelta individuale
essa si concretizza in una pluralità di esperienze che difficilmente possono essere
riunite in un’unica corrente. Per questo, la conseguenza pratica sulla politica
emerge come frammentata ed eterogenea, con un potere di incisione ancora
limitato.
Tuttavia, proprio il carattere individuale della scelta e il fatto che il consumo
rappresenti qualcosa di abitudinario e quotidiano, fa sì che per la persona questo
cambiamento risulti estremamente importante, tanto da rappresentare un completo
capovolgimento dello stile di vita. In questo senso, le reti di consumo critico si
propongono di cambiare la società dall’interno, a partire da una rivoluzione a
livello individuale da esportare nella società. L’atteggiamento, più che di protesta,
diventa quindi propositivo e positivo.
Allo stesso tempo, l’enfasi sull’individuale e sulla quotidianità si accompagna alla
preoccupazione che i consumi critici possano rimanere una realtà marginale, senza
riuscire a incidere in modo rilevante sulla società capitalista. Inoltre, il timore di
molti attivisti nelle reti di consumo critico è che una diffusione massiccia di
queste pratiche possa venire assorbita dal sistema capitalistico, e che il consumo
critico diventi una moda, piuttosto che una scelta consapevole. Si sviluppa
un’antinomia tra il successo commerciale e l’integrità etica dei consumi critici.
La soluzione prospettata da molti attivisti, così come dai fautori della decrescita, è
quella di mantenere il collegamento con il territorio, attraverso la molteplicità
delle esperienze (contro la standardizzazione) e il coesistere di esperienze diverse
e sempre nuove che provengono dal basso e dal piccolo. La ricetta sembra essere
198
quella di sfuggire all’omologazione ricercando un’identità forte e radicata nei
rapporti con il territorio e con le persone.
Resta comunque il problema della difficoltà nel coniugare individuale e collettivo,
cioè la capacità di “tradurre la politica del quotidiano promossa dal consumo
critico in una forma di partecipazione politica efficace” (Sassatelli, 2008).
Il consumo deve quindi essere sostenuto da una rete di significati, da pratiche e
rapporti sociali, da reti di relazioni che inseriscano l’agire di consumo in un
ambito di idee e valori condivisi e non di semplice soddisfazione di un bisogno.
La scelta di un prodotto diventa così espressione di una scelta di vita e di un
percorso politico che determina il rifiuto dell’attuale sistema e propone un diverso
modo di affrontare l’economia. Il concetto di decostruzione dell’immaginario
proposto da Latouche si inserisce appieno in questo filone di esperienze. La scelta
di una vita che non si basa sulla quantità ma sulla qualità, di un percorso che pone
al centro le relazioni con gli individui piuttosto che le relazioni economiche, che
sostiene l’uguaglianza delle popolazioni del mondo invece di accentuare la
distanza attraverso metodi di consumo iniqui sono elementi che appartengono sia
al mondo del consumo critico che alle proposte della decrescita.
In effetti, non essendo la decrescita una vera e propria teoria, essa si esplicita
piuttosto attraverso esperienze concrete che non tramite programmi e ricette già
pronte.
199
6.6 L’altra rete
Intorno alle nuove pratiche di consumo si costruiscono rapporti che danno vita
sostanzialmente a nuove comunità. Si è detto come la rilevanza delle relazioni e il
substrato morale che caratterizza quelli che sono stati chiamati i laboratori della
decrescita, rappresentino una reazione all’atomizzazione generata dal consumismo
e al conseguente isolamento sociale. Il desiderio di comunità appare radicato e
cercato con costanza. E’ interessante notare come, in realtà, la “voglia di
comunità” sia diffusa in modo generalizzato nella società, tanto da esplicitarsi in
forme di aggregazione non tradizionali, rese possibili soprattutto dalle nuove
tecnologie di comunicazione.
Il processo di deterritorializzazione messo in atto dalla globalizzazione favorisce
il nascere di processi di aggregazione non più basati sulla prossimità fisica, ma
piuttosto sulla prossimità culturale. Le nuove tecnologie comunicative permettono
lo sviluppo di reti che suppliscono alla degenerazione dei rapporti faccia-a-faccia,
implementando una nuova forma di reciprocità, basata non sull’interazione fisica,
ma sulla condivisione di idee e valori.
Liberati dai vincoli fisici, gli individui possono completare la ricerca di collettività
attraverso la creazione di comunità virtuali, che possono condividere ogni tipo di
argomento. Quando l’oggetto di condivisione è una merce, si può parlare di
comunità di consumo, o di brand: individui che si riuniscono attorno a un
marchio, un prodotto o un punto vendita. Essi cercano informazioni e assistenza
rispetto al proprio consumo, ma manifestano anche il desiderio di trasformare un
agire individuale in un agire collettivo. Essere parte di una comunità di consumo
permette di “soddisfare al meglio il bisogno che si riconosce in quell’area di
consumo” (Fabris, 2003). E’ frutto di una socialità diversa da quella tradizionale,
che non si riconosce in un progetto politico o sociale, non si iscrive a nessuna
finalità: la sua unica ragion d’essere “è la cura di un presente vissuto
collettivamente” (Fabris, 2003). Il collante è il consumo, come agire che genera
emozioni e passioni che sfociano in un’estetica collettiva, la cui base è un oggetto,
un bene di consumo. Consumare lo stesso bene diventa la dimostrazione di un
sentire comune che si realizza attraverso un oggetto. In qualche modo questo
200
fenomeno è frutto della mercificazione della società contemporanea, in cui gli
oggetti, più che le relazioni, diventano il fulcro della vita sociale. La relazione non
è fine a se stessa ma, per essere implementata, ha bisogno dell’intermediazione di
un oggetto o di un comportamento di consumo. Il consumo, d’altro canto, si
espande fino a includere non solo il prodotto, ma anche le relazioni che possono
nascere dall’interesse comune in un ambito di consumo. Attraverso la rete, le
relazioni diventano più facili, rapide e potenzialmente globali.
Si può parlare di comunità di consumo anche nell’ambito del consumo critico?
Sicuramente esistono delle affinità, ma sono evidenti anche alcune differenze. Le
potenzialità della rete sono un vantaggio che anche i consumatori critici hanno
deciso di cogliere: come si è visto, i vari gruppi si organizzano e dialogano tra
loro attraverso internet. Il web, grazie alla rapida diffusione delle informazioni,
consente di dare ampia visibilità alle proprie iniziative e permette di mantenere i
rapporti anche in mancanza della prossimità fisica. Tuttavia, dagli esempi
presentati in questo capitolo, emerge come le tecnologie informatiche siano
utilizzate come strumento, piuttosto che come obiettivo della relazione. In altre
parole, in molte comunità virtuali la relazione viene messa in atto proprio perché
mediata dal mezzo informatico, perché consente una maggiore fluidità e facilità
nell’instaurare un rapporto. Nel caso del consumo critico e dell’economia solidale,
il passaggio nella rete è un mezzo per arrivare a un altro obiettivo. Se le generiche
comunità di consumo hanno come fine il prodotto (e grazie a esso si possono
anche creare delle situazioni di socializzazione), nelle “comunità di consumo
critico” il fine non è tanto il consumo in sé, quanto la dimostrazione della propria
critica all’economia di mercato. Inoltre, l’aspetto relazionale non è un corollario al
consumo, ma un elemento centrale di questi movimenti, che auspicano una
socializzazione più “umana”, basata su rapporti costruiti e “lenti”, nel senso di
relazioni che non si consumano nella frenesia tipica della società contemporanea,
ma che si gustano grazie a incontri e confronti continuativi e “reali”.
Le comunità virtuali si configurano come una risposta sia alla disgregazione delle
relazioni sociali, sia alla crisi dei territori come luoghi attivi di partecipazione
sociale. Obiettori della crescita e consumatori critici, invece, puntano proprio a
riportare la partecipazione all’interno dei territori. Si preferisce l’incontro faccia-
201
a-faccia: non si spiegherebbe, altrimenti, il tempo speso nell’organizzazione dei
gruppi in cui si ritrovano i membri dei movimenti. Sarebbe più comodo dialogare
tramite internet anche all’interno della stessa città, per evitare di dover trovare del
tempo da dedicare a incontri “reali”. Proprio la dimensione del tempo rappresenta,
invece, il cuore del discorso: le cose facili e le scorciatoie non piacciono, la
reciprocità deriva dalle relazioni che si possono sentire e gustare. Riappropriarsi
del proprio tempo, e decidere in che modo spenderlo, rappresenta una conquista
per gli obiettori della crescita.
I Gas, che pure sono comunità di consumo e che hanno organizzato il proprio
coordinamento nazionale attraverso la rete internet, tengono a sottolineare che non
è il consumo il fine ultimo del loro impegno. L’attenzione è rivolta piuttosto a ciò
che fa da contorno al consumo: i metodi di produzione, i diritti dei lavoratori,
l’impatto ambientale e sociale del prodotto. Il consumo diventa il mezzo per
affermare quali sono i principi etici che muovono queste persone.
D’altro canto, l’attenzione all’aspetto locale e il reiterato riferimento a un
“progetto locale” che si ritrova in tutte le esperienze di consumo critico e solidale,
porta alla conclusione che le comunità che si creano sono reali, piuttosto che
virtuali. La rete resta uno strumento fondamentale per mettere in connessione le
diverse realtà, e si dimostra un’ottima tecnologia al servizio di questo scopo. Ma
viene utilizzata più come mezzo di informazione che come strumento di
socializzazione, al quale si preferiscono i rapporti faccia-a-faccia, sentiti come più
veri e genuini.
202
CONCLUSIONI
Nel corso di questo lavoro, sono state evidenziate diverse problematiche legate
all’attuale modello di sviluppo, esportato in tutto il mondo grazie al contributo
della globalizzazione. L’emergere del problema climatico con toni sempre più
preoccupanti, tali da trovare spazio sui media, è solo un aspetto del problema. La
sua importanza non deve oscurare il lato più nascosto della globalizzazione e dello
sviluppo, cioè il progressivo logoramento dei legami sociali e delle pratiche
relazionali sia nei Paesi occidentali che nel Sud del mondo.
Lo
sviluppo,
seppure
teoricamente
riproducibile,
pare
non
essere
universalizzabile, soprattutto a causa dei limiti fisici del pianeta. L’aspetto
quantitativo dello sviluppo risulta incompatibile con la struttura fisica della Terra.
Gli aspetti qualitativi, d’altro canto, si sono diffusi assai poco. Il benessere
derivante dall’accumulazione di beni, che pure ha portato significativi
miglioramenti nella vita dell’uomo occidentale, è ancora un sogno da raggiungere
per molte delle popolazioni che vivono nei Paesi in via di sviluppo.
La critica allo sviluppo e all’accumulazione capitalista esposta in questo lavoro,
ha tuttavia cercato di esplicare come non solo l’avere sia importante per realizzare
il benessere di una società. E’ innegabile che i bisogni fondamentali debbano
essere garantiti per assicurare la sopravvivenza ma, oltre a questi, non sempre
“avere di più” corrisponde a una vita migliore. Gli autori analizzati in questo
lavoro sottolineano invece come, anche a livello economico, siano molto più
importanti gli aspetti qualitativi delle merci e le relazioni che si instaurano con le
persone che ci sono intorno, con la comunità a cui si appartiene.
Le esperienze presentate nel capitolo precedente sono degli esempi pratici
dell’importanza delle relazioni all’interno di un contesto che si distacca dal
paradigma sviluppista per proporre un’alternativa alla dinamica della crescita
illimitata.
La teoria della decrescita (anche se, come si è visto, sarebbe più opportuno
chiamarla movimento), si propone come una sintesi tra la critica sociale dello
sviluppo e la critica ecologia che, superato il concetto di sviluppo sostenibile,
203
traccia l’affresco di una società liberata dall’assillo della crescita e avviata verso
un modo diverso di intendere i rapporti umani e i rapporti economici.
La comunità e il territorio
Herman Daly tratteggia il suo progetto di società sostenibile a partire dalla
riscoperta della comunità, mentre la decrescita e le esperienze di consumo critico
vedono nel locale la possibilità di uno sviluppo economico diverso, più a misura
d’uomo. Entrambi gli approcci considerano la globalizzazione e la ricerca della
crescita illimitata la causa di un processo disgregativo che minaccia le relazioni
umane e i rapporti sociali: “Siamo indotti a cercare […] soluzioni personali a
contraddizioni sistemiche; cerchiamo la salvezza individuale da problemi comuni”
(Bauman, 2001). Il risultato è una crescente incertezza che si traduce nella ricerca
di cose concrete, come il nostro corpo con tutte le sue estensioni esosomatiche e i
suoi baluardi. Nel fare ciò, cresce la diffidenza verso ciò che ci circonda, gli
estranei e il diverso da noi, che si traduce in un isolamento progressivo che lacera
i rapporti con la fetta di società che ci sta intorno.
Anche il territorio, come la comunità, appare intaccato dal processo della
globalizzazione: la dinamica delocalizzativa messa in atto dalle imprese
multinazionali e l’internazionalizzazione del mercato del lavoro provocano un
affievolimento del territorio come soggetto autonomo, che si trova a fare i conti
con dinamiche globali antitetiche alla sua identità locale. La dimensione
economica gioca un ruolo fondamentale: la creazione di un unico mercato
mondiale consente di superare i limiti regolamentativi dello stato-nazione e di
realizzare il sogno di un mercato veramente libero. La territorialità non si è
dissolta, ma piuttosto è stata colpita nei suoi aspetti di sovranità e di relazionalità,
che rendono il territorio non solo uno spazio fisico a supporto delle attività umane,
ma un vero e proprio attore nelle dinamiche economiche e sociali di una
comunità.
Il territorio e la cultura locale che esso incorpora sono inoltre minacciati da
un’altra
forma
di
globalizzazione:
quella
che
viene
anche
chiamata
204
occidentalizzazione del mondo. L’esportazione della cultura occidentale nel resto
del mondo, attraverso una sorta di nuova colonizzazione commerciale, ma anche
attraverso l’esportazione di un modello di sviluppo che intende trasferire il
successo occidentale sul resto del mondo, causa un repentino declino delle
tradizioni locali, a vantaggio di un’omologazione che riguarda più le aspirazioni
che le reali condizioni di vita.
Questo problema non si manifesta soltanto nel Sud del mondo, ma negli stessi
Paesi occidentali, che pian piano hanno perso quanto era legato alla tradizione e a
un modo di intendere la vita fatto di relazioni, sobrietà e convivialità.
I movimenti della decrescita e dell’economia solidale, cercando di recuperare
questi elementi, producono un rinnovamento nell’idea di comunità e di territorio.
Si tratta di un vero e proprio recupero e riappropriazione culturale. Come
sottolineato più volte dai diversi autori e dai protagonisti di esperienze di
decrescita, questo non implica un ritorno al passato, ma un nuovo modo di
intendere l’economia e le relazioni, tenendo però ben presente l’insegnamento del
passato. E’ un fatto culturale, nella misura in cui significa pensare il proprio stile
di vita a partire dalla sapienza e dalle risorse locali esistenti, assumere la
responsabilità del proprio patrimonio come sostegno e qualità della vita da
mantenere nel futuro, autodeterminazione in forma creativa del proprio modello
economico, organizzazione di processi interattivi di progettazione autonoma
attraverso la costruzione di reti sociali e produttive locali in grado di
autorganizzarsi rispetto ai sistemi territoriali locali e allo stesso tempo in grado di
rapportarsi, criticamente e in autonomia, alle reti globali.
In questo senso è possibile parlare di sviluppo locale, nella misura in cui i
cittadini, per manifestare il proprio dissenso a una forma economica che non
condividono, si riuniscono in gruppi che si relazionano con il territorio attraverso
un rapporto operativo reale. La riscoperta dei produttori locali e la pratica
dell’autoproduzione rendono il territorio, con le sue risorse, un soggetto attivo
nell’implementazione di uno stile di vita alternativo e allo stesso tempo rendono i
cittadini consapevoli e responsabili del territorio stesso.
Nella misura in cui il territorio assume questa rilevanza, esso impone anche ritmi
e tempi diversi alla vita umana. L’esempio dei Gas, che consumano
205
esclusivamente frutta e verdura di stagione, corrisponde a un modo diverso di
intendere il tempo: non è l’uomo a imporre i propri ritmi, sempre più frenetici,
anche all’ecosistema, ma è il territorio che impone i propri tempi, definendo esso
stesso la propria sostenibilità. Ecco allora che, quello che per l’economia della
crescita diventa un costo aggiuntivo (coordinare le necessità economiche con i
limiti ambientali), nell’economia della decrescita diventa un automatismo dettato
dall’ambiente stesso, che si realizza con la semplice consapevolezza, da parte del
cittadino/consumatore, che la natura presuppone dei tempi che l’uomo non può
stravolgere senza causare danno.
Un diverso modo di vivere che potrebbe essere definito slow life: per i fautori
della decrescita e per gli aderenti alle Reti di economia solidale, la
riappropriazione del tempo si concretizza attraverso i momenti spesi per
confrontarsi sui nuovi prodotti da acquistare; nel tempo passato a confezionarsi un
abito, magari nell’ambito di un gruppo di cucito, invece di un pomeriggio speso a
fare shopping; nei pomeriggi passati con i figli invece che trascorsi in ufficio a
fare straordinari.
Anche la dicotomia tempo libero/lavoro assume un valore diverso: i contorni
diventano meno netti, perché diventa difficile catalogare attività come
l’autoproduzione nelle due categorie, così come il tempo impiegato nella
redazione del bilancio famigliare o nella ricerca sul territorio di nuovi produttori.
La società della decrescita presuppone un vivere lento, più misura d’uomo, perché
quello che si cerca è la riappropriazione del gusto delle relazioni umane, per
godere appieno della propria vita. Sfuggire alla moda, alla pubblicità e ai consumi
condizionati permette di riscoprire la propria identità e i propri reali bisogni,
abbandonando gli oggetti che appesantiscono, infastidiscono e occupano ormai
troppo spazio e troppo tempo.
L’economia si sposta su una scala diversa: dal livello globale al livello locale,
mettendo in pratica concetti quali la conservazione, la stabilità, l’autosufficienza e
la cooperazione. La possibilità di creare reti dal basso, non gerarchiche ma
solidali, consente di contrastare gli effetti negativi della globalizzazione,
inserendo nelle reti stesse il territorio, come attore a tutti gli effetti. “Dal momento
in cui si guarda il territorio come un luogo denso di storia, di cultura, di saperi, di
206
strumenti per uno sviluppo autogovernato, da quel momento si sta lottando
efficacemente contro un territorio usato dalle grandi multinazionali e da chi lo
tratta come puro strumento per la produzione di profitto e di mercato” (Magnaghi,
2002).
Le risorse del territorio vengono percepite come ricchezze da valorizzare,
riprodurre e conservare, al fine di autoprodurre un proprio duraturo sviluppo. Il
tentativo di chiudere i cicli economici all’interno del territorio facilita la riduzione
dell’impronta ecologica e crea un rapporto con i luoghi dell’abitare che rende i
soggetti più responsabili delle proprie azioni e del proprio agire economico.
La debolezza dei movimenti critici attuali risiede nella loro frammentarietà e nella
loro molteplicità. Nonostante questo venga percepito come una ricchezza culturale
e come possibilità di esprimere la propria individualità all’interno di un gruppo,
l’altra faccia della medaglia mostra come questo renda deboli i movimenti a
livello di incidenza sul sistema globale. Il progetto della Rete di economia solidale
punta proprio nella direzione di mettere insieme le diverse realtà, non per
omologarle, ma perché ogni gruppo, nei vari luoghi, sia in grado di mettere in atto
un modello economico alternativo, partendo dalle risorse e dalle peculiarità del
territorio. Le reti di produttori, consumatori, volontari, attivisti e culture che si
esprimono nei vari movimenti possono essere in grado di realizzare dei laboratori
di decrescita autogovernati.
Gli obiettori della crescita si presentano come cittadini che desiderano partecipare
attivamente alla vita amministrativa ed economica, così come i sostenitori
dell’economia solidale. L’impegno dimostrato da questa parte della popolazione,
sebbene rappresenti una minoranza in un panorama che vede sempre maggior
disinteresse verso la politica, è stato in qualche modo percepito dalle
amministrazioni. La Rete del Nuovo Municipio, nata nel 2002 e sottoscritta da
molti amministratori locali, tenta il seguente passaggio: a partire dalla crescente
domanda di partecipazione dal basso e da un nuovo ruolo delle amministrazioni
locali, oggi più sensibili e attrezzate, diventa possibile stipulare patti locali per lo
sviluppo del territorio, incontri a mezza strada fra amministrazioni locali e
movimenti. La Carta (lo statuto dell’associazione) propone di stipulare patti tra
soggetti diversi, amministratori locali che “si sporgono” verso il sociale e
207
movimenti che si aprono verso l’istituzionale e che, anche con conflitti, si
muovono verso la costruzione di patti e di laboratori costituenti nuovi istituti di
democrazia. “La promozione, da parte del Nuovo municipio, di economie locali
che mettano in valore i beni territoriali e ambientali comuni, che tendano a
chiudere i cicli della riproduzione dell'ambiente e della società locale, che
sviluppino tecnologie e filiere produttive appropriate al luogo e alle sue risorse,
può generare sicurezza comunitaria senza città blindate, competizione sulla
qualità dei prodotti senza guerra, relazioni improntate allo scambio solidale”.33
Il progetto della decrescita è implicitamente anche un progetto di relazioni sociali,
di appropriazione fisica e culturale, di costituzione di significati sociali. La
riscoperta del senso del luogo, ovvero l’osservazione e la partecipazione
all’ambiente che ci circonda, passa anche attraverso la riscoperta dei legami
comunitari. Proprio la globalizzazione fa sì che tutti gli individui vivano in una
forma di interdipendenza, per cui esistono compiti che non possono essere
affrontati individualmente, ma che occorre sostenere collettivamente. E’ qui che
nasce il desiderio di ritrovare la comunità, come possibilità di affrontare
l’incertezza e le sfide comuni. Tale sentimento, per chi sceglie l’economia solidale
e la decrescita, risulta ancora più acuto, perché nella comunità il proprio
comportamento viene supportato e assume caratteristiche più reali e vere.
Tra gli elementi che identificano una comunità, Bagnasco suggerisce l’identità, la
fiducia e la reciprocità E’ possibile trovare questi elementi all’interno delle reti di
economia solidale e nella società proposta dalla decrescita?
L’identità è definita come modo in cui gli individui si pongono all’interno di un
campo simbolico, tracciando confini e limiti per mantenere la differenza tra sé e il
mondo. Individuare un proprio spazio all’interno della società dispersa diventa
molto più difficile: la comunità, come insieme più ristretto e definito di individui
permette di definire meglio il proprio ruolo. Coloro che fanno propria la critica
allo sviluppo, implementando modi di vita differenti da quelli proposti dal
sistema, si prospettano come attori protagonisti di un processo di cambiamento
che li vede attivi in prima persona. La ricerca di un’identità passa attraverso la
33
Carta del Nuovo Municipio (www.nuovomunicipio.org)
208
scelta di consumi e modus vivendi differenti, come risposta all’omologazione
della globalizzazione e come testimonianza dei propri valori morali.
La fiducia rappresenta l’aspettativa di reciprocità nel lungo periodo, aspettativa
positiva derivata dall’esperienza che rende gli individui disponibili a giochi
cooperativi. Questo aspetto è fortemente sentito all’interno dei Gruppi di acquisto
solidale, che creano reti di fiducia con i propri fornitori, così come è determinante
nella formazione di distretti di economia solidale. La fiducia deriva dalla
conoscenza diretta e dalla creazione di rapporti personali che vanno oltre il
semplice rapporto economico, ma si concretizzano nella condivisione di un
progetto e di valori.
L’economia si inserisce nella comunità attraverso il concetto di reciprocità. Il
cuore del sistema economico, infatti, è rappresentato dagli scambi che, in un
contesto di economia di mercato, permettono la soddisfazione di entrambi gli
attori coinvolti, che percepiscono un reciproco vantaggio. Il concetto di
reciprocità, che bene rappresenta gli scambi anche nell’abito del commercio
critico e solidale, contiene però delle sfaccettature diverse. Il termine reciprocità,
infatti, è un concetto ampio e variegato: “Dire vita civile è dire reciprocità” scrive
Bruni (2006), intendendo la vita civile come l’insieme di tutti i comportamenti
che permettono la convivenza e lo sviluppo di una comunità.
Reciprocità può essere intesa, in una prima accezione, come reciprocità cauta: è
la forma tipica dei contratti, ovvero una situazione in cui i soggetti decidono di
accordarsi mettendo a rischio molto poco del loro interesse personale, poiché il
contratto prevede un sistema di enforcement (garantito dalle istituzioni) che tutela
i contraenti. La reciprocità, in questo caso, nasce da un calcolo razionale. E’ la
forma di razionalità ammessa nella teoria economica neoclassica. Essa, infatti,
considera le relazioni di mercato, diverse dalle relazioni personali di amicizia e
conoscenza. Esse si sviluppano sostanzialmente tra persone che non si conoscono,
per cui solo un contratto può far nascere la fiducia e la reputazione. La
cooperazione, in questo contesto, è frutto del mercato, e sono gli scambi a
permettere la nascita di relazioni di reciprocità. Questo tipo di reciprocità è quindi
condizionale, nel senso che non esiste gratuità nelle azioni ma, in assenza di
enforcement, le prestazioni tra due soggetti saranno una la ragione e la condizione
209
per la prestazione dell’altro. Senza incentivi, e al di fuori dei contratti,
difficilmente si mette in atto un comportamento cooperativo, poiché il significato
di relazionalità cauta indica esattamente la scarsa propensione ad attuare la prima
mossa da parte dei soggetti (essi cooperano solo in risposta di un comportamento
cooperativo).
La reciprocità cauta non è in grado di spiegare i comportamenti di consumo
critico che non si basano su calcoli razionali rispetto al proprio interesse, ma che
vedono, invece, nelle relazioni, una componente più importante dello scambio
stesso.
Riprendendo la distinzione di Bruni, è possibile descrivere altri due tipo di
reciprocità: la reciprocità philia e la reciprocità incondizionale.
La condizionalità, anche nel linguaggio comune, sembra essere la caratteristica
tipica della reciprocità: esiste reciprocità, infatti, nel momento in cui la relazione
prevede una restituzione nei confronti di un comportamento precedente. La
reciprocità philia rientra in questa categoria: essa richiama esplicitamente al
concetto di amicizia. La cooperazione nasce da interazioni ripetute, in cui il
soggetto rischia la prima mossa, cooperando, aspettando la disponibilità dell’altro
soggetto a mantenere questo rapporto di “amicizia”. Chiaramente, se il soggetto B
non si dimostra disponibile a cooperare, il rapporto si interrompe. In questo caso
la fiducia non nasce dagli scambi, ma è preesistente: il mercato permette di
verificarla, ma essa nasce in un momento precedente, attraverso una relazione di
conoscenza e di confronto che precede l’aspetto economico. Questo tipo di
reciprocità si adatta bene ai Gruppi di acquisto solidale, in cui lo scambio avviene
con una cerchia di fornitori “amici”, scelti sulla base di determinate caratteristiche
condivise. Al contrario della reciprocità cauta, lo scambio non è anonimo, ma
avviene in un contesto di “amicizia”, in cui le intenzioni (il perché si decide di
cooperare) risultano fondamentali e l’identità dei soggetti fa dell’azione
economica un elemento altamente personalizzato.
Il terzo tipo di reciprocità si slega dalla condizionalità, quasi a sembrare una
contraddizione in termini. Essa si può esprimere anche con il termine gratuità:
l’azione cooperativa, infatti, avviene indipendentemente dai comportamenti altrui,
poiché il valore aggiunto è intrinseco all’azione stessa. Le motivazioni degli altri
210
non contano, poiché la scelta viene effettuata sulla base di convinzioni eticomorali molto forti. La scelta, però, diventa pienamente efficace solo se gli altri
soggetti rispondono con un comportamento reciprocante: la condizionalità non è
nella scelta, quindi, ma nei risultati. Nonostante questo, il soggetto continua ad
applicare il proprio comportamento, anche se non riceve risposte positive, poiché
il valore intrinseco della scelta riesce a compensare i costi. Anche questo tipo di
reciprocità di adatta bene a spiegare i comportamenti dei consumatori critici: le
loro scelte nascono, infatti, da una presa di coscienza che modifica i loro valori. In
questo contesto si può anche spiegare l’importanza, sottolineata più volte, delle
relazioni: i comportamenti, non essendo dettati dal semplice calcolo razionale,
derivano dalla soddisfazione che si riceve dalla relazione stessa, prima ancora che
dalla merce scambiata. E’ così possibile, anche se salta l’ipotesi della
condizionalità, continuare a parlare di reciprocità: essa deriva dalla relazione,
senza la quale il comportamento cooperativo non si mette in atto, neppure nei
soggetti che praticano la gratuità. Bruni, infatti, distingue quest’ultima
dall’altruismo, che è un rapporto incondizionale e non reciproco, poiché per
attuarsi non ha bisogno dell’elemento relazionale e, in quanto tale, può anche
essere impersonale.
L’economia solidale e l’economia della decrescita che, come si è visto sono
strettamente correlate e hanno confini molto labili tra di loro, hanno come oggetto,
più che le merci, i beni. La distinzione, già accennata nel capitolo cinque, riflette
la differenza nella valutazione economica tradizionale: i beni, infatti, hanno valore
perché soddisfano un bisogno, ma la valutazione del loro prezzo di mercato può
risultare difficile o impossibile. In particolare, all’interno di queste economie,
sono i beni relazionali quelli che assumono maggiore rilevanza: sono elementi che
emergono dalle relazioni e che non possono essere consumati né prodotti da un
solo individuo, ma dipendono dalle interazioni con gli altri e possono essere
godute solo nella reciprocità. Essi diventano la principale ricchezza all’interno di
una comunità poiché rappresentano il suo prodotto, e solo all’interno di essa
possono essere ricreati, attraverso la reciprocità.
Nonostante le due forme di reciprocità che meglio si adattano alla comunità e
quindi alle economie solidali siano la reciprocità philia e la reciprocità
211
incondizionale, Bruni sottolinea come la ricchezza di una società stia nella
molteplicità delle reciprocità. “La reciprocità è una, ma le reciprocità sono molte.
[…] Ciò che infatti è tipico in ogni forma di reciprocità è il suo essere un dare che
incontra un ricevere. Per questo la reciprocità è una. Al tempo stesso, le modalità
e le motivazioni sottostanti le reciprocità sono diverse. Le reciprocità sono molte.
[…] Più le forme di reciprocità sono molte e articolate, più aumenta l’eterogeneità
della vita civile, più l’alchimia degli interessi che diventano inconsapevoli alleati
della gratuità può funzionare” (Bruni, 2006).
L’analisi delle varie forme di reciprocità condotta da Bruni mostra che in
un’interazione complessa tra le varie forma di reciprocità, anche quando la
gratuità parte con un vantaggio numerico, è la non cooperazione che tende ad
avere la meglio nel tempo. Sono, infatti, i soggetti che si comportano secondo la
reciprocità cauta e la reciprocità philia a rappresentare l’ago della bilancia e a
equilibrare la situazione; il rischio è, infatti, che, di fronte a troppa gratuità,
aumentino i comportamenti opportunistici non-cooperativi.
Emerge allora la necessità, se si vogliono diffondere le buone pratiche del
commercio critico e della decrescita, di non creare delle reti esclusive e selettive,
ma di mantenere un rapporto aperto di confronto, anche se critico, con il resto
della società che presenta diverse vocazioni e diversi gradi di motivazioni
intrinseche. La logica del “non volersi contaminare”, altrimenti, può essere una
condanna all’estinzione. Attraverso il confronto, invece, è possibile, in primo
luogo informare e, in seconda battuta, attivare i “cooperatori dormienti” che,
sebbene predisposti alla reciprocità, non sono abbastanza “coraggiosi” per
compiere la prima mossa. “I cooperatori del commercio equo [e del commercio
critico], se passano dal confronto ‘faccia a faccia’ con la grande distruzione non
cooperativa […] a un confronto a tre o a quattro dimensioni, possono ottenere
addirittura l’obiettivo che nel mercato ‘normale’ si affermi la reciprocità, e si salvi
anche la loro identità fatta anche di gratuità” (Bruni, 2006).
I movimenti di economie alternative tentano di inserirsi negli spazi abbandonati
dall’economia globale: alla flessibilità e velocità di quest’ultima, essi
antepongono la lentezza dell’economia informale. La decrescita si pone un
obiettivo più ambizioso: occupare anche gli spazi di cui si è impadronito il
212
sistema attuale. L’economia di mercato, infatti, riesce a funzionale al meglio
usando risorse materiali e culturali socialmente prodotte. Sono risorse preziose e a
riproduzione lenta, che l’economia sempre più veloce e onnivora tende a sfruttare
rapidamente senza riprodurle e senza pagare il prezzo di tale uso. La riscoperta del
valore di queste risorse è la chiave per costruire una società della decrescita, in cui
possono coniugarsi libertà e solidarietà.
La limitata diffusione (parlando di numeri) dei movimenti di altra economia,
rappresenta il principale ostacolo alla realizzazione di una società della decrescita.
Per giocare un ruolo importante essa deve essere in grado di offrire opportunità
concrete e deve saper coinvolgere ampie fasce della popolazione. L’esperienza
accumulata dai vari movimenti può essere il punto di partenza: “realizzano già,
qui e ora, il modello immaginato per il futuro” (Guadagnucci, 2007). La
partecipazione diffusa della popolazione alle scelte economiche e sociali del
territorio deve essere il mezzo per raggiungere il cambiamento, attraverso la
diffusione delle buone pratiche di cittadinanza, che poggiano sulla condivisione e
sulla creatività delle persone.
213
BIBLIOGRAFIA
Libri
BAGNASCO A.
1999 Tracce di comunità, Bologna, Il mulino
BAUMAN Z.
2001 Voglia di comunità, Roma, Laterza
2007 Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli
esclusi, Trento, Edizioni Erickson
BECATTINI, G., SFORZI F.
2002 (a cura di) Lezioni sullo sviluppo locale, Torino, Rosenberg & Sellier
BEVILACQUA P.
2001 Miseria dello sviluppo, Roma, Laterza
BONAIUTI M.
2001 La teoria bioeconomica, Roma, Carocci Editore
2005 (a cura di) Obiettivo decrescita, Bologna, Emi
BRESSO M.
1993 Per un’economia ecologia, Roma, La nuova Italia scientifica
BRUNI, L.
2006 Reciprocità. Dinamiche di cooperazione economia e società civile,
Milano, Mondadori
CACCIARI P.
2006 Pensare la decrescita. Sostenibilità ed equità, Napoli, Edizioni Intra
Moenia
DACREMA P
2007 La dittatura del Pil, Venezia, Marsiglio Editore
214
DALY H. E.
1981 Lo stato stazionario: l'economia dell'equilibrio biofisico e della crescita
morale, Firenze, Sansoni
2001 Oltre la crescita: l’economia dello sviluppo sostenibile, Torino, Edizioni
di Comunità
DALY H.E., COBB jr J.B.
1989 Un’economia per il bene comune, Como, Red Edizioni
DEMATTEIS G., GOVERNA F.
2005 (a cura di) Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il modello SLoT,
Milano, Franco Angeli
DERIU M.
2005 Una rivoluzione dell’immaginario, in BONAIUTI M. (a cura di), Obiettivo
decrescita, Bologna, Emi
DI MEGLIO M.
1997 Lo sviluppo senza fondamenti, Trieste, Asterios Editore
ERCOLE E.
2000 I fattori strutturali dello sviluppo locale nella recente riflessione
sociologica, in CICIOTTI E., SPAZIANTE A. (a cura di), Economia,
territorio e istituzioni, Milano, Franco Angeli
FABRIS G.
2003 Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Milano, Franco Angeli
GADREY J., JANY-CATRICE F.
2005 No Pil! Contro la dittatura della ricchezza, Roma, Castelvecchi
GEORGESCU-ROEGEN N.
1982 Energia e Miti economici, Torino, Bollati Boringhieri
2003 (a cura di M. Bonaiuti) Bioeconomia, Torino, Bollati Boringhieri
GUADAGNUCCI L.
2007 Il nuovo mutualismo. Sobrietà, stili di vita ed esperienze di un’altra
società, Milano, Feltrinelli
HIRSCH F.
1981 I limiti sociali dello sviluppo, Milano, Bompiani
215
LATOUCHE S.
2006 Come sopravvivere allo sviluppo, Torino, Bollati Boringhieri
2007 La scommessa della decrescita, Milano, Feltrinelli
2008 Breve trattato sulla decrescita serena, Torino, Bollati Boringhieri
LAVILLE J.-L.
1998 L’economia solidale, Torino, Bollati Boringhieri
LEONINI L., SASSATELLI R.
2008 (a cura di) Il consumo critico, Roma, Laterza
MAGNAGHI A.
1990 Per una nuova carta urbanistica, in MAGNAGHI A. (a cura di), Il
territorio dell’abitare, Milano, Franco Angeli
2000 Il progetto locale, Torino, Bollati Boringhieri
MANDER J., GOLDSMITH E.
1998 (a cura di) Glocalismo, Bologna, Arianna Editrice
MEADOWS D. H.
1972 (a cura di) I limiti dello sviluppo. Rapporto del System dynamics group
Massachusetts Institute of Technology (MIT) per il progetto del Club di
Roma sui dilemmi dell’umanità, Milano, Edizioni scientifiche e tecniche
Mondadori
OSTI G.
2006 I nuovi asceti. Consumatori, imprese e istituzioni di fronte alla crisi
ambientale, Bologna, Il Mulino
PALLANTE M.
2004 Un futuro senza luce? Come evitare i black out senza costruire nuove
centrali, Roma, Editori Riuniti
2005 La decrescita felice. La qualità della vita non dipende dal Pil, Roma,
Editori Riuniti
2007
Discorso sulla decrescita, Roma, Luca Sossella Editore
RAY, D
1998 Development Economics, Princeton, Princeton University Press
216
RIST G.
1996 Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, Torino, Bollati
Boringhieri
RITZER G.
2000 La religione dei consumi, Bologna, Il Mulino
ROSTOW W.
1962 Gli stadi dello sviluppo economico, Torino, Einaudi
STIGLITZ J. E.
2002 La globalizzazione e i suoi oppositori, Torino, Einaudi
2006 La globalizzazione che funziona, Torino, Einaudi
VALERA L.
2005 Gas. Gruppi di Acquisto Solidali, Milano, Terre di Mezzo
VOLPI F.
1994 Introduzione all’economia dello sviluppo, Milano, Franco Angeli
2003 Lezioni di economia dello sviluppo, Milano, Franco Angeli
UNDP
1991 Rapporto sullo sviluppo umano n. 2, Torino, Rosenberg & Sellier
WCED
1988 Il futuro di tutti noi. Rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente
e lo sviluppo, Milano, Bompiani
217
Articoli
Ariès P., La décroissance, un mot-obus, La dècroissance, Aprile 2005
Bonaiuti M:, Immaginare un’economia altra: Rete e Distretti di Economia
Solidale, Eupolis, 2006
Bonaiuti M., Decrescita e Politica, Per una società autonoma, equa e sostenibile,
www.decrescita.it, Maggio 2008
Cheynet V., Engager une politique de décroissance, www.decroissance.org,
Agosto 2005
Cianciullo A, Da domani la Terra è in rosso: “Le risorse dell’anno esaurite”,
Repubblica, 22 settembre 2008
Clémentin B., Cheynet V., La décroissance soutenable, www.decroissance.org
Daly H., Che cos’è lo sviluppo sostenibile, Lettera Internazionale, Anno XXIII, n.
92, 2007, pagg. 20-24
Harribey J.-M., Una contraddizione irrisolvibile, Le Monde Diplomatique,
dicembre 2002
Latouche S., Sviluppo, una parola da cancellare, Le Monde Diplomatique,
maggio 2001
Latouche S., Costruire la decrescita, CSN-Ecologia Politica, n. 1-2, gennaiogiugno 2004
Latouche S., Manifesto del dopo sviluppo, novembre 2005, www.decrescita.it
Latouche S., Ecofascismo o eco democrazia, Le Monde Diplomatique, novembre
2005
Latouche S., Abbasso lo sviluppo sostenibile! Evviva la decrescita conviviale!,
www.decrescita.it, aprile 2007
Magnaghi A., Dai comuni polvere alle reti di municipi, Communitas, n.3/4,
giugno 2005, Milano
Moretti G:, Bioregioni. La consapevolezza di abitare un luogo di relazioni,
www.decrescita.it, settembre 2008
Pallante M., Le virtù della sobrietà, www.decrescita.it, maggio 2007
218
Documenti
H. S. Truman, Inaugural address, 20 gennaio 1949, in Documents on American
Foreign Relations, Princeton University Press, Connecticut 1967
N. Georgescu-Roegen, La legge di entropia e il problema economico, conferenza
tenuta il 3 dicembre 1970 al Department of Economics, University of
Alabama
Forum Permanente del Terzo Settore, Oltre la crescita, alla ricerca di un nuovo
paradigma economico e sociale, 18 settembre 2005, Pordenone
Conferenza sulla Decrescita Economica per la Sostenibilità Ecologica e l’Equità
Sociale, Dichiarazione sulla decrescita, 18 e 19 aprile 2008, Parigi,
www.decrescita.it
Gruppo di lavoro tematico “Impronta Ecologica e Sociale” della Rete di Lilliput,
Atti del Seminario” Strategie di rete per l’economia solidale”, 19
novembre 2002, Verona
Progetto Res, Documento programmatico della Rete di Economia Solidale, 10
dicembre 2005, www.recosol.org
Rete italiana di economia solidale, Carta per la Rete Italiana di economia
solidale, Marzo 2007, www.recosol.org
Des, 2004, Incontro sui Distretti di Economia Solidale, 21 novembre 2004, Ca’
Fornaletti
Des 2006, Percorsi di Economia Solidale. Criticità e potenzialità delle esperienze
in atto, 11 marzo 2006, Roma
Des 2008, Sintesi assemblea Des 2008, 7 giugno 2008, Verona
Distretto di economia solidale Torino e provincia, Carta dei principi, 10
settembre 2003, www.recosol.org
Documento base dei Gas, I gruppo di acquisti solidale. Un modo diverso di fare
la spesa, Luglio 1999, www.retegas.org
Relazione di A. MAGNAGHI, I Gruppi di acquisto solidale nel progetto locale,
Convegno dei Gas, 12 maggio 2002, Marzabotto, Bologna
219
Campagna Bilanci di giustizia, Rapporto annuale 2006, Sedere sulla spiaggia,
sonnecchiare al sole e contemplare l’orizzonte, www.bilancidigiustizia.it
Campagna Bilanci di Giustizia, Rapporto 2007, La rivoluzione dei consumi e del
lavoro, www.bilancidigiustizia.it
Carta del Nuovo Municipio, Per una globalizzazione dal basso, solidale e non
gerarchica, www.nuovomunicipio.org
Siti internet
www.altreconomia.it
www.bilancidigiustizia.it
www.cambieresti.net
www.carta.org
www.comunisolidali.org
www.decrescita.it
www.decrescitafelice.it
www.decroissance.org
www.depiliamoci.it
www.ecologiapolitica.it
www.monde-diplomatique.it
www.nuovomunicipio.org
www.recosol.org
www.repubblica.it
www.retegas.org
www.retelilliput.org
www.sbilanciamoci.org
220
Ringraziamenti
Ringrazio il relatore prof. Carlo Salone e la correlatrice prof.ssa Anna Cugno per
le loro consulenze e i loro suggerimenti. Ringrazio la mia famiglia e Serafino che
mi hanno permesso di arrivare fino a questo lavoro; un ringraziamento
particolare a Caterina per il “supporto tecnico”. Ringrazio tutti gli amici di
questi anni d’università, in particolare Marco, per le preziose conversazioni e
Lorenzo, per il tempo trascorso insieme. Infine, un ringraziamento a tutti gli
amici e le persone che mi hanno fornito stimoli interessanti per questo lavoro e
che mi sono state accanto.
221