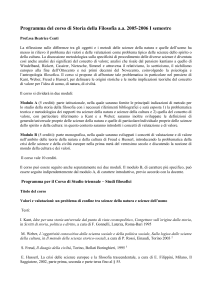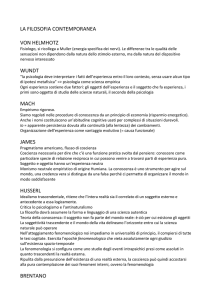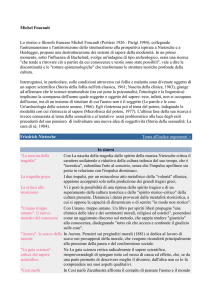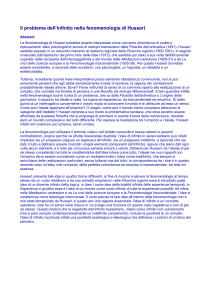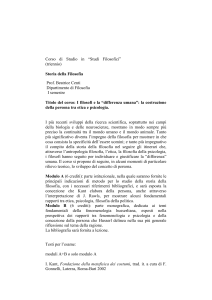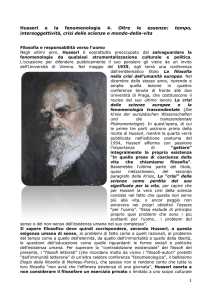Paolo D’Alessandro
IL MONDO DEI FENOMENI
E LA LORO INTERPRETAZIONE
Libreria Cuem
Milano 2004
2
INDICE
INTRODUZIONE
P.
5
P.
13
P
45
[1, P. 5; 2, P. 6; 3, P. 7; 4, P. 8; 5, P. 10]
PARTE PRIMA
CARTESIO
[1, P. 13; 2, P. 14; 3, P. 17; 4, P. 19; 5, P. 20;
6, P. 21; 7, P. 24; 8, P. 26; 9, P. 29; 10, P.
31; 11, P. 34; 12, P. 36; 13, P. 41]
KANT, I
[1, P. 45; 2, P. 47; 3, P. 49; 4, P. 51; 5, P.
55; 6, P. 56; 7, P. 59]
KANT, II
P.
63
P.
85
[1, P. 63; 2, P. 66; 3, P. 68; 4, P. 69; 5, P.
71; 6, P. 74; 7, P. 77; 8, P. 80]
PARTE SECONDA
HUSSERL, I
[1, P. 85; 2, P. 86; 3, P. 89; 4, P. 93; 5, P.
95; 6, P. 96; 7, P. 98; 8, P. 101; 9, P. 104;
10, P. 108; 11, P. 110]
3
HUSSERL, II
P.
113
[1, P. 113; 2, P. 115; 3, P. 118; 4, P. 121; 5, P.
123; 6, P. 126; 7, P. 128; 8, P. 130; 9, P.
132; 10, P. 135]
PARTE TERZA
HEIDEGGER, I
P.
139
P.
163
[1, P. 139; 2, P. 140; 3, P. 143; 4, P. 147; 5,
P. 149; 6, P. 150; 7, P. 154; 8, P. 156; 9, P.
159]
HEIDEGGER, II
[1, P. 163; 2, P. 165; 3, P. 165; 4, P. 167; 5,
P. 168; 6, P. 171; 7, P. 174; 8, P. 177; 9, P.
179; 10, P. 182; 11, P. 187; 12, P. 189]
4
INTRODUZIONE
1
Quando ci si chiede in che modo si arrivi a comprendere e a spiegare quel che si ha sott’occhio, si approda a considerazioni e conclusioni alle volte ben distanti le une dalle altre.
Nelle nostre pratiche quotidiane si fa continuamente esperienza di eventi e di accadimenti: in ciò consiste indubbiamente l’essenza della nostra vita, dell’inessere storico. Con espressione filosoficamente più appropriata potremmo forse dire che si fa esperienza
della realtà fenomenica.
Si fa esperienza del mondo dei fenomeni, successivamente si comunica ad altri (e a se stessi con gli altri e forse prima che agli altri) quello di cui si fa esperienza. Secondo una tradizione filosofica che risale ad
Aristotele, l’uomo, infatti, è zoon logon echon, un animale che parla di continuo, e che nel linguaggio pertanto può giustamente riconosce la sua stessa essenza.
Per il tramite dell’oralità come anche della scrittura si dice tutto quello che viene sperimentato. Ci si
chiede allora, ed è questo il punto di svolta del far filosofia, quel “luogo” nel quale sorge la domanda teoretica
circa la vita, che semplicemente e ingenuamente si vive,
quale sia l’esperienza che la coscienza va facendo durante il suo naturale processo vitale.
La risposta, dunque, dev’essere detta, affidata di
necessità a un linguaggio, sempre sottoposto poi a un
atto di comprensione. Questo sta a significare che quel
5
che è detto, il dire esplicito in qualsiasi modo venga
detto, non possiede di per sé alcun senso, se questo
non venga decodificato mediante specifico processo di
lettura.
2
È indubbio dunque che si faccia esperienza del
mondo dei fenomeni, ma cos’è un fenomeno? Dal greco
phainomai (manifestare e mostrare), che contiene nella
sua radice il termine phos (luce), fenomeno sta a indicare “quel che viene alla luce, nell’evidenza”.
Notiamo qui la differenza tra le due espressioni,
che sembrano voler dire lo stesso: “quel che ci appare”
e “quel che si manifesta”. Nella prima il “fenomeno”
sembra essere oggetto, perché siamo in fondo noi
stessi a vederlo, siamo noi che prendiamo atto del suo
venire alla luce; nella seconda invece sembra essere
soggetto, in quanto è sua l’iniziativa di rivelarsi a noi.
Tra le diverse realtà fenomeniche la scrittura (o
forse sarebbe meglio dire le scritture) è quella che
permette il sapere e, più in generale, la conoscenza.
Con il medium della scrittura, infatti, crediamo di poter
rispondere all’interrogativo “come si pensa?” e ancora:
“cosa si arriva a conoscere?”, marcando orizzonti e limiti del nostro pensiero, con impostazione di problematiche di marca gnoseologica ed epistemologica.
Cosa si conosce? Con tale interrogativo si sottintende che si possano conoscere delle cose, ma, chiediamoci, cos’è un “cosa”? Qual è, direbbero i medievali,
la sua quidditas? È fuor di dubbio che si diano delle co-
6
se, ma esistono forse anche delle cose, al di qua e al di
fuori del loro darsi a noi e tali che siano arriviamo a
conoscerle, crediamo di poterle conoscere?
Problemi gnoseo-epistemologici si confondono così
o sfociano in una problematica ontologica, circa l’essere
stesso di quelle “cose” che risultano essere oggetto di
conoscenza.
3
Sin dai suoi esordi la filosofia si è indirizzata al
mondo fenomenico. Anzi, il far filosofia può senz’altro
essere fatto coincidere proprio con una considerazione
originaria, che concerne il mondo dei fenomeni. Nel Teeteto, a esempio, Platone discute la teoria gnoseologica
di Protagora, secondo il quale la conoscenza si risolve in
toto nella sensazione. Si conosce mediante sensi e sentimenti; ogni cosa, dunque, è sempre e soltanto per quel
che appare, tale qual è sentita e percepita.
Questo è il pensiero manifesto di Protagora, che
riduce così la cosa alla sua apparenza sensibile. Il suo
pensiero esoterico, invece, quella dottrina nascosta,
che sottende quella esplicita e alla quale si è indirizzati, è da individuare nella coincidenza dell’essere della
cosa con il suo apparire. In fondo Protagora dice che
nessuna cosa potrà mai essere colta nel tempo come
identica a se stessa, perché sarà sempre e continuamente cangiante, a seconda delle prospettive e dei
“luoghi” spazio-temporali in cui è percepita: “niente mai
è, ma sempre diviene”1.
7
La conoscenza andrebbe dunque a rispecchiare il
divenire delle cose, sarebbe tutt’una con il loro puro
apparire. A questo punto, però, l’approfondimento delle
stesse “apparenze”, che brulicano nei soggetti senzienti e percipienti, mostra la loro contraddittorietà. Contro la tesi di Protagora, Platone intende pertanto provare come la sensazione non possa generare vera conoscenza, perché questa risiederebbe soltanto nell’opinione (doxa), che sia opportunamente sostenuta dal discorso (logos).
4
Non siamo tanto interessati qui a questo punto di
svolta in Platone, che successivamente articolerà il logos con la dialettica, permettendo così la nascita del
pensiero filosofico in Occidente. Piuttosto che il punto
di arrivo di questa discussione a distanza con Protagora, interessa un breve inciso, che si apre a questo punto del dialogo: “certo tu mi segui Teeteto, non è vero?
Né mi sembra che tu sia nuovo a siffatte argomentazioni. In verità Socrate io sono straordinariamente meravigliato […] di quel che siano queste apparenze”1.
Il giovane interlocutore di Socrate, si badi bene,
non è qui preoccupato tanto di chiarire il problema teorico relativo alla conoscenza, ma si rende testimone di
una situazione particolare di tipo emozionale, che è costretto a subire: quella di “straordinaria meraviglia”,
provocata da percezioni e sensazioni di fronte alle ap1
1
Teeteto, 152e
Ivi, 155c
8
parenze delle cose. Prosegue, poi, dicendo: “talora, se
mi ci fisso a guardare, realmente ho le vertigini”1.
Quando pertanto si pone attenzione, con sguardo
più accorto, a quel qualcosa che provoca stupore non
solo non viene meno lo status particolare in cui ci si è
venuti a trovare, ma anzi se ne accentuano i caratteri
più specificamente estranianti. L’osservare con maggiore attenzione quel che appare fa cadere il soggetto in
preda a vertigini, addirittura perciò con totale sconvolgimento dell’equilibrio psico-fisico: da una parte subendo il turbamento della sensibilità, con la sensazione di
spostamento dell’ambiente circostante e/o del proprio
corpo in esso (con l’effetto del capogiro), e dall’altra
avendo le traveggole, vale a dire la perdita momentanea
del proprio equilibrio psichico in seguito a turbamento
dell’animo. Proprio di questo si tratta quando si parla di
“vertigine”!
Tutto ciò accade in seguito al “rispecchiamento”
senza alcun mascheramento (si legga: “razionalizzazione”) e senza pertanto alcuna difesa, della percezione
del divenire, del fluire della realtà delle cose, senza
quei punti fermi, che possano costituire valide certezze: è quel che appare dell’essere delle cose delle quali
si fa esperienza.
Alla dichiarazione di Teeteto, relativa allo stupore (thaumazein) prima e alle vertigini (skotodinio), poi,
Socrate risponde che “è proprio del filosofo quello che
1
Ivi, 155d
9
tu provi, di esser pieno di meraviglia. Né altro cominciamento (arché) ha il filosofare che questo”1.
L’interlocutore di Socrate, dunque, non sembra
costituire un caso patologico, poiché la sua natura e, di
conseguenza, le sue reazioni emotive sono in perfetta
consonanza con l’essenza stessa di colui che fa filosofia. Ci si affretta ad aggiungere che il thaumazein non
solo è una caratteristica del pensiero, ma che di esso è
addirittura l’arché, principio e fondamento, l’unico fondamento.
Socrate, e Platone con lui, sta qui sostenendo che
l’inizio di ogni sapere risiede nel provar stupore dinanzi
alle sensazioni, meglio forse dire dinanzi allo sguardo
più accorto che considera il divenire delle cose. Solo a
partire dal complesso status emotivo del provar stupore e vertigini allo stesso tempo, l’uomo è messo così
nelle condizioni di pensare: sta nascendo il filosofo, che
solo in un secondo momento, come insegna il Sofista,
diverrà dialettico.
5
Prima ancora di qualunque esercizio del pensiero
stesso, del darsi e del costituirsi di qualunque logos, si
dà uno stato emotivo rispetto a quel che appare; meglio
ancora: esso sembra provocato dalle modalità stesse
con cui la realtà fenomenica si manifesta. Il come delle
apparenze si caratterizza mediante il divenire, vale a
dire il non essere. Si ricordi qui che si è chiesto cosa
sia una cosa, l’oggetto di conoscenza, marcando così il
1
Ibidem
10
passaggio dal problema gnoseologico ed epistemologico
a quello ontologico. La risposta che sembra ora venir
fuori dal “luogo” dell’arché del far filosofia è che la cosa non ha di per sé un proprio essere: essa, infatti, è
tra l’essere e il non essere, perché diviene.
Di qui hanno origine stupore e vertigini.
Nell’Analitica esistenziale, lo si vedrà, Heidegger parla
della “tonalità emotiva” dell’Angst. Di fronte a che si
prova angoscia, piuttosto che paura (Furcht)? Si risponde: di fronte al niente, all’assenza di un ente specifico e determinato.
L’arché del pensiero, il “cominciamento” della filosofia accade quando si è presi, in uno stato ekstatico
da questa tonalità emotiva o emozione fondamentale e
originaria (Grundstimmung). Si tratta della reazione alle “apparenze” (a quel che appare), ai fenomeni, vale a
dire a quel che si manifesta, per come si manifesta, per
(il) che si manifesta e per il fatto stesso che si manifesta.
11
PARTE PRIMA. CARTESIO
1
L’incipit della teoretica risiede, pertanto, in un
turbamento al cospetto della realtà del mondo, del
semplice apparire delle cose del mondo. Dunque il mondo, nel suo complesso, così come anche nei suoi elementi componenti e interagenti, risulta problematico, se
non addirittura misterioso per noi che lo viviamo e che
proviamo a conoscerlo. Risulta essere tale, proprio per
il fatto che esso non viene mai recepito e percepito, in
toto o per partes, in modo immediato, ma sembra sempre offrire resistenze e ostacoli alla nostra piena comprensione.
La riflessione teoretica ha da cimentarsi con il
fenomeno, così come ha il compito di affrontare il problema stesso che le s’impone nel suo stesso “cominciamento”, legato alla pura e semplice percezione della realtà. Oggi intendiamo affrontare proprio tale questione. Dobbiamo scegliere un punto di vista, da privilegiare, un “luogo” ideale che possa fungere da osservatorio.
Piuttosto che quello proprio dei Dialoghi di Platone, da
cui pure hanno avuto origine le nostre riflessioni, pensiamo sia opportuno privilegiare il topos teoretico dell’opera di Cartesio, a buon diritto riconosciuto universalmente come “padre” del pensiero moderno e contemporaneo.
A Cartesio si deve tutta la grandezza del pensiero
dell’Occidente, come anche la sua miseria, a motivo di
opzioni teoretiche ben precise, di ambiguità, contrad-
13
dizioni ed errori di valutazione o di prospettiva. Uno su
tutti e per tutti: il fondamentale e arcinoto dualismo,
con la distinzione di res cogitans da res extensa e con
tutte le conseguenze che ne sono derivate sia per le
scienze, sia per la stessa filosofia, conseguenze che
hanno un indubbio riscontro negativo anche nel cosiddetto “buon senso comune”.
2
Di Cartesio si leggeranno passi scelti dal Discorso
sul metodo e dalle Meditationes.
Filosofo e scienziato al tempo stesso, dapprima
nei suoi studi fa esperienza del pensiero della tradizione, di orientamento scolastico tomistico, che condizionerà successivamente, per contrasto, l’intera sua attività teoretica. Rifiuta il verbalismo della scolastica, in
favore della ricerca di un sapere fondato sul modello
della conoscenza matematica, con l’ambizione di pervenire a una sintesi filosofica che fornisse un quadro sistematico altrettanto valido e definitivo, anche le
scienze.
Il Discorso (1637) è lo scritto più famoso di Cartesio e rappresenta i fondamenti della metafisica, espressi sotto un profilo autobiografico, dal momento
che egli dichiara di voler delineare una “storia del mio
spirito”. Scritto in lingua francese, il testo è a carattere divulgativo dal momento che a quel tempo la lingua
colta e scientifica era quella latina. Le Meditationes de
prima philosophia (1640) costituiscono la stesura più
ampia e in certo qual modo definitiva del pensiero car-
14
tesiano. Il testo circola tra i teologi e i filosofi più famosi del tempo (Gassendi, Hobbes, Mersenne, i teologi
della Sorbona, i gesuiti, ecc.), i quali inviano obiezioni,
cui Cartesio s’impegna a rispondere. Il Discorso, dunque, trova il suo naturale completamento nelle Meditationes, incentrate sui grandi temi di Dio, dell’anima, del
mondo e della verità.
Nella prima parte del Discorso si sostiene la tesi
che ragione e buon senso per natura sono comuni a tutti gli uomini, indistintamente; ma allora il fatto che opinioni, idee e pensieri siano diversi non sarebbe dovuto a
maggiore o minore ragionevolezza, ma piuttosto al fatto che sono i pensieri indirizzati su itinerari diversi e,
poi, anche al fatto che non si considerano sempre le
medesime cose. Inoltre, il motivo della diversità di giudizio risiede nel fatto che non applichiamo la ragione
allo stesso modo e con le medesime modalità di ricerca.
Lo scritto è un vero e proprio quadro della propria
vita, caratterizzata da studi diversi e da numerosi
viaggi. Prima di entrare nel vivo delle questioni teoretiche, altra considerazione importante risiede in una
puntualizzazione, rivelatrice delle peculiari modalità
con cui in seguito Cartesio vorrà accingersi all’indagine
teoretica. Si sostiene che la filosofia, seppure coltivata dai migliori intelletti di ogni tempo, non offre garanzie di verità, poiché “diverse opinioni possono essere
sostenute da persone anche dotte, circa uno stesso argomento”. Dal momento, poi, che le scienze attingono
proprio dalla filosofia i loro stessi principi, sui fondamenti malfermi della filosofia non è proprio possibile
15
edificare qualcosa di stabile e di duraturo. “Ecco perché, conclude Cartesio, appena l’età mi permise di uscire dalla tela dei miei predecessori, abbandonai interamente lo studio e risolsi di non cercare altra scienza al
di fuori di quelle che potevo trovare in me stesso o nel
gran libro del mondo”1.
La ricerca che viene intrapresa, perciò, è tesa a
conoscere il mondo, vale a dire a compiere lo studio
della natura fisica delle cose, come anche a conoscere
se stessi, la natura dell’uomo, da intendere anzitutto
quale “fatto naturale”. Allo scopo di perseguire al meglio tali intenti Cartesio intraprende viaggi per tutta
Europa, compiendo varie esperienze, le quali si rivelano
però deludenti e poco rassicuranti: la disparità di vedute tra uomini comuni è infatti la medesima riscontrata
tra le opinioni dei filosofi.
A conclusione della prima parte del Discorso, si
trova scritto: “dopo aver così impegnato alcuni anni a
studiare nel libro del mondo e a farne esperienza, presi
un giorno la risoluzione di studiare anche me stesso e
d’impegnare tutte le forze del mio ingegno a scegliere
il cammino da seguire”2. Messo da parte lo studio della
natura delle cose del mondo, si porta l’indagine unicamente sulla natura umana, passando così dall’”esterno”
all’”interno”. Tutte le forze sono poi tese a individuare
il cammino da seguire, vale a dire il metodo.
1
2
Cartesio, Discorso sul metodo, I, Bari, Laterza, p. 8.
Ivi, p. 9.
16
3
Si apre qui una parentesi, per noi interessante,
circa la modalità della ricerca su se stesso, che è da
condurre in solitudine pressoché totale. Per giustificare tale scelta egli racconta come un giorno del 1619 si
trovasse in Germania, tutto solo con i propri pensieri.
D’improvviso lo sorprende un pensiero in particolare,
che induce a riflettere sulla situazione di solitudine
che sta vivendo e sui motivi per i quali essa è senz’altro
da privilegiare: “non vi è quasi mai tanta perfezione
nelle opere composte di pezzi fatti da artefici diversi,
quanta in quelle costruite da uno solo. Gli edifici, a esempio, cominciati e condotti a termine da un solo architetto, di solito, sono più belli e meglio ordinati di
quelli che sono stati riadattati più volte servendosi di
vecchi muri tirati su per tutt’altro scopo”1.
Il motivo del privilegiamento dell’opera e del pensiero di uno solo è precisato subito dopo: le opere del
medesimo individuo, di norma almeno, tendono al medesimo scopo, dal momento che la causa finalis dà unità e
omogeneità al pensiero. Si sposta poi il ragionamento,
per analogia, prima sulle scienze e poi sulla filosofia. Se
fin da ragazzi, a scuola, piuttosto che essere affidati a
diversi precettori, che troppo spesso danno indicazioni
e giudizi contrastanti e contraddittori (tot capita, tot
sententiae), avessimo potuto esercitare appieno la ragione e fossimo stati guidati unicamente da essa, avremmo avuto un solo maestro e dunque saremmo pervenuti senza alcun dubbio a giudizi validi.
1
Ivi, p. 10.
17
Anche in questo caso si prospetta l’esercizio in
solitudine della propria ragione, avendo eliminato qualsiasi elemento estraneo al proprio sé: “per la scoperta
di verità un po’ difficili la maggioranza dei consensi vale
poco o nulla, perché è più facile che le scopra un uomo
solo che non tutto un popolo. Per queste ragioni, dunque, io non sapevo scegliere nessuno le cui opinioni mi
sembrassero preferibili a quelle degli altri, e mi trovai,
si può dire, costretto a cercare di guidarmi da me
stesso”1, con l’aiuto pertanto della sola ragione.
Qui Cartesio sembra sostenere che la verità non
è mai democratica, popolare o appannaggio del senso
comune; vale a dire non è affatto vero che si possa
stabilire una verità, un giudizio vero, appoggiandosi al
pensiero dei più, relativamente a un problema, a un argomento o a un’idea. È più facile, infine, che possa conseguire la verità un individuo in perfetta solitudine, solo con se stesso, piuttosto che un intero popolo, nel
senso di tanti individui assieme e concordi.2
1
Ivi, p. 13.
Cartesio naturalmente non è vissuto in un’epoca di sondaggi com’è
la nostra, eppure sembra prevederla, stigmatizzandola. Tramite indagini “di mercato”, a esempio, si crede di poter stabilire cosa pensi
(come sia incline a pensare) la gente su un determinato argomento
(o su un prodotto). A indagine conclusa, si perverrà a un’opinione
comune, che collima con una specie di media ponderata delle varie
risposte ottenute. Non si perverrà invece alla verità relativa al
prodotto o all’argomento sottoposto a indagine. Insomma, giungere
a stabilire cosa pensi la maggioranza delle persone appartenenti a
una comunità non significa conseguire l’obiettivo della ricerca
scientifica e filosofica, che risiede, a detta di Cartesio, nella verità.
2
18
4
Nell’intento di conseguire il proprio obiettivo,
Cartesio si allontana dai luoghi in cui ha conoscenti e si
ritira in Olanda, dove per tra la “folla di una popolazione attivissima intenta ai propri affari e non curiosa di
quelli degli altri”, vive solitario e tranquillo quanto nei
deserti più remoti.
Vediamo come procede allora nella sua ricerca. In
un primo momento non ripudia d’un tratto tutte le opinioni che si sono insinuate, volente o nolente, nella sua
mente senza alcun vaglio critico da parte della ragione,
ma prende tempo per arrivare a tracciare prima il disegno generale dell’opera nuova o del nuovo pensiero,
che va elaborando. L’intento è soprattutto quello di
cercare un vero ed efficace metodo da seguire nella
ricerca. Degli studi compiuti in precedenza si salva, in
parte, solo la logica, anche se è la scienza che serve
per spiegare quel che si sa già. Con essa non s’impara
nulla di nuovo, e dunque non si perviene ad alcuna verità1.
Cartesio cerca allora un altro metodo, che riesca
a evitare i difetti di logica, di geometria e di algebra,
le scienze “esatte”, un metodo che tenga presenti però
alcune regole logiche fondamentali:
1.
accogliere come verità soltanto quel che si arriva
a conoscere con evidenza e ammettere nei propri
giudizi quello che si presenta al nostro intelletto
1
Non è a caso che Heidegger sosterrà drasticamente che “la scienza non pensa”, anticipato in questo giudizio perentorio da Kant, come avremo modo di vedere.
19
2.
in modo chiaro e distinto, escludendo così ogni
possibilità di dubbio;
dividere ogni problema in parti minori, mediante
analisi dello stesso;
3.
condurre i pensieri con ordine, cominciando dai più
semplici, per passare poi ai più complessi;
fare enumerazioni complete e revisioni generali,
giungendo così a una sintesi finale.
Tale metodo sembra essere il più sicuro, perché
permette di servirsi della ragione nel modo migliore
possibile. Il metodo del sapere logico-matematico, in
fondo, rivisitato ad hoc viene assunto come filosofico; i
principi della filosofia, poi, creano il presupposto e il
fondamento per tutte le scienze.
4.
5
La terza parte del Discorso tratta della “morale
provvisoria”, con la quale si indicano regole di comportamento da seguire in un tempo di vera e propria transizione. Insomma, prima di arrivare a smantellare la filosofia scolastica bisogna ben organizzare un pensiero
nuovo. Nel frattempo, però, non si può rimanere privi
del tutto di indicazioni, tese a orientarci nell’agire; si
tratta di sottostare, appunto, a una morale provvisoria:
a) obbedire alle leggi e alle consuetudini del Paese in
cui si vive; b) rimanere fermi e risoluti nelle proprie azioni, seguendo anche le opinioni più dubbie; c) voler
modificare se stessi e i propri desideri, piuttosto che
le cose del mondo, perché nulla è interamente in nostro
potere all’infuori dei nostri pensieri.
20
Assicurato da tali massime morali, che vengono
tenute da parte, assieme alle verità delle fede, mai
messe in discussione perché non sottostanno al vaglio
della ragione, Cartesio comincia a disfarsi di tutte le
proprie opinioni.
Come testimoniano le Meditationes, egli cerca la
verità nel dialogo con gli uomini colti del suo tempo, durante i numerosi viaggi, che compie tra il 1619 e il 1628.
Contro le opinioni correnti egli attiva il dubbio sistematico, che sembra differire da quello degli scettici, che
dubitano quasi per il gusto di dubitare. Non è infatti
fine a se stesso, ma costruttivo, proposto in modo universale e generalizzato, al solo fine di conseguire una
certezza. Non si propone, dunque, in atteggiamento nichilistico, per distruggere ogni proposizione sedicente
vera, ma intende pervenire a un pensare in positivo, dopo aver negato la certezza di tutte le opinioni correnti.
Il metodo nuovo consiste nel porre in dubbio, pertanto, le opinioni proprie ed altrui, non intendendo più
accettare acriticamente le auctoritates, così come si
faceva comunemente nell’ambito della filosofia scolastica. Tale metodo sembra funzionare bene, in quanto
si distruggono le opinioni non fondate e si arriva a prestare attenzione a esperienze utili, che costruiscono
opinioni più probanti e più sicure.
6
La quarta parte del Discorso è decisiva per
l’economia dell’opera. Dopo aver seguito, almeno in un
primo tempo, la seconda massima della morale provviso-
21
ria, che imponeva la regola di rimaner fermi nelle proprie azioni accettando anche le opinioni più dubbie,
Cartesio decide ora di operare ben diversamente, con
una svolta che lo fa agire in modo esattamente contrario, con il rigetto di tutte le opinioni dubbie: “rigettare
come interamente falso tutto ciò in cui potessi immaginare il menomo dubbio, per vedere se, così facendo, alla fine, restasse qualcosa nella mia credenza di assolutamente indubitabile”1.
Si noti qui come, a conferma di quanto proposto in
precedenza e del convincimento circa la verità che può
essere conseguita tramite ragione più facilmente dal
singolo individuo, Cartesio tenda a creare, attorno alla
propria attività di ricerca teoretica una specie di “terra bruciata”. Egli fa il vuoto, rifiutando qualsiasi opinione, presente o passata, e arrivando a pensare o a credere di poter pensare, nello status di perfetta solitudine. Com’è che si perviene in tale stato? Come si riesce a fare il “vuoto” attorno a sé e in sé? Come ci si
isola dal mondo?
Si pongono sotto osservazione prima e in stato
d’accusa poi i propri sensi: “poiché i nostri sensi talvolta ci ingannano, volli supporre non esserci nessuna cosa
che fosse quale essi ce la fanno immaginare”2. Si ricordi qui che per parte nostra ci stiamo chiedendo cosa
sia la cosa (evento o accadimento), che si dà alla nostra
conoscenza.
1
2
Cartesio, Discorso, I, p. 23.
Ibidem
22
Cartesio sembra rispondere che la “cosa” è inesistente, almeno rispetto alle rappresentazioni che ci si
propongono di volta in volta. Pertanto il sensorio, mediante percezioni e sensazioni, offre a noi soltanto
un’apparenza della realtà, che consiste nei “fenomeni”,
inducendo così a falsi ragionamenti, mai a vere e proprie dimostrazioni. Il “falso ragionamento” consiste nel
fatto che si stabilisca in modo indebito la corrispondenza di un quid con quel che è l’apparenza immaginifica
prodotta dal sensorio. Viene così messo in stato
d’accusa l’apparato sensoriale, che crea di primo acchito un collegamento col mondo. In conclusione, la verità
non proviene affatto dai sensi1.
Si va poi ben oltre questa prima e importante osservazione: gli stessi pensieri devono essere presi in
considerazione soltanto in forma dubitativa. Come lo si
dimostra? Il ragionamento proposto è semplice. Gli
stessi pensieri, presenti nella mente in stato di veglia,
possono aversi anche durante il sonno. Anzi, altrove
viene detto che alle volte i pensieri del dormiente sono
addirittura più vivi e manifestano maggiore senso di
realtà rispetto a quelli che si hanno nello stato di veglia. Ora è di tutta evidenza che i pensieri di colui che
sogna non abbiano alcuna realtà, perché parto di fantasia e d’immaginazione da parte del sognatore, ma allora,
almeno in un primo tempo e per finzione, si può arrivare
a concludere “che tutto quanto è entrato nel mio spiri1
Si ricorderà qui opportunamente come questa sia la medesima conclusione cui perviene Platone, contrapponendosi alla dottrina protagorea della conoscenza, identificata con la sensazione.
23
to sino a quel momento con sia affatto più vero delle
illusioni dei miei sogni”1.
Pertanto così come non sono veri e reali i pensieri
del sogno allo stesso modo potrebbero non essere tali
neppure quelli della vita di veglia, i quali poi spesso risultano anche addirittura meno vivi di quelli avuti in sogno. Dunque, se posseggo dei pensieri ciò si deve al fatto che qualcosa, dal di fuori del mio “io”, è penetrato in
me, qualcosa che, possedendo la stessa evidenza delle
immagini oniriche, è da giudicare illusoria e ingannevole,
così come lo sono gli stessi sogni.
In conclusione ogni cosa, sia che si tratti di percezioni, di sensazioni e di sentimenti, sia che si tratti
di pensieri, può anche essere non vera. Tutto è così da
porre in dubbio. Non è possibile conseguire alcuna verità, neppure mediante l’analisi dei nostri pensieri, così
come in precedenza si è visto e si è detto in merito al
nostro sensorio.
7
Tutto è da porre in dubbio, qualsiasi tipo di conoscenza. La considerazione finale, cui si perviene, permette però di incrinare la stessa universalizzazione.
Insomma, non tutto, in realtà, può essere messo in
dubbio: “subito dopo mi accorsi che, mentre volevo in
tal modo pensare falsa ogni cosa, bisognava necessariamente che io, che la pensavo fossi pur qualcosa. Per
cui, dato che questa verità. io penso dunque sono è così
ferma e certa che non avrebbero potuto scuoterla ne1
Cartesio, Discorso, I, p. 23.
24
anche le più stravaganti supposizioni degli scettici, giudicai di poterla accogliere senza esitazione come il
principio primo della mia filosofia”1.
L’aver voluto pensare ogni cosa come non vera, per
una scelta imposta proprio dal dubbio metodologico relativo a tutte le opinioni, proprie ed altrui, ha portato
inevitabilmente a una conseguenza: il dubbio stesso non
può essere totale, dal momento che proprio in forza del
dubitare qualcosa risulta certo, dunque vero: l’io, il
soggetto o la coscienza che sta esercitando il dubbio
metodico, l’io, nell’atto stesso del proprio dubitare.
Proprio per aver voluto dichiarare che tutto è non
vero, si è fatta strada, di soppiatto, ma anche in modo
deciso, almeno una verità: io penso, dunque sono, che
nella traduzione latina delle Meditationes suona così:
ego cogito, ergo sum, sive esisto. Questa è di fatto una
verità, la prima che si è conseguita, perché possiede i
caratteri di un’idea chiara e distinta, vale a dire possiede i requisiti logico-metodologici a suo tempo presentati come condicio sine qua non del reperimento
stesso di una verità teoretica.
Questo è il principio indiscusso e indiscutibile della filosofia cartesiana, ma allo stesso tempo, a ben riflettere, è il nostro stesso fondamento, se è vero che
questa pagina del Discorso ha inciso profondamente
nell’intero pensiero occidentale, con quel che segue,
come si vedrà.
Viene poi proposta un’importante precisazione,
che almeno nel Discorso evita la critica del passaggio
1
Ibidem
25
indebito alla sfera ontologico-esistenziale. La verità
prima che si consegue non riguarda il pensato o dei particolari pensieri, ma la stessa attività del pensiero. Non
si sostiene, insomma, la verità di uno specifico giudizio,
di un’opinione, tra quelle considerate dubbie; quel che è
vero, evidentemente tale, in modo chiaro e distinto, è il
pensiero pensante: è vero che si pensi, è vero il che del
pensare, non il cosa del pensiero, non questo o quel
pensiero particolare.
Si riconosce, dunque, come reale/vera la facoltà
del pensare, pur dovendo continuare ad ammettere, al
momento, come si vedrà, che quel che si pensa possa
essere pura illusione, della natura stessa di un sogno,
un’autentica non verità. Sembra essere vera l’attività
del pensare, mentre rimane nel dubbio il suo stesso
prodotto, ogni suo prodotto.
8
Si è pervenuti al fondamento stesso della filosofia cartesiana, che va però approfondito. Si torna così
a radicalizzare il dubbio universale, sostenendo la possibilità di fingere addirittura la non esistenza del proprio corpo, del mondo intero, come anche di qualsiasi
“luogo” spazio-temporale, in cui l’io, in particolare l’io
penso, abbia modo di soggiornare.
Anche in questo caso possiamo certamente simulare la non esistenza del mondo e del corpo proprio, che
è in uno col mondo, ma senza alcun dubbio non si può
fingere che l’io che pensa non abbia esistenza. Anzi,
proprio il fatto che arriviamo a dubitare dell’esistenza
26
di quel che è altro-da-noi stessi, fa sì che si possa pervenire alla certezza ed evidenza dell’esistenza del proprio sé. Vale a dire, si è garantiti in certo qual modo del
luogo stesso da cui si dubita, che permette di dubitare.
Riflettiamo ancora un po’. Qui l’io penso è contrapposto a quel che è altro da sé. L’alterità è rappresentata globalmente dal mondo, ma prima ancora dallo
stesso corpo che appare essere il proprium di quell’io,
che è soggetto in causa, corpo che è indubbiamente
parte di mondo. Ancora di più: la contrapposizione è
proposta tra un esterno (il mondo/corpo) e un interno
(l’io/anima). Pertanto, e di conseguenza, si può concludere che se l’io fosse privo dell’attività del pensare sarebbe addirittura privo di esistenza, perché l’esistenza
gli inerisce proprio in quanto pensante. Troviamo così
scritto che l’io “è una sostanza di cui tutta l’essenza o
natura consiste solo nel pensare e che per esistere non
ha bisogno di luogo alcuno né dipende da alcuna cosa
materiale”1.
L’io, insomma, non avrebbe bisogno di un mondo in
cui collocarsi, né di un corpo proprio in cui insediarsi.
La conclusione è d’obbligo: “questo che dico “io”, e cioè
l’anima per cui sono quel che sono, è qualcosa di interamente distinto dal corpo ed è anzi tanto più facilmente
conosciuto, sì che anche se il corpo non esistesse, non
perciò cesserebbe di essere tutto ciò che è”2.
Si dice, perciò, che l’io è tutt’uno con l’anima, e in
seguito la filosofia occidentale parlerà del soggetto,
1
2
Ibidem
Ivi, pp. 23-24.
27
della coscienza, della mente, per dire pressappoco lo
stesso. L’io possiede un suo essere in sé e per sé costituito; insomma, non avrebbe bisogno di null’altro per
essere quel che è, al di fuori del proprio sé; inoltre è
separato, per essenza, dal mondo della materialità e
della corporeità. Se, per ipotesi allora, non esistesse il
corpo, l’io continuerebbe a essere quel che è, quale io
penso.
Il corpo, insomma, è inessenziale al nostro esistere quale sostanza pensante. Si è qui in presenza di un’evidente piega platonica del pensiero di Cartesio, per il
quale l’anima potrebbe anche avere esistenza al di fuori
del proprio corpo, al di fuori di qualsiasi corpo.
Mediante il metodo di ricerca, fondato sul dubbio
sistematico, si arriva a formulare almeno una proposizione vera, si consegue finalmente una verità. Ma cos’è
che fonda la certezza indubitabile di tale proposizione? Scrive Cartesio: “in questa affermazione: io penso,
dunque sono non c’è nulla che me ne assicuri la verità,
eccetto il vedere chiaramente che per pensare bisogna
essere”1. Sembra che venga così ribadito ancora una
volta il senso dell’affermazione certa cui si era pervenuti in precedenza. Si avrebbe pertanto il passaggio,
con inversione dei termini stessi in gioco da un penso
dunque sono a un sono dunque penso (o posso pensare);
il passaggio da una riflessione gnoseologica a un’impostazione ontologica del problema.
Cerchiamo di capire meglio. Il dubbio metodico
porta alla certezza della verità relativa all’io penso,
1
Ivi, p. 24.
28
poiché dubitare è tutt’uno col pensare. D’altra parte,
però, la certezza/verità del pensare va a coniugarsi, di
stretta necessità, con un’altra certezza, quella relativa
all’essere che è in grado di pensare. Vale a dire che non
si può ammettere l’esistenza di una sostanza pensante
là dove si è costatata l’attività del pensare, che è
tutt’una col dubbio.
Il pensare, dunque, dev’essere sempre supportato
da un essere. Di conseguenza, possiamo arrivare a dire
che in tal modo Cartesio stia stabilendo una sorta di
primato ontologico dell’essere sul pensiero. Insomma,
per poter pensare bisogna prima essere. Per lo meno
nel caso dell’uomo, poi, il pensiero specifica l’essere e lo
caratterizza quale unicum tra tutti gli altri esistenti.
9
Si è visto così come dal dubbio universale si passi
almeno a una certezza/verità e come essa si caratterizzi. Un’altra considerazione, in certo qual modo finale
e decisiva, che riguarda ancora il dubbio metodico, porta poi Cartesio a passare dall’idea dell’io a quella di Dio
e successivamente alla dimostrazione dell’esistenza di
Dio, indispensabile per poter recuperare la verità delle
cose stesse del mondo.
Leggiamo: “in seguito a ciò, riflettendo sul fatto
che io dubitavo e che chiaramente vedevo essere maggiore perfezione il conoscere che il dubitare, per cui
l’esser mio non era del tutto perfetto, mi proposi di
cercare donde avessi appreso a pensare a qualcosa di
più perfetto ch’io non fossi [vale a dire più perfetto
29
dell’io che pensa]; e conobbi con evidenza che doveva
essere da una natura realmente più perfetta di me”1.
Qui Cartesio sostiene che dubitare è un’attività
del pensiero inferiore al conoscere, perché chi dubita è
sempre in stato di palese inferiorità rispetto a colui
che sa, tanto è vero che fa ogni sforzo possibile per
uscire dal dubbio e approdare alla conoscenza certa. Di
conseguenza, allora, dal momento che l’attività del pensare, nel caso specifico quella di Cartesio, versa in fondo nel dubbio, la natura dell’uomo, quale sostanza pensante, risulta essere imperfetta.
D’altra parte, poi, il dubbio metodico investe indistintamente tutte le idee che albergano nella nostra
mente. Qual è la loro provenienza? Possono e, forse,
devono essere rifiutate, perché non sufficientemente
chiare e distinte? Se risultano vere, dall’io stesso che,
per quanto imperfetto, è riuscito a produrle; se invece
false, dal nulla, vale a dire sempre dalla natura dell’io,
che proprio perché staziona nel dubbio è imperfetta e
produce così, di conseguenza, anche la non verità.
Quel che viene asserito, però, come realtà di natura inferiore all’io non può essere sostenuto per
un’idea che sia a esso superiore. Insomma, non possiamo ragionare in modo analogo a quel che facciamo per i
pensieri dell’io, relativamente all’idea stessa di una realtà superiore e più perfetta che l’io arrivasse a pensare. Se si dà, pertanto, nella sostanza pensante imperfetta dell’uomo l’idea di un essere perfetto, superiore
all’uomo che lo pensa, tale idea non può in nessun caso
1
Ibidem
30
provenire (essere creazione di) da quell’essere dichiarato per essenza imperfetto, ma solo da un essere perfetto, da quello stesso essere di cui si possiede l’idea:
“essa [l’idea di essere perfetto] doveva, dunque, essere
stata messa in me da una natura realmente più perfetta di me, e tale, anzi, che avesse in sé tutte le perfezioni di cui io potevo avere qualche idea, cioè, per dirla
con una sola parola, che fosse Dio”1.
Si ha così il passaggio dall’io (penso) a Dio; meglio
ancora, dall’idea dell’io e dalle idee che l’io ha nella propria mente, e che sono tutt’uno con esso, perché l’io è
in quanto pensa, a un’idea particolare qual è l’idea di un
essere perfetto, Dio stesso.
10
Si tratta ora di compiere un ultimo passo, che
porterà dall’idea di Dio, quale essere perfetto, alla sua
esistenza, dovendo affrontare tutti i problemi concernenti le garanzie che si possono avere nel passaggio
dall’idea all’esistenza di una cosa. Bisogna affrontare
prima il problema relativo alle difficoltà che si hanno
nella dimostrazione dell’esistenza, a partire dalle idee
e dal pensiero, non tanto quelle che riguardano
l’esistenza di Dio, ma anche quelle relative all’esistenza
del mondo e dell’anima, e cioè dell’io stesso del cogito.
Secondo Cartesio il motivo delle difficoltà risiede
nel fatto che non si riesce a elevare la propria mente al
di sopra della realtà materiale e sensibile. Non siamo
abituati, infatti, a prendere in debita considerazione
1
Ibidem
31
alcunché, se non mediante l’immaginazione, vale a dire
mediante rappresentazioni, ma questo è il modo proprio
di pensare la realtà specifica delle cose sensibili.
La filosofia scolastica sembra aver fatto proprio
l’insegnamento materialistico di Aristotele, portando
sino alle estreme conseguenze l’impossibilità di dimostrare razionalmente l’esistenza dell’anima (l’io) e di
Dio, quando crede di doversi fondare sul principio gnoseologico secondo cui “non vi è nulla nell’intelletto che
prima non sia passato attraverso i sensi”. Certo che
nessuno abbia mai fatto esperienza sensibile né dell’anima, né di Dio, intesi quali “puri spiriti”, si dovrà concludere che le idee di “anima” e di “Dio” non sono intelligibili e dunque non vere. Questo naturalmente nonostante che la stessa Scolastica abbia poi creduto di
poterne ugualmente dimostrare l’esistenza!
Contro questa deriva nichilistica del pensiero,
Cartesio ritiene di poter ribadire che chi pretende di
comprendere la verità di queste due idee, servendosi
della “prova” dell’immaginazione e delle connesse rappresentazioni è del tutto fuori strada. È come se si volessero udire i suoni oppure sentire degli odori, mediante gli occhi.
Si dice poi ancora di più, quando si sostiene che lo
stesso criterio di verità degli organi di senso (della
sensibilità e pertanto dell’immaginario) è da connettere
strettamente all’intelletto e dunque mai ai sensi stessi,
che possono sempre ingannare. Si faccia qui riferimento a quanto affermato sin dall’inizio del Discorso.
32
Il criterio di verità è dato perciò solo dalla ragione, mai dai sensi o dall’immaginazione. Con quali specifiche modalità la ragione consegue la verità? non certo
perché essa garantisce che quel che cade sotto i sensi
oppure quel che immaginiamo sia vero, in una specie di
corrispondenza speculare tra la realtà “fotografata”
dalle percezioni e le rappresentazioni che albergano in
noi, ma piuttosto perché ci assicura che le idee e i pensieri che sono in noi debbano avere qualche fondamento
di verità. Questo “perché è impossibile che Dio, il quale
è tutto perfezione e tutto veracità, le abbia messe in
noi senza alcun fondamento”1.
Tra le indubbie qualità di Dio non può assolutamente esservi quella negativa di trarre in inganno l’uomo, creando in lui delle illusioni, mediante immaginazioni e rappresentazioni, fondate su conoscenze empiriche, originate dal sensorio.
Vediamo ora di cosa sia criterio di verità la nostra
ragione. Essa non dà conto della verità di una realtà esterna all’io che pensa, ma solo della verità di una certa
e necessaria correlazione tra le idee dell’ego cogito e
un aliquid che appartiene al mondo, che è esterno rispetto all’io stesso. Tale correlazione non può che essere veritiera (ha cioè un fondo per lo meno di verità),
poiché le idee, e in particolare quella stessa di correlazione tra interno ed esterno, sono immesse nell’io da
Dio stesso, da quell’essere perfetto che per natura non
può ingannare.
1
Ivi, p. 28.
33
Dio garantisce così il fondamento di verità della
ragione e dunque dell’io penso, nella corrispondenza tra
quel che sembra essere la realtà di un mondo, fenomeno esterno a noi, e l’io che sente e immagina e pensa
quel che è altro da sé ed “esterno”.
11
Fermiamo qui la lettura del Discorso e occupiamoci delle Meditationes de prima philosophia, in particolare della seconda e della sesta1.
Nella seconda Cartesio indaga sul fondamento del
filosofare e si chiede se lo stesso “io” possa essere
considerato almeno come un qualcosa. In particolare, se
l’io possa essere considerarsi legato ai sensi e al corpo,
e se sì, come ciò sia possibile. Anzitutto, se si considerasse l’essere dell’uomo come un composto di visobraccia-membra-ossa-carne, il corpo sarebbe in fondo
da intendere come una macchina priva di vita. Non si
può pertanto rispondere all’interrogativo “chi è l’io
dell’uomo?”, facendo riferimento unicamente al corpo, e
di conseguenza non sarebbe vera la risposta: io sono il
mio corpo.
1
In sintesi: nella I si tratta del dubbio metodico; nella II dello spirito dell’uomo e della sua distinzione dal corpo; nella III delle prove
dell’esistenza di Dio; nella IV della verità di quel che si concepisce
in modo chiaro e distinto: nella V si insiste sulle prove dell’esistenza
di Dio con altre dimostrazioni; nella VI si distingue tra azione
dell’intelletto e attività dell’immaginazione, mostrando la distinzione dell’anima dal corpo e allo stesso tempo il fatto che essa risulti a
esso congiunta.
34
Se, infatti, oltre che la “struttura” del corpo si
considerano anche le sue attività, dobbiamo ipotizzare
altro, che si associ al corpo stesso, per arrivare a costituire così il totum dell’uomo. Insomma, la considerazione del fatto che l’io si nutra, si muova, senta e pensi
comporta l’esistenza dell’anima, con la specifica funzione di dar vita (vegetativa, sensitiva e intellettivospirituale) al meccanismo corporeo.
Si è detto che io sono non è da identificare al solo
corpo, ma neppure si può arrivare a dire che coincide
con quel che è l’anima, che sembra dar vita al corpomacchina. Io sono non viene spiegato, insomma, da certe prerogative dell’anima, che arriva a muovere le
membra del meccanismo corporeo, che è aria sottile e
penetrante1, diffusa nelle membra, che è “soffio di
vento”, perché io sono una cosa che pensa, vale a dire
uno spirito, un intelletto e una ragione.
Leggiamo: “ma che cosa, dunque, sono io? Una cosa
che pensa. E che cos’è una cosa che pensa? È una cosa
che dubita, che concepisce, che afferma, che nega, che
vuole, che non vuole, che immagina anche, e che sente.
Certo non è poco, se tutte queste cose appartengono
alla mia natura”2. Sostenere che la prerogativa dell’io
risiede nel pensare significa, com’è naturale, includere
nel pensiero il dubitare-concepire-affermare-negarevolere, ecc. Ma c’è anche dell’altro; altri attributi ap1
Scrive Cartesio: “qualcosa di rado e di sottile, come un vento, una
fiamma, o un’aria delicatissima insinuata e diffusa nelle parti più
grossolane di me” (…)
2
Cartesio, Meditationes, I, I, p. 81.
35
partengono al pensiero e dunque all’anima, pur essendo
di per sé e di primo acchito collegabili al corpo. Da una
parte la facoltà di immaginare, dall’altra il sentire, il
provare sensazioni e percezioni. Sia l’immaginazione, sia
il sentire debbono essere considerate null’altro che
pensare. Si noti che qui Cartesio sta sostenendo che
l’essere dell’uomo informa di sé, del proprio stesso essere tutto quel con cui viene in rapporto e pertanto risulta essere diverso il sentire e l’immaginare dell’uomo
rispetto a quello dell’animale o del vegetale. L’immaginare, il sentire/sentimento dell’uomo sono infatti informati da ragione e da pensiero.
12
Consideriamo ora, almeno in parte, la sesta meditazione, Dell’esistenza delle cose materiali e della reale
distinzione tra l’anima e il corpo dell’uomo.
Nella seconda meditazione Cartesio aveva notato
come la conoscenza di un corpo, elemento spirituale,
fosse un atto mentale e dunque come fossero da includere nell’ambito proprio e specifico del pensiero e dell’anima anche percezione e immaginazione. Si arriva così al paradosso di sostenere che è più facile conoscere
il proprio io (lo spirito), piuttosto che la realtà del corpo, che è esterno rispetto all’io.
Nella sesta meditazione tale problema è radicalizzato. Affrontando il discorso relativo alla materialità dei corpi, che appare “esterna” all’io penso, ci si
chiede addirittura se esistano mai delle cose materiali,
dal momento che sinora si è potuto riconoscere soltan-
36
to l’esistenza del cogito e dunque di una sostanza pensante o spirituale. La domanda sembra legittima: il
dubbio metodico ha posto in forse ogni realtà; l’unica
poi che è risultata indubitabile è stata quella relativa al
pensiero, dunque una realtà immateriale.
C’è però da dire che alberga nell’uomo una facoltà
particolare che tenta di convincere dell’esistenza della
materia. Tale facoltà è l’immaginazione, mediante la
quale la capacità di conoscere si applica ai corpi; essa è
da distinguere da altri tipi di conoscenza, quelli relativi
al pensiero e alla ragione.
Nell’intento di mostrare la distinzione tra due diverse conoscenze, Cartesio propone l’esempio di un
triangolo. Esso viene concepito mediante un concetto,
come quella particolare figura geometrica compresa
tra tre linee, così come se lo rappresenta l’immaginazione, che lo equipara all’ipotetica materia di un quid
conosciuto, che di dà “in natura”. La “figura” concettuale di triangolo, di cui si è potuto senz’altro fare esperienza, nella considerazione di una materia dalla forma
triangolare, figura che è compresa tra tre linee tenute
assieme in un certo modo in osservanza a determinate
leggi, è stabilita dalla ragione, che determina i dispositivi secondo i quali si dà un triangolo e in mancanza dei
quali esso non può proprio darsi.
Cartesio conclude osservando come questo accada
“per la forza e per l’applicazione interna del mio spirito”. La cosa è senza dubbio più chiara se facciamo riferimento a un’altra figura geometrica: il chiliogono. In
questo caso dobbiamo immaginare e pensare una figura
37
geometrica di mille lati. Ora se è vero che noi, anche se
con maggiori difficoltà rispetto al triangolo, possiamo
arrivare a stabilire gli elementi essenziali “di ragione”
per una tale figura, di essa, però, non potremo certo
averne un’immagine, a differenza di quel che capita per
il triangolo.
Seguendo la nostra abitudine per rappresentare
cose corporee, anche in questo caso si tenterà di pervenire a elaborare un’immagine, ma essa risulterà alquanto confusa. Che differenza potrà mai darsi, a livello di immagine si badi bene e non certo di concetto, tra
un chiliogono e un miriagono (figura geometrica di diecimila lati)? Conclude pertanto Cartesio: “com’io conosco chiaramente che ho bisogno di una particolare tensione dello spirito per immaginare, della quale non mi
servo per concepire; e questa particolare tensione di
spirito mostra evidentemente la differenza che passa
tra l’immaginazione e l’intellezione o concezione pura”1.
Qui si sostiene che deve darsi l’esistenza di una
“tensione dello spirito”, quale specifica facoltà, perché
si possa pervenire all’elaborazione di immagini delle cose: lo “spirito” è attivo a supporto della facoltà di immaginare. Inoltre esiste anche un’altra tensione del
medesimo spirito, tesa a concepire, vale a dire a pensare le cose. Infine si marca una sostanziale differenza
tra le due tensioni spirituali: una cosa è immaginare, altra cosa è concepire; una cosa è avere rappresentazioni
delle cose, altra cosa è possedere concetti delle stesse.
1
Ivi, p. 122.
38
Cartesio va poi ben oltre questa precisazione,
quando sostiene che “questa mia facoltà di immaginare,
in quanto differisce dalla facoltà di concepire, non è in
nessun modo necessaria alla mia natura o alla mia essenza, e cioè all’essenza del mio spirito”1. Si ritiene, insomma, che l’io sia una sostanza pensante, per cui tutto
ciò che esula di per sé dal pensiero, pur essendo legato
allo spirito umano, alla sua “tensione”, è in realtà inessenziale.
Si è così pervenuti a ipotizzare una doppia funzione dell’io. Da una parte lo spirito che pensa, che elabora concetti e idee e tutto questa elaborazione avviene
al suo stesso interno, perché esso “si volge verso se
stesso”; dall’altra lo spirito che immagina, che produce
rappresentazioni delle cose, rivolgendosi in realtà verso l’esterno, al di fuori del proprio sé, verso l’altro da
sé: infatti “si volge verso il corpo”, il proprio, come anche verso altri corpi, verso il mondo dei corpi o delle
cose materiali.
Ci si chiede ora come si arrivi a produrre rappresentazioni e immagini. Bisogna ipotizzare l’esistenza di
cose esterne ed estranee alla realtà vera, all’unica verità della sostanza pensante dell’io. Tale ipotesi è dovuta al fatto che abbiamo in noi stessi, nel nostro “interno” spirituale, un’idea di “cosa” che va distinta dalla
stessa natura pensante: dal momento, poi, che la sostanza pensante è spirituale, per contrapposizione quel
che è altro da essa sarà materiale.
1
Ibidem
39
A proposito della “percezione” della materialità
delle cose corporee, sinora Cartesio ha fatto riferimento soltanto alla geometria, con la proposta della distinzione tra figura geometrica colta “in natura” e di
cui si possiede una rappresentazione e “concetto” della
medesima figura. Pertanto sinora solo il senso della vista era di per sé preso in debita considerazione,
nell’atto di percezione. Ora si nota, però, che oltre alla
vista anche altri sensi siano impegnati, e di continuo,
nel momento in cui dalla tensione dello spirito vengono
elaborate le immagini. Delle sollecitazioni, insomma,
provengono da tutto il sensorio, assieme alla memoria,
che ricorda sensazioni e percezioni avute in precedenza.
Sin dall’inizio Cartesio ha messo in dubbio la fede
nei sensi e, di conseguenza, nell’immaginazione, indicando e proponendo quale unica verità dell’esistenza quella
legata al solo pensiero. D’altra parte, però, ha dovuto
anche ammettere che sentire e immaginare ineriscono
strettamente alla sostanza pensante, in quanto sottoposte a una “tensione” specifica dello spirito dell’uomo.
La certezza di esistere dell’io dipende unicamente
dal cogito, vale a dire dall’io stesso: sono, dunque penso
e, ancor prima penso, dunque sono. Questo è il portato
ultimo dell’antropologia e dell’ontologia cartesiana: l’uomo è quel qualcosa che pensa. Sembrerebbe in linea con
la definizione di marca aristotelica: zoon logon echon,
sennonché in Cartesio piuttosto che vivente e senziente (zoon) il corpo dell’uomo è macchina e automa.
40
13
A questo punto, però, il corpo è posto oramai come problema. Se l’uomo, infatti, è sostanza pensante,
cos’è allora il suo corpo? Qual è il rapporto che si deve
stabilire tra l’io che pensa e il corpo proprio? Leggiamo:
“e sebbene forse (o piuttosto certamente, come dirò
subito dopo) io abbia un corpo, al quale sono assai
strettamente congiunto, tuttavia poiché da un lato ho
una chiara e distinta idea di me stesso, in quanto sono
solamente una cosa pensante (res cogitans) e in estesa
e dall’altro lato ho un’idea distinta del corpo, in quanto
esso è solamente una cosa estesa (res extensa) e non
pensante, è certo che questo io, cioè la mia anima, per
la quale sono ciò che sono, è interamente e veramente
distinta dal mio corpo e può essere o esistere senza di
lui”1.
Dell’uomo e sull’uomo si hanno pertanto due distinte idee: una chiara del suo io o del sé, la sostanza
pensante e immateriale, l’altra non chiara, anche se distinta dall’io stesso, vale a dire il corpo proprio, quale
sostanza non pensante e materiale. Si ha così a che fare con due ben diverse realtà, la res cogitans e la res
extensa. Si conclude che l’io, quello di cui si ha esperienza diretta, l’anima stessa, per cui siamo quel che
siamo, è del tutto distinto dal proprio corpo. Insomma,
l’anima può esistere prima del corpo e, pertanto, priva
di esso2.
1
Ivi, pp. 126-7.
Appare qui di tutta evidenza il riferimento all’antropologia platonica. Nel Fedone, dialogo in cui si prospetta l’essere umano di fron2
41
In conclusione, Cartesio afferma che l’io è e che il
suo essere non dipende dal suo avere. Subito dopo aggiunge che l’io ha caratteri peculiari, che lo contraddistinguono da ogni altro essere. Esso è sostanza pensante, è per essenza pensiero, ma, al tempo stesso, l’io ha
(deve avere) un corpo proprio. Si sottolinea, dunque,
come essere e avere coappartengano alla medesima realtà.
Si tratta allora di stabilire come essere e avere
trovino il modo di coesistere nel medesimo io e di comunicare. Questo perché l’io non risulta essere semplicemente alloggiato nel corpo proprio, ma intimamente e
strettamente congiunto a esso, confuso con esso. L’io
(o anima) e il corpo sono così da considerare, almeno
nell’uomo, un tutt’uno, possedendo la medesima unità di
struttura. Insiste in proposito Cartesio, sostenendo
che l’io non è nel corpo così come il pilota è nel battello,
che guida tra le onde. Infatti, se il corpo è ferito si
prova dolore, proprio perché corpo e anima sono tutt’uno, una inscindibile unità. Non si sentirebbe dolore a livello fisico, dunque, ma se ne avrebbe solo un’idea in
spirito cogliendo la ferita solo tramite l’intelletto, se
l’io fosse nel corpo in un rapporto di mera esteriorità,
te alla fine dell’esistenza, si delinea la fine dell’organismo vivente
con due destini ben diversi, due prospettive ontologiche distinte
per anima e per corpo.
Mentre la res materiale è senz’altro destinata alla corruzione, la
res spirituale mantiene il suo stato, indipendentemente dal destino
del corpo: in seguito all’avvenuta purificazione, è destinata a tornare contemplare quel mondo delle idee, da cui trae la stessa origine.
42
così come il pilota in una nave ha idea della falla che si
è aperta, ma non ne soffre personalmente.
Cartesio pone il problema del corpo proprio e, più
in generale, dei corpi, vale a dire delle realtà mondane
estranee all’io che le pensa. Nel trattato su Il mondo1,
dopo aver stabilito verità concernenti l’io penso, Dio e
la sua esistenza, egli si appresta così a mostrare altre
verità che concernono il mondo fisico in generale.
Di nostro interesse è il fatto che si crede di mostrare con quali modalità gli oggetti, che sono esterni
rispetto al nostro io, riescano a imprimere in esso diverse idee e pensieri, mediante luce, suoni, odori, sapori… Si cerca così di spiegare come rappresentazioni e
immagini, legati al nostro sentire e percepire, si imprimano nell’io e vi rimangano. Cartesio precisa che è in
una parte del corpo proprio che si annidano idee e pensieri e rappresentazioni. Tutto avviene nel cervello.
Dove, però, in particolare e specificamente? Si localizza con maggiore precisione “scientifica” il topos proprio del pensiero, quando si parla del “senso comune
dove tali idee vengono raccolte”. Il senso comune è il
sensorio, vale a dire l’organo interno al cervello stesso,
comune a tutti i sensi.
Il sensorio è individuato nella ghiandola pineale,
che ha sede al centro del cervello, alla quale affluireb1
Il trattato non verrà mai pubblicato, in seguito alla condanna di
Galilei e sarà solo indirizzato ai “dotti”, e cioè ai filosofi e ai teologi
scolastici, di idee tradizionaliste, contro i quali si andava imponendo
la nuova scienza della natura, fondata su esperimento e calcolo matematico.
43
bero tutte le immagini delle impressioni sensibili e nella
quale avrebbe anche sede la stessa anima con i suoi
pensieri e con le sue idee.
44
PARTE PRIMA. KANT, I
1
Si è portata l’indagine su Cartesio, alla ricerca di
un chiarimento circa il darsi della cosa, del come del
suo darsi e delle modalità di rappresentazione di quel
che appare, perché si è inteso proporre tale problematica agli albori del pensiero moderno, convinti che proprio quel pensiero costituisce l’ossatura portante del
nostro stesso pensiero.
Si è visto come il dubbio metodico conduca all’unica certezza del cogito e, dunque, del soggetto conoscente. Nella speculazione cartesiana si fa però strada
l’interrogativo relativo alla garanzia della veridicità
delle nostre cogitationes: come accertarsi che i pensieri e i concetti, presenti nella mente, abbiano un corrispettivo nella realtà, esterna a noi, nella perfetta
congruenza con cose effettivamente esistenti?
È posto così il problema dell’essere, non garantito
certo e di per sé dalla facoltà del pensare, ancora meno del dubitare. Come si ricorderà, Cartesio individua in
Dio, e ancora prima nell’idea di un Dio la garanzia del
fatto che non possiamo in nessun caso cadere in errore
quando crediamo a una corrispondenza tra immagini
mentali e cose, presumibilmente esistenti e indipendenti da noi stessi, che immaginiamo proprio quelle e
non altro.
Perché non si tratterebbe di pura e semplice illusione? Si risponde che Dio, Summum Bonum, non potrà
mai prendersi gioco di noi, come un perfido diavolo in-
45
gannatore. È però naturale che, fondando il suo discorso sull’idea di Dio, tutto sta a dimostrare che egli esista e, soprattutto, che l’io non s’inganni proprio con
quell’idea che possiede di lui.
Cartesio crede di riuscire a farlo, puntando come
si è visto sull’idea di perfezione. A noi non interessano
qui tanto le diverse prove dell’esistenza di Dio, quanto
piuttosto sottolineare il fatto che il ricorso a lui sia indispensabile per supportare l’argomento di garanzia.
È interessante qui notare come, nonostante l’opposizione pregiudiziale a tutta la tradizione e in particolare alla scolastica tomista, proprio nel reperimento
del garante della verità e della corrispondenza tra idea
pensata e cosa esistente, Cartesio si rifaccia a Tommaso d’Aquino. Difatti le prove dell’esistenza di Dio sono
analoghe a quelle proposte nella Summa teologica, nella
questione An Deus sit, anche se c’è da sottolineare il
fatto che mentre Tommaso si muoveva ancora e soltanto in un ambito di intellectus fidei, e dunque decisamente teologico, qui la prospettiva intenderebbe essere soltanto di stampo teoretico, fornendo delle prove
puramente razionali; inoltre il rapporto stretto, e l’adaequatio, tra cose e intelletto è garantito da una precedente concordanza tra le idee di Dio e le cose create
o da creare proprio in virtù e in forza di quelle stesse
idee.
Cerchiamo ora di portare sino in fondo l’analogia
con Tommaso. In proposito sarebbe interessante il
confronto puntuale con gli articoli della quaestio citata
della Summa.
46
Cosa sta a significare che Dio è garante della verità del nostro dire, delle nostre conoscenze, vale a dire della corrispondenza tra cosa e idea, dell’adaequatio
rei et intellectus? Significa che tutte le nostre verità,
le verità insite nel nostro dire (logos) sono tutte dipendenti, senza eccezione alcuna, da quelle verità che
risiedono sin dall’origine della creazione in mente Dei,
le quali arrivano a realizzare l’adaequatio in modo totale e perfetto, essendo completa la conformità tra le
idee in (e di) Dio e la loro stessa realizzazione negli enti mondani, da lui stesso creati. Dice in fondo lo stesso
Platone, quando nel mito della caverna della Repubblica
rivela che quelle ombre che si muovono sulla parete
della caverna corrispondono per omoiosis agli oggetti
posti al di fuori, illuminati dal Sole.
In conclusione, nel tentativo di proporsi in alternativa alle auctoritates della tradizione, Cartesio continua a collocare il suo pensiero, che pure dovrebbe far
perno sulla sola ragione, in un luogo teologico. Il suo finisce con l’essere un discorso su Dio e di Dio, là dove la
verità in Dio è quella che pregiudizialmente garantisce
la possibilità stessa che si diano poi delle verità per
l’uomo.
2
Poniamo ora il caso che la “prova” dell’esistenza di
Dio non tenga o che semplicemente non venga ritenuta
probante; in questo caso verrebbe a mancare la garanzia riguardo alla corrispondenza tra idee e realtà, vale
a dire non si avrebbe più alcuna certezza dell’esistenza
47
delle cose del mondo, adeguate a quel che appare. È
questo proprio il caso del pensiero moderno, in certo
qual modo “laicizzato”, è il caso di Immanuel Kant.
Nella Critica della ragion pura la verità, infatti,
non viene più considerata, programmaticamente, in un
luogo teologico, perché si ritiene impossibile che la pura ragione (die reine Vernunft, puro intelletto) possa
arrivare ad avere idee di Dio, della libertà umana e dell’immortalità dell’anima, e dunque a darne una dimostrazione, quali oggetti di possibile esperienza.
A ragion veduta, dunque, nella Prefazione alla seconda edizione della Critica della Ragion pura Kant
scrive che su tali argomenti “ho dovuto sopprimere il
sapere per sostituirvi la fede”. Tale puntualizzazione è
ben lontana, come si è avuto modo di vedere, da quella
cartesiana del Discorso e delle Meditationes.
Se è vero che non può e non vuole muoversi il luogo teologico (logos su Dio), Kant intende allora collocarsi in luogo antropologico della verità, proprio facendo a meno ormai della garanzia di un Dio, per arrivare a
concepire e a dire il vero. C’è da osservare qualcosa che
va ancora oltre: di fatto Kant non sembra più interessato alla verità stessa, intesa almeno come adaequatio
rei et intellectus, meglio ancora egli crede di non doversi (potersi) più occupare nemmeno del conformarsi
(omoiosis) della realtà delle cose del mondo con
l’intelletto che le conosce. Ma allora, di cosa ha da occuparsi la filosofia?
Figlio del suo tempo, egli eredita almeno in parte
lo scetticismo di David Hume, circa la inconoscibilità
48
della realtà esterna al soggetto conoscente. Pertanto
opera una scelta di campo quasi obbligata e ben precisa
tra i due corni del dilemma, rivelatisi inconciliabili, tra
due realtà che entrano in rapporto tra loro, ma che sono di natura totalmente diversa. Egli finisce col privilegiarne una sola. Tra l’io conoscente e la cosa conosciuta, tra la ragione e la realtà (per tornare alla nostra
terminologia), egli s’interessa soltanto della ragione
(nella terminologia kantiana, del Verstand, intelletto) e,
soprattutto, delle condizioni di possibilità della conoscenza dell’altro da sé, in cui risiede il dato di esperienza.
Kant non sembra dunque affatto interessato a
quel che è la realtà, altro da noi, che si arriva a conoscere, anzi dice espressamente e a più riprese che essa, proprio in quanto altro, o alterità assoluta, risulta
inconoscibile. S’interessa allora delle modalità del nostro conoscere e del “luogo” in cui esso si svolge. Considera così la struttura conoscitiva dell’io penso di Cartesio, vale a dire, volendo impiegare la sua terminologia,
indaga sulle condizioni di possibilità indispensabili, senza le quali non si potrebbe mai dare conoscenza per
l’uomo. Tali condizioni costituiscono il trascendentale, e
cioè quel che si riferisce al fondamento apriori, a prescindere da qualsiasi esperienza, della possibilità stessa di un’esperienza.
3
Cerchiamo ora di far luce sul luogo teoretico e
antropologico, in cui si muove il filosofo tedesco. Tro-
49
viamo scritto: “chiamo trascendentale ogni conoscenza
che si occupa non di oggetti, ma del nostro modo di conoscenza degli oggetti, in quanto questa dev’essere
possibile apriori”1.
La filosofia trascendentale kantiana, pertanto, è
qua tale priva di contenuti, e cioè priva di qualsiasi riferimento diretto alla realtà. Essa non ha “oggetti”
propri. Quello di Kant appare così un discorso propedeutico alla filosofia. Nell’Antropologia pragmatica leggiamo difatti che “non si può insegnare la filosofia, ma
solo a filosofare”. La Critica della ragion pura, perciò,
non intende offrire al lettore un contenuto di verità,
come pretenderebbero un po’ tutti i sistemi filosofici,
quanto piuttosto la struttura di trasformazioni possibili nella dinamica dell’attività conoscitiva, in una sorta
di gioco concettuale.
Non si tratta, però, di una mera e superficiale costruzione ludica, fine a se stessa, dal momento che
Kant intende mostrare come, nello sviluppo del conoscere e nella sua articolazione pratica si attui il processo di oggettivazione.
Proprio partendo dalle analisi relative alla struttura dell’io penso e delle modalità trascendentali di conoscenza, si arriva così a mostrare come si costituisca
l’oggetto di conoscenza. Da notare come le condizioni
che Kant indica circa il costituirsi dell’oggetto siano
esse stesse progettuali, e dunque a loro volta tali condizioni non possono essere considerate degli oggetti.
Eppure si è alla presenza di un processo reale, in cui si
1
I. Kant, Critica della ragion pura, Bari, Laterza, p. 58.
50
costituisce, e quindi si oggettiva, la realtà fenomenica,
mediante pratiche diverse. Lo studio di tale processo è
contenuto nella Critica della ragion pura.
Dal momento che le conoscenze trascendentali
che rendono possibile l’oggettivazione non sono oggetti
esse stesse, devono essere prese in considerazione,
almeno in prima battuta, come presupposti o postulati.
Anzi, Kant ne parla di per sé e più semplicemente come
dei fatti: 1. il fatto della sensibilità, che consiste nel
costatare l’esistenza di una materia sensibile, di cui
sembra essere costituito l’oggetto di esperienza. Come
sia (stata) posta in essere tale materia non è dato a noi
di saperlo, perché ci troviamo ancora a livello di quelle
condizioni che precedono qualsiasi processo indagabile;
2. il fatto dell’intuizione, che costata l’esistenza delle
due forme di spazio e di tempo, che ricevono e organizzano a loro modo quel materiale sensibile che concerne il fatto della sensibilità; 3. il fatto dell’intelletto,
che rileva la struttura delle dodici categorie, che costituiscono l’intelaiatura necessaria per la formazione
stessa dei concetti.
Si noti qui che tali fatti, dati come presupposti o
come postulati, sono assunti senza il bisogno o la necessità di stare in qualche modo a giustificarli. La spiegazione avverrà da ultimo, a costruzione compiuta,
quando sarà stata chiarita la loro funzione.
4
In base a tali presupposti, vediamo ora di chiarire
quello che viene considerato a buon diritto il principio
51
stesso “motore” del trascendentalismo. Quidquid recipitur admodum recipientis recipitur. La massima latina
sta a significare che la forma del recipiente o del ricevente condiziona e struttura in certo qual modo e necessariamente le modalità stesse delle ricezione. Si
pensi qui a un liquido che va ad assumere, di volta in
volta, la forma del contenitore in cui viene versato e
conservato. Non può non essere che così.
Tale principio non costituisce affatto una novità
all’interno della storia della filosofia. Quel che è il novum in Kant e nel suo trascendentalismo, così inteso, è
il pensare che questo condizionamento è la condicio sine qua non della stessa ricezione sensibile. Pertanto
Kant non dice soltanto che le forme della struttura di
ricezione modellano quel che viene da noi percepito, ma
addirittura che non si dà ricezione o percezione alcuna
senza quelle forme specifiche e particolari di ricezione.
Quindi il formarsi di un qualsiasi oggetto di esperienza è possibile soltanto se vengono riconosciute le
forme di ricezione condizionanti di spazio e di tempo,
quali trascendentali e pertanto presupposte. In conclusione, quel che è materia, vale a dire il fatto primo della sensibilità, o si assoggetta alle condizioni previe di
spazio e di tempo, e cioè all’intuizione sensibile, oppure
resta al di fuori della possibilità stessa di conoscenza.
Insomma sarebbe del tutto inesistente per noi.
Vediamo ora più da vicino in cosa consista il novum
che si riscontra in Kant. Certamente nel fatto che spazio e tempo siano considerati organi trascendentali
52
della sensibilità. In fondo anche l’occhio condiziona la
visione, così come l’orecchio lo fa per l’audizione, eppure occhio e orecchio e le loro modalità di funzionamento non sono affatto trascendentali. In fondo noi possiamo ricevere sensazioni e conoscenze anche senza
servirci di questi due organi e delle rispettive modalità
formali di funzionamento. Mentre invece, ed è un fatto,
il fatto o presupposto della sensibilità in uno col fatto
dell’intuizione, che nessun intelletto umano possa ricevere materia dalla sensibilità se essa non sia informata
precedentemente da spazio e da tempo.
Sin qui si è parlato di trascendentale in riferimento alla materia dell’esperienza sensibile, poniamo
ora il problema riguardo al fatto dell’intelletto. Anche
in questo caso si pone il problema dell’apriori e del trascendentale. Le cose, però, sembrano andare diversamente. Finché si parla di sensazione, vale a dire di una
facoltà di pura e semplice ricezione, si comprende agevolmente il fatto che la materia, per essere ricevuta,
va ad adattarsi docilmente alla modalità e alle forme
che sono necessarie per riceverla. Quando invece si
tratta dell’intelletto consideriamo una facoltà attiva,
che opera spontaneamente. In quanto tale, la facoltà
sembrerebbe ben diversa da quel recipiente, che impone in modo automatico una sua forma precostituita,
sempre la stessa.
Sottolineando così la spontaneità e l’autonomia
della facoltà intellettiva, si potrebbe arrivare a concludere che l’intelletto è allora in grado di produrre
l’oggetto stesso, mediante le sue specifiche forme.
53
Non si tratterebbe, pertanto, di un semplice adattamento di un oggetto già dato.
Neppure questo sembra essere quel che Kant intende, quando parla di autonomia nel fatto dell’intelletto, a differenza di quel che accade nel fatto dell’intuizione sensibile. Prendendo così posizione contro ogni
prospettiva di pensiero dualistica e idealistica, egli sostiene che non è affatto l’intelletto a produrre gli ogetti che conosce. Esso non fa allora altro che pensare,
a suo modo naturalmente, degli oggetti che però non
produce. Tali oggetti sono continuamente indicati e definiti da Kant come oggetti-dati per(al) l’intelletto.
Com’è allora che accade che oggetti-dati si presentino a noi soltanto secondo le forme secondo cui
l’intelletto li pensa? A esempio, come mai si danno tra i
fenomeni delle successioni necessarie che l’intelletto
stesso richiede, come se i fenomeni avessero tra loro
legami di tipo causale, mentre tale legame è il modo
stesso di pensare dell’intelletto, la forma che esso impone alle sue rappresentazioni?
Kant riflette per dieci anni su tale problema. Alla
fine la sua soluzione è nello schematismo trascendentale, secondo il quale l’intelletto non produce oggetti e
pertanto non è neppure nella possibilità di imprimere
loro la propria forma, almeno in modo diretto. Esso non
può agire, insomma, analogamente a quel che fanno le
forme spazio-temporali della sensibilità, che condizionano direttamente la materia.
L’intelletto arriva però a imprimere, mediante le
dodici categorie, una propria forma alle forme ricetti-
54
ve di spazio e di tempo. Ma allora, esso condiziona per
lo meno indirettamente l’oggetto, anche se non lo produce. Infatti, per far parte dell’esperienza ogni oggetto deve conformarsi alla condizione del tempo, ma il
tempo, grazie allo schematismo, a sua volta è sottoposto a strutturazione da parte dell’intelletto. Tale
strutturazione traduce in schemi temporali (numero,
grado, successione) la struttura delle categorie intellettuali (quantità, qualità, materia, causa). Grazie a ciò
l’oggetto viene condizionato direttamente dalla forma
del tempo, ma è anche vero che esso è poi anche condizionato indirettamente dalle forme dell’intelletto, che
a loro volta hanno condizionato la forma-tempo.
5
Colti gli elementi essenziali dello schematismo
trascendentale, proviamo ora a fermare la nostra attenzione su quel che sinora si è acquisito.
Il punto di vista trascendentale del criticismo
kantiano (che in quanto presupposto è l’elemento inindagato, condizionante l’intera ricerca) obbliga a considerare soltanto l’oggetto per noi, mai in se stesso. Si
considera, insomma, quell’oggetto che per entrare nell’ambito di un’esperienza possibile deve conformarsi al
modo universale e necessario secondo il quale è dato a
noi di esperirlo. L’oggetto va a costituirsi in modo conforme al nostro modo di percepire, intuire e pensare.
L’errore della metafisica è dovuto al fatto di non
aver mai considerato tutto ciò, vale a dire le condizioni
che rendono possibile la conoscenza, e ancor prima la
55
stessa esperienza. La metafisica cade pertanto nell’illusione, che inerisce in fondo in modo costitutivo il vedere, di poter arrivare a cogliere percettivamente e a
concepire concettualmente le cose stesse, in sé e per
sé, ignorando l’indispensabile mediazione del noi, vale a
dire dell’io penso.
Kant, insomma, sostiene che la cosa in sé non si dà
mai a noi qua tale. Quel che si presenta è il fenomeno,
scambiato ed equivocato per la stessa realtà, perchè
quel che appare a noi sembra coincidere perfettamente
con quel che è: l’apparire è tutt’uno con l’essere. Proprio questo è il punto di vista ingenuo del (buon) senso
comune e della prospettiva metafisica, che ignorano il
punto di vista trascendentale.
6
Affrontiamo ora con Kant il problema gnoseologico, e di seguito, come avvenuto già per Cartesio, quello
ontologico. Come si conosce e cosa si conosce? Leggiamo: “la nostra conoscenza scaturisce da due fonti principali dello spirito, la prima delle quali è la facoltà di ricevere le rappresentazioni (la ricettività delle impressioni), la seconda quella di conoscere un oggetto mediante queste rappresentazioni (spontaneità dei concetti). Per la prima un oggetto ci è dato; per la seconda
esso è pensato, in rapporto a quella rappresentazione
(come semplice determinazione dello spirito)”1.
La conoscenza scaturisce dunque da due fonti spirituali. La prima è la facoltà di ricevere rappresenta1
Ivi, p.93.
56
zioni (Vorstellungen), e cioè tutte quelle impressioni
che s’imprimono nei nostri sensi; la seconda è la facoltà
di conoscere un oggetto, proprio in forma mediata da
quelle stesse rappresentazioni e impressioni. La conoscenza consta, pertanto, di due momenti (Cartesio parla di due distinte conoscenze, come si ricorderà): di
una ricezione in certo qual modo passiva di immagini e
di rappresentazioni e della conoscenza vera e propria,
che comporta la produzione di concetti, che si fondano
sul collegamento indispensabile alle rappresentazioni
del primo momento conoscitivo.
Si arriva a conoscere un oggetto, mediante la
“spontaneità” dei concetti. La conoscenza, pertanto, ed
è proprio questa la conclusione cui Kant sembra pervenire, si dà soltanto nei concetti. Inoltre la prima facoltà ha a che fare con un oggetto-dato, mentre la seconda è alle prese con un oggetto-pensato. Da notare come
quel che è pensato sia da intendere, per Kant, in stretta e necessaria relazione con quel che è dato nelle impressioni, nelle immaginazioni e nelle rappresentazioni.
Di seguito, pertanto, si afferma che “intuizione e
concetti costituiscono dunque gli elementi di ogni nostra conoscenza; per modo che né concetti, senza che a
loro corrisponda in qualche modo intuizione, né intuizione, senza concetti, possono darci conoscenza”1.
L’intuizione è la ricezione di immagini e di rappresentazioni indipendentemente da noi, vale a dire che
l’oggetto si dà, si offre alla nostra ricezione tale quale
è; i concetti, invece, sono tutt’uno con il pensare l’og1
Ibidem
57
getto, la cui rappresentazione viene elaborata con le
modalità proprie dell’io conoscente; in quanto pensato,
esso è dunque in dipendenza da chi lo pensa.
Sembra poi opportuna una puntualizzazione: non si
tratta di ipotizzare due forme di conoscenza, perché
essa è pur sempre unica, fondandosi sulla stretta interconnessione tra i due elementi (intuizione di rappresentazioni e concetti): l’uno non può in nessun caso fare
a meno dell’altro.
Proseguiamo la lettura della Critica: “nessuna di
queste due facoltà è da anteporre all’altra. Senza la
sensibilità nessun oggetto ci sarebbe dato e senza intelletto nessun oggetto pensato. I pensieri senza contenuto sono vuoti le intuizioni senza concetti sono cieche. È quindi necessario rendere i concetti sensibili (e
cioè aggiungervi l’oggetto dell’intuizione), quanto rendersi intelligibili le intuizioni (cioè ridurle sotto i concetti). Queste due facoltà o capacità non possono
scambiarsi le loro funzioni. L’intelletto non può intuire
nulla né i sensi nulla pensare. La conoscenza non può
scaturire se non dalla loro unione”1.
Tutto ciò non sta affatto a significare che possano essere scambiate le funzioni delle due facoltà che
vengono mantenute ben distinte. È per questo motivo
che si propone una duplice indagine, che riguardi per un
verso la sensibilità e per altro verso l’intelletto stesso:
“per questo noi distinguiamo la scienza delle leggi della
1
Ivi, p. 94.
58
sensibilità in generale, l’estetica, dalla scienza delle
leggi dell’intelletto in generale, la logica”1.
7
Proponiamo ora qualche considerazione generale
circa la logica e la sua funzione conoscitiva, prima di
occuparci decisamente dell’Estetica trascendentale. La
logica generale pura o trascendentale astrae da ogni
contenuto di conoscenza, vale a dire che non si occupa
del rapporto possibile e necessario della conoscenza
con il proprio oggetto; difatti essa tratta soltanto della forma corretta del pensiero. A questo punto Kant
propone un inciso circa il criterio di verità, che per noi
che siamo “passati” attraverso Cartesio, è davvero significativo: “il criterio semplicemente logico di verità,
cioè l’accordo di una conoscenza con le leggi universali
e formali dell’intelletto (Vernunft) e della ragione
(Verstand) è bensì la condicio sine qua non, quindi la
condizione negativa di ogni verità; ma la logica non può
andare più oltre, e non ha pietra di paragone con cui
possa scoprire l’errore che non tocchi la forma, ma il
contenuto”2.
Qui sembra che Kant contribuisca ad aprire la
strada alla critica heideggeriana mossa nei confronti
della scienza in generale e della logica in particolare: la
scienza non pensa, meglio: la scienza, e ancor prima la
logica, non si occupa, non deve occuparsi della verità. Il
criterio logico di verità, infatti, essendo costituito
1
2
Ibidem
Ivi, p. 99.
59
dall’accordo di una conoscenza con le leggi formali dell’intelletto, è una condizione negativa, che nulla ha da
dire in positivo, dunque, dell’oggetto conosciuto, del
contenuto di conoscenza.
D’altra parte la logica non va oltre, perché le è
preclusa la possibilità di stabilire accordo e corrispondenza con il contenuto di conoscenza. Essa può così operare un controllo circa l’eventuale errore che riguardi la forma, mai portare la sua indagine sul contenuto.
Pertanto, una conoscenza può essere riconosciuta come
logicamente corretta e vera, perché rispettosa delle
leggi universali e necessarie del pensiero, ma la logica
nulla è in grado di dire circa il contenuto di verità, dunque circa l’accordo sempre ricercato tra conoscenza e
proprio oggetto.
La logica formale affronta i problemi inerenti l’opera e l’attività formale dell’intelletto e dispone tutti
gli elementi quali principi di valutazione in forza di questa sua attività. Tale parte della logica viene detta analitica: essa è pietra di paragone negativa di verità, dal
momento che si tratta di esaminare e valutare delle
conoscenze, anzitutto dal punto di vista formale, prima
di poter andare a esaminarne il contenuto “per vedere
se contengano una verità positiva, in rapporto con l’oggetto”. E però la sola forma della conoscenza, forma
propria della logica, è ben lontana dal poter stabilire la
verità oggettiva. Pertanto “nessuno, col semplice aiuto
della logica, può arrischiarsi a giudicare e ad affermare
checchessia degli oggetti, senza aver prima raccolto, al
60
di là della logica, una fondata informazione intorno a
essi”1.
Ciò detto, si sostiene subito dopo che esiste anche un’altra forma di logica, che tenta di passare da
canone di valutazione a “organo di effettiva produzione, almeno all’apparenza di affermazioni oggettive”, realizzando in realtà, precisa Kant, un uso abusivo della
logica. Tale parte della logica generale è la dialettica.
Considerata quale organo di conoscenza, tesa ai
contenuti oggettuali, la logica generale è sempre, quale
dialettica, logica dell’apparenza. È qui da intendere, naturalmente, nel senso negativo e spregiativo del termine. È il modo in cui si cerca di dare alla propria ignoranza circa l’oggettualità una “tinta di verità”, sostanziandola di contenuti, mentre invece il discorso della
logica dovrebbe essere relativo solo alle pure forme.
Circa la dialettica, poi, leggiamo: “infatti, poiché
essa [la dialettica o logica dell’apparenza] non ci insegna nulla circa il contenuto della conoscenza, ma semplicemente le condizioni formali dell’accordo con l’intelletto, le quali del resto, rispetto agli oggetti, sono assolutamente indifferenti; così, la pretesa di servirsene
come di strumento (organo) per allargare ed estendere, almeno secondo si pretende, le conoscenze non può
riuscire se non a una vuota ciancia, onde si affermi con
qualche apparenza, o s’impugni a capriccio ciò che si
vuole”2.
1
2
Ivi, p. 100.
Ivi, p. 101.
61
La logica non insegna nulla circa il contenuto di
verità, ma semplicemente verifica le condizioni formali
dell’accordo con l’intelletto; tali condizioni sono del
tutto indifferenti rispetto agli oggetti di conoscenza.
Ma allora, quando la logica dialettica pretende di servirsi degli strumenti intellettuali con l’intento di estendere e ampliare le proprie conoscenze, risulta nient’altro che vuota chiacchiera.
Ciò detto della logica, ne deriva una conseguenza
relativa alla ricerca della verità. La verità quale adaequatio è del tutto impossibile da stabilire “logicamente”, perché proprio nell’ambito delle competenze e delle condizioni di possibilità dell’intelletto, non si dà mai
alcun accordo tra la conoscenza e la realtà stessa di un
oggetto dato. Questo perché la logica generale o trascendentale non deve occuparsi programmaticamente,
lo si è visto, di uno dei due corni del dilemma:
dell’oggetto di conoscenza o da conoscere.
Dell’oggetto che si dà a noi non si occupa la logica,
ma piuttosto l’Estetica trascendentale, vale a dire la
prima parte della Critica della ragion pura.
62
PARTE PRIMA. KANT, II
1
Per arrivare a comprendere se, come e con quali
limiti l’oggetto di esperienza venga colto e considerato,
leggiamo almeno in parte l’Estetica trascendentale.
Scrive Kant che “non c’è dubbio che ogni nostra
conoscenza incomincia con l’esperienza; da che infatti
la nostra facoltà conoscitiva sarebbe stimolata al suo
esercizio se ciò non avvenisse per mezzo degli oggetti
che colpiscono i nostri sensi e, per un verso, danno origine da sé a rappresentazioni, per un altro, muovono
l’attività del nostro intelletto a paragonare queste rappresentazioni a riunirle o separarle e a elaborare in tal
modo la materia grezza delle impressioni sensibili, per
giungere a quella conoscenza degli oggetti chiamata esperienza? Nel tempo, dunque, nessuna conoscenza in
noi precede l’esperienza e ogni conoscenza comincia con
questa”1.
Qui Kant mostra di muoversi secondo le coordinate di una ben precisa e tradizionale linea di pensiero,
molto battuta in Occidente, che va da Aristotele alla
scolastica di Tommaso e giunge poi al suo tempo con
Locke, Berkeley e Hume, dal cui dubbio scettico, come
si sa, egli volle prendere le mosse.
Sono le tesi proprie dell’empirismo, rivedute e
corrette, però, dal suo trascendentalismo. Si pensi qui,
quale esemplificazione, all’effato della Scolastica: omnis cognitio incipit a sensu. L’incipit sta appunto a indi1
Kant, Critica della ragion pura, pp. 39-40.
63
care che la conoscenza, ogni conoscenza, trae la propria origine necessitata e necessitante dal “luogo” in
cui si compie l’esperienza sensibile. Altro effato significativo, anche per Kant stesso, è poi quello di Locke:
“nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu”, a
cui però già Leibniz aggiungeva, quale importante precisazione, che sembra fare da vero e proprio battistrada
alla stessa prospettiva kantiana della Critica: “…nisi intellectus ipse”.
L’effato della scolastica sta a significare che si
conosce alcunché solo a partire dall’esperienza che si
fa con i propri sensi. Ma cos’è esperienza? Per cercare
di dare risposta si finisce col prospettare una situazione dualistica ben precisa, che noi moderni abbiamo imparato a conoscere per lo meno da Cartesio in avanti,
secondo la quale l’esperienza consiste nella messa in relazione di un interno con un esterno, di un soggetto con
un oggetto.
Intesa allora, almeno “originariamente”, come esperienza la conoscenza consiste nella messa in contatto tra due, che sembrano distinti e ben diversi. Kant fa
riferimento, così, a un “che”, a un qualcosa che provoca
e pone in movimento e in essere. Ma cos’è questo aliquid? Si tratta in fondo di “oggetti che colpiscono i
sensi”. Detto diversamente, è un quid diverso e altroda-noi stessi che giunge a stimolare l’intero nostro
sensorio, dal momento che la provocazione può avvenire
per tutti i sensi.
Cos’è che accade al momento del contatto? Avviene la messa in relazione di sé (l’io) con altro-da-sé
64
(l’oggetto), che comporta due modalità: 1. il contatto
puro e semplice, in forza del quale dalle impressioni che
i sensi ricevono dagli oggetti si originano le rappresentazioni. Queste, di per sé, precisa Kant, sono “originate
da se stesse”, vale a dire nascono spontaneamente, automaticamente, in modo del tutto autonomo, rispetto al
soggetto conoscente; 2. oltre che ad essere contatto
tra oggetto percepito e soggetto percipiente la messa
in relazione con le rappresentazioni è una sorta di provocazione. Questo sta a significare che gli oggetti, che
sollecitano il sensorio, “muovono l’attività dell’intelletto” e lo spingono ad attivarsi, a compiere in tal modo il
suo specifico lavoro.
In un primo tempo pertanto gli oggetti sono attivi
nei confronti dei nostri sensi, che rimangono del tutto
passivi; in un secondo tempo, invece, gli oggetti, divenuti ormai rappresentazioni oggettuali (non più quel quid
indistinto, che imprime l’immagine sul sensorio), sottostanno a loro volta all’attività della Vernunft.
Vediamo di precisare in cosa consista l’attività
dell’intelletto. Kant parla di un “lavoro” relativo alle diverse rappresentazioni: il paragonarle, con attività di
comparazione e di equiparazione; il riunirle, proponendo
attività di collegamento; il separarle, con attività propria di differenziazione e di distinzione. Il lavoro sulla
materia grezza, proveniente dalla sensibilità è necessario, perché le stimolazioni percettive che avvengono
nel sensorio possano arrivare alla prima e fondamentale
conoscenza dell’oggetto, che è poi l’esperienza di esso.
65
2
Proseguiamo a leggere l’Introduzione: “sebbene
ogni nostra conoscenza cominci [incipit] con l’esperienza non perciò essa deriva tutta dall’esperienza. Infatti
potrebbe benissimo essere che la nostra conoscenza
empirica fosse un composto di ciò che noi riceviamo
dalle impressioni e di ciò che la nostra propria facoltà
di conoscere vi aggiunge da sé (stimolata unicamente
dalle impressioni sensibili); aggiunta che noi propriamente non distinguiamo bene da quella materia che ne è
il fondamento, se prima un lungo esercizio non ci abbia
resi attenti a essa, e non ci abbia scaltriti alla distinzione”1.
Detto che ogni conoscenza dell’uomo, che è spirito
incarnato immerso nella materia, ha origine di necessità dall’esperienza sensibile, c’è da aggiungere subito
dopo che non tutta la conoscenza può essere ricondotta e ridotta all’esperienza sensibile. Vale a dire: la conoscenza non trova spiegazione esaustiva in uno studio
concernente la sensibilità.
La stessa conoscenza sensibile, riconducibile naturalmente alle percezioni sensibili, non si riduce affatto a esse, perchè risulta essere un composto. Da
una parte si dà quel che noi riceviamo dall’esterno mediante le impressioni dei nostri sensi, in quanto soggetto percipiente, che sente il mondo oggettuale; dall’altra
si dà quel che sempre aggiungiamo per conto nostro, indipendentemente da quel che proviene dall’esterno e
che ci ha provocato: si tratta di altro rispetto a quel
1
Ivi, p. 40.
66
che sono le nostre pure e semplici impressioni sensibili.
In questo secondo caso il “noi” è da intendere come
struttura del soggetto che conosce tramite percezione
e sensazione, con modalità empirica. Qualcosa viene aggiunto proprio in forza del nostro lavoro, che si sviluppa, però, sulla scorta di quel che proviene dal di fuori.
Sono ora proposti due rilievi. Si dice anzitutto
qualcosa della facoltà, la quale “aggiunge da sé” solo a
patto che venga stimolata dalle nostre impressioni sensibili. Dunque la facoltà preposta alla conoscenza empirica non si attiva se non in forza e per virtù di una provocazione, che giunge dall’esterno; inoltre quel che proviene dal di fuori di noi stesi e quel che proviene dalla
nostra stessa facoltà costituiscono un composto. Questo sta a significare che si fa esperienza di un tutt’uno,
per cui è difficile distinguere in modo netto, con idee
chiare e distinte di stampo cartesiano insomma, quel
che noi stessi andiamo di volta in volta ad aggiungere,
proprio mediante la modalità formale del nostro conoscere. Mediante l’apparato conoscitivo modifichiamo
quella “materia grezza” o materia prima che qui è dichiarata Grund, fondamento, del conoscere, la sua condicio sine qua non, davvero indispensabile.
Per operare una distinzione tra interno ed esterno si richiede un lungo e faticoso esercizio d’indagine
della Critica, rivolto alla conoscenza di quelle forme pure che risultano di per sé indipendenti dall’esperienza e
dalle impressioni di tutti i sensi: sono le forme trascendentali, tutt’uno con la struttura del soggetto conoscente e percipiente. Tale conoscenza è a priori,
67
perché si distingue da quella empirica, che invece è a
posteriori, avendo origine, come si è visto sin dalle prime battute dell’Introduzione all’Estetica, soltanto in
seguito all’esperienza sensibile.
Scrive Kant: “noi dunque intenderemo in seguito
per conoscenze a priori non conoscenze siffatte che
abbiano luogo da questa o da quella esperienza, ma che
non dipendano assolutamente da nessuna esperienza. A
esse sono contrapposte le conoscenze empiriche, o tali
che sono possibili solo a posteriori, cioè per esperienza”1.
3
Si apre a questo punto un inciso, per noi di una
certa importanza, anche in vista di quella svolta in ambito conoscitivo che si è vista realizzata nel Discorso
sul metodo di Cartesio. Kant fa cenno a certe conoscenze che escono “dal campo di tutte le possibili esperienze e hanno l’apparenza di allargare l’ambito dei nostri giudizi al di là di tutti i limiti dell’esperienza per
mezzo di concetti a cui non si può dare in nessuna parte
di essa un oggetto corrispondente”2.
Qui si arriva a parlare, dunque, di conoscenze che
in certo qual modo trascendono il mondo della sensibilità, a tal punto che per i loro concetti non si danno mai
oggetti corrispondenti. Saremmo, dunque, al di là
dell’esperienza sensibile. A tali conoscenze l’uomo, poi,
annette la massima importanza. Scrive infatti in propo1
2
Ivi, p. 41.
Ivi, p. 44.
68
sito Kant che esse riguardano le investigazioni proprie
della ragione (Vernunft) umana, che “noi riteniamo di
gran lunga la più alta, e la loro meta molto più sublime
di tutto ciò che possa apprendere l’intelletto (Verstand) nel campo dei fenomeni”1.
Qui viene detto allora che tali conoscenze non sono più appannaggio dell’intelletto (Verstand), ma piuttosto della ragione (Vernunft): sarà la Critica della ragion pratica a occuparsi di tutti quei concetti, che sono
privi di oggetti corrispondenti, perché non hanno alla
loro “base” esperienze sensibili.
Quali sono queste conoscenze, proprie della
scienza metafisica? Sono i concetti o idee di Dio, della
libertà dell’uomo e dell’immortalità dell’anima, che riguardano rispettivamente teologia, etica e psicologia.
Pertanto, e concludendo, la prima Critica non sembra
aver nulla da dire circa tali concetti, dal momento che
non si posseggono rappresentazioni o impressioni sensoriali, non avendo mai fatto esperienza empirica di
nessuno di questi tre “oggetti”. Questi tre, infatti, non
sono oggetti di esperienza, in quanto non cadono in alcun modo sotto i nostri sensi. Teniamo bene a mente
questo inciso, davvero decisivo per mostrare il passo in
avanti di fondamentale svolta teoretica di Kant nel
pensiero moderno.
4
Dopo l’inciso, che marca in modo netto e inequivocabile la distanza dal pensiero cartesiano del Discorso
1
Ibidem
69
e delle Meditationes, torniamo ora all’Introduzione, per
concluderne la lettura.
Data la definizione di “trascendentale”, da noi già
considerata, Kant conclude sostenendo che oltre alla
sensibilità è da considerare anche quel che è il proprium dell’intelletto, volendo intendere la conoscenza
nella sua globalità. Leggiamo pertanto che “si danno due
tronchi dell’umana conoscenza, che rampollano probabilmente da una radice comune, ma a noi sconosciuta:
cioè senso e intelletto; col primo dei quali ci sono dati
degli oggetti, col secondo essi sono pensati”1.
Sembrano così darsi due possibili conoscenze;
meglio ancora, la conoscenza umana è unica, ma può distinguersi in sensibile e in intelligibile. Per il senso gli
oggetti di conoscenza sono dati, vale a dire s’impongono
all’apparato conoscitivo della sensibilità del soggetto
che li conosce; per l’intelletto, invece, gli oggetti sono
pensati, vale a dire che per il dato proveniente dalla
conoscenza sensibile arriva a realizzarsi una specifica
elaborazione da parte dell’intelletto, consistente nella
sua concettualizzazione.
Soltanto a questo punto la conoscenza umana risulta completa. Il fatto che, nonostante la distinzione
necessaria tra senso e intelletto, la conoscenza sia unica, viene sottolineato nel dire che sia l’una che l’altra
facoltà hanno la medesima origine. Da osservare, infine, la notazione circa la “radice comune” delle due facoltà conoscitive (sensi ed intelletto), che risulta “a noi
sconosciuta”. Si ricorderà qui come Cartesio invece
1
Ivi, p. 61.
70
credesse di poterla identificare nella ghiandola pineale,
all’interno del cervello.
5
La prima parte della Critica riguarda la teoria
trascendentale della sensibilità. Si tratta dell’Estetica
trascendentale, che studia le condizioni di possibilità,
indispensabili perché si dia conoscenza empirica.
Il nostro interesse per l’Estetica piuttosto che
per la Logica è dovuto al fatto che proprio in essa è delineato il rapporto diretto tra l’io e la realtà, tra soggetto conoscente e oggetto da conoscere o conosciuto;
viene insomma proposta la relazione con l’oggetto dato
o con il dato dell’oggetto.
Leggeremo alcuni brani della prima parte
dell’Estetica e successivamente i Paralogismi, esclusi
dalla seconda edizione della Critica, che riguardano
proprio il rapporto tra l’io che conosce e il mondo esterno, oggetto di conoscenza. Nel primo paragrafo
troviamo scritto: “in qualunque modo e con qualunque
mezzo una conoscenza si riferisca a oggetti, quel modo,
tuttavia per cui tale riferimento avviene immediatamente e che ogni pensiero ha di mira come mezzo, è
l’intuizione”1.
Anzitutto qui si fa questione di una conoscenza,
che faccia riferimento a oggetti di esperienza. Si precisa poi che diverse sono le modalità del conoscere, ma
che se ne dà una in particolare che propone un riferimento della conoscenza al suo oggetto, in modo presso1
Ivi, p. 65.
71
ché immediato; tale messa in relazione tra soggetto
che conosce e oggetto da conoscere è un medium che il
pensiero deve privilegiare, in vista di una conoscenza
completa e compiuta. La conoscenza immediata è data
dall’intuizione (Anschauung), che è una specie di “colpo
d’occhio” percettivo: consiste nel fatto dell’intuizione,
quello che informa la materia “grezza” dell’esperienza,
mediante le forme di spazio e di tempo. Essa poi fa da
medium tra oggetti di esperienza e pensiero, poiché si
riferisce all’oggetto immediatamente, mentre il pensiero lo fa mediatamente per il tramite, appunto,
dell’intuizione.
Prosegue, poi, Kant: “ma questa [l’intuizione] ha
luogo soltanto a condizione che l’oggetto ci sia dato; e
questo [l’oggetto dato], a sua volta, è possibile, almeno
per noi uomini, solo in quanto modifichi, in certo modo
lo spirito. La capacità (ricettività) di ricevere rappresentazioni per modo in cui siamo modificati dagli oggetti, si chiama sensibilità”1.
Cos’è che fa lo spirito umano, l’io dell’uomo, per intuire? Com’è che può darsi l’intuizione, vale a dire la
percezione della materia oggettuale? Risulta indispensabile una condizione, senza la quale non potrebbe darsi
alcuna intuizione. L’oggetto, che è il contenuto stesso
dell’intuizione sensibile, è a noi dato: questo sta a significare che essa non può in alcun modo essere intesa
quale visione, frutto di immaginazione e di fantasia
creativa dell’io penso. Ancora più precisamente: il fatto
che l’oggetto si dà (es gibt) a noi in modo autonomo, in1
Ibidem
72
dipendentemente dalla nostra volontà soggettiva, è
possibile solo a patto che il nostro spirito venga modificato proprio da esso. E cioè, il fatto che l’oggetto
s’imponga a noi è tutt’uno con la modifica che avviene
nel nostro essere. L’io viene dunque modificato da quel
che gli risulta esterno, così come esso stesso arriva a
modificare l’altro da sé.
Si precisa poi che tutto ciò accade “almeno per
noi uomini” (la precisazione è apportata alla seconda edizione della Critica), a noi che non siamo “puri”, ma
spiriti incarnati nella materia e interagenti con essa,
dunque dipendenti fondamentalmente e originariamente
dalla sensibilità. È proprio alla sensibilità che si rivolge
un’ultima osservazione: l’intuizione è prodotto peculiare
della facoltà di essere modificati dagli oggetti, ricevendo immagini e rappresentazioni di cose dall’esterno.
Tale facoltà è la sensibilità.
Notiamo subito come qui si faccia riferimento
semplicemente e soltanto a un primo contatto che avviene tra realtà esterna e interno dell’io-soggetto: si
tratta infatti della percezione dell’oggetto. Non si dà
ancora, allora, una conoscenza sensibile vera e propria,
che si avrà soltanto nella sensazione, nella considerazione non solo dell’attività dell’oggetto sull’io, ma anche
del fatto che la struttura conoscitiva viene modificata
proprio in forza di tale attività. In conclusione, l’intuizione è altra cosa rispetto alla conoscenza, anche intesa semplicemente come conoscenza sensibile.
Viene poi detto che quell’oggetto fornito dal senso tramite intuizioni e rappresentazioni è in seguito
73
pensato dall’intelletto, che elabora le rappresentazioni
in concetti. Kant insiste con la solita annotazione, in
stretta relazione al fatto primo e indubitabile che omnis cognitio incipit a sensu: il pensiero, di stretta necessità e in qualsiasi modo diretto o indiretto, deve rifarsi sempre a intuizioni e pertanto alla sfera della
sensibilità. Esso coglie infatti l’oggetto di conoscenza
con concetti solo tramite il medium dell’intuizione sensibile. È così allora che noi non possiamo avere a che
fare con alcun oggetto da conoscere, se l’oggetto stesso non ci è dato o non si dà a noi nell’intuizione sensibile. Anche in questa nota, poi, si insiste sul fatto che si
debba far riferimento a una radice comune e fonte di
per sé sconosciuta, che è condizione prima e indispensabile per qualsiasi conoscenza umana.
6
Proseguiamo la nostra lettura: “l’azione di un oggetto sulla capacità rappresentativa in quanto noi ne
siamo affetti è sensazione. Quella intuizione che si riferisce all’oggetto mediante sensazione, dicesi empirica. L’oggetto indeterminato di una intuizione empirica
si dice fenomeno”1.
Nella percezione, come si è visto, avviene il primo
contatto tra l’io e la realtà del mondo, che, però, può
essere considerato da due diversi punti di vista: da
parte dell’oggetto e da quella del soggetto. Abbiamo
già detto del primo e si è mostrato come l’oggetto in
quanto dato, modifichi lo spirito dell’uomo, imponendosi
1
Ibidem
74
con le sue impressioni, tramite immagini e rappresentazioni. Infatti l’oggetto risulta attivo, mentre il soggetto ricevente è passivo.
Ora Kant considera il secondo punto di vista. Dice
infatti che si deve anche far riferimento all’azione
dell’oggetto dato sulla nostra facoltà di rappresentare
“in quanto noi ne siamo affetti”, vale a dire che dobbiamo tenere in debita considerazione le conseguenze
del contatto ex parte subjecti. È così che arriviamo a
occuparci della sensazione. Pertanto, mentre la percezione comporta mera passività dell’io, la sensazione implica un processo che vede l’io sempre attivo.
Infine, si è letto che l’oggetto indeterminato, vale
a dire qualunque oggetto, contenuto in una intuizione
empirica, che trova corrispondenza nell’esperienza sensoriale, viene definito da Kant fenomeno.
“Fenomeno” è Erscheinung e sta a indicare “quel
che si manifesta, che appare”. Nell’Estetica kantiana il
termine è da leggere in stretta connessione ad Anschauung, intuizione. Anschauung, da schauen guardare,
sta a indicare “quel che è guardato”, mentre Erscheinung indica piuttosto “il da guardare”, “quel che appare,
perché sia visto/guardato”. E difatti l’Erscheinung è
l’oggetto di un’Anschauung, vale a dire che il fenomeno
è oggetto di visione intuitivo-percettiva. Fenomeno è
oggetto di percezione, oggetto primordiale di conoscenza, dal momento che l’atto percettivo mette in
contatto, in un primo contatto, l’io con la realtà.
Proseguiamo ora l’esame del testo kantiano. Nel
fenomeno Kant distingue due elementi, che comunque
75
risultano inscindibilmente connessi l’un l’altro: la materia, che corrisponde alla sensazione, e la forma, che
corrisponde al fatto che la molteplicità delle rappresentazioni materiali e sensibili sia di fatto ordinata “in
determinati rapporti”1.
Si propongono qui alcune notazioni: 1. la forma, vale a dire l’ordine che le rappresentazioni sensibili assumono di volta in volta, non può essere a sua volta oggetto di sensazione, perché non può darsi esperienza
alcuna di una forma qua tale; 2. la materia del fenomeno è data sempre a posteriori, e cioè essa è relativa a
un oggetto dato, di cui si ha intuizione e percezione solo in forza di un’esperienza; 3. la forma del fenomeno,
invece, si trova bell’e pronta nello spirito umano come a
priori, essendo parte ricettiva delle rappresentazioni.
Essa prescinde da ogni possibile sensazione, precede la
sensazione e pertanto risulta da essa separata.
Ciò detto, Kant ipotizza ad experimentum un doppio processo di astrazione. Si formula così l’ipotesi di
avere la rappresentazione di un corpo, vale a dire di
essere alle prese con l’intuizione e con l’esperienza di
un oggetto reale, dunque materiale. Proviamo allora a
separare da tale rappresentazione: a. quel che ne pensa
l’intelletto, vale a dire quel che il Verstand aggiunge
all’oggetto dato, mediante la sua specifica modalità di
conoscenza, secondo lo schematismo trascendentale; b.
quel che appartiene alla sensazione, vale a dire quel che
il sensorio tutto aggiunge, mediante la specifica moda-
1
Ivi, p. 66.
76
lità del percepire, con l’impenetrabilità dei corpi, la durezza, il calore dell’oggetto dato, ecc.
Ebbene, operate tali “sottrazioni” e decurtazioni,
non tutto sembra vanificare, perché qualcosa pur sempre rimane. Non arriviamo, cioè, ad annullare in toto le
rappresentazioni da cui siamo partiti nella nostra ipotesi sperimentale. Dalla intuizione epirica, cui si è sottratto il lavoro concettuale dell’intelletto e la precedente e necessaria elaborazione del sensorio, rimane la
forma che “ha luogo a priori nello spirito, anche senza
un attuale oggetto dei sensi, o una sensazione quasi
semplice forma della sensibilità”1.
Lo studio delle forme pure della sensibilità è affidato all’estetica trascendentale, che costituisce la
prima parte della dottrina trascendentale degli elementi ed è da distinguere dal sapere che invece contiene e studia i principi del pensiero puro, la logica trascendentale: “in questa ricerca si troverà che vi sono
due forme pure di intuizione sensibile come principi
della conoscenza a priori, cioè spazio e tempo”2.
7
Non andiamo oltre la nostra considerazione della
Critica, ma leggiamo il § 8 su Osservazioni generali
sull’estetica trascendentale. Kant riepiloga il suo pensiero circa la natura stessa della conoscenza sensibile,
intesa in termini molto generali. Elenchiamo qui di se-
1
2
Ibidem
Ivi, p. 67.
77
guito quei punti fermi che sono stabiliti e che fungono
per noi da riepilogo di quanto si è detto:
1.
la nostra intuizione altro non è se non la rappresentazione di un fenomeno, vale a dire il nostro
modo di cogliere e, poi, di dire tutto quel che ci
appare;
2.
abbiamo intuizione delle cose, le quali, proprio in
quanto oggetto, sono altro rispetto a quel che noi
siamo in grado di cogliere effettivamente di esse;
3.
oltre alle cose, esistono poi le relazioni tra le cose
stesse, che costituiscono il mondo, la realtà complessa e globale delle cose-di-mondo. Anche queste relazioni sono diverse, di per sé, da quel che
ci appaiono; sono dunque da distinguere rispetto
ai fenomeni. Pertanto i rapporti tra le cose sono
altro rispetto a quella rappresentazione, che sappiamo intercorrere tra esse;
4.
formuliamo ora l’ipotesi della scomparsa dell’uomo
dalla faccia della terra. Verrebbe così a mancare
quel soggetto che percepisce, facendo esperienza
di mondo. Oppure, e più semplicemente, facciamo
l’ipotesi della soppressione, anche solo momentanea, della “natura soggettiva dei sensi in generale”1: quale conseguenza avremo che la natura, i
rapporti tra le cose della realtà e, finalmente, le
forme pure di spirito e di tempo svanirebbero addirittura nel nulla;
1
Ivi, p. 83.
78
di conseguenza, “i fenomeni non possono esistere
in sé, ma soltanto in noi”1. Se, per ipotesi, venissimo meno noi, non esisterebbero neppure più i
fenomeni naturali, i rapporti tra le cose e le intuizioni pure di spazio e di tempo.
Fatte queste precisazioni e stabiliti così dei punti
fermi, Kant deduce, e in certo qual modo sembra costretto a farlo, che è per noi del tutto “sconosciuto e
inoltre è proprio inconoscibile quel che ci possa essere
negli oggetti in sé e separati dalla ricettività dei nostri
sensi”2.
Degli oggetti, o cose di mondo, noi riusciamo a conoscere soltanto, mediante intuizioni empiriche, quel
che a nostro modo percepiamo. Viene poi puntualizzato
che tale modalità di ricezione non appartiene a ogni essere, ma solo a noi uomini. Da notare in questo discorso
l’importanza del modo di percepire, assieme a quella
dell’intuizione, a motivo del fatto che noi possiamo avere a che fare solo con esso, si può arrivare a conoscere
solo quel che concerne il modo di percepire gli oggetti
e non gli oggetti stessi.
Di tale modalità si distinguono, come a suo tempo
si è visto, delle forme pure (spazio e tempo) di una materia, che risiede nella sensazione degli oggetti dati,
all’apparenza a noi esterni, o che almeno vengono sentiti come tali. Le forme sono colte a priori e corrispondono all’intuizione pura, mentre la materia viene invece
colta a posteriori e corrisponde all’intuizione empirica.
5.
1
2
Ibidem
Ibidem
79
A questo punto Kant nota che anche se portassimo la nostra intuizione al più alto grado di chiarezza,
non potremmo mai arrivare a conoscere null’altro all’infuori del nostro modo di intuire o di percepire, nelle
particolari e peculiari condizioni di spazio e di tempo.
Conclude pertanto: “ma che cosa possano essere
gli oggetti in se stessi, per illuminante che sia la conoscenza dei fenomeni, che soltanto ce n’è data, non ci
sarebbe mai noto”1. Per quanto arriviamo a rendere
chiara la conoscenza sensibile e intuitiva relativa agli
oggetti per noi, vale a dire ai fenomeni (è l’oggetto che
ci appare, oggetto per la nostra rappresentazione sensibile), non potremo mai arrivare a conoscere gli oggetti in se stessi e per se stessi.
Più avanti, poi, Kant fa notare che comunque viviamo sempre nella illusione di poter arrivare a conoscere le cose in sé, mentre invece, si ribadisce, malgrado le più attente ricerche, non possiamo pervenire
che ai fenomeni. Si conosce empiricamente non tanto il
mondo reale, quanto piuttosto il mondo fenomenico.
8
Concludiamo la lettura del § 8 sulle Osservazioni
generali, con un’ulteriore precisazione, che concerne il
fenomeno. Si torna così a ribadire che mediante le
forme pure di spazio e di tempo, vale a dire mediante
l’intuizione degli oggetti esterni, e mediante l’intuizione
che lo spirito ha di sé stesso con l’aiuto del senso in-
1
Ivi, p. 84.
80
terno, si approda alla percezione non tanto di oggetti in
sé, quanto piuttosto del modo in cui essi appaiono a noi.
Viene fatta la seguente precisazione: il fatto che
ci troviamo ad avere a che fare con oggetti così come
appaiono, non sta a significare affatto che gli oggetti
che arriviamo in tal modo a conoscere siano una pura e
semplice parvenza.
In Kant “fenomeno” è Erscheinung, mentre invece
Schein è “parvenza”. Apparenza/parvenza è qui considerata come qualcosa che, alla prova dei fatti, risulta
fuorviante e illusoria. Troviamo infatti scritto che “sarebbe un errore se facessi una pura parvenza di ciò
che invece devo considerare come fenomeno”1.
Nel fenomeno gli oggetti, e assieme a essi le qualità che noi attribuiamo loro, sono da considerare come
effettivamente dati. Solo pertanto per il fatto che le
qualità dipendono unicamente dal modo di relazionarsi
del soggetto all’oggetto che l’oggetto stesso in questione ha da essere distinto, proprio in quanto fenomeno, dall’oggetto in sé. I predicati o qualità del fenomeno vengono attribuiti all’oggetto da conoscere in relazione e dipendenza dal nostro senso. Dunque, quel che
viene detto del fenomeno è strettamente connesso al
rapporto tra oggetto e soggetto conoscente, a quel
primo contatto che avviene tra la realtà mondana e l’io.
Si pensi a esempio al color rosso di una rosa: l’oggetto
“rosa” è rosso soltanto in quanto entra in relazione con
la sensibilità del nostro “io”.
1
Ivi, p. 90. Altre traduzioni rendono con “apparenza” il termine Er-
scheinung, ma poi fanno corrispondere Schein a “illusione”.
81
Kant nota così come l’attribuzione di predicati
all’oggetto può avvenire solo mediante il rapportarsi
con il senso. Proviamo a dirlo diversamente: non si può
attribuire di per sé un qualsiasi predicato, il medesimo
predicato di un fenomeno all’oggetto inteso quale “semplice parvenza”, all’oggetto di cui non si ha esperienza
sensibile. In quest’ultimo caso, infatti, “si verrebbe ad
attribuire all’oggetto per sé, ciò che invece gli può convenire solo in rapporto ai sensi o in generale al soggetto”1.
Qui Kant ribadisce con efficacia quanto già detto
precedentemente a proposito di realtà e di idealità, di
realtà empirica e di idealità trascendentale di spazio e
di tempo, in relazione al fenomeno, vale a dire
all’oggetto per noi della conoscenza empirica. Troviamo
così scritto che “fenomeno è ciò che non appartiene
all’oggetto in se stesso, ma si trova sempre nel rapporto di esso [oggetto] col soggetto ed è inseparabile dalla rappresentazione di questo [soggetto]”2.
Pertanto il fenomeno, inseparabile dalla rappresentazione che di esso si fa il soggetto conoscente, di
per sé non appartiene all’oggetto dato, ma neppure si
può sostenere, nota Kant, che appartenga al soggetto.
Ci si pone così sia contro il realismo ingenuo, sia contro
l’idealismo acritico e assoluto. Si dà fenomeno, allora,
soltanto e unicamente all’interno di una ben precisa relazione tra soggetto e oggetto, nel contatto tra i due
1
2
Ibidem
Ivi, p. 90.
82
protagonisti, entrambi necessari per la intuizione empirica.
Quando si crede di poter attribuire predicati agli
oggetti in sé e per sé considerati, e non agli oggetti per
i nostri sensi, ignorando così il rapporto indispensabile
dell’oggetto in questione con il soggetto (ignorando che
l’oggetto è sempre e soltanto oggetto per noi), allora
non ci troviamo più alla presenza di una fenomeno, ma
di una parvenza o di una illusione. È l’illusione che possa
esistere, che si dia a noi, una realtà a se stante, indipendente dal nostro io che tende a conoscerla; meglio
ancora, ci si illude che possa essere conosciuta una realtà esterna qua tale, vale a dire staccata da ogni relazione con il noi soggetto che conosce.
Pertanto, e concludendo, un quid che sia altro, totalmente altro da noi potrà pure esistere, ma al di fuori del suo darsi a noi esso sarebbe per noi irraggiungibile, proprio perché alterità assoluta, ab-soluta sciolta
da condizionamenti, e cioè svincolata da qualsiasi relazione.
Accade infatti che proprio nel momento in cui noi
giungiamo a descrivere e a conoscere l’oggetto dato
quale oggetto altro, noi lo rielaboriamo e lo trasformiamo di stretta necessità. Questo altro da noi, allora,
da realtà in sé e per sé diviene, mediante trasformazione empirica, una realtà per noi.
Con Kant di fatto è impossibile portare l’indagine
sulla realtà tout court; non è poi nemmeno possibile,
però, indagare sul soggetto per sé considerato (si è visto, difatti, come Kant sia contro il realismo, ma anche
83
contro l’idealismo). Il “luogo” teoretico in cui è possibile e necessario condurre l’indagine, allora, è quello del
rapporto tra soggetto e oggetto, chiarendo però che
non si è mai collocati in una posizione del tutto neutrale, perché pur sempre situati dal punto di vista del soggetto stesso.
In tale luogo arrivano a costituirsi sia la realtà
oggettuale per noi, il mondo dei fenomeni, sia il soggetto conoscente, che non esiste mai quale struttura vuota, del tutto priva di un qualsiasi contenuto.
84
PARTE
SECONDA.
HUSSERL, I
1
Platone, Cartesio e Kant sembrano indirizzarci al
dialogo con un altro filosofo, Edmund Husserl.
La filosofia, ci dice Platone, ha origine nel thaumazein, il “provar stupore” al cospetto dei phainomena,
di fronte alle “apparenze” delle cose. Cartesio, poi, si
chiede se e come possiamo assicurarci che le rappresentazioni mentali, quel che ci appare nella sfera dell’immaginario, siano reali, quale corpo-altro rispetto al
nostro “io penso” (cogito). Kant sembra voler evitare
dubbi, confusioni e situazioni teoretiche di stallo: con
l’esclusione di Dio quale “oggetto” di discorso si pone
nell’impossibilità di assicurarsi la garanzia della verità
come adaequatio. Egli opera così una decisa e netta
scelta di campo a favore del soggetto conoscente, sostenendo di voler portare l’indagine unicamente sulla
struttura trascendentale dell’io penso, dal momento
che le cose, gli oggetti intesi in sé e per sé e di cui c’è
comunque da ipotizzare l’esistenza, gli oggetti che si
danno a noi, sono di fatto inconoscibili.
Nel pensiero contemporaneo Edmund Husserl è
quel pensatore che potrebbe a buon diritto essere definito il “continuatore”, anche se critico come si vedrà,
di Cartesio e di Kant, proprio per il suo intento di elaborare una fenomenologia trascendentale.
Da Cartesio egli eredita, con la sua epoché, il
dubbio metodico; da Kant, invece, l’attenzione al fenomeno, anche se si dovrà marcare una ben precisa di-
85
stinzione tra fenomenologia trascendentale husserliana
e trascendentalismo kantiano.
2
Per introdurci al pensiero di Husserl, occupiamoci
di un breve scritto del 1910, uno dei primi da lui pubblicati, in certo qual modo programmatico, intitolato La
filosofia come scienza rigorosa. In esso si delinea una
di quelle che saranno poi le idee guida del pensiero husserliano: l’idea che ha della filosofia il pensatore, in relazione agli altri saperi e alle altre scienze.
Leggiamo la Premessa: “fin dal suo primo inizio la
filosofia ha preteso di diventare scienza rigorosa, anzi
di esser tale scienza da poter soddisfare alle più alte
esigenze teoretiche e di render possibile, da un punto
di vista etico-religioso, una vita guidata da norme razionali pure. È questa una pretesa che si è fatta valere
or con maggiore ed or con minore energia, ma che non è
mai stata abbandonata, nemmeno nel tempo in cui gli
interessi e le attitudini per la teoria pura han minacciato di rovinare, o in cui le forze della religione hanno
vincolato la libertà della ricerca teoretica”1.
La filosofia ha da sempre preteso di poter divenire scienza rigorosa, anche quando ha creduto di poter
svolgere il compito di guida con norme razionali, elaborate però da un punto di vista etico e/o religioso; tale
pretesa non è mai stata abbandonata, anche quando le
“forze della religione” hanno in certo qual senso contri1
E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, Torino, Paravia,
1958, p. 1.
86
buito a inquinare la ricerca teoretica, vale a dire quando la filosofia si è mossa in “luogo” teologico.
Insomma, l’ethos proprio della moderna filosofia
consiste nel fatto che essa tende ad affinare sempre
più la propria metodologia, per arrivare finalmente a
costituirsi come scienza rigorosa: “ma l’unico frutto
maturo di questi tentativi è stata la fondazione e
l’autonomia delle scienze rigorose della natura e dello
spirito, insieme a nuove discipline matematiche”1.
Dunque le scienze, sia quelle della natura sia quelle dello spirito, acquistano sempre maggiore rigore,
mentre la filosofia, che pure continua a mantenere con
tali saperi un certo rapporto, a tal punto che almeno
per le scienze dello spirito si è indotti a dubitare della
loro autonomia da essa, non consegue rigore: “il senso
proprio dei problemi filosofici non ha mai raggiunto il
livello di una spiegazione scientifica”2. Questo capita,
nonostante che la filosofia rappresenti “l’immortale
pretesa dell’umanità a una conoscenza pura e
assoluta”3.
Inoltre la filosofia, proprio perché non produce
conoscenze certe, è incapace di un insegnamento che
abbia validità oggettiva. È interessante notare come
qui Husserl citi Kant (si tratta della medesima citazione, a suo tempo da noi stessi proposta), il quale nell’Antropologia pragmatica sosteneva che non si può insegnare la filosofia, ma soltanto a filosofare, propo1
2
3
Ivi, p. 2.
Ibidem
Ivi, p. 3.
87
nendo così una sorta di “pratica teorica” o una metodologia del pensiero. Questo accade proprio perché la filosofia non è (ancora) una scienza. Se invece lo fosse,
sarebbe comunicabile e pertanto anche insegnabile: “se
la filosofia non la si può apprendere, gli è perché essa
non presenta vedute intellettuali fondate e comprese
in maniera oggettiva, cioè perché essa manca tutt’ora
di problemi, metodi e teorie che siano concettualmente
ben determinati”1.
Si discetta ancora sulla differenza tra scienze e
filosofia. La filosofia non è affatto da considerare una
scienza imperfetta, perché non è affatto una scienza:
come tale, insomma, non ha ancora cominciato a esistere. Tutte le scienze, in fondo, sono da considerare imperfette, eppure nessuno può certo “dubitare della verità oggettiva (o anche della probabilità oggettivamente fondata) delle teorie matematiche e scientifiche”2.
Nel campo delle scienze non c’è più posto per “opinioni, intuizioni e punti di vista particolari di qualcuno”3. Se questo capita in campo scientifico, si dice che
il sapere con cui si ha a che fare deve ancora assurgere
al rango di autentica scienza. La filosofia non è scienza,
perché ancora “imperfetta”, ma perché in essa “tutto è
soggetto a controversia, ogni presa di posizione è solo
frutto di convinzione personale o di interpretazione
1
2
3
ibidem
Ivi, p. 4.
Ibidem
88
propria di una scuola, tutto è questione di punto di vista”1.
Si cominci qui col notare come Husserl sostenga, a
nostro avviso giustamente, come la filosofia da sempre
sia stata fatta coincidere con l’ermeneutica; inoltre sostiene che la filosofia, proprio per il fatto che intenda
proporsi come scienza, debba puntare alla ricerca di
una “verità oggettiva”, non più soggetta alle opinioni di
ciascuno e di tutti, e dunque al di fuori da una prospettiva ermeneutica, fondata sempre e immancabilmente
su un punto di vista che è relativo.
3
Ci si chiede poi se la filosofia voglia (e possa)
mantenersi fedele allo scopo di diventare scienza rigorosa. Per il suo progresso in questa direzione sono decisivi i momenti storici in cui avvengono vere e proprie
rivoluzioni epistemologiche, dovute al fatto che dei
pensatori criticano alla radice metodologica le pretese
che hanno le filosofie precedenti di costituirsi come
“scienze”.
Husserl fa cenno al “rivolgimento” socraticoplatonico, alla rivoluzione di Cartesio, agli albori del
pensiero moderno, in reazione alla scolastica e infine
alla più radicale critica della ragione in Kant. Nella filosofia romantica, però, tale atteggiamento muta. Hegel,
a esempio, da una parte tiene ferma la validità oggettiva e assoluta del suo metodo di ricerca e della sua dottrina, d’altra parte, però, mancando il suo sistema di
1
Ivi, p. 5.
89
un’adeguata critica della ragione, che è l’unica a rendere possibile la scientificità in filosofia, arriva addirittura a falsificare la tendenza della filosofia a costituirsi scienza rigorosa.
Dopo Hegel si affermano il naturalismo e lo storicismo, che con il loro scetticismo negano la validità assoluta della parola filosofica, ridotta oramai a Weltanschauung. Si è così pervenuti a una sorta di deviazione
psicologico-irrazionalistica dell’impulso filosofico, con
accentuazione della soggettività e perdita conseguente
del valore scientifico. Ogni filosofia troverebbe, infatti, il suo valore e la sua giustificazione soltanto nella
relazione al proprio tempo storico. Fatta questa premessa, in due brevi capitoli Husserl critica la “filosofia
naturalistica” e lo storicismo o filosofia della Weltanschauung.
Portiamo ora la nostra attenzione alla Conclusione,
dove si ipotizza una svolta della filosofia moderna, che
prende le distanze dall’atteggiamento scettico per instradarsi verso la scienza, fondandosi oramai su basi
sicure e seguendo un metodo finalmente rigoroso.
La scienza è un valore. Anche la Weltanschauung
naturalmente lo è, ma si tratta di stabilire una netta
differenza tra le due Weltanschauung è un habitus
fondato sulla singola e individuale personalità, mentre
la scienza è una “formazione collettiva”, creatasi mediante il lavoro di generazioni di scienziati. Essendo diversa la fonte stessa del valore, restano distinte le
funzioni, il modo di operare e di insegnare.
90
La Weltanschauung “insegna nello stesso senso in
cui insegna la saggezza; una personalità si rivolge ad
un’altra; come maestro, secondo lo stile di questa filosofia, può rivolgersi alla più ampia sfera di pubblico sol
colui che vi sia chiamato per una particolarità significativa del suo carattere e per saggezza propria”1.
La scienza, invece, è impersonale: gli operatori
scientifici non hanno bisogno di essere o risultare
“saggi”, ma di possedere doti teoretiche. Leggiamo così
che “profondità è affare di saggezza, chiarezza scientifica è affare di teoria rigorosa. Il processo essenziale della ricostituzione della scienza rigorosa sta nel
trasformare le intuizioni profonde in forme razionali
inequivocabili. Anche le scienze esatte ebbero il loro
lungo periodo di “profondità”, e come le scienze nelle
lotte del Rinascimento, così, oso sperare, la filosofia
nelle lotte del nostro tempo passerà dallo stato della
profondità a quello della chiarezza scientifica”2.
La scienza, quale valore, è una realtà che s’impone
nel nostro tempo storico; è anche per questo motivo
che s’intende pervenire a una filosofia che sia scienza,
perché essa stessa acquisti realtà e rigore. Per conseguire tale scopo bisogna soddisfare alcune condizioni.
Anzitutto “non accettiamo nulla come già dato, né lasciamo valere come punto di partenza quel che ci è stato tramandato e che non ci lasciamo abbacinare dalla
grandezza di un Nome, ma in pura dedizione al problema stesso e alle istanze che ne derivano, cerchiamo di
1
2
Ivi, p. 81.
Ivi, p. 82.
91
guadagnare il cominciamento; così ci saremo attenuti al
radicalismo che è proprio ed essenziale alla autentica
scienza filosofica”1.
Analogamente a quel che osserva Cartesio nel suo
Discorso, Husserl prende le distanze dalla tradizione,
da quel che è il gia dato delle filosofie precedenti.
Nemmeno l’autorità dell’ipse dixit potrebbe indurci a
credere in qualcosa che appartiene a una Weltanschauung, piuttosto che a una verità scientifica. Husserl si rende ben conto che la sua posizione, tesa a esser dediti unicamente “al problema stesso [della filosofia come scienza] e alle istanze che ne derivano”, si attiene al radicalismo, perché propone uno stacco netto
rispetto alla storia del pensiero occidentale.
Certo la storia potrà essere ancora di aiuto, ma
solo perché si possa essere in qualche modo ispirati
dalle analoghe svolte teoriche accadute nel tempo e dal
loro “contenuto spirituale”, che testimoniano della vitalità della filosofia in ogni tempo. Leggiamo, così, che
“non diventiamo filosofi attraverso le filosofie. Rimanere legati alla storia, cercare di occuparsene in
un’attività storico-critica, e voler raggiungere la scienza filosofica, mediante un’elaborazione eclettica o in un
anacronistico ”rinascimento”, tutto ciò non porta che a
tentativi senza speranza. L’impulso alla ricerca non de-
ve provenire dalle filosofie, ma dalle “cose” e dai problemi”2.
1
2
Ivi, p. 83.
Ibidem
92
4
La filosofia deve svolgere finalmente il suo compito radicale, risalendo sino ai suoi principi e alle sue origini. Deve conseguire lo scopo di pervenire al cominciamento: “i suoi assolutamente chiari problemi, i metodi
delineati entro il significato proprio di questi problemi,
e prima che abbia trovato il campo ultimo di lavoro, in
cui si danno le “cose” con chiarezza assoluta”1.
C’è una precisazione che riguarda le “cose”. Husserl invita a non scambiare le “cose” cui fa riferimento
con i fatti empirici, perché l’attenzione ai fatti, tipica
di un ingenuo e superficiale pragmatismo, dimentica
che la scienza filosofica ha sempre piuttosto a che fare con idee, che “sono date in gran copia e in maniera
assoluta alla intuizione immediata”. Si tratta allora di
prendere atto delle cose-di-pensiero, non venendo però
mai meno al principio della “radicale assenza di pregiudizio”.
Infine una nota circa il metodo. Ciascuno deve oramai “vedere con i propri occhi”, non falsando sotto
l’effetto di pregiudizi quel che effettivamente si è visto. Circa i metodo, e proprio a motivo dell’idea di visione ora delineata, Husserl prende le distanze dalle
scienze fisico-matematiche, che pure apparivano costituire un vero e proprio modello.
Leggiamo che “poiché è nelle più notevoli scienze
moderne, nelle scienze fisico-matematiche che la parte
esteriorizzante più grande di lavoro procede secondo
1
Ivi, p. 84. Si consideri qui l’analogia con la prospettiva cartesiana
dell’ideale dell’evidenza e della chiarezza e distinzione delle idée.
93
metodi indiretti, noi siamo portati a sopravvalutare i
metodi indiretti e a disconoscere il valore delle prensioni dirette”1.
La realtà non viene colta dalla ragione filosofica e
scientifica indirettamente, ma mediante “prensione”
diretta, la “prensione [intuizione] fenomenologica di
essenza”, che ottiene “una gran quantità di conoscenze
rigorosissime, decisive per ogni ulteriore filosofia”.
Si noti qui, anzitutto, la netta presa di distanza
dal Kant della Critica della Ragion Pura, il quale sostiene che il Verstand e la Vernunft non contattano direttamente la realtà oggettuale, ma solo indirettamente.
Ancora di più: Kant parla di “intuizione pura” quale condizione di possibilità dell’esperienza sensibile, per una
conoscenza non ancora proposta nella sfera
dell’eidetica, il campo proprio della Logica.
Husserl, invece, sta qui parlando della scienza filosofica, fondata sull’esercizio della ragione e sostiene
l’idea metodologica di una visione delle cose in presa diretta per una “prensione” delle essenze (eide), che appaiono a noi per quel che sono, al di qua degli eventuali
pregiudizi che su di esse si possano avere.
Inoltre Husserl individua in questo sapere primo
della fenomenologia di essenze il principio e il fondamento di ogni filosofia che voglia trovare i modi di costituirsi come scienza rigorosa: la fenomenologia trascendentale come filosofia prima, dunque.
1
Ivi, p. 84.
94
5
La Filosofia come scienza rigorosa, un testo programmatico di Husserl, non è certo però il suo primo
scritto. Il saggio fa da spartiacque tra i primi e importanti scritti husserliani e le opere che potremmo definire della maturità.
Si è detto come le due parti centrali del testo,
dedicate a una critica del naturalismo e dello storicismo, siano indicative della temperie in cui andava a inserirsi la problematica husserliana. Vediamo ora le cose
più da vicino, vale a dire valutiamo il particolare climax
culturale che il giovane Husserl viveva per comprendere meglio la sua stessa reazione e la ricerca conseguente di una metodologia teoretica di innovazione.
La fenomenologia husserliana nasce nel periodo
convenzionalmente detto della “reazione al positivismo”, tra la fine dell’800 e i primi trenta anni del ‘900.
Dopo il crollo degli ambiziosi propositi dell’idealismo, si
assisteva ora alla radicale messa in crisi dei principi
stessi del positivismo. In particolare Husserl prende le
distanze in modo netto dal naturalismo empirista, che
faceva da base teoretica alle scienze positive della natura.
Reagendo al positivismo, la fenomenologia husserliana, poi, carezza l’ambizioso proposito di mettere in
questione la tradizione scientifica europea, per aprire
la strada a una filosofia prima, che possa proporsi sino
in fondo come rigorosamente scientifica e fare così da
supporto indispensabile, poi, per qualsiasi scienza.
95
I primi interessi di Husserl sono matematici, sulla
scorta e sulle indicazioni del suo maestro Brentano.
Nella Filosofia dell’aritmetica (1891) egli entra nella
polemica assai viva nella Germania del tempo tra psicologisti e logicisti. Le origini della controversia sono antiche e tradizionali nel pensiero europeo. Nel Medioevo
la disputa prende il nome di “problemi degli universali”
e divide il campo tra nominalisti e realisti.
I nominalisti negano il carattere di realtà separata e di essenza indipendente rispetto ai termini universali o alle categorie che riconducono piuttosto a un’attività mentale del soggetto conoscente. I nominalisti
possono essere equiparati agli psicologisti del tempo di
Husserl, per i quali ogni “realtà” è un prodotto della
psiche.
I realisti, invece, credono di poter affermare che
i termini logici abbiano un valore di realtà in sé e per sé
e che pertanto non possono affatto essere dipendenti
dalla situazione dinamica aleatoria e occasionale di associazioni mentali o psichiche del singolo soggetto che
pensa.
6
A lungo incerto tra queste due posizioni, Husserl
finisce poi per concepire il proposito ambizioso di un
superamento di entrambe, che verrebbe compiuto nella
sua fenomenologia trascendentale.
Mette in crisi lo psicologismo, ereditato da Brentano, la conoscenza dell’opera di Bolzano, matematico e
filosofo leibniziano, che elabora una teoria oggettivi-
96
stica della proposizione, della verità e della rappresentazione considerate “in sé”. La scienza non è pertanto
studiata come elaborazione psichica del soggetto conoscente, ma secondo una sua struttura oggettiva e logica. Tale struttura, per Bolzano, è del tutto indipendente dall’attività della coscienza, che pure la concepisce,
così come si deve distinguere il contenuto di una proposizione dalla sua espressione verbale. Il concetto, insomma, è da distinguere dal termine o dal nome che lo
“rappresenta”.
Di qui il carattere dell’“in sé”: gli oggetti del pensiero sono irreali e mantengono questo carattere anche
quando sono pensati, vale a dire inseriti nella serie reale degli accadimenti e delle produzioni psichiche. Sotto
l’ispirazione dell’”oggetto in sé” di Bolzano, dunque,
Husserl comincia a impostare il problema delle essenze,
delle “figure essenziali” immanenti al divenire di ogni
esperienza e senza le quali la scienza stessa, quella empirica e positiva, non sarebbe possibile.
È il problema stesso di Platone, delle idee platoniche, che rivive in forme nuove in ogni età e in ogni pensatore; se non lo si affronta, non si potrà mai fondare
una scienza, con la pretesa di universalità, che sia veramente rigorosa. Husserl perviene così in un “luogo”
teoretico, al di là dei contrasti tra psicologismo e logicismo. Difatti mentre lo psicologismo non conseguiva
l’universalità e l’oggettività, il logicismo falliva anch’esso tale compito perché, con il procedere astratto e
formale, non comprendeva l’autentica origine del lavoro
97
e del discorso scientifici, che si fondano sempre su esperienze singolari e individuali.
L’origine della scienza e ancora prima della fenomenologia quale filosofia prima, proposta a fondazione
del sapere scientifico è nell’intuizione, nella capacità di
intuire e di “vedere” le figure essenziali che costituiscono le strutture stesse della nostra esperienza,
strutture che sono sempre alla portata di tutti, anche
se di esse non sempre ne abbiamo chiara coscienza.
Ben consapevole di essere tra, di operare una
scelta di campo tra esterno e interno, nella elaborazione del proprio pensiero Husserl collega l’influenza in
certo qual modo contrastante dei suoi due maestri.
D’accordo con Brentano, pone a fondamento della
sua ricerca il concetto di intenzionalità, secondo il quale la coscienza “intenziona” il proprio oggetto, vale a dire essa significa sempre qualche cosa: insomma, non si
dà mai una coscienza pura e vuota, ma sempre e soltanto una coscienza di (qualcosa).
D’accordo poi con Bolzano, riconosce agli oggetti/cose, intenzionati dalla coscienza, il valore di figure
essenziali di universali che per un verso sono irreali
(non materiali o meramente psicologici) e per altro verso hanno una funzione di realtà, nei casi particolari di
esperienze dirette di mondo.
7
Dopo un decennio di ricerche, testimoniato da
scritti minori, nel 1913 Husserl pubblica le Idee per
una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologia
98
(Ideen I): si tratta del vero e proprio atto di nascita
della fenomenologia trascendentale.
È d’importanza davvero decisiva, per i nostri scopi, la prima sezione, nella quale si riassumono la Ricerche logiche, intitolata Essenza e conoscenza di essenza. Nel primo paragrafo di questa sezione, su Conoscenza naturale ed esperienza, si osserva che le scienze si fondano su visioni originariamente afferenti. Significa che esse si basano su esperienze originarie che
danno rappresentazione della cosa nell’originale e non
per meri simboli o astrazioni. Simboli e astrazioni rinviano sempre infatti a un’esperienza originaria, che nel
caso di realtà fisiche coincide con la percezione “esterna”, mentre in quello di realtà psichiche con la percezione “interna”, o autopercezione.
Tutte le scienze di esperienza fanno riferimento
al mondo, come campo generale di indagine; queste
scienze sono “scienze dei dati di fatto”.
Proseguiamo la lettura: “le scienze di esperienza
sono scienze dei dati di fatto. Gli atti costitutivi dell’esperienza pongono il reale individualmente, come esistente nel tempo e nello spazio…”. Husserl sembra qui
voler far propria la lezione kantiana dell’Estetica, sostenendo che l’oggetto reale è quello che si dà a noi per
il tramite delle “forme” di spazio e di tempo.
Vediamo ora cosa si dice ancora dell’oggetto di
esperienza, tutt’uno col dato di fatto delle scienze empiriche. Anzitutto l’essere proprio dell’oggetto individuale è del tutto casuale. Di esso possiamo infatti affermare: è così, vale a dire esso ha questo status es-
99
senziale, ma avrebbe anche potuto essere diversamente. Insomma, le cose (individuali) di mondo non sono affatto necessarie: le leggi di natura possono pertanto
stabilire con una certa precisione che, date certe e
particolari circostanze, si danno certe e non altre conseguenze, come dati di fatto.
Allora le leggi e le regole di natura sono “fattizie”, perché legate all’individualità esperienziale. Appena, però, stabiliamo che, a motivo di un certo contesto
circostanziale, la fatticità comporta una necessità, ecco che, con l’emergere di una regola per la cosa esperita, si affaccia il senso di una universalità.
Scrive Husserl: “dicendo: ogni dato di fatto potrebbe “per essenza” essere diverso da quello che è,
lasciammo già intendere che al senso di ogni essere casuale si conviene di avere appunto un’essenza, un eidos
afferrabile a priori e che questa essenza si inserisce in
una gerarchia di verità essenziali di diverso grado di
generalità. Un oggetto individuale non è qualcosa di
semplicemente individuale, un effimero “questo qui”,
ma, in quanto è in se stesso così e così costituito, possiede come propria caratteristica dei predicati essenziali, che necessariamente gli competono (competono
all’ente in se stesso)”1.
Qui per la prima volta compare il concetto di essenza (eidos). Nel dato di fatto individuale, nella considerazione del “questo qui” che viene esperito, c’è l’eventualità nel suo darsi (es gibt) e casualità. L’individuo
1
E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologia, Milano, il Saggiatore, p. 38
100
può essere quel che è, ma avrebbe potuto anche non
essere. D’altra parte, però, per il fatto stesso che l’individuo sia determinato da circostanze, da altro-da-sé
e da altri dati di fatto, sta a significare che per esso si
può stabilire una necessità: esso doveva essere così e
così e non poteva che essere tale quale effettivamente
è.
Si stabilisce così una norma/legge del suo essere,
che travalica questo individuo qui, perché assume carattere di universalità. In queste, determinate circostanze, e soltanto in queste, si dà la particolare essenza, che accomuna o può accomunare poi questo individuo anche ad altri della medesima specie.
Ogni cosa materiale, perciò, ha una sua specificità
essenziale ed è anzitutto quella “cosa materiale in generale”; quindi ha una determinazione specifica e circostanziata da tempo, durata, figura, ecc. Quello che appartiene all’essenza di un individuo può così appartenere, per specificità di essenza, anche ad altri individui, a
categorie intere di individui.
8
Vediamo ora la definizione di “essenza”: “indico
anzitutto ciò che si trova nell’essere proprio di un individuo come sui quid. Ma ogni simile quid può venir “messo in idea”. Una visione empirica o individuale può essere trasformata in visione di essenza (ideazione) dove
questa stessa possibilità è da intendere come essenziale e non empirica”1.
1
Ibidem
101
Nel cogliere percettivamente il dato di fatto empirico si ha visione del quid di esso, ma allo stesso tempo tale visione si trasforma in visione di essenza, vale a
dire in ideazione o intuizione (Anschauung). Questo sta
a significare che nell’atto esperienziale rivolto alla cosa
materiale si arriva a cogliere, mediante visione o intuizione, quel che è l’essenza o idea della cosa stessa. Si
legge subito dopo, difatti, che “l’elemento intuito consiste quindi nella corrispondente essenza pura o eidos”.
La visione che permette di cogliere l’essenza delle
cose può poi essere adeguata o inadeguata. Essa è adeguata quando le essenze si offrono alla nostra visione
solo “da un lato” o anche da più lati, ma mai possono offrirsi “da tutti i lati”, come sarebbe necessario per poter avere effettivamente visioni di essenza perfettamente adeguate. A esempio, una cosa fisica, quale figura spaziale, si offre soltanto e per principio attraverso
“adombramenti” unilaterali. Accade allora che per
quanto la figura possa di volta in volta arricchirsi di altre visioni, corrispondenti ad altri “lati” della cosa, in
consonanza della multilateralità dell’esperienza che si
va facendo, di fatto non si arrivano mai a esaurire le
più minute determinazioni e si cade in un processo che
si svolge ad infinitum.
Insomma, nessuna cosa può mai offrirsi al nostro
“sguardo”, alla nostra visione di essenza, nella sua totalità, perché non si è in possesso in realtà di uno sguardo
panoramico. Questa non è da considerare una imperfezione della cosa, ma il suo stesso essere costitutivo. Le
cose e il loro darsi quali fenomeni vanno a coincidere: il
102
darsi è per adombramenti e questo è il proprium della
cosa spaziale: è ciò per cui essa è spaziale e non ha un
altro modo possibile di essere.
Neppure Dio, il creatore di ogni cosa, dirà Husserl, potrebbe avere visione di una cosa spaziale che
tradisca il suo modo di darsi o lo “superi”. La cosa spaziale non potrà essere vista nemmeno da Dio stesso “da
tutti i lati”, così come l’onnipotenza di dio non potrebbe
arrivare a suonare su violini una funzione ellittica.
Adeguata o no, la visione empirica individuale può
trasformarsi in visione di essenza (eidos), che è oggetto di una nuova specie. Vediamo di arrivare a stabilire
ora un punto fermo. Husserl ci ha portati dalla considerazione del questo qui percettivo, della cosa sottoposta
a visione e a visione di essenza, all’oggetto di esperienza. Leggiamo: “la visione empirica, in specie l’esperienza, è coscienza di un oggetto individuale; in quanto
è visione lo porta a datità [dato di fatto]; in quanto è
percezione, lo porta a datità originaria, ossia a consapevolezza di afferrare l’oggetto nell’originale “in carne
e ossa””1.
La visione di essenza prende consapevolezza di
cogliere l’oggetto che si dà “in se stesso”. Tale oggetto,
successivamente, potrà anche essere “soggetto” per
altre predicazioni, vere o false che siano, ma è importante questa sua prima e originaria determinazione,
che è ancora antepredicativa. Proseguiamo la lettura:
“ogni possibile oggetto, in termini logici ogni soggetto
di possibili predicati veri, ha appunto le sue maniere di
1
Ivi, p. 40
103
presentarsi ad uno sguardo capace di rappresentarlo,
di vederlo, di coglierlo nell’originale, prima di ogni pensiero predicativo”1.
L’intuizione individuale e la visione essenziale sono
una sorta di binomio inscindibile. Non è possibile “vedere” un individuo, senza al tempo stesso e immancabilmente vederne anche l’essenza, perché solo quest’ultima è in grado di render conto di quel particolare individuo, di quel certo e determinato individuo.
D’altra parte, c’è anche da osservare e da aggiungere che le essenze non possano sussistere separatamente dagli individui, in quanto esse stanno negli individui come loro forma determinante e al di fuori di tale
relazione non hanno alcun essere. Alle differenze tra le
due visioni (individuale ed essenziale) corrispondono le
relazioni tra esistenza, nel senso dell’esistere individualmente, ed essenza, tra dato di fatto ed eidos.
9
Più avanti, cap. II, § 24, proprio in considerazione
del suo punto di partenza determinato dai dati di fatto, Husserl rivaluta l’empirismo, anche se ancora una
volta intende demarcare, rispetto a esso, una precisa
distinzione, mostrandone “pregiudizi” e “fraintendimenti naturalistici”.
Proseguiamo la lettura del testo: “giudicare le cose razionalmente o scientificamente significa volgersi
“alle cose stesse”, risalire dai discorsi e dalle opinioni
1
Ibidem
104
alle cose, interrogarle nel loro offrirsi ed eliminare
tutti i pregiudizi a esse estranei”1.
Cadendo in un equivoco, l’empirismo crede, però,
di dire in altro modo quel che sostiene lo stesso Husserl quando afferma che tutte le scienze hanno origine
dall’esperienza. Vediamo allora la puntualizzazione che
viene proposta. L’empirista pensa che la scienza vera
possa identificarsi con la scienza sperimentale; pertanto propone di stare ai dati di fatto, mettendo al bando
idee o essenze, quali veri e propri “spettri metafisici”.
La vera scienza è quella effettuale, che si fonda sui
dati di fatto. Tutto quel che non è realtà, per essa è
immaginazione ed una scienza che si fondi sull’immaginazione è di per sé una scienza immaginaria, vale a dire
un discorso non scientifico.
Naturalmente la scienza della natura non contesta
la realtà delle immaginazioni, le quali però in quanto dati di fatto psichici devono rientrare nella scienza della
psiche, la psicologia. Da contestare è l’operazione intellettuale, che porta dalle immaginazioni, in virtù della
visione essenziale eidetica fondata proprio su di esse,
alla considerazione degli oggetti irreali. Insomma, la
scienza naturalistica contesta a Husserl una specie di
“acrobazia ideologica”, con costruzione speculativa a
priori di marca idealistica.
Alla critica che viene dal mondo della scienza
Husserl risponde, sostenendo che quel che afferma
l’empirista si fonda semplicemente su fraintendimenti e
su pregiudizi: “l’errore di principio dell’argomentazione
1
Ivi, p. 43.
105
empiristica sta nell’identificare o scambiare la fondamentale esigenza di un ritorno alle “cose stesse” con
l’esigenza di ridurre all’esperienza ogni fondazione della conoscenza. Per lui [per l’empirista], data la comprensibile restrizione naturalistica della sfera delle
cose conoscibili, l’esperienza è senz’altro l’unico atto
capace di offrire le cose.
Ma le cose non sono senz’altro cose della natura,
la realtà nel senso usuale non è senz’altro la realtà in
generale e quell’atto originariamente offerente che diciamo esperienza si riferisce soltanto alla realtà della
natura”1.
L’empirista confonde l’esigenza del “ritorno” alle
cose stesse o ai dati di fatto con l’altra esigenza riduzionistica, di per sé, di limitare la fondazione stessa
della conoscenza all’esperienza. Ancora di più: l’empirista naturalista riduce la conoscenza alla sfera delle
cose soggette alla sensibilità, non comprendendo che le
cose in generale, che pure sono cose di natura, non
coincidono affatto in modo esaustivo con esse.
Compiere l’identificazione tra cose naturali, di cui
si può avere esperienza sensibile, e cose in generale, è
un’operazione che viene considerata ovvia e legittima;
essa è però fonte di fraintendimento, dal momento che
è proprio l’ovvietà inindagata a indurre all’errore.
La critica di Husserl va poi ancora più a fondo, per
mostrare come l’empirista nella sua considerazione della conoscenza faccia valere un pregiudizio di fondo, relativo proprio alla fondazione empirica della stessa co1
Ivi, p. 44.
106
noscenza. L’esperienza diretta cui crede di doversi e
volersi appellare, quale unico input della conoscenza,
fornisce solo singolarità e nessuna generalità o universalità. L’esperienza, dunque, così come la intende
l’empirista naturalista, non è sufficiente. D’altra parte,
egli non può fare appello, come invece fa Husserl, alla
visione di essenze, perché le nega di principio, appellandosi unicamente all’induzione in uno con quel complesso di ragionamenti mediati, per mezzo dei quali la
scienza empirica perviene ai suoi principi generali.
A questo punto ci si chiede: di che natura è la verità dei principi mediati, induttivi o deduttivi che essi
siano? Tale verità è forse percepibile? Di che natura
sono poi i principi che reggono le modalità di ragionamento dell’empirismo? Empirica, forse? In conclusione,
“pare proprio che gli empiristi non si siano accorti che
le pretese scientifiche, da loro sollevate nelle loro tesi,
si ritorcano contro quelle stesse tesi”. Difatti è proprio assurdo e contraddittorio affermare, quale principio, che “tutti i giudizi si debbano fondare sull’esperienza empirica”: questa affermazione è manifestamente non vera, non valida universalmente, in quanto
essa non si fonda sull’esperienza empirica. Il principio
enunciato risulta pertanto falso, proprio in base al suo
stesso enunciato, che impone il doversi fondare tutti i
giudizi sull’esperienza empirica.
Husserl affonda poi la sua critica, mostrando come la presa di distanze dall’empirismo, legato alle
scienze della natura, nei confronti delle filosofie, intese ideologicamente, risulti davvero illusorio, poiché essi
107
stessi soffrono, proprio nei loro principi, di pregiudizi
di fondo. Gli empiristi criticano, infatti, i filosofi in
quanto ideologi, con teorie astratte e preconcette. In
realtà sono loro stessi ad avere teorie preconcette e
pertanto risultano sin troppo simili a quei filosofi che
criticano.
10
A questo punto, prendendo le distanze dall’empirismo naturalistico, con la sua visione di essenze di
stampo fenomenologico Husserl arriva a smarcarsi anche da prospettive filosofiche: “mentre essi [gli empiristi naturalistici] da veri filosofi che partono da un
determinato punto di vista e in palese contraddizione
con il loro principio della libertà da ogni pregiudizio
prendono le mosse da opinioni non chiarite e non fondate, noi partiamo da ciò che sta prima di tutti i punti di
vista: dalla sfera complessiva del dato visibile anteriore ad ogni pensare teorizzante da tutto ciò che si può
immediatamente vedere e afferrare, purché non ci si
lasci accecare dai pregiudizi e distogliere dal prendere
in considerazione intere classi di dati genuini”1.
Ricordiamo qui quanto asserisce Husserl nella Filosofia come scienza rigorosa: le filosofie non conseguono alcuna verità oggettiva, perché non hanno il rigore metodologico della scienza. In esse tutto è soggetto
a controversia, le prese di posizioni sono arbitrarie e
fondate su convincimenti personali, su interpretazione
e su punti di vista.
1
Ivi, pp. 46-7.
108
Qui si sostiene che la conoscenza dell’empirismo
naturalistico è ben lungi dall’essere scientifica, perché
l’empirista si comporta come il filosofo, fondando il
proprio ragionamento, il proprio input conoscitivo, su un
punto di vista.
Si sta così affermando:
1.
tutte le filosofie, di ogni tempo e di ogni dove,
hanno fallito quello che pure sembrava essere il
loro obiettivo primario (il costituirsi come “scienza rigorosa”), perché hanno assunto un punto di
partenza falsato da uno specifico e particolare
punto di vista: da intendere quale pregiudiziale,
rispetto alla ricerca di una qualsivoglia verità oggettiva;
2.
tutte le filosofie sono pertanto da considerare
ideologie, perché hanno per base o punto di partenza e quale idea-guida un principio di parte, inindagato e indiscusso, che orienta ad unum la ricerca. Tutte le filosofie sono così interpretative
della realtà, proprio in forza di quel loro principio
primo;
3.
l’empirismo, in quanto filosofia, non si sottrae a
questa situazione di impasse e a questa contraddizione: crede di proporsi come scienza, ma finisce per falsare la propria indagine circa i dati di
fatto, cui pure fa costante riferimento con un’idea da cui ha origine la sua prospettiva e che in
realtà non risulta mai esperibile come puro e semplice “fatto” empirico.
109
L’empirismo è dunque in contrasto palese con gli
stessi principi della scienza, che crede di dover indagare sempre sui dati di fatto, con spirito scevro da qualsiasi pregiudizio, non prendendo le mosse da opinioni
non chiare e infondate. Con la sua fenomenologia, che
intende proporsi come “scienza rigorosa”, Husserl, invece, prende le mosse proprio da quel che precede
qualsiasi punto di vista, da quel che è l’oggetto dato,
che si propone alla visione, prima ancora che di esso
possiamo articolarne una teoria, se non addirittura un
concetto.
Si crede così di proporre una metodologia di ricerca, una gnoseologia scientifica, che si fondi su un
principio secondo il quale l’oggetto da conoscere può
essere visto e afferrato (greifen) immediatamente,
senza la mediazione dunque di pregiudizi (teorie e opinioni), senza che si diano “filtri” al nostro occhio,
nell’atto della sua visualizzazione. L’oggetto afferrato
(gegreift) soltanto in seconda istanza diviene concetto
(Begrift).
11
A questo punto Husserl, che pure, come si leggerà
ancora meglio nell’Introduzione della Krisis, intende
opporsi al positivismo, afferma: “se positivismo è la
fondazione assolutamente spregiudicata [priva di pregiudizi] di tutte le scienze sul “positivo”, cioè su quello
che si afferma originariamente, noi siamo i veri positivisti. Effettivamente non permettiamo ad alcuna autorità nemmeno a quella delle moderne scienze naturali,
110
di privarci del diritto di riconoscere tutte le modalità
della visione come equivalenti sorgenti di conoscenza”1.
Nota poi il filosofo tedesco che la fenomenologia
viene accusata di realismo platonico, vale a dire che si
pongono le idee e le essenze come fossero degli oggetti
e così come si fa per gli altri oggetti, si attribuisce loro essere reale e vero e quindi la possibilità di poterle
cogliere mediante intuizione o visione. Si difende la fenomenologia, precisando che non si è inteso affatto
proporre una sorta di ipostatizzazione platonica delle
idee, dal momento che comunque i concetti stessi di
essenza e di oggetto dato sono sempre ben distinti.
Vengono poi proposte ancora una osservazione e
un’obiezione. Idee ed essenze sono pur sempre dei concetti e pertanto delle formazioni psichiche, prodotte
da astrazione: sono nomi illustri e altisonanti per “modesti fatti psicologici”, che sembrano scaturire per via
di astrazione da visioni individuali. Si tratta dunque di
prodotti psicologici. In quanto tali, esse hanno la stessa
importanza e la stessa validità e veridicità di qualsiasi
finzione arbitraria: a esempio l’idea del centauro, che
suona il flauto, da noi liberamente immaginata, che è
una nostra formazione rappresentativa, sarebbe da
considerare visione individuale di un prodotto psichico.
Consideriamo ora la risposta di Husserl. Certo la
formazione dei concetti si produce liberamente e spontaneamente quale prodotto dello spirito; inoltre nell’idea di centauro che suona il flauto, nella formazione
specifica di questo concetto, come di ogni altro, si ha
1
Ivi, p. 47.
111
una rappresentazione, ma questa non trova alcuna corrispondenza in un Erlebnis psichico1. Perciò il centauro
non è di fatto nulla di psichico, perché non esiste
nell’animo, né nella coscienza, né altrove: esso è niente
(niente), perché risiede in toto nell’immaginazione.
Eppure l’Erlebnis/immaginazione è sempre immaginazione di un qualcosa (del centauro che suona, appunto), vale a dire che all’Erlebnis appartiene il centauro fantasticato, in quanto a un atto psichico appartiene
qualcosa che non esiste nella psiche: “non si confonda
l’Erlebnis dell’immaginare con ciò che in esso [Erlebnis]
è immaginato, come tale”.
Concludendo: “il coglimento e la visione di essenza
è un atto che può atteggiarsi secondo parecchie modalità, in particolare la visione dell’essenza è un atto originariamente offerente e quindi è l’analogo del percepire sensibile e non dell’immaginare”2.
1
Si noti qui come Erlebnis sia difficilmente traducibile. Il termine
indica il momento vivente contenuto nella coscienza. Si può pertanto avere l’Erlebnis del percepire, del fantasticare, del ricordare,
del desiderare, ecc.
2
Ivi, p. 50.
112
PARTE
SECONDA.
HUSSERL, II
1
Proviamo a riassumere il pensiero di Husserl, acquisito mediante la lettura del primo capitolo di Ideen
I, che riassume le Ricerche logiche e, più in generale,
tutto il cosiddetto “primo Husserl”.
Anzitutto, dal concetto di essenza o di eidos, come anche da quelli di intuizione e di visione sono rigorosamente da escludere tutte le suggestioni mistiche e
le ipotesi neoplatoniche, che si rifanno alla tradizione.
Difatti le essenze si offrono a noi, di danno nella nostra vita quotidiana, nell’esperienza più comune e abituale, che si possa fare.
Ci si presentano di continuo i dati di fatto, vale a
dire tutti gli accadimenti legati a individualità: il rumore che mi arriva dalla strada, la voce del docente, la luce che entra dalla finestra, l’essere venuti al mondo in
quel giorno. Sono tutti dati di fatto. Un dato di fatto
casuale e individuale diviene, però, necessario, perché
sempre visto all’interno di una struttura ben definita,
che costituisce la modalità stessa del suo darsi a noi; la
fenomenologia parla così del suo esser fenomeno: il puro e semplice atto percettivo individuale diviene universale, per il darsi di certe sue determinazioni contestuali.
La parola “fenomeno” non è qui intesa, come in
Kant, quale manifestarsi apparente di qualcosa, che è
“cosa in sé”, che nella sua natura più propria si nasconde proprio nel fenomeno; in Husserl, invece, fenomeno
113
è il darsi della cosa stessa, come essa è in se stessa,
perché proprio in quanto si dà la cosa è tutt’una col suo
apparire: la cosa è, in quanto appare.
Ogni cosa o dato di fatto si dà così a noi con una
sua essenza pura (il rumore dato-di-fatto è questo rumore qui), ma l’essenza sta a prospettare una tipicità
del questo qui che lo distingue a esempio dal colore, dal
suono, ecc. Un “questo qui” totalmente privo di determinazioni essenziali, quelle che costituiscono il fenomeno e senza le quali non si dà ente, non avrebbe alcun significato, perché non sarebbe proprio il questo qui,
dunque si potrebbe identificare con il niente, oppure si
tratterebbe della materia prima informe, proposta in
forma dubitativa dallo stesso Aristotele. Anche il più
grezzo e confuso accadimento, dunque, ha in sé
dell’universalità.
Tale universalità precede qualsiasi nostro giudizio
o ragionamento, qualsiasi induzione o deduzione, dunque
qualsiasi filosofia o ideologia, che si delinei come sistema, così come qualsiasi scienza, perché si presenta
come il modo stesso di essere (lo “stile”) del mondo, di
quel mondo che si dà quale fenomeno, che è sempre già
dato prima di qualsiasi nostra riflessione su di esso.
È per questo che l’universalità, allo stesso modo
delle essenze, è intuitiva, cioè naturalmente, spontaneamente e immediatamente visibile e direttamente afferrabile, mediante percezione. Insomma, il rumore si
dà, come caso particolare dell’eidos “rumore”, si dà a
me, il che significa che io, posto immediatamente al suo
114
cospetto quale dato che si presenta alla mia vita percettiva, lo afferro.
Le essenze sono contenute nelle esperienze fattuali, nei dati di fatto, ed è possibile una scienza di tali
essenze: la fenomenologia. In quanto basata sull’intuizione e sulla visione, essa è scienza positiva; non è una
teoria, perché si basa sempre e fondamentalmente sull’esperienza percettiva, ma non è neppure una scienza
sperimentale, come si è visto. La fenomenologia è anzi il
più radicale empirismo, perché essa si basa sul seguente principio generale: quello che è sperimentato è sperimentato, quello che è dato è dato. Nessuna teoria, opinione, punto di vista o Weltanschauung può cancellare
questo fenomeno, che è condizione di possibilità trascendentale, perché possano darsi teoria, opinione e
punto di vista. Si ha da assumere quel che è dato, così
come è dato e nei limiti e determinazioni in cui si è dato, vale a dire nel modo in cui si è dato.
2
Bisogna sforzarsi di descrivere, allora, quel che si
trova, quel che realmente si percepisce, si ricorda e si
fantastica. La fenomenologia non è pertanto una costruzione di sistema o una razionalizzazione di esperienze, ma pura e semplice descrizione dei dati di fatto, il dire che le cose stanno, così come si danno.
Tutto questo però è molto meno semplice di quel
che può sembrare a prima vista, perché per descrivere
quello che realmente si prova bisogna liberarsi dagli innumerevoli pregiudizi teorici, mettendo così in luce le
115
strutture essenziali di ogni nostra esperienza dei fenomeni di mondo, vale a dire dei dati di fatto.
Per liberarsi dei pregiudizi bisogna fare epoché,
sospendendo il proprio giudizio.
L’epoché, antica prassi filosofica, nello scetticismo greco sta a indicare la “sospensione del giudizio”,
che Pirrone e i suoi discepoli esercitavano sul mondo e
sulle opinioni degli uomini.. In Husserl l’espressione
sembra essere più vicina al dubbio metodico di Cartesio, nell’insistenza circa il suo carattere fondativo rispetto alla scienza: essa, infatti, non sarebbe negativa
e fine a se stessa come nello scetticismo greco relativistico e nichilistico. In Husserl si manifesta, poi, anche l’eredità socratica, che dà all’epoché un’intonazione
decisamente etica.
Da una parte, allora, si abbandonano i pregiudizi,
dall’altra c’è assunzione di responsabilità personale del
pensatore che deve anzitutto conoscere se stesso
(gnoti seauton socratico), per assumere “in prima persona” il compito del sapere. È quel che chiede Cartesio
nel Discorso, quando sostiene l’esigenza di tornare a se
stessi “almeno una volta in vita”. È interessante notare
come Husserl, al termine delle Meditazioni cartesiane,
ricordi l’importanza del motto di Agostino: noli foras
ire, redi in te ipsum (in interiore nomine habitat veritas, prosegue il testo, come si sa).
Vediamo ora, più specificamente, in cosa consista
l’epoché. Anzitutto è l’astensione dalla validità e dall’ovvietà del mondo quotidiano, dalle cosiddette “ovvietà mondane”. Il mondano è tutto quello che si offre alle
116
nostre attenzione e considerazione come fornito di una
validità e di un valore che risultano inindagati. È il campo di quel che è abituale, circa il quale non si pone alcuna domanda relativamente al “perché?” e al “come?”.
Portato alle ultime conseguenze: si dà per scontato e
per acquisito, quale ovvietà prima e universale, che c’è
e si dà un mondo.
Husserl, insomma, con l’epoché, non intende affatto negare l’essere del mondo e neppure annullarne in
certo qual modo la validità, ma piuttosto la sospende,
simulando la sua non validità, almeno in un primo momento e di primo acchito. Si può pertanto sospendere
una validità che si possiede, non cancellandola, ma ponendola “tra parentesi” ed eventualmente, in seguito, la
si potrà recuperare. Quale la conseguenza? Non si
permane più nell’atteggiamento naturale e aproblematico nei confronti del mondo; non si è nell’ingenuità naturale, ma ci si chiede: come può accadere che io abbia un
mondo ,”come mi è dato (o mi si dà) un mondo”. Si fa
questione, insomma, del modo di essere e della forma
propria del fenomeno.
Nel volgersi per la prima volta in questo modo
problematico all’essere del mondo risiede il primo attuarsi dell’epoché. Con essa si inibisce l’atteggiamento
naturalistico e mondano, da considerare con sospetto:
non è più così ovvio e scontato, in fin dei conti, che ci
sia o si dia un mondo reale davanti a noi, quale oggetto
che si contrappone a un soggetto. Esso diviene così, per
noi che lo sperimentiamo, un puro fenomeno: è in quanto ci si dà, per l’evento del suo darsi, e nel modo in cui
117
ci si dà, in forza delle modalità del suo darsi. Di tale
fenomeno Husserl intende penetrare il come, arrivando
a manifestarne così il senso.
La realtà del mondo, ovvia e naturale, è così ridotta (si tratta della riduzione eidetica o fenomenologica)
al fenomeno “mondo” o, se si vuole, al mondo dei fenomeni. Dalla realtà cosiddetta oggettiva si è passati alla
realtà fenomenica (oggi si potrebbe ipotizzare un ulteriore passaggio alla realtà virtuale).
3
L’epoché viene prospettata da Husserl sin da Ideen I, ma è poi ripresa nella Krisis, dove la “via cartesiana” è alla fine abbandonata, evitando il brusco passaggio dall’atteggiamento naturalistico a quello trascendentale, che viene richiesto dall’epoché. A differenza
di Cartesio, il punto di partenza non è più l’idea di una
conoscenza apodittica, che il pensatore francese ingenuamente recupera dalle cosiddette scienze esatte,
come si ricorderà, ma risiede nel concreto mondo della
vita (die Lebenswelt), tema dominante l’intera Krisis.
È l’epoché infatti a rendere concretamente possibile una fenomenologia, e dunque anche una scienza, del
mondo della vita.
Iniziamo ora a leggere il § 39 della Krisis: “come
può l’essere-già-dato del mondo della vita diventare un
tema autonomo e universale? Evidentemente solo attraverso un mutamento totale dell’atteggiamento naturale, un mutamento per cui non viviamo più come prima,
in quanto uomini dell’esistenza naturale, nella costante
118
partecipazione alla produzione delle validità del mondo
già dato, anzi ci asteniamo proprio da questa partecipazione […]. Soltanto così possiamo penetrare ciò che il
mondo è in quanto terreno di validità della vita naturale
nei suoi propositi e nelle sue attuazioni e, correlativamente, ciò che la vita naturale e la sua soggettività in
definitiva sono, la soggettività in quanto pura soggettività, che funge nella produzione delle validità”1.
Husserl indirizza l’attenzione e la speculazione
sull’oggetto dato kantiano e si chiede come si possa individuarlo quale tema specifico, vale a dire “autonomo”,
a se stante e privo di interpolazioni e sovrastrutture, e
“universale”, con una conoscenza che risulti valida per
tutti e non soltanto per coloro che ne fanno esperienza. Per realizzare tale obiettivo si esige un radicale
mutamento di atteggiamento, vale a dire non si deve
assumere più l’atteggiamento spontaneo e naturale, che
riconosce come ovvietà indiscussa e indiscutibile il
mondo già dato.
In quanto esistenti, semplicemente e soltanto come naturali, partecipiamo alla produzione della validità
delle cose del mondo, senza neppure rendercene conto.
Si tratta di operare una sorta di astensione da tale
partecipazione irriflessa: in questo consiste il mutamento totale e radicale che viene auspicato.
Viene inoltre detto che mediante il radicale mutamento di atteggiamento: 1. si riesce a penetrare quel
che il mondo è, il suo essere, quale presupposto della
1
E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, il Saggiatore, § 39.
119
vita che viviamo con atteggiamento naturale; 2. si riesce a penetrare quel che la stessa vita naturale e la
soggettività a essa relazionata e connessa sono; 3. la
soggettività (il cogito cartesiano) è qui da intendere
quale “pura soggettività”, che produce, elabora e realizza le validità stesse della vita naturale.
Husserl nota che la vita che realizza le validità
del mondo non può essere indagata restando nell’ambito
dell’atteggiamento naturale, per cui “occorre un rivolgimento totale, una epoché universale assolutamente
peculiare”.
Proseguiamo nella lettura: “è possibile un modo di
epoché universale, quello che d’un colpo solo mette fuori gioco nel suo complesso quell’atteggiamento implicato
dall’intreccio complessivo della validità, che costituisce, in quanto “atteggiamento naturale” unitario, la
“semplice” vita diretta” […]. In altre parole, noi assumiamo un atteggiamento che si pone al di sopra della
vita universale (soggettiva e intersoggettiva) della coscienza nella quale il mondo per coloro che lo vivono ingenuamente è “qui”, indiscutibilmente alla mano, è
l’universo di tutto ciò che è alla mano, il campo di tutti
gli interessi di vita già praticati e che continuamente si
riproducono. Tutto ciò è posto preliminarmente fuori
gioco dall’epoché e perciò è posta fuori gioco tutta la
vita naturale, orientata sulla realtà “del” mondo”1.
L’atteggiamento che si assume pone al di sopra
della vita della coscienza singolare e collettiva, che ragiona secondo il buon senso comune per il quale il mondo
1
Ivi, § 40.
120
e la vita: a. sono qui e lo sperimentiamo nell’immediatezza del loro darsi a noi; b. sono alla mano, nel senso
che possiamo coglierli in presa diretta; c. sono tutt’uno
con quanto singolarmente e collettivamente pratichiamo, produciamo e riproduciamo.
4
Capita proprio che l’epoché ponga fuori gioco tutte queste certezze e ovvietà indiscusse relative al
mondo e alla vita. Dunque si pone in sospensione di giudizio la stessa realtà del mondo. A questo punto Husserl fa una puntualizzazione circa l’epoché che tende a
smarcarlo da un’adesione totale alla “via cartesiana”. A
differenza del dubbio metodico, che va praticato per lo
meno una volta in vita (e può darsi una sola volta!), infatti, l’epoché è da intendere come un atteggiamento
abituale, cui ci si indirizza e per il quale ci si decide una
volta per tutte. È dunque il frutto di una scelta motivata, che poi “regge” ogni momento di vita successivo.
Dunque, “non è affatto un atto transitorio, che può essere anche ripetuto, ma che rimane isolato e casuale”.
Grazie all’epoché permanente, quale atteggiamento “professionale”, lo sguardo del filosofo, da intendere
nel senso più ampio possibile, si rende veramente libero
da pregiudizi. A cosa equivale la libertà conquistata?
Precisa Husserl: “questa liberazione equivale alla scoperta della correlazione universale, in sé assolutamente
conclusa re assolutamente autonoma di mondo e di coscienza di mondo”1. Insomma, Husserl sostiene che
1
Ivi, § 41.
121
l’epoché è in grado di mostrare la caratteristica peculiare del mondo della vita, nel suo carattere “fungente”
e fondativo, rispetto al mondo colto in atteggiamento
naturale e ovvio. La sua “riduzione” a fenomeno comporta lo svelarsi di una correlazione universale di mondo e di coscienza, che in forza dell’intenzionalità brentaniana è sempre coscienza-di e dunque coscienza-dimondo.
Mondo e coscienza-di-mondo non possono essere
presi come due realtà separate e contrapposte: in questa affermazione è chiara l’altra critica a Cartesio e al
suo dualismo, che è pregiudizio implicito della coscienza
ingenua, che si atteggia naturalmente. Il modo di essere del mondo è modo di essere fenomeno per una coscienza; d’altra parte, poi, la coscienza è intenzionale e
il suo modo di fungere intenzionalmente acquista sempre il carattere della mondanità spazio-temporale.
Prosegue poi il testo: “quest’ultima [la coscienza
di mondo] non è altro che la vita di coscienza della soggettività, che produce la validità del mondo, la soggettività che nelle sue continue attuazioni ha sempre un
mondo ed è sempre attivamente formatrice”1.
È interessante marcare qui ancora una volta una
presa di distanze da Cartesio. Husserl sostiene che è la
vita della coscienza del soggetto a dare validità al
mondo. Ciò si realizza mediante l’attività propria del
soggetto, il quale da una parte possiede sempre un
mondo, d’altra parte nella sua attività è sempre formatore, vale a dire ricrea un mondo.
1
Ibidem
122
Husserl mostra così di non porsi affatto il problema, così come lo poneva Cartesio, il quale era pervenuto a un io penso che non poteva avere alcuna garanzia
della verità dei suoi pensieri. La garanzia cartesiana in
Dio, il quale ha immesso nell’io o permette che siano in
lui delle idee che hanno un corrispettivo nella realtà.
Husserl non sembra aver bisogno di tale “garanzia”,
perché il punto di approdo dell’epoché, a differenza del
dubbio cartesiano, è il correlato coscienza-di-mondo,
con l’idea di un soggetto che è in grado di produrre da
sé la “validità del mondo” dei fenomeni.
Un’ultima puntualizzazione: “questa [tutto l’esercizio proposto di epoché, per risalire a una base trascendentale] non è tuttavia una “concezione”, una “interpretazione” appiccicata al mondo. Qualsiasi concezione di…, qualsiasi opinione “sul” mondo trova il suo
terreno nel mondo già dato. Proprio a questo terreno
mi sono sottratto con l’epoché: mediante l’epoché io sto
al di sopra del mondo, il mondo diventa per me un fenomeno, in un senso assolutamente peculiare”1
5
Nel § 42 Husserl sostiene che l’epoché è in grado
di rendere possibile, a suo modo naturalmente, uno
sguardo sperimentale, per il quale l’oggetto che viene
sperimentato è il mondo, il fenomeno-mondo, come pure
la coscienza-di-mondo.
Nel paragrafo successivo, proprio in forza di queste considerazioni, si mostra la necessità di abbando1
Ibidem
123
nare la “via cartesiana”, che pure si era con profitto intrapresa, proprio per aver “afferrato” mediante epoché e tramite il metodo fenomenologico trascendentale
la datità del mondo. Si pone così il problema del come
dell’essere già dato del mondo, in quanto proprio il fenomeno sta a indicare la modalità in cui si danno a noi i
dati di fatto. Si sta dicendo insomma che non è affatto
problematico, come sembrava inizialmente, l’essere dei
dati-di-fatto mondani, perché il fatto di un essere giàda-sempre dato del mondo “è accessibile a chiunque
sulla base dell’atteggiamento naturale: cioè come
l’essere-già-dato di un mondo di cose essenti nella costante evoluzione dei modi relativi di datità”1.
Il tema proprio d’indagine della fenomenologia
trascendentale husserliana non è allora costituito dal
mondo, almeno direttamente, “bensì esclusivamente
dall’evoluzione dei modi di datità in cui il mondo si è costitutivamente già dato”. Qui Husserl crede di dover
compiere una sorta di autocritica, meglio una correzione di tiro rispetto a Ideen I, dove aveva creduto di dover prospettare una via “più breve” per l’epoché trascendentale. Tale via allora era stata definita come la
“via cartesiana”, concepita come puro e semplice approfondimento del dubbio metodico delle Meditationes,
anche se “depurata dai pregiudizi e dalle confusioni di
Cartesio”.
Quale il neo o, come viene definito, lo svantaggio
di quel modo di procedere? “Essa [la “via” o il metodo
perseguito e posto in atto] con un salto porta sì all’ego
1
Ivi, § 43.
124
trascendentale, ma insieme, in quanto non è oggetto di
un’esplicitazione progressiva, rivela l’ego trascendentale in un’apparente mancanza di contenuto”. Insomma,
l’io fungente si ritrova solo, in perfetta solitudine, “privo di contenuto”; dunque in situazione analoga a quella
di Cartesio, il quale, almeno in seguito e in forza del
dubbio metodico, in un primo tempo arriva solo ad affermare l’ego come evidente e certo.
Prima di affrontare la tematica propria del mondo-della-vita, vale a dire di mostrare il contenuto
dell’ego trascendentale, è opportuno almeno un cenno al
cogito e cioè all’ego stesso, in Husserl. In un certo senso il primo campo d’indagine che l’epoché dischiude è
proprio quello relativo al cogito o coscienza pura.
La coscienza non corrisponde all’indubitabilità
dell’io sono di marca cartesiana, quanto al fatto che il
passaggio da un atteggiamento naturale diretto verso il
mondo a un atteggiamento riflessivo-descrittivo su
questo atteggiamento medesimo, pone automaticamente all’interno di quell’esperienza che la coscienza fa da
sempre di se stessa e correlativamente del suo mondo.
Proprio il riconosciuto carattere intenzionale della coscienza, che è sempre coscienza-di e dunque sempre corredata da un contenuto, fa sì che il cogito husserliano riesca a sfuggire le tentazioni idealistiche.
L’accusa di idealismo, come anche quelle di psicologismo
e di solipsismo, cui si è già fatto cenno, sembra poco
sostenibile, soprattutto leggendo la Krisis. Rivendicando pertanto, come fa a più riprese in contrapposizione
alle scienze oggettivistico-positivistiche, l’esigenza di
125
un ritorno al soggetto, Husserl non ci riporta certo a
una sorta di atto creatore di Fichte o a un Io assoluto
di marca gentiliana, ma piuttosto sul terreno originario
di evidenza, del quale la ricerca filosofica e scientifica
non può in alcun modo fare a meno.
6
Il soggetto di cui parla la fenomenologia è sempre
soggetto incarnato (e si pensi qui all’importanza e alla
centralità indiscussa del corpo e del corpo proprio in
Husserl); inoltre il soggetto ha sempre come correlato
un mondo: questo correlato è intenzionale, dunque è
fenomeno non naturalistico, non è insomma una res nel
senso cartesiano del termine.
Inoltre Husserl non inventa il soggetto, né lo dimostra, ma cerca di descriverne fenomenologicamente
le operazioni, che contengono intenzionalmente il significato “mondo” in tutti i suoi modi di datità.
Perciò il soggetto possiede un corpo, il corpo proprio (Leib) e questo la coscienza ingenua lo sa da sempre, ma la fenomenologia insegna ad analizzare e a descrivere il come si costituiscono in noi la nozione dell’”avere un corpo” e successivamente, attraverso il corpo proprio, anche l’avere e l’afferarre per intuizione di
essenza, il mondo di altri corpi (Körper) e di cose. Ogni
indagine non può dunque che partire dal soggetto stesso, dall’io “in prima persona” e mai da una teoria dell’anima, dello spirito o del soggetto astratto, protagonista di filosofie idealistiche; l’indagine prende l’avvio da
126
quel che noi siamo da sempre e che sappiamo e facciamo costantemente sul piano del mondo della vita.
In prima persona e “in carne e ossa”, noi non siamo
un astratto io trascendentale, ma il soggetto agente
delle nostre concrete operazioni; il soggetto che qui
parla, che ascolta, che scrive, che pensa…
Tali operazioni sono significative: hanno una direzione e un senso, vale a dire una intenzionalità. L’aspetto significativo di tutte le operazioni intenzionali, di
quelle operazioni che non compie soltanto una coscienza
separata dal corpo, ma l’uomo tutto intero sul terreno
del quotidiano mondo della vita, è ciò che Husserl chiama trascendentale.
Ancora una parola sull’intenzionalità della coscienza, che ha carattere trascendentale. Immanente alla
coscienza, essa annuncia l’esistenza di quel che è altro
da essa. Allora, il fatto che Husserl prenda spunto dal
soggetto non significa affatto che riduca il mondo alla
coscienza e/o a un prodotto della coscienza o dell’io,
ma che scopra che è nella coscienza, in uno con essa, la
genesi della mondità del mondo, vale a dire delle modalità particolari in cui si danno i fenomeni dei dati di
fatto.
Insomma, nella coscienza si dà allo stesso tempo e
in contemporanea l’estraneità e la partecipazione al
flusso di vita della stessa coscienza. È questo quel che
si definisce il correlarsi intenzionale tra mondo e coscienza di mondo.
127
7
Occupiamoci ora del “mondo-della-vita” (Lebenswelt).
Troviamo scritto che “dobbiamo avviare le nostre
ricerche lungo la nuova via rendendo oggetto di un interesse esclusivo e conseguentemente teoretico il
mondo della vita, in quanto terreno della vita umana nel
mondo e innanzi tutto il modo in cui appunto gli inerisce
questa funzione generale di essere terreno”1.
La Lebenswelt è il Grund, terreno, ma anche fondamento per qualsiasi riflessione teoretica sulla vita
dell’uomo, è il trascendendentale o condizione di possibilità di qualunque conoscenza relativa all’esistenza.
Prosegue, poi, Husserl: “inutilmente cercheremo di reperire nella letteratura filosofica mondiale ricerche
che ci possano servire di base, ricerche che abbiano visto in questo compito il compito specifico di una scienza autonoma (anche se si tratta di una scienza molto
particolare) di una scienza che concerne la tanto disprezzata doxa e che tutt’a un tratto acquista la dignità di un fondamento (Grund) della scienza e pretende
quindi all’episteme –e perciò siamo costretti a cominciare completamente da capo”2.
Il tema del mondo-della-vita viene così presentato come novità assoluta nel panorama della letteratura
filosofica mondiale e quale svolta radicale nel campo
proprio della ricerca fenomenologica. Non è del tutto
vero: né l’una cosa, né l’altra. Dagli inediti, infatti, sap1
2
Ivi, § 44.
Ibidem
128
piamo che la dimensione precategoriale e prescientifica, quella per intenderci delle intuizioni e visioni di essenze, affiora molto presto nella sua riflessione (si
pensi qui anche alle Ideen, I); anche se è proprio nella
Krisis che perviene a maturità, quale concetto chiave
costitutivo e fondamentale su cui fa perno l’intera fenomenologia trascendentale.
Inoltre la Lebenswelt è mondo dell’opinione, dunque mondo della doxa, cui lo stesso Husserl fa riferimento, e non certo a caso. Ma allora, come fa il pensatore tedesco a sostenere che tale mondo non è mai
stato in precedenza considerato in tutta la letteratura
mondiale? Husserl dimentica, forse, il contributo di
Parmenide, che pone il problema anche se poi immediatamente lo rifiuta; quello di Platone, che lo accetta in
tutta la sua contraddizione; quello di Aristotele, che
facendo riferimento a Eraclito dichiara esplicitamente
di voler prendere le mosse proprio da esso. Egli dimentica infine Hegel, che nella Fenomenologia dello spirito
offre il primo storico tentativo di sollevare il sapere
apparente o opinione a sapere rigoroso e scientificamente dispiegato.
Husserl ha ragione invece nel sostenere che la sua
ricerca è di portata radicalmente innovatrice e trasformatrice, in quanto a modalità di realizzazione. La
metodologia che porta a stabilire come la doxa sia
Grund del sapere scientifico (episteme) ha la pretesa
di essere scientifica essa stessa.
129
8
Leggiamo ora il § 28, dove è ricavabile una definizione della Lebenswelt: “qui possiamo cercare di chiarire i termini del mondo sensibile, mondo dell’intuizione
sensibile, mondo sensibile dell’apparizione [fenomeno],
nella loro determinata legittimità. In ogni verifica che
rientra nella vita degli interessi naturali, che si mantiene nell’ambito del mondo della vita, il ritorno
all’intuizione sensibilmente esperiente svolge un ruolo
rilevante. Perché tutto ciò che si rappresenta come una
cosa concreta nella dimensione del mondo della vita ha
ovviamente una corporeità, anche se non è un mero
corpo, se, a esempio, un animale o un oggetto culturale
e quindi ha anche proprietà psichiche e spirituali. Se
noi badiamo soltanto all’aspetto fisico delle cose è
chiaro che esso si rappresenta percettivamente soltanto nel vedere, palmare, udire, ecc. cioè nei suoi aspetti
visuali, tattili, acustici e simili.
Qui partecipa evidentemente e immancabilmente
il nostro corpo proprio (Leib), che non manca mai nel
nostro campo percettivo, con gli inerenti organi percettivi (occhi, mani, orecchi, ecc.). essi svolgono un ruolo costante per la coscienza in quanto fungono nel vedere, nel sentire, ecc. unitamente all’inerente mobilità
egologica, alla cosiddetta cinestesi”1.
Siamo posti davanti alla cosa concreta della corporeità del mondo sensibile, nella considerazione prima
dell’aspetto fisico delle cose, colte tramite percezione.
In questo “luogo” dell’esperienza conoscitiva partecipa,
1
Ivi, § 28.
130
quale parte attiva e determinante, il Leib o corpo proprio con i suoi organi percettivi. A differenza di Cartesio, dunque, che si chiedeva dubbioso se all’idea di un
corpo proprio potesse nella realtà delle cose corrispondere un corpo reale, Husserl sostiene invece che
gli organi di percezione svolgono una funzione determinante per la coscienza, e dunque per l’io penso stesso,
assieme alla mobilità dell’io, o cinestesi.
In Husserl il termine “cinestesi” dev’essere forse
considerato come formazione neologistica. Di per sé,
infatti, la “cinestesia” è “sensibilità muscolare che interviene nella regolazione dell’attività motoria”. Con cinestesi, invece, Husserl sembra intendere i movimenti
del corpo vivo e animato (Leib), che distingue dal corpo
meramente passivo (Körper). Le cinestesi ineriscono a
ogni percezione. L’ego, cioè, percepisce attraverso le
intenzionalità cinestetiche degli organi di senso, unificati nel corpo proprio, inteso come organo unificatore.
Si tratta di qualcosa di analogo al “sensorio comune” di
Aristotele o al sensus communis dei medievali.
Nota poi Husserl che nelle precedenti considerazioni sulla coscienza percettiva delle cose, relativamente al proprio campo percettivo, quel che può essere
percepito è unicamente il corpo proprio e mai un corpo
estraneo, in quanto corpo proprio. Insomma, questa è la
ragione teoretica per la quale la fenomenologia deve,
almeno in prima istanza, accettare una sorta di solipsismo, quel medesimo rischio in fondo che corre Cartesio
con il dubbio metodico e con l’unica certezza del cogito,
dell’io penso. Posso prendere le mosse soltanto dalle e-
131
videnze intuitive personali, dalle mie visioni-intuizioni
di essenze, conseguite mediante cinestesi; questo capita perché solo il mio corpo è per me corpo proprio, capace appunto di cinestesi, e solo in esso l’Io assiste a
un decorso temporale degli Erlebnisse. I corpi degli altri sono invece estranei, per l’io sono meri oggetti
(Körper).
9
Non possiamo in questa sede cercare di risolvere
il problema dell’intersoggettività, che nella Krisis Husserl torna ad affrontare, dopo averlo trattato nelle sua
Meditazioni cartesiane. Riprendiamo, invece, la tematica della Lebenswelt, ponendola in stretta relazione
all’elaborazione scientifica e prima ancora all’ipotesi di
una filosofia prima, che si proponga e s’imponga come
scienza rigorosa. È proprio così che si ritorna al momento iniziale e programmatico della riflessione husserliana.
Husserl ricorda che “la scienza è una realizzazione dello spirito umano che storicamente presuppone un
punto di partenza costituito dal mondo intuitivo della
vita a tutti già dato, ma che insieme, in quanto è praticata [la scienza] e in quanto si sviluppa, presuppone
questo mondo circostante, il quale è costantemente dato per ogni scienziato”
Ci si chiede, a questo punto, se la Lebenswelt
debba diventare un tema autonomo, un “tema di constatazioni scientificamente garantite”, vale a dire, appunto, soggette a scienza. D’altro canto sembrerebbe
132
che trattare “il mondo della vita in quanto tema scientifico lo fa apparire un tema accessorio e parziale
nell’ambito del tema complessivo della scienza obiettiva”. Insomma, tale tema apparirebbe come secondario.
E invece: “è chiaro che prima del problema generale
della sua funzione per una fondazione evidente della
scienza obiettiva, il problema del senso di essere peculiare e costante di questo mondo della vita per gli uomini che vivono in esso, ha buona ragione di essere posto. Non sempre questi uomini nutrono interessi scientifici e gli scienziati stessi non sono sempre occupati
nel loro lavoro scientifico; inoltre, come mostra la storia, non sempre c’è stata nel mondo un’umanità che vivesse abitualmente nella dimensione di un interesse
scientifico da molto tempo costituito. Il mondo della
vita, invece, c’è sempre stato, prima di qualsiasi scienza, qualunque sia il modo d’essere che esso ha
nell’esperienza della scienza.
Si può quindi porre il problema del modo d’essere
del mondo della vita in sé e per sé; ci si può porre completamente sul terreno di questo mondo intuitivo, mettendo fuori gioco tutte le opinioni e le nozioni della
scienza obiettiva [che, com’è naturale, pure si interessa del “mondo”]”1.
In vista di una fondazione o rifondazione delle
scienze, nel campo scientifico il problema del senso
della Lebenswelt deve essere posto, per diverse buone
ragioni: 1. non sempre l’umanità cura interessi scientifici, come anche non sempre gli stessi scienziati si occu1
Ivi, § 33.
133
pano di scienza; 2. la storia dell’uomo dimostra che non
sempre c’è stata un’umanità che vivesse abitualmente
in una tensione scientifica, mentre invece: 3. la Lebenswelt si dà sempre e immancabilmente, perché essa è
prima di ogni attività teoretico-scientifica, prima di
ogni teoria, come si è visto.
Si esige dunque lo studio della Lebenswelt, mediante la fenomenologia trascendentale. All’obiezione
che essa,come tale, è già universalmente nota, quale
ovvietà che inerisce a qualsiasi vita umana, Husserl risponde che questo è senz’altro vero, ma che riguarda
ancora l’atteggiamento naturale delle cose e del mondo
e non ancora propriamente quello fenomenologico: “certo alla vita prescientifica questa conoscenza basta,
come le basta il suo modo di trasformare la non conoscenza in conoscenza e di attingere occasionalmente
una conoscenza sulla base dell’esperienza e dell’induzione […]. Ciò basta alla prassi quotidiana”, ma bisogna
“compiere un passo in avanti, per pervenire a una conoscenza scientifica”.
Sinora non si è mai indagato scientificamente il
modo in cui la Lebenswelt funga da fondamento e il modo in cui sono fondate le sue molteplici validità prelogiche rispetto alle verità teoretiche. Troviamo scritto: “probabilmente la scientificità richiesta dalla Lebenswelt come tale nella sua universalità è una scientificità peculiare, non di ordine logico-obiettiva, una
scientificità che, per essere definitivamente fondante
è la più alta nella scala dei valori”.
134
Si chiede Husserl, allora, come arrivare a realizzare questa diversa scientificità. Occorre “evitare di
ricorrere ai dati della sensibilità come se essi fossero
effettivamente ciò che caratterizza immediatamente
le datità puramente intuitive del mondo della vita”. I
dati della sensibilità sono per Husserl già una “teoria”,
che si sovrappone in modo sovrastrutturale alla Lebenswelt. Come tutte le teorie anche questa persegue un
ideale logico-obiettivo, ma non sfugge all’idea della verità in sé delle cose. Per la fenomenologia trascendentale tale idea è un’indebita astrazione compiuta inconsapevolmente sulla base della Lebenswelt, dove le cose
non sono sperimentate “in sé”, come potrebbe apparire
per i dati della sensibilità osservati oggettivamente,
ma soltanto nella correlazione a una coscienza.
10
Prosegue Husserl, dicendo che” il primum reale è
l’intuizione “meramente soggettivo-relativa” della vita
prescientifica nel mondo. Certo, per noi [quoad nos] il
“meramente” ha una sfumatura di spregio che esprime
la diffidenza tradizionale per la doxa, ma nella vita
prescientificfa stessa questa sfumatura scompare. Qui
il “meramente” sta a indicare una sicura verificazione,
un complesso di conoscenze predicative controllate e di
verità precisamente definite secondo le esigenze imposte dai progetti pratici di vita, i quali ne determinano il
senso […]. Le scienze costruiscono sopra l’ovvietà della
Lebenswelt, se ne servono attingendo a esso tutto ciò
che volta per volta è necessario ai loro scopi. Ma usare
135
in questo modo la Lebenswelt non significa conoscerla
scientificamente nel suo modo di essere”1.
Il “ritorno al soggetto” anche in campo scientifico
è qui ribadito: “mentre lo scienziato è occupato e interessato in questo modo, obiettivamente, d’altra parte
l’elemento soggettivo relativo funge per lui non in quanto semplice tramite irrilevante, bensì in quanto ultimo
elemento fondante della validità di essere di qualsiasi
verifica obiettiva, e quindi sorgente di evidenza, quale
sorgente di verificazione […]. Il mondo della vita è un
regno di evidenze originarie. Ciò che è dato in modo evidente è “esso stesso” dato nella percezione e cioè
esperito nella sua presenza immediata oppure è ricordato nella memoria […]. Qualsiasi verifica pensabile riconduce a questi modi dell’evidenza, perché “esso stesso” sta in queste intuizioni come un elemento realmente
esperibile e verificabile”2.
Husserl determina, infine, il compito fenomenologico. Si tratta di considerare concretamente, in tutti i
modi della relatività soggettiva che gli ineriscono, il
mondo della vita, in cui tutti si vive intuitivamente, con
le sue realtà così come esse si danno. Il compito esclusivo è quello di cogliere lo “stile” del mondo nel suo
fluire eracliteo, che è “meramente soggettivo e apparentemente inafferrabile”.
Vediamo ora quali sono le conclusioni: “noi, che
abbiamo svolto sinora le nostre considerazioni dall’interno dell’epoché, a ogni momento possiamo riprodurre
1
2
Ivi, § 34.
Ibidem
136
l’attività naturale e, dall’interno di essa, indagare le
strutture invariabili della Lebenswelt. Il mondo della
vita, che comprende in sé tutte le formazioni pratiche
(persino quelle delle scienze obiettive in quanto fatti
culturali) è immerso in un costante riferimento alla
soggettività”1.
Nonostante ciò la Lebenswelt mantiene una tipologia essenziale, a cui rimangono legate sia la vita, sia
tutte le scienze di cui la vita è “terreno”. Perciò essa
possiede un’ontologia propria, che dev’essere attinta
soltanto in una pura evidenza. Possiamo allora concludere dicendo che il mondo della vita è certo soggettivo e
relativo, ma nel senso che esso è in stretta connessione
con il decorso e lo sviluppo di fenomeni di soggettività,
relativi a un soggetto individuale e concreto, al suo
Leib, il corpo proprio individuale. Tuttavia le strutture
di tale mondo della vita non sono relative. La sua evoluzione accade secondo tipicità di essenze, che possono
venir descritte, mediante la descrizione fenomenologica, compito filosofico per eccellenza. La qual cosa rende possibile un’ontologia della Lebenswelt, cioè una tipologia del mondo che è sempre disponibile, con le sue
evidenze, per il nostro vivere quotidiano e nel quale si
edificano i valori della cultura e delle scienze.
1
Ivi, § 51.
137
PARTE TERZA: HEIDEGGER, I
1
Percorriamo ora l’ultimo tratto del nostro itinerario.
Ci si occuperà di Martin Heidegger, discepolo di
Husserl, il quale sembra seguire gli insegnamenti del
Maestro, anche se in realtà ne prende le distanze. Analizzeremo alcuni paragrafi di Essere e tempo. Proprio in
questa, che rimane la sua opera principale, viene marcata la differenza con la fenomenologia husserliana,
nonostante che Heidegger sostenga, come si vedrà, la
bontà del metodo fenomenologico in funzione del procedere stesso del suo pensiero.
Sein und Zeit è pubblicato nel 1927, contemporaneamente in un volume e, come articolo, nella rivista di
Husserl “Jahrbuch für Phänomenologie und phänomenologische Forschung”. Leggiamo l’esergo, nel quale si
prende spunto da una citazione di Platone: “è chiaro
che voi da tempo siete familiari con ciò che intendete
quando usate l’espressione essente; anche noi credemmo un giorno di comprenderlo senz’altro, ma ora siamo
caduti nella perplessità” [Platone, Sofista, 244 a]. Heidegger commenta “abbiamo noi oggi una risposta alla
domanda intorno a ciò che propriamente intendiamo con
la parola ‘essente’? Per nulla. È dunque necessario riproporre il problema del senso dell’essere. Ma siamo
almeno in uno stato di perplessità per il fatto di non
comprendere l’espressione ‘essere’? Per nulla. È dunque
necessario incominciare col ridestare la comprensione
139
del senso di questo problema. Lo scopo del presente lavoro è quello della elaborazione del problema del senso
dell’’essere’”1.
2
Nel Sofista Platone è il primo a porre il problema
dell’ente. Ancora oggi dobbiamo dare una risposta, perché non sappiamo propriamente cosa intendiamo con tale parola. Cos’è l’essente (Seiende)? Dunque, prosegue
Heidegger, è necessario “riproporre il problema del
senso dell’essere”, perché per arrivare a chiarire cosa
sia un “ente”, si tratta di reimpostare il problema relativo all’essere dell’ente, su cui si sta ricercando.
È di un certo interesse, lo fa notare Heidegger
stesso, come noi non siamo per nulla perplessi per il
fatto che non abbiamo effettiva comprensione dell’espressione “essere”. Lo scopo del lavoro risiede nell’elaborazione della problematica relativa all’essere, colto
storicamente, vale a dire nel tempo.
Nel primo paragrafo, Necessità di una ripetizione
esplicita del problema dell’essere, Heidegger afferma
che nonostante l’intera storia della metafisica, l’essere
è stato dimenticato; e d’altra parte non si tratta affatto di una “cosa” qualsiasi, perché è il problema dell’intera filosofia. Sulla base di una speculazione, che
ereditiamo dalla filosofia greca, si è costituito una sorta di dogma, che tende a legittimarne l’omissione e addirittura la rimozione: il concetto dell’essere sarebbe
da considerare quello più generale e vuoto di tutti ed è
1
M. Heidegger, Essere e tempo, Milano, Longanesi, p. 14.
140
per questo che resiste a qualsiasi tentativo di definizione.
Nei confronti della sua stessa impostazione e
contro ogni prospettiva si stampo metafisico si prospettano così tre pregiudizi: 1. quello di “essere” è il
concetto più generale di tutti. Aristotele riconosce la
sua generalità, quale trascendentale (per i medioevali
sarà il trascendens), da contrapporre alla molteplicità
reale di ogni altro concetto. La generalità riconosciuta
risiede nell’unità analogica, per cui on pollakos legherai.
Hegel definisce l’essere come l’immediato indeterminato, ponendo tale definizione a base di tutte le successive elaborazioni categoriali (nella Logica, poi, essere e
nulla sembrano arrivare a coincidere nel divenire); 2. il
concetto di “essere” è indefinibile. Non può essere
concepito come un ente, perché sembra fondare l’ente,
in forza della sua generalità, D’altra parte non è possibile definire l’essere, muovendo da concetti più alti, né
presentarlo, muovendo da quelli più bassi; 3. Il concetto di essere è ovvio. Ogni espressione che lo contenga
appare infatti immediatamente comprensibile: tutti
credono di comprendere cosa significhi, a esempio, che
“il cielo è azzurro e io sono contento”, ma, sostiene
Heidegger, questa è una comprensione media, che nasconde di fatto un’incomprensione. Essa sta a mostrare
come ogni modo di essere, che pone noi stessi in relazione a un qualsiasi ente, nasconda un enigma.
In conclusione, viviamo già da sempre nella comprensione dell’essere, ma allo stesso tempo il senso
dell’essere continua a rimanere per noi quasi del tutto
141
oscuro. È per questo motivo che esso è da sempre il ricercato e il da ricercare.
Di necessità è allora da ripetere il problema
dell’essere, non tanto per offrirne una soluzione, quanto piuttosto per elaborarne in modo adeguato l’impostazione stessa. A proposito di questa necessità individuata di saper trovare il modo giusto di porre il problema dell’essere, compito primo di una filosofia, che
voglia prendere le distanze da quella che è considerata
vera e propria rimozione, è di un certo interesse una
nota relativa alla comprensione media, da cui parte l’indagine. La comprensione media è sempre indispensabile
per qualsiasi comprensione: sono qui in gioco metodo e
pensiero di Heidegger, vale a dire precomprensione e
comprensione, come si avrà modo di vedere.
Leggiamo: “la posizione di un problema, in quanto
cercare, esige di essere preliminarmente guidata da ciò
che è cercato. Il senso dell’essere deve quindi esserci
già accessibile in qualche modo. Come dicemmo, noi ci
muoviamo già sempre in una comprensione dell’essere. È
da essa che sorge il problema esplicito del senso dell’essere e la tendenza alla determinazione concettuale
di esso. Non sappiamo che cosa significa ‘essere’. Ma
per il solo fatto di chiedere: ‘che cosa è ‘essere’? ci
manteniamo in una comprensione del ‘è’, anche se non
siamo in grado di stabilire concettualmente il significato di questo ‘è’. E neanche conosciamo l’orizzonte entro
cui cogliere e fissare il senso dell’essere. Questa comprensione media e vaga dell’essere è un fatto”1.
1
Ivi, p. 22.
142
3
Il cercato è l’essere, vale a dire quel che (quid)
determina ogni ente, in quanto ente, ma l’essere non è
esso stesso un ente. In proposito Heidegger sostiene
che all’interno della filosofia occidentale si può costatare oblio e rimozione dell’essere, dal momento che anche quando la tradizione ha inteso parlare addirittura
di Dio e di Assoluto ha finito col far riferimento a un
Ente supremo, piuttosto che all’essere.
Pertanto: 1. il senso dell’essere che dev’essere ricercato richiede un apparato concettuale suo proprio,
che si differenzi da quei concetti mediante i quali
l’ente ottiene la determinazione del suo significato. Si
noti qui che Sein und Zeit non sarà portato a conclusione, ma interrotto, dopo la pubblicazione della prima
parte, proprio a motivo della mancanza di adeguato linguaggio; 2. l’interrogato è l’ente stesso, se essere significa essere dell’ente, di qualsiasi ente; l’ente verrà
inquisito a proposito del proprio essere.
Ciò detto viene individuato un ente particolare e
specifico, che costituisca la via di accesso alla giusta
impostazione del problema del senso dell’essere, perché “volgere lo sguardo”, “comprendere”, afferrare
concettualmente” sono comportamenti propri del cercare e modi di essere di un ente particolare, che “noi
stessi siamo, i cercanti”.
Troviamo così scritto: “questo ente, che noi stessi
sempre siamo e che fra l’altro ha quella possibilità di
143
essere che consiste nel porre il problema, lo designamo
col termine Dasein (Esser-ci)”1.
La posizione esplicita del problema del senso dell’essere richiede un’adeguata esposizione preliminare
circa il Dasein. Si esige pertanto un’”analitica ontologica dell’Esserci come estensione dell’orizzonte per l’interpretazione del senso dell’essere in generale”. Si
tratta della cosiddetta analitica esistenziale, che riguarda la struttura ontologica del Dasein, che è Existenz. Anche in prospettiva del confronto con la fenomenologia trascendentale husserliana e nell’intento di
evidenziare i punti di “rottura” tra le due diverse concezioni della medesima fenomenologia, è per noi interessante un’osservazione circa la comprensione media
dell’essere e il Dasein. L’essere, sostiene Heidegger, è
il presupposto di qualsiasi ontologia sinora esistita. Com’è da intendere tale presupposizione”?
Essa “ha il carattere di un colpo d’occhio (Augenblick) preliminare sull’essere […]. Questo colpo d’occhio
direttivo sull’essere nasce da quella comprensione media dell’essere in cui già da sempre ci muoviamo e che,
alla fine, appartiene alla costituzione essenziale dell’Esserci”2. Notiamo qui la stretta analogia tra questo
colpo d’occhio sull’essere qui ipotizzato e la intuizione
di essenze di Husserl; inoltre il concetto di comprensione media rievoca la doxa husserliana.
Cominciamo a fare però alcune distinzioni. Heidegger opera uno stacco tra il problema ontologico e
1
2
Ivi, p. 24.
Ivi, p. 25.
144
quello ontico, con riferimento alla ricerca in ambito
scientifico. In proposito notiamo qui un altro particolare significativo di differenza: mentre Husserl prende
l’avvio dal tentativo (cartesiano) di elaborare una filosofia come scienza rigorosa, Heidegger invece dà indicazione circa il problema per eccellenza in ambito teoretico, su cui indirizzare ogni sforzo del pensiero: il
senso dell’essere. Inoltre sia l’un pensatore che l’altro
criticano le filosofie della tradizione e al tempo stesso
le scienze, perché ritengono comunque che un’impostazione radicalmente nuova del pensiero teoretico, mediante metodologia fenomenologica, possa essere rifondativi sia della filosofia sia delle scienze.
A proposito del legame e della differenza tra
scienza e filosofia scrive Heidegger che “l’indagine
scientifica compie la demarcazione e la prima fissazione degli ambiti delle cose in modo grossolano e rozzo”1;
altrove, d’accordo in certo qual modo con Kant, sostiene lapidariamente e provocatoriamente addirittura che
“la scienza non pensa”. L’elaborazione dell’ambito delle
cose avviene dunque sin dall’ambito prescientifico. Inoltre, si parla anche qui, come in Husserl, di “crisi delle scienze”, crisi dei loro stessi fondamenti; e questa
osservazione e rilevazione vale sia per le scienze della
natura, sia per le scienze dell’uomo, sia per la scienza
di Dio, la teologia.
Si tratta allora di operare una revisione dei concetti fondamentali, che costituiscono “le determinazioni in cui l’ambito di cose che sta alla base di tutti gli
1
Ivi, p. 27.
145
oggetti tematici di una scienza perviene alla comprensione preliminare che guida ogni ricerca positiva”1. Ora
capita che le scienze non siano in grado di pervenire a
un chiarimento circa i loro fondamenti. Cosa che può
dare soltanto la filosofia, mediante ricerca ontologica,
che è “più originaria della ricerca ontica delle scienze
positive”2.
Le scienze dunque “non pensano”, sia perché non
riconoscono i propri presupposti, sia perché non arrivano a chiarire i propri fondamenti; e d’altro canto un’indagine del genere non viene a coincidere con il loro
compito precipuo.
In conclusione Heidegger, così come ha fatto
Husserl, propone l’aspetto trascendentale della sua ricerca: “il problema dell’essere mira perciò alla determinazione a priori delle condizioni di possibilità non solo delle scienze che studiano l’ente, che è tale in questo
o in quel modo, e che si muovono quindi già sempre in
una comprensione dell’essere, ma anche delle ontologie
stesse, che precedono le scienze ontiche e le fondano.
Ogni ontologia, per quanto disponga di un sistema di categorie ricco e ben connesso, rimane, in fondo, cieca e
falsante rispetto al suo intento più proprio, se non ha in
primo luogo sufficientemente chiarito il senso dell’essere e se non ha concepito questa chiarificazione come
il suo compito fondamentale”3.
1
2
3
Ivi, p, 29.
Ivi, p. 30.
Ibidem
146
4
Leggiamo ora il § 6: Il compito di una distruzione
della storia dell’ontologia.
L’essere del Dasein, su cui anzitutto deve portare
l’attenzione il filosofo, che intenda porre di nuovo il
problema dell’essere, trova il suo stesso senso nella
temporalità: il ci (da) indica infatti il qui e ora della determinazione di un certo ente. La temporalità è la condizione della storicità, che significa la costituzione del
divenire storia dell’esserci come tale, sul cui fondamento è possibile qualcosa come storia del mondo. Dunque è l’essere storico di un determinato ente, il Dasein,
che determina la storicità del mondo intero.
Scrive Heidegger che “nel suo essere effettivo,
l’Esserci è sempre come e che cosa già era. Esplicitamente esso è il suo passato”1. Tale storicità elementare
però può restare nascosta; essa può essere scoperta
solo mediante uno specifico impegno di ricerca. Dunque
può accadere che il Dasein “cada” nel mondo che gli appartiene, cada anche dentro una tradizione, e dunque
nel proprio passato, senza aver avuto modo di poterla
affermare concettualmente in modo esplicito.
Accade così che “la tradizione prende il predominio e tende così poco a rendere accessibile ciò che
tramanda che, innanzi tutto e per lo più, piuttosto lo
copre. Essa rimette il tramandato alla ovvietà e blocca
l’accesso alle “fonti” originali, a cui le categorie e i concetti tramandati erano stati attinti in modo originale.
1
Ivi, p. 43.
147
La tradizione fa addirittura dimenticare questa provenienza”1.
La tradizione così tramandata ha occultato il problema del senso dell’essere, caduto nella dimenticanza.
Bisogna allora che la tradizione in cui da sempre siamo
(siamo il nostro passato) sia “resa nuovamente fluida e
che i veli da essa accumulati siano rimossi”. Come può
avvenire tutto ciò? Risponde Heidegger: “questo compito è da noi inteso come da distruzione (Destruktion)
del contenuto tradizionale dell’ontologia antica, distruzione da compiersi sotto la guida del problema
dell’essere, fino a risalire alle esperienze originarie in
cui furono raggiunte quelle prime determinazioni dell’essere che fecero successivamente da guida”2.
Il problema relativo all’interpretazione dell’essere
va poi di pari passo con una connessione tematica ineludibile con il fenomeno del tempo e con la problematica
della temporalità: essere e tempo, appunto.
Nota Heidegger come il primo e l’unico pensatore
che ha percorso seriamente almeno un tratto di strada
nel senso della direzione della temporalità fu Kant, il
quale lo fece sotto la spinta della considerazione del
mondo dei fenomeni. La trattazione di Heidegger, almeno per quel che riguarda il tempo, intende gettar luce anzitutto sullo schematismo trascendentale kantiano, fornendone un’interpretazione. Si perverrà alla
conclusione che Kant fallì nel tentativo di penetrare
nella problematica della temporalità. Fu impedito dalla
1
2
Ivi, p. 45.
Ivi, p. 47.
148
dimenticanza del problema dell’essere in generale, e
dalla conseguente mancanza di un’ontologia dell’Esserci,
di un’analitica ontologica della soggettività del soggetto. Proprio a motivo di ciò Kant accetta dogmaticamente la posizione di Cartesio, nonostante introduca in essa sviluppi davvero essenziali.
5
Nel § 7 su Il metodo fenomenologico della ricerca, Heidegger tratta del concetto di fenomeno, di logos e di fenomenologia.
Per il fatto che si sia determinato l’oggetto della
ricerca, sembrerebbe già di per sé indicato il metodo
d’indagine; e invece il metodo dell’ontologia resta ancora una volta “altamente problematico”. Si tratta di far
partire la ricerca da “necessità oggettive” e dal modo
di trattazione che viene richiesta dalle cose stesse.
Ci si trova di fronte al problema fondamentale
della filosofia e il metodo di trattazione dev’essere
quello fenomenologico.
Le puntualizzazioni che seguono sembrano servire
a Heidegger per porsi in modo inequivocabile sulla scia
di Husserl: 1. il metodo fenomenologico non subordina il
lavoro del filosofo a un punto di vista determinato, né a
una corrente di pensiero, che sia più o meno dominante
al momento; 2. l’espressione “fenomenologia”, caratterizzando il metodo, non specifica affatto il che cosa
reale degli oggetti della ricerca filosofica, ma il loro
come, la modalità espressiva e di manifestazione delle
cose o dei dati di fatto, come direbbe Husserl; 3. il
149
termine “fenomenologia” esprime la massima che può
essere così formulata: “verso le cose stesse”, in contrapposizione a “costruzioni fluttuanti, ai trovamenti
casuali, all’assunzione di concetti giustificati solo apparentemente”1.
Dopo aver dichiarato in sintesi, in questi tre punti, la fedeltà agli insegnamenti husserliani, s’intende
approfondire la questione del metodo d’indagine, con
l’esposizione del concetto preliminare di “fenomenologia”. Nel farlo, e lo si fa non accettando acriticamente
il significato tradizionale del termine, si perviene a una
posizione che addirittura divarica rispetto a quella di
Husserl. Insomma, Heidegger intende la fenomenologia
ben diversamente da quella prospettata in Ideen e nella Krisis.
6
La “fenomenologia” è espressione composta da
due termini: “fenomeno” e “logica” (phainomenon e logos
per i greci). Analogamente a quel che diciamo per dei
termini analoghi, quali psicologia, sociologia, biologia,
teologia, ecc., potremmo sostenere, anche se forse un
po’ superficialmente, che si tratta di “scienza dei fenomeni”. Molto probabilmente, cominciamo a osservare,
che è proprio così che la intende lo stesso Husserl.
Heidegger ritiene invece che si debba anzitutto
andare alla radice del significato dei due termini componenti e successivamente stabilire il senso che risulta
dalla loro unione.
1
Ivi, p. 54.
150
A. Il concetto di fenomeno.
L’espressioe greca phainomenon, da cui “fenomeno”, deriva da phainestai, che significa “manifestarsi”.
Phain è “quel che si manifesta”, il manifestantesi; phainestai è la forma media di phaino, che significa “illuminare”, “portare in chiaro” e che deriva dalla radice pha
come anche phos, che è “luce”, “chiaro”. Pertanto phainomenon è “ciò in cui qualcosa può manifestarsi, rendendo visibile in se stesso, perché arriva alla luce (in
chiaro)”.
Allora il “fenomeno” è quel che si rende manifesto
in se stesso. Il mondo dei fenomeni è l’insieme di ciò
che è alla luce del giorno o che può essere portato alla
luce: tutto quel che i greci identificavano senz’altro
con ta onta, gli essenti o le cose.
Come Kant, poi, Heidegger distingue “fenomeno”
da “apparenza” o parvenza. “Fenomeno” sta a significare il modo particolare in cui qualcosa si incontra, inerisce la cosa, mentre “apparenza” significa un rapporto di
riferimento interno alla cosa, la quale è, ma appare poi
soltanto in un certo modo e dunque cela il suo proprio
essere nel carattere fenomenico.
Nella tradizione occidentale spesso si è confusa
l’apparenza con il fenomeno e pertanto un concetto ordinario e comune di fenomeno con un altro concetto di
marca fenomenologica. Si tratta allora di arrivare a cogliere nel fenomeno inteso in senso ordinario quel che
“già sempre di manifesta preliminarmente e contemporaneamente, benché non tematicamente”1 e può essere
1
Ivi, p. 60.
151
portato all’automanifestazione. In conclusione, “questo
così-automanifestantesi-in-se-stesso (le “forme dell’intuizione”) è ciò a cui noi diamo il nome di fenomeno della fenomenologia”.
B. Il concetto di logos.
In Platone e in Aristotele tale concetto non è affatto univoco. Il significato fondamentale è quello di
discorso; successivamente, proprio su tale base logos è
stato tradotto come “ragione”, “giudizio” e “concetto”.
A ogni modo logos non significa primariamente “giudizio”, se con tale termine s’intende il collegare un concetto con un altro o il “prendere posizione” e/o “valutare”.
Logos quale discorso significa qualcosa come deloun, vale a dire “rendere manifesto quello di cui nel discorso si discute”. Aristotele parla della funzione apofantica (da apophainesthai) del logos, che lascia vedere
(phainestai) qualcosa e precisamente quello su cui verte
il discorso. Lo lascia vedere per coloro che discorrono
fra di loro (logos dia, che è poi dialogos, dialogo). Inoltre, nella sua realizzazione concreta il logos/discorso
ha il carattere del parlare, della comunicazione con le
parole: logos è phoné.
Ancora di più: poiché il logos è un “lasciar vedere”
proprio per questo motivo esso può essere vero o falso.
Nota Heidegger che bisogna rifiutare l’idea di verità
come adeguamento o conformità tra parola e cosa, che
viene dalla tradizione metafisica: la veritas quale adaequatio rei et intellectus; questa idea non è affatto un
elemento primario del concetto greco di aletheia.
152
Pertanto l’esser vero del logos, in quanto aletheuein significa: “nel legein, in quanto apophainesthai
trarre fuori l’ente di cui si discorre dal suo nascondimento e lasciarlo vedere come non nascosto (alethes),
scoprirlo”1; d’altra parte “essere falso” (pseudesthai)
vuol dire ingannare, nel senso di “coprire”, di “far rimanere nascosto”.
“Vero”, nel senso più puro e originario, è il puro
noein, la percezione, che guarda puramente alle più
semplici determinazioni d’essere dell’ente. Tale noein
non potrà mai essere falso; tutt’al più potrà non percepire, avendo accesso insufficiente all’ente. La funzione
essenziale del logos, dunque, risiede nel “puro lasciare
vedere qualcosa”, nel “lasciare percepire l’ente”.
C. Il concetto preliminare di fenomenologia.
Leggiamo: “se esaminiamo concretamente i risultati dell’interpretazione di ‘fenomeno’ e di ‘logos’, salta
subito agli occhi l’intima connessione che li stringe.
L’espressione fenomenologia può essere formulata come segue in greco: leghein ta phainomena, dove leghein
significa apophainesthai ta phainomena: lasciar vedere
da se stesso ciò che si manifesta, così come si manifesta da se stesso. Questo è il senso formale dell’indagine che si autodefinisce fenomenologia. Ma in tal modo
non si fa che esprimere la massima formulata più sopra:
verso le cose stesse”2.
Cos’è che la fenomenologia deve lasciar vedere,
mediante le sue descrizioni? Cos’è che merita il nome di
1
2
Ivi, p. 62.
Ivi, p. 64.
153
fenomenologia? Certo è qualcosa che innanzi tutto e
per lo più non si manifesta, qualcosa che resta nascosto
rispetto a ciò che si manifesta. Ora, puntualizza Heidegger, non si tratta di questo o di quell’ente, ma
dell’essere dell’ente, di qualsiasi ente. La fenomenologia
ha preso perciò come oggetto tematico qualcosa che
esige di diventare fenomeno. Ancora di più: la fenomenologia è il modo di raggiungere quel che deve costituire il tema proprio dell’ontologia. Insomma, “l’ontologia
non è possibile che come fenomenologia”1.
Il concetto fenomenologico di fenomeno intende
proporre l’automanifestazione dell’essere dell’ente, il
suo senso. L’essere dell’ente non può essere inteso come qualcosa che stia dietro o sotto alcunché e che non
appare, perché “dietro i fenomeni della fenomenologia
non si trova assolutamente nulla, a meno che non vi si
celi qualcosa di destinato a divenire fenomeno. È proprio perché i fenomeni, innanzitutto e per lo più non
sono dati, che occorre la fenomenologia. Esser coperto
[dietro] è il concetto contrario di fenomeno”2.
7
Considerata alle prese con il suo oggetto, la fenomenologia è la scienza dell’essere dell’ente o anche
ontologia. Heidegger ricorda che è necessaria un’ontologia fondamentale, che assuma come tema l’ente che
ha il privilegio di poter indagare e ricercare sull’essere,
1
2
Ivi, p. 66.
Ibidem
154
vale a dire porsi la domanda circa il senso dell’essere
dell’ente, il Dasein.
Anticipa poi che la ricerca che riguarda il Dasein
porterà a un risultato certo: “il senso metodico della
descrizione fenomenologica è l’interpretazione (Auslegung). Il logos della fenomenologia dell’Esserci ha il carattere dell’ermeneuein, attraverso il quale il senso autentico dell’essere e le strutture fondamentali dell’essere dell’Esserci sono resi noti alla comprensione d’essere propria dell’Esserci. La fenomenologia dell’Esserci
è ermeneutica nel senso originario della parola, secondo
cui essa designa il compito stesso dell’interpretazione”1.
Vediamo cos’è accaduto. Cercando di stabilire il
senso dell’essere, tramite l’analitica dell’Esserci e dopo
aver delineato il significato del metodo fenomenologico, Heidegger giunge alla conclusione che la metodologia propria e specifica della descrizione fenomenologica è tutt’una con l’interpretazione. Il logos della fenomenologia, che è discorso, come si è visto, ma anche
svelamento, è caratterizzato dall’ermeneuein.
Notiamo qui come tutto questo mal si concili con
quanto avevamo letto ed evidenziato nei testi in cui
Husserl proponeva la fenomenologia trascendentale
quale scienza rigorosa, contrastando opinioni, punti di
vista, Weltanschauungen e interpretazioni.
È interessante notare come subito dopo, quasi a
voler denegare la presa di distanze netta, addirittura
clamorosa nei confronti del maestro, Heidegger tenga
1
Ivi, pp. 68-69.
155
a ribadire, al termine della lunga Introduzione a Essere
e tempo, il suo debito nei confronti di Husserl: ontologia e fenomenologia non sarebbero dunque discipline
diverse, per i motivi su detti, ma denoterebbero entrambe la filosofia tout court nel suo oggetto e nel suo
procedimento: “la filosofia è ontologia universale e fenomenologica, muovente dall’ermeneutica dell’Esserci”1.
E ancora: “le ricerche che seguono [e che avranno proprio quelle conseguenze teoretiche!] sono state possibili solo sul fondamento posto da E. Husserl con le Ricerche logiche, dal quale la fenomenologia venne alla luce”2.
In una nota, poi, si aggiunge che la ricerca è in
grado di compiere qualche passo in avanti verso le “cose stesse” per merito di Husserl, del suo magistero di
Friburg, che rese familiari i diversi campi dell’indagine
fenomenologica, mediante una guida davvero efficace e
permettendo l’accesso anche a ricerche non ancora
pubblicate, e dunque probabilmente anche ai materiali
preparatori della Krisis.
8
Procediamo ora nella lettura del testo.
Delineato il campo proprio dell’analitica esistenziale, rispetto a quelli di antropologia, psicologia e biologia, nel secondo capitolo Heidegger tratta dell’essere-nel-mondo come costituzione fondamentale del Dasein.
1
2
Ivi, p. 70.
Ibidem
156
Leggiamo il § 12: Linee fondamentali dell’esserenel-mondo a partire dall’in-essere come tale. Già in
precedenza nel § 4 Heidegger aveva sostenuto che
“all’Esserci appartiene in linea essenziale di essere in
un mondo. La comprensione dell’essere, propria dell’Esserci, concerne perciò cooriginariamente la comprensione di qualcosa come “il mondo” e la comprensione
dell’essere dell’ente accessibile all’interno del mondo”1.
Per stabilire l’essere proprio dell’Esserci non si
può fare a meno del riferimento al mondo. Heidegger,
poi, distingue due “comprensioni” che sono della stessa
portata, complementari e quindi cooriginarie: la comprensione relativa a un quid che non definiamo come il
nostro mondo, quale totalità degli enti e la comprensione dell’essere di un ente, di qualsiasi ente, che viene
individuato immancabilmente all’interno del mondo.
Qui Heidegger approfondisce il carattere fondamentale della mondità dell’Esserci. Si sostiene che le
determinazioni di essere del Dasein possono essere
colte solo sul fondamento della costituzione di essere
che viene individuata come in-der-Welt-Sein. La traduzione “essere-nel-mondo” non sembra render bene l’idea che Heidegger crede di voler proporre con questo
esistenziale. Notiamo anzitutto che si tratta di un neologismo, con espressione unica, i cui termini sono legati
da trattini, in vista di un significato unitario.
Vediamo ora quale spiegazione dia Heidegger. Per
comprendere l’intera espressione bisogna spiegare l’inder-Welt, in secondo luogo si dovrà precisare l’in1
Ivi, p. 33.
157
essere, vale a dire la realtà di quell’essere che è in,
nel-mondo, nella sua costituzione di essenza.
Cosa significa essere-in, nel-mondo? Di primo acchito, in una comprensione ovvia, che è quella del buon
senso comune “in atteggiamento naturale” o “comprensione media” delle cose, si sarebbe portati pensare a
un essere che è in, vale a dire che è dentro. Pertanto
avremmo a che fare con un ente che è dentro un altro
ente, che funge da contenitore rispetto al primo. A esempio: l’acqua è nel bicchiere, la chiave è nella toppa
della porta, ecc. Con la determinazione dell’in, inteso
come dentro viene proposto un rapporto di essere tra
due enti, che hanno una determinata estensione rispetto al loro luogo in uno spazio condiviso. Difatti: acqua,
bicchiere, chiave, toppa e porta sono tutti enti contenuti nel medesimo luogo. Naturalmente le relazioni tra
gli enti possono essere ulteriormente estese: il banco è
nell’aula, che è nell’edificio, che è in Milano, che è in
Europa, che è nel mondo.
Ecco che così, per gradi o se si preferisce anche
in un “colpo solo” si arriva alla determinazione ultima di
un ente (di qualsiasi ente) che è nel o dentro il mondo,
intendendo quest’ultimo come lo spazio universale, che
tutto comprende e contiene. Direbbe Jaspers l’Umgreifende, il tutto-abbracciante.
Tutti gli enti, in questa determinazione dell’in come dentro, sarebbero caratterizzati da quella che Heidegger definisce la “semplice presenza”, in quanto sono
cose presenti nel mondo. Tale in-essere delle cose è un
carattere ontologico categoriale.
158
Heidegger precisa, invece, che l’in-essere dell’inder-Welt-Sein sta a significare un esistenziale. Tro-
viamo così scritto: “perciò non può essere pensato come l’esser semplicemente-presente di una cosa corporea (il corpo dell’uomo) “dentro” un altro ente semplicemente presente. L’in-essere non significa dunque la
presenza spaziale di una cosa dentro l’altra, poiché
l’”in”, originariamente, non significa affatto un riferimento spaziale del genere suddetto”1.
9
Cosa significa allora l’in di in-der-Welt-Sein, se
non dentro con una precisa connotazione spaziale? L’in
deriva da innan, abitare e soggiornare, in cui an ha il significato di “sono abituato, sono familiare con, sono solito”. Dunque, l’essere cui appartiene per essenza l’inessere è proprio quell’ente che io sempre sono.
L’espressione sono, poi, richiama anch’essa l’abitazione.
Più esplicitamente di quanto non faccia in Essere e
tempo, in uno scritto contenuto nel volume, che raccoglie vari saggi, dal titolo Costruire abitare pensare,
Heidegger sostiene che abitare (buan) è tutt’uno con
l’essere proprio dell’io, dell’io sono, appunto: in tedesco
ich bin. Il modo in cui io sono, il modo in cui l’uomo è
sulla terra e nel mondo è il buan, l’abitare2.
Io sono, dunque, significa io abito, soggiorno
presso: io soggiorno presso il mondo, che mi è familiare. Il mondo risulta allora per me tale, proprio in virtù
1
2
Ivi, p. 93.
Cfr. M. Heidegger, Saggi e discorsi, Milano, Mursia, pp. 97-107.
159
di un soggiorno e di un’abitudine. L’essere che io sono,
inteso quale esistenziale, significa allora abitare presso, aver familiarità con.
Per arrivare a comprendere ancora meglio ed evitare possibili equivoci, che forse permangono se si pensa che tutta questa spiegazione potrebbe a ogni modo
essere ricondotta a interpretare l’in come “dentro”, nel
senso che l’io è dentro la propria abitazione, potremmo
forse appellarci alla traduzione francese dell’espressione in-der-Welt-Sein, a opera della fenomenologia di
M. Merleau-Ponty, che suona così: être-au-monde.
L’Esserci è allora mondano non tanto perché abita
il (nel) mondo, tanto meno perché è un ente che è contenuto nel mondo, ma piuttosto perché tra questo ente
particolare e il mondo si dà una sorta di coimplicazione
e di simbiosi. Essere-al-mondo comporta una relazione
di coessenzialità, che esclude pertanto qualsiasi carattere di esteriorità di un ente rispetto a un altro ente.
Più avanti, nel cap. IV, Heidegger dedica la trattazione all’approfondimento del fondamento ontologico
dell’in-essere, in quanto tale. L’intento è quello di proporre una specie di “ispezione fenomenologica” di tutte
le strutture tipiche e caratterizzanti l’in-der-WeltSein, ma allo stesso tempo “aprire la via alla determinazione dell’essere originario dell’Esserci stesso, la cura (die Sorge)”.
Die Sorge è il carattere esistenziale, che specifica al meglio l’essere-al-mondo: con esso difatti Heidegger crede si possa chiarire sia l’essere-presso-ilmondo, vale a dire l’abitare e l’aver familiarità con nel
160
prendersi cura degli enti intramondani, sia il conessere
nel mondo, vale a dire il mit-Sein di un mondo comune
ad altri Dasein. Così intesa, la cura precede, quale fondamento, ogni situazione, essa è costitutiva di ogni
comportamento.
Individuata die Sorge come carattere ontologico
essenziale dell’in-essere, Heidegger specifica poi i caratteri del Dasein. Scrive così che “l’ente la cui essenza è costituita dall’essere-nel-mondo è il suo ci”; insomma, l’Esserci è specificato dal “ci”. Cosa sta a significare il da del Da-sein? Esso indica il qui e ora, l’hic et
nunc, per una determinazione precisa, puntuale spaziotemporale dell’esistenza, di ciascuna esistenza singola.
Si tratta del qui e ora di un “io” che è sempre
compreso da un essere-per un determinato utilizzabile,
un essere-per, che si prende cura, che ha cura degli
enti intramondani. Il qui determina l’essere dell’Esserci
in modo esistenziale, ne specifica il posto che si fonda
nell’essere-al-mondo. L’espressione da (ci) significa allora l’essenziale apertura, che è modalità specifica del
proprio essere, perché proprio mediante essa e soltanto con essa l’Esserci ci è, è qui e ora, per se stesso in
uno con l’Esserci del mondo.
161
PARTE
TERZA.
HEIDEGGER, II
1
Veniamo ora alla determinazione per noi fondamentale, proposta nell’Analitica esistenziale. Nel § 28
troviamo scritto che “i due modi cooriginariamente costitutivi in cui l’Esserci ha da essere il suo Ci sono la situazione emotiva e la comprensione. Situazione emotiva e comprensione sono cooriginariamente determinate
dal discorso”1.
Sta qui prendendo forma, anche se al momento si
dà soltanto un cenno, la divaricazione nei confronti della fenomenologia trascendentale di Husserl. In particolare vedremo come il modo stesso di intendere la comprensione e il connesso discorso porteranno Heidegger
a prendere le distanze dal Maestro.
Intanto si comincia con l’affermare che risultano
allo stesso modo e nella stessa misura cooriginarie e
coessenziali per l’essere del Dasein, per il suo ci e per
la sua cura delle cose, Befindlichkeit, Verstehen e Rede.
2
Prima di occuparci della comprensione (Verstehen), cui dedicheremo l’ultima parte del corso che fungerà anche da confronto con la fenomenologia husserliana, proponiamo qualche breve riflessione sulla situazione emotiva (Befindlichkeit). Anzitutto è quella stes-
1
M. Heidegger, Essere e tempo, p. 211.
163
sa che in sede ontica è riconosciuta sotto il nome di
umore o di tonalità emotiva.
La Befindlichkeit precede ogni atto di conoscenza
e di volizione, perché è costitutiva di qualsiasi attività
teorico-pratica; essa è apertura dell’Esserci nel suo
stato proprio di in-der-Welt-Sein, che è uno stato di
gettatezza (Geworfenheit). Si dà, poi, una situazione
emotiva per eccellenza, una Grundstimmung, che risiede nell’Angst (altra cosa rispetto alla Furcht, la paura).
Si prova Angst mai di fronte a un ente intramondano,
perché l’oggetto di tale Stimmung è sempre e del tutto
indeterminato. Il davanti-a-che dell’Angst è pertanto il
nulla, l’esperienza di nulla.
Cos’è, però, che s’intende per “nulla”? Il nulla non
è qui inteso come nihil negativum, come niente, la negazione di un ente determinato, e neppure come privazione della totalità degli enti. Il nulla si fonda qui su qualcosa di assolutamente originario, vale a dire con il mondo stesso.
Pertanto, “se il davanti-a-che dell’Angst è il nulla,
cioè il mondo in quanto tale, ne viene: ciò dinanzi a cui
l’Angst è tale, è l’essere-nel-mondo stesso”1.
In conclusione, proprio in quanto elemento ontologicamente costitutivo dell’Esserci, l’Angst apre (è apertura a) originariamente al mondo come mondo, alla
mondità del mondo. Di qui l’ulteriore considerazione
circa il come ci si senta in questa particolare situazione
emotiva: nell’Angst si è spaesati, non ci si sente più a
casa propria, l’io è fuori di sé.
1
Ivi, p. 291.
164
3
Prendiamo ora in considerazione l’Esserci come
comprensione (Verstehen), leggendo il § 31.
Torniamo a quanto già detto, anche perché è lo
stesso Heidegger che non si stanca di sottolinearlo e di
ribadirlo: Befindlichkeit e Verstehen sono due caratteri ontologici del Dasein, che vanno tenuti sempre assieme. Questo sta a significare che sono cooriginari. Di
conseguenza, se si proporrà un’indagine sulla situazione
emotiva, si dovrà tener conto anche della comprensione, e viceversa se ci si occupa della comprensione si
dovrà nel contempo considerare che essa è sempre indirizzata emotivamente.
La comprensione è qui da intendere come comprensione primaria o originaria, vale a dire come un esistenziale o come carattere ontologico del Dasein; ne va
dell’essere del Dasein. Questo significa che è da distinguere nettamente dallo spiegare (Erklären) e dalla
comprensione com’è comunemente intesa (Verständlichkeit). Insomma, il Verstehen non è affatto un modo
possibile di conoscere tra gli altri, ma l’elemento costituente l’essere del ci dell’Esserci, vale a dire la condizione stessa di possibilità (un trascendentale), perché
possano darsi, in seguito, lo spiegare e il comprendere.
Il Verstehen è allora l’in-vista-di-cui l’essere-almondo risulta aperto come tale e questa apertura è
tutt’una con la comprensione, che è da riconoscere pertanto come la modalità propria mediante la quale l’Esserci si rapporta al suo mondo. Troviamo così scritto
che “l’apertura della comprensione, in quanto apertura
165
dell’”in vista-di-cui” e della significatività, concerne cooriginariamente l’intero essere-nel-mondo. La significatività è ciò rispetto-a-cui il mondo è aperto come tale.
Che l’”in vista-di-cui” e la significatività siano aperti
nell’Esserci, significa che l’Esserci è un ente per cui, in
quanto essere-nel-mondo, ne va di se stesso”1.
L’apertura della comprensione è allo stesso tempo
apertura dell’in-vista-di-cui, finalizzata agli enti intramondani come anche apertura di significatività: e cioè
gli enti acquistano un preciso significato all’interno del
mondo, proprio in forza di essa.
La significatività riguarda il rispetto a cui il mondo come tale è aperto, riguarda la relazione biunivoca
tra Esserci e mondo. La possibilità stessa di significazione è implicita in tale relazione.
Pertanto, sostenere che l’in-vista-di-cui e la significatività sono apertura nell’Esserci sta a significare
che l’Esserci proprio per il fatto che è in-der-WeltSein, risulta essere un ente che in forza di tale apertura arriva a porre in gioco se stesso. Questo accade
una volta che si sia stabilita la relazione e il modo stesso di relazionarsi ad altro da sé.
Spesso si adopera l’espressione “comprendere
qualcosa” nel senso di essere in grado di e di essere
capace di, di potere; insomma, “della comprensione fa
parte, in linea essenziale, il modo di essere dell’Esserci
in quanto poter essere”2. Si precisa poi che l’Esserci, in
quanto già-da-sempre in una sua specifica situazione
1
2
Ivi, p. 225.
Ibidem.
166
emotiva, è insediato in determinate possibilità, non in
altre, tanto meno in tutte: “in quanto è quel poter essere che è, ne ha già sempre lasciate perdere alcune
[di possibilità]”1.
4
La comprensione è possibilità e progettualità (poter-essere finalizzato e significativo); in quanto tale
essa esprime quella che può definirsi la visione dell’Esserci, che è in uno con il luogo di apertura del ci e
viene a coincidere con l’Esserci stesso, che viene determinato cooriginariamente nei modi fondamentali
dell’in-essere e cioè della visione ambientale, del prendersi cura e dell’aver cura.
Dire che ogni visione si fonda sulla comprensione
sta, però, a significare che s’intende arrivare a sottrarre all’intuizione il suo rango primario nel processo
di conoscenza. Infatti “intuizione e pensiero sono due
lontani derivati della comprensione. Anche la visione
delle essenze fenomenologica si fonda nella comprensione esistenziale”2. Con questa osservazione, come appare evidente, Husserl sembra essere servito!
A conclusione del paragrafo troviamo poi scritto
che “situazione emotiva e comprensione caratterizzano, come esistenziali, l’apertura originaria dell’in-derWelt-Sein”3. Si ribadiscono così i caratteri ontologici
(essenziali e strutturali) dell’essere dell’Esserci, inteso
1
Ivi, p. 226.
Ivi, p. 231.
3
Ivi, p. 232.
2
167
come essere-al-mondo. L’apertura originaria dell’inessere è caratterizzata allo stesso tempo e allo stesso
modo da Verstehen e da Befindlichkeit. Difatti, l’Esserci è in grado di vedere, di prendere visione e di
comprendere, soltano se si trova in uno stato emotivo,
se è caratterizzato emotivamente. L’elemento umorale
e affettivo è in uno, dunque, con quello logico e razionale. Per comprendere bisogna essere mossi ed emozionati, perché è proprio nel provare emozioni rispetto agli
enti intramondani che si arriva a comprendere gli stessi, in quanto solo così ci si dispone nell’apertura al mondo.
Di cosa, poi si ha visione? Qui si tratta di una “visione ambientale preveggente”, di una specie di “colpo
d’occhio (Augenblick) situazionale e contestuale, che è
tutt’uno col trovarsi nel proprio mondo-ambiente, nel
proprio habitat.
L’Esserci ha visione del suo poter-essere, della
sua stessa possibilità gettata (die Geworfenheit) nell’inessere. Infatti il suo stesso progetto, il progetto
dell’inessere, è determinato dal fatto che l’Esserci è
gettato nel ci, vale a dire condizionato in quanto storico nel suo essere essenziale per quel che riguarda situazione emotiva e comprensione.
5
Muoviamo ora un passo in avanti, davvero decisivo:
“se vogliamo innanzi tutto chiarire fenomenologicamente il modo di essere quotidiano della comprensione quale si costituisce nella situazione emotiva e il modo cor-
168
rispondente di essere dell’apertura integrale del Ci, si
rende necessaria un’elaborazione più concreta di questi
esistenziali”1.
La fenomenologia (ma, chiediamoci, è ancora la
medesima metodologia di Husserl?) intende chiarire il
come della comprensione, che si determina sempre nella Befindlichkeit. Con questa affermazione Heidegger
sembra porsi al di fuori della fenomenologia husserliana, in quanto poco prima aveva sostenuto che la comprensione anticipa le intuizioni di essenze; inoltre la
cooriginaria Befindlichkeit di Heidegger è addirittura
inesistente in Husserl.
Leggiamo il § 32: Comprensione e Interpretazione.
Nell’intento di chiarire la modalità quotidiana della comprensione, è necessario elaborare ulteriormente
gli esistenziali. Questo può avvenire portando l’attenzione sull’Auslegung, l’interpretazione. Nota Heidegger
che il progetto specifico del Verstehen, che è presente
almeno in nuce sin dalla prima e originaria considerazione del Dasein, ha la possibilità di un suo sviluppo: “a
questo sviluppo del comprendere diamo il nome di interpretazione (Auslegung). In essa la comprensione,
comprendendo, si appropria di ciò che ha compreso”2.
In che senso, chiediamoci, l’interpretazione è da
intendere come uno sviluppo necessario del “progetto”
del comprendere? Heidegger risponde che solo mediante Auslegung quel che si trova a livello semplicemente
1
2
Ibidem
Ivi, p. 233.
169
progettuale, ovvero quel che è nel poter essere della
significatività, si fa concreto e si realizza in una effettiva comprensione. Pertanto si danno due momenti distinti della comprensione: il Verstehen, quale esistenziale, che è in uno con la Befindlichkeit e che è da intendere quale poter essere, potenzialità, e il Verstehen che si appropria di quel che già da sempre ha compreso; e lo fa solo mediante Auslegung.
Da queste ultime considerazioni risulta essere
molto stretto il legame e il rapporto tra Verstehen e
Auslegung, a tal punto che potrebbero essere confuse:
comprendere è interpretare, vale a dire che pensare è
tutt’uno con interpretare.
Difatti nell’Auslegung, la comprensione non si trasforma in qualche altra cosa rispetto a quel che è già,
ma diviene se stessa, passando proprio da potenzialità
o da virtualità ad atto. Insomma, trattando dell’Auslegung, è pur sempre del Verstehen che ci stiamo occupando. Inoltre, è proprio l’Auslegung che si fonda sul
Verstehen e non viceversa, vale a dire –come potrebbe
sembrare erroneamente e a prima vista- che è il Verstehen a fondarsi sull’atti di interpretazione. Comprendo effettivamente solo se ho ben interpretato, ma
per poter interpretare bisogna avere già compreso. Qui
si comincia a delineare il cosiddetto “circolo ermeneutico”.
Infine, l’Auslegung non risulta essere mai la semplice riproposizione del Verstehen, ma il suo sviluppo,
una successiva, ulteriore e in certo qual senso definitiva rielaborazione, in quanto porta a compimento le po-
170
tenzialità di un progetto, le potenzialità insite appunto
nella comprensione.
6
Vediamo ora quale possa essere il percorso di sviluppo del “progetto”, compiuto proprio mediante l’atto
di Auslegung. Il punto di partenza è nella significatività
o potenzialità di senso, che è poter (sempre) essere
proprio del Verstehen: è apertura all’interno del comprendere, apertura al mondo (si torni qui a quanto detto relativamente all’inessere). E cioè, si arriva di volta
in volta a rendere concreto ed effettivo il prender cura e l’aver cura degli enti intramondani utilizzabili, ottenendo appagamento con quel determinato e specifico
ente che ci si para davanti, con quell’ente con cui si ha
a che fare al momento.
Mediante Auslegung, dunque, la visione ambientale
preveggente che è apertura all’inessere, concretizza la
comprensione: questo sta a significare che tale visione
giunge finalmente a interpretare un mondo intero, che
in qualche modo, però, risulta già-da-sempre compreso.
È solo a questo punto del percorso che l’utilizzabile,
l’ente intramondano con cui si ha a che fare di volta in
volta, accede in modo esplicito alla visione: si è pervenuti così alla vera e propria conoscenza, che risulta
completa soltanto in forza dell’Auslegung.
Ben diversa, si ricorderà, la visione di essenze
husserliana, che non ha bisogno di un “percorso” e di
uno sviluppo di progetto per realizzarsi, ma di un “colpo
d’occhio” di intuizione. Approfondiamo ora la questione.
171
L’utilizzabile, oggetto di Verstehen e di Auslegung, meglio, progetto di-, è reso esplicito nella sua funzione in
quanto utile per un certo scopo o una certa, determinata finalità. Quel che viene allora colto dall’ente intramondano, mediante Auslegung è in modo esplicito qualcosa in quanto qualcosa. Troviamo così scritto che
“quando la visione ambientale preveggente chiede che
cosa sia un determinato utilizzabile, la risposta conforme alla visione ambientale preveggente è la seguente: “esso è per…”1.
L’indicazione che si ricava relativa al per-che-cosa
giunge a denominare qualcosa in quanto tale, in piena
conformità al proprio essere, dunque. Quel che è compreso perviene all’esplicitazione nell’Auslegung, proprio
con un decisivo chiarimento circa l’in quanto, finalmente scoperto. Scrive Heidegger: “l’in quanto esprime la
struttura esplicativa del compreso: come tale costituisce l’interpretazione”2.
L’Auslegung è però presente dovunque e non soltanto in questa parte dell’Analitica. Il vedere ambientale e preveggente, quel vedere che in certo qual modo
precede qualsiasi visione conoscitiva piena e completa,
anticipa l’interpretazione ed è tutt’uno con il commercio (Umgang) con l’utilizzabile intramondano. L’Umgang
è il modo di essere-al-mondo, in uno con gli enti intramondani, di cui il Dasein si prende cura, proprio in vista
della loro utilizzabilità. È il primo modo possibile di a-
1
2
Ivi, p. 234.
Ibidem
172
ver rapporto con gli enti, che è, per l’essenziale, un
rapporto di significatività.
Tale vedere coglie infatti ambientalmente l’ente
utilizzabile in quanto “tavolo”, “quaderno”, “penna”, ecc.,
insomma sta a indicare il “questo” qui e ora e non ha di
per sé bisogno di alcuna asserzione circa quel che interpreta ambientalmente, perché si completi la visione.
Così inteso il vedere s’identifica con un’esperienza
primordiale e originaria del mondo, quella che viene
fatta degli enti intramondani con cui si ha a che fare e
dei quali ci si prende cura. Essa è senza dubbio antepredicativa o prepredicativa, ma, precisa Heidegger, “è
essa stessa comprendente-interpretante”1.
A tale esperienza manca ancora, però, una determinazione di essere, che accade soltanto mediante interpretazione (Auslegung), anche se questo non sta a
significare che nel commercio con il mondo, con
l’utilizzabile intramondano, il Dasein non sia già di per
sé interpretante. Com’è possibile? Il carattere esistenziale di interpretabilità o di potenzialità all’interpretazione, ancor prima dell’effettivo atto di interpretazione, che ne stabilisce e determina l’in quanto, è dovuto alle specifiche dell’essere-per dell’ente nel suo
aspetto di utilizzabile e nella funzione di rinvio/rimando: l’ente è essere-per altri-da-sé.
L’essere-per, che comporta rinvio e relazione, implica una comprensione dell’ente che s’incontra, che
precede ogni possibile asserzione (Aussage) tematica
circa l’ente stesso. Pertanto “l’asserzione tematica non
1
Ibidem
173
è la matrice dell’”in quanto” ma la sua prima espressione; la quale è possibile solo perché l’”in quanto” preesisteva come esprimibile”1.
7
Proviamo ora a concludere il nostro itinerario teoretico.
Nel parlare della visione ambientale preveggente
Heidegger l’ha definita semplice visione, in cui ci
s’imbatte sempre nel momento stesso in cui si ha a che
fare con qualcosa. Ora, tale visione è tutt’altro che
“semplice”. Difatti l’immediato accesso che abbiamo alla realtà del mondo, proprio tramite visione ambientale,
contiene “in modo originario la struttura dell’interpretazione”2 e pertanto anche l’ipotesi di poter arrivare a
percepire qualsiasi ente privo dell’in quanto e cioè privo
di qualsiasi considerazione di rinvio e di relazione propria dell’utile-per è totalmente fuori dalla realtà delle
cose, e dunque astratta.
Quel qualcosa sarebbe infatti lì, davanti a noi,
come “semplice presenza” e presupporrebbe uno sguardo non più aperto alla visione, perché non più in grado
di comprendere. Quale il motivo? L’ente intramondano
non avrebbe in fondo nulla da dire di sé, dal momento
che verrebbe a mancare lo stesso presupposto della
comunicazione, che risiede proprio, come si è già visto,
nel parametro del rinvio e del rimando, nonché della relazione.
1
2
Ibidem
Ivi, p. 235.
174
Insomma l’ente intramondano non sarebbe nella
possibilità di entrare in relazione con il nostro sguardo,
aperto alla visione preveggente: non entrerebbe mai
nella visione, neppure in quella originaria ambientale.
Esso non possiede i caratteri di un absolutum, in quanto
esser per sé, ma è da considerare sempre relativo a un
ente che sia in grado di riconoscerlo.
Si noti qui come Heidegger insista molto sul carattere ermeneutico-interpretativo di qualsiasi conoscenza, anche di quella più immediata, qual è la percettiva: “ma affermare che ogni percezione di un mezzo
utilizzabile è comprendente-interpretante e che, nella
visione ambientale preveggente, essa lascia che
s’incontri qualcosa in quanto qualcosa, non equivarrà a
dire che, innanzi tutto si incontra qualcosa come semplicemente presente e poi lo si giudica in quanto porta,
in quanto casa? Ciò equivarrebbe a una completa incomprensione della funzione specifica di apertura propria
dell’interpretazione”1.
Vengono qui proposte due considerazioni, per noi
di rilievo. Anzitutto si dice che non è possibile sostenere che prima incontriamo l’ente come qualcosa di semplicemente presente, che è qui davanti a noi come un
qualcosa senz’altra aggettivazione, e poi si arriva a determinarne l’in quanto: lo si caratterizza e specifica
come “tavolo”, come “finestra”, come “penna”…; in secondo luogo se si dice che questo è quel che accade, significa fraintendere completamente la funzione che è
propria di apertura (l’inessere) dell’interpretazione.
1
Ibidem
175
L’interpretazione non è affatto un’attività intellettiva che rivesta l’ente, il quale di per sé si presenta
nella sua “modalità” di “semplice presenza”: nel qual caso si tratterebbe di un oggetto, che si contrappone a
un soggetto nella conoscenza scientifica, che prospetta
la spiegazione. L’interpretazione rivestirebbe l’ente,
fornendolo di un significato e attribuendogli un valore.
Non accade questo nella relazione e nel rapporto originari e primordiali, che si stabiliscono tra il Dasein, quale essere-al-mondo e gli enti intramondani con cui esso
ha a che fare. Infatti nel rapporto con l’ente intramondano quale utilizzabile si consegue già da sempre, e di
primo acchito, vale a dire sin dalla visione ambientale e
preveggente, la piena appagatività, e cioè la comprensione dell’in-essere nel proprio mondo, già in atto o che
è da sempre.
Quel che accade in seconda istanza, però, è che
tale appagatività è resa esplicita e perviene all’emergenza e a piena consapevolezza soltanto mediante interpretazione (Auslegung), che rende manifesto qualcosa che già si dà, che già è. Si distingue così una comprensione implicita e originaria, dell’utilizzabile, da
un’apprensione esplicita dell’ente, che è realizzata mediante un’interpretazione tematica. La comprensione
implicita è il Grund, elemento essenziale e costitutivo,
condizione di possibilità dell’interpretazione “quotidiana”, vale a dire di quella che trova corrispondenza nella
visione ambientale preveggente.
176
8
In cosa consiste l’interpretazione quotidiana? Essa va ulteriormente chiarita. Ha una struttura che si
articola, quale unità composta e complessa, in tre momenti: predisponibilità, previsione e precognizione.
PREDISPONIBILITÀ. Nel momento in cui si appropria della comprensione, arrivando così a renderla concreta, l’interpretazione realizza lo svelamento di quel
che è implicito e nascosto: “sotto la guida di una prospettiva che stabilisce la direzione in cui il compreso
dev’essere interpretato”1. La prospettiva è tutt’una col
punto di vista, che naturalmente può differenziarsi: da
essa si determina una direzione, che dà indicazioni precise in funzione di una specifica e particolare interpretazione tematica, che si rende necessaria. L’interpretazione, dunque, è predisposta, vale a dire programmata in precedenza, prima ancora di attuarsi effettivamente con particolari modalità.
PREVISIONE. L’interpretazione si fonda sempre su
qualcosa che assegna e circostanzia il predisponibile,
vale a dire una possibilità di interpretazione piuttosto
che un’altra, piuttosto che tutte le altre. Questo vuole
dire che è prevista la scelta, che è previa allo stesso
atto interpretativo.
PRECOGNIZIONE. Il compreso, in quanto predisposto e previsto, è infine elaborato in concetti. Qui Heidegger sostiene che l’Auslegung può far scaturire la
concettualità in due diversi modi: sia ricavandola dall’ente stesso che è oggetto di comprensione e di inter1
Ivi, p. 236.
177
pretazione, sia proponendo una concettualità elaborata
in concetti che in certo qual modo si contrappongono
all’ente stesso: l’ente insomma non trova mai perfetta
corrispondenza alla sua rappresentazione cognitiva, alla
sua Vorstellung. In ambedue i casi, però, l’Auslegung si
è già indirizzata per una determinata concettualità, la
precognizione appunto.
Concludendo questa delucidazione circa l’interpreaione quotidiana, Heidegger scrive che “l’interpretazione di qualcosa in quanto qualcosa è fondata essenzialmente nella predisponibilità, nella previsione e nella
precognizione. L’interpretazione non è mai l’apprendimento neutrale di qualcosa di dato”1.
Viene detto così che quando l’Auslegung arriva a
stabilire l’in quanto di un quid, che è l’oggetto dato ancora privo di determinazioni, di cui fa esperienza (l’in
quanto del banco, della finestra, della penna…), essa è
fondata e strutturata; essa è conformata. Nell’atto
dell’Auslegung, dunque, il Dasein non si presenta mai
come ente “privo di qualità”; nel caso dell’Auslegung
“quotidiana” non si dà nemmeno una conoscenza neutrale e/o oggettiva: insomma, l’interpretazione non comprende mai un oggetto neutro.
L’ente con cui si ha a che fare, il quid di cui si fa
esperienza, non è mai percepito come qualcosa di puramente dato e come qualcosa di semplicemente presente.
Si propone, in proposito, il caso dell’esegesi dei
testi. All’apparenza delle cose si è alla presenza di un
1
Ibidem
178
dato immediato da studiare e da valutare oggettivamente; sembra questa, a esempio, l’idea che hanno gli
storiografi. In realtà, precisa Heidegger, contro l’idea
“scientifica” dello storico e, più specificamente, dello
storico della filosofia, non è affatto vero che tale dato
venga accolto come puro, perché c’è da tenere in conto
che esso è sempre assunto e recepito da un Dasein, che
comprende e interpreta.
È da tenere ben presente proprio il fatto che
l’assunzione implica una modalità che è implicita in ogni
processo interpretativo, vale a dire la modalità di predisposizione, di previsione e di precognizione. Tale modalità è tutt’una con la struttura conoscitiva e di comprensione dell’Auslegung, che si propone il lavoro di esegesi; essa è già-da-sempre posta e pertanto entra in
attività per permettere l’atto stesso di Auslegung, che
altrimenti e con diverse modalità non sarebbe affatto
possibile.
9
Si è detto di predisposizione, di previsione e di
precognizione. Com’è da intendere il “pre”? qual è il suo
carattere? Heidegger si chiede se possa essere inteso
come un apriori formale, di tipo kantiano. In questo caso la funzione del “pre” sarebbe quella di una determinazione di modalità di ricezione dell’oggetto dato noumenico, per stabilire il quoad nos relativo alla res.
L’apriori formale rappresenterebbe la condizione
trascendentale, e pertanto indipendente da qualsiasi
esperienza concreta: prescinde da qualsiasi contenuto
179
di esperienza. Saremmo così alle prese con due strutture, che precedono qualsiasi atto di comprensione e di
interpretazione: sia il pre della comprensione, sia l’in
quanto dell’interpretazione.
Il pre e l’in quanto sono da porre in stretta relazione all’apertura del Dasein nel suo Da e al suo progetto rispetto al mondo, all’inessere del mondo. Si è visto
come apertura sia possibilità di significatività, vale a
dire il poter essere di un significato, proprio a motivo
della relazione che intercorre tra Dasein ed enti intramondani. L’ente intramondano viene così a trovarsi,
in quanto progettato nel mondo, in una totalità significativa, che è tutt’una con il prendersi cura.
Quando l’ente intramondano viene “portato a comprensione”, viene cioè scoperto a partire dall’essere del
Dasein, erroneamente sosteniamo che esso abbia senso.
Heidegger precisa che quel che è compreso, perché
colto nella visione ambientale preveggente, non è affatto il senso, ma piuttosto l’ente stesso.
Cos’è allora il senso e come si dà a noi? È qualcosa
che inerisce l’apertura di comprensibilità e di interpretabilità del mondo da parte del Dasein. Il senso è allora
tutt’uno con la comprensione e con l’interpretazione: è
una cosa sola con il poter essere dell’inessere, nella sua
relazione con gli enti; è tutt’uno con la struttura formale dell’Auslegung comprendente. Esso è il rispetto-ache, in base al quale qualcosa di cui facciamo esperienza diviene comprensibile e interpretabile in quanto
qualcosa.
180
Proprio perchè tale, il senso è quel che determina
sia il pre sia l’in quanto, quale struttura della predisposizione, previsione e precognizione. Conclude Heidegger: “il senso è un’esistenziale dell’Esserci e non una
proprietà che inerisce all’ente e che gli sta “dietro” o
che vaga in qualche “intermondo”. Solo l’Esserci “ha”
senso, e ciò perché l’apertura dell’essere-nel-mondo
non è “riempibile” che attraverso l’ente in essa scoperto”1.
Il senso non è un quid che appartenga all’ente, che
gli inerisca. Non è qualcosa che l’ente possiede, che
magari si trova dietro o dentro l’ente, in esso nascosto,
ed è pertanto da rendere manifesto attraverso una
ben determinata procedura, che sarebbe tutt’una con
l’atto di conoscenza e d’interpretazione. Se così fosse,
la comprensione e l’interpretazione verrebbero a coincidere con un specie di atto rivelativo e veritativo, che
arriverebbe a rendere manifesto quel che già da sempre è nella cosa, nell’essere stesso dell’ente provvisto
di senso.
Non è l’ente a possedere un proprio senso, ma è
piuttosto il Dasein che ha senso. Ma allora, e di conseguenza, il fatto che crediamo di aver scoperto un ente
che ha un suo senso sta a significare che è proprio il
Dasein che ha donato un senso a quel determinato ente.
Il senso che il Dasein possiede è inerente il suo stesso
essere-al-mondo, la sua apertura, che è vuota di qualsiasi contenuto, perché apriori formale, finché non siano fatte esperienze effettive di mondo, vale a dire non
1
Ivi, p. 238.
181
accadano comprensioni e interpretazioni di enti intramondani.
Se è vero che solo il Dasein è fornito di senso, di
conseguenza è esso stesso che dà senso; soltanto esso
è in grado di dare senso, possedendone in certo qual
modo l’esclusiva. Questo sta a significare che gli enti
intramondani non hanno senso alcuno, se non nella loro
relazione al Dasein, il datore di senso. È nella relazione,
dunque, che il Dasein informa di sé quel che è altro-dasé e mediante tale informazione comunica quel senso
che possiede, perché esso è tutt’uno con la sua struttura di esistenza.
10
Di conseguenza gli enti intramondani sarebbero
del tutto privi di senso e tali rimarrebbero se non ci
fosse un ente particolare che, nell’atto di comprensione
e d’interpretazione, non riuscisse a darglielo.
Cos’è che Heidegger intende dire qui e quali possono essere le conseguenze per il nostro discorso che
tende a marcare la specificità dell’ermeneutica heideggeriana e, nel far ciò, a mostrare la distanza che si delinea rispetto alla fenomenologia husserliana? Il senso
di cui si parla, sinonimo qui di significato, indica la finalità, la direzione e il valore, come anche, facendo riferimento al linguaggio, il voler dire.
Proviamo ad applicare quanto siamo andati dicendo
al libro, a un testo scritto; come si ricorderà Heidegger propone il caso dell’esegesi del testo. Il testo
scritto, in quanto oggetto di esperienza, è un ente in-
182
tramondano, come tanti altri; di esso, in quanto tale,
facciamo l’esperienza in una tipografia (luogo di nascita), così come in una libreria (luogo di acquisto) e infine
sulla nostra scrivania (luogo di lettura e di studio, vale
a dire di fruizione del bene acquisito).
Il lettore, che comprende e interpreta, ne fa esperienza, dandogli un senso, proprio mediante il suo
atto di comprensione. Egli dà senso a quel che di per sé
un senso proprio non avrebbe, dà parola a quel che ne è
privo. Eppure, almeno nel caso del libro, le cose non
stanno esattamente così. Il testo scritto, che dunque
ha come in quanto il da-leggere, è difatti un ente intramondano particolare: è il prodotto di una precedente comprensione e interpretazione, che solo successivamente si è reificata e oggettivata nel volume a stampa.
Pertanto si dovrà tenere in debito conto che il
Dasein/lettore nel donare senso al testo entra in rapporto non soltanto con l’ente intramondano, ma anche
con un altro se stesso (altro Dasein): meglio ancora,
entra in relazione con un’altra comprensione e apertura
all’inessere, che a sua volta, in altro tempo e in altro
luogo, ha donato senso.
Veniamo ora a considerare quello che può essere
considerato il “cuore” stesso dell’Analitica esistenziale,
per lo meno per quel che riguarda l’ermeneutica. In
quanto si muove necessariamente entro l’apertura del
ci dell’Esserci, ogni interpretazione è relativa all’essere-al-mondo nella sua totalità. Pertanto, “in ogni comprensione del mondo è con-compresa l’esistenza e vice-
183
versa”1: si tratta di una relazione biunivoca tra l’essere
che comprende e quel che viene compreso con interscambio e rispecchiamento. Inoltre “ogni interpretazione si muove nella struttura del “pre” che abbiamo
descritta. L’interpretazione, che è promotrice di nuova
comprensione, deve aver già compreso interpretando”2.
A questo punto Heidegger valuta attentamente
l’obiezione che potrebbe essere mossa a tale tipo di
ragionamento da parte della scienza e della logica. Il
procedimento dimostrativo non può che rifiutare quel
che si sta qui sostenendo, e cioè che quel che si arriva
a conoscere mediante l’intrepretazione è in certo qual
modo già compreso, prima ancora dell’atto di Auslegung. La scienza e la logica infatti non presuppongono
mai quel che si propongono di dimostrare. Heidegger
puntualizza: “se l’interpretazione deve sempre muoversi nel compreso e nutrirsi di esso, come potrà condurre
a risultati scientifici senza avvolgersi in un circolo,
tanto più che la comprensione presupposta è costituita
dalle convinzioni ordinarie degli uomini e del mondo in
cui vivono? Le regole più elementari della logica ci insegnano che il circolo è circolus vitiosus”3.
La scienza, vale a dire quel processo conoscitivo
che si autodefinisce “oggettivo”, crede che ci si muova
linearmente in un movimento progressivo che va dal
non-sapere al sapere, arrivando a conseguire nel momento finale della ricerca qualcosa che non sussisteva
1
2
3
Ivi, p. 239.
Ibidem
Ibidem
184
nel momento iniziale. Soltanto al termine si dà quel che
sin dall’inizio si cercava, ma non si possedeva. Le considerazioni di Heidegger circa la struttura esistenziale
del Dasein delineano un processo di conoscenza rappresentabile con un cerchio, piuttosto che con una linea.
Comprendere e interpretare implicano infatti un movimento che, una volta che sia pervenuto al termine, indica lo stesso stadio iniziale, insistendo su di esso: la fine contiene così il suo stesso principio, là dove si viene
a scoprire anche che il momento iniziale della ricerca
conteneva già in nuce il risultato finale.
Quel che è da riconoscere e da comprendere/interpretare è anticipato, previsto e preconosciuto,
in quanto presupposto necessario nel già conosciuto.
Quel che è nello stadio finale del processo di conoscenza è anticipato in quel che è dato nello stadio iniziale e primordiale.
Da tale constatazione e da tale differenza deriva
una specie di necessaria rimozione di qualsiasi interpretazione storiografica del processo conoscitivo,
scientifico-oggettivo, di tipo rigoroso. Questo perché
un sapere che si fondi sull’interpretazione storiografica, che accetti la comprensione e la conoscenza storico-dialettica, non può non arrivare a considerare quel
che accade come già presente in quel che è già accaduto. Come insegna Hegel, mediante l’esplicitazione del
processo dialettico dell’Aufhebung, ogni momento storico contiene il precedente e anticipa in nuce il successivo.
185
L’ideale di conoscenza proprio delle scienze rigorose sembra essere lo stesso anticipato dalla storiografia, che auspica che un giorno il circolo vizioso possa
essere evitato, per poter finalmente arrivare a produrre “una storiografia indipendente dall’autore, come si
presume lo sia la scienza della natura”1.
In questo consiste la cosiddetta neutralità e oggettività, con indipendenza da autore/soggetto e da
tentazioni psicologiche, della ricerca scientifica. Si
torni qui a considerare le critiche di Husserl a tutte le
filosofie, in nome di una filosofia intesa come scienza
rigorosa. Puntualizza, però, Heidegger in proposito: “se
si vede in questo circolo un circolo vizioso e se si mira a
evitarlo o semplicemente lo si “sente” come un’irrimediabile imperfezione, si fraintende la comprensione da
capo a fondo” e poco più avanti: “l’importante non sta
nell’uscir fuori del circolo, ma nello starvi dentro nella
maniera giusta. Il circolo della comprensione non è un
semplice cerchio, in cui si muova qualsiasi forma del conoscere, ma l’espressione della pre-struttura propria
dell’Esserci stesso”2.
Stare nel circolo “nella maniera giusta” sta a significare non lasciarsi imporre predisponibilità, previsione e precognizione dalle opinioni correnti e comuni in
modo acritico, ma far sì che il pre e l’in quanto arrivino
a evidenziarsi nell’atto esperienziale stesso, in relazione con le cose stesse. Conclude, perciò, Heidegger: “il
circolo del conoscere appartiene alla struttura del sen1
2
Ivi, p. 240.
Ibidem
186
so, che è un fenomeno radicato nela costituzione esistenziale dell’Esserci, nella comprensione interpretante. L’ente per cui, in quanto essere-nel-mondo, ne va
del suo essere stesso, ha una struttura circolare di carattere ontologico”1.
11
Leggiamo ora il paragrafo successivo.
In precedenza avevamo letto che “i due modi cooriginariamente costitutivi in cui l’Esserci ha da essere il
suo Ci sono la situazione emotiva e la comprensione.
Situazione emotiva e comprensione sono cooriginariamente determinate dal discorso”2. Prima di parlare del
discorso (die Rede) Heidegger, chiarito il carattere
ontologico del Dasein in quanto Befindlichkeit e Verstehen, nel § 33 tratta dell’asserzione (Aussage) o giudizio.
Aussage, da sagen aus, indica il “portar fuori (aus)
il dire (sagen) nel detto, in quel che effettivamente
viene detto. In continuità con quanto già affermato, si
tratta di esternare, di portar fuori il compreso, in vista della sua comunicazione, che si attua e si finalizza
nella relazione intersoggettiva del mit Sein. Leggiamo
così che “ogni interpretazione si fonda nella comprensione. Il senso è ciò che viene articolato nell’interpretazione e che già nella comprensione si delinea come
articolabile. Poiché l’asserzione (il “giudizio”) è fondata
nella comprensione e costituisce una forma derivata di
1
2
Ivi, p. 241
Ivi, p. 211.
187
perfezionamento dell’interpretazione, anch’essa “ha” un
senso”1.
Dopo aver ribadito la continuità tra comprensione-interpretazione-asserzione, Heidegger sottolinea
un’importante conseguenza. Si riscontra il senso nell’Aussage, nel fatto che essa dice il senso, proprio nel
determinarlo. Questo non sta però a significare che il
senso abbia una sua origine nell’Aussage, nell’atto del
dire e del giudicare, vale a dire nella tematizzazione ed
esternazione dell’atto di interpretazione, perché, lo si
è visto, esso è colto nella stessa visione ambientale
preveggente, che si era avuto modo di considerare come “comprendente e interpretante” allo stesso tempo.
In una sorta di precedenza di tipo ontologico,
piuttosto che temporale, il senso precede la sua stessa
determinazione in un giudizio detto. Cos’è allora il giudizio di asserzione (Aussage)? Più avanti Heidegger ce
ne offre una definizione: “l’asserzione è una manifestazione che determina e comunica”2, e cioè è la modalità espressiva dell’Auslegung che caratterizza, puntualizza e specifica il comprendere/interpretare, in vista
della sua comunicazione ad altri, per la sua condivisione
intersoggettiva nella messa in gioco “pubblica”.
A questo punto si indica il passaggio che avviene
dall’interpretazione ambientale preveggente, contenuta
nella stessa apertura al mondo dell’Esserci, all’asserzione. Si tratta del passaggio dall’in quanto ermeneutico-esistenziale, all’in quanto apofantico, proprio del
1
2
Ivi, p. 241.
Ivi, p. 245.
188
giudizio. Insomma, si consuma lo spostamento dalla
sfera dell’ontologico a quella dell’ontico.
Nel primo caso l’in quanto sta a indicare l’ente
come utilizzabile (mezzo per-): è il con-che dell’averea-che fare dell’inessere al mondo; nel secondo caso l’in
quanto sta a indicare l’ente che è oggetto dell’asserzione: è l’intorno-a-che proprio di un giudizio, che
sta a definire l’ente come presenza, contrapposta al
soggetto conoscente e oramai priva dell’originaria significatività. Avviene così una specie di livellamento
dell’in quanto originario, che si appiattisce nell’in quanto
della semplice presenza “oggettiva”: l’oggetto è Gegenstand rispetto a un soggetto, nell’Aussage.
La parola assertiva tradisce il senso originario
dell’ente intramondano, proponendosi quale detto e nascondendo il suo non detto, vale a dire il poter essere,
che il detto implicito, nelle sue scelte di potenzialità,
ha emarginato e messo da parte; tale detto è da intendere quale pensato, che trova esplicitazione nel da
pensare, ma che allo stesso tempo anche lo nasconde.
12
Concludiamo ora con la lettura del § 34: L’Esserci
e il discorso. Il linguaggio.
Troviamo scritto, ed è dunque ribadito, che l’asserzione è il modo proprio di determinazione dell’interpretazione, che tende a realizzarsi nell’espressione
della comunicazione. Questo processo ha il suo sbocco
nel dire (sagen) e nel parlare (sprechen). In certo qual
modo l’asserzione sta a rappresentare la parola inter-
189
na, ancora muta, mentre il dire dà voce a tale parola
all’esterno. Inoltre si potrebbe distinguere ulteriormente, manifestando l’asserzione sia viva voce, sia mediante altri segni comunicativi.
Scrive Heidegger che “il fondamento ontologicoesistenziale del linguaggio è il discorso. Nelle nostre
analisi della situazione emotiva, della comprensione,
dell’interpretazione e dell’asserzione abbiamo già ripetutamente fatto appello a questo fenomeno, ma esso è
sempre sfuggito in certo modo di soppiatto all’analisi
tematica.
Il discorso è esistenzialmente cooriginario alla situazione emotiva e alla comprensione”1.
Il discorso (die Rede) rappresenta la modalità at-
traverso cui si articola la comprensione del mondo, nella quale trova l’espressione ultima e rivelatrice il poter
essere della comprensione. Esso sta alla base sia dell’asserzione, sia dell’interpretazione. Nel discorso si
articola, infatti, senza alcun dubbio, la molteplicità dei
significati, che sono forniti di quel senso, che è in uno
con la comprensione, ma che non trova espressione se
non nelle asserzioni di un discorso, che lo strutturano
così mediante specifici significati.
Accade così che nel discorso la totalità dei significati accede alla parola. Sono proprio i significati,
precisa Heidegger, che trovano sbocco nelle parole e
non viceversa: le parole, intese come cose, di per sé sono prive di senso e arrivano a essere provviste di significati soltanto in un secondo tempo. È il significato, in1
Ivi, pp. 251-2.
190
somma, che anima la parola, la quale in un primo tempo
è pura e semplice emissione di voce (flatus vocis).
A questo punto viene offerta una precisazione
che caratterizza ancora meglio l’aspetto ontologicoesistenziale del discorso. Troviamo così scritto che “la
connessione che il discorso ha con la comprensione e la
comprensibilità, è chiarita da una possibilità esistenziale del discorso, il sentire. Non è a caso che, se non
abbiamo sentito “bene”, diciamo di non aver “capito”. Il
sentire è costitutivo del discorrere”1. Si stabilisce così
una corrispondenza. Come la comunicazione si fonda sul
discorso, così la percezione acustica si fonda sul sentire. Strettamente connesso al discorso e alla comunicazione, il sentire (udire e ascoltare, al tempo stesso)
rappresenta “l’apertura primaria e autentica dell’Esserci al suo poter essere più proprio, come ascolto della voce”2.
L’Esserci sente, perché comprende e comprende a
partire dal suo essere-al-mondo con altri (mit-Sein),
con cui comunica. Proprio sul fondamento del poter
sentire originario è possibile qualcosa come l’ascoltare.
Dinanzi al detto, al discorso di altri, non abbiamo mai
percezione acustica di semplici suoni allo stato “puro”.
Difatti noi non sentiamo affatto soltanto il suono delle
parole, neppure quando il detto viene espresso mediante un linguaggio del tutto comprensibile, perché confuso, oppure perché non abbiamo bene udito oppure perché espresso in una lingua a noi sconosciuta.
1
2
Ivi, p. 255.
Ibidem
191
Anche quando il discorso è incomprensibile a chi
lo ode, non si presenta mai quale serie di suoni, ma pur
sempre come parole incomprensibili. Quando si ascolta,
poi, un discorso su un determinato argomento possiamo
certo essere portati anche a fare attenzione alla dizione, e dunque al suono delle parole dette, ma questa è
davvero secondaria, perché viene senz’altro preceduto
da una “comprensione preliminare di ciò che il discorso
dice”1. Discorrere e sentire/ascoltare si fondono pertanto nella comprensione e “soltanto chi ha già compreso può ascoltare”2.
Per finire, il discorso è costitutivo, essendo in uno
con la comprensione del ci dell’Esserci. Difatti l’Esserci
è inessere che discorre, è inessere che proprio mediante discorso (ascolto, sentire, parlare, comunicare)
esprime al meglio se stesso.
“L’Esserci ha linguaggio”, si legge, e altrove, poi,
Heidegger afferma che l’uomo è nella lingua e, cioè,
parla di continuo. Non è pertanto a caso che i greci, la
cui esistenza quotidiana era caratterizzata dal dialogo,
avevano definito l’uomo come zoon logon echon, il vivente che parla.
1
2
Ivi, p. 257.
Ibidem
192