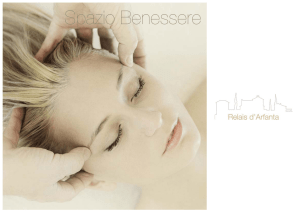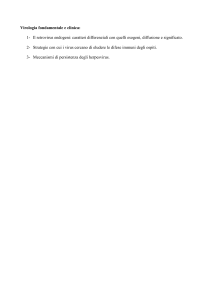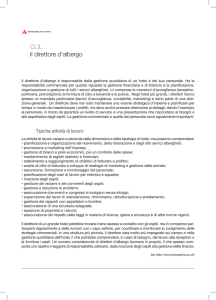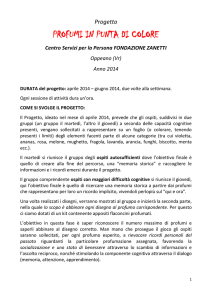www.lombardiasociale.it
“Finalmente a casa”. Considerazioni sull’umanizzazione dell’assistenza
di Marco Noli, Direttore della RSA “Don Cuni” di Magenta
L’articolo che segue propone una serie di riflessioni sul tema dell’umanizzazione dell’assistenza
nelle strutture residenziali, sul significato del “prendersi cura” quando non è più possibile curare per
guarire, e sull’accompagnamento e la condivisione che possono essere offerte alle famiglie degli
ospiti.
Sentirsi “a casa” in una RSA
“Finalmente a casa”: queste parole mi sono state dette da una figlia che ho incontrato nel mio
ufficio nella RSA “Don Cuni” di Magenta dopo un ricovero di suo padre in ospedale. L’anziano,
affetto da demenza severa e ospite della nostra struttura, aveva avuto uno scompenso cardiaco che
aveva richiesto un ricovero ospedaliero di una quindicina di giorni.
Non ho potuto fare a meno di notare che, mentre la figlia mi diceva quelle parole, i suoi occhi si
sono velati. La sua frase, riferita al rientro dell’anziano non al domicilio ma in RSA, mi ha ancora
più colpito perché pronunciata da una famiglia che aveva faticato molto ad accettare il ricovero del
congiunto nel nucleo demenze (il padre, che era un punto di riferimento in famiglia, in poco tempo
aveva perso il senno, assumendo comportamenti a volte anche violenti).
Nei giorni successivi queste parole mi sono tornate alla mente diverse volte: durante un audit sulla
qualità, durante una verifica dell’organismo di vigilanza ai sensi del DLgs 231/01, in una riunione
in ASL dove venivano illustrate le nuove regole socio sanitarie regionali e infine durante una
vigilanza dell’ASL per l’appropriatezza.
Mi sono chiesto perché mi tornassero alla mente, soprattutto in quei momenti, e ho pensato di
condividere le mie riflessioni con questo scritto.
La prima risposta che mi sono dato ė che in quelle occasioni avevo misurato la significativa
distanza tra ciò che vogliono i nostri ospiti e i loro familiari e le riflessioni che caratterizzano le
riunioni precedentemente citate
Sgombro subito il campo da possibili equivoci: è sacrosanto fare tutto ciò che può rendere migliori i
nostri servizi, ma forse qualche volta dimentichiamo di ascoltare quello che ci chiedono i nostri
ospiti e i loro familiari. Nella nostra azione di miglioramento dei servizi occorre tenere
presente le loro richieste e le loro aspettative, spesso implicite e poco inquadrabili in protocolli
predefiniti.
I nostri ospiti e le loro famiglie vogliono trovare nelle nostre strutture una “casa”.
Ma cos’è una “casa”, per tutti noi? Anzitutto è un luogo dove noi ci sentiamo accolti, per l’ appunto
“a casa”. Un luogo dove riconosciamo gli spazi, i mobili, i volti, i profumi, i rumori, i silenzi, i cibi.
Luoghi dove c’è la nostra storia. Luoghi dove incontriamo i nostri amici. Luoghi dove possiamo
“lasciarci andare”. Lasciarci andare nei gesti affettuosi, nell’espressione di ciò che sentiamo:
possiamo piangere, gioire, ridere perché nessuno ci giudica. Luoghi dove ci si scontra anche ma
dove ci si riconosce, dove si chiede scusa e ci si perdona. Luoghi in cui ci si può ascoltare: si
possono dire parole che tengono compagnia nella vita. Certo non tutte le case sono così ma questo
credo sia l’immaginario positivo quando si pensa alla parola “casa”. Non è forse per questo che
spesso, dopo un po’ che si è in giro, si vuole tornare a casa?
Le nostre strutture, quindi, secondo i nostri ospiti e i loro familiari debbono cercare di essere
case. Ė comprensibile: in ospedale solitamente ci si sta per pochi giorni, nelle RSA ci si sta spesso
anni e quindi diventano luoghi di vita, non esclusivamente di cura.
Le RSA possono essere come una casa, forse non come una famiglia vista la numerosità delle
persone, ma certamente come comunità di vita.
A questo punto mi sono sorte alcune domande. Come accogliamo i nostri ospiti? Penso alle
procedure di accoglienza, perfette, impeccabili sul piano dell’efficienza tecnica, indispensabili per
una vera presa in carico (ne siamo proprio sicuri?), ma se manca il sorriso accogliente, il volto
aperto, come può sentirsi a casa il nostro ospite? Come un familiare ci può affidare il suo
congiunto? E certamente il sorriso a cui mi riferisco non è quello di cortesia, spesso accennato e
subito percepito come finto, ma quello dell’empatia.
La camera condivisa è legata alla vita comunitaria, ma la personalizzazione del proprio piccolo
spazio fa “casa”. Certo, occorre provvedere alle norme antincendio, alla sicurezza, ai farmaci, ma
questo non basta. Volete fare felice un anziano? Lasciate che appenda le foto dei nipoti o dei figli o
conservi in camera qualche suo oggetto gonfio di ricordi. Spesso tutto questo vale molto di più di
qualche pastiglia. Qualche volta nell’entrare nelle camere dei nostri ospiti ci è venuto da bussare
alla porta? Non si può fare sempre, ma il bussare significa “riconosco che è il tuo spazio ed entro
chiedendo il permesso”. E quante volte, mentre si cambiano gli ospiti , ci si dimentica di accostare
la porta.
E ancora: l’abitudine di dare del tu agli ospiti. Può essere opportuno quando il rapporto si consolida
e diviene segno di confidenza, di riconoscimento, ma all’inizio può stonare. A tutte le persone che
incontriamo per la prima volta diamo del tu?
Il pranzo e la cena sono momenti in cui ci si trova insieme in famiglia, momenti ricchi di significato
nelle nostre case: come ritroviamo questi significati nelle nostre strutture? Certo ci sono gli insulti
della malattia, ma attraverso il modo in cui chiedo agli anziani ospiti cosa gradiscono, da come
verso il cibo e porgo il piatto, o invito a mangiare l’anziano recalcitrante, posso fare passare un
mondo di parole e di sentimenti.
La sveglia al mattino in famiglia suona per il pigro che vuole rigirasi nel letto, per quello che salta
subito dal letto e per quello che ha i suoi tempi. Nelle strutture cosa succede? Sveglia alle 7 (o forse
prima), giù dal letto partendo dall’inizio o dalla fine del corridoio e avanti così, quasi
meccanicamente come in una catena di montaggio. Certo ci sono le alzate complesse che richiedono
tempo, non si può indugiare, ma siamo sicuri che un pizzico di attenzione ai bisogni degli ospiti non
si possa avere?
Antropologia nella cura e antropologia della cura
La casa è il luogo in cui si può lasciarsi andare. Le famiglie dei nostri ospiti a volte hanno bisogno
di lasciarsi andare, di gridare il loro dolore contro il mondo e contro di noi, che siamo i più vicini in
quel momento, perché provate dall’esperienza dei loro cari che non riconoscono più. Possiamo
accogliere questo dolore che spesso si manifesta in lamentele, in recriminazioni e dare tempo di
elaborare il lutto di una realtà che è cambiata troppo in fretta e che è difficile da accettare. Figli che
sono chiamati a fare i genitori dei propri genitori: non è un’esperienza indolore e rapida, richiede
tempo, accompagnamento e comprensione. E se quest’accettazione non interviene noi siamo
chiamati ad accogliere anche questo stato di cose, pur con la fatica che richiede, soprattutto agli
operatori più vicini nell’assistenza. Spesso noi non ci pensiamo: ma cosa sappiamo noi delle storie
di vita di queste famiglie? Chi siamo noi per semplificare e forse giudicare?
Questa è antropologia nella cura, cioè tutte quelle forme che umanizzano la cura, ma ci è chiesto
di andare oltre e di approdare all’antropologia della cura, così come l’ ha definita Carlo Mario
Mozzanica[1].
L’antropologia della cura ė quella che ci dice che ognuno di noi è unico e irripetibile, e “affida la
cura agli orizzonti antropologici della persona, non in sostituzione o in alternativa agli orizzonti
tecnici della medicina, ma come spazio e orizzonte di senso, da offrire alle possibili alternative
dell’intervento”
L’antropologia della cura significa anzitutto l’ascolto di ogni individualità. Non avere già delle
risposte precostituite. La salute e la cura che ognuno di noi vuole per sè sono elementi da scoprire in
un dialogo continuo. L’elaborazione del proprio invecchiamento richiede un accompagnamento
attento, capace di comprendere le angosce e le attese di ogni persona. E’ il ben – essere
dell’anziano, cioè il suo bene non misurabile solo dai dati clinici ma dalla sua congruità
esistenziale.
La domanda di fondo non può che essere: quale vissuto della vecchiaia, e delle malattie che spesso
l’accompagnano, hanno i nostri ospiti e le loro famiglie? (E specularmente sorge un altro
interrogativo: come l’operatore pensa e vede la sua e l’altrui vecchiaia?)
Il “prendersi cura” differisce dal “curare” perché assume la consapevolezza dell’impossibilità
di guarire e allora sa attendere, sa assistere non intervenendo, sa graduare l’intervento
secondo il desiderio e non esclusivamente secondo il bisogno, spesso oggi interpretato più dal
familiare che non dall’anziano stesso. Prendersi cura è accompagnare e condividere, proprio
quando le tecniche mediche sono impotenti e quando la capacità terapeutica è consiste
semplicemente nell’esserci. Tutto questo potrebbe aprire molte riflessioni, già a partire dall’uso dei
farmaci spesso somministrati per ogni singolo sintomo, senza una visione d’insieme, provocando
inutili sprechi e effetti collaterali peggiori della cura.
La grande dimenticanza: l’avvicinarsi della morte.
Nelle RSA spesso si tratta di affrontare malattie e sofferenze improvvise che mettono a dura prova
l’identità delle persone e la capacità di accoglienza e sopportazione dei loro famigliari.
L’elaborazione di un peggioramento delle condizioni di vita richiede tempo sia da parte dell’ospite
sia da parte del familiare. Non dobbiamo dimenticare che anche all’operatore è richiesta questa
fatica. Infatti, nel paradigma delle scienze biomediche il peggioramento della condizioni di salute è
un fallimento e solo un orizzonte antropologico può aprire ad altri significati.
Come pure l’elaborazione di quella che oggi è la grande dimenticanza: l’avvicinarsi della morte.
L’elaborazione del compimento della vita oggi è spesso negata, nessuno sostiene né l’anziano né la
sua famiglia a questo evento che è parte della vita. Oggi più che mai, a fronte della gravità degli
ospiti presenti in struttura, si evidenzia questa necessità. E’ una riflessione con delle specificità
differenti dal fine vita in un Hospice. In RSA si tratta di elaborare la condizione di invecchiamento
che gradualmente riduce le proprie autonomie, mina il corpo e mina lo spirito (è nota la depressione
che colpisce la maggior parte degli anziani in RSA). Non solo, mette in crisi i familiari che debbono
elaborare il peggioramento delle condizioni di salute e l’avvicinarsi della perdita del proprio caro.
Solo un percorso antropologico sul senso della vecchiaia e della morte può mettere al riparo
dall’accanimento terapeutico, a volte perpetrato inconsciamente, più per accontentare il
dolore del familiare che le reali esigenze dell’anziano.
Curare, lo sanno molto bene i medici, a volte non è dare farmaci ma essere vicini al malato, ai
familiari e accogliere il loro dolore, certo salvaguardando sempre la dignità dell’anziano, che non
dev’essere esposto a inutili sofferenze. La medicina narrativa ci può aiutare in questo percorso: è un
approccio relazionale che arricchisce l’atto medico dei racconti degli ospiti e anche degli operatori,
che nel racconto stesso possono scoprire il senso esistenziale di quanto stanno vivendo e
riconoscersi. La letteratura non ci ha consegnato esempi di lettura della condizione della vecchiaia
della malattia, della demenza che illuminano il “percorso” e non solo il “decorso” della vita delle
persone. La vecchiaia non è forse caratterizzata proprio dall’integrazione, dalla riappacificazione
con la propria vita per conquistare la propria individualità e giungere al proprio compimento?
Compimento della vita, ribadisco, non fine della vita. Certo questa comprensione della vecchiaia
dovrebbe iniziare fuori dalle nostre strutture ed essere patrimonio dalla cultura collettiva. La
sociologa Céline Lafontaine[2] (2) ci dice, invece, che viviamo in una società post-mortale dove
all’imponente apparato biomedico è assegnato il diritto esclusivo di rispondere alle domande sulle
cose ultime, fondamentali per la vita e costitutive per la dignità di tutti. Non si muore più,
semplicemente, si muore “per qualcosa”. E come ci ricorda Norbert Elias : “Mai come oggi gli
uomini sono morti così silenziosamente e igienicamente e mai sono stai così soli”.
Noi possiamo provare ad iniziare questo percorso antropologico nella quotidianità delle nostre
strutture anche perché solo così riusciremo a prenderci cura dei nostri ospiti. Infatti, la medicina
contemporanea, lo sappiamo, spesso non guarisce ma, quando va bene, cronicizza il disturbo e ciò
richiede il prendersi cura. Il prendersi cura è una caratteristica dell’umano, come ci ricorda il mito
di Igino del III secolo A.C, che dice dell’uomo “finché esso vive lo possiede Cura””.
Ritorno alle riunioni che citavo all’inizio – durante le quali mi sono venute alla mente le parole di
quella figlia- per ribadire che quello che facciamo in materia di qualità, di appropriatezza, di
sicurezza ė sicuramente utile perché serve a dare dei servizi migliori, ma non dobbiamo mai
dimenticarci che i nostri ospiti e familiari vogliono una casa dove vivere la loro esistenza e
poter morire in serenità, “sazi dei loro giorni” .
[1] c.m. mozzanica, Servizi alla persona. Un’organizzazione (in) compiuta, Saronno, Monti 2000, 2^
[2] C. Lafontaine , Il sogno dell’eternità, San Giorgio a Cremano, Medusa 2009
14 maggio 2014