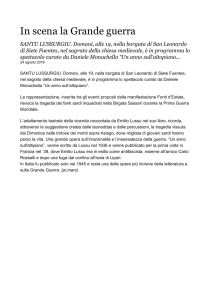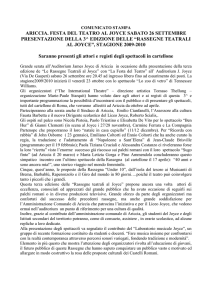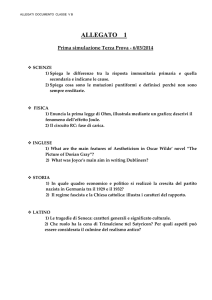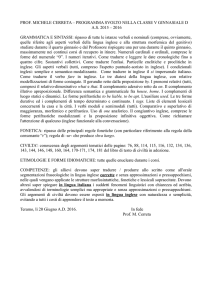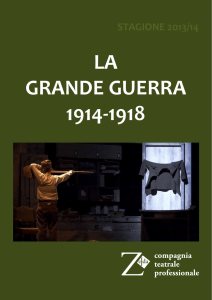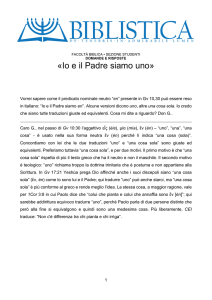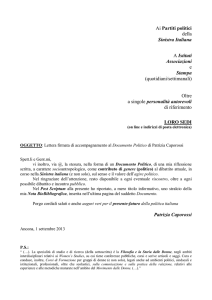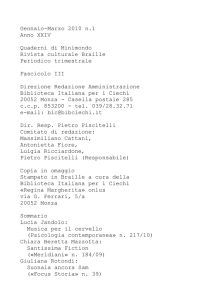(Patrizia Caporossi)
Joyce Lussu,
la traduzione d’amore di una sibilla del ‘900
C’è una poesia, scritta da questa eccezionale donna che è Joyce Lussu (1912-1998), intitolata
L’utopia, dove l’invenzione del possibile, all’interno della realtà quotidiana, diventa la vita stessa e
semina, con la passione irrinunciabile della convivialità, che si fa impegno, gesti e sguardi aperti
sul mondo. Su questo posizionamento si situa lo stare al mondo e si caratterizza quell’arte
peculiare di lasciare consapevolmente segno-di-sé sul crinale dell’orizzonte storico. E’ questo il
lascito più rilevante di Joyce Lussu, questa protagonista unica del Novecento, che esprime nel suo
vissuto tutta la trama di un’epoca, ricca e contraddittoria, nell’esserne partecipe e protagonista
attiva. Già col proprio nome Joyce Lussu raccoglie in sé la sfida identitaria di un’anima mai
scontata, continuamente aperta allo scenario della storia, mai sottrattasi alle sfide, anzi pronta a
esserne provocatoria presenza. In questo, è stata una sibilla in carne e ossa, come le sue amate e
studiate sibille marchigiane, la sua terra paterna, innestata con il ramo inglese della famiglia
Salvadori. “Innesto” è la parola-chiave di Joyce (all’anagrafe italiana burocraticamente Gioconda)
che trova, poi, nella Sardegna del grande Emilio Lussu, l’altra dimensione e, per sempre, in uno
spazio plurale continuamente aperto. Dal radicamento marchigiano, questa sibilla contemporanea
si è spalancata sul mondo con la forte semplicità di gesti su gesti e la significativa leggerezza di chi
si espone in modo diretto e vero e (la) fa (la) storia. Mai portarsi dietro più di quanto puoi tenere
con una mano, diceva sempre, perché cuore e testa possono bastare per essere e scoprire, strada
facendo, l’essenziale che si è, senza ingombri ma con la libertà di esserci nell’ascolto aperto al
suono del mondo. E non c’è luogo, non c’è parte che non soddisfi questo richiamo, di esserci in un
modo o nell’altro, ma sempre interamente. Di non delegare né rimandare perché conta superare le
frontiere e avere la cittadinanza del mondo, nel rispetto di sé e dell’alter. Si è così pronti ad
assumersi la responsabilità della vita, a cui si è chiamati, perché è così che si abita la propria
coscienza. Joyce Lussu non è solo stata una donna impegnata nella polis, col tardivo
riconoscimento della medaglia d’argento al valor militare al grado di capitano, ma anche una
filosofa profonda, formatasi ad Heidelberg con Martin Heidegger, Karl Jaspers, Hannah Arendt e
tanti altri, poi una storica protagonista e una particolarissima poetessa che, rompendo la
grammatica accademica, regala oggi un’eredità culturale incredibilmente parlante di sé e del senso
delle parole, in un’epoca, la nostra, così carica di orpelli linguistici di vacua sostanza. Essere corpo
nella storia significa scrivere e tradurre, dando voce alla distanza e al silenzio: così è stato per lei e
infiniti, ancora non del tutto esplorati, sono gli esiti della sua produzione. Intanto, un lascito
(Patrizia Caporossi)
indiscutibile sono le travolgenti poesie in italiano del turco Nazim Hikmet, che incontra, a
Stoccolma, al Congresso internazionale per la pace. Quando le viene presentato, nella pronuncia
turca europeizzata in Naasm Hhikhmet con un “a” lunghissima e molte aspirazioni, così racconta in
Tradurre poesia (ed. Robin, 1998), ne è affascinata e assume su di sé tutte le stimolazioni possibili
fino a voler tentare di tradurlo senza conoscere di fatto il turco. E’ Nazim stesso che la sostiene
nell’impresa e le racconta della possibilità di poter sempre tradurre, se si apprende, soprattutto, la
lezione della terra, del suo sapore e, nutrendosi così del loro stesso incontro, dell’impegno per la
pace e la libertà che li segna e li contraddistingue, il progetto diventa un’utopia reale. Nasce tra
loro una mitica amicizia che permetterà la conoscenza del turco in Italia, tramite, in particolare,
bellissimi, ormai famosissimi, versi d’amore come quelli de Il più bello dei mari (Il più bello dei mari/
è quello che non navigammo./ Il più bello dei nostri figli/ non è ancora cresciuto./ I più belli dei
nostri giorni/ non li abbiamo ancora vissuti./ E quello/ che vorrei dirti di più bello/ non te l’ho ancora
detto). Joyce Lussu tradurrà oltre 7000 versi di questo poeta turco, perseguitato dal governo
filohitleriano che starà ben 12 anni in carcere e si deve a lei l’unica raccolta italiana, Paesaggi
umani. Ma, se il mondo è stata la sua patria e, ovunque ci sia stato bisogno di impegno e lotta per
la libertà, semplicemente andava, Joyce Lussu ha conosciuto e tradotto opere di tanti e tra i più
grandi intellettuali del Novecento mondiale, come Ho Chi Minh e Agostinho Neto, che conosce,
con Emilio Lussu, nel 1941, a Lisbona e che diventerà per lei una lezione vivente perché riflette,
amareggiata, sul fatto che la sua prima conoscenza dell’Africa avviene fuori dall’Africa, perché a
Lisbona l’angolano Agostinho era incarcerato semplicemente per la sua negritudine. Conosce
dell’Africa la nostalgia di Neto per poi, però, andare a comprendere ed essere realmente tra gli
africani. Il suo tradurre è così sempre un farsi corpo tra i corpi con l’anima intera e, allora, la lingua
sorgiva, che è sempre quella materna, può parlare e comunicare il senso delle cose. Certo
l’esperienza linguistica, che sottolineo personalmente (cfr. Il corpo di Diotima. La passione
filosofica e la libertà femminile, Ed. Quodlibet 2009), essere, in primis, appunto quella sorgiva, va
praticata direttamente, partendo dallo scavo della propria lingua che, in quanto materna, è
portatrice del senso concreto della vita: vita che le donne tesorizzano in sé, iscritta com’è nel loro
corpo, nonostante le esclusioni e le invisibilità storiche. Dirà: ho cominciato a tradurre poesie per
caso. Il caso (mai a sé) dell’incontro, che, in quanto tale, improvvisamente le svela che tradurre
non è un arido esercizio accademico e filologico sulle complicanze grammaticali e sintattiche di
una lingua, ma è sforzo per comprenderla: è quasi riviverla. E, soprattutto, questo vale per la
poesia, come sarà per le sue (cfr. Inventario delle cose certe, AndreaLivieditore, 1998), che non
può essere il luogo della schiavitù delle parole, ma, all’opposto, della libertà del sentire e del
capire. Questa peculiarità poetica è subito colta, per esempio, da Benedetto Croce, quando
conosce Joyce Lussu e ne apprezza (non solo) lo stile. Ecco, allora: che il tradurre non declini nel
rischio del tradire, dato che è sempre un tradere, un passaggio, ma sia la capacità cogliere e di
mettere al mondo la vita, unico denominatore comune tra chi traduce e chi legge: matrice
dell’appartenenza all’umana-unità. Inevitabilmente e necessariamente.
Patrizia Caporossi
docente di Storia e Filosofia
Ancona
Ancona, 2 giugno 2009