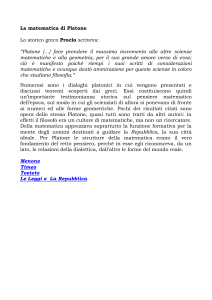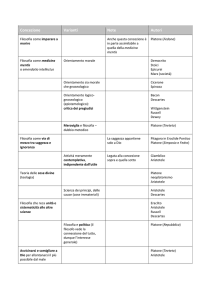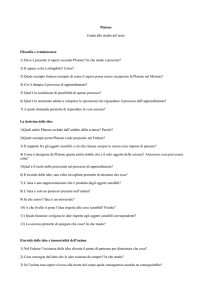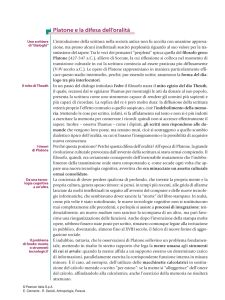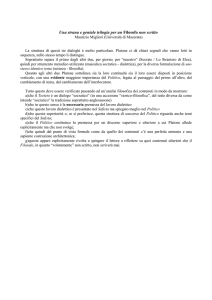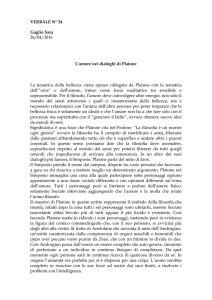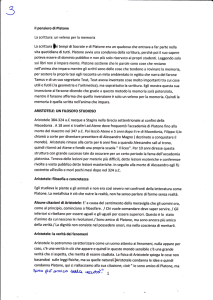Marcello Zanatta
IL PLATONE DI J.N. FINDLAY
E ARISTOTELE
Il testo è pubblicato da www.filosofia.it, rivista on-line registrata;
codice internazionale issn 1722-9782. Il © copyright degli articoli è
libero. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto
è tratto da www.filosofia.it. Condizioni per riprodurre i materiali:
Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all’interno di
questo sito web sono no copyright, nel senso che possono essere
riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro
modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di
Filosofia.it, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità
di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che
sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri
ben visibili: www.filosofia.it. Ove i materiali, dati o informazioni
siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere
effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale alla
homepage www.filosofia.it o alla pagina dalla quale i materiali, dati
o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell’avvenuta riproduzione,
in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.filosofia.it
dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo
[email protected], allegando, laddove possibile, copia elettronica
dell’articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.
www.filosofia.it
issn 1722-9782
1. È Findlay stesso a tracciare le linee maestre della sua
esegesi del pensiero platonico e a indicarne i capisaldi nella
«Prefazione dell’autore» all’edizione italiana del suo Platone.
Le dottrine scritte e non scritte 1, curata da Giovanni Reale (†),
che ha altresì presentato criticamente l’opera in una utile
«Introduzione» e ha aggiunto in appendice le testimonianze
antiche sulle dottrine non scritte 2.
Le indicazioni che Findlay dà circa le pietre miliari della
sua esegesi platonica e i relativi capisaldi teorici sono precise
e puntuali. Ed effettivamente la lettura dello scritto permette di constatare con assoluta nitidezza che il percorso
si sviluppa lungo una via maestra segnata di esse. Cosicché
è opportuno servirsene da guida nell’analisi dell’interpretazione dell’autore.
Occorre tuttavia precisare, in via preliminare, l’ambito
entro il quale questa complessivamente si muove. Si tratta
dello spazio aperto dal cosiddetto «nuovo paradigma» proCfr. J.N. Findlay, Platone. Le dottrine scritte e non scritte. Con una raccolta
delle testimonianze antiche sulle dottrine non scritte, trad. it. di R. Davies, a
cura di G. Reale, Milano 1994, pp. lvi-lviii.
2 Cfr. ibid., pp. vii-xl. L’importanza di questa «Introduzione» non
dev’essere sfuggita allo stesso Reale, che l’ha fatta stampare in un corpo
maggiore rispetto a tutte le altre parti del volume, compreso il testo stesso
di Findlay. A corredo del volume l’elenco completo degli scritti di Findlay
redatto da Michele Marchetto (pp. xli-lii), che di alcuni – i più recenti –
offre pure una presentazione ragionata.
1 posto dagli studiosi della scuola di Tubinga e Milano. Findlay stesso non manca di dichiarare che fu la pubblicazione
«delle opere di Krämer, di Gaiser e di altri» a convincerlo
a esporre quelle convinzioni sulla filosofia di Platone che
aveva maturato subito dopo la laurea a Oxford in litterae
humaniores nel 1926, ma non aveva mai ritenuto di presentare. I fautori del «nuovo paradigma» gli hanno, dunque,
offerto la prospettiva idonea a farlo. In effetti, da costoro egli
deriva l’impostazione esegetica di fondo, costituita dall’idea
che Platone non sia comprensibile sul piano filosofico se
non entro un quadro teorico unitario che abbraccia tutte le
sue espressioni e vi dà significato. Esse sono rappresentate
dai Dialoghi, dalle Lettere (soprattutto la settima) e dalle
testimonianze della tradizione orale.
Subito si indicheranno le differenze strutturali sussistenti
a questo proposito tra l’esegesi dei fautori del «nuovo paradigma» e l’esegesi di Findlay, ma ciò che in questo momento
preme mettere in chiaro è la comune impostazione di fondo: il pensiero di Platone non soltanto si sviluppa secondo
una linea unitaria e continua, ma è retto da un’unica concezione di base e manifesta dall’inizio alla fine, ossia dalle
sue espressioni cronologicamente primarie alle ultime, la
medesima dottrina.
1.1 Qui entra in causa l’idea di «sistema». Non vi è dubbio
che i fautori del «nuovo paradigma» presentino la filosofia
di Platone come un sistema compatto. Di «sistema» si deve
parlare anche a proposito del Platone di Findlay, ove per «sistema» s’intende una composizione univoca e unitaria delle
parti, e tale che in essa l’idea che si trova alla fine si trova
identicamente anche all’inizio. E poco importano, a questo
livello, le differenze di struttura tra il sistema tubinghese e
il sistema findlayano, che peraltro sono rilevanti e saranno
subito messe in chiaro, giacché entro un inquadramento
complessivo e in linea generale è interessante rilevare l’identità d’impianto che fatalmente sono destinati ad avere
quei modi d’accostarsi a un pensatore che nella sua produzione si sforzano di rintracciare nessi di continuità legati
allo sviluppo di una medesima idea di fondo. Più o meno
aperto (o chiuso) che sia il sistema delineato, esso rivela in
ogni caso, essenzialmente, l’impiego di un medesimo cliché
nell’indagine storiografica, e il carattere della maggiore
o minore apertura (o chiusura) rappresenta soltanto una
variazione lungo il medesimo motivo.
Le differenze tra i due modi di rappresentare il «sistema»
della filosofia di Platone chiamano direttamente in causa
alcuni di quei capisaldi dell’esegesi findlayana, richiamati
dallo stesso studioso, che, come si diceva in apertura, è utile
e importante utilizzare come filo conduttore per comprendere criticamente la sua opera.
Va innanzitutto messo in chiaro che, mentre per i fautori
del «nuovo paradigma» ciò che rende la filosofia di Platone
un sistema, e un sistema compatto e per così dire monolitico, è costituito dalla metafisica delle dottrine non scritte,
la cui presenza allusiva essi pretendono di rintracciare fin
dai primi Dialoghi, per Findlay il carattere sistematico della
filosofia di Platone è espresso dall’unità non di una dottrina,
ossia di «un disegno conclusivamente elaborato», bensì di
un «progetto» dottrinale.
1.2 Un progetto che – ecco una seconda basilare differenza – il filosofo né tradusse mai in uno scritto né espresse
mai in una formulazione compiuta e organica perché si
trattava di un «programma profondo e costante», ma «poco
chiaro per quanto riguarda il suo scopo e il suo metodo» 3,
insomma «una visione incipiente […] che», in quanto tale,
3 J.N. Findlay, Platone, p. lv.
«non poteva mai ricevere una chiara espressione scritta» 4,
stante che Platone «non poteva comunicare ad altri le cose
che non sapeva dire chiaramente a se stesso» 5. Essa è sì
«interamente intelligibile» 6, ma come visione d’insieme,
giacché per ciò che riguarda il dettagliato e preciso comporsi
degli elementi mancano i termini stessi su cui giudicare.
Il carattere orale della dottrina costituente il nucleo del
pensiero platonico è dunque dovuto al suo essere soltanto
un progetto, una delineazione di massima che non ricevette
mai una formulazione dettagliata, e non già – come ritengono i fautori del «nuovo paradigma» – perché essa toccava
livelli di profondità tali da non poter essere compresa di
chiunque, come invece accade a uno scritto, ma da essere
presentata unicamente ad adepti. Nella linea esegetica del
«nuovo paradigma» la comunicazione orale del pensiero
filosofico è, insomma, una scelta dettata dalla profondità
dello stesso e dalla sconvenienza di offrirlo anche a chi non
si sia adeguatamente coltivato nella filosofia. Per Findlay,
invece, è la conseguenza della consapevolezza di Platone
della incompiutezza del suo disegno filosofico.
1.3 Ma anche per ciò che attiene al contenuto della dottrina lo iato tra le due esegesi è notevole. Tanto più notevole
quanto più si colgono le prospettive nelle quali vengono
proposte e le si commisuri a esse. Si tratta di sfondi teorici
di valore ultimativo, che segnano il senso profondo delle
due esegesi medesime. Per i fautori del «nuovo paradigma» il nucleo del pensiero di Platone, quel nucleo che si
ritroverebbe in tutte le sue espressioni, a partire dai primi
Dialoghi, è la metafisica del princìpi, dell’Uno e della Diade
4 5 6 J.N. Findlay, Platone, p. 319.
Ibid., p. lvi.
Ibid.
indefinita di Grande e Piccolo, che costituiscono il portato
della tradizione indiretta. Dottrina «metafisica», si è detto,
perché tale è il significato di fondo che gli studiosi di questa
linea esegetica – Reale in testa – conferiscono alla filosofia di
Platone e in esso individuano il suo spessore teoretico. Detta
filosofia è essenzialmente una metafisica. Certo, anche l’aspetto matematico entra necessariamente in causa, giacché
intorno a esso si sviluppano le testimonianze della tradizione
indiretta e a esso s’improntano i Dialoghi come il Filebo con
la teoria del limite e dell’illimitato. Ma si tratta di un aspetto
che si risolve in una visione metafisica: la dimensione matematica è rilevante in quanto chiama in gioco i «princìpi»
dell’Uno, per l’appunto, e della Diade indefinita , i quali,
essendo princìpi dei numeri, cui si riconducono le Idee,
sono in ultima istanza i princìpi della totalità dell’esistente.
Dunque, una valenza metafisica, nella quale si risolve la valenza matematica. Ovvero – altrimenti detto – la struttura
matematizzante è in essenza l’espressione dottrinalmente
concreta in cui prende forma una grandiosa concezione
metafisica della realtà. Non così, invece, per Findlay, che
sfuma sulle implicanze metafisiche del progetto di matematizzazione, fissando per contro l’attenzione teorica proprio
sul carattere matematico del progetto medesimo. Ciò che, a
suo avviso, in ultima analisi interessa a Platone è delineare
una prospettiva di massima nella quale i significati ideali
siano raccolti e delineati nei loro rapporti quantitativi. Ai
fautori del «nuovo paradigma» preme prospettare, invece, il
pensiero di Platone nei termini di un sistema compatto nel
quale si scandisce un preciso disegno della totalità dell’esistente a partire da due princìpi. La metafisica, insomma,
da un lato, la matematizzazione, dall’altro.
In questo Findlay mostra la propria formazione analitica,
giacché è ben vero che è studioso anche di Hegel, da cui
ha derivato – con ogni probabilità – l’idea di sistema come
progetto in sviluppo (anche se, a ben vedere, da Hegel egli si
stacca nel ritenere che il progetto, almeno in Platone, non è
mai concluso, non giunge cioè alla piena realizzazione così
da configurare l’assoluto in sé e per sé), ma per ampia parte
le sue radici culturali affondano nella fenomenologia e la sua
educazione filosofica si svolge in ambiente anglosassone.
1.4 Altro aspetto basilare che divide l’esegesi di Findlay
da quella dei fautori del «nuovo paradigma» è il differente
peso dato ai sistemi neoplatonici di Ammonio Sacca e di
Plotino o, almeno, a una parte di essi, quella cioè che concerne la dottrina delle tre ipostasi. Nel senso che per Findlay
il Neoplatonismo dà la cifra del pensiero di Platone e funge
pertanto da criterio in base a cui coglierne il significato. In
effetti, esso, «con poche eccezioni, è completamente fedele
al suo modello ed esprime semplicemente ciò cui si perviene,
se si medita sui passaggi maggiormente speculativi delle
opere scritte di Platone» 7. Per cui «è solo alla luce di un’interpretazione plotiniana che Platone assume la sua piena
statura» 8. I fautori del «nuovo paradigma» non mancano
certo di misconoscere l’importanza del Neoplatonismo per
la comprensione di Platone, ma non ne fanno davvero il criterio per accedere alla peculiarità della dimensione storica
del suo pensiero. Si tratta invece di uno sviluppo e pertanto
va letto come prospettiva, non come cifra documentale.
È comunque interessante mettere in rapporto quest’avvaloramento del Neoplatonismo quale criterio ermeneutico
di Platone e il carattere soltanto progettuale del suo disegno
matematizzante. Tale rapporto, infatti, contribuisce non
poco a far intendere l’esegesi posta in atto da Findlay. Così,
se si considera la dimensione afatica che in Plotino la spe7 8 J.N. Findlay, Platone, p. 343.
Ibid.
culazione raggiunge al suo culmine, quando cioè perviene
all’Uno, e che il carattere di strutturale incompiutezza e
di mera progettualità dell’impianto matematizzante del
pensiero platonico è dovuto, ad avviso di Findlay, all’impossibilità, riconosciuta da Platone stesso, di un linguaggio e di
un impianto concettuale in grado di esprimerlo adeguatamente 9, si trova una singolare e significativa convergenza.
All’idea che i princìpi ultimi sono attingibili, per Platone,
soltanto a livello di pura progettualità e mai di dettagliata
definizione e di piena ed esaustiva esibizione della loro
interna dinamica per l’insufficienza di ogni possibile linguaggio e i limiti della conoscenza ha contribuito non poco
la scelta esegetica di fare del Neoplatonismo e in particolare
di Plotino, con la teoria delle tre ipostasi, la chiave di lettura
del pensiero di Platone. In questa chiave, infatti, l’Uno plotiniano con la sua ineffabilità funge inevitabilmente da lente
d’ingrandimento per scrutare la natura dell’Uno platonico
entro il progetto di globale matematizzazione.
2. È probabile che questa singolare e – francamente – discutibile scelta esegetica sia alla radice di certi giudizi che
Findlay ha pronunziato circa l’interpretazione aristotelica
del pensiero di Platone e, specificamente, la fonte aristotelica
delle dottrine non scritte. Una fonte alla quale Findlay, in
linea in questo con i fautori del «nuovo paradigma», riconosce piena attendibilità, impegnandosi anche a confutare,
e in modo assai convincente, l’interpretazione di Cherniss,
detrattore, notoriamente, di qualsivoglia valore storico alla
testimonianza dello Stagirita 10. Anche Findlay, infatti, al
Cfr. J.N. Findlay, Platone, p. 319: «Platone con il suo profondo senso
critico della inadeguatezza di ogni espediente linguistico e concettuale…».
10 Ibid., pp. 375-398.
9 pari dei fautori del «nuovo paradigma», è convinto che il
pensiero di Platone appare nella sua giusta luce, ossia in una
prospettiva storiografica che possa vantare di esprimere
«ciò che egli ha autenticamente e veramente detto», solo
integrando i Dialoghi, le Lettere e la tradizione indiretta.
I Dialoghi – egli puntualizza, polemizzando con l’esegesi
«classica» di Platone, sviluppatasi a partire da Schleiermacher – «presi per se stessi non consentono a nessuno di
esprimere il proprio parere su nessuno degli argomenti in
essi discussi: rimandano al di là di se stessi […]. Certamente
contengono le intuizioni platoniche più profonde» 11, e tali
sono quelle che richiamano le istanze di quel progetto di matematizzazione che costituisce l’asse portante della filosofia
platonica, ma per coglierle nel loro valore speculativo, ossia
nella loro profondità, occorre non isolarle, ma comporle
con le dottrine non scritte. Così, «un’analisi di Platone […]
che si limiti alla lettura dei dialoghi 12 finirebbe per spogliare
Platone della sua dignità filosofica e del suo interesse» 13.
Per altro verso, se ogni espressione del pensiero di Platone, e in particolare i Dialoghi, si comprende soltanto all’interno del progetto di matematizzazione e del suo riferirsi «in
modo palese a uno o due princìpi fondamentali», nei quali
risiede «l’essenza chiarificatrice del tutto» 14, è evidente che
Findlay non può ammettere un progresso nello sviluppo
della filosofia platonica. Certo, egli riconosce che l’elaborazione di tale «grandioso progetto» attraversa «molte tappe
successive» 15, ha cioè uno «svolgimento»; ma si tratta di
uno svolgimento che non comporta alcun autentico proJ.N. Findlay, Platone, p. lv.
Findlay usa «dialoghi», con l’iniziale minuscola, a proposito degli
scritti di Platone, e così ho lasciato nelle citazioni.
13 Ibid., p. lvi.
14 Ibid.
15 Ibid., p. 17.
11 12 gresso nel passaggio da una «fase» all’altra, bensì soltanto
differenti modi di attestarsi del progetto in rapporto a differenti ambiti problematici. E che questo «sviluppo» non
rappresenti affatto per Findlay un «progresso», si ricava
agevolmente dalla sua stessa valutazione della successione
delle fasi: «nessuna» di esse egli ritiene infatti che sia stata
«conclusiva», e «alla fine <il progetto stesso fu> assegnato
alla classe dell’inaccessibile piuttosto che a quella del perfettamente realizzabile» 16. Cosicché, anche ammettendo
che in tale progetto e nei princìpi dell’Uno e della Diade in
cui si compendia si debba riscontrare la cifra, per Platone,
della spiegazione ultima del reale, questa cifra non sarebbe il risultato «ultimo» di una riflessione che vi perviene
solo nella fase finale del suo svolgimento. Giacché anche i
primi Dialoghi – come abbiamo visto – testimonierebbero,
ad avviso di Findlay, con le loro «intuizioni più profonde»
l’esistenza di quel progetto, che perciò deve pensarsi essere
stato nella mente di Platone fin dal primo momento del suo
affacciarsi alla filosofia 17.
Peraltro, «neppure la successione storica dei dialoghi
[…] riesce a dare un quadro chiaro dello sviluppo del pensiero di Platone» 18. Chi ha pensato a uno sviluppo storico
della filosofia platonica secondo una linea di successivi
approfondimenti e tale che lungo di essa le dottrine non
scritte, accertate nella loro effettiva autenticità platonica,
corrispondono alla fase finale, si è ingannato ed è caduto
in un grossolano abbaglio esegetico.
J.N. Findlay, Platone, p. 17.
Significativa a questo proposito la seguente affermazione di Findlay:
«Platone anche in questo periodo iniziale capì che solo nel senso di una
globale struttura matematizzata, oppure aritmetizzata, il regno intero dei
significati ideali poteva svilupparsi dall’Uno, che era alla base sia dei significati numerici, sia delle virtù socratiche» (ibid.).
18 Ibid., p. lv.
16 17 E allora si delinea una situazione, per la verità non poco
paradossale e inverosimile, secondo cui Platone fin dal primo momento del suo filosofare avrebbe avuto in mente una
concezione complessiva della realtà alla luce della quale si
esplicherebbe il significato profondo di tutte le sue meditazioni, anche di quelle prime, ma che al contempo egli stesso
non poté mai formulare compiutamente perché conscio
dell’impossibilità di definirla in dettaglio. I Dialoghi, in
particolare, sarebbero comprensibili soltanto alla luce di
un progetto che è sì intelligibile, ma soltanto limitatamente,
stante che lo è solamente per linee generali e nel suo insieme.
Dunque, in modo approssimativo.
2.1 La prima domanda che verrebbe da porre è perché
mai Platone avrebbe riposto il senso ultimo del tutto, e sin
dall’inizio della sua speculazione, in un progetto che non
è definibile se non a grandi linee. È verosimile supporre
che per lui la conoscenza di ciò che è il fondamento di ogni
cosa e che in quanto tale ne racchiude la verità profonda ed
essenziale sia una conoscenza che non si raggiunge in modo
determinato? E inoltre: è plausibile che Dialoghi come l’Apologia di Socrate e l’Eutifrone – per citare i casi più eclatanti
–, dove la riflessine verte sul processo intentato al Maestro
ateniese e sul santo, s’inquadrino in una concezione della
totalità dell’esistente e non siano comprensibili se non in
essa? Che cosa ha a che fare la dimensione dell’intero con la
rammemorazione della difesa di Socrate e con la ricerca di
che cos’è la santità? E infine: come può essere «pienamente
intelligibile» (sic!) un disegno in cui non è né definito né
definibile il nesso tra le parti?
3. Poiché dunque il progetto globale entro cui va inquadrata
la filosofia di Platone è quel progetto di matematizzazione
confluente nella dottrina dei princìpi attestata dalla tradizione indiretta e, soprattutto, dalla testimonianza di Aristotele,
occorre vedere in dettaglio come Findlay si rapporta a questa
testimonianza e, in generale, come legge l’interpretazione
aristotelica di Platone.
3.1 Per un verso, com’è ovvio, la sua valutazione di essa
è altamente positiva. Essa è la fonte primaria da cui si trae
informazione delle dottrine non scritte, e poiché queste a suo
avviso sono certamente ascrivibili a Platone e costituiscono il
fondamento del suo pensiero, è ovvio e imprescindibile che
consideri la notizia aristotelica in proposito degna di molto
valore. «Dobbiamo […] essere profondamente grati ai resoconti aristotelici – scrive Findlay 19, che sono saldi e coerenti
nelle loro linee principali […] e che inoltre sono degni di fede
per il fatto che ciò che essi riferiscono non poteva essere il
prodotto della capacità di fraintendimento di Aristotele». Si
tratta, com’è noto, dei «resoconti» costituiti da Met., Α [I] 6;
9; 13; 14, nonché dai frammenti Sul bene, quel «resoconto»
della lezione (o del corso di lezioni) di Platone sul bene i cui
contenuti sono altresì riproposti nella Metafisica.
Ma per altro verso Findlay imputa ad Aristotele – come
già appare nel giudizio sopra riportato e poi a più riprese
viene ribadito 20 – un vero e proprio «fraintendimento» del
pensiero di Platone, praticato nel presentare non soltanto la
teoria delle Idee, ma altresì quella delle dottrine non scritte.
Gli stessi resoconti di queste, se sono globalmente degni di
fede, sono però, a suo vedere, «oscuramente contraddittori
nei loro particolari» 21.
J.N. Findlay, Platone, p. 319.
Cfr., ad esempio, ibid., p. lvi: «Aristotele non capì mai il programma
platonico».
21 Ibid.
19 20 Si tratta pertanto di vedere in modo analitico in che cosa
consiste un tale fraintendimento, di valutare in quale ottica Findlay lo giudica tale e, in ultima analisi, se si tratta
davvero di un fraintendimento del pensiero di Platone. Va
in ogni caso fatto presente che nel formulare un siffatto
duplice giudizio su Aristotele: di attendibilità, quanto alla
credibilità e al valore storico delle notizie fornite intorno
alle dottrine non scritte, ma al contempo di fraintendimento
sia di queste stesse che della dottrina delle Idee, Findlay si
allinea in tutto ai fautori del «nuovo paradigma», anche
questo annoverandosi tra i motivi di solidarietà delle due
esegesi, per cui la valutazione che a questo riguardo si trarrà
circa il giudizio di Findlay potrà considerarsi estendibile
anche ai fautori del «nuovo paradigma».
3.2 Ora, l’aspetto forse più vistoso del «fraintendimento»
aristotelico, quel fraintendimento che a partire da Aristotele
si è perpetrato per secoli e secoli nell’esegesi di Platone e
che sta alla base dell’incomprensione della genuina valenza
del progetto platonico, consiste nell’aver egli concepito le
Idee in modo dualistico rispetto agli enti empirici, «come
se si trattasse di un secondo mondo di significati separati,
in contrasto con il mondo solido delle cose particolari» 22.
A partire da questo fraintendimento il progetto stesso di
matematizzazione e, di conseguenza, la natura dei princìpi
(l’Uno e la Diade indefinita) che ne stanno alla base risultano falsificati. La falsificazione, derivante per l’appunto
dall’incomprensione da parte dello Stagirita del progetto
platonico e del ruolo che in esso hanno le Idee, consiste
nell’aver egli presentato queste ultime come ipostatizzazioni degli universali, vale a dire come universali esistenti
in modo separato, ossia aventi un’esistenza in se stessi, in
22 J.N. Findlay, Platone, p. lvii.
tale esistenza separata avendo lo Stagirita surrettiziamente
risolto il carattere del «per sé» che Platone annette ai significati ideali, ma in tutt’altra valenza. In effetti, ad avviso di
Findlay, per Platone «le cose particolari […] non hanno in
sé niente di sostanziale, niente di onticamente ontico» 23, ma
sono soltanto esemplificazioni di significati ideali giacché
«figurano soltanto nella descrizione di quello che gli εἴδη
sono e di quello che gli εἴδη producono» 24.
3.2.1 Occorre subito osservare l’impostazione neoplatonica di questo modo d’intendere la natura degli enti empirici
e l’applicazione di una concezione plotiniana a Platone. La
materia, notoriamente, per Plotino corrisponde al massimo depotenziamento dell’essere e quasi al non-essere. In
perfetta analogia Findlay attribuisce a Platone la teoria
che «le cose», più esattamente gli enti empirici, che sono
per l’appunto materiali, non hanno nessuna consistenza
«onticamente ontica».
3.2.2 Già questa convinzione, che sta alla base della costruzione esegetica findlayana del progetto matematizzante
di Platone e del corrispondente fraintendimento aristotelico,
è rivelativa del suo carattere fortemente congetturale e, vien
da dire, del modo assolutamente «personale» di leggere i
piani di realtà (assoluto essere, divenire = essere e non-essere, assoluto non-essere ovvero nulla) proposti da Platone,
per esempio, nel noto passo della Repubblica dove è a tema,
in corrispondenza a essi e per i relativi risvolti gnoseologici,
la teoria della «linea divisa». Qui l’assoluto non-essere – in
termini findlayani l’assoluta assenza di onticità ontica – non
è attribuito certo al divenire e alle «cose» che ne sono sog23 24 J.N. Findlay, Platone, p. lvii.
Ibid.
gette, giacché esse, ad avviso di Platone, sono essere e non
essere, tale per l’appunto essendo il divenire. Dunque, per
quanto labile sia la loro realtà, le cose hanno consistenza
reale, ossia essere, sia pur congiunto a non-essere. In effetti,
non sono mere «esemplificazioni» di significati ideali, ma
«copie» dei modelli ideali, e la copia è alcunché di reale,
ancorché la sua realtà sia mutevole e imperfetta.
E ancora: «le cose mutevoli e sensibili – scrive Findlay
– non sono niente in se stesse; possiedono l’essere solo nel
senso in cui incarnano, rispecchiano, dimostrano in modo
molteplice, partecipano in modo imperfetto e disperso, o,
come si dice in termini moderni, esemplificano un εἶδος
o una classe di εἴδη. L’essere degli esempi è esaurito dalla
loro esemplificazione, della quale i soli soggetti logici sono
gli εἴδη; gli esempi stessi sono, in realtà, esemplificazioni,
subite dagli εἴδη, di cui sono mere modalità» 25.
Va subito rilevato che nessuno dei termini posti in campo
da Findlay per specificare la natura degli enti empirici rispetto alle Idee traduce «partecipazione» (μέθεξις) e «imitazione» (μίμησις) con i quali Platone esprime questo rapporto,
né sul piano concettuale il denotato dei primi corrisponde
al denotato dei secondi. In realtà, non si «rispecchia» e non
si «imita» un «aspetto unitario».
Che dunque per Platone le cose siano «esemplificazioni» delle Idee e non abbiano altra realtà che quella di meri
«esempi» di esse, corrisponde a una lettura del tutto impropria dei concetti e dei termini reperibili negli scritti platonici.
3.3 Il secondo momento del progetto platonico, frainteso da Aristotele, è il passaggio dalle cose ai significati
ideali, ovvero alle Idee. Non si tratta del passaggio da un
«essere» mutevole a un «essere» stabile, ovvero – secondo
25 J.N. Findlay, Platone, p. 35.
la terminologia e la concettualità del Fedone – dal «visibile»
all’«invisibile», ossia da due ordini di «realtà», tali essendo le
«realtà» che cadono sotto il senso della vista e quelle che non
si colgono sensibilmente, ma del passaggio dagli esempi ai
significati da essi esemplificati. «La prima fase [«prima» nel
quadro del progetto platonico, corrispondente a quello che
abbiamo indicato come «secondo momento») consiste nel
mettere al centro della realtà un certo numero di modelli in
cui l’intelligibilità e l’eccellenza siano preminenti, e intorno
ai quali si raggruppino tutte le altre possibilità e verità come
frammenti del pensiero» 26. Tali «modelli» sono esattamente
le Idee o – come sovente le denomina Findlay – i significati
ideali, che fin dal loro essere raggiunti da Platone si presentano, secondo l’interprete, come «frammenti del pensiero»
e, come tali, necessitanti di essere ricondotti a unità.
Ma prima di essere fatti oggetto di una tale riconduzione
egli «cerca di classificarli secondo princìpi a essi intrinseci» 27.
È questa la «seconda fase», e i princìpi loro intrinseci sembrano essere i cinque generi del Sofista. Ma non è l’identificazione di ciò a cui con questa espressione l’interprete allude
che in questo momento interessa fare oggetto di riflessione.
3.3.1 Interessa invece porre l’accento sul fatto che il
passaggio a questi modelli non si configura affatto come
passaggio a un «secondo mondo» solo nell’ottica in cui gli
enti empirici non costituiscono affatto un «primo mondo»
giacché sono mere esemplificazioni. La derealizzazione di
essi sul piano «onticamente ontico» è il presupposto teorico
e al tempo stesso esegetico che permette di dire che nella
seconda fase Platone non raggiunge un piano ulteriore di
«realtà» rispetto a quello delle cose e che, dunque, l’inter26 27 J.N. Findlay, Platone, p. 20.
Ibid.
pretazione dualistica delle Idee è un fraintendimento. Tale
giudizio di fraintendimento è l’esito e la conseguenza della
convinzione che gli enti empirici per Platone non hanno consistenza reale, sia pur labile, ma sono solamente esempi. Una
convinzione – abbiamo testé avuto modo di osservare – del
tutto «personale» di Findlay e per niente affatto rispondente
non soltanto a riscontri sui testi platonici né a considerazioni
su di essi, ma addirittura in contrasto con questi.
In quest’ottica il giudizio sul «fraintendimento» aristotelico delle Idee di Platone, quel fraintendimento che è stato
seguito per secoli e secoli nella presentazione storiografica
del pensiero di questo filosofo, si configura come esso stesso
il risultato di un «fraintendimento».
3.3.2 Nel presentare la natura delle Idee, Findlay fa riferimento pressoché interamente al loro carattere d’intelligibilità, ossia di significati stabili. Nel passo precedentemente riportato è esattamente questa dell’intelligibilità
la connotazione con cui le qualifica. Vi aggiunge anche
l’eccellenza, determinazione che a ben vedere si risolve
nell’intelligibilità. Infatti da quel contesto così come da altri
passi si comprende che tale determinazione è contrapposta
dall’interprete alla mutevolezza delle «esemplificazioni»,
non a caso chiamata direttamente in causa e contrapposta
a sua volta alla stabilità degli εἴδη là dove egli afferma che
«la tendenza fondamentale del Platonismo» fu generata
«dalle sue origini nella teoria di Eraclito e di Cratilo intorno
al flusso e dal desiderio di riproporre in una versione ripristinata la stabilità eleatica» 28; ond’è che l’eccellenza degli
εἴδη risiede nella stabilità del significato, ossia nella stabilità
della dimensione intelligibile. Peraltro va richiamato che
assai spesso Findlay indica gli εἴδη come «significati ideali»,
28 J.N. Findlay, Platone, p. 30.
marcando in tal modo anche a livello della denominazione
che loro caratteristica basilare è l’intelligibilità, di cui il
significato è il riverbero e, per così dire, la faccia speculare.
Dunque, ciò che negli εἴδη è stabile è il significato ed essi
sono significati stabili, ossia permanenti. Per contro Findlay
sembra non considerare o comunque dare assai scarsa rilevanza nella sua esegesi al loro carattere di universalità.
Va infine considerato un terzo carattere delle Idee, ampiamente attestato nei Dialoghi, ossia il loro essere per sé.
Findlay, che rifiuta l’interpretazione dualistica degli εἴδη,
non presenta questa determinazione come denotante il loro
essere separate, vale a dire sostanze, ma come espressione
della stabilità o permanenza dei significati in cui consistono.
Ora, su queste determinazioni: significati, permanenti,
universali, per sé, occorre riflettere. E innanzitutto occorre
osservare che la permanenza, ossia la stabilità, per il fatto
stesso di indicare continuità nell’«esistere», ovvero il perdurare nell’«essere», non può che rappresentare un carattere
della sostanza, stante che essa financo dal termine che la
esprime (οὐσία) chiama in causa l’essere (τὸ ὂν), e – più
esattamente – un carattere costitutivo di essa.
Dunque, l’essere gli εἴδη significati stabili, ovvero per sé,
null’altro può voler dire se non che sono significati sostanziali. Ma proprio questo fa problema. Giacché carattere
peculiare della sostanza (non solo della sostanza aristotelicamente concepita e teorizzata, ma di ogni concezione della
sostanza, vale a dire della nozione di sostanza in quanto tale;
si pensi per esempio a Cartesio, che definisce la sostanza
res quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad existendum) è
l’essere separata, l’avere cioè un’esistenza per se stessa 29.
29 Cfr. R. Descartes, Principia philosophiae (1664), P. I, § 51, in Id.,
Œuvres, éd. Adam-Tannery, t. VIII, Paris 1905, p. 24,21-23: «Per substantiam
nihil aliud intelligere possumus, quam rem quae ita existit, ut nulla alia re
indigeat ad existendum».
Ma l’essere «significati separati» è una contraddizione
in termini. Gli εἴδη, infatti, sono universali. Il significato
stesso, a ben vedere, è un predicato, ossia un universale.
Pertanto, l’essere gli εἴδη significati separati vuol dire che
sono sostanze universali separate, e questo è impossibile,
giacché l’universale per sua stessa natura (quella sua natura
che è stata puntualizzata da Aristotele, ma che non corrisponde al «suo» modo di concepire l’universale, bensì ne
manifesta il proprium) è ciò che si predica dei molti, ossia
l’unita di un molteplice, e come tale non può sussistere che
nei molti stessi, non separatamente da essi.
Sotto questo profilo l’avere Aristotele presentato le Idee
platoniche come sostanze universali separate e, dunque,
come un assurdo, forse potrà anche non essere «ciò che
Platone ha veramente detto», ma è senz’altro «la verità»
di ciò che ha detto, in quanto la denunzia fa riferimento a
strutture formali della sostanza in quanto tale e su di esse
si àncora, e dunque prescinde dal modo in cui Platone l’ha
pensata (se mai l’abbia pensata così come Findlay ritiene),
attestandosi invece in assoluto.
3.3.3 Ma anche in riferimento a una differente concettualizzazione – in realtà a una differente formulazione delle
istanze sopra richiamate – questa stessa conclusione s’impone. In Cat. 5, com’è noto (uno scritto che per la sua datazione pristina è cronologicamente assai vicino alla presenza
dello Stagirita nell’Accademia se non addirittura databile al
tempo di essa, cosicché il confronto con le Idee platoniche
risulta particolarmente vivo), Aristotele, dopo aver distinto
la predicazione essenziale o «dirsi di un soggetto» dalla
predicazione accidentale o «essere in un soggetto» e aver
tracciato sulla base della combinazione di queste due strutture predicative una prima mappa ontologica, definisce la
sostanza prima, ovvero quella che si dice «in senso primario
e principale» (πρώτως καὶ κυριώς) come ciò che né è in un
soggetto, né si dice di un soggetto. Si tratta dunque della
sostanza individuale, ovvero dell’individuo sostanziale.
L’individuo, pertanto, rappresenta la sostanza a più forte
titolo, mentre le sostanze universali, vale a dire le specie e i
generi sostanziali, sono «sostanze seconde», le quali indicano «quale è» piuttosto che «che cos’è» 30. Ora, se le Idee sono
sostanze, e sostanze in senso forte, non possono che essere
individui. Per cui il loro essere anche universali definisce
un vero e proprio assurdo, giacché delinea un individuo
universale. Insomma, se sono sostanze non possono essere
universali e se sono universali non possono essere sostanze.
Ancora una volta occorre far presente che i rilievi sopra
formulati, concernendo le strutture formali della sostanza
e dell’universale, costituiscono i parametri concettuali per
definire l’adeguatezza o l’assurdità di una teoria che metta
assieme la sostanzialità e l’universalità. Per cui, da capo, se
anche l’essere le Idee platoniche degli «individui universali»
non corrisponde a ciò che Platone ha veramente detto di
esse, corrisponde tuttavia alla verità del suo dirne.
3.4 Il terzo e il quarto momento del progetto platonico
frainteso da Aristotele consistono nella matematizzazione
delle Idee (quella che Findlay indica come «terza fase») e nella
30 Dottrina, questa che la sostanza prima è l’individuo, che non è affatto
contraddetta da Met., Ζ (VII) 3 dove Aristotele sostiene che sostanza prima
è la forma o essenza. Ciò è piuttosto uno sviluppo e un approfondimento
della dottrina di Cat. 5. Ché, nel tempo in cui compose questa πραγματεία
o questo λόγος Aristotele non aveva ancora elaborato la dottrina della
materia e della forma. Cosicché, avendola elaborata e avendo così definito
l’individuo come sinolo di materia e forma, è logico che si chiedesse quale
di queste due componenti determina in senso, per l’appunto, «primario» il
suo essere sostanza, e conclude che è la forma. A questa conferisce pertanto
la qualifica di sostanza prima. Una qualifica che, come si vede, non soltanto
non confligge con quella per la quale la sostanza prima è l’individuo, ma,
all’opposto, l’approfondisce.
riconduzione del sistema così delineato ai princìpi dell’Uno
e della Diade (la «quarta fase»). Una riconduzione che per
i motivi sopra indicati non ebbe successo, per cui il disegno
rimase solamente una prospettiva abbozzata. Le parole di
Findlay a riguardo sono inequivocabili e su di esse occorre
riflettere: «la terza fase è il tentativo di ridurre tutta questa
ricchezza [scil. gli εἴδη e la relativa classificazione secondo
princìpi loro intrinseci] alla formalità e purezza che, secondo
Platone, può trovarsi solo in una matematica subordinata
alla filosofia. E, infine, c’è la fase in cui si cerca di derivare
tutta questa purezza ordinata da princìpi, o da un principio,
da una purezza metamatematica adeguata, secondo Platone,
all’ineffabilità necessaria dell’Assoluto mistico» 31.
Tre rilievi a questo proposito s’impongono.
3.4.1 Innanzitutto salta immediatamente agli occhi la
valenza neoplatonica dell’Uno così inteso, in esso dovendosi
individuare «l’Assoluto mistico»; per cui, se il fraintendimento di Aristotele nell’attestare la derivazione da esso dei
numeri ideali consiste nel non averla presentata secondo
questa concezione dell’Uno e, in particolare, se prende forma
nel non aver messo in luce che si tratta di una derivazione
da un principio mistico e ineffabile, non v’è dubbio che il
fraintendimento si presenta come atto decettivo dal carattere
ben strano e, comunque, marcato da un modo del tutto singolare e personale di pensare l’autenticità dell’Uno platonico.
Certo, Findlay, pensando all’azione dell’altro principio,
la Diade indefinita di Grande e Piccolo che ha potenza
duplicatrice ed è «come una sostanza plastica» (ἐκμαγείον;
cfr. Met., Α [I] 6, 988 a 1), non manca di indicare, seguendo
la ricostruzione del Robin 32, la derivazione dei numeri
31 32 J.N. Findlay, Platone, p. 20.
Ibid., pp. 442-450.
ideali secondo una scansione matematica nella quale, oltre
alla duplicazione, «che produrrà solo le potenze del due»,
interviene il «principio di unità o uniformità che, esercitando le sue operazioni caratteristiche, cercherà di trovare
la media aritmetica tra due numeri, ossia un numero che
superi il precedente tanto quanto è superato dal seguente».
Ottenuto così, secondo questo processo, «la triplicità o il
numero tre eidetico, egualmente distante dalla duplicità
quanto dalla doppia duplicità», in virtù dell’azione che «la
triplicità esercita su se stessa e sulla duplicità, e viceversa,
si avranno ovviamente tutte le potenze del tre [ossia il 9]
e tutti i multipli del tre [ossia il 6 e il 9] e del due [ossia il
4, il 6, l’8 e il 10]. Solo quando si arriva al primo numero
primo dopo il tre, ossia al cinque, si ricorre nuovamente
all’azione egualizzatrice e mediatrice dell’Unità, per cui la
cinquinità verrà collocata nello spazio tra la doppiaduplicità e la tripladuplicità»33.
Ma allora la funzione «egualizzatrice e mediatrice»
dell’Uno è ben altro che mistica, l’Uno stesso non ha questa
natura e, a ben vedere, l’intero processo non è caratterizzato
da una «purezza metamatematica», non potendosi propriamente considerare metamatematiche la duplicazione,
la potenza e la stabilizzazione tra un termine precedente e
uno conseguente se non in quanto eseguite su essenze e non
su quantità. Ma allora il carattere metamatematico non sta
in queste operazioni, ossia nel processo, bensì in ciò su cui
le operazioni sono eseguite.
3.4.2 Ma in ogni caso (e siamo al secondo rilievo) occorrerebbe comprendere se per Findlay le tre fasi specificano
una successione soltanto logica o anche cronologica. Ché,
se vige la seconda alternativa, dal momento che la suc33 J.N. Findlay, Platone, p. 61.
cessione temporale chiama direttamente in questione la
storicità del suo realizzarsi, sarebbe più consono che anche
il criterio esegetico fosse di natura storica e, in specie, che
la successione delle fasi fosse ricostruita secondo una linea
storico-progressiva e non alla luce della fase finale.
Inoltre, perché mai l’ultimo sviluppo, manifestando l’ultima esigenza, dovrebbe essere il criterio col quale fare luce
sulle esigenze che portarono alle fasi precedenti, quando
esse furono avvertite?
Se invece vige la prima ipotesi occorrerebbe chiedere
che concatenazione «logica» è mai quella nella quale non
è costitutivamente possibile definire la struttura dell’atto di derivazione dei numeri ideali dall’Uno, stante che
questo è l’atto supremo di un disegno che per intrinseche
difficoltà concettuali e linguistiche non poté essere specificato, come in precedenza abbiamo sentito affermare da
Findlay, restando perciò a livello di un mero progetto; e
come può essere «logica» una concatenazione nella quale
la derivazione suddetta non è precisabile se non mediante
il ricorso alla mistica.
3.4.3 Infine occorre fissare l’attenzione sul fatto che Findlay a più riprese dichiara che questo progetto, nel suo articolarsi nella riduzione degli enti empirici a esemplificazioni
degli εἴδη, nella risoluzione degli εἴδη a numeri e rapporti
matematici, cioè a numeri ideali, e nella derivazione dei
numeri ideali dall’Uno e dalla Diade, prospetta una concezione analogica della realtà, pari (fatta salva una differenza,
che peraltro non sembra rivestire una rilevanza significativa
in ordine alla definizione del tipo di rapporto indicato da
Findlay) all’analogia dell’essere teorizzata da Aristotele.
Le parole dello studioso in proposito sono nette e inequivocabili. «Socrate-Platone fa bene a esplorare le gradazioni
della gerarchia ontologica e a respingere come assurda
quell’ontologia-a-un-livello che, essa stessa radicata in una
confusione filosofica, è sempre stata infinitamente produttiva degli altri (sic! Credo si tratti di un refuso e che si debba
leggere “delle altre”). Egli assume, come Aristotele asserirà
più tardi esplicitamente, che ci sono diversi sensi, primario,
secondario, terziario ecc., in cui qualcosa può essere detto
essere o essere qualcosa e non niente (ad es. Cat. 2 a 11-8;
Met., Γ [IV] 2, 1003 a 33-b 19)» 34.
Qui, come si vede, l’«ontologia-a-un-livello» null’altro è
se non una concezione monistica dell’esistente. Concezione che Socrate e Platone avrebbero rifiutato per far valere
invece una gerarchia ontologica, ossia differenti gradazioni
di realtà, corrispondente alla tesi aristotelica che l’essere si
dice e ha molti significati. Si tratta, in tutta chiarezza, della
notissima tesi secondo cui τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς, ossia
dell’analogia dell’ente, come conferma la citazione del passo
della Metafisica (Γ [IV] 2, 1003 a 32).
Qui la confusione in cui incorre Findlay salta immediatamente agli occhi. Anche a prescindere dall’assimilazione
sotto il profilo dottrinale di Socrate e Platone e dal conseguente aver fatto del primo il teorico di un’ontologia, cosa
che, dopo il mancato accoglimento sul piano della critica
storica delle tesi di Burnet e Taylor, nessuno studioso del
maestro ateniese sarebbe disposto ad avallare, va rilevato il
fraintendimento che sorregge la presentazione della multivocità dell’essere professata da Aristotele come una gradazione e una gerarchia dell’essere. Questo processo, di cui è
facile e immediato scorgere la matrice neoplatonica, non
ha nulla a che vedere col fatto che l’essere aristotelicamente
inteso si dice in molti sensi. Ché, l’ontologia aristotelica
prevede che i molteplici significati dell’essere siano tutti
essere a pari titolo, stante che tutti corrispondono all’ori34 J.N. Findlay, Platone, p. 182.
ginario scandirsi dell’essere stesso, che proprio per questo
è un omonimo, e il primato della sostanza rispetto alle altre categorie o significati supremi dell’essere non significa
affatto che essa è maggiormente essere di quelli, ossia che
possiede un grado di realtà superiore agli altri, vale a dire
alle altre categorie, ma solamente che è quel significato,
di pari pienezza ontologica degli altri, in riferimento a cui
questi si pongono. Laddove la gerarchia proposta da Findlay
prevede un differente grado ontologico dei differenti livelli
di essere, e precisamente una pienezza di essere maggiore
dell’Uno rispetto agli εἴδη e di questi rispetto alle loro esemplificazioni. Queste ultime, infatti, per Findlay non hanno
una consistenza «onticamente ontica», mentre pienezza
di essere appartiene agli εἴδη, e a maggior titolo ai princìpi
da cui derivano.
In linea con il passo testé letto si consideri questo secondo. «Chiaramente la teoria platonica delle idee – scrive
Findlay – fu il primo saggio dell’analogia dell’essere che
Aristotele, pur invertendone completamente l’applicazione, ha per primo formulato a livello semantico, e di cui
quasi tutta la filosofia medioevale è un’elaborazione. Solo
le idee sono realmente; gli esempi e le anime sono solo un
accidente marginale e variabile dell’essere delle idee, un
modo in cui le idee defluiscono e si mostrano, anche se
senza dubbio le anime sono un defluire infinitamente più
onorevole e più simile alle idee che non le manifestazioni
corporee, mentre lo spazio non è che più che un settore o
campo confusamente ipostatizzato, nel quale dobbiamo
immaginarci che abbia luogo il defluire delle idee. Platone
come Aristotele crede che l’essere si dica in molti sensi, e
che alcuni di questi abbiano una prerogativa linguistica
e ontologica rispetto ad altri, solo che, mentre per Aristotele gli individui e le loro essenze hanno questa sorta
di prerogativa (cfr. ad es. Cat. 5), per Platone sono le idee
(e successivamente i loro princìpi) ad avere questa sorta
di prerogativa, poiché tutto ciò che esiste oltre le idee è
variamente dipendente da esse» 35.
Che la differenza dei diversi livelli dell’essere corrisponda
a un maggiore o minore grado di realtà, qui è testualmente
asserito: «solo le idee sono realmente», «gli esempi e le anime
sono solo un accidente marginale e variabile dell’essere delle
idee, un modo in cui le idee defluiscono e si mostrano», «le
anime sono un defluire infinitamente più onorevole e più
simile alle idee che non le manifestazioni corporee», «lo
spazio non è che più che un settore o campo confusamente
ipostatizzato, nel quale dobbiamo immaginarci che abbia
luogo il defluire delle idee». Esempi, idee, anima, spazio,
e poi l’Uno e la Diade non sono, propriamente, molteplici
significati dell’essere, ma gradi dell’essere, connotati da
valenza ontologica in misura maggiore o minore. La qualificazione di «infinitamente onorevole» attribuita all’anima
rispetto agli esempi (ossia alle cose sensibili) ne è un’attestazione lampante. E poiché questo modo d’intendere la
realtà, attribuito a Platone, è ritenuto da Findlay corrispondere all’analogia dell’essere teorizzata da Aristotele,
la quale per le ragioni precedentemente chiarite è dottrina
del tutto diversa, occorre di nuovo osservare l’equivoco
della confusione. E va da sé che la differenza indicata da
Findlay tra il vigere l’analogia, per Aristotele, anche per gli
individui, e il fatto che per Platone, per il quale gli individui empirici, ossia le cose, non sono essere, ma esempi di
essere e dunque non passibili di attribuzione dell’analogia
dell’essere, essa vige soltanto per le Idee, non scalfisce in
nulla l’assimilazione della concezione platonica dei piani
di realtà all’analogia dell’essere di Aristotele, e l’equivoco
che l’assimilazione incarna.
35 J.N. Findlay, Platone, p. 383 sg.
Ma v’è di più. Com’è noto, l’analogia aristotelica è analogia di proporzione, vale a dire uguaglianza di rapporti
tra la sostanza e gli altri significati dell’essere (la qualità
si rapporta alla sostanza come la quantità si rapporta alla
sostanza come l’avere si rapporta alla sostanza ecc.). Per
contro, la maggiore o minore pienezza ontologica dei livelli
di realtà, attribuiti da Findlay a Platone, ovvero, come egli
dice, l’onore che essi hanno sul piano dell’essere, delineando
una gerarchia e una gradazione di livelli di realtà di matrice
neoplatonica, propriamente non può intendersi come analogia. Ma poiché Findlay chiama in causa l’analogia «di quasi
tutta la filosofia medievale», assimilando a essa la gerarchia
ontologica di Platone e considerandola alla stregua di quella
dello Stagirita, oltre all’equivoco di detta assimilazione è
agevole riscontrare anche l’equivoco della equiparazione.
Ché, se si considera l’analogia entis tomista, che non a caso
gli interpreti di Aristotele chiamano in causa per indicarne
la differenza da quell’analogia teorizzata dallo Stagirita, la
distanza da questa seconda è strutturale, trattandosi, com’è
noto, di analogia di partecipazione (l’ente che «è» l’essere,
ossia l’ipsum esse subsistens, lo partecipa agli enti che «hanno»
l’essere. Questi infatti, che di per sé sunt possibilia esse et non
esse, possono sia essere che non essere, come si esplica nella
terza via, se esistino non hanno tratto da sé l’essere, ma lo
hanno partecipato dall’ente che è per essenza).
Il fatto si è che, a ben vedere, il disegno platonico delineato da Findlay non prospetta una concezione analogica
della realtà, bensì una concezione rigorosamente monistica,
e il seguente passo lo attesta eloquentemente: il «progetto
essenziale di Platone […] fu di ridurre tutti i “sensi [scil. le
Idee] fondamentali” a un solo senso fondamentale (o, al
limite, a un paio di sensi fondamentali [scil. l’Uno e la Diade
indefinita di Grande e Piccolo]) che contenesse in sé una
fecondità infinita di differenziazione e di specificazioni da
trovarsi solo nell’ambito della quantità e del numero, poiché
solo in ambito matematico il semplice e l’uniforme possono
differenziarsi in una inimmaginabile complessa infinità di
generi» 36. Dove, in tutta evidenza, l’invocata riduzione di
tutte le Idee ai princìpi fondamentali dell’Uno e della Diade così da conseguire una omogeneità «qualitativamente»
semplice e uniforme dell’esistente, stante che è dal punto di
vista qualitativo che tutto si riconduce all’Uno e alla Diade
indefinita, è l’attestazione più lineare e lampante di una
visione monistica dell’esistente stesso. E la differenziazione,
essendo affidata a un processo matematico, ossia quantitativo, non è in essenza che la ripartizione della medesima
qualità in quantità maggiori o minori nei differenti livelli
dell’esistente.
bibliografia utilizzata e di riferimento
Aristotele, Le categorie. Monografia introduttiva, traduzione e
commento di M. Zanatta. Testo greco a fronte, Milano 1989.
– Metafisica. Monografia introduttiva, testo greco, traduzione,
commento e indici analitici a cura di M. Zanatta, 2 voll., Milano
2009.
– Frammenti. Opere logiche e filosofiche. Introduzione, testo greco,
traduzione, commento e indici analitici a cura di M. Zanatta,
Milano 2010.
E. Berti, Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima, Padova
1977.
R. Descartes, Principia philosophiae (1664), in Œuvres, éd.
Adam-Tannery, t. VIII, Paris 1905.
J.N. Findlay, Il mito della caverna, trad. it., Milano 2003.
K. Gaiser, La metafisica della storia in Platone. Interpretazione
e commentario storico-filosofico di Repubblica VII, 534 b 3-d 2,
Milano 1992.
36 J.N. Findlay, Platone, p. 8.
H.J. Krämer, Dialettica e definizione del bene in Platone, trad. it.,
Milano 1996.
M. Marchetto, L’etica impersonale. La teoria dei valori di J.N.
Findlay, Napoli 1989.
– La filosofia di John Niemeyer Findlay tra fenomenologia e platonismo, in J.N. Findlay, Il mito della caverna, pp. 1-248.
– Il realismo metafisico di John Niemeyer Findlay, l’influsso della
fenomenologia su un neo-neoplatonico, «Aquinas», 3 (2004), pp.
571-601.
Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Milano 2000.
G. Reale, Per una nuova interpretazione di Platone. Rilettura della
metafisica e dei grandi Dialoghi alla luce delle Dottrine non scritte,
Milano 19875.
L. Robin, La théorie aristotélicienne des idées et des nombres d’après
Aristote, Paris 1908; repr. Hildesheim 1963.
S. Thomae Aquinatis In duodecim libros Metaphysicarum Aristotelis expositio, a cura di M.R. Cathala e R.M. Spiazzi, Torino 1950.
A.J. Taylor, Platone. L’uomo e l’opera, trad. it., Firenze 1968.