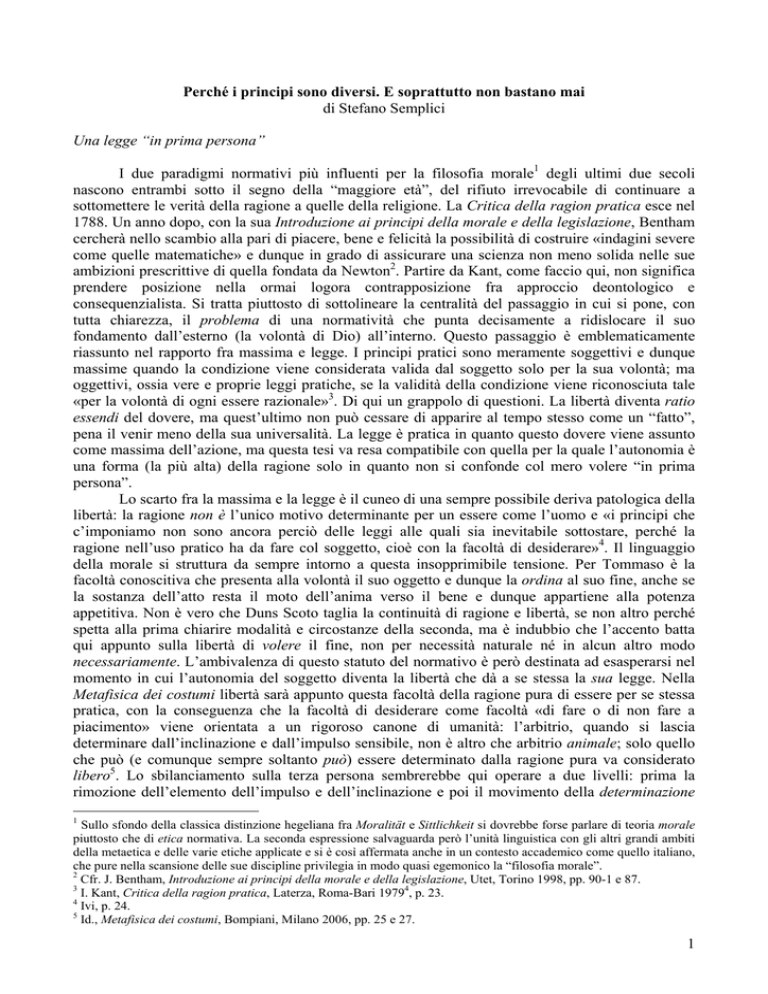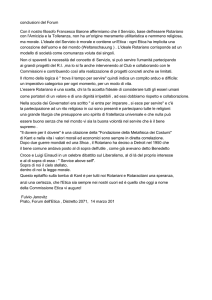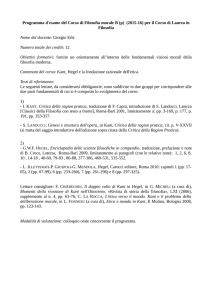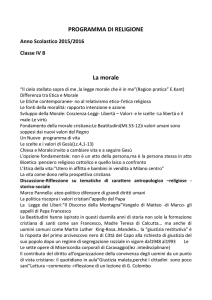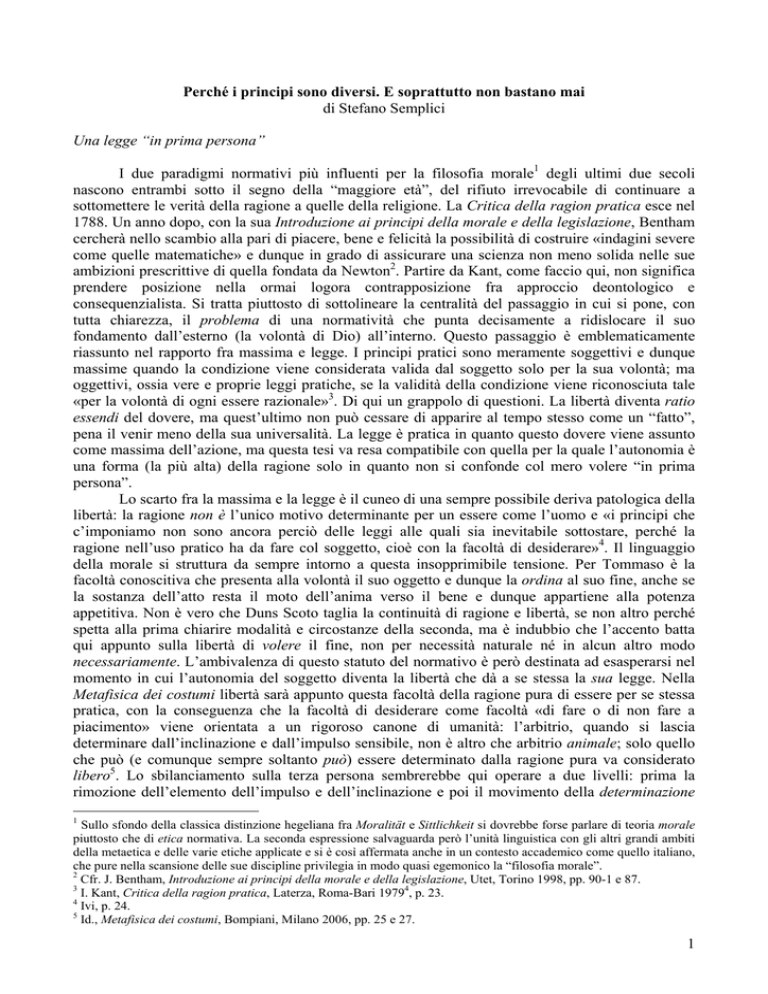
Perché i principi sono diversi. E soprattutto non bastano mai
di Stefano Semplici
Una legge “in prima persona”
I due paradigmi normativi più influenti per la filosofia morale1 degli ultimi due secoli
nascono entrambi sotto il segno della “maggiore età”, del rifiuto irrevocabile di continuare a
sottomettere le verità della ragione a quelle della religione. La Critica della ragion pratica esce nel
1788. Un anno dopo, con la sua Introduzione ai principi della morale e della legislazione, Bentham
cercherà nello scambio alla pari di piacere, bene e felicità la possibilità di costruire «indagini severe
come quelle matematiche» e dunque in grado di assicurare una scienza non meno solida nelle sue
ambizioni prescrittive di quella fondata da Newton2. Partire da Kant, come faccio qui, non significa
prendere posizione nella ormai logora contrapposizione fra approccio deontologico e
consequenzialista. Si tratta piuttosto di sottolineare la centralità del passaggio in cui si pone, con
tutta chiarezza, il problema di una normatività che punta decisamente a ridislocare il suo
fondamento dall’esterno (la volontà di Dio) all’interno. Questo passaggio è emblematicamente
riassunto nel rapporto fra massima e legge. I principi pratici sono meramente soggettivi e dunque
massime quando la condizione viene considerata valida dal soggetto solo per la sua volontà; ma
oggettivi, ossia vere e proprie leggi pratiche, se la validità della condizione viene riconosciuta tale
«per la volontà di ogni essere razionale»3. Di qui un grappolo di questioni. La libertà diventa ratio
essendi del dovere, ma quest’ultimo non può cessare di apparire al tempo stesso come un “fatto”,
pena il venir meno della sua universalità. La legge è pratica in quanto questo dovere viene assunto
come massima dell’azione, ma questa tesi va resa compatibile con quella per la quale l’autonomia è
una forma (la più alta) della ragione solo in quanto non si confonde col mero volere “in prima
persona”.
Lo scarto fra la massima e la legge è il cuneo di una sempre possibile deriva patologica della
libertà: la ragione non è l’unico motivo determinante per un essere come l’uomo e «i principi che
c’imponiamo non sono ancora perciò delle leggi alle quali sia inevitabile sottostare, perché la
ragione nell’uso pratico ha da fare col soggetto, cioè con la facoltà di desiderare»4. Il linguaggio
della morale si struttura da sempre intorno a questa insopprimibile tensione. Per Tommaso è la
facoltà conoscitiva che presenta alla volontà il suo oggetto e dunque la ordina al suo fine, anche se
la sostanza dell’atto resta il moto dell’anima verso il bene e dunque appartiene alla potenza
appetitiva. Non è vero che Duns Scoto taglia la continuità di ragione e libertà, se non altro perché
spetta alla prima chiarire modalità e circostanze della seconda, ma è indubbio che l’accento batta
qui appunto sulla libertà di volere il fine, non per necessità naturale né in alcun altro modo
necessariamente. L’ambivalenza di questo statuto del normativo è però destinata ad esasperarsi nel
momento in cui l’autonomia del soggetto diventa la libertà che dà a se stessa la sua legge. Nella
Metafisica dei costumi libertà sarà appunto questa facoltà della ragione pura di essere per se stessa
pratica, con la conseguenza che la facoltà di desiderare come facoltà «di fare o di non fare a
piacimento» viene orientata a un rigoroso canone di umanità: l’arbitrio, quando si lascia
determinare dall’inclinazione e dall’impulso sensibile, non è altro che arbitrio animale; solo quello
che può (e comunque sempre soltanto può) essere determinato dalla ragione pura va considerato
libero5. Lo sbilanciamento sulla terza persona sembrerebbe qui operare a due livelli: prima la
rimozione dell’elemento dell’impulso e dell’inclinazione e poi il movimento della determinazione
1
Sullo sfondo della classica distinzione hegeliana fra Moralität e Sittlichkeit si dovrebbe forse parlare di teoria morale
piuttosto che di etica normativa. La seconda espressione salvaguarda però l’unità linguistica con gli altri grandi ambiti
della metaetica e delle varie etiche applicate e si è così affermata anche in un contesto accademico come quello italiano,
che pure nella scansione delle sue discipline privilegia in modo quasi egemonico la “filosofia morale”.
2
Cfr. J. Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, Utet, Torino 1998, pp. 90-1 e 87.
3
I. Kant, Critica della ragion pratica, Laterza, Roma-Bari 19794, p. 23.
4
Ivi, p. 24.
5
Id., Metafisica dei costumi, Bompiani, Milano 2006, pp. 25 e 27.
1
che adegua la massima alla legge, il soggettivo all’oggettivo. Che ne è, a questo punto, del
periclitante equilibrio fra i due poli della moralità?
Si può tentare di uscire da questa impasse seguendo diverse vie. La prima e più radicale è
naturalmente quella di Nietzsche. Il «vecchio Kant» ha avuto il merito di forzare la gabbia, ma si è
poi comportato come una volpe che rifà il cammino all’indietro e, smarrita, in quella gabbia sceglie
infine di tornare. Lasciandosi «accalappiare» dall’imperativo categorico, dalla pretesa che il mio
giudizio debba coincidere con il giudizio di tutti, egli restaurò nella morale la «stabilità»
dell’universale, mentre si tratta ormai di scegliere l’ebbrezza della navigazione in un mare di nuovo
aperto, che anzi non era forse mai stato così aperto. È al poeta che spetta di ricomporre in uno ciò
che è frammento, enigma ed orrida casualità6. Il presupposto di questa frattura insieme estetica e
ludica (il bambino che creando gioca e che giocando crea) è la riduzione dello stesso soggetto
cartesiano ad un’illusione metafisica generata dal bisogno di stabilità e durata. Dietro il cogito non
c’è una causa sui comunque determinata, ma una serie di affermazioni temerarie e infondate: che
pensare sia l’attività di qualcosa come una causa, che si sia già fissato quel che deve valere come
pensiero. Il congedo kantiano dall’io-sostanza potrebbe essere, da questo punto di vista,
semplicemente l’altro volto della timidezza che riporta la volpe nella sua gabbia.
L’altra strada è quella di un’inversione o almeno di un ribilanciamento del rapporto fra la
prima e la terza persona. L’inversione può assumere il tratto più marcatamente anti-teorico
dell’orientamento della libertà a ciò che all’interno della vita umana «deve essere scoperto, seguito,
abbracciato con fiducia»: la morale si fa a partire non dalla legge ma dal nostro impulso «più
profondo», anche quando non sia del tutto chiaro «dove esso ci condurrà»7. In una versione più
prudente di «individualismo metodologico» è l’opzione naturalistica ed empiristica ad alzare un
argine invalicabile contro ogni olismo e contro tutte le concezioni che risucchiano l’autonomia
dell’uomo nella volontà di Dio, nei meccanismi socio-economici o nelle forze biologiche8. La
fortuna delle diverse versioni dell’etica della (delle) virtù appare invece legata proprio al tentativo
di incorporare lo spostamento del baricentro teorico dalla domanda sul che cosa devo fare a quella
su chi voglio essere in una prospettiva che possa comunque qualificarsi in senso normativo.
Elisabeth Anscombe, nel suo celebre articolo pubblicato nel 1958 sulla filosofia morale moderna,
aveva puntualizzato la matrice teologica di nozioni come dovere e soprattutto legge, concludendo
per la loro inattualità in un contesto storico-culturale nel quale è diventato impossibile continuare a
fondare la morale in Dio9. Il modello aristotelico della saggezza viene recuperato in vista di una
concezione di “norma” ad un tempo più aperta e più spessa di quella che caratterizza le prospettive
deontologiche e consequenzialiste. Più aperta, perché smarcata dal primato di una ragione
impersonale che dovrebbe funzionare da setaccio di disposizioni, tendenze, desideri e facoltà tutti
implicati nella determinazione della volontà. Più densa, proprio perché alla pura forma
dell’imperativo categorico o al calcolo della maggior felicità per il maggior numero si intende
sostituire la concretezza di una rete di pratiche di vita. Le difficoltà di questo approccio sono note
non meno dei suoi vantaggi. La sua filigrana, continuando a citare Anscombe, rimane «un resoconto
della natura umana». Se ciò viene inteso nel senso dell’universale delle capacità, di una lista «degli
elementi necessari a un funzionamento autenticamente umano che sia in grado di raccogliere un
ampio consenso transculturale»10, quel che si assume come moralmente (e politicamente) vincolante
è semplicemente l’impegno a garantire le condizioni per poter essere chi si vuole e non quel che si
deve. Chiedere di più alla nozione di natura significa tornare ad impigliarsi nella questione dell’uno
e dei molti. Esiste il Bene di tutti? Chi misura e giudica l’equilibrio che chiamiamo saggezza? E, in
ultima analisi, perché dovremmo preferirlo?
6
Cfr. F. Nietzsche, La gaia scienza, §§ 335 e 343 e Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1993, p. 162.
B. Williams, La moralità. Un’introduzione all’etica, Einaudi, Torino 2000, pp. 78-9.
8
Cfr. E. Lecaldano, Etica, Utet, Torino 1995, cap. I.
9
Cfr. E. Anscombe, Modern Moral Philosophy, in «Philosophy», 33(1958), pp. 1-19.
10
M.C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana, il Mulino, Bologna 2002, p. 74.
7
2
Il nodo della prima persona rimane d’altronde la spina relativista (che tuttavia onoriamo con
il nome di dignità) nel fianco di ogni teoria dell’universale-razionale. La prospettiva “da manuale”
dell’utilitarismo, secondo la quale al ruolo attivo del soggetto nella determinazione del dovere si
sostituirebbe la valutazione imparziale di “quantità” aggregate di felicità, ha da tempo integrato
l’opzione metodologica per la quale “ognuno vale per uno e tutti valgono solo per uno” con il
riconoscimento del ruolo ineliminabile della libera scelta degli individui a partire dai loro specifici
bisogni e valutazioni: soddisfazione delle preferenze piuttosto che piacere fisico, dunque, ma anche
libertà «da modelli morali ingiustamente gravosi che cerchino di regolare anche nei più piccoli
dettagli il loro comportamento»11. Un autore come Hare è ben consapevole che il successo della
combinazione “prescrittivista” di metodo dell’universalizzazione e utilitarismo appunto delle
preferenze dipende dalla capacità di superare la tradizionale obiezione “personalista” al calcolo per
aggregazione; per questo elabora una complessa teoria dell’immedesimazione simpatetica con le
preferenze altrui, cercando di trasformare la questione delle differenze interpersonali e
intertemporali in questione intrapersonale. Lo sforzo per una diversa modulazione del rapporto fra
la prima e la terza persona taglia trasversalmente le diverse e spesso distanti tradizioni normative.
Anche per la rilettura più aggiornata dell’antica ipotesi del diritto naturale i beni umani
fondamentali dei quali si occupa l’etica non sono più l’oggetto di una conoscenza della natura
umana e si impongono piuttosto nell’esercizio della libertà come filigrana di principi pratici
indimostrabili e per se nota, che «non abbisognano di ulteriori spiegazioni che li giustifichino»12. Si
può allora porre la domanda davvero decisiva: in che misura la normatività dipende dalla
giustificazione di un principio che per essere morale deve declinarsi in prima persona e per essere
normativo non può non declinarsi nel paradosso di un’assenza? La terza persona è certo
implacabilmente presente nel dispiegarsi di tutti i suoi meccanismi impositivi. E tuttavia, appunto in
linea di principio, non può non essere questa assenza, perché solo così può chiedere di essere
rispettata da “non importa chi”.
Due volte distanti dal «vecchio» Kant
L’attacco dell’Analitica della ragion pratica propone, oltre alla distinzione di massima e
legge, due tesi che non è più possibile condividere, almeno nella loro forma semplificata. Due tesi
che, oltretutto, sembrano escludere pregiudizialmente dall’ambito della riflessione propriamente
morale i luoghi nei quali più evidente appare oggi il “bisogno” di normatività. La prima coincide
con la prospettiva dell’incompatibilismo “metafisico” rilanciato da Kant. La reale capacità causale
della libertà è il presupposto di una concezione che sul soggetto non pretende più una presa
cognitiva di tipo sostanzialistico e tuttavia mantiene un’ipotesi fondativa trascendentale forte. Nella
conoscenza della natura i principi di ciò che accade sono nello stesso tempo leggi, perché il mondo
fenomenico è retto dalla catena rigida della necessità. La libertà rompe questa catena e i suoi
imperativi consentono una partecipazione vera al mondo noumenico, a un altro regno rispetto a
quello che già commentando la tragedia del terremoto di Lisbona Kant guardava con pacato
distacco: «L’uomo non è nato per erigere su questo teatro della vanità capanne eterne»13.
Nell’austero maestro di Königsberg, sicuramente, non si trova un’antropologia della corporeità
come quella con la quale Hegel inaugura la filosofia dello spirito. Anche se il suo pensiero non
corrisponde affatto all’icona banalizzata della contrapposizione fra la ragione e la dimensione
materiale della natura umana, è piuttosto a Fichte che occorre guardare per una più chiara
11
J.C. Harsanyi, Moralità e teoria del comportamento razionale, in A. Sen e B. Williams (edd.), Utilitarismo e oltre, il
Saggiatore, Milano 2002, pp. 71 e 77.
12
J. Finnis, Legge naturale e diritti naturali, Giappichelli, Torino 1996, p. 85.
13
I. Kant, Scritti sui terremoti, 10/17, Salerno 1984, p. 55. Sulla matrice “incompatibilista” della visione kantiana della
libertà cfr. H.E. Allison, Kant’s Theory of Freedom, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
3
consapevolezza del nesso fra la libertà e quel corpo al quale «colleghiamo la permanenza e
l’identità della nostra personalità»14.
Uno “stacco” così netto dalla natura è ormai insostenibile. Da una parte perché le
neuroscienze hanno rilanciato ad un livello ben più impegnativo la sfida di un monismo che ha
dimostrato ampiamente di poter superare le aporie del materialismo riduzionista. Si può senz’altro
accettare che l’egoismo dei meme funzioni in modo di gran lunga più complesso di quello dei geni,
fino ad ammettere che solo agli umani appartiene l’outlook sulle cose distanti e future e che l’antica
fedeltà a codici morali e superiori non era affatto «un’illusione»15, ma senza cedere di un passo
rispetto all’attribuzione alla coscienza di uno spessore diverso da quello di un fenomeno biologico
ordinario, al pari della digestione o della fotosintesi, «della mitosi, della meiosi o della secrezione di
enzimi»16. Dall’altra perché è proprio il modello di razionalizzazione dell’umano offerto dalla
tecnoscienza ad aver riaperto la frattura critica del dovere fra quel che possiamo e quel che
vogliamo fare. Questo universale, che ha trasformato lo scienziato in figura esemplare del
cosmopolitismo inutilmente vagheggiato nell’agire politico degli uomini di buona volontà, sembra
limitarsi appunto a promettere un potere che non impone alcun dovere, ma opera in realtà ad un
livello più profondo. La dinamica dell’immaginario, del senso e del valore si trova inglobata
nell’espansione incontrollata dell’artificiale, che varca ormai la soglia dell’integrità e identità
corporea, facendo del cyborg la cifra conclusiva della antropotecnologia teorizzata da Sloterdijk17.
Si consolida così una potenza autonoma che dietro l’usbergo della neutralità dispiega e determina le
condizioni concrete dell’esistenza. Di più: decreta la fine dell’ex-istere in un progetto e nelle
diverse riserve del simbolico, perché si farà e si sarà tutto ciò che la tecnoscienza, il phármacon che
insieme cura e uccide, potrà.
La seconda tesi irrimediabilmente inattuale di Kant riguarda l’impermeabilità della
distinzione fra imperativi ipotetici e categorici, i soli a determinare la volontà in quanto volontà e
non in un modo che è sì razionale, ma rispetto ad un effetto e dunque restando al di qua della
purezza e autonomia della ragion pratica. Nella seconda Critica una tavola riassume in questa
prospettiva tutti i motivi determinanti pratici materiali del principio della moralità. In quella del
Giudizio l’obiettivo di escludere «ogni partecipazione della natura» nella definizione di tale
principio si esplicita in una delimitazione altrettanto inflessibile dei contenuti di una trattazione
autenticamente filosofica della facoltà di desiderare: la dottrina della felicità rientra nell’ambito
tecnico-pratico delle regole dell’abilità e della prudenza e il suo posto è dunque accanto
all’economia domestica, all’agricoltura, alla politica, alla dietetica18. Anche qui occorre evitare le
banalizzazioni. Non è vero che Kant paga per la purezza della forma dell’imperativo il prezzo della
ricchezza dei contenuti senza i quali la morale non è esperienza concreta, ma esercizio astratto
dell’intelletto (basta la già citata Metafisica dei costumi a ricordarlo). E nella Fondazione egli
teorizza esplicitamente la fecondità del metodo che cerca il principio della morale in un movimento
circolare che parte dalla conoscenza comune e ad essa ritorna19. È vero, tuttavia, che Kant non
concede spazio ad una reale “regionalizzazione” del principio, ad una contaminazione di interno ed
14
J.G. Fichte, Fondamento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza, Laterza, Roma-Bari
1994, § 5.
15
D.C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings of Life, Simon & Schuster, New York 1995, p.
470.
16
Cfr. J. Searle, Mind, Language and Society, Basic Books, New York 1998 e The Rediscovery of the Mind, Mit Press,
Cambridge (Ma) 2002.
17
Feroci, come è noto, furono le polemiche che fecero seguito alla sua conferenza Regeln für den Menschenpark, tenuta
in Baviera nel 1999, nella quale Sloterdijk teorizzava il diritto ad una «riforma genetica» che garantisse la
pianificazione dei caratteri distintivi dell’uomo e la riduzione dei «rischi biologici» connessi all’esistenza.
18
I. Kant, Critica del giudizio, Laterza, Roma-Bari 19794, pp. 10-1.
19
«In questo scritto ho seguito il mio metodo che reputo il più conveniente quando si vuol salire analiticamente dalla
conoscenza comune verso la determinazione del principio supremo di essa, per poi discendere sinteticamente
dall’esame di questo principio e delle sue fonti verso la conoscenza comune a cui viene applicato» (I. Kant, Fondazione
della metafisica dei costumi, Tea, Milano 1997, p. 8). Analitico va qui inteso, evidentemente, nel significato aristotelico
di “risoluzione” di pensieri e ragionamenti nella loro figura fondamentale.
4
esterno che faccia del secondo qualcosa di più del luogo in cui si applicano le virtù dell’abilità e
della prudenza, pur non mancando qualche punto di contatto in particolare fra la sfera del diritto e
quella della morale (si pensi allo scritto sulla pace perpetua). Il rischio è che alla fine il principio
venga considerato astratto (come nell’esempio dell’uomo disperato che vorrebbe togliersi la vita o
di quello che sa di non poter restituire un prestito del quale non può fare a meno per andare avanti)
perché troppo spesso e non perché troppo sottile.
È di contaminazioni che vive in larga misura la riflessione normativa. Habermas non esita a
definire controintuitiva e inconsistente la suddivisione topografica delle competenze del diritto e
della morale nei termini della polarità pubblico/privato. In entrambi i casi si discute di principi
«intersoggettivamente riconosciuti» e il fatto che rimanga specifico del diritto il potere di
coercizione non esclude e anzi in qualche modo impone una dinamica di reciproca “trasgressione”.
Dal punto di vista di una teoria discorsiva del principio morale, perché essa traduce in una prassi
appunto pubblica l’ideale assunzione di ruolo intesa da Kant in termini puramente individualistici e
“interiori”. Ma anche dal punto di vista del concreto operare del legislatore politico, che sempre
«ricomprende in sé anche gli aspetti morali delle materie da regolamentare»20. Tanto più nel
momento in cui non è più “in nome di Dio” che si fanno le leggi e le ideologie totalitarie hanno da
tempo bruciato l’ipotesi di un’autofondazione assoluta della politica. Cresce il consenso intorno alla
tesi di un “ritorno in pubblico” della religione, ovviamente non come dispensatrice di regole di
senso ultime e principi non negoziabili, ma piuttosto come espressione di una esigenza di
trascendenza aperta e intrinsecamente plurale. A maggior ragione vale la necessità, fra la nostalgia
di perdute fondazioni metafisiche forti e la rassegnazione ad una asettica registrazione e validazione
dei rapporti di forza, di mantenere l’impegno ad una giustificazione del nesso fra la soggettività
della decisione e la sostanzialità del costume e della tradizione, se non dell’essere dell’uomo. I
principi non si cercano più a partire da singoli attori e neppure, come voleva il riduzionismo
sociologico prima maniera, da macrosoggetti di natura statale e sociale, bensì nel medium
«attraverso cui s’intrecciano interazioni e si strutturano forme di vita» e ritrovando di quest’ultimo
le condizioni insieme possibilitanti e limitanti della razionalità21. Il carattere necessariamente
linguistico di tale medium sarebbe un corollario non tanto dell’esigenza di universalità e neppure
soltanto del riconoscimento di questa facoltà come l’asse intorno al quale si strutturano tutte le
forme dell’essere e dell’agire umani, quanto della constatazione che l’etica del discorso è l’unica
per la quale si possa dire che il genitivo vale come soggettivo in quanto essenzialmente,
anteriormente oggettivo.
La politica è certamente il primo luogo nel quale si mette in discussione la
compartimentazione del giudizio morale. Limitiamoci a due considerazioni. Ogni Costituzione
include, tipicamente nella sua prima parte, il riferimento a principi decisamente metagiuridici,
utilizzando un vocabolario che arriva talvolta a sfiorare quello dell’impeto di una religione
(ovviamente civile…). La Carta dei diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini dell’Unione
Europea (comunemente nota come Carta di Nizza) non fa eccezione e si apre con un impegnativo e
retoricamente assai denso riferimento alla dignità. Non sembra davvero possibile, appunto nei
momenti costituenti, mantenere la distinzione fra i moral e i legal rights. Il consenso alle istituzioni,
che è poi il patriottismo come «sentimento politico fondamentale» del quale già parlava Hegel, si
regge su alcuni valori comuni, tanto è vero che è proprio quando il pluralismo inizia ad erodere
questo pavimento etico che si avverte più forte il disagio per le conseguenze della pur “corretta”
applicazione del principio di maggioranza. Le controversie bioetiche sono la quotidiana
dimostrazione di questa difficoltà. A un livello più generale, è il riferimento ai diritti umani che
costringe a ripensare l’idea che il problema della fonte della legge non va confuso con quello
dell’origine/fondamento del loro contenuto. Ci sono certo soggetti e procedure ai quali
l’ordinamento «attribuisce l’idoneità o la capacità di produrre norme giuridiche», ma è altrettanto
20
J. Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Guerini e Associati,
Napoli 1996, pp. 130 e 134.
21
Ivi, p. 11.
5
vero – così scriveva Norberto Bobbio – che tale divaricazione fra fonte e valore si apre e può aprirsi
solo da un certo punto in poi, che il primato metodologico della prospettiva positivista può e forse
deve accompagnarsi ad una sorta di giusnaturalismo “ideologico” sul piano delle opzioni di base22.
Il riferimento a tali opzioni di base sembra imporsi anche rispetto al sistema funzionale che
insieme alla tecnoscienza e prima e meglio della politica ha dimostrato di poter realizzare
l’unificazione della società post-nazionale. Le leggi della morale appaiono parcellizzate e
contrapposte all’interno di tradizioni che certo comunicano fra loro, ma non si fondono e, talvolta,
cozzano. Le leggi del mercato, al contrario, si presentano come la filigrana di quasi tutte le
dinamiche che attraversano e fluidificano i confini delle antiche appartenenze culturali, geografiche
e politiche, che si tratti dell’onda lunga della mcdonaldizzazione, dell’inglese di internet o degli eroi
dello sport, del cinema e della musica. Anche qui appare all’opera una peculiare forma di
“neutralità”, che mentre consente il calcolo razionale dell’impiego dei mezzi e delle condizioni di
scambio ne determinerebbe la costitutiva impoliticità, analogamente a quanto garantito dalle
procedure matematizzate della ragione tecnologica. Anche qui, tuttavia, si generano anticorpi alla
pretesa di un riduzionismo che è ormai il nuovo volto dell’antica questione filosofica della libertà:
c’è una tecno-economia che tratta l’idea di umanità alla stregua di una mera figura di genere,
accomunata a «ciò che è comune ad ogni cosa, ossia alla misura espressiva del danaro»23. Il bisogno
di etica non è allora semplicemente l’ultimo e forse disperato stratagemma dei filosofi che cercano
di sopravvivere. In esso si mantiene una doppia linea di resistenza alla “demitologizzazione”
dell’universale nella quale, dopo la religione, dovrebbe infine dissolversi anche l’illusione di
categoricità del bene. Wittgenstein e Keynes, insomma. Forse resta vero che «i nostri problemi
vitali non sono ancora neppure toccati» quando tutte le domande della scienza dovessero aver
trovato risposta. Forse si può ancora continuare a chiedere agli economisti di considerare il loro
lavoro come quello dei dentisti, che ci liberano dal dolore, ma non sanno dirci cosa fare di questa
libertà24.
Continuiamo a parlare di etica normativa non nonostante la scienza, l’economia e il diritto,
ma in riferimento e forse anche grazie ad essi. Ciò non corrisponde semplicemente alla peculiare
vitalità e centralità del momento applicativo della riflessione sul “buon” uso della libertà, ma ad una
più profonda trasformazione di metodo. La normatività che è possibile tematizzare all’interno del
medium delle forme di vita, volendo restare ad un’impostazione di matrice trascendentale, non
sembra poter eccedere il carattere di una necessità debole, per la quale sempre Habermas parla
anche di trascendenza intramondana o pragmatica controfattuale. La «costrizione» alla quale
l’agente si trova sottomesso corrisponde cioè semplicemente ad una «corona d’idealizzazioni
inevitabili» (autonomia e veridicità verso sé e verso gli altri, implicita ascrizione a questi ultimi di
una responsabilità morale), che non solo non consentono una duplicazione dei piani del reale, ma
neppure la definizione di imperativi deontologici che corrispondano a «una costellazione di valori
privilegiati». In questo modo si supererebbe il limite della posizione originaria come posizione
d’imparzialità che Habermas imputa a Rawls: il medium è reale e non una condizione fittizia
rispetto alla quale ciascun singolo individuo sarebbe in grado di intraprendere da solo il tentativo di
giustificare le norme fondamentali. Proprio per questo, tuttavia, la normatività del principio si
guadagna solo forzandone l’aspetto formale-procedurale e restando impigliati, quanto ai contenuti,
nella concreta e mutevole configurazione storico-culturale dell’orizzonte dell’intesa. Senza contare
che l’atteggiamento performativo corrispondente a questo télos si impone solo a chi almeno una
decisione in senso lato morale l’abbia già presa e dunque «voglia mettersi d’accordo con un
destinatario circa qualcosa nel mondo»25.
22
Cfr. N. Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino 1979, p. 189 e Giusnaturalismo e positivismo giuridico,
Edizioni di Comunità, Milano 1965, p. 146.
23
N. Irti, Nichilismo giuridico, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 144-5.
24
Cfr. rispettivamente L. Wittgenstein, Tractatus 6.52 e J.M. Keynes, Esortazioni e profezie, il Saggiatore, Milano
1968, pp. 272-7.
25
Cfr. J. Habermas, Fatti e norme, cit., pp. 11-2 e Etica del discorso, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 74-5.
6
A ciò si aggiunge il sempre più deciso ribilanciamento dell’altro elemento tipicamente
kantiano della libertà come auto-nomia (c’è libertà perché c’è la sua legge). Nella tradizionale
dialettica fra la libertà di (l’arbitrio del fare o non fare a proprio piacimento) e la libertà per non
appare più possibile rimuovere l’idea che il suo potere costitutivo si manifesta essenzialmente come
apertura di un orizzonte e che, di conseguenza, il pluralismo dei principi non può essere liquidato
come proiezione di una volontà ancora imperfetta e ne è al contrario l’espressione fondamentale.
Questa accentuazione, peraltro, non è completamente estranea neppure a Kant. La legge morale, per
diventare operativa, deve essere scelta come massima e nel saggio sul male radicale questo poter
essere sempre altrimenti si giustificherà sullo sfondo di una vera e propria indeterminatezza
ontologica. Il fondamento oggettivo delle massime non può non restare impenetrabile ed è in tal
senso che va intesa l’ipotesi che l’uomo possa non essere per natura né buono né cattivo o anche
«buono e cattivo contemporaneamente: in parte buono e in parte cattivo»26. La libertà non è tale
perché risolve un’opposizione (soggettivo e oggettivo, ragione e istinti, cultura e natura), ma
appunto perché, in primo luogo, la costituisce. Si può rileggere questa conclusione, forse un po’
provocatoriamente, nel linguaggio del mind-body problem. Il 19 aprile del 2007 «Nature» ha
pubblicato un articolo che illustra i risultati di una ricerca su un particolare tipo di lesione, che
interessa l’area cerebrale coinvolta nella produzione delle emozioni e in particolare di quelle
caratterizzate socialmente. Ebbene: la ricerca dimostra che la presenza di questa lesione «aumenta i
giudizi morali utilitaristici» e che, di fronte al classico dilemma del carrello impazzito che ucciderà
cinque uomini e può essere fermato solo sacrificando un innocente, questi pazienti scelgono senza
esitazioni di buttare quest’ultimo dal ponte. Lasciamo da parte la questione neoriduzionista e
restiamo pure in attesa della scoperta di un’analoga lesione nel cervello dello zelatore ad oltranza
della deontologia. L’idea che sembra in ogni caso imporsi è che un centro morale dell’uomo
potrebbe essere ritagliato solo per sottrazione di questo o quello fra i diversi fattori che
codeterminano il giudizio finale su quel che si deve o non si deve fare. La decisione è
strutturalmente policentrica e solo per questo umana, anche quando si ammette che una decisione è
infine possibile. Dunque non ci si può neppure fermare alla tesi che l’unica alternativa al
relativismo delle opzioni arbitrarie sia l’accesso a «conoscenze vere e fondate in ambiti del reale
distinti da quelli delle scienze»27. L’unità in ogni caso pragmatica della concezione di sé è
comunque legata a un corpo e a un punto di vista anche sul più avanzato fronte costruttivistico della
recente Kant-Renaissance: «Quando deliberi, è come se ci fosse qualcosa oltre e al di sopra di tutti i
tuoi desideri, qualcosa che sei tu e che sceglie in base a quale desiderio agire […] Identificarsi con
tale principio o modo di scegliere significa essere “una legge a te stesso”, ed essere unificato come
tale»28.
L’etica di cui abbiamo bisogno
Ci sono diversi modi per superare il tradizionale impianto lineare-deduttivistico delle teorie
normative nella consapevolezza della necessaria circolarità fra l’universalità dei principi-leggi e i
luoghi concreti dell’etica, nella consapevolezza cioè che la diversità dei principi è l’interfaccia
dell’evidenza che essi, comunque, non bastano mai. Procedere per via kantiana può allora
significare interpretare il giudizio pratico come un giudizio non determinante, ma riflettente, quindi
obbligato a risalire dal particolare all’universale attivando sul perno del possibile una dinamica
aperta del processo di costruzione del dovere. Poggiare la proposta normativa sulla esemplarità
della scelta e dell’azione che incarnano un valore, identificare l’universale nello stesso momento in
26
I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, Laterza, Roma-Bari 1980, p. 18.
M. Lenoci, La ragione umana tra scienza e filosofia, in S. Zaninelli (ed.), Scienza, tecnica e rispetto dell’uomo, Vita
e Pensiero, Milano 2001, p. 27.
28
C.M. Korsgaard, Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit, in Creating the Kingdom
of Ends, Cambridge University Press, Cambridge 1996, pp. 369-70. Cfr. R. Mordacci, Kant-Renaissance. La riscoperta
dell’etica normativa di Kant, in I. Kant, Metafisica dei costumi, cit., pp.768-70.
27
7
cui gli attribuiamo il particolare, comporta l’abbandono della pretesa della ragion pratica di
garantire per ogni problema «una e una sola soluzione corretta» e tuttavia consolida l’intuizione di
una dimensione di autenticità dell’identità che rimane orientata dall’ideale dell’eguale rispetto e, a
sua volta, orienta ad una riconciliazione degli interessi e delle prospettive in conflitto29. Partendo
dalla centralità hegeliana dell’esperienza del riconoscimento si può puntare a soddisfare l’esigenza
di mediare il momento universale-astratto della moralità e le concrete e per questo variabili
dimensioni dell’eticità valorizzando gli elementi strutturali di quest’ultima, senza cioè accettarli
nella mera contingenza della loro configurazione storica: la fiducia in sé che nasce nell’amore, il
rispetto di sé che è reso possibile dal diritto e infine la stima di sé alimentata dalla solidarietà che
unisce una comunità di valore potrebbero indicare le condizioni di una libertà ad un tempo
sufficientemente formale e più ricca di contenuto rispetto al solo principio di autodeterminazione30.
Un’alternativa al decisionismo come nudo arbitrio può anche essere costruita attraverso un processo
di fondazione relativa, una sorta di «non relativismo comparativo» che interpreta la distinzione fra
metodo del giudizio e metodo di autorità in termini di apprendimento e dunque rimettendo in
movimento la dinamica altrimenti monologica di massima e legge, di prima e di terza persona. Se il
ruolo dell’esperienza, rispetto al principio, rimane semplicemente quello delle premesse minori di
un sillogismo, è chiaro che non si esce dall’astrattezza di un meccanismo deduttivo. Si tratterebbe
allora di mantenere la serietà e l’ambizione di verità di quel che si dichiara in prima persona,
accettando tuttavia la possibilità che appunto misurando le proprie convinzioni morali fondamentali
con una considerazione in terza persona delle loro condizioni si possa arrivare ad una loro modifica.
Fermo restando, naturalmente, che l’eventuale dimostrazione della relatività delle condizioni della
genesi di un giudizio nulla consente di concludere sulla relatività della sua validità31.
C’è però un’altra via per dire che il principio “non basta”. Non si tratta in questo caso di
valorizzare la circolarità principio/esperienza, bensì di incunearsi proprio nel presupposto di quella
di massima e legge, che è l’autonomia come capacità non tanto di darsi la propria legge quanto
piuttosto, nel senso della Selbstständigkeit, appunto di bastare a se stessi, di “stare” essenzialmente
con se stessi. Questo, come è noto, è il passo compiuto con epocale decisione nell’etica come
filosofia prima proposta da Levinas. L’autoreferenzialità del fondamento (se la legge non è assunta
come massima non esiste come legge morale) toglie sì il realismo ingenuo dell’io-sostanza, ma non
il carattere sottilmente proto-logico della onto-logia: la libertà può diventare ed effettivamente è
diventata l’ultimo nome della causa sui, tanto è vero che è proprio questo il punto d’attacco delle
nuove forme di riduzionismo. Insomma: la questione della libertà resterebbe comunque la questione
onto-logica della soggettività, rispetto alla quale Levinas, con il gesto inaudito del suo
rovesciamento in soggezione (il soggetto che non è originariamente pensiero; il soggetto che non è
originariamente il nominativo grammaticale, ma l’accusativo: me voici), punta decisamente alla
denucleazione di ogni stance, «di ogni “stanza” della pretesa sostanza»: assoluzione dalla totalità e
processo di «infinizione» (infinition)32.
Retorica di un discorso edificante? Forse no, se lo si intende come un modo per rimanere
radicalmente, pragmaticamente dentro il nuovo medium dispiegato nella svolta linguistica.
Radicalmente, perché è legittimo il sospetto che nella trasformazione della appercezione
trascendentale in sintesi della comunicazione quest’ultima continui ad essere intesa, alla resa dei
conti, come l’oggetto «reso possibile da un soggetto così è così costituito, o da più soggetti che
rappresentano l’iterazione del modello o dell’essenza del soggetto umano». Soggetto che tornerebbe
così ad essere il vero primum, coerentemente con l’istanza fondamentale della filosofia moderna:
uscire dall’aporia essere-dover essere passando progressivamente, come ho già richiamato, da una
29
Cfr. A. Ferrara, Giustizia e giudizio, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 13 e 19.
Cfr. A. Honneth, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
1994, cap. 9.
31
Cfr. E. Tugendhat, Problemi di etica, Einaudi, Torino 1987, pp. 67 sgg.
32
M.M. Olivetti, Analogia del soggetto, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 75.
30
8
normatività dell’esterno ad una normatività dell’interno33. Forse il passaggio che si deve osare,
uscendo dalla uni-versalità uni-vocante del cogito, è invece quello all’ironia del loquor. I verbi dei
fatti “essenziali” della vita dell’uomo sono deponenti: parlare, nascere (nascor), morire (morior).
Quasi a rimarcare l’impossibilità di dire la Selbstständigkeit senza riconoscere in essa la presenza,
la precedenza dell’altro e degli altri. Con una conseguenza e un problema. La conseguenza è che la
relazione fondamentale nella quale si dispiega la scena dell’etica non è la simmetria, ma l’alternanza. La temporalità non è quel che si deve ridurre per accedere al razionale-universale o ciò in cui
si dispone il materiale della premessa minore di un sillogismo, ma neppure semplicemente la
condizione di una pragmatica controfattuale messa in opera da soggetti liberi e uguali. La
temporalità “implica” il dovere nella sua dinamica generativa, che è, fra l’altro, la responsabilità per
l’«incarnazione» di tale dovere in altre persone: il loquor è l’umano di chi non c’è più e di chi non
c’è ancora. E la violenza una scelta che contraddice non un obbligo del rispetto implicito nella
regola di costruzione dell’universale, bensì l’atto costitutivo dell’io stesso.
Il problema è appunto l’universale. Per un autore come Levinas il terzo mi guarda negli
occhi dell’altro ed è questo sguardo che schiude l’umanità, quella contraddizione nel Dire dalla
quale nasce la giustizia come comparazione, coesistenza, contemporaneità, raccoglimento, ordine,
uguaglianza. Insomma: l’essenza «come sincronia: insieme in un luogo»34. Universalità e
molteplicità personale è il titolo dell’ultimo scritto di Marco Maria Olivetti. La “giustificazione”
della correlazione reciproca che mi lega all’altro uomo non viene immediatamente orientata
all’illeità come traccia della trascendenza. Il tema è, senza equivoci, l’esser lógos dell’universale.
Un lógos che si dispiega (si amplia?) rinunciando alla prepotenza cognitiva di una onto-logia
ingenua ed è dunque il léghein di una parola moltiplicante e sempre in contraddizione con se stessa,
specie quando ne va della «questione personale». Contraddizione fra moltiplicazione e raccolta: la
schiuma dell’infinità non è raccolta nella coppa hegeliana del regno degli spiriti e da essa, al
contrario, trabocca. Contraddizione fra la validità che si raggiunge per consenso unanime e quella
che si regge invece su una unione universale, che è l’unità del genere sul piano logico e l’autorità di
un’istituzione e dei suoi capi sul piano storico: la omnitudo distributiva e la omnitudo collectiva
dell’ultimo capitolo dello scritto kantiano sulla Religione. Hegel e Kant, a rimarcare che è di
filosofia che stiamo parlando.
Non si chiama a raccolta senza conflitto, senza una frattura che il diritto può sanare
restaurando l’ordine di una coercizione puramente esteriore e peraltro, significativamente, avendo
per il momento rinunciato all’idea della civitas maxima vagheggiata da Wolff. Questo non è
possibile sul piano morale. E forse non è neppure auspicabile. E allora? È proprio Kant a
riconoscere che, quando si parla di quel dovere particolare che è «del genere umano verso se
stesso», ci vuole un Altro come terzo: la comunità etica è concepibile solo come «un popolo di Dio,
retto secondo leggi della virtù»35. La seconda parte della definizione dovrebbe garantire (non senza
difficoltà) la coerenza con il presupposto dell’autonomia della ragion pratica. La prima ci ricorda
che l’intenzione rimane nascosta nel segreto dei cuori, là dove i giudici terreni non potranno mai
raggiungerla. Ma anche che il bene supremo «come bene comune a tutti» non può essere prodotto
né dal solo sforzo del singolo né attraverso la mediazione politica degli interessi. Per questo apre ad
una legge che diventando massima non cessa di essere Faktum. Una fuga metafisica, che si
potrebbe cercare di puntellare rileggendo per esempio con Hermann Cohen la connessione storica
fra monoteismo e idea di umanità, oltre ogni vincolo di appartenenza e separazione nella prossimità
della relazione io-tu? Forse. Un’indicazione metodologica a tenere la contraddizione senza violenza
e dunque intendendo il “principio” come un orientamento indefinitamente inclusivo e progressivo?
Certamente. Ma anche, probabilmente, l’apertura ad una diversa dimensione del giudizio morale,
che è universale non in quanto determinante e neppure in quanto riflettente, perché non lascia in
armonia e in pace con se stessi e talvolta nemmeno con gli altri. Un giudizio profetico, allora, che
33
Ivi, pp. 100-2.
E. Levinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 1983, pp. 196-7.
35
I. Kant, La religione…, cit., p. 106.
34
9
evoca una certezza diversa da quella delle idee chiare e distinte e che non può dismettere il dubbio
come si fa con la scala a pioli usata per salire sul tetto (anche perché non si vive sui tetti). È sempre
possibile fare altrimenti. E la comunità etica serve alla filosofia per non dimenticare la domanda su
quel che «non posso non sperare»36.
36
M.M. Olivetti, Universalità e molteplicità personale, in F. Botturi e F. Totaro (edd.), Universalismo ed etica
pubblica, Vita e Pensiero, Milano 2006, p. 34.
10