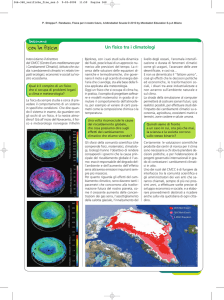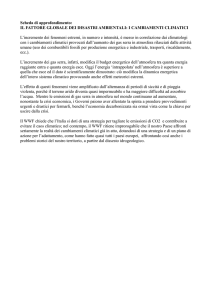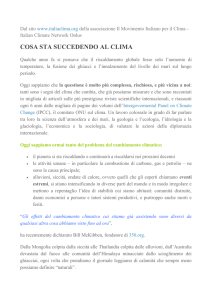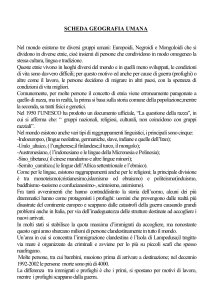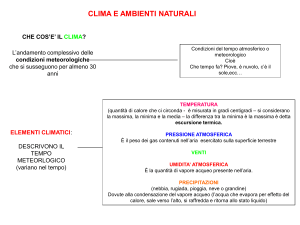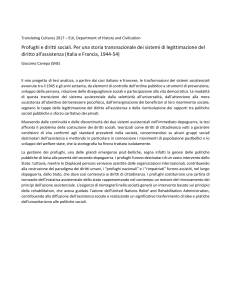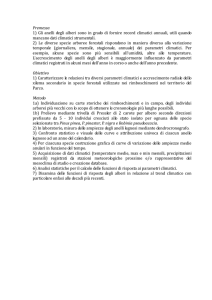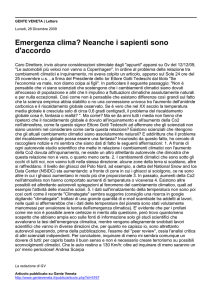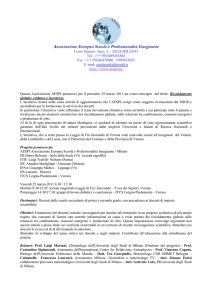DOSSIER 2010
Profughi ambientali
A cura di Luciana Delfini, Laura Genga, Lorenzo Grassi e Maurizio Gubbiotti
Cinquanta milioni di esuli
In fuga per il clima una popolazione pari a quella dell’Italia
S
econdo le ultime stime, il numero dei profughi ambientali nel mondo quest’anno
supererà di slancio la soglia dei 50 milioni
(nel 1990 erano la metà). Una quantità pari
all’intera popolazione italiana costretta all’esodo
forzato in conseguenza dei catastrofici cambiamenti climatici: inquinamento e riscaldamento
globale, desertificazione e siccità, scioglimento
dei ghiacciai e crescita dei livelli del mare,
eventi meteorologici estremi come alluvioni e
uragani, sino alle guerre per il controllo delle
materie prime. Senza contare i 192 milioni di
persone che non vivono nella loro terra di nascita, pari al 3% della popolazione mondiale.
Ma le prospettive sono ancora più inquietanti,
considerato che sia l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che
l’International Organization for Migration (IOM)
hanno previsto che entro il 2050 si raggiungeranno i 200/250 milioni di persone coinvolte
(una ogni 45 nel mondo), con una media di 6
milioni di uomini e donne costretti ogni anno a
lasciare i propri territori (un numero che equivale al doppio degli abitanti di Roma). A questi si
aggiungono i tanti sfollati per decisioni che
impongono la costruzione di dighe o impianti
industriali che comportano la distruzione di centri urbani o dei terreni e degli ambienti di vita e
lavoro. Così il degrado economico e politico
rischia di innescare un circolo vizioso.
Lo spostamento di popolazioni dovuto al degrado dell’ecosistema e alle variazioni del clima è
un fenomeno che si ripete da sempre nella storia dell’umanità. A differenza del passato, però,
la modificazione dell’ambiente ad opera dell’uomo è oggi così rapida e di tale forza da risultare
imprevedibile, come dimostrano i sempre più
frequenti disastri naturali. Il Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia (UNICEF), in un suo recente
rapporto, ha evidenziato come negli ultimi
decenni il numero e la gravità di questi disastri
siano aumentati in modo significativo. Tra il
2005 e il 2007, l’agenzia dell’ONU ha risposto a
una media annua di 276 emergenze in 92
Paesi, oltre la metà delle quali causate da calamità, il 30% da conflitti e il 19% da emergenze
sanitarie. Inoltre, stando ai dati dell’ultimo rapporto sullo sviluppo umano dell’United Nations
Development Programme (UNDP), il
Programma ONU per lo Sviluppo, oggi vi sono
344 milioni di persone a rischio per i cicloni tropicali, 521 milioni minacciate dalle inondazioni e
130 milioni dalla siccità. Oltre a vittime e sfollati,
inoltre, le calamità - che spesso colpiscono aree
già povere - si lasciano dietro uno strascico
fatto di potenziali epidemie e aumento del
rischio fame. Se fino a qualche anno fa erano le
guerre la principale causa delle emigrazioni di
massa, oggi il riscaldamento globale rappresenta un fattore predominante (nel 2008 ben 20
I numeri
250 milioni
276
192 milioni
344 milioni
È la stima delle persone che nel 2050
si vedranno costrette a lasciare i propri
territori resi ormai invivibili dagli effetti
dei cambiamenti del clima
Sono le persone che attualmente non
vivono nella loro terra di nascita (pari
al 3% dell’intera popolazione mondiale)
milioni di persone sono state costrette a spostarsi temporaneamente o definitivamente in
seguito a eventi meteorologici estremi, contro i
4,6 milioni di profughi creati da guerre e violenze). Ormai il numero dei profughi ambientali ha
superato quello dei profughi di guerra. Ciò
nonostante, queste persone non esistono da un
punto di vista giuridico, non essendo stati riconosciuti come “rifugiati” dalla Convenzione di
Ginevra del 1951, né dal suo Protocollo supplementare del 1967. Oltre alla necessità di uno
status giuridico per i profughi ambientali, la vera
urgenza è quella di far comprendere che molte
questioni legate all’ospitalità e all’accoglienza
nei nostri Paesi devono in primo luogo essere
affrontate attraverso un serio impegno collettivo
nella lotta ai cambiamenti climatici.
Misure ancor più necessarie se si pensa che, al
di là delle prospettive future, gli effetti del riscaldamento globale sono già una drammatica realtà in molti Paesi, che pagano un prezzo alto per
vittime e sfollati. All’inizio del 2009, ad esempio,
piogge torrenziali hanno inondato buona parte
dell’Africa Australe, colpendo quasi un milione e
mezzo di persone e provocando 150 mila sfollati. L’emergenza è stata particolarmente grave in
Angola e Namibia, dove migliaia di persone si
sono dovute confrontare con la distruzione dei
raccolti e una persistente insufficienza di cibo.
In Myanmar (ex Birmania) il ciclone Nargis nel
maggio 2008 ha fatto 140 mila vittime, colpendo
anche altri 2-3 milioni di persone e costringendo
800 mila persone a sfollare. Ancora tutto da
valutare, infine, l’impatto devastante che potrà
avere anche sulla popolazione l’enorme sversamento di petrolio in atto nel Golfo del Messico.
Sono state in media le emergenze alle
quali ogni anno ha dovuto far fronte
l’UNICEF tra il 2005 e il 2007 in 92 Paesi,
oltre la metà causate da calamità
Sono le persone a rischio per i cicloni
tropicali, altre 521 milioni di persone
sono invece minacciate da inondazioni
Se la Puglia diventa
un grande deserto
Il fenomeno dei profughi ambientali
deve portare a considerare l’Italia non
solo come Paese di destinazione, ma
anche come possibile punto di partenza. La nostra penisola, infatti, ha già
iniziato a scontare gli effetti del riscaldamento globale in quanto area mondiale “a più alta vulnerabilità in termini
di perdita di zone umide e in particolare degli ecosistemi e della biodiversità
marino-costiera”. Si stima che saranno
sommersi circa 4.500 chilometri quadrati del territorio.
A preoccupare è anche la progressiva
desertificazione. L’Italia infatti, negli
ultimi 20 anni, ha visto triplicare l’inaridimento del suolo e si stima che il 27
per cento del territorio nazionale
rischia di trasformarsi in deserto. Sono
interessate soprattutto le regioni meridionali, dove l'avanzata del fenomeno
rappresenta già da un decennio una
vera e propria emergenza ambientale.
La Puglia è la regione più esposta con
il 60% della sua superficie, seguita da
Basilicata (54%), Sicilia (47%) e
Sardegna (31%). Ma sono a rischio
anche le piccole isole.
Il volto umano
del Global Warming
Dalle aree più vulnerabili tentativi di multilateralismo
L
a presenza a Copenhagen di Paesi fino a
poco tempo fa considerati marginali, “periferia del mondo” - come il piccolo Stato
insulare di Tuvalu o i Paesi africani del G77 - e
la loro partecipazione come protagonisti a pieno
titolo ai lavori del vertice, ha fatto irrompere
sulla scena politica mondiale l’emergenza dei
profughi ambientali con una forza nuova. E da
questo inedito protagonismo può venire anche
una innovazione nei rapporti internazionali.
Nonostante venticinque anni fa l’allora direttore
dell’UNEP, Essan El-Hinnawi, avesse già definito i profughi del clima “persone che hanno
dovuto forzatamente abbandonare le loro abitazioni per necessità temporanee o permanenti a
causa di grandi sconvolgimenti ambientali
(naturali e/o indotti dall’uomo), che hanno
messo in pericolo la loro esistenza, o danneggiato seriamente la loro qualità di vita”, ai
migranti ambientali ancora non è riconosciuto lo
status giuridico di ‘rifugiati’. Oggi una tale mancanza non è realisticamente più tollerabile.
Senza il riconoscimento giuridico, infatti, milioni
di persone si vedono privare non solo del diritto
di chiedere asilo, ma anche degli aiuti internazionali connessi allo status di rifugiato.
Fra i Paesi individuati come i più vulnerabili ai
cambiamenti climatici ci sono le isole e quelli
con una consistente quota di popolazione
costiera. Le vittime designate dell’innalzamento
dei livelli del mare sono dunque il Bangladesh, i
Paesi Bassi e molte piccole isole dell’Oceano
Pacifico. Già ora i duemila abitanti delle Isole
Carteret, arcipelago della Papua Nuova Guinea,
e i centomila della Repubblica di Kiribati, combattono quotidianamente contro l’avanzata dell’oceano. A rischio anche le Maldive, che a
causa dell’innalzamento dei mari si vedranno
sommergere circa l’85 per cento dell’isola principale e gran parte dell’arcipelago, costringendo
300 mila persone a cercare rifugio altrove.
Sempre per l’innalzamento dei mari l’Africa
potrebbe essere inondata per quasi tre milioni
di ettari, mentre il solo Egitto vedrà diminuito il
suo territorio di circa due milioni di ettari nel
delta del Nilo, evento che costringerà all’esodo
forzato ben otto milioni di persone, compresa la
popolazione di Alessandria. Per quando riguarda l’America del Sud, invece, lo Stato più a
rischio sarebbe la Guyana, da dove potrebbero
arrivare altri 600 mila profughi ambientali.
Poi ci sono le stime legate al rischio delle inondazioni. Uno dei casi più drammatici si è avuto
a inizio 2009 in Namibia. A marzo dello scorso
anno l’ONU contava oltre 350 mila persone colpite dalle inondazioni in quel Paese. Tanto che
il portavoce dell’Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA), Ufficio di coordinamento degli Affari umanitari delle Nazioni
Unite, Elizabeth Byrs, aveva lanciato da
Ginevra l’allarme per la loro sicurezza alimentare. Le inondazioni hanno infatti danneggiato
oltre la metà delle strade e messo a rischio
circa il 63% dei raccolti. Per questo, l’ONU stimava che circa mezzo milione di persone
potesse trovarsi rapidamente in condizioni di
insicurezza alimentare. Una previsione molto
grave anche in prospettiva. Secondo la Byrs,
infatti, “544 mila persone potrebbero essere colpite da insicurezza alimentare tra il 2009 e il
2010”. Come se non bastasse, nella vicina
Angola, l’OCHA stimava altre 160 mila persone
colpite da inondazioni.
Significativa anche la situazione del Brasile, che
tra aprile e giugno 2009 ha vissuto due drammi
contrapposti: mentre il Sud del Paese attraversa la peggiore ondata di siccità degli ultimi 80
anni, il Nord e il Nord-Est sono stati colpiti da
violente inondazioni. Il Rio delle Amazzoni, ad
esempio, ha superato il maggior livello di piena
mai registrato nella sua storia conosciuta: 30
metri al di sopra del livello normale. Nel suo ultimo rapporto, l’IPCC ha indicato tra le aree che
subiranno maggiormente gli effetti del cambiamento anche il Vietnam, che potrebbe perdere
500 mila ettari di terra nel delta del fiume Rosso
e altri due milioni nel delta del Mekong, costringendo dieci milioni di persone a spostarsi.
Fenomeni meteorologici estremi come i cicloni
e gli uragani - eventi che la “febbre” del pianeta
rende sempre più frequenti - non sono da
meno. Per convincersene basta scorrere le
classifiche del Munich Re e ricordarsi che nei
ricchi Stati Uniti “Katrina” ha costretto a lasciare
le proprie case quasi un milione di persone.
Negli ultimi tempi dalle aree più vulnerabili al
climate change sono iniziate ad arrivare delle
proposte di soluzioni “tampone” al problema dei
migranti ambientali. In attesa che venga finalmente e giuridicamente riconosciuto lo status di
rifugiato ambientale questi tentativi - che certamente non rappresentano la soluzione organica
e definitiva al problema - hanno comunque il
merito di tenere alta l’attenzione dell’opinione
pubblica e dei decisori politici internazionali su
un’emergenza pericolosamente sottovalutata
che coinvolge milioni di persone nel mondo.
Non solo. Arrivando spesso e volentieri da piccoli Stati, questi tentativi di approccio concreto
al problema rappresentano anche un importante
e innovativo spazio di multilateralismo in seno
alla politica internazionale.
Cochabamba rilancia
la Giustizia Climatica
Dalla dichiarazione finale della Conferenza
dei Popoli sul Cambiamento Climatico e i
Diritti della Madre Terra.
22 aprile 2010 - Cochabamba, Bolivia
Considerando la mancanza di volontà politica
dei Paesi sviluppati di soddisfare in maniera
effettiva i loro obblichi e impegni assunti nell’ambito della Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico e il
Protocollo di Kyoto, e a fronte della mancanza
di un organo giuridico internazionale che prevenga e sanzioni tutti i delitti e crimini climatici e ambientali che attentano ai diritti della
Madre Tierra e dell’umanità, chiediamo la
creazione di un Tribunale Internazionale di
Giustizia Climatica e Ambientale che abbia la
capacità giuridica vincolante di prevenire, perseguire e punire gli Stati, le Imprese e persone che per azione o omissione contaminano e
provocano il cambiamento climatico.
Tuvalu, le piccole isole
e l’impari lotta degli Inuit
Tre esempi che tengono alta l’attenzione sul tema
Q
uelli che seguono sono i dettagli di tre
esempi che negli ultimi tempi hanno
riportato all’attenzione degli organismi
internazionali e dell’opinione pubblica mondiale
il problema dei profughi ambientali.
Tuvalu
Questo piccolo arcipelago dell’Oceano Pacifico
(circa 11.000 abitanti) ha da tempo avviato
negoziati separati con i governi di Australia e
Nuova Zelanda, i quali hanno sistematicamente
negato la possibilità di considerare ufficialmente
i migranti tuvaliani come “rifugiati ambientali”.
Ma le autorità di Aukland hanno comunque
accettato di concedere ogni anno la residenza a
75 cittadini tuvaliani all’interno della cosiddetta
Pacific Access Category (PAC). Entrata in vigore nel 2002, per il governo neozelandese la
PAC “non è una politica di accoglienza dei profughi ambientali”, ma una semplice politica
migratoria destinata ai lavoratori provenienti dai
Paesi limitrofi. Tuttavia attraverso questo strumento Tuvalu ha trovato un canale di migrazione fondamentale per i propri cittadini che nei
prossimi anni si vedranno costretti alla fuga in
conseguenza dei cambiamenti climatici.
Pacific Small Island
Gli Stati delle piccole isole in Via di sviluppo del
Pacifico (Pacific Small Island Developing
States) hanno optato per una via più “istituzionale”. I PSIDS, infatti, hanno mantenuto alta
l’attenzione della politica internazionale sul problema dei mutamenti climatici e dei loro effetti,
migranti innanzitutto, ponendo il problema alle
stesse Nazioni Unite. Nell’agosto 2008, ad
esempio, questi piccoli Stati hanno portato
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a
New York, una bozza di risoluzione intitolata
The threat of climate change to international
peace and security, la minaccia del mutamento
climatico alla pace e alla sicurezza internazionale. Sostenuto anche da Canada, Filippine,
Seychelles e Maldive, il documento chiedeva
all’Assemblea di portare all’attenzione del
Consiglio di Sicurezza la questione della crisi
climatica. Pur senza nominare esplicitamente i
profughi ambientali, la bozza di risoluzione allude chiaramente ai conflitti che grandi ondate
migratorie provocate dal global warming potrebbero innescare in diverse parti del pianeta. Dal
2008 ha raccolto anche l’adesione di Australia,
Nuova Zelanda e dei Ventisette membri UE.
Inuit contro Stati Uniti d’America
Nonostante la sproporzione nei rapporti di
forza, gli eschimesi di Canada, Alaska,
Groenlandia e Russia hanno deciso di citare in
giudizio gli USA. Una denuncia per lesione dei
loro diritti umani è stata presentata all’Inter
American Commission for Human Rights
(IACHR). Nel 2005 l’Inuit Circumpolar
Conference (ICC), una ONG rappresentativa di
circa 155 mila eschimesi delle regioni artiche,
ha presentato una petizione all’IACHR per
denunciare la violazione dei diritti umani risultante dal cambiamento climatico provocato dalle
azioni e dalle omissioni degli Stati Uniti
d’America (fino al 2008 il Paese maggior
responsabile dell’inquinamento atmosferico e
non sottoscrittore del Protocollo di Kyoto). A
causa del global warming e dello scioglimento
dei ghiacci, infatti, gli inuit saranno costretti a
lasciare le loro terre, il loro stile di vita e i loro
mezzi di sostentamento tradizionali. L’IACHR
non ha accolto la petizione, ma nel 2007 ha
chiesto all’ICC un intervento sulla relazione tra
cambiamento climatico e diritti umani.
Tra degrado e povertà
un circolo vizioso
Europa impreparata
a migrazioni definitive
La World Bank ha stimato che un
miliardo e 400 milioni di persone si trovano già oggi nel mondo in zone ad
alta fragilità ambientale. Di queste
circa 500 milioni abitano in regioni
aride e circa 400 milioni vivono in territori ormai di scarsa qualità la cui produttività tende ad esaurirsi rapidamente. La compromessa abitabilità di certe
aree, forzando la popolazione a spostarsi, provoca ulteriore degrado e
impoverimento e innesca una competizione per l’accesso alle poche risorse
disponibili. Secondo dati forniti
dall’UNEP, il Programma Ambiente
delle Nazioni Unite, risulta che dei
circa 5 miliardi di ettari utilizzati in agricoltura in aree semi aride o in prossimità di deserti, ben il 70% circa di questi è già degradato e gran parte soggetta a desertificazione.
Secondo uno studio del German
Marshall Fund, a causa dei cambiamenti climatici Europa e Usa subiranno nuove ondate di immigrazione. La
preoccupazione della Comunità
Europea è che i flussi migratori
aumenteranno e a spostarsi saranno
le persone provenienti dagli strati più
fragili delle società, però avvisa il GMF
principalmente da Sud a Sud. Secondo
lo studio il mondo occidentale sta
ignorando il problema di tipo umanitario che potrebbe essere generato dai
nuovi flussi e i Paesi ricchi sono
impreparati a ricevere i rifugiati climatici. Si tende infatti ad affrontare le
immigrazioni con soluzioni temporanee, mentre coloro che scapperanno
dalle conseguenze ambientali derivate
dai cambiamenti climatici lo faranno in
maniera definitiva.
Il Bangladesh sull’orlo
della guerra del clima
Si innalzano muri contro chi fugge dalle inondazioni
I
l confine di filo spinato tra India e
Bangladesh, che divide prati incolti e
boschetti di tamarindi, c’era già prima dell’evidenza del cambiamento climatico, ma questo fornisce un motivo in più per rafforzarlo ed
estenderlo: sul lato della instabile barricata climatica del Bangladesh il mare sta invadendo il
delta del Gange e gli scienziati pensano che
entro la metà del secolo almeno 15 milioni di
persone dovranno essere evacuate per non
annegare nel mare che sale. L’India guarda terrorizzata a questa prospettiva, visto che è già
alle prese con un’immigrazione clandestina
inarrestabile e sta cercando di rafforzare elettronicamente e militarmente il suo poroso confine
di 2.100 miglia di reticolati con il Bangladesh.
“Il Bangladesh è il Paese che potrebbe avere
più rifugiati climatici di qualunque altro sulla
terra - sostiene Isabel Hilton, esperta ambientale di Ong britanniche che si occupa dell’Asia Questo muro ci dice che le persone che se ne
stanno andando non devono andare in India”.
La prospettiva della migrazione internazionale
di milioni di cittadini è un argomento delicato in
Bangladesh e gli esperti di sicurezza nazionale
la considerano come la peggiore conseguenza
globale dei cambiamenti climatici. Secondo gli
analisti militari, l’aumento delle temperature, la
carenza di acqua potabile e le modifiche che
subirà il territorio potrebbero portare alcune tra
le già vulnerabili comunità dell’Asia-Pacifico,
sudamericane e africane, a guerre per risorse
sempre più scarse. Nicholas Stern, il noto economista che studia le possibili conseguenze dei
cambiamenti climatici, ha avvertito che la mancata riduzione delle emissioni di gas serra può
portare ad una “estesa guerra mondiale”.
Nessuno sa ancora come e dove partirà le
prima scintilla dell’incendio innescato dai cambiamenti climatici, ma il pericolo è imminente e
rende sempre più urgente un accordo internazionale. Il focolaio potrebbe essere proprio in
Bangladesh, dove la maggior parte del territorio
è ad una quota inferiore a 20 metri sul livello
del mare, con un governo indeciso tra la necessità di lanciare l’allarme sui cambiamenti climatici e il desiderio di mettere la sordina al problema della migrazione. L’India sostiene infatti che
sul suo territorio vivono già clandestinamente 5
milioni di bangladesi, il governo di Dacca
risponde che si tratta di cifre gonfiate. La questione è una costante fonte di tensione tra le
due nazioni e i cicloni che devastano ripetutamente le aree costiere del Bangladesh non aiu-
I numeri
15 milioni
Sono le persone che dovranno essere
evacuate dalla zona del delta del Gange
per non annegare nel mare che sale
20 metri
È la quota altimetrica sul livello del mare
al di sotto della quale si trova la maggior
parte del territorio del Bangladesh
tano. Secondo Abdul Kalam Azad, senior research fellow al Bangladesh institute of
International and strategic studies, quello della
migrazione di massa è un problema ingigantito
dai media. La pensa diversamente Rabab
Fatima, rappresentante per l’Asia del Sud
dell’International Organization for Migration:
“L’insensibilità politica ha prodotto una carenza
di studi su cosa significhi il climate change per I
flussi migratori in Bangladesh. Il Paese non è
ancora preparato a capire come dovrà confrontarsi con questo agormento e l’atteggiamento
prevalente è quello di pensare che il cambiamento climatico sia un grave problema e che lo
sia anche la migrazione, ma non si mettono in
collegamento i due elementi. Temo che ciò non
accadrà culturalmente almeno sino alla prossima generazione e questo potrà creare enormi
difficoltà”. Intanto nei villaggi di frontiera ognuno
ha almeno un familiare illegalmente emigrato in
India e si parla di “clandestini” ridotti in schiavitù.
Si dibatte poi sul fatto se gli uomini e le donne
che fuggono dalle inondazioni che li hanno privati di tutto siano “rifugiati climatici” oppure,
come continua a sostenere il governo di
Dacca, normali “migranti”. Una distinzione che
non è solo accademica, visto che potrebbe
avere reali implicazioni per quanto riguarda i
bilanci nazionali, il diritto internazionale e le
politiche migratorie. “Gli altri Paesi non vogliono responsabilità per queste masse in movimento - ragiona Koko Warner, dell’ufficio
Environmental migration, social vulnerability,
and adaptation dell’università Onu di Bonn Sono tutti strenuamente sulla difensiva e questo può diventare esplosivo”.
Divario di risorse
contro la vulnerabilità
Oltre ad essere i responsabili storici
dell’inquinamento atmosferico e quindi
del mutamento climatico, i Paesi industrializzati sono quelli - per il momento
- meno esposti agli effetti del surriscaldamento del pianeta (anche se gli Stati
Uniti d’America non sono immuni a
fenomeni devastanti) e comunque
sono quelli che hanno a disposizione
le risorse più ingenti per fronteggiarne
gli effetti catastrofici. Tra le nazioni
maggiormente esposte agli effetti del
global warming ci sono il Bangladesh
e i Paesi Bassi, entrambe a rischio per
l’innalzamento dei livelli del mare e
entrambe alla prese con politiche di
adattamento. Peccato che le forze in
campo siano assolutamente diseguali.
Il Bangladesh, da parte sua, sta già
facendo molto per ridurre la vulnerabilità della popolazione, ma ovviamente
gli interventi messi in campo scontano
la ristrettezza di risorse a disposizione.
Con un reddito annuo pro-capite di
appena 450 dollari il Bangladesh sta
perfezionando un sistema di allarme
rapido ed efficace per far fronte al
rischio dei cicloni e un parallelo sistema di allertamento e previsione delle
inondazioni.
Per quanto riguarda invece il governo
olandese, ha programmato investimenti per un importo superiore ai 100 dollari pro-capite annui di qui al prossimo
secolo. Con un reddito pro-capite di
circa 45 mila dollari, l’Olanda ha avviato in questi anni un organico ed esteso
programma di delocalizzazione selettiva dalle aree più basse del suo territorio, considerato che la protezione continua si è rivelata una prospettiva assolutamente insostenibile.
Un disastro in attesa
Ignorati gli effetti delle catastrofi ambientali “lente”
C
ome ricorda l’Istituto per l’ambiente e la
sicurezza umana dell’Università delle
Nazioni Unite (Unu-Ehs), “ci sono fondati
timori che il numero di persone che fuggono da
condizioni ambientali insostenibili crescerà esponenzialmente via via che il mondo sperimenterà
gli effetti del cambiamento del clima”. Il direttore
dell’Unu-Ehs, Janos Bogardi, insiste sulla necessità che questa nuova categoria di rifugiati trovi
un posto nei trattati internazionali: “Dobbiamo
prevedere le necessità di assistenza, proprio
come per le persone che fuggono per altre
situazioni”. Ma salta agli occhi anche un’altra
discriminazione tra le persone costrette a emigrare perché il luogo dove abitavano non è più
in grado di consentire la sopravvivenza umana.
Le vittime di catastrofi naturali improvvise come l’onda di tsunami in Asia nel dicembre del
2004, o un uragano come “Katrina” - risultano
infatti ben visibili e di solito beneficiano di sostegno e aiuto umanitario pubblico e privato.
Janos Bogardi fa notare che invece non è così
per i milioni di persone costrette a sfollare da
cambiamenti ambientali più silenti e graduali: il
riscaldamento globale, ad esempio, o catastrofi
“lente” come la desertificazione, la diminuzione
delle riserve idriche o l’innalzamento del livello
del mare. Basta ricordarsi che Marocco, Tunisia
e Libia perdono ciascuno oltre 1.000 chilometri
quadrati di terra produttiva ogni anno a causa
della desertificazione, o che in Egitto metà della
terra arabile irrigata soffre di salinizzazione e in
Turchia 160 mila chilometri quadrati di terra
agricola subiscono l’effetto dell’erosione.
La perdita di terre coltivabili non potrà che spingere la popolazione agricola a emigrare: su
altre terre limitrofe, se ve ne saranno a disposizione, o più probabilmente in città, o all’estero.
Per capire la gravità della situazione si può
sommare la desertificazione e l’erosione dei
suoli all’innalzamento dei livelli del mare e
all’erosione delle coste, come in Louisiana (che
perde circa 65 chilometri quadrati l’anno di
costa “mangiata” dal mare) o come in Alaska
(dove centinaia di piccoli centri abitati sulle
coste settentrionali sono sul punto di franare nel
mare Artico via via che il permafrost si scioglie).
Si combini tutto questo alla frequenza crescente
di uragani disastrosi. Il risultato, dice l’istituto
dell’ONU, è “un disastro in attesa”, che creerà
ripetute e massicce ondate di migrazioni. Il
numero di persone costrette a muoversi per
ragioni legate all’ambiente potrebbe presto
superare quelle che lo stesso ONU chiama
“persone di cui preoccuparsi”: rifugiati e sfollati
all’interno del proprio Paese a causa di conflitti,
richiedenti asilo, apolidi, in tutto oltre 19 milioni
di persone. Secondo la Croce Rossa e la
Mezzaluna Rossa, già oggi ci sono più persone
sfollate da disastri ambientali che dalle guerre.
Cancun: ultima chiamata
Dopo l’assordante silenzio di Kyoto e Copenhagen
A
perto sotto gli auspici positivi di una sintonia ritrovata sui temi di ambiente, green
economy, energie pulite e febbre del pianeta, tra gli USA dell’era Obama e l’UE, il 2009
è stato un anno di grande attesa e preparativi
finalizzati al buon esito della quindicesima
Conferenza delle Parti sul Clima. Sia per la politica istituzionale, che si è preparata all’appuntamento di Copenhagen con un denso calendario
di vertici tematici, sia per la politica di “movimento”, che ha impegnato la società civile internazionale in un altrettanto ricco elenco di forum
e manifestazioni distribuiti su entrambi gli emisferi del globo. Ma la politica istituzionale,
spiazzata anche dal nuovo protagonismo di
Paesi prima non molto influenti sul fronte internazionale - Paesi del BASIC, Paesi emergenti e
Stati insulari del Pacifico - non ha saputo dare
risposte adeguate a quanti, in tutto il mondo,
chiedevano che in Danimarca si chiudesse un
buon accordo, capace di dare seguito, in
meglio, al Protocollo di Kyoto.
Il generico accordo politico sul clima uscito da
Copenhagen, infatti, lascia aperti i principali
problemi sul tavolo della trattativa climatica globale e fra questi quello dei profughi ambientali.
E visto che nel frattempo la scadenza di Kyoto
(2012) si è avvicinata, per uscire dalla crisi climatica il mondo ha ancora meno tempo. Se
non si riuscirà ad adottare un accordo interna-
zionale sul clima vincolante prima della scadenza del mandato di Kyoto, per altro, tutto il complesso sistema dei vincoli, dei controlli internazionali, dei commerci di quote di emissione e
dei programmi di assistenza tecnologica ai
Paesi in via di Sviluppo previsto dal pur imperfetto protocollo sottoscritto nel 1997, rischia di
saltare interrompendo drammaticamente i processi di riduzione delle emissioni.
Il mondo è quasi fuori tempo massimo, ma per
correre ai ripari sono ancora disponibili gli
appuntamenti della conferenza tecnica
dell’UNFCCC di Bonn (giugno 2010), che
dovrebbe rimettere in moto il processo di definizione di un accordo climatico globale, e soprattutto la COP16 di Cancun prevista per dicembre
2010. Se in tale occasione non sarà adottato il
Post Kyoto, le conseguenze saranno drammatiche e si potrà considerare davvero chiuso il
processo avviato nel 1997 con il Protocollo
Kyoto. Così, a poca distanza dalla chiusura di
Copenhagen, è stato lo stesso Segretario esecutivo della Convenzione ONU sui cambiamenti
climatici, Ivo de Boer, a sottolineare la necessità
di chiudere l’anno con un trattato, dichiarando
che proprio quanto accaduto alla COP15
“rende soltanto il compito più urgente” per il
mondo che deve affrontare i cambiamenti climatici. Nel lungo termine, infatti, l’unico obiettivo che può garantire una certa sicurezza al pia-
neta è un taglio dell’80 per cento almeno entro
il 2050 dei gas serra. Tuttavia è nel breve periodo che si gioca la battaglia più importante: nel
2020 le emissioni che alterano il clima dovranno
essere state già considerevolmente diminuite, a
cominciare ovviamente dai Paesi che hanno
inquinato di più. In ragione della loro maggiore
responsabilità storica sull’effetto serra, i Paesi
industrializzati sono chiamati ad agire per primi,
siglando un duplice impegno: ridurre sostanzialmente entro il 2020 i gas serra (almeno del 40
per cento) e finanziare con risorse adeguate la
mitigazione e l’adattamento ai mutamenti climatici (almeno i 30 miliardi promessi per il prossimo triennio per arrivare entro il 2020 a decine di
miliardi di euro).
Qualche segnale positivo, lo scorso marzo, è
arrivato dalla cosiddetta “Dichiarazione di Nusa
Dua”, a Bali. Nell’isola indonesiana, infatti, si è
riunita l’undicesima Special session del governing council and global ministerial environment
forum UNEP - la sessione speciale del forum
composto dal consiglio direttivo e dalla plenaria
ministeriale dell’UNEP - meeting in cui i ministri
dell’Ambiente di mezzo mondo hanno dichiarato
che intensificheranno la loro cooperazione in
fatto di lotta al mutamento climatico e di protezione dell’ambiente. Ancora, la “Dichiarazione di
Nusa Dua”, ha evidenziato anche l’importanza
della biodiversità, i vantaggi che si avrebbero
dalla progressiva trasformazione dell’economia
in una sistema a basso tenore di carbonio e il
comune impegno ad adoperarsi per un esito
positivo della COP16. Nonostante quella di
Nusa Dua sia una solo una dichiarazione di
intenti, sancisce principi importanti ed è la prima
dichiarazione di così alto livello sottoscritta dai
ministri dell’Ambiente di 130 Paesi dopo quella
del 2000 a Malmöe. Non a caso il direttore esecutivo dell’UNEP, Achim Steiner, ha espresso
viva soddisfazione: “Poco più di un mese dopo
la Conferenza di Copenhagen, i ministri
dell’Ambiente hanno parlato con una sola voce,
chiara ed inequivocabile”, aggiungendo che “di
fronte al continuo degrado dell’ambiente e alle
sfide del cambiamento climatico, l’immobilismo
non è un’opzione”.
A maggiore garanzia del raggiungimento di un
buon accordo sul clima, inoltre, è importante
anche la cornice nella quale l’accordo stesso
sarà definito. In un mondo interdipendente, in
cui l’alto grado di dipendenza reciproca è reso
sempre più evidente proprio dalla crisi climatica,
infatti, fermare la febbre del pianeta ha possibilità di successo solo se gli obiettivi e gli interventi
da mettere in campo sono globalmente condivi-
si. A quanti, come l’ex leader britannico Gordon
Brown, dopo Copenhagen hanno iniziato a
sostenere l’idea che i termini dell’accordo vadano fissati in meeting ristretti stile G8, G20 o G2,
bisogna invece ribadire con fermezza che la
definizione del Post Kyoto deve necessariamente passare per un processo multilaterale e
democratico. Ossia in ambito ONU e UNFCCC.
I problemi sul tavolo delle trattative
Copenaghen ha portato il cambiamento climatico al più alto livello di governo, l’agreement
riflette inoltre un consenso politico sul lungo termine circa la necessità di rispondere con una
riduzione drastica delle emissioni ai cambiamenti climatici. In Danimarca è emersa anche
l’indiscutibile necessità che i Paesi industrializzati finanzino il Fondo di adattamento ai mutamenti climatici, ma le cifre messe a disposizione
sono al momento assolutamente insufficienti. E
non è stato sostanzialmente messo in discussione il modello di sviluppo e lo stile di vita “usa
e getta” che ha portato il mondo sulla soglia del
baratro. In buona sostanza, a eccezione della
dichiarazione d’intenti globalmente condivisa di
contenere il surriscaldamento del pianeta entro i
2° C, all’indomani della COP15 la crisi climatica pone al mondo gli stessi problemi irrisolti che
erano usciti da Poznan, a dicembre del 2008.
Equità e giustizia sociale
Come evidenziato dalla quindicesima
Conferenza delle Parti, il nuovo accordo internazione sul Clima non potrà eludere i temi dell’equità e della giustizia sociale. Se a livello
scientifico è acclarato che i Paesi in via di
Sviluppo, storicamente responsabili per una
quota assolutamente minoritaria dell’inquinamento atmosferico, sono quelli che subiscono le
maggiori conseguenza dei cambiamenti climatici, grazie alle proteste e alle posizioni assunte
da Paesi Emergenti e G77 al vertice danese è
ormai chiaro anche politicamente che, senza
garantire l’accesso a energia, tecnologie pulite
e crescita economica a tutti i cittadini del
mondo, non passerà alcun accordo.
Profughi ambientali
È uno dei temi che sta entrando nell’agenda
politica internazionale e nella coscienza di fette
sempre maggiori di opinione pubblica e società
civile globale. I profughi ambientali, milioni di
persone costrette a lasciare le proprie case da
inondazioni, desertificazioni, o fenomeni climatici estremi, sono le principali vittime del mutamento climatico. Tuttavia il problema non veniva
affrontato in ambito di Kyoto e neanche l’agreement di Copenhagen ha affrontato la questione.
Di più, siamo in una fase in cui non ci si può
aspettare altro che una recrudescenza della
crisi. La soluzione del problema passerà per il
riconoscimento del diritto dei migranti ambientali
a godere del sistema di protezione internazionale accordato a profughi e richiedenti asilo.
E se pure è evidente che il cammino per il riconoscimento dello status di rifugiati ambientali ai
migranti del clima sarà lungo, è altrettanto evidente che le basi per raggiunge tale obiettivo ci
sono. Anche a livello di giurisdizione internazionale. Nel momento in cui il Protocollo di Kyoto
ha riconosciuto il nesso tra sviluppo e mutamento climatico, ha infatti riconosciuto anche la
relazione che lega gli impatti del mutamento climatico alle migrazioni ambientali. Non a caso
da Kyoto è scaturito anche un fondo per la mitigazione e l’adattamento. Peccato che ancora il
ciclo non si stato chiuso e che l’anello debole
della catena, ossia le vittime del surriscaldamento del pianeta, sia rimasto senza adeguata
tutela. Ma con il tema caldo dei profughi
ambientali, dovrebbe misurarsi il costruendo
trattato sul clima. Di fronte alla prospettiva di
240 milioni di profughi ambientali al 2050, inoltre, affrontare la questione assume anche un
carattere strategico per sicurezza globale. Ecco
perché, seppur con tempi lunghi ed elefantiaci,
il tema non potrà restare senza risposte.
Fondo di adattamento
Dai piccoli Stati insulari del Pacifico e
dell’Oceano Indiano, che rischiano in un futuro
prossimo di essere sommersi a causa dell’innalzamento del livello del mare, agli Stati africani
resi sempre più vulnerabili da siccità e desertificazione, ai Paesi costieri esposti sia ai cicloni
che all’innalzamento dei mari, le aree in cui è
necessario intervenire con urgenza sono molteplici. Come sancito dal Protocollo di Kyoto questo intervento dovrà essere finanziato con fondi
adeguati e in misura crescente dai Paesi industrializzati, in ragione della loro maggiore
responsabilità nell’effetto serra. Che provengano da fondi fast o meno, inoltre, è necessario
rendere i finanziamenti per l’adattamento obbligatori, e non volontari come sono tuttora.
Egualmente necessaria, anche la trasparenza
nella gestione di tali fondi.
Green economy e sviluppo sostenibile
Sul banco degli imputati come principale
responsabile del global warming c’è il modello
di sviluppo dominante, basato su fonti fossili e
consumi in crescita continua. Arginare la febbre
del pianeta e intervenire alle radici del problema, significa quindi promuovere lo sviluppo e la
diffusione di un modello di produzione energetica e industriale virtuoso, fondato sull’implementazione delle fonti rinnovabili, del risparmio
e dell’efficienza energetici. La premessa dello
sviluppo e del benessere economico, inoltre,
non può più essere riassunta nella formula
magica di consumi in crescita continua, ma
deve fondarsi su prospettive ecosostenibili.
Fermare deforestazione
e agricoltura intensiva
Uno degli imperativi cui deve rispondere il futuro trattato sul clima è il blocco della deforestazione che, insieme ai cambiamenti nell’uso dei
suoli e all’agricoltura, rappresenta secondo dati
IPCC del 2007 il 30,9% delle emissioni globali
(IPCC 2007b). Rimasti indefiniti dopo Poznan, a
Copenhagen non hanno avuto sorte migliore e
restano tuttora nel limbo i meccanismi e la normativa internazionale che dovranno garantire
l’arresto della deforestazione.
Il Dipartimento Internazionale di Legambiente
si occupa dei profughi ambientali dal 2005,
in collaborazione con docenti universitari,
centri di ricerca e giornalisti. Per mantenere
alto il livello di attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su questo tema di primaria importanza, il Dipartimento ha partecipato
in questi anni a numerosi convegni, seminari
e dibattiti nazionali e internazionali. Ha inoltre
realizzato periodicamente un Dossier.
Questo Dossier è aggiornato a maggio 2010
Legambiente
Dipartimento Internazionale
Via Salaria, 403 - 00199 Roma (Italia)
Tel. +39 0686268362 - +39
0686268344
[email protected]
www.legambiente.it