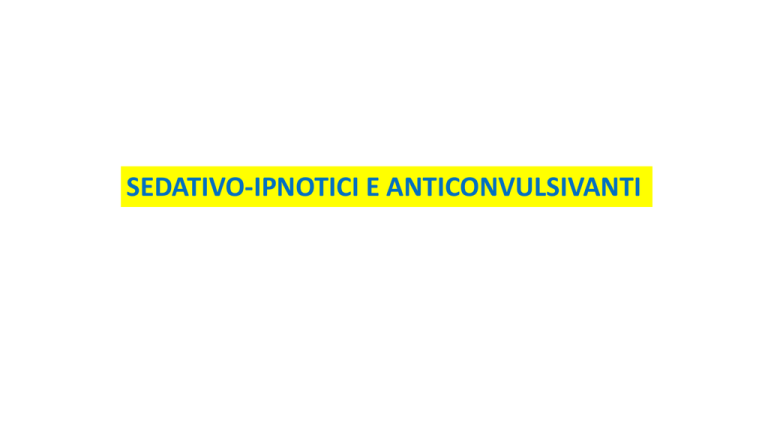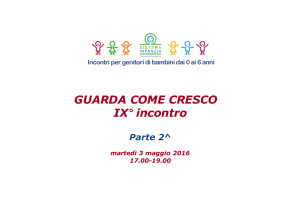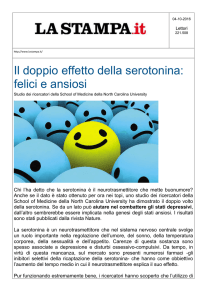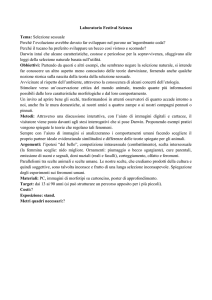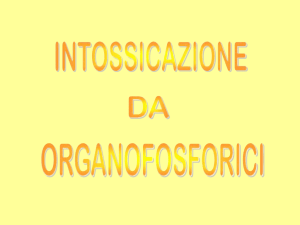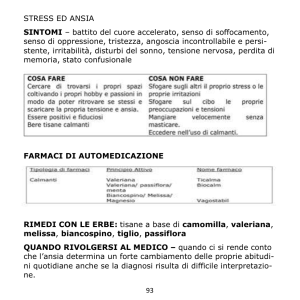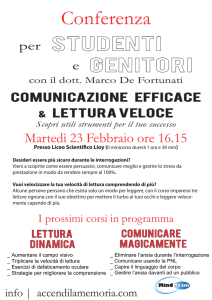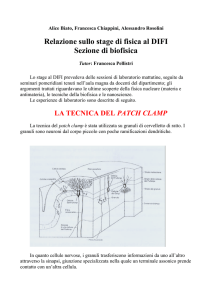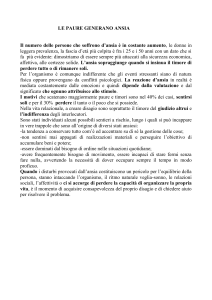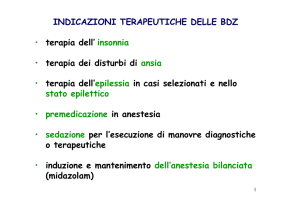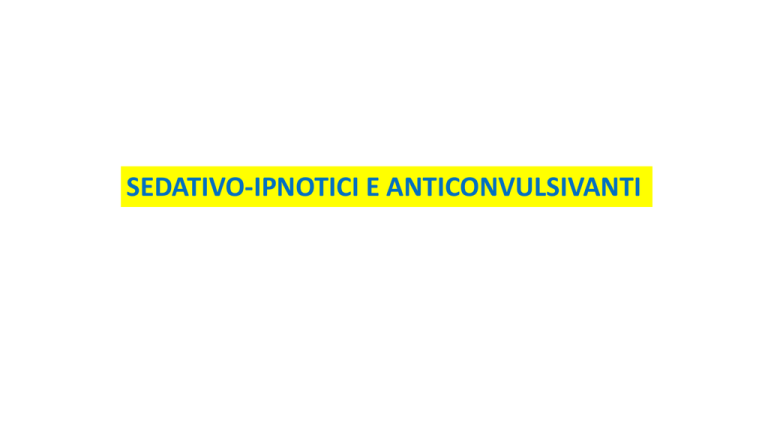
SEDATIVO-IPNOTICI E ANTICONVULSIVANTI
Sistema GABAergico
acido gamma-amino-butirrico
Attività inibitoria
Localizzazione cervello e
midollo spinale
Modulatore delle risposte del
SNC
“valium endogeno”
Due tipi di recettori:
Rec. A aumenta la permeabilità a
Cl- in entrata
Rec. B al K+ in uscita
Comuque con lo stesso risultato:
iperpolarizzazione della
membrana post-sinaptica
Il sistema gabaergico non è definibile in termini di circuiti neuronali perché è diffuso
in tutto il sistema nervoso, esercitando un’azione di sedazione sull’attività elettrica
neuronale.
I farmaci che migliorano l’azione neurotrasmettitoriale del GABA sono detti
ansiolitici.
I farmaci che, al contrario, inibiscono l’azione del GABA sono i convulsivanti.
RECETTORI GABAERGICI
GABAA: mediano l’azione inibitoria veloce (100 millsecondi).
Canale permeabile al Cl-. Si apre in seguito al legame di due
molecole di GABA. Sito di legame di Benzodiazepine e
Barbiturici.
GABAB: mediano l’inibizione lenta, accoppiati a Gi. Attivati
selettivamente da baclofen.
Nella retina i GABAA non presentano il sito di legame a
benzodiazepine e barbiturici.
Il recettore A del GABA (GABAA) è un recettore-canale, sia presinaptico che
postsinaptico, appartenente alla classe I (insieme al recettore colinergico nicotinico, al
recettore serotoninico di tipo 3 e al recettore glicinergico di tipo A), quindi è un
pentamero, costituito da subunità raggruppate in sette famiglie (alfa1-6, beta1-3, gamma13, delta, epsilon, rho e teta), che si combinano variamente; ogni subunità del pentamero
è costituita da 4 domini transmembrana ad α-elica.
Struttura chimica delle benzodiazepine
Metabolismo delle benzodiazepine.
EPILESSIA
Definizioni
Epilessia
Sindrome cronica caratterizzata dalla ricorrenza di crisi epilettiche
spontanee e ricorrenti (due o più)
Crisi epilettica
Per crisi epilettica si intende la manifestazione clinica parossistica (sintomi
motori, sensitivo/sensoriali, psichici, associati o meno a perdita di coscienza)
dovuta ad una scarica anomala, ipersincrona di una popolazione più o meno
estesa di neuroni corticali, generalmente di tipo eccitatorio che riescono a
superare la barriera dei neuroni inibitori.
A- neurone “normale”
B- neurone “epilettico”
Sintomatologia
Abbiamo un concatenarsi di eventi che possono andare da una mancanza di
attenzione a delle convulsioni tonico-cloniche.
La mancanza di attenzione può essere caratterizzata da intangibili assenze
mentre sindrome più severa è quella convulsiva (fino alle tonico-cloniche).
L’epilessia può generarsi in qualsiasi punto del sistema nervoso centrale (SNC)
tramite focus epilettogeni.
➢Se il focus coinvolge la corteccia cerebrale, fondamentale per la memoria
immediata, i movimenti, il linguaggio, la vista, l’udito, l’attivazione determina
una convulsione.
➢Se il bersaglio è l’ipotalamo le ripercussioni si avranno sul sistema autonomo
periferico, con alterazioni a livello simpatico e parasimpatico.
➢Scariche sul midollo allungato, infine, producono perdita di coscienza.
Focus diffusi a tutti e 3 questi livelli, determinano un grave quadro epilettico.
CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CRISI
EPILETTICHE
• Parziali
- Semplici
- Complesse
Secondariamente generalizzate
• Generalizzate
- Assenze
- Miocloniche
- Atoniche
- Toniche e/o cloniche
• Non classificabili
-
Tipi di Epilessie
Accessi Parziali:
interessano piccole aree del SNC, sono
limitatamente estese e spesso non determinano
contrazioni
tonico-cloniche
ma
soltanto
contrazioni muscolari involontarie con esperienze
sensoriali anomale, della durata di pochi secondi.
Accessi Generalizzati:
•Assenze (piccolo male) – caratterizzate da scariche elettriche a
breve durata, che determinano fugaci perdite di coscienza (per alcuni
secondi) senza generare convulsioni. L’effetto è una perdita di
interazione con la realtà (simile elettroshock).
•Accessi Tonico-Clonici (grande male) – caratterizzati da scariche
abnormi a tutto il SNC. Si manifestano contrazioni della muscolatura
striata di tipo tonico-cloniche, dolorose (ma non avvertite dal soggetto
che è incosciente). Si hanno ripercussioni anche sul sistema nervoso
simpatico e parasimpatico: scialorrea (bava), perdita del controllo degli
sfinteri viscerali. L’esito può essere addirittura infausto o per
soffocamento (per la chiusura dell’epiglottide dovuta alla retrazione
dell’ipoglosso) o fibrillazione (per la scarica abnorme sui recettori ß1
cardiaci).
Status epilepticus o stato di male epilettico
• Crisi epilettica che dura più di 30 minuti, oppure due o più crisi
durante un periodo di 30 minuti, senza un completo recupero
tra le crisi
• Si tratta di una grave emergenza medica, che può condurre a
ipossia, ipotensione, acidosi e ipertermia. La terapia deve
risolvere la crisi entro 60 minuti.
Focus epilettico
E’ il punto di partenza della scarica elettrica patologica (non
sempre individuabile).
L’attività elettrica anomala può poi diffondersi a tutta la
corteccia.
La diffusione (spreading) avviene quando la scarica elettrica del
focus oltrepassa la soglia per cui i neuroni circostanti vengono a
loro volta attivati (recruitment).
Possono essere reclutati:
- neuroni in aree contigue al focus
- neuroni coinvolti in circuiti associativi brevi
- neuroni appartenenti a lunghi circuiti associativi.
ORIGINI PATOLOGICHE DEL FOCUS:
➢ genetica, spesso nell’ambito di sindromi complesse
➢ traumatica
➢ flogistica
➢ neoplastica
➢ ischemica
➢ … sconosciuta
FATTORI SCATENANTI L’ATTACCO:
➢ variazioni di glicemia, pH plasmatico, equilibrio elettrolitico
➢ anossia
➢ alterazioni metaboliche o endocrine
➢ affaticamento
➢ stress
➢ carenze nutrizionali
➢ intossicazioni da farmaci o brusche sospensioni di farmaci
➢ … indeterminati
Meccanismi di epilettogenesi
Modificazioni dell’attività di canali ionici
Evidenze:
elettroshock sperimentale
modificazioni dell’equilibrio elettrolitico
canalopatie (alterazioni genetiche di canali al Na+,Ca2+,K+)
Diminuzione dei meccanismi di inibizione sinaptica
Evidenze:
pentilentetrazolo, picrotossina, bicucullina, ß-carboline
stricnina
alterazioni genetiche di subunità dei recettori GABA
Aumento dei meccanismi di eccitazione sinaptica
Evidenze:
kainato, NMDA, quisqualato
alterazioni genetiche sperimentali dei recettori o
trasportatori del glutammato
autoanticorpi anti-GluR3
ANTIEPILETTICI
Terapia dell’Epilessia
• MONOTERAPIA iniziale
• BI-POLITERAPIA successiva (2-3-4 farmaci in associazione)
Scelta del farmaco:
-TIPO DI EPILESSIA
!-INTERAZIONI: · INDUZIONE
· INIBIZIONE
· SPIAZZAMENTO
METABOLISMO –
CYP 450
AVVERTENZE :
SOSPENSIONE -> sempre alto rischio di rebound
GRAVIDANZA -> ! di teratogenicità con tutti gli antiepilettici. Importanti i
supplementi di folati e vitamina C
ALLATTAMENTO -> permesso con terapie a dosi normali (tranne barbiturici,
etosuccimide)
CARATTERISTICHE FARMACOCINETICHE COMUNI
❖ La maggior parte è attiva per os e tutti devono entrare nel SNC
❖ L’assorbimento è in genere buono (80-100 %)
❖ La maggior parte si lega in alta percentuale alle proteine
plasmatiche tranne: Fenitoina, BZD, acido valproico
❖ Sono metabolizzati principalmente dal fegato (spesso metaboliti
attivi)
❖ Frequenti interazioni con altri farmaci
❖ La maggior parte ha emivita lunga (>12 h)
Meccanismi d’azione dei farmaci antiepilettici
Blocco dei canali del Na+ voltaggio-dipendente (Carbamazepina,Fenitoina,Ac Valproico..)
Blocco dei canali Ca2+ voltaggio –dipendenti (Etosuccimide, Ac Valproico..)
Potenziamento dei sistemi inibitori GABA-mediati:
• Sinergismo allosterico con il GABA (barbiturici e benzodiazepine)
• Inibizione del riassorbimento del GABA (tiagabina)
• Inibizione della degradazione del GABA (vigabatrina)
• Aumento della liberazione del GABA (gabapentina)
Antagonismo dei recettori di aminoacidi eccitatori (Felbamato, Topiramato)
Bromuro di K e Na (non più usato in medicina umana a causa dei notevoli effetti collaterali – resta di largo impiego
nel cane e nel gatto sia in mono sia associato a fenobarbital)
- iperpolarizza le membrane neuronali (il Br penetra attraverso i canali del Cl)
- potenzia l’attività GABAergica
PSICOANALETTICI
CONVULSIVANTI E
STIMOLANTI RESPIRATORI
STIMOLANTI
PSICOMOTORI
❖ I primi sono sostanze a diversa struttura chimica, i cui meccanismi d’azione sono, per
la maggior parte, non ancora completamente chiariti e che agiscono su cervello e
midollo spinale dove determinano: ipereccitabilità dei riflessi, aumento dell’attività
dei centri respiratori e vasomotori e, a dosaggi maggiori convulsioni (scarsa attività
sulle funzioni mentali)
❖ I secondi esercitano effetti considerevoli a carico delle funzioni mentali e del
comportamento, determinando eccitazione, resistenza alla fatica ed aumento
dell’attività motoria. L’effetto dura generalmente poche ore ed è seguito da
depressione ed ansia
STIMOLANTI RESPIRATORI E CONVULSIVANTI
Impiegati per contrastare l’insufficienza respiratoria acuta
Stricnina (antagonista della glicina)
Picrotossina (blocco non competitivo
Doxapram
•
•
•
•
•
Stimola il centro della respirazione (bulbo)
Stimola i chemocettori aortici e carotidei
Efficace sulla gran parte delle specie animali
seppure con qualche differenza (suino, coniglio,
ovino e pollo risultano più resistenti)
EV, IM, SUBLINGUALE nella depressione respiratoria
indotta da barbiturici e anestetici inalatori
A dosaggi più alti di quelli terapeutici provocano:
ipertensione, convulsioni e iperventilazione
dell’azione del GABA sui canali del Cl-)
Entrambe scarsamente maneggevoli
(convulsivanti) quindi impiegati
esclusivamente a fini sperimentali
STIMOLANTI PSICOMOTORI
❖ Metilxantine
❖ 4-aminopiridina
❖ Antagonisti 2-adrenergici (yoimbina e
talazolina impiegate per contrastare gli effetti della
xilazina e, associate alla 4-aminopiriddina per
accorciare l’anestesia indotta da ketamina)
❖ Amfetamine, Cocaina
METIL- XANTINE
MECCANISMO D’AZIONE
Raramente impiegate come stimolanti SNC ma per ridurre la sensazione di fatica ed
aumentare la capacità di lavoro muscolare; azione diuretica; broncodilatazione
REGOLATORI DEL COMPORTAMENTO
PSICOFARMACOLOGIA VETERINARIA
DISTURBI COMPORTAMENTALI NELL’ANIMALE
esempi
ANSIA: risposta emotiva ad uno stimolo che presagisce una situazione potenzialmente
pericolosa o imprevedibile. L’animale anticipa una situazione negativa
Disturbi correlati all’ansia:
• Ansia generalizzata
• Aggressività (su base ansiosa)
• Atteggiamenti compulsivi
IL CANE E L’ANSIA
ANSIA DA SEPARAZIONE
(tra le forme di ansia più frequenti)
quando separati dai membri della famiglia, i cani possono andare incontro a comportamenti
di stress ed incappare in problemi comportamentali connessi all’assenza o alla percezione
dell’assenza dei membri del proprio gruppo (diagnosticata nel 20-40% dei cani che vengono
visitati presso le cliniche comportamentali)
Definizione più utilizzata: «patologia comportamentale, motivata dall’ansia, che si
presenta unicamente durante l’assenza del proprietario»
(anche se il proprietario è in casa ma non può venire in contatto con il suo padrone)
Trattarla è fondamentale:
• Benessere dell’animale che si trova in situazione di stress
• Rappresenta una delle principali cause di rottura del legame tra proprietario e animale (canile!)
ANSIA DA SEPARAZIONE
SINTOMI COMUNI
SINTOMI MENO COMUNI
❖ Eliminazioni inadeguate
❖ Anoressia
❖ Atteggiamenti distruttivi
in casa
❖ Diarrea
❖ Eccessive vocalizzazioni
❖ Auto-traumatismi
❖ Vomito
granuloma da leccamento
(es. di auto-traumatismo)
Con il termine di "auto-traumatismi" si indicano le lesioni che il cane od il gatto si auto-infliggono e che vanno da una banale alterazione
del colore del pelo, dovuta alla diluizione effettuata dalla saliva, a lesioni ben più importanti che arrivano alle automutilazioni (coda in
primis)
Normalmente nel cane sono localizzate ai carpi o tarsi (soprattutto sinistri) e alla coda, ma ad esempio nel dobermann è frequentemente
interessato il fianco. Nel gatto le aree maggiormente interessate sono addome, fianchi e coda.
Qualsiasi tentativo di risolvere il problema con bendaggi, collari elisabettiani ed altri accorgimenti che limitano semplicemente la presa di
contatto, da dei risultati parziali e/o temporanei.
(il problema deve essere affrontato dal punto di vista comportamentale per poter dare risultati permanenti)
AGGRESSIVITÀ: uno dei problemi comportamentali più diffusi,
In natura si distinguono due tipi di aggressività - predatoria e affettiva o emozionale. La
prima, che porta alla disponibilità di cibo, conferisce all’animale una piacevole sensazione,
mentre l’aggressione rabbiosa, al contrario dà delle sensazioni negative. Rientrano in
questo tipo di aggressività motivata dalla rabbia (offensiva o difensiva):
❖
❖
❖
❖
❖
Aggressività
Aggressività
Aggressività
Aggressività
Aggressività
da paura e da dolore
territoriale
da dominanza
intrasessuale tra maschi
patologica (cause organiche)
ognuna di esse richiede uno specifico iter terapeutico
DEPRESSIONE
Segnali tipici:
•
•
•
•
•
•
Dorme più del solito
Mangia poco e rifiuta il cibo
Non ha interesse per i suoi giochi preferiti
Tende ad isolarsi
Esce svogliatamente per la passeggiata quotidiana
Non reagisce se chiamato
❖ MODIFICAZIONE AMBIENTALE
❖ TERAPIA COMPORTAMENTALE
❖ TERAPIA FARMACOLOGICA
RELAZIONI TRA DISTURBI COMPORTAMENTALI E NEUROTRASMETTITORI
I disturbi comportamentali sono così eterogenei che i ruoli dei vari e probabili
causali possono differire molto da caso a caso. Il comportamento può, infatti,
influenzato da molteplici cause: ormonali, patologiche, ambientali
In generale, la probabilità di sviluppare disturbi comportamentali è correlata
combinazione delle comuni esperienze di vita e delle caratteristiche individuali
anche al fattori genetici)
fattori
essere
ad una
(legate
Nell’uomo, fenomeni impulsivi aggressivi hanno assunta una connotazione negativa, che rimanda a condizioni reattive
disturbate o pscicopatologiche.
Negli animali, comportamenti di tipo agonistico-aggressivo conservano il significato di comportamenti specie-specifici
(es. aggressività predatoria) in quanto favoriscono la sopravvivenza degli individui e dei gruppi sociali
I circuiti neurologici coinvolti sono molteplici e non ancora ampiamente studiati.
Nonostante i dati abbiano dato risultati a volte contrastanti, sembra ipotizzabile
una relazione tra alterate concentrazioni di alcuni neurotrasmettitori e disturbi
comportamentali su base ansiosa in numerose specie.
Nell’instaurare e mantenere atteggiamenti e comportamenti ansiosi e aggressivi su
base ansiosa sembra che siano implicate variazioni dei livelli centrali di serotonina e
di GABA (neurotrasmettitori che calmano la risposta di stress) e di catecolamine, in
particolare dopamina e noradrenalina (hanno azione facilitante risposte di tipo
ansioso). L’interazione tra questi neurotrasmettitori è talmente complessa che i
cambiamenti in un sistema inevitabilmente producono cambiamenti su un altro.
Alterazioni a carico del sistema centrale serotoninergico, in particolare bassi, sono
risultate essere un comune denominatore in letteratura (insufficiente controllo
dell’impulso aggressivo piuttosto che un’aumentata motivazione aggressiva)
In uno studio (Reisner TL et al. «Comparison of cerebrospinal fluid monoamine metabolite levels in
dominant-aggressive and non aggressive dogs», 1996) è stata misurata la concentrazione liquorale
dell’acido 5-idrossiendolacetico (5-HIAA), un metabolita della serotonina, indicatore indiretto della
concentrazione centrale della stessa serotonina
RISULTATI
SOGGETTI CON DIAGNOSI DI AGGRESSIVITÀ: bassi livelli liquorali di 5-HIAA
SOTTOGRUPPO (cani aggressivi con un passato di
episodi di morsicatura non preceduti da segnali di
avvertimento - es. ringhi percettibili): livelli più bassi
rispetto al sottogruppo di cani che utilizzano questi
segnali di avvertimento
ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI OSSERVATI e PROBABILI BASI NEUROBIOLOGICHE
❖ Disturbi dei comportamenti di pulizia del corpo – sistema dopaminergico, serotoninergico
e degli oppioidi
❖ Disturbi del comportamento sessuale – fattori ormonali
❖ Disturbi del comportamento alimentare – sistemi serotoninergico e degli oppioidi
❖ Disturbi della locomozione – sistema dopaminergico
FARMACI REGOLATORI DEL COMPORTAMENTO
ANTIDEPRESSIVI
AGONISTI DEL
RECETTORE GABA
AGONISTI DEL
RECETTORE
SEROTONINERGICO
ANTAGONISTI
β-ADRENERGICI
TRANQUILLANTI
MAGGIORI
ANTICONVULSIVANTI
STIMOLANTI
FITOTERAPICI
FERORMONI
PROGESTINICI
AGONISTI R DEL GABA: BZD (diazepam, alprazolam, oxazepam, lorazepam, clorazepato
dipotassico, clordiazepossido, clonazepam) – GABAA (sito
allosteriico)
IMPIEGHI CLINICI: marcatura urinaria, paura situazionale, attacchi di panico e di ansia
acuti, aggressività predatoria
AVVERTENZE: evitare di somministrare al gatto le BZD che danno metaboliti attivi
(alprazolam e oxazepam) poiché a maggior rischio di sviluppare necrosi
epatica fulminante
AGONISTI R SEROTONINA (5-HT1A): BUSPIRONE HCl
(ansiolitico non sedativo
«ansioselettivo» molto ben tollerato)
il sottotipo recettoriale regola l’umore e il comportamento
Latenza d’azione (>7 gg) Breve emivita (3 volte/die!)
IMPIEGHI CLINICI: marcatura urinaria, paure lievi
Serotonina
• Serotonin (5-hydroxytryptamine,5-HT) is a monoamine
neurotransmitter.
• Biochemically derived from tryptophan, serotonin is primarily
found in the
• gastrointestinal (GI) tract,
• platelets, and the
• central nervous system (CNS) of animals, including humans
Distribuzione fisiologica della
serotonina
5% SNC
95% tratto GI di cui:
90% cellule EC
10% neuroni
RECETTORI SEROTONINERGICI
individuati 7 tipi (5-HT1-7) e svariati sottotipi ma solo per i primi quattro tipi si hanno buone conoscenze
Sottotipo
5-HT1A,1B,1D
Funzione
Neuronal inhibition of central nervous system (CNS) neurons,
smooth muscle relaxation, contraction of some vascular
smooth muscle (BUSPIRONE agisce su 5-HT1 A presinaptici : effetti ansiolitici)
5-HT2
Neuronal depolarization; vasoconstriction of most blood vessels,
bronchoconstriction, contraction of gastrointestinal smooth muscle,
platelet aggregation (5HT2C responsabili del senso di sazietà)
5-HT3
Neuronal depolarization leading to activation of autonomic
reflexes, neuronal excitation in the CNS
5-HT4
Gastrokinetic action (cholinergically mediated ileal contraction)
myocardial stimulation, esophageal relaxation (in animal studies)
Recettore
5-HT1
5-HT2
Sottotipo
Meccanismo di trasduzione
del segnale
5-HT1A
Gi/o
cAMP
5-HT1B
Gi/o
cAMP
5-HT1D
Gi/o
cAMP
5-HT1E
Gi/o
cAMP
5-HT 1F
Gi/o
cAMP
5-HT2A
Gq/11
IP3/DAG
5-HT2B
Gq/11
IP3/DAG
5-HT2C
Gq/11
IP3/DAG
5-HT3
5-HT3
5-HT4
5-HT4
Gs
5-HT5A
?
5-HT5B
?
5-HT6
Gs
cAMP
5-HT7
Gs
cAMP
5-HT5
5-HT7
Recettore canale
cAMP
Localizzazione dei recettori 5-HT
• 5-HT1: SNC, vasi meningei
• 5-HT2: SNC, muscolatura liscia
• 5-HT3: SNC, afferenze vagali, chemoreceptor
trigger zone (antagonisti usati come antiemetici)
• 5-HT4: SNC, tessuto cardiaco, GI
FATTORI CHE INFULENZANO
I LIVELLI CORPOREI DI SEROTONINA
• Stress
• Mancanza di sonno
• Mancanza di esercizio
• Alimentazione scorretta
(dieta povera di triptofano)
• Mancanza di luce
Melatonina
Ormone prodotto dall’epifisi
Agisce sull’ipotalamo e regola il
ciclo sonno-veglia
Attenzione all’uso improprio!
(aumento GH, riiduzione GnRH)
ANTAGONISTI β-ADRENERGICI:
CARAZOLOLO (l’effetto ansiolitico probabilmente
deriva dal blocco dei β1 centrali e periferici – utile anche la
riduzione degli effetti cardiovascolari e dei tremori associati
all’ansia)
IMPIEGHI CLINICI: stress da trasporto e da costituzione di nuovi gruppi nei bovini, stati
ansiosi, paure situazionali
STIMOLANTI: METILFENIDATO, PEMOLINA, AMFETAMINE risposta paradossale in pz
affetti da disturbi da iperattività e deficit dell’attenzione (ADHD)
nei quali si assiste ad un recupero della calma!
FITOTERAPICI: HYPERICUM PERFORATUM (azione antidepressiva –rilascio monoamine)
VALERIANA OFFICINALIS (azione tranquillante)
risposte variabili
IMPIEGHI CLINICI: non indicati per trattamenti di lunga durata
FERORMONI:
sostanze biochimiche volatili escrete a basse concentrazioni dagli animali
(dalle ghiandole sudorpare, salivari, lacrimali, etc.), con la funzione di
inviare segnali e, quindi, in grado di influenzare il comportamento e la
fisiologia (sviluppo e riproduzione) degli altri individui della stessa specie
generano comportamenti e reazioni fisiologico-comportamentali in altri
individui della stessa specie che vi vengono a contatto
es. i feromoni sessuali che vengono scambiati per contatto o per stimolo
olfattivo e che provocano interesse sessuale in un altro individuo
MECCANISMO D’AZIONE: in parte ancora sconosciuto. Mediato dalle innervazioni
dell’organo vomero-nasale (organo di senso olfattorio
ausiliario - vestigiale nell’uomo) dell’animale che li annusa, il
quale è correlato al bulbo olfattorio, all’amigdala, all’area
preottica e all’ipotalamo
In tutti i settori dell'attività umana è sviluppato un "gergo" o linguaggio tecnico in cui ad una
semplice parola corrisponde un concetto complesso.
Gli animali «sociali» usano odori, ossia i feromoni, come "linguaggio tecnico«. Sono sostanze
importanti nella comunicazione sociale e sessuale intraspecifica nella maggior parte degli
animali, dagli insetti ai mammiferi, uomo compreso (seppur meno importante, soprattutto in
età adulta)
I ferormoni più famosi sono quelli sessuali ma ne esistono di varia natura
❖
❖
❖
❖
❖
feromoni sessuali
feromoni di aggregazione
feromoni di dispersione
feromoni di aggressione o di allarme (molto più volatili perché devono diffondersi rapidamente)
feromoni di traccia (molto più stabili per consentire maggiore persistenza del messaggio che rappresentano)
I feromoni dell’ape
regina inibiscono
lo sviluppo degli
organi riproduttori
delle operaie
I feromoni appaganti del cane e del gatto sono fisiologicamente secreti dal solco intermammario della
femmina nel corso dell’allattamento ed hanno il compito di rassicurare i poppanti e di indurre stabilità
emotiva e sicurezza. Sembra che tali proprietà persitano anche in età adulta regolando lo stato
emozionale del cane e del gatto per tutta la vita. La sintesi di queste molecole a scopo terapeutico ha
fornito un'arma in più. Sono preparazioni non soggette a prescrizione medica. L’efficacia dei feromoni
è confermata da numerose pubblicazioni internazionali
Questi prodotti si presentano sotto forma di collari e diffusori ambientali nel cane, che consentono
la liberazione costante dei feromoni per un effetto prolungato e continuo di 1 mese; sotto forma di
nebulizzatore e diffusore ambientale nel gatto
Le possibilità di impiego nel cane sono:
- favorire la corretta socializzazione del
cucciolo nei confronti di estranei, altri cani
e nuove situazioni; può essere impiegato
dal 3°-4° mese fino al 6° mese di età
- controllare le paure nell’ambiente
esterno (rumori forti, estranei)
- fobie post-traumatiche
- adozione del cucciolo ed adattamento a
nuovo ambiente
Gli utilizzi nel gatto sono:
- marcature urinarie in casa.
- graffiature verticali.
- mal di trasporto (miagolii, agitazione, ...).
- adozione del cucciolo ed adattamento a
nuovo ambiente
ANTIDEPRESSIVI (TIMOANALETTICI)
Ipotesi monoaminergica
Secondo quest'ipotesi, la depressione sarebbe causata da un deficit di serotonina, noradrenalina e dopamina.
A supporto di questa teoria sta il fatto che i farmaci antidepressivi aumentano la trasmissione di queste monoamine.
Tuttavia, gli antidepressivi alterano molto rapidamente le concentrazioni di monoamine, ma l'effetto terapeutico s'instaura
solo a distanza di settimane. Inoltre, non vi è una relazione fra la potenza dell'effetto sulla concentrazione extracellulare
delle monoamine e l'efficacia antidepressiva; in altre parole, non è detto che un farmaco in grado di aumentare molto la
concentrazione
di
monoamine
nel
vallo
sinaptico
abbia
migliori
proprietà
antidepressive
Pertanto, appare evidente che il deficit di serotonina, noradrenalina e dopamina non può essere l'unica causa
scatenante la depressione