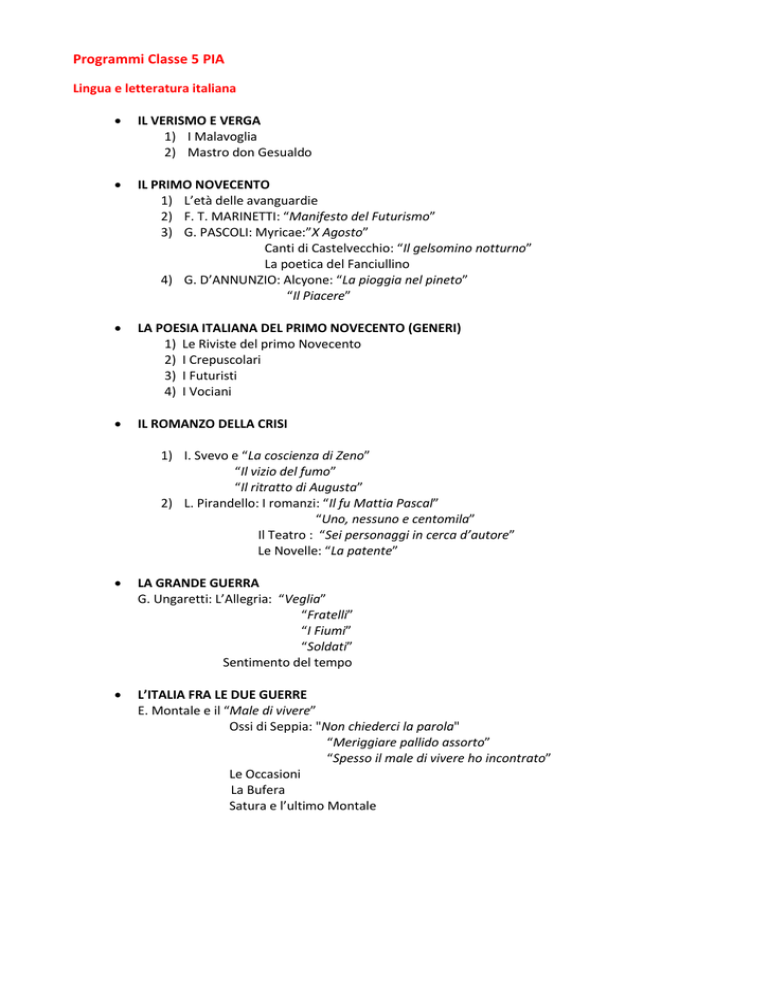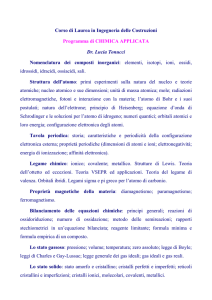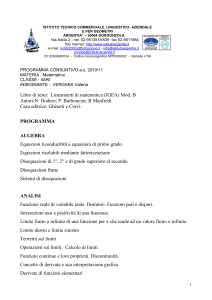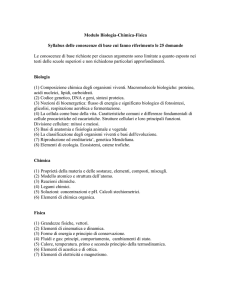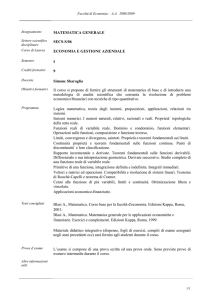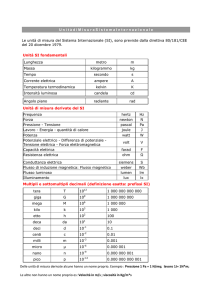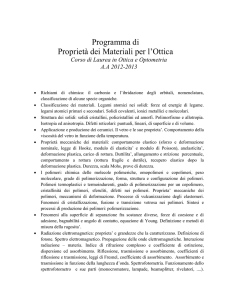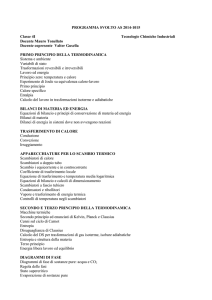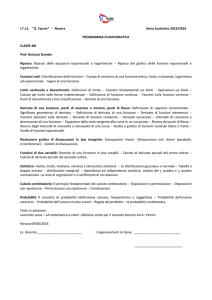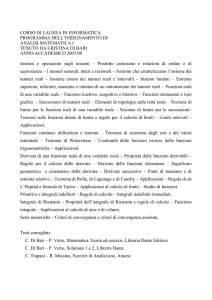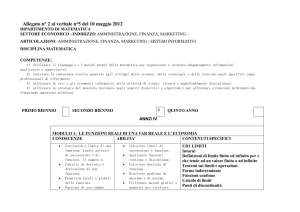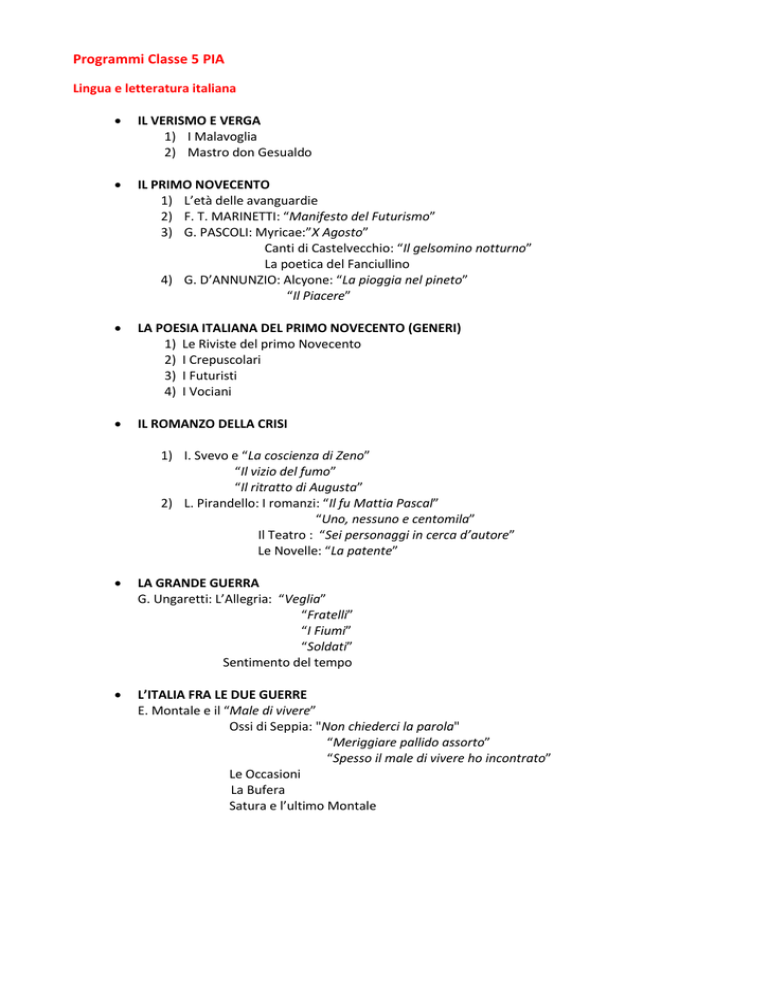
Programmi Classe 5 PIA
Lingua e letteratura italiana
IL VERISMO E VERGA
1) I Malavoglia
2) Mastro don Gesualdo
IL PRIMO NOVECENTO
1) L’età delle avanguardie
2) F. T. MARINETTI: “Manifesto del Futurismo”
3) G. PASCOLI: Myricae:”X Agosto”
Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
La poetica del Fanciullino
4) G. D’ANNUNZIO: Alcyone: “La pioggia nel pineto”
“Il Piacere”
LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO (GENERI)
1) Le Riviste del primo Novecento
2) I Crepuscolari
3) I Futuristi
4) I Vociani
IL ROMANZO DELLA CRISI
1) I. Svevo e “La coscienza di Zeno”
“Il vizio del fumo”
“Il ritratto di Augusta”
2) L. Pirandello: I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”
“Uno, nessuno e centomila”
Il Teatro : “Sei personaggi in cerca d’autore”
Le Novelle: “La patente”
LA GRANDE GUERRA
G. Ungaretti: L’Allegria: “Veglia”
“Fratelli”
“I Fiumi”
“Soldati”
Sentimento del tempo
L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE
E. Montale e il “Male di vivere”
Ossi di Seppia: "Non chiederci la parola"
“Meriggiare pallido assorto”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
Le Occasioni
La Bufera
Satura e l’ultimo Montale
Storia
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
La conferenza di pace e la Società delle Nazioni
Il nuovo volto dell’Europa
L’età dei totalitarismi
L’Unione Sovietica di Stalin
Il dopoguerra in Italia
La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso
L’ascesa del Fascismo
Verso la dittatura
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
Gli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali
Roosevelt e il New Deal
La crisi della Germania repubblicana
Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo
Il Nazismo al potere
L’ideologia nazista e l’Antisemitismo
Il regime fascista in Italia
I rapporti tra Chiesa e fascismo
Le leggi razziali
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra
Il riarmo della Germania nazista
La seconda guerra mondiale
La svolta del 1941: la guerra diventa totale
L’inizio della controffensiva alleata (1942-43)
La caduta del fascismo e la Guerra Civile in Italia
La vittoria degli Alleati
Lingua inglese
B. Franchi Martelli: “ English Tools”; Ed. Minerva Scuola
Biology and Biochemistry
Human Anatomy
Life Processes
◦ Human Body Systems: circulatory, digestive, nervous
◦ The circulatory system
◦ The human brain
◦ Mitosis and cancer
Food and Health
Biochemistry
◦ Nutrition
◦ Biomolecules
◦ Chemical structure of food
◦ Genetically modified food
Chemistry and Environment
Energy and Environment
Sources of energy:
▪ non – renewable and renewable
◦ Climate changes:
▪ Climate is changing... Why?;
▪ The greenhouse effect
◦ Alternative sources of energy:
▪ Solar energy
▪ Wind power
▪ Bio – energy
▪ Hydro-electric power
Biotechnology and Medicine
Genes and Genome
◦ What is a gene? What is a genome?
◦ What is DNA?
Proteins
◦ Protein synthesis and the genetic code
Biotechnology
◦ What is biotechnology?
Matematica
Argomenti
Introduzione all’Analisi
Insieme dei numeri reali
Intorni e intervalli aperti e chiusi sulla retta reale.
Estremi superiori ed inferiori di intervalli. Massimi e minimi.
Funzioni reali di una variabile reale
Definizione e classificazione di funzioni reali ad una variabile reale.
Dominio e codominio di una funzione.
Definizione di grafico di una funzione.
Intersezione del grafico di una funzione con gli assi cartesiani.
Funzione inversa (cenni) e funzioni composte.
Limiti e definizione di continuità
Limiti
Definizioni di limiti. Limite destro e limite sinistro..
Limiti di funzioni elementari.
Teoremi di: unicità, permanenza del segno e del confronto (solo enunciati).
Teoremi sulle operazioni tra limiti (solo enunciato).
Esempi di calcolo di limiti di funzioni razionali.
Forme indeterminate; esempio del limite notevole sin(x)/x.
Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui.
Funzioni continue
Definizione di funzioni continue in un punto e in un intervallo.
Classificazione punti di discontinuità.
Calcolo differenziale
Derivate di una funzione
Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica.
Definizione di funzione derivata e derivate successive.
Derivabilità di una funzione.
Calcolo differenziale
Derivate di funzioni elementari.
Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati).
Derivate di funzioni composte.
Derivate di ordine superiore.
Applicazione dello studio del segno delle derivate per la determinazione degli intervalli di monotonia,
dei punti stazionari e della concavità di una funzione. (*)
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (solo enunciati)
Teorema di Rolle e di Lagrange. (*)
Teorema di De L’Hopital.
Introduzione allo studio di funzioni
Procedura per determinazione del grafico di una funzione. (*)
Esempi di studio di funzioni elementari (algebriche intere e fratte). (*)
I punti contrassegnati da (*) non sono stati ancora trattati appena introdotti alla data di compilazione
del presente programma.
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
MODULO 1: LA SICUREZZA
Rischio, prevenzione e protezione
Il sistema di gestione dei rischi
Il rischio nel laboratorio di chimica e microbiologia
Normativa che regolamenta etichettatura dei prodotti chimici: Reach, CLP
Valutazione dei rischi legati alla manipolazione delle sostanze chimiche
Segnaletica di sicurezza
Rifiuti prodotti dai laboratori
MODULO 2: QUALITÀ DEI DATI ANALITICI
Raccolta e sintesi dei dati
Prestazioni degli strumenti analitici
Calcoli e arrotondamento
Scelta del valore centrale di una serie di dati
Fonti di errore dei risultati
Distribuzione di frequenza e probabilità:
dall’istogramma alla curva;
frequenza e probabilità;
curve di distribuzione di probabilità: distribuzione normale o gaussiana; distribuzione normale
ridotta;
distribuzione del t di Student; gradi di libertà; intervallo di fiducia di una media; errore standard
della media.
La variabilità dei dati nell’analisi chimica- probabilità e statistica:
Parametri e definizioni
Concetto di “test statistici”
Test di significatività: test di Dixon
Relazioni lineari tra due variabili:
Regressione
MODULO 3: QUALITÀ DEL PROCESSO ANALITICO
Riepilogo delle diverse fasi del processo analitico
Prelievo e trattamento preliminare del campione
Classificazione dei metodi di analisi
Materiali di riferimento
Calibrazione
Controllo di qualità e Buona Pratica di Laboratorio
Controllo delle apparecchiature: taratura/calibrazione e manutenzione ordinari
taratura degli strumenti di misura volumetrica
MODULO 4: I PROCESSI BIOTECNOLOGICI
Produzione della birra:
Caratteristiche, controlli e trattamenti delle materie prime
Fasi del processo produttivo
Schema dell’impianto per la produzione
Produzione del latte e derivati
acidità totale del latte
determinazione del lattosio
estrazione e purificazione della caseina
Le bevande nervine
Estrazione della caffeina dal tè e dal caffè
MODULO 5 : IL CONTROLLO DI QUALITA NEI LABORATORI DI ANALISI
Principi di gestione della qualità: politica, pianificazione, assicurazione.
Accreditamento, certificazione, normazione
Validazione e tecniche utilizzate per la determinazione della prestazione
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
IL MONDO DELL’ATOMO
Le particelle subatomiche
NATURA E PROPRIETA’ DELLA LUCE
Teoria ondulatoria della luce
Teoria corpuscolare della luce
IL MODELLO DELL’ATOMO SECONDO LA FISICA CLASSICA
Spettro di emissione dell’idrogeno
La teoria di Bohr e il suo modello dell’atomo di idrogeno
Numero quantico principale
Numero quantico secondario e numero quantico magnetico
Numero quantico di spin
IL MONDO DELL’ATOMO SECONDO LA FISICA MODERNA
La meccanica quantistica
Definizione dell’ equazione di Schrödinger
Orbitali atomici
L’atomo secondo la meccanica quantistica
Forma degli orbitali atomici s e p
Configurazione elettronica degli elementi
Moderna classificazione periodica degli elementi
SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO IN FIAMMA
Spettri di assorbimento atomico
Assorbimento atomico e concentrazione
COMPONENTI STRUMENTALI:
Sorgenti di energia raggiante e sistemi di atomizzazione: atomizzatore a fiamma e a fornetto di
grafite
Schemi ottici generali
Curva di lavoro
SPETTROFOTOMETRIA DI EMISSIONE ATOMICA
L’emissione atomica e lo spettrogramma
Cenni di spettrofotometria di emissione al plasma
Cenni di analisi qualitativa e quantitativa
IL PETROLIO
L’origine del petrolio e la formazione dei giacimenti
Caratterizzazione del grezzo
Caratteristiche dei prodotti petroliferi: i distillati leggeri, i distillati medi, i distillati pesanti. Le
caratteristiche delle benzine
I POLIMERI
Terminologia e nomenclatura
Materie plastiche, fibre ed elastomeri
La struttura dei polimeri: omopolimeri, copolimeri, polimeri lineari, ramificati e reticolati
Cenni su configurazione e conformazione,
Massa molare e grado di polimerizzazione
Caratteristiche del polietilene
ALCOL ETLICO
Carateristiche chimico fisiche dell’etanolo: punto di fusione, punto di ebollizione, legame a
idrogeno, comportamento anfotero, reazione di formazione di eteri, esteri e alogenuri alchilici.
Utilizzo commerciale dell’alcol etilico
Reazione di idratazione dell’etilene
AMMONIACA
Caratteristiche chimico-fisiche dell’ammoniaca
Reazione di formazione a partire da azoto e idrogeno: cinetica e termodinamica della reazione
Utilizzo commerciale dell’ammoniaca
Laboratorio
Determinazione del grado alcolico delle bevande
Determinazione del contenuto di ferro nel cioccolato
Determinazione spettrofotometrica dello zafferano
Tecniche di produzione e di organizzazione
MODULO 1: I CAMPI DI INDAGINE DELLA MICROBIOLOGIA
Nascita ed evoluzione della microbiologia
Campi di indagine della microbiologia
La salute: nascita del concetto moderno, determinanti e prerequisiti
Igiene, educazione sanitaria
Caratteri dell’esperimento
Il laboratorio e l’organizzazione delle attività
MODULO 2: LA BIOTECNOLOGIA: ORIGINE ED EVOLUZIONE
Le biotecnologie: storia, finalità, prodotti e settori di applicazioni
Biotecnologie tradizionali e innovative
Le biotecnologie microbiche
I biocatalizzatori molecolari
Substrati e prodotti: i terreni di coltura per la microbiologia industriale
Le fasi di produzione:
MODULO 3 : PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE ALIMENTARI : SICUREZZA E QUALITA’
Aspetti normativo - sanitari relativi ai cicli di produzione, trasformazione e conservazione dei
principali prodotti alimentari.
La qualità alimentare. Sistemi di autocontrollo, HACCP.
Il piano di campionamento
I metodi di conservazione degli alimenti : gli additivi alimentari
Il packaging : contenitori ed etichette alimentari
Produzioni alimentari (lieviti, pane, vino, birra, yogurt, formaggi)
Il latte e i derivati:
Trattamenti di conservazione del latte posto in commercio o destinato alla produzione dei derivati
Protocolli delle analisi microbiologiche del latte
Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti
I reattori chimici
Definizione e caratteristiche
Classificazione dei reattori chimici
Reattore discontinuo
Reattore continuo
Reattore semicontinui
I fermentatori
L’impianto biotecnologico
Il fermentatore
Classificazione dei fermentatori
La sterilizzazione
I sistemi antischiuma
La configurazione di un impianto
La configurazione dei biorettori e I sistemi di agitazione
Il monitoraggio di un processo biotecnolgico
Misure e controlli di un processo biotecnogico: controlli on-line, In-line, off-line
La lavorazione del petrolio
Trattamenti preliminari
Il topping
Il vacuum
Il cracking
Il reforming
I polimeri
Generalità : polimeri naturali, artificiali e sintetici
Struttura e caratteristiche dei polimeri
Formazione dei polimeri: polimerizzazione per addizione e per condensazione
Metodi di polimerizzazione: polimerizzaione in fase gassosa e in fase liquida
Processo Hoechst del di HDPE
Cenni sulle problematiche tossicologiche ed ambientali dei polimeri, degradazione dei polimeri
La produzione di etanolo
Il processo di produzione dell’etanolo per idratazione dell’etilene
La produzione dell’ammoniaca
Preparazione dell’idrogeno e dell’azoto e compressione dei gas
Reattori di sintesi
Separazione dell’ammoniaca prodotta
Processo di Haber-Bosch-Mittasch
Processo Fauser-Montecatini
Il trattamento delle acque reflue e trattamenti di potabilizzazione
Classificazione dei trattamenti
Tattamenti fisici semplici: grigliatura, sedimentazione, filtrazione, distillazione, congelamento,
Trattamenti chimici: coagulazione, flocculazionechiariflocculazione, sedimentazione secondaria,
addolcimento, osmosi inversa, trattamenti di ossidazione e di riduzione, demineralizzazione,
elettrodialisi deferrizzazione e demanganizzazione, defosfatazione, demetalizzazione
Disinfezione
Trattamento delle acque provenienti da industria petrolchimica
Scienze motorie e sportive
CONOSCENZA E RISPETTO DELLE REGOLE, CONOSCERE I RISCHI DEL FUMO, DELLA SEDENTARIETA’,
DELL’OBESITA’ E DEL DOPING. CONOSCERE ESERCIZI DI MOBILITA’ E FLESSIBILITA’ ARTICOLARE, DI
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO.
CONOSCENZA E PRATICA DEI FONDAMENTALI DI ALCUNI SPORT.
CONOSCENZA E PRATICA DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI,
LE REGOLE E I FONDAMENTALI DEI GIOCHI SPORTIVI,
LA PALLAVOLO.
PRINCIPI DI ANATOMIA: IL CORPO UMANO, OSSA MUSCOLI E ARTICOLAZIONI. ENDOCRINOLOGIA E
TECNICA DELLE SCIENZE MOTORIE.
Religione
La conoscenza di sé alla base della ricerca della propria dignità. Analisi e commento del testo “La
conoscenza di sé” di K. Gibran e l’oracolo di Delfi.
Il concetto di persona.
Libertà: video tratto dal film “Detachment” sulla libertà di pensiero.
Il personalismo cristiano.
La giustizia sociale.
La dignità e la relazione con l’altro attraverso l’empatia. Visione e commento del video di Brenè
Brown sull’empatia. Visione del film “Quasi amici”. I media e il rispetto della dignità delle persone.
La Shoah.
Il Giubileo della Misericordia.
La Sindone.
La bioetica. Distinzione tra bioetica laica e cattolica.
Visione del film “Gattaca” sull’eugenetica.
La questione del gender.
Il valore della vita.
Il rispetto della vita: l’aborto e la questione della pillola del giorno dopo.
L’inseminazione artificiale.
Il trapianto di organi.
La malattia. La follia.
L’eutanasia e l’eutanasia clandestina.
La vita dopo la morte.
Materia alternativa
Studio della sintassi musicale di base.
Test attitudinale-conoscitivo iniziale (E.E. Gordon)
Principi costruttivi delle scale maggiori e minori con individuazione del centro tonale e funzione dei gradi
più importanti (funzione di Tonica e Dominante)
Teoria degli intervalli e relativo riconoscimento uditivo.
Costruzione degli accordi per sovrapposizione successiva di terze relazionate alla nota fondamentale.
Accordi allo stato fondamentale e rivoltato e relativa nomenclatura usata nelle partiture e in generale in
tutti gli spartiti che utilizzano le sigle.
Esecuzione a 4 mani di semplici brani: melodia, accordi e linea del basso.
Studio tematico di Fur Elise di L. Van Beethoven con relativa contestualizzazione nell'ambito della scala
minore su cui è costruito (la minore).
Cambio di modalità per evidenziare le principali caratteristiche del modo maggiore e minore.
Accompagnamento nella versione originale e con le armonie espresse mediante l'uso degli accordi
rappresentati dalle sigle.
Visione e ascolto del tema tratto dalla 1a Sinfonia di Gustav Mahler, 2° movimento: Frere Jacques in minore.
Studio della tecnica compositiva ad imitazione tematica (Canone) con esecuzione alla tastiera di Fra
Martino sia in modo maggiore che minore.
Improvvisazione sulla scala pentafonica (tasti neri).