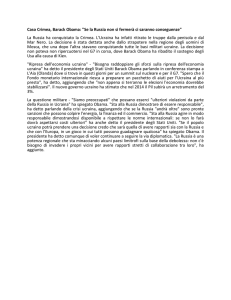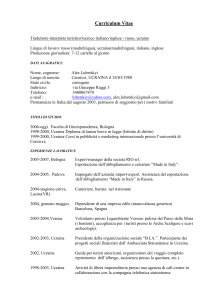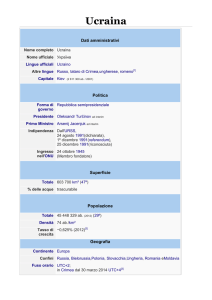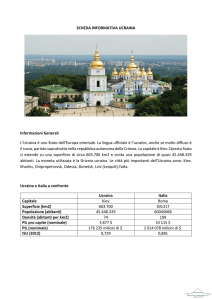Cronache di una rivoluzione
Crisi e guerra in Ucraina
A cura di Rassegna Est
Introduzione
________________________________________________________________________________________________________________
Rassegna Est, che si autodefinisce “il ponte tra l’Italia e l’Europa orientale”, avendo seguito da
vicino l’evoluzione dei fatti ucraini dell’ultimo anno, ha pensato di fare cosa gradita ai propri
lettori pubblicando il presente ebook, con l’obiettivo di tracciare una sorta storia della crisi
ucraina, che sia comprensibile per chiunque e facilmente fruibile online.
Nelle prime pagine del libro appaiono loghi e presentazioni di alcune aziende italiane presenti sul
territorio e che fanno parte del Comitato degli Imprenditori Italiani in Ucraina, creato nel 2012
dall’Ambasciata d’Italia a Kiev. È anche grazie al loro sostegno che è stato possibile realizzare
questo lavoro. Attraverso di esso le aziende intendono lanciare un messaggio di positività:
nonostante la situazione politica ed economica del Paese presenti elementi di elevata
complessità, sussistono dei margini entro i quali è possibile, auspicabilmente, continuare a
esercitare l’attivit{ economica e commerciale.
L’originalit{ dell’idea sta nel fatto che le vicende dell’Ucraina dell’ultimo anno e mezzo vengono
ricostruite attraverso una serie di articoli già pubblicati su alcune testate giornalistiche e
riorganizzati ora in modo tale da ripercorrere, tra le righe, anche le varie tappe che l’Ucraina ha
attraversato dai tempi della “Rivoluzione arancione” (2004) ai giorni nostri.
È uno scritto che presenta un’interessante valenza documentaria, in quanto disegna anche un
quadro stimolante dell’attuale situazione geopolitico-economica dell’Ucraina e dell’Est Europa. Si
tratta di un’attenta analisi delle nuove dinamiche Est-Ovest, che riporta alla memoria i tempi
della Guerra fredda. Ma se una volta si fronteggiavano due distinti blocchi di potere, che con la
loro netta contrapposizione garantivano una sostenibile stabilità a livello internazionale, quello
attuale è un confronto/conflitto dai contorni più sfumati e insidiosi, poiché la disgregazione
dell’Urss ha compromesso la compattezza a Est, portando con sé la nascita di non pochi conflitti
“interni”, di cui il più preoccupante è proprio quello in atto in questo Paese.
Questo libro, dunque, contribuisce a fornire utili strumenti per consentire di formarsi un giudizio
quanto più autonomo possibile nell’attuale momento storico, offrendo un resoconto strutturato
della situazione politico-economica non solo dell’Ucraina, ma anche dell’Europa, nel cui interno si
sono purtroppo riprodotti drammatici eventi che si tendevano a considerare, forse con una certa
superficialità, irripetibili.
Fabrizio Romano
Ambasciatore d’Italia in Ucraina
Note della redazione
________________________________________________________________________________________________________________
Gli articoli che appaiono in questo lavoro sono una parte di quelli che nel corso della crisi ucraina
i giornalisti di Rassegna Est hanno pubblicato su diverse testate italiane, cartacee e online. Tra
queste figurano Europa, Il Manifesto, Limes, Pagina 99, Popoli, Reset, Lettera 43, Linkiesta,
Askanews. Alle loro redazioni va tutta la nostra gratitudine.
La selezione degli articoli è stata fatta dando la priorità a quei temi direttamente collegati con
l’Ucraina in quanto tale. Quindi gli articoli dedicati alle conseguenze della crisi, è il caso di quelli
sulle sue ricadute in Russia (sanzioni, rublo, etc.), sono stati spesso scartati. Lo spettro del
racconto sarebbe forse divenuto troppo ampio. Ciò nonostante, i nostri articoli sull’Ucraina
hanno cercato sempre di prestare la doverosa attenzione al significato profondo di questa
vertenza, che non contamina la sola ex repubblica sovietica, ma l’intera Europa e le sue relazioni
con la Federazione russa, se non gli equilibri complessivi a livello internazionale. Né nella forma,
né nella sostanza abbiamo effettuato variazioni agli articoli pubblicati sui giornali, salvo
rarissime eccezioni e quasi sempre in base a esigenze di impaginazione.
Per la translitterazione e l'utilizzo dei nomi ucraini e russi sono state usate le versioni
comunemente adottate dalla stampa italiana, anche se non corrette dal punto di vista
strettamente linguistico. Dunque Tymoshenko e non Tymošenko; Yatseniuk e non Jaceniuk; la
Maidan, anziché il Maidan.
Le foto utilizzate sono state scaricate dalla rete, tra quelle la cui licenze autorizza la libera
fruizione. Gli autori e la fonte sono sempre stati indicati. Lo scatto di copertina è di Sasha
Maksymenko e risulta disponibile alla pagina Flickr del fotografo. Quanto alle firme, abbiamo
preferito dare risalto all’aspetto collettivo del lavoro. Quindi non le troverete. Ognuno di noi
scrive secondo la propria visione e la propria coscienza, ma ciò che trasfonde in pagina è spesso il
risultato di un confronto e della condivisione di un progetto. Rassegna Est, appunto.
________________________________________________________________________________________________________________
Rassegna Est racconta e spiega l’Europa balcanica, centrale e post-sovietica con una particolare
attenzione alle vicende economiche, chiave di lettura decisiva della regione. È sia un’agenzia di
giornalisti che forniscono i loro contributi a varie testate, sia un portale di servizio indirizzato alle
imprese italiane, la cui presenza a Est è molto radicata.
www.rassegnaest.com
I sostenitori
RIF-1 (INBLU) ha un proprio ufficio di rappresentanza nella capitale Kiev e filiali produttive a Zhytomyr, Berdicev e
Kirovograd. I dipendenti sono oltre 2000. È presente in Ucraina dal 1992 e si occupa di produzione e vendita di
calzature. I prodotti sono prevalentemente destinati a un tipo di clientela di fascia media.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
INDESIT COMPANY è il secondo produttore europeo di elettrodomestici. Commercializza lavabiancheria, frigoriferi,
lavastoviglie, cucine e prodotti da incasso. Nell’ex repubblica sovietica è presente sin dal 1996, con due dei suoi
marchi: Indesit e Hotpoint-Ariston. Attualmente vanta la quota maggiore di mercato, in termini di unità vendute.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
IVECO UCRAINA, lanciata nel 1996, è la controllata di Iveco nel paese. La sua missione è vendere sul mercato locale
l’intera gamma dei prodotti realizzati dalla casa madre: veicoli commerciali, cargo, bus, mezzi da lavoro. L’azienda
serve inoltre sia il settore minerario che quello delle costruzioni, attraverso il rinomato marchio Iveco Astra.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
MAPEI, fondata nel 1937 a Milano, è oggi il maggior produttore mondiale di adesivi e prodotti chimici per l’edilizia.
Internazionalizzata già dagli anni Sessanta, l’azienda ha aperto nel 2006 il suo nuovo ufficio a Kiev, dopo dieci anni di
presenza sul mercato locale. La sua rete tecnico-commerciale, estesa, copre tutte le più importanti regioni del paese.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
TECNOCAP è il terzo player mondiale nella produzione di chiusure metalliche, per vasi e bottiglie in vetro, come per
contenitori in plastica e metallo. Fondata nel 1993 da Michelangelo Morlicchio, ha sede a Cava de’ Tirren. La
controllata ucraina, Tecnocap UA, è stata creata nel 2005. Serve il mercato locale e quelli dello spazio post-sovietico.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
USS SECURITY fornisce servizi e prodotti legati al settore della sicurezza. Tra i suoi client vanta soggetti quali
Unicredit Bank, la catena degli hotel Radisson Blu, la compagnia petrolifera UVL Oil e l’ambasciata italiana a Kiev.
L’azienda è parte del gruppo U.S. Invest, a cui sono collegate 60 compagnie in Russia, Ucraina e nei paesi baltici.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Il Comitato degli Imprenditori Italiani in Ucraina
Le aziende che hanno sostenuto il progetto di Rassegna Est sono tra quelle aderenti al Comitato
degli Imprenditori Italiani in Ucraina. Nato nel 2012, è presieduto dall’Ambasciatore d'Italia. Esso
mira a riunire i rappresentanti delle imprese italiane presenti in Ucraina e delle principali
imprese ucraine che abbiano attuali, concreti interessi con l’Italia.
Il Comitato non eroga servizi e non ha personalità giuridica. Costituisce un organismo consultivo
di imprese e operatori economici, che si confronta con l’Ambasciata su temi, aspettative e
difficolt{ del mondo aziendale italiano in Ucraina. Ha lo scopo di favorire l’interazione degli
imprenditori italiani, ma è anche aperto ai rappresentanti dei principali gruppi ucraini che
vantano relazioni d’affari con l’Italia.
Il Comitato ha un’Assemblea, che comprende tutti i suoi membri, e un Consiglio Direttivo,
composto da un numero ristretto di imprenditori che, al loro interno, nominano un portavoce.
Kiev, 28 febbraio 2015
www.comitatoimprenditori.com
Indice
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
L’antipasto della crisi
pag. 11
La rivincita di Yanukovich
pag. 12
Yulia, sentenza al gas
pag. 14
Gli errori di Victor
pag. 16
Un’altra rivoluzione?
pag. 17
Dialogo tra sordi
pag. 19
Maidan
pag. 21
Accordo Ucraina-Ue: si va verso il niet
pag. 22
Yanukovich aspetta il rilancio
pag. 24
Governo sotto assedio
pag. 26
Odessa non è Kiev
pag. 28
I conti in rosso
pag. 30
Guerra fredda in Ucraina
pag. 32
Putin abbassa il prezzo del gas
pag. 34
Kiev guarda alla Russia
pag. 36
Gli equilibrismi di Yanukovich
pag. 38
Si fermerà la rivolta ucraina?
pag. 40
Verso il regime change
pag. 43
La marcia su Kiev
pag. 44
Il boomerang delle leggi “anti-protesta”
pag. 46
La rivolta in mano agli estremisti
pag. 47
Finale di partita
pag. 49
Via Azarov, ma non basterà
pag. 51
L’Europa è solo un pretesto
pag. 52
Leopoli, l’enclave ribelle
pag. 54
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
La fine di Yanukovich
pag. 57
Fuck the EU
pag. 58
Il compromesso minacciato
pag. 59
Il giorno più lungo
pag. 61
Ci sono davvero due Ucraine?
pag. 63
Accordo senza soluzione
pag. 65
La incognite del dopo-Yanukovich
pag. 67
Ritratto di un vinto
pag. 69
La penisola della discordia
pag. 72
Il ritorno di Yulia
pag. 74
Crimea addio
pag. 76
Putin si prende la Crimea
pag. 77
Lo scacco del Cremlino
pag. 79
Le chiese cristiane in un paese diviso
pag. 81
Gli errori del nuovo potere
pag. 84
Chi comanda a Kiev
pag. 86
Il bancomat di Bruxelles
pag. 89
Dalle barricate nasce la guardia nazionale
pag. 91
Scrittori e rivoluzione
pag. 93
La lingua degli ucraini
pag. 95
Primavera rimandata
pag. 97
L’Est contro
pag. 100
Il Donbass non è la Crimea
pag. 101
La spartizione degli oligarchi
pag. 103
Le mani sull’est
pag. 105
I piani di Mosca
pag. 107
Perché i russi stanno con Putin
pag. 109
Guerra civile
pag. 111
L’Ucraina dilaniata
pag. 114
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9
Kiev si affida ai super ricchi
pag. 116
Guerra e voto
pag. 118
Le mosse del Fondo
pag. 119
Gli oligarchi con Yatseniuk
pag. 121
Cosa vuole Putin?
pag. 122
Odessa e la guerra del popolo
pag. 125
Leopoli alla finestra
pag. 127
Rivoluzione permanente
pag. 129
La mediazione tedesca
pag. 131
La crisi corre nei tubi
pag. 133
Le leggerezze di Kiev
pag. 135
La danza degli oligarchi
pag. 137
Il gattopardo di Kiev
pag. 144
La Bankova di Poroshenko
pag. 145
Strada in salita
pag. 148
Il fronte del gas
pag. 150
Progetto Eurasia
pag. 152
L’ancora europea
pag. 155
Il piatto vuoto di Kiev
pag. 156
I tubi congelati
pag. 157
L’illusione antifascista del Donbass
pag. 159
Accordo tra speranza e timori
pag. 161
Kiev, e adesso?
pag. 163
Il mistero del Boeing malese
pag. 167
Morire per Donetsk?
pag. 168
Chi ha abbattuto l’MH17?
pag. 170
Mosca al bivio
pag. 171
Le chance della diplomazia
pag. 173
Ma il Cremlino non cederà
pag. 175
And now, Mr. Putin?
pag. 176
Cap. 10
Cap. 11
Cap. 12
Cap. 13
La partita delle sanzioni
pag. 178
Governo in crisi
pag. 179
Nuovi, vecchi padroni
pag. 181
Chi sono i capetti del Donbass?
pag. 183
Sanzioni e convogli
pag. 186
La strage dimenticata
pag. 187
Le sanzioni al microscopio
pag. 189
Il potere dei pochi
pag. 192
Arrivano i russi
pag. 194
L’offensiva
pag. 196
Festa triste a Kiev
pag. 198
Il difficile dopoguerra
pag. 200
Il calcio ai tempi della rivoluzione
pag. 202
Unica soluzione: il compromesso
pag. 204
Tregua fragile
pag. 207
Poroshenko senza alternative
pag. 208
Chi sta vincendo?
pag. 210
Le proposte di Kiev
pag. 212
Il conflitto congelato
pag. 214
La nuova Rada
pag. 217
I signori di Kiev
pag. 218
L’incognita degli indipendenti
pag. 220
Urne chiuse, questioni aperte
pag. 222
Vittoria dimezzata
pag. 224
I guai di Poroshenko
pag. 226
Al tavolo dei tycoon
pag. 228
Putin vuole che l’Ucraina resti un pantano
pag. 229
Combattere d’inverno
pag. 232
Sull’orlo del baratro
pag. 233
Cap. 14
Cap. 15
I cyborg
pag. 234
Dieci anni dopo
pag. 237
A che servono le sanzioni?
pag. 239
La pausa
pag. 241
Il governo straniero
pag. 242
Nuovo esecutivo, vecchi problemi
pag. 244
Lo spettro del default
pag. 246
L’Ucraina non è più neutrale
pag. 249
Annus horribilis
pag. 250
Prima e dopo Minsk
pag. 252
La guerra dei media
pag. 253
Escalation
pag. 255
I rischi che Christine Lagarde corre a Kiev
pag. 257
Quale negoziato?
pag. 257
Le vere sfide del dopo-Minsk
pag. 262
Sacrificio per cosa?
pag. 265
1
L’ANTIPASTO DELLA CRISI
(gennaio 2010-ottobre 2013)
All’inizio del 2010 Victor Yanukovich vince le elezioni presidenziali. Per l’ex
repubblica sovietica inizia un periodo di travaglio interno, politico ed economico,
sulla falsariga dei cinque anni precedenti, durante i quali il Paese è stato retto dalla coppia
arancione costituita da Yulia Tymoshenko e Victor Yushchenko. A livello internazionale si assiste a
uno spostamento progressivo verso la Russia, con il nuovo capo di Stato che tenta di tenere
comunque il piede in due scarpe, guardando sia verso il Cremlino, sia verso Bruxelles. Il processo di
integrazione nell’architettura dell’Unione Europea si concretizza attraverso l’Accordo di
associazione, parafato già nel marzo 2012, ma rimasto congelato a causa del caso Tymoshenko, l’ex
premier finita nel frattempo nelle patrie galere. La decisione da parte di Yanukovich di non firmare
l’Accordo porterà alle prime proteste di massa nel novembre del 2013 e alla successiva rivoluzione.
Congresso del Partito popolare europeo, 2012. Manifesto per la liberazione di Yulia Tymoshenko (Flickr)
11
La rivincita di Yanukovich
Limes, 9 febbraio 2010
________________________________________________________________________________________________________________
Morta e sepolta. A cinque anni. La rivoluzione arancione ha avuto vita breve, intensa e turbolenta.
A dire il vero è nata e morta sulla Maidan, la piazza simbolo di Kiev e della vittoria effimera del
duo Yushchenko-Tymoshenko su Victor Yanukovich - allora considerato l’autore del brogli e il
mandante dell’avvelenamento alla diossina che ha segnato per sempre il volto dell’ormai ex capo
di Stato - già nella primavera del 2005. Poche settimane dopo le tende in piazza e l’euforia di
mezza nazione la realtà aveva portato l’Ucraina con i piedi per terra. Nessuna illusione, con una
classe politica del genere, nessuna rivoluzione, nessun cambiamento. Il voto da cui è uscito
vincente Yanukovich non fa altro che confermare che il paese è alla disperata ricerca di stabilità e
che i cinque anni trascorsi sono stati il fallimento politico di una classe dirigente che ha
camminato sui falsi binari, commettendo un errore dietro l’altro, in politica estera come in quella
interna. Non si tratta solo della fretta e dell’insistenza ottusa di Yushchenko verso la Nato e dei
conflitti inevitabili con il Cremlino, ma soprattutto dell’incapacità di affrontare un percorso
lineare di progresso politico ed economico nazionale, distaccandosi dai caratteri rigidi e deleteri
del sistema oligarchico.
Più che per i suoi meriti, Yanukovich è destinato
a vincere le presidenziali grazie all’infelice esito
della rivoluzione arancione, che tante aspettative alimentò.
Il tonfo di Victor Yushchenko al primo turno, poco più del 5 per cento, una specie di record
mondiale in negativo per un presidente alla ricerca del prolungamento del proprio mandato, è
stato il simbolo di un disastro completato con il fallimento della Tymoshenko. Anche se la bionda
eroina della rivoluzione ha annunciato gravi manipolazioni e non si dà ancora per vinta,
Yanukovich sarà il successore di Yushchenko. A urne ancora aperte il premier in carica aveva
annunciato irregolarità e la volontà di non riconoscere il risultato di oltre mille sezioni nelle quali
i suoi rappresentanti sarebbero stati esclusi dai locali. Un richiamo non solo alla piazza, ma anche
ai tribunali. Ma i giudizi positivi degli osservatori internazionali sullo svolgimento generale delle
12
elezioni - il presidente dell’Assemblea parlamentare dell’Osce (Organizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in Europa) Joao Soares ha parlato di «suggestivo spettacolo di elezioni
democratiche» sottolineando che «per chiunque in Ucraina queste elezioni sono state una
vittoria» e che è ora per i leader del paese di ascoltare il verdetto del popolo e assicurare una
transizione pacifica del potere - hanno evidentemente consigliato alla battagliera Tymoshenko di
inserire la retromarcia.
Intanto Yanukovich, che appena dopo la chiusura dei seggi e la diffusione dei sondaggi che lo
davano chiaramente in testa aveva annunciato l’apertura di una nuova pagina nella storia del
paese e affermato che «abbiamo perso molto tempo negli ultimi cinque anni e il nostro compito è
ora quello di dare nuovi impulsi all’economia, modernizzare l’industria e migliorare il tenore di
vita degli ucraini» - ha invitato la Tymoshenko a preparare le valige e lasciare la poltrona di
primo ministro.
Brutta botta per l’ex principessina del gas e pasionaria in arancione, in campagna elettorale
convertitasi al putinismo, che invece di compiere l’ennesima impresa e recuperare lo svantaggio
del primo turno è costretta a lasciare il posto a colui che aveva definito «un rappresentante dei
circoli criminali e dell’oligarchia». Ma il collasso è solo farina del suo sacco: Victor Yanukovich
non è certo un animale politico, per quantificare il suo carisma basta uno zero, era già finito
cinque anni fa dopo il ribaltone rivoluzionario. Farlo resuscitare in questo modo è un’impresa che
pochi sarebbero riusciti a compiere. Eppure è proprio questo che è successo: il duo YushchenkoTymoshenko ne ha combinate talmente tante che, pur di cambiare, i disperati ucraini si sono
aggrappati a un soggetto come Yanukovich. E sono in molti, non solo gli oligarchi che hanno
puntato su di lui e sul probabile futuro premier Sergei Tigipko, a fregarsi le mani. Al Cremlino
sorridono, pensando che quello che cinque anni fa era stato tacciato di essere un burattino di
Putin, accusato di aver falsificato le elezioni e aver organizzato una cenetta avvelenata, torna ora
al potere in maniera considerata democratica anche in occidente.
13
Yulia, sentenza al gas
Lettera 43, 11 ottobre 2011
________________________________________________________________________________________________________________
L’ultimo capitolo di questa storia non è stato certo scritto l’11 ottobre con il verdetto di
colpevolezza e la condanna a sette anni di reclusione per Yulia Tymoshenko. Il tribunale
distrettuale di Pechersk ha emesso la sua sentenza e questa è solo una puntata di una telenovela
che non è cominciata con l’arresto dell’eroina della rivoluzione arancione lo scorso 5 agosto, ma
molto tempo prima, quando l’ex primo ministro non era ancora entrata in politica ed era
conosciuta come «la principessa del gas». Dalla metà degli Anni 90 gli attori dell’interminabile
sceneggiata (con gli ucraini in veste di impotenti spettatori) sono rimasti sempre gli stessi. Sino
allo scorso decennio erano tutti nella stessa barca: l’oligarca dalla treccia bionda si era
conquistata un seggio in parlamento e poi era andata a occupare il posto di ministro dell’Energia,
l’ex governatore della banca centrale Victor Yushchenko era diventato premier nominato dal
presidente Leonid Kuchma, Victor Yanukovich era il potente governatore della regione di
Donetsk, il bacino industriale che tra acciaio e carbone produce gran parte della ricchezza del
Paese. Alle loro spalle giocavano gli altri oligarchi, profittatori delle privatizzazioni selvagge degli
Anni 90: da Rinat Akhmetov a Victor Pinchuk. Poi è arrivata la rivoluzione del 2004, quella
arancione, che in Ucraina è però chiamata «la rivoluzione dei milionari contro i milardari». Poco a
che vedere con le questioni democratiche, nonostante la vulgata passata in Occidente.
Il duo Yushchenko-Tymoshenko - uscito vincitore dal duello alla luce del sole tra i seggi e le
piazza e da quello un po’ più oscuro del braccio di ferro tra Mosca e Washington - è rimasto
sostanzialmente in sella per un quinquennio (con i brevi intermezzi di governo di Yuri
Yechanurov e Victor Yanukovich) ma non ha mantenuto lo straccio di una promessa, andando a
rotoli lo scorso anno quando Yanukovich ha avuto l’occasione di prendersi la rivincita. Lo scontro
interno, per evitarne uno analogo in vista delle prossime elezioni parlamentari e soprattutto
presidenziali in calendario nel 2012 e nel 2015, è stato anticipato così nei tribunali. Il processo di
Kiev si deve leggere in questo senso e ha ragione Tymoshenko quando parla di «giustizia
selettiva». Ma non solo. Dietro le vicende dei protagonisti si staglia uno scenario internazionale
che ha a che fare con l’orientamento geopolitico del Paese e, soprattutto, con il gas.
14
Affari vecchi, che risalgono ai tempi di Kuchma e Boris Eltsin e di cui hanno raccolto l’eredità da
una parte Yushchenko e Yanukovich e dall’altra Vladimir Putin e Dmitri Medvedev. Ucraina e
Russia sono, infatti, legate dai tubi e dal gas che vi passa attraverso. Già nel 1997 si erano
accordate alla loro maniera, con Kiev che aveva ottenuto tra l’altro sconti sulla bolletta dietro la
concessione della base di Sebastopoli per la flotta russa. Modello ripreso nel 2010 con gli accordi
di Kharkiv. Tra le molteplici guerre del gas quella risolta nel 2009 da Tymoshenko è stata
utilizzata dai giudici di Kiev come scusa per mettere sotto scacco la pasionaria ribelle accusata di
aver concordato prezzi troppo alti.
Ecco dunque che la condanna della ex premier è diventata l’arma per chiedere una revisione dei
contratti con la Russia. Yanukovich vuole in sostanza prendere due piccioni con una fava: mettere
in un angolo definitivamente la sua rivale di sempre e dall’altro rafforzare la posizione ucraina
nel caso di un ricorso a un arbitrato internazionale per chiedere la riduzione delle tariffe.
Il processo all’ex premier è sì un caso di giustizia selettiva,
come denuncia l’Ue, ma anche un modo con cui Kiev chiede
alla Russia uno sconto sul prezzo del gas.
Per questo motivo il Cremlino si è espresso nelle scorse settimane sottolineando la validità degli
accordi e prendendo le difese di Tymoshenko. Anche in questo caso i valori in gioco non sono
certo quelli democratici o dell’indipendenza del sistema giudiziario. E, puntuale, è arrivata la
denuncia di Vladimir Putin: «È rischioso e controproducente mettere a repentaglio l’intero
pacchetto di accordi» con l’Ucraina per la fornitura di gas, ha detto il premier russo. E che la
storia puzzi di gas lo sa benissimo anche l’Unione europea, che in queste settimane si è sbracciata
in favore della bionda Yulia. Ma anche a Bruxelles, dove l’unità di pensiero è cosa rara, la strategia
nei confronti dell’Ucraina è condizionata dai rapporti con la Russia. Tra Ue e Kiev sono in corso le
trattative per arrivare alla firma dell’accordo di associazione, passo simbolico per agganciare
l’Ucraina nell’orbita europea. Un avvicinamento che con la condanna di martedì potrebbe
arrestarsi, rischiando però di isolare Yanukovich e spingerlo verso Mosca, che da tempo ha già
pronta la sua offerta per l’entrata nell’unione doganale euroasiatica, sconto sul gas incluso.
15
Il presidente ucraino ha fatto capire che l’ultima parola sul caso Tymoshenko non è stata però
ancora detta. Tra appelli, accordi parlamentari e soprattutto extraparlamentari il destino della
Lady di ferro potrebbe insomma cambiare. Yanukovich ha ribadito in questi mesi la vocazione
europea di Kiev e la volontà di firmare l’accordo con l’Ue. Se il prossimo passo fosse diretto
dunque a tranquillizzare Bruxelles e si arrivasse alla conclusione dei negoziati, quello successivo
dovrebbe accontentare il Cremlino, a cui fa gola il controllo sul sistema di gasdotti ucraino e sul
colosso che li gestisce, Naftogaz.
Gli errori di Victor
Limes, 25 gennaio 2012
________________________________________________________________________________________________________________
Victor Federovich era stato eletto nel febbraio 2010 al ballottaggio, sconfiggendo quella Yulia
Tymoshenko che poi sarebbe finita dietro le sbarre. L’entrata alla Bankova era stata
accompagnata dal tripudio della stragrande maggioranza degli ucraini, desiderosi di voltar
pagina dopo i cinque anni disastrosi della rivoluzione arancione. I rating di Yanukovich nel marzo
di due anni fa erano pari a quelli di Victor Yushchenko all’inizio della sua presidenza, le
aspettative altrettanto alte: i sondaggi di oggi dicono che è andata allo stesso modo e che gli
ucraini che supportano il loro capo di Stato sono pochi (7,3% sostegno pieno, 27,9% parziale,
59,4% contro, dati Razumkov Center dicembre 2011). Un crollo rispetto all’inizio, quando aveva
con sé oltre il 65% della popolazione e contro solo il 25%. Qualcosa è andato storto e non si tratta
solo della vendetta contro la Tymoshenko, che da poco ha migliorato la propria considerazione
tra gli ucraini (14,6% sostegno pieno, 23% parziale, 54,9 contro).
Il duello tra presidente ed ex premier - finito con la bionda rivoluzionaria in galera condannata a
sette anni - è un elemento marginale nella valutazione dei cittadini, soprattutto di quelli che
costituiscono il tradizionale serbatoio elettorale del Partito delle regioni nell’est del paese. La
realtà è che sono state disattese le promesse fatte in campagna elettorale e Kiev non ha ancora
trovato una via precisa per il rilancio dell’economia. Yanukovich e il primo ministro Mykola
16
Azarov navigano a vista, senza una strategia per il lungo periodo. La crisi del 2008-2009 è stata
superata, ma la situazione contingente non offre troppe speranze per un veloce rilancio. Il deficit
di bilancio previsto per il prossimo anno è del 2,5% del pil, in linea anche con le richieste del
Fondo monetario internazionale; la crescita secondo il governo sarà del 3,9% (3,5% per l’Fmi); le
incertezze però rimangono.
In bilico c’è l’avvicinamento all’Unione Europea, con la firma dell’Accordo di associazione
congelata per il caso Tymoshenko; i rapporti con la Russia sulla questione del gas (eventuale
partecipazione alla gestione del gts, nuovi prezzi, riforma di Naftogaz) rimangono tesi. Le riforme
strutturali - pensioni, fisco, liberalizzazioni - sono state avviate in maniera parziale e gli effetti si
avranno in ogni caso sul lungo periodo. Gran parte della popolazione, quella lontana dai giochi
degli oligarchi, non vuole aspettare. Ecco quindi il tonfo di Yanukovich, preso oltretutto tra la
morsa di Bruxelles e quella di Mosca, con l’Europa che pretende standard democratici e non li
ottiene e la Russia che vuole riagganciare l’ex repubblica nella propria orbita e non ci riesce.
Il presidente e il suo entourage più stretto hanno per ora vinto la battaglia contro la nemica
Tymoshenko, ma su tutti gli altri fronti la situazione è ancora di stallo. E le opzioni per ribaltare la
prospettive a proprio favore incominciano davvero a restringersi.
Un’altra rivoluzione?
Limes, 16 marzo 2012
________________________________________________________________________________________________________________
Se a Mosca qualcuno è già sceso per le strade, manifestando il proprio dissenso verso il Cremlino
e chiedendo a gran voce riforme democratiche, a Kiev per ora gli animi non si sono ancora
scaldati e la frustrazione nei confronti del presidente Victor Yanukovich, incapace di rilanciare
economicamente il paese, si è estrinsecata solo nel tonfo della sua popolarità.
Qualcosa però potrebbe cambiare anche nell’ex repubblica sovietica, sempre stando ai numeri
delle ricerche sociologiche che indicano una crescita del potenziale della protesta. Secondo
l’istituto Ifak, il 31% della popolazione - valore sensibilmente in crescita - è disposto a scendere
17
in piazza, anche se la maggioranza (52%) non ha intenzione di reclamare in maniera attiva; il
17% non si esprime. A differenza però dei russi, o almeno di quelli che vogliono mandare a casa
Vladimir Putin e chiedono in sostanza uno Stato più libero, gli ucraini che si rivoltano contro
Yanukovich paiono farlo non con la mano sul cuore, ispirati dagli ideali democratici, ma con
quella nel portafoglio.
I dati dell’Ifak in questo senso parlano chiaro e mostrano che chi è disposto a ribellarsi lo farebbe
per diversi motivi, il maggiore dei quali (per il 59% degli ucraini) è il mantenimento del lavoro e
la richiesta di uno stipendio più elevato. Al secondo posto (48%) c’è la richiesta di miglioramento
della pensione e nel settore sanitario. Più lontani (30%) quelli che ritengono la troppa corruzione
la ragione più valida per dare addosso a presidente e governo. Lontanissimi (11%) sono invece
quelli che vorrebbero far sloggiare il capo di Stato dalla Bankova con la priorità di un tasso
maggiore di democrazia e libertà.
Insomma, è chiaro che il presidente è ritenuto responsabile della difficile situazione economica in
cui versa ancora gran parte degli ucraini. Significativo è in questo senso anche il giudizio negativo
sui primi due anni del suo mandato che è arrivato dall’est del paese, suo bacino elettorale
tradizionale. Poco conta invece nell’opinione pubblica il duello con l’opposizione e l’utilizzo della
giustizia selettiva che ha portato dietro le sbarre Yulia Tymoshenko e Yuri Lutsenko. Al momento
è improbabile che il potenziale dei sondaggi si trasformi in vera e propria protesta su larga scala.
Negli scorsi mesi ci sono state alcune contestazioni di categorie specifiche (pensionati, piccoli
commercianti, veterani dell’Afghanistan e liquidatori di Chernobyl), ma non si è assistito a grandi
azioni coordinate. Decisivi saranno i prossimi mesi, che porteranno alle elezioni parlamentari di
ottobre. Sino ad ora l’opposizione (a parte la Tymoshenko in galera, è il leader del Fronte del
cambiamento Arseni Yatseniuk ad approfittare maggiormente di rating positivi) non ha saputo
coagulare il malcontento popolare. L’entrata in vigore di alcune riforme (pensioni, sanità, fisco)
capaci di incidere velocemente sulla qualità della vita dei cittadini potrebbe anche depotenziare
la protesta sociale e renderla inutilizzabile dagli avversari di Yanukovich durante la campagna
elettorale. Di fronte a un sensibile cambiamento nei prossimi sei mesi anche le eventuali
manipolazioni elettorali potrebbero passare in secondo piano (già ora per l’Ifak solo il 17% degli
ucraini è pronto a protestare per elezioni davvero libere). Se invece - nonostante il bonus degli
Europei di calcio - anche dopo l’estate continuasse il trend economico instabile, allora
18
l’appuntamento di ottobre potrebbe diventare per la Bankova davvero complicato da gestire.
Esplosiva potrebbe essere proprio l’incapacità di soddisfare le istanze popolari associata alla
volontà di continuare a gestire lo Stato senza portare benefici diffusi alla maggioranza dei
cittadini. In questo caso, diversamente alla Russia dove le proteste dopo le elezioni si sono
quietate, in Ucraina si potrebbe assistere a qualche disordine in più.
Dialogo tra sordi
Limes, 18 marzo 2013
________________________________________________________________________________________________________________
La storia infinita: tra Ucraina e Unione Europea le relazioni vanno avanti a singhiozzo e il vertice
bilaterale di fine febbraio a Bruxelles si è concluso con un nulla di fatto. Da un lato il presidente
della Commissione Juan Manuel Barroso e del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, dall’altro
il capo di Stato ucraino Victor Yanukovich e una delegazione con la partecipazione anche del
governatore della Banca centrale Igor Sorkin: hanno discusso le prospettive di integrazione
europea per l’ex repubblica sovietica firmando tra l’altro un accordo per un finanziamento di 610
milioni di euro nei prossimi due anni. Briciole, rispetto al programma di aiuti che Kiev sta
tentando di rinegoziare con il Fondo Mondiale Internazionale per oltre 15 miliardi. Barroso ha
sottolineato comunque l’importanza dell’Ucraina nel settore della cooperazione energetica e
Yanukovich si è detto ottimista, confermando la volontà di sottoscrivere l’Accordo di associazione
con Bruxelles entro la fine dell’anno.
Tra le due parti però il convitato di pietra che risponde al nome di Yulia Tymoshenko ha pesato
sul dialogo, lasciando poco spazio per lo scongelamento della situazione. Se nella dichiarazione
congiunta al termine del vertice Bruxelles e Kiev hanno ribadito le intenzioni di collaborazione e
riaffermato «la cooperazione per ciò che riguarda l’associazione politica e l’integrazione
economica sulla base del rispetto dei valori e la loro effettiva promozione», in realtà lo stallo
rimane. L’Ue desidera la Tymoshenko libera, l’Ucraina vuole mantenere l’ex premier in galera, o
quantomeno esiliarla con la sicurezza che non faccia più ritorno in patria a immischiarsi in
19
faccende politiche. Difficile che si giunga al compromesso, anche se l’ipotetica liberazione dell’ex
ministro degli interni Yuri Lutsenko, in carcere da oltre un anno, potrebbe essere un gesto che va
verso questa direzione.
L’Ue pigia sull’acceleratore e vuole passi concreti entro maggio, per firmare l’Accordo di
associazione a novembre al vertice di Vilnius. A Kiev si studiano con calma le strategie di uscita.
Con quali risultati è tutto da vedere. Si tratta per Yanukovich di rimediare al crescente isolamento
in cui ha spinto il paese nei suoi difficili esercizi di equilibrio tra Bruxelles e Mosca. Sul versante
russo la questione del gas rimane irrisolta e anche sulla partecipazione all’Unione doganale si
continua a trattare. L’incontro tra Vladimir Putin e Yanukovich a Zavidovo all’inizio di marzo non
ha smosso le acque.
Il Cremlino preme per l’integrazione euroasiatica e mette sul piatto forti sconti sulla bolletta
energetica per arrivare a una gestione comune del sistema ucraino dei gasdotti. Gazprom ha
presentato un conto di 7 miliardi a Naftogaz per i contratti take or pay del 2012 apparentemente
non soddisfatti. Kiev non vuole finire nelle braccia di Mosca e nemmeno cedere a Bruxelles. La
strategia di Yanukovich di navigare a vista rischia però nei prossimi mesi di dover mutare di
fronte quantomeno all’ultimatum dell’Ue. Se non ci sarà la firma sull’Accordo di associazione,
saliranno le probabilità che l’asse ucraino si sposti definitivamente verso la Russia.
20
2
MAIDAN
(novembre-dicembre 2013)
Dopo mesi di tira e molla Yanukovich annuncia ufficialmente alla fine dei
novembre 2013 ciò che era ormai chiaro, e cioè che l’Ucraina non avrebbe firmato
l’Accordo di associazione con Bruxelles. La decisione conduce alle prime proteste di piazza, il 21
novembre a Kiev. Maidan Nezalezhnosti (Piazza dell’Indipedenza) si trasforma nel cuore della
rivolta che ben presto si estende in varie città del Paese, soprattutto del centro e dell’ovest. Come nel
2004, l’est e il sud del Paese rimangono indifferenti ai fermenti nella capitale. Fra scontri e tentativi
di ricucire gli strappi tra governo e opposizione, le prime settimane di dicembre non portano a
nessun compromesso. La strada per la rivoluzione è di fatto già aperta, con Unione Europea e Stati
Uniti, schieratasi apertamente contro Yanukovich. La Russia appoggia il presidente e il governo
ancora in carica a Kiev, offrendo sostegno economico e politico.
Un manifestazione sulla Maidan di Kiev (Evgeny Feldman / Wikipedia)
21
Accordo Ucraina-Ue: si va verso il niet
Linkiesta, 14 novembre 2013
________________________________________________________________________________________________________________
Il 28 novembre a Vilnius, in Lituania, l’Ucraina potrebbe compiere un passo storico verso
l’integrazione europea: al summit del Partenariato orientale potrebbe essere sottoscritto
l’Accordo di associazione, comprendente l’intesa per la creazione di un’area di libero scambio,
che porterebbe Kiev verso la strada di Bruxelles, sottraendola all’orbita della Russia. Il
condizionale ripetuto è d’obbligo, dato che secondo gli ultimi sviluppi il piano potrebbe saltare. A
mettere i bastoni tra le ruote ucraine sulla via della casa comune europea è arrivato infatti il
Cremlino, preoccupato che l’ex repubblica sovietica possa intraprendere un cammino un po’
troppo indipendente, emancipandosi dal rapporto, talvolta un po’ torbido e turbolento, che lega
inevitabilmente le due repubbliche ex sovietiche. Questione di gas, ma non solo.
A rischiare di mandare all’aria il summit di Vilnius è in primo luogo la vicenda di Yulia
Tymoshenko. L’ex premier ucraina è stata condannata nel 2011 a sette anni di reclusione per
abuso d’ufficio. L’accusa è stata quella di aver valicato le sue competenze di primo ministro nel
gennaio 2009, quando firmò a Mosca con Vladimir Putin contratti energetici a condizioni
sfavorevoli per l’Ucraina. Allora disse che per Kiev non c’era alternativa, spacciando in patria
l’inchino allo zar come un successo per aver fermato l’ennesima guerra del gas. Nel 2010
Tymoshenko perse poi le elezioni presidenziali contro Victor Yanukovich e iniziò il suo calvario.
Isolata all’opposizione, abbandonata dagli ucraini delusi dalle promesse non mantenute della
Rivoluzione arancione e dagli oligarchi che un tempo la sostenevano, è stata vittima di quella che
Bruxelles ha definito «giustizia selettiva»: i processi a suo carico (oltre alla prima condanna, ne
pendono altri due sulla sua testa, uno per evasione fiscale per fatti avvenuti alla metà degli anni
Novanta quando era chiamata «la principessa del gas» e gestiva il colosso energetico Uesu, l’altro
per il coinvolgimento del deputato Evgeni Shcherban, avvenuto nel 1996) non sarebbero altro
che un complotto organizzato da Yanukovich per metterla fuori dai giochi politici.
Le posizioni sono inconciliabili. Da un lato l’Unione europea ha posto all’Ucraina una serie di
condizioni per arrivare alla firma dell’Accordo di associazione. Tra queste proprio quella
imprescindibile della liberazione di Yulia Tymoshenko. Dall’altro Yanukovich pur avendo inviato
22
in questi mesi segnali positivi in direzione di Bruxelles - come quello della liberazione di Yuri
Lutsenko, ex ministro degli Interni, finito in carcere dopo il solito processo sommario - si è
mostrato irremovibile: l’ex premier non sta in prigione per aver rubato noccioline, la giustizia
ucraina, che piaccia o no all’Europa, deve fare il suo corso. Anche i tentativi di mediazione degli
ultimi giorni, con una missione speciale dell’Ue in Ucraina alla ricerca di un compromesso, paiono
essere finiti nel vuoto. «È tutto difficilissimo», ha affermato sconsolato Aleksander Kwasniewski,
ex presidente polacco e inviato di Bruxelles in Ucraina. Yanukovich ha fatto orecchie da mercante
a ogni ultimatum dell’Unione - l’ultimo scade martedì 19 novembre - con il risultato che l’eroina
della rivoluzione arancione è sempre dietro le sbarre e l’Ucraina sta per perdere il treno europeo.
A meno di improbabili capovolgimenti dell’ultima ora, il 28 novembre 2013 non sarà insomma
una data da ricordare, né a Kiev, né a Bruxelles.
Troppo facile pensare che l’intesa Kiev-Bruxelles dipenda dal solo caso Tymoshenko.
Pesa anche l’intreccio di relazioni tra la Russia e l’Ucraina.
E di certo non è facile scioglierne i nodi, cambiando gli equilibri strategici.
Tutt’al più a Mosca. La realtà è che dietro la firma dell’Accordo di associazione non c’è solo il caso
Tymoshenko, ma il complesso sistema di relazioni, politiche ed economiche, che legano l’Ucraina
alla Russia. Il Cremlino, pur di bloccare l’avvicinamento di Kiev all’Europa, ha rispolverato tutte le
armi del suo repertorio, dal lobbismo soft alle più dure guerre commerciali: per oltre due anni, da
quando Yanukovich non solo a parole, ma anche a fatti, ha annunciato di voler portare l’Ucraina
verso Occidente (i primi tentativi per giungere a quello che ancora non si chiamava Accordo di
associazione, ma Accordo di partnership, si erano arenati ai tempi della Tymoshenko), Vladimir
Putin ha messo enormi pressioni sul presidente ucraino perché recedesse dal suo intento.
Ma solo all’inizio di novembre, quando anche a Bruxelles circolava già ottimismo in vista della
scadenza di Vilnius e si lodavano le doti di resistenza di Yanukovich, è arrivata la svolta: dopo un
paio di faccia a faccia decisivi tra i due presidenti, la situazione è mutata radicalmente. E a far
cambiare idea alla Bankova sono state le offerte sul tavolo energetico. I contratti PutinTymoshenko che Yanukovich sta tentando invano di rinegoziare sono validi sino al 2019.
Attualmente l’Ucraina paga per l’import di gas russo oltre 400 dollari per 1000 metri cubi,
23
compreso uno sconto di circa 100 dollari stabilito con il patto di Kharkiv del 2011 che prevede lo
sconto sulla bolletta in cambio della permanenza della flotta russa a Sebastopoli, in Crimea. La
Russia avrebbe offerto un prezzo di 260 nel caso l’Ucraina abbandonasse l’idea dell’Europa e
ritornasse nella culla dell’ex Urss partecipando al progetto putiniano dell’Unione doganale con
Bielorussia e Kazakistan. In più Gazprom sarebbe interessata alla gestione del sistema di gasdotti
ucraino sul modello bielorusso (dove il colosso russo ha rilevato le quote di Beltrangaz). Con le
casse statali e ancor più quelle di Naftogaz che piangono miseria, Yanukovich starebbe insomma
per dire di no all’Europa, sorridendo a Mosca. Giocoforza, vista la debole posizione: «La Russia
non fa certo concessioni, se le aspetta dalla controparte ucraina», ha detto realisticamente
Volodymir Omelchenko, responsabile del dipartimento energetico del Razumkov Center di Kiev.
Senza contare che, secondo indiscrezioni, Putin avrebbe promesso una linea di finanziamenti per
una quindicina di miliardi di dollari, per supplire ai mancati accordi tra Kiev e il Fondo Monetario
Internazionale, il cui programma di aiuti è congelato da quasi due anni.
Sulla firma dell’Accordo di associazione pesa quindi l’ombra di Mosca e il gran finale arriverà
davvero a Vilnius. È però certo che la posizione ucraina non cambierà e Yulia Tymoshenko
resterà perciò in carcere. Come ha ricordato il politologo Kostantin Bonadarenko, direttore
dell’Istituto Gorshenin nella capitale ucraina: «Sarà l’Unione a decidere se firmare o no». Kiev e
Mosca hanno fatto i loro giochi, la palla passa a Bruxelles.
Yanukovich aspetta il rilancio
Il Manifesto, 30 novembre 2013
________________________________________________________________________________________________________________
Cosa, dopo Vilnius? Il vertice tenutosi giovedì e venerdì nella capitale lituana ha dimostrato che la
strategia europea per agguantare una più stretta cooperazione con i sei paesi dell’area ex
sovietica che aderiscono alla Eastern Partnership (Bielorussia, Armenia, Azerbaigian, Moldova,
Georgia e Ucraina) non è vincente. Gli incentivi economici e commerciali squadernati da
Bruxelles, pur se vantaggiosi, si sono rivelati inadatti a portare i paesi in questione a convergere,
24
senza indugi, sull’opzione europeista. C’è la resistenza forte della Russia. Come c’è la necessità, da
parte delle stesse ex repubbliche sovietiche, di evitare lo strappo e mantenere rapporti
equilibrati con Mosca.
Georgia e Moldova sono stati gli unici paesi del sestetto a firmare le intese. Ma un conto è siglarle,
un altro implementarle. Tbilisi, oltre a non convincere pienamente Bruxelles, vista la lista di
indagini e arresti eccellenti scattati nell’ultimo anno nei confronti di esponenti del precedente
governo, quello guidato dall’ex presidente Mikhail Saakashvili, deve fronteggiare il rinnovato
slancio russo, sotto forma di assistenza economica e militare, verso l’Abkhazia e l’Ossezia del sud.
Sono le due province ribelli della Georgia. Il Cremlino le controlla. Quanto alla Moldova, va
verificata la situazione politica interna. Nei mesi scorsi la coalizione europeista salita al potere
nel 2009 è stata a un passo dal collasso a causa di una crisi politica, condita da risvolti giudiziari.
Il nodo più intricato è tuttavia quello dell’Ucraina, il paese che a livello strategico vanta, nello
spazio ex sovietico, la rilevanza maggiore. Il no di Viktor Yanukovich alle intese con l’Ue ha
spostato di nuovo il baricentro di Kiev verso la Russia, facendo fallire l’appuntamento di Vilnius.
Ma la partita è tutt’altro che conclusa. Mosca può dirsi soddisfatta dalla mancata firma degli
accordi Bruxelles-Kiev, che la mette al riparo da svantaggiose ripercussioni economiche e le dà
inoltre modo di cercare di riconquistare l’Ucraina alla causa dell’Unione eurasiatica, il progetto
«comunitario» - finora ha la sola forma di una federazione doganale tra Russia, Bielorussia
e Kazakhstan (l’Armenia dovrebbe associarsi nel 2014) - che Putin ha in mente per sé e i suoi
vicini. Il Cremlino dovrà però rimodulare la tattica di corteggiamento. Yanukovich ha infatti
dimostrato, giocando spregiudicatamente su due fronti, che l’Ucraina non aderirà mai da una
posizione subalterna e che eventualmente può sempre (ri)cercare la sponda europea.
La lezione che trae l’Europa da Vilnius è duplice. Primo: la Russia non intende mollare la presa
sull’Ucraina. Kiev, pur se sta perdendo una parte del suo ruolo di cerniera energetica tra Russia
e Ue (presto il gas russo arriverà in Europa dal fondale del Baltico e dai Balcani), rimane per
Putin un tassello strategico. Se prende la via dell’Europa può cadere tutta l’impalcatura
dell’Unione eurasiatica. Secondo: Yanukovich non è disposto, quanto meno non alle condizioni
discusse in quest’ultimo periodo (espatrio e cure mediche in Germania), a scarcerare Yulia
Tymoshenko, cosa che Bruxelles aveva richiesto formalmente. Insomma, serve un altro copione.
Quello della Eastern Partnership non ha la forza attrattiva che si pensava.
25
Volendo tagliare corto: sia la Russia che l’Ue devono rilanciare. Yanukovich aspetta di vedere le
rispettive puntate. La partita ucraina ha anche, ovviamente, una dimensione domestica. La scelta
di non firmare gli accordi con l’Ue ha esposto Yanukovich alle proteste popolari. Dopo la grande
dimostrazione del 21 novembre (100mila persone in piazza), a Kiev s’è continuato a manifestare.
Ieri la polizia ha caricato. La piazza è bifronte. Da un lato ci sono i giovani. Gente che s’affaccia per
la prima volta alla politica, ma lo fa con piglio antipolitico. Detesta Yanukovich e auspica una
prospettiva europea, ma non ha una grossa stima dei partiti dell’opposizione e non crede che
Yulia Tymoshenko sia una santa. L’altro segmento è quello delle forze parlamentari
dell’opposizione. Pregustano la spallata e chiedono nuove elezioni. Dopo il pestaggio di ieri,
inoltre, è stata lanciata la proposta di convocare lo sciopero generale. Yanukovich sa che,
dovessero queste due componenti saldarsi, potrebbe vacillare. C’è dunque da credere che
cercherà di perseguire la tattica del divide et impera. Al momento, in ogni caso, non deve faticare
troppo. Sono gli stessi dimostranti che non riescono a trovare una chimica. Come registrava il sito
di Radio Free Europe, la piazza ha restituito persino a livello visivo che tra gli antipolitici e i
politici, a loro volta divisi tra i sostenitori della Tymoshenko e i nazionalisti duri e puri di
Svoboda, non c’è dialogo: gli uni schiacciati su un lato della spianata, gli altri dalla parte opposta.
Governo sotto assedio
Il Manifesto, 2 dicembre 2013
________________________________________________________________________________________________________________
Proseguono le proteste in Ucraina. Ieri i manifestati hanno chiuso l’accesso all’edificio dove ha
sede il governo. Un blocco in piena regola, che ha impedito agli impiegati di recarsi in ufficio. Ma
quello dell’esecutivo non è l’unico palazzo del potere su cui le attenzioni dei dimostranti si sono
concentrate. Nelle ultime ore s’è registrata un’incursione anche alla sede del comune di Kiev.
E sulla piazza dell’indipendenza, il più grande slargo di Kiev, s’è materializzata una tendopoli,
circondata da barricate tirate su con qualsiasi cosa: panchine, piloni spartitraffico, alberi.
L’impressione è che la protesta stia cambiando di segno. Sulle prime si era configurata come
26
un’eruzione spontanea di rabbia verso il presidente Viktor Yanukovich, che nei giorni scorsi, alla
vigilia del vertice di Vilnius tra l’Ue e sei repubbliche ex sovietiche, ha declinato gli incentivi
economici e commerciali offerti da Bruxelles nell’ambito della Eastern Partnership, iniziativa
dell’Europa per rilanciare i rapporti con l’Est, cercando - scopo chiaro anche se non confessato di depotenziare l’influenza di Mosca nell’area.
Nel corso dei giorni le proteste sulla Maidan hanno cambiato registro,
trasformandosi nel tentativo di cacciare Victor Yanukovich da palazzo.
Con il passare dei giorni, la voglia di assestare una spallata al governo e al presidente è diventata
sempre più chiara. I partiti dell’opposizione, ieri, hanno rinnovato con insistenza la richiesta di
elezioni anticipate, oltre alla liberazione di Yulia Tymoshenko. Ci sono voci che riguardano la
convocazione di uno sciopero generale. Yanukovich, presumibilmente spiazzato dalla reazione
popolare, sta reagendo alla sua maniera: temporeggia e gioca su tutti i tavoli. Da una parte ha
annunciato un’indagine sui pestaggi di domenica contro i dimostranti, ha licenziato il capo della
polizia di Kiev e chiamato l’opposizione al dialogo. Dall’altra sa che può e deve approfittare delle
divisioni nella piazza. I giovani, tra i primi a fiondarsi in strada, esibiscono un approccio
antipolitico. Odiano Yanukovich, ma hanno scarsa fiducia nei reduci della rivoluzione arancione.
I quali, dal canto loro, hanno il problema di doversi dissociare da Svoboda, partito saldamente
radicato nelle aree occidentali del paese e ancorato alla tradizione del nazionalismo ucraino, che
sta facendo un gran baccano, lì a Kiev. L’altra questione, non certo irrilevante, è che
nell’opposizione non c’è un leader che sappia unificare. Il più accreditato sembrerebbe Vitali
Klitschko, uno dei più grandi boxeur della storia, da tempo sceso in politica. Ma è difficile che
possa svettare e farsi portavoce della rivolta. L’esito della partita dipende anche dalle dinamiche
territoriali. Ieri diverse assemblee regionali hanno aperto sessioni per discutere dei recenti fatti
di Kiev. Dalle aree occidentali del paese, ucrainofone e propense a guardare all’Europa, arriverà
senz’altro una condanna. Il consiglio della regione di Ivano-Frankivsk già s’è espresso duramente,
come quello di Leopoli. Ma il vero nodo è l’est russofono legato a Mosca, dove Yanukovich
raccoglie la stragrande maggioranza dei suoi voti. Se da Donetsk e Kharkiv, i due centri principali
dell’oriente ucraino, dovesse emergere una nota di biasimo, se non di peggio, il presidente
27
potrebbe finire all’angolo. Intanto si sussurra che già giovedì alla Rada, il Parlamento, potrebbe
tenersi un voto sulla fiducia all’esecutivo guidato da Mykola Azarov.
Sempre sul fronte domestico è interessante seguire il posizionamento degli oligarchi. I veri
padroni del paese ai quali, secondo molti, Yanukovich, da quando è alla presidenza, ha accordato
loro gran bei favori. È probabile che i tycoon attendano di vedere, prima di decidere, come si
evolverà la situazione sul fronte internazionale. In particolare si tratta di capire con quanti soldi
l’Ue potrebbe incoraggiare Kiev a tornare sui propri passi, rilanciando il discorso delle intese
economico-commerciali. A Vilnius Yanukovich l’aveva messa proprio sul piano dei quattrini,
chiedendo abbastanza sfacciatamente, in cambio della firma degli accordi, 20 miliardi di euro.
Un’iniezione di denaro necessaria a salvare il paese dallo spettro della bancarotta, ma anche
a distribuire dividenti tra gli oligarchi. Ora il presidente, consapevole che l’Ue vuole sventare lo
smacco totale sulla Eastern Partnership, cerca di riannodare il dialogo ripartendo proprio dal
discorso degli stimoli finanziari. E presto dovrebbe volare a Bruxelles. Nel frattempo Yanukovich
negozia anche con i russi. Mentre ieri Putin, alla sua maniera, ha sostenuto che le proteste di Kiev
non hanno un respiro pro-europeo, ma ricordano piuttosto un pogrom e sono il tentativo,
sostenuto dall’estero, di abbattere un governo legittimamente eletto.
Odessa non è Kiev
Linkiesta, 3 dicembre 2013
________________________________________________________________________________________________________________
Odessa dista circa 450 km in linea d’aria da Kiev. Ma mai come in questi giorni tra la perla del
Mar Nero e la capitale ucraina la distanza sembra essere incommensurabile. Due mondi, due volti
dello stesso Paese che oggi come dieci anni fa, durante la Rivoluzione arancione, appaiono
differenti e inconciliabili. Due facce della stessa medaglia di cui solo una finisce sotto i riflettori
dei media internazionali, mentre l’altra è costretta a fare da spettatrice. Kiev è ritornata come nel
2004 a essere al centro dell’attenzione, è qui che si gioca la partita più avvincente e spettacolare,
Odessa guarda un po’ incredula e si chiede cosa succederà alle tende sulla Maidan, la piazza
28
dell’Indipendenza diventata simbolo della Rivoluzione arancione e oggi culla del nuovo
movimento di protesta contro il presidente Victor Yanukovich. Il capo di Stato, che oggi è partito
alla volta della Cina per una visita di tre giorni all’insegna degli accordi economici (Pechino sta
diventando un partner fondamentale per Kiev, alla ricerca di liquidità per far fronte alla crisi e
rimpinguare le malandate casse dello Stato), ha preso tempo. Dopo gli scontri episodici dei giorni
scorsi e la grande manifestazione di domenica che ha ricordato i fasti del 2004, quando fu ancora
lui il protagonista in negativo dopo i brogli alle presidenziali che diedero il via ai fermenti
arancioni, ha deciso di evitare il muro contro muro.
Ma è chiaro che sia la Maidan che il Municipio, ancora occupato dagli attivisti, saranno prima o
poi sgomberati. Se necessario anche con le maniere forti. Anche da Odessa si seguono gli sviluppi
della situazione nella capitale con apprensione, ma con altro spirito: qui non ci sono state e non ci
sono grandi manifestazioni a favore dell’Europa, la gente non è scesa in piazza a chiedere le
dimissioni del presidente che non ha firmato l’Accordo di associazione con l’Europa. Bruxelles è
lontana, Mosca più vicina. Non solo per questioni storiche, culturali e linguistiche che risalgono
indietro nei secoli, ma anche per come si è sviluppata negli ultimi vent’anni non solo la città, ma
tutta questa zona del Paese che si allarga sino alla Crimea: le regioni del sud dell’Ucraina, come
quelle dell’Est, sono rimaste dopo il crollo dell’Urss e l’indipendenza da Mosca sempre legate più
alla Russia che all’Europa.
A Odessa, al pari dei grandi centri industriali come Donetsk e Kharkiv, domina un realismo un po’
pessimista, che contrasta con l’idealismo filoeuropeo dei manifestanti di Kiev e delle regioni
occidentali. Per gli odessiti, Bruxelles non è la panacea di tutti i mali del Paese, l’Europa non salva
da mala amministrazione e corruzione, basta guardare agli esempi geograficamente più vicini a
partire dalla Romania e dalla Bulgaria. A Odessa campeggiano i manifesti giganti del movimento
Scelta Ucraina, filorusso e antieuropeo, che mettono in guardia da un avvicinamento del Paese
all’Ue. Il leader, Victor Medvedchuk, è un po’ la longa manus di Vladimir Putin in Ucraina, visto
che tra i due il rapporto personale è molto stretto (il presidente russo è il padrino di battesimo
della figlia del politico ucraino), e soprattutto perché è sempre stato legato ai poteri forti vicini a
Mosca, sin dai tempi del presidente Leonid Kuchma. Nonostante in realtà Scelta Ucraina sia un
partito molto marginale (non raccoglierebbe nemmeno l’1% a livello nazionale), l’attività di
lobby di Medvedchuk ha dato comunque i suoi frutti. Ma lo scetticismo verso l’Europa, a Odessa,
29
come negli altri centri delle regioni meridionali e orientali, non si tramuta certo in un amore
sviscerato verso il Cremlino, la cui presenza è considerata da una discreta parte della
popolazione come ingombrante.
Tantomeno il supporto verso il presidente ucraino è incondizionato: la gente d’Ucraina, dal Mar
Nero ai Carpazi, dal Donbass alla Galizia, conosce bene i suoi polli e il duello Yulia TymoshenkoVictor Yanukovich non è mai stato idealizzato, tanto che per le centinaia di migliaia di
manifestanti scese in piazza a Kiev le priorità sono quelle di una politica estera più europeista e
di una politica interna differente da quella proposta da Yanukovich e dal primo ministro Mykola
Azarov: il cambiamento non passa così dalla liberazione di Yulia Tymoshenko, di cui la maggior
parte degli ucraini ha un’opinione differente da quella che si ha in Occidente ma attraverso
un’altra rivoluzione. Il problema fondamentale per l’Ucraina è però proprio l’inadeguatezza della
classe politica che non offre solide alterative, con l’oligarchia sempre a controllare tutto da dietro
le quinte. Ecco perché a Odessa si osservano con il beneficio del dubbio i moti rivoluzionari di
Kiev guidati dall’ex pugile Vitaly Klitschko, dallo scialbo tecnocrate Arseni Yatseniuk e dal
nazionalista un po’ antisemita Oleg Thyanibok.
I conti in rosso
Linkiesta, 4 dicembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Alla fine dei conti rimane una questione di soldi, oltre ovviamente che di geopolitica. In questi
giorni fibrillanti le cifre che sono girate tra Kiev, Mosca e Bruxelles dimostrano ancora una volta
come il caso di Yulia Tymoshenko e il duello sulla sua liberazione non siano stati altro che uno
specchietto per le allodole. E che il presidente Victor Yanukovich, nel bel mezzo della situazione
incandescente a Kiev, se ne sia partito per una visita di tre giorni in Cina all’insegna della
cooperazione economica, la dice tutta sulle priorità della Bankova. In questo momento per il capo
di Stato è indispensabile cercare di tappare in ogni modo i buchi nelle casse statali, visto che il
peggioramento della situazione economica si rifletterebbe in maniera ancor più gravosa sia sugli
30
ucraini che sulla sua posizione in vista delle presidenziali del 2015. Senza soldi freschi, da
ridistribuire all’interno del sistema oligarchico, la sua rielezione diventerebbe problematica.
Le manifestazioni di questi giorni sono legate sì alla decisione di Yanukovich di abbandonare il
corso europeo, ma il malumore generalizzato dovuto allo stato di crisi permanente in cui il Paese
si trova ha contribuito a far esplodere la protesta. L’economia non si è ancora ripresa dal tonfo
del 2009, quando il Pil è caduto del 15%. Il 2013 è stato sostanzialmente un anno di stagnazione
e per il prossimo la crescita prevista è minima.
Le trattative per un piano di aiuti del Fondo Monetario Internazionale da 15 miliardi di dollari
sono congelate per diverse ragioni. Da un lato il governo ucraino si è sempre rifiutato di adottare
alcune misure richieste dal Fondo, in primo luogo quella di aumentare i prezzi del gas domestico
con lo scopo di accrescere le entrate statali, che avrebbe però pesato sulle fasce più deboli della
popolazione. Dall’altro il Fmi ha sempre avuto il dubbio che parte del prestito potesse finire in
realtà in canali oscuri (il nuovo report di Transparency International pubblicato ieri indica
l’Ucraina come il paese più corrotto in Europa) e soprattutto servire per pagare gli enormi debiti
del colosso energetico ucraino Naftogaz nei confronti di quello russo Gazprom (secondo Mosca ci
sarebbe ancora una bolletta non pagata dallo scorso anno di circa 7 miliardi di dollari).
Se fosse stato firmato l’Accordo di Vilnius, Bruxelles e Washington avrebbero più o meno
generosamente allargato le tasche (non certo fino alle cifre sparate dal presidente ucraino alla
vigilia del vertice, necessari a suo parere per modernizzare il Paese e portarlo nel corso di
qualche anno agli standard occidentali), ma di fronte allo stop sull’asse euroatlantico, Yanukovich
ha optato comunque per l’opzione orientale tra Russia e Cina. Mosca chiuderà quindi un occhio
sui conti non ancora regolati e probabilmente le due ex repubbliche sovietiche rivedranno i
prezzi del gas. Attualmente Kiev paga oltre 400 dollari per 1000 metri cubi: se entrasse
nell’Unione euroasiatica patrocinata dal Cremlino i costi d’importazione potrebbero essere
dimezzati.
La variante cinese è in realtà un tentativo non solo di supplire ai mancati accordi con l’Europa,
ma anche di smarcarsi dall’assoluta dipendenza dalla Russia. È ormai un paio d’anni che Kiev e
Pechino hanno iniziato un avvicinamento strategico Avviati ai tempi di Leondi Kuchma e Jang
Zemin, i rapporti hanno visto un’accelerazione proprio con l’arrivo di Yanukovich alla Bankova; il
31
supporto ucraino su questioni fondamentali per la Cina come Tibet e Taiwan si è tramutato così
in un deciso interesse cinese per gli investimenti in Ucraina, in ogni campo. Solo quest’anno sono
stati sottoscritti accordi per oltre 10 miliardi di dollari, altrettanti sono stati nel 2012, e per il
2014 e successivi Yanukovich spera di fare il pieno in questi giorni a Pechino.
Un ruolo fondamentale nella partnership in crescendo lo hanno le tecnologie militari: tra il 2002
e il 2009 Kiev ha fornito armamenti per 1,9 miliardi di dollari, e altri 1,3 miliardi sono già
calcolati per il prossimo biennio, con l’Ucraina che potrebbe sorpassare la Russia come fornitore
privilegiato di Pechino. Ecco spiegato perché per Yanukovich l’incontro con il presidente cinese
Xi Jinping è più importante di quello che succede in casa propria, dove comunque è atteso il fine
settimana per il confronto diretto con gli arrabbiati leader dell’opposizione che a Kiev continuano
a guidare l’assedio ai palazzi del potere.
Guerra fredda in Ucraina
Linkiesta, 5 dicembre 2013
________________________________________________________________________________________________________________
Il percorso di avvicinamento dell’Ucraina all’Europa, ora congelato dopo il fallimento del vertice
di Vilnius, non è solo un problema tra Kiev e Bruxelles. La Russia è un altro protagonista nella
vicenda e il tentativo di impedire l’integrazione nelle strutture occidentali risponde alla volontà
del Cremlino di tenere ancora legati quei Paesi che non solo hanno fatto parte dell’Unione
Sovietica sino al 1991, ma con cui i legami storici, culturali e linguistici vanno indietro nei secoli.
Dopo la fine della Guerra Fredda però gli equilibri sono cambiati, l’Europa si è allargata a est (dal
2004 le repubbliche baltiche sono entrate a far parte non solo dell’Ue, ma anche della Nato,
esattamente come vari stati della Mitteleuropa) e il Vecchio continente è ridiventato una
scacchiera sulla quale sia le potenze regionali che quelle mondiali hanno mosso e tuttora
muovono le loro pedine. Gli Stati Uniti, attraverso la Nato e l’influenza su alcuni stati dell’ex
blocco orientale, sono diventati attori principali accanto all’Unione Europea nel cercare di
guadagnare influenza in quello che Mosca ha considerato sempre il proprio giardino di casa. Si
spiega così il battibecco di ieri a distanza tra il segretario di Stato americano John Kerry e il
32
ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, con quest’ultimo che ha accusato la Nato di interferire
negli affari interni ucraini, dicendo di non capire perché si senta in diritto di farlo.
L’Ucraina è stata in questi ultimi anni terra di contesa tra Russia e Occidente (con l’Ue al traino
degli Usa, ma divisa al suo interno) che hanno ripetutamente tentato di spostare verso Est e verso
Ovest un Paese che per questioni geografiche è lì dov’è, cioè nel mezzo, e per ragioni di cose non
può che essere al centro di scontri geopolitici. Un destino che ad esempio la vicina Polonia ha
subito nel secolo scorso. All’inizio del terzo millennio il turno è quello dell’Ucraina indipendente,
che negli ultimi vent’anni ha tentato sempre di tenere il piede in due scarpe. Se i legami con la
Russia sono sempre stati stretti, anche se opachi, e hanno attraversato un po’ tutti i settori, dando
la precedenza a quello economico-energetico, Ue e Stati Uniti hanno cominciato sin dagli anni
Novanta ad avviare rapporti istituzionalizzati: così già il presidente Leondid Kuchma (19942004) si è appropinquato all’Europa (l’Accordo di partnership e cooperazione è datato 1998) e
anche alla Nato (la Charta è stata sottoscritta nel 1997).
Sotto certi aspetti l’Ucraina ricorda la Polonia del XX secolo:
un paese schiacciato tra potenze, teatro di dure contese strategiche.
La Rivoluzione arancione del 2004, con l’arrivo al potere di Victor Yushchenko (2005-2010) ha
segnato l’apice dello scontro tra Russia e Occidente, che si sono schierate apertamente sul
terreno di battaglia ucraino, abbandonando le quinte. La svolta pro Nato avviata dal presidente
arancione con la decisione di entrare nel Map (Membership action plan) è stata però bloccata nel
2008 al vertice di Bucarest, quando Germania e Francia si sono opposte, suscitando l’ira di
Washington e facendo tirare un sospiro di sollievo a Mosca. È lo stesso schema che si è visto al
vertice di Vilnius con in ballo l’Accordo di associazione tra Kiev e Bruxelles. La posizione
intransigente sul caso di Yulia Tymoshenko (firma in cambio della liberazione) è stata perseguita
dalla Germania, mentre i Paesi europei più filoamericani, a partire da Polonia, avrebbero scelto
anche il compromesso di una sottoscrizione dell’intesa con l’ex premier dietro le sbarre pur di
raggiungere l’obbiettivo prefisso. Con l’arrivo alla Bankova nel 2010 di Victor Yanukovich le
prospettive di far risorgere l’avvicinamento alla Nato sono state seppellite, almeno in teoria, con
33
la dichiarazione adottata dal parlamento sulla neutralità del Paese, mentre si è spalancata la
porta dell’Europa con l’accelerazione nel programma di Partenariato orientale e l’Accordo di
associazione parafato nel 2012.
L’ultima battaglia è ancora in corso. L’Ucraina, paese di 45 milioni di abitanti, è l’ex repubblica
sovietica più vasta dopo la Russia (escluse quelle centroasiatiche) ed è un pezzo fondamentale
dell’ex Impero che da un lato Mosca vuole tenere assolutamente accanto a sé e dall’altro
Washington vuole strappare per indebolire il nemico di un tempo, considerato oggi amico, anche
se poco affidabile. Le accuse di interferenze reciproche sono naturalmente questioni di
prospettiva, visto che entrambe le parti non sono mai state spettatrici, ma sono scese
direttamente in campo. I problemi maggiori nascono però proprio nel momento in cui i giocatori
vogliono fare anche gli arbitri.
Putin abbassa il prezzo del gas
Linkiesta, 9 dicembre 2013
________________________________________________________________________________________________________________
Vladimir Putin e Victor Yanukovich firmano un accordo per l’abbassamento del costo del gas
importato da Kiev, ridotto da più di 400 dollari a 268,5 dollari durante i colloqui in corso al
Cremlino. È una notizia dell’ultim’ora che sembra mettere un punto fermo nella trattativa in
corso da mesi tra i due presidenti. Il patto prevede anche l’investimento da parte di Mosca di 15
miliardi di dollari in titoli di Stato ucraini. Il denaro verrà prelevato dal fondo di benessere
nazionale russo. Prima dell’incontro di oggi 17 dicembre a Mosca, i due si sono visti lo scorso fine
settimana a Soci, in un incontro che ha destato scalpore, perché giunto proprio nel bel mezzo
delle proteste di Kiev contro la svolta di un Presidente che ha sbattuto la porta in faccia
all’Unione Europea (Ue) per volgersi verso quella Euroasiatica (Uea) patrocinata dal Cremlino.
Kiev chiedeva da tempo la rinegoziazione dei contratti stabiliti nel 2009 tra Putin e Yulia
Tymoshenko, validi - prima dell’accordo di oggi - sino al 2019. Per l’Ucraina il prezzo che
oscillava intorno ai 400 dollari per 1000 metri cubi era troppo alto. In realtà vi era incluso già un
34
ribasso di circa 100 dollari stabilito con gli accordi di Kharkiv del 2011, ma la cifra stava
comunque pesando sulle casse dello Stato ucraino. Mosca, in realtà, era già disposta a scendere se
Kiev, abbandonata la via verso l’Ue, avesse compiuto davvero il salto verso l’Uea: Putin è arrivato
a offrire nel passato anche 160 dollari per 1000 metri cubi (sulla linea dei 170 che paga ora la
Bielorussia). Il Cremlino, attraverso la pressione nel settore energetico, punta a tenere agganciata
l’ex repubblica sovietica, che dipende ancora troppo dalle importazioni russe. Non solo: Gazprom
vorrebbe impadronirsi del sistema ucraino dei gasdotti come ha già fatto con la Bielorussia,
assicurandosi in questo modo un controllo totale. La strategia aggressiva del colosso russo passa
anche attraverso i progetti di Nordstream e Soutstream, i due gasdotti destinati a tagliare fuori
l’Ucraina dal versante settentrionale e da quello meridionale. Se il primo è già in funzione, del
secondo è stata posta la prima pietra alla fine del 2012 e, almeno in teoria, dovrebbe cominciare a
pompare una volta ultimato nel 2015.
Sconto sul gas e salvataggio finanziario: così Putin vuole riprendersi l’Ucraina.
Fallisce la politica dei due forni portata avanti da Yanukovich.
Il condizionale si deve al fatto che secondo alcuni osservatori l’eventuale presa di possesso del
gas ucraino potrebbe rallentarne la realizzazione. In ogni caso, partendo proprio dalle mosse
sulla scacchiera europea, sembra che Gazprom si sia concentrata più sul consolidamento della
posizione di forza acquisita nel passato, trascurando una reale diversificazione e soprattutto
trascurando forse gli investimenti necessari per fa fronte nel prossimo futuro alle sfide della
produzione e dello sviluppo. L’Espo (East Siberia-Pacific Ocean) è l’unico oleodotto nato per
invertire la rotta delle esportazioni petrolifere verso la Cina, mentre il gasdotto Altai è ancora
sulla carta. In particolare, secondo alcuni analisti, Gazprom avrebbe dormito sugli allori per
troppo tempo e ora dovrebbe rincorrere il treno partito negli Stati Uniti con la rivoluzione del gas
di scisto. L’aumento dell’offerta di gas sul mercato (con gli Usa che presto potrebbero entrare
anche come fornitori su quello europeo e, viceversa, i produttori del Golfo come il Qatar che
invece di esportare Oltreoceano potrebbero riversare sul Vecchio continente) ha spinto e
spingerà probabilmente i prezzi al ribasso, creando non poche difficoltà anche al gigante
controllato dal Cremlino. Benché sia secondo Forbes la seconda compagnia energetica mondiale,
35
dietro alla saudita Saudi Aramco e davanti all’iraniana Nioc, Gazprom si è trovata ultimamente
davanti ad alcuni problemi strategici e congiunturali che hanno fatto ridurre la produzione e
l’export negli ultimi due anni.
Le difficoltà sui mercati europei, con la revisione dei contratti a lungo termine e la riduzione dei
prezzi, aggiunta a quelle interne di non riuscire a sfruttare ancora i giacimenti siberiani e artici,
hanno fatto traballare un po’ la creatura tanto cara a Putin, che sta tentando di arraffare tutto
quello che può nelle relazioni da sempre opache con le ex repubbliche sovietiche. Mettendo spalle
al muro Bielorussia e Ucraina, la Russia persegue una strategia che può sì essere efficace sul
breve periodo, ma non risolve i punti interrogativi sul futuro. In Europa il Terzo pacchetto
energetico, che prevede in sostanza la separazione tra produzione e distribuzione, è uno scoglio
che, se non superato con un compromesso, potrebbe dare a Gazprom un brutto colpo: soprattutto
in considerazione del fatto che le vie del gas sono ora tutte sulla direttrice est-ovest, mentre per
soddisfare l’Asia, dove pure c’è sete di gas e petrolio anche se i prezzi non sono quelli che la
Russia riesce a spuntare sul mercato europeo, ci vorranno tempo e investimenti. Il Cremlino però
è più interessato adesso alle questioni urgenti, le grandi spese si fanno sul mercato ucraino.
Kiev guarda alla Russia
Il Manifesto, 11 dicembre 2013
________________________________________________________________________________________________________________
Poker o risiko che sia, in Ucraina si continua ancora a giocare. Si bluffa, si rilancia, si passa la
mano. E così via. Ieri i Berkut, le forze speciali del ministero dell’Interno, hanno cercato sia di
sgomberare piazza dell’Indipendenza, sia di assumere il controllo del municipio di Kiev, occupato
da giorni, assieme alla sede dei sindacati, dai dimostranti. In piazza c’è stata qualche
colluttazione, poi gli agenti si sono ritirati. Stesse scene davanti al comune. I Berkut hanno dato
l’impressione di volerselo prendere, salvo poi rinculare, respinti dalla muraglia umana
schieratasi davanti al palazzo e dal lancio di acqua gelida scagliato su di loro dalla gente
acquartierata nell’edificio. È possibile che il governo, che ha detto che non intende usare la forza,
36
voglia fiaccare con quella che i media anglosassoni hanno definito una charme offensive la
resistenza degli oppositori, sperando che anche il freddo faccia la sua parte. La temperatura
è infatti scesa a più di dieci gradi sotto zero e starsene lì in piazza diventa difficile. Malgrado
questo l’opposizione non intende smobilitare e nei prossimi giorni punta a organizzare un’altra
grande adunata. Parola d’ordine: cacciare Yanukovich. Intanto sono state rilasciate dieci persone
arrestate in seguito agli scontri con la polizia del primo dicembre. Misura attesa, che però non
dovrebbe sortire effetti palliativi sul corso della protesta.
Scenario convulso e zigzagante anche sul fronte dei negoziati. Ieri la responsabile della politica
estera dell’Ue, Catherine Ashton, al suo secondo giorno di visita a Kiev, ha nuovamente conferito
con le autorità, che da parte loro hanno chiesto venti miliardi di euro in cambio della firma degli
Accordi di associazioni e delle misure sul libero scambio, che Yanukovich, il 21 novembre, aveva
bocciato, facendo esplodere la rivolta popolare. Ci sarebbe la possibilità che una delegazione
ucraina, guidata dal primo ministro Mykola Azarov, si rechi oggi a Bruxelles a discutere della
cosa. Ma il portale EuObserver, citando fonti comunitarie, ha riportato che Azarov non dovrebbe
intraprendere il viaggio e che la Commissione è dell’idea che il futuro dell’Ucraina non può
ridursi a una gara tra chi offre di più. Peccato sia proprio questa la piega che le recenti vicende
hanno preso. L’Ucraina è alle prese con una rognosa crisi finanziaria, che la sta trascinando verso
il baratro. Yanukovich deve trovare molto presto dei soldi, che diano un po’ di linfa al paese e a lui
stesso, dato che all’inizio del 2015 si terranno le elezioni presidenziali.
Conti alla mano, il capo di stato - che ha ottenuto da poco crediti da Pechino - sembra essersi
deciso a prediligere le offerte di Mosca: cash e gas. Sono immediate. Quelle europee invece
comportano vantaggi nel lungo termine ma impongono nel breve riforme costose, che
potrebbero intaccare l’ossatura dell’industria e quindi - punto non secondario - gli interessi dei
potenti oligarchi. Scelte costose, socialmente e politicamente, le prevedeva anche il pacchetto di
aiuti del Fmi. Infatti è stato respinto. L’impressione, continuando in ogni caso a non scartare
l’ipotesi di sorprese last minute, è che Yanukovich, alzando la posta con gli europei, abbia voluto
dialogare indirettamente con Mosca, pretendendo aiuti massicci, senza però aderire, quanto
meno non adesso, all’unione doganale che Mosca sta promuovendo nell’ex Urss, pilastro della
nascente Unione eurasiatica, il grande sogno strategico di Putin. Se è questo lo scenario che sta
davvero prendendo forma, ci si può chiedere se al presidente russo convenga tenersi un’Ucraina
37
così sfilacciata. Da una parte viene da dire di no. Pompare ossigeno nelle arterie ucraine rischia di
essere molto, troppo costoso. Dall’altra, una Kiev precaria potrebbe essere domata facilmente
e aderire all’Unione eurasiatica in posizione subalterna.
Un’altra questione è capire i motivi dell’ossessione russa per l’Ucraina. Qui va ribaltata una
credenza, affermatasi negli ultimi anni, secondo cui la Russia non ha più prismi ideologici e bada
solo, pragmaticamente e aritmeticamente, a coltivare i suoi interessi. In parte è vero, ma
l’Ucraina, oltre a costituire un cuscinetto strategico, ha una dimensione anche sentimentale. Lì
è sorto il primo stato russo della storia, la Rus’ di Kiev. Fatto, questo, che nella mente dei russi ha
un suo indubitabile peso e si lega a doppio filo alla gelosa custodia dell’alterità politica, storica
e culturale che Mosca vanta, non senza orgoglio, rispetto all’occidente. Se Kiev virasse verso
l’area euro-atlantica, assorbendone i paradigmi, sarebbe una catastrofe.
Gli equilibrismi di Yanukovich
Linkiesta, 11 dicembre 2013
________________________________________________________________________________________________________________
Dopo due settimane di muro contro muro per le strade di Kiev è arrivato quasi liberatorio il
giorno della diplomazia. Per tentare di risolvere la crisi è arrivata ieri, 10 dicembre, la ministra
degli Esteri dell’Unione europea Catherine Ashton, con il difficile compito di trovare in due giorni
un compromesso che possa prima di tutto avviare la normalizzazione in una capitale che è ancora
in stato di assedio. Da una parte i manifestanti dell’opposizione continuano a presidiare la piazza
dell’Indipendenza, il municipio e la sede dei sindacati; dall’altra le forze di polizia in tenuta
antisommossa sono pronte a intervenire per l’eventuale sgombero, nel caso in cui dovesse
arrivare l’ordine dall’alto.
Le autorità hanno evitato sino ad ora l’uso massiccio della forza, ma l’arrivo delle squadre speciali
nelle zone nevralgiche del centro cittadino ha fatto salire la tensione già ieri e la preoccupazione
è serpeggiata subito nelle cancellerie occidentali che osservano con preoccupazione l’evolversi
delle vicende nella capitale ucraina.
38
Gli ultimi sviluppi sembrano aver però riportato un po’ di tranquillità, anche se una scintilla sulla
Maidan o nelle vie adiacenti farebbe precipitare di colpo tutto. La mediazione europea della
Baronessa Ashton potrebbe contribuire a evitare che la situazione nelle strade degeneri
improvvisamente, in attesa di vedere come a livello politico si potranno accordare governo e
opposizione per uscire da quello che fino a qualche ora fa pareva un vicolo cieco, e ora fa
intravedere una via d’uscita. Forse. La responsabile della diplomazia europea si è incontrata con
il presidente Victor Yanukovich, che già ieri sembrava aver aperto al dialogo, seguendo la
proposta di una tavola rotonda nazionale.
Mercoledì in giornata è programmato l’atteso incontro tra governo e opposizione. Il
sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland, che a sua volta ha incontrato i leader della
protesta, si è espressa fiduciosa dopo i colloqui che ha definito molto produttivi.
La troika antiregime, formata da Vitaly Klitschko, Arseni Yatseniuk e Oleg Tiahnybok, ha invero
ancora intenzione di far piazza pulita, chiedendo le dimissioni del capo dello stato ed elezioni
anticipate, ma dovrà probabilmente rimodulare le proprie richieste. Yatseniuk, che ha raccolto la
guida di Patria, il partito di Yulia Tymoshenko, ha ventilato l’ipotesi di un governo tecnico, senza
specificare però chi e su quale basi dovrebbe guidarlo. In questa direzione sono andati anche gli
ex presidenti Leonid Kravchuk e Leonid Kuchma, ideatori della tavola rotonda, che hanno
suggerito a Yanukovich di licenziare il primo ministro Mykola Azarov.
Resta da vedere chi potrebbe prendere il posto del fedelissimo di Yanukovich: c’è già chi vocifera
il ritorno di Petro Poroshenko, il magnate conosciuto come il Re del cioccolato per aver fatto la
sua fortuna nell’industria alimentare, passato dai fasti della Rivoluzione arancione come
sostenitore di Victor Yushchenko e Yulia Tymoshenko a ministro proprio dell’ultimo governo
Azarov. Ma è solo un nome dei tanti nel mazzo. Sicuro è che come sempre gli oligarchi
giocheranno un ruolo importante nella distribuzione delle poltrone, muovendo le loro vecchie e
nuove pedine. Un gioco da cui l’opposizione non è certo estranea. Ciò che è comunque certo è che
qualche testa al governo rotolerà, oltre a quella di marmo della statua di Lenin che è diventata il
simbolo della ribellione antirussa. Da Mosca, di fronte all’offensiva diplomatica europea, sono
arrivate le accuse di interferenze negli affari interni ucraini: la Duma, il parlamento russo, ha
accusato gli Stati occidentali di mettere il naso dove non dovrebbero e ha denunciato le proteste
di piazza come destabilizzanti. Il duello a distanza tra la Russia e Ue insomma continua, con
39
Yanukovich che sembra intenzionato a prendere ancora tempo. Il presidente ha annunciato che
l’Accordo di associazione con Bruxelles potrebbe essere firmato nella primavera del prossimo
anno. Difficile decifrare se le parole del capo dello Stato siano il modo per placare l’ira della
piazza e mostrarsi accondiscendente nei confronti dell’Unione, che continua a ripetere che la via
verso l’integrazione rimane aperta, oppure celino una strategia diversa.
La realtà è che in questo momento l’Ucraina continua ad avere il piede in due scarpe, non
agganciata a Bruxelles e nemmeno legata a Mosca. I dossier tra Cremlino e Bankova sono ancora
aperti, Yanukovich e Putin non hanno ancora messo nero su bianco nulla e gli equilibrismi del
presidente ucraino, passati e presenti, non sono mai piaciuti allo Zar, che vorrebbe chiudere il più
in fretta possibile il capitolo Ucraina. L’eventuale nuovo governo a Kiev non potrà quindi sottrarsi
facilmente all’ombra di Mosca, anche se decisioni già prese verranno in qualche modo riviste.
Si fermerà la rivolta ucraina?
Europa, 18 dicembre 2013
________________________________________________________________________________________________________________
Sono passati quasi due mesi dall’inizio delle proteste a Kiev. È un arco di tempo più lungo di
quello che, a cavallo tra il 2004 e il 2005, portò la rivoluzione arancione a trionfare. Allora le
adunate di piazza durarono una ventina di giorni. Se le attuali proteste dovessero essere
trasposte in un grafico, con i giorni sull’asse delle ascisse e il numero dei manifestanti su quello
delle ordinate, ci sarebbero delle grosse impennate in corrispondenza dei fine settimana. È che in
piazza Indipendenza, lo slargo che fa da campo base ai dimostranti, ci sono presidi quotidiani di
qualche migliaio di persone e notevoli prove di forza nei weekend, quando dal resto del paese
arrivano rinforzi massicci. Ieri c’è stata però un’eccezione. La piazza infatti s’è gonfiata di gente,
dopo l’annuncio degli accordi sanciti a Mosca tra il presidente ucraino Viktor Yanukovich e
l’omologo russo Vladimir Putin, che ha concesso importanti tagli sui prezzi del gas (da 400 a 268
dollari per mille metri cubi) e sostegno finanziario diretto (quindici miliardi di dollari in acquisti
di bond). L’intesa congela momentaneamente, a livello internazionale, la partita. Yanukovich ha
40
scelto di farsi salvare dai russi, cosa che spinge verso il basso le quotazioni su una ripresa delle
trattative con l’Ue. Se ne riparlerà eventualmente in primavera. Ma in ogni caso è chiaro che i
fattori domestici dello scontro restano incollati al tappeto. Gli ucraini acquartierati in piazza
dell’Indipendenza continuano a chiedere le dimissioni di Yanukovich e del governo.
Fino a quando durerà? Finirà presto o andrà avanti a oltranza? Difficile tracciare previsioni. Ma,
questo sì, si possono prendere in considerazione tutti i fattori in campo. A partire da quello, non
secondario, del clima. A Kiev fa freddo e stare in piazza è una prova di resistenza fisica, oltre che
psicologica. È chiaro che Yanukovich e il governo di Mykola Azarov, che non intendono schiodarsi
dalla poltrona, fanno leva anche su questo. Sperano che il «generale inverno» induca la gente a
tornarsene a casa, stanca di farsi percuotere dall’aria rigida e tagliente.
Tuttavia, se nei giorni scorsi le temperature sono scese rapidamente verso il basso, toccando
anche i -10 e dando l’impressione che stesse arrivando il peggio, adesso c’è stata una
stabilizzazione. Non vanno giù più di tanto, e dovrebbe continuare così fino a gennaio. Insomma,
si può ancora resistere.
Yanukovich ha in serbo un’altra arma. Non dovrebbe più sguinzagliare i Berkut, i corpi speciali
del ministero degli interni. Il capo di stato ha visto che l’intervento di forza non fa che
galvanizzare i dimostranti. È stato così dopo i pestaggi del 30 novembre (il giorno marea umana a
Kiev). È stato così dopo il tentativo di sgomberare la piazza e riprendere il controllo dei due
edifici, il comune di Kiev e la sede dei sindacati, occupati dai dimostranti. Il siluramento del capo
della polizia di Kiev, del sindaco della capitale e del vicecapo della sicurezza nazionale, oltre alla
liberazione di alcuni esponenti della protesta, rientrano in questo copione. In altre parole
Yanukovich, vestendo gli abiti del democratico che non teme il dissenso, è intenzionato a lasciare
che i manifestanti continuino a starsene in piazza, auspicando che prima o poi, a corto di
munizioni, lascino l’accampamento.
In questo ha ricevuto una mano da Putin. Ieri, a Mosca, i due non hanno discusso l’eventuale
accesso ucraino allo spazio doganale patrocinato dal Cremlino per l’ex Urss, pilastro della futura
Unione eurasiatica. Avrebbe dato ancor più benzina alla protesta e Putin, benché non ne abbia
stima, sa che l’unico che può dargli garanzie, a Kiev, è proprio Yanukovich. Dunque non intende
trascinarlo - non per ora - nella sua orbita d’influenza. Gli darà modo, almeno fino alle
41
presidenziali del 2015, di sventolare davanti ai suoi sostenitori e persino a chi sta in piazza i
risultati delle intese di Mosca: mantenimento di un tasso accettabile di sovranità nazionale e
sconto vistoso sconto sul gas, con prospettive di rilancio dell’economia.
Un’altra questione da considerare è la coesione dei partiti dell’opposizione, che con il passare dei
giorni hanno assunto le redini della protesta. Arseni Yatseniuk, Vitali Klitschko e Oleh Tiahnybok,
i tre alfieri della protesta, sono sì uniti nel chiedere la testa di Yanukovich, ma hanno linee
politiche molto diverse tra loro e non così facilmente amalgamabili. Anzi. Yatseniuk è l’attuale
capo di «Patria», il partito di Yulia Tymoshenko. Ha esperienza parlamentare e ministeriale, ma
sconta il fatto di essere il supplente dell’eroina della rivoluzione arancione, in carcere dal 2011. Il
suo carisma non è così dirompente. Lo è invece quello di Vitali Klitschko, che da poco ha deciso di
appendere i guantoni al chiodo e di darsi solo alla politica. Su di lui e sul suo partito centrista
(Udar), scommetterebbero Angela Merkel e qualche cancelleria occidentale. Klitschko è un po’
l’uomo nuovo e alle elezioni del 2012 è riuscito a ottenere consensi anche nei distretti dell’est,
dove il Partito delle regioni di Yanukovich fa sempre grandi scorpacciate. Ma bisogna capire se da
qui alle presidenziali del 2015 riuscirà a trasformarsi da outsider a leader. Quanto a Tiahnybok e
al suo partito, Svoboda, fortemente nazionalista e radicato nel solo occidente del paese, non è
affatto semplice vedevi una «chimica» elettorale con Yatseniuk e Klitschko. Volendo tirare le
somme, non è da escludere che l’unità di queste settimane possa, con il passare del tempo,
scompaginarsi. Come non è da escludere - al momento è addirittura quasi certo - che venga a
mancare un accordo, in vista del voto del 2015, su un unico candidato dell’opposizione. Questo è
il quadro. Potrebbe succedere ancora di tutto. Potrebbe anche non succedere.
42
3
VERSO IL REGIME CHANGE
(gennaio 2014)
La protesta che durante il Capodanno e il Natale ortodosso pareva essersi sopita si
risveglia invece a metà gennaio. Il tentativo di Yanukovich di imbavagliare Maidan
con provvedimenti legislativi ad hoc si trasforma in un boomerang. Sia Kiev che nel resto del Paese a
infiammare la rivolta sono di nuovo quindi i passi del governo, che dopo il compromesso raggiunto
con Mosca non trova la strategia giusta per placare l’opposizione e la piazza. Le regioni dell’ovest
premono per il cambio di potere nella capitale, dove il trio Klitschko-Yatseniuk-Tiahnybok fatica a
tenere sotto controllo l’ala radicale nazionalista e pronta a tutto. Le pressioni esterne acuiscono la
gravità delle crisi che sia avvia verso la definitiva esplosione.
Gli scontri a Kiev (Sasha Maksymenko / Flickr)
43
La marcia su Kiev
Il Manifesto, 2 gennaio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Sono stati in piazza e hanno fatto sentire la loro voce, si sono scontrati con i poliziotti e hanno
esultato, mostrando la bandiera del loro partito, quando le forze di sicurezza hanno desistito
dallo sgomberare la sede del comune di Kiev, occupata qualche giorno dopo l’inizio delle
dimostrazioni contro il governo e il presidente Viktor Yanukovich, lo scorso 21 novembre. Ma
tutto sommato i militanti di Svoboda, partito ultra-nazionalista, finora s’erano mimetizzati. Erano
stati uno dei segmenti della protesta. Mercoledì, il primo gennaio, hanno invece dispiegato la
prova di forza e si sono presi tutta la ribalta mediatica. Almeno 15mila persone hanno marciato,
impugnando fiaccole, nel pieno centro della capitale ucraina. I cori scanditi: «Gloria all’Ucraina»,
«morte ai nemici». Il motivo della manifestazione: il centocinquesimo anniversario della nascita
di
Stepan
Bandera, capo politico della
più radicale
e violenta
delle
due
costole
dell’Organizzazione dei nazionalisti ucraini (Oun), movimento che durante la seconda guerra
mondiale promosse la nascita di uno stato ucraino indipendente, fondato su criteri etnici.
Gli ultranazionalisti di Svoboda scendono in piazza a Kiev.
Una prova di forza, per chi si considera erede di Stepan Bandera.
Si alleò tatticamente con Hitler per fare l’Ucraina indipendente.
L’Oun ebbe la sua culla nelle attuali regioni occidentali dell’Ucraina. Fecero parte dello stato
polacco fino al 1939, quando quest’ultimo, in virtù del patto Ribbentrop-Molotov, fu dissolto dalla
Germania nazista e dall’Urss. Da allora alla fine del conflitto gli uomini di Bandera, inquadrati
nell’esercito insorto ucraino (Upa), non si schiodarono dalla trincea. Bandera instaurò un
rapporto di collaborazione con il Terzo Reich (il grosso degli storici dice più tattico che
ideologico), si scontrò con l’Armata rossa, contribuì al massacro di migliaia di polacchi e secondo
qualche fonte anche alle deportazioni degli ebrei. Dopo la guerra si stabilì a Monaco di Baviera e lì
si spense, nel 1959. Ma al di là delle note biografiche, resta il marchio da lui impresso sul ‘900.
L’Ucraina occidentale divenne un orrendo laboratorio di violenza.
44
Il retaggio di Bandera non si limita ai soli libri di storia. La sua figura divide gli ucraini. Nelle
regioni dell’est, più legate alla Russia e al mito della grande guerra patriottica combattuta da
Mosca contro Hitler, viene visto come un collaborazionista. In quelle occidentali, più ancorate
all’ucrainità, è per molti un eroe della patria. Della sua eredità se ne è appropriata Svoboda. E così
torniamo al punto di partenza, alla manifestazione tenuta l’altro giorno dagli ultra-nazionalisti,
guidati da Oleh Tiahnybok. Non si è trattato solo di onorare Bandera, ma di rimarcare che
Svoboda, che alcuni giudicano impregnato di razzismo, se non di neonazismo, sa mobilitare e può
ambire in futuro a crescere in termini di consenso (prese il 10,44% alle politiche del 2012). Il
punto, infatti, è che benché si siano sforzate in queste settimane di mostrarsi unite, facendo
fronte comune contro il presidente Viktor Yanukovich, accusato di aver rifiutato l’integrazione
europea per vendersi a Mosca, dalla quale ha da poco ricevuto 15 miliardi in finanziamenti e un
taglio corposo sui costi del gas, le forze dell’opposizione corrono una gara parallela in cui ognuno
cerca di tirare acqua al proprio mulino. Il che potrebbe persino avvantaggiare Viktor Yanukovich,
che nei primi mesi del 2015 conta di confermarsi alla presidenza.
Il vantaggio competitivo che potrebbe avere Svoboda sugli altri partiti dell’opposizione sta
proprio nel nazionalismo radicale, nel linguaggio aggressivo, nel ragionare più di pancia che di
testa, nell’alternatività rispetto alla postura istituzionale del partito della Tymoshenko (Patria)
e di quello di Vitali Klitschko (Udar). Il primo si colloca su una linea patriottica-conservatrice, il
secondo tende al centrismo. Resta da vedere se Svoboda saprà imporsi anche fuori dal suo
tradizionale steccato di consensi, vale a dire i distretti di Leopoli, Ivano-Frankivsk e Ternopil,
tutti all’ovest. Sono le stesse terre dove Bandera imperversò. Nel 2012 ottenne qualche buon voto
(di protesta) anche a Kiev, ma da est, dove Yanukovich fa il pieno, riportò solo le briciole. Difficile
che possa ribaltare il copione e scrollarsi di dosso l’etichetta di partito regionale. La cosa certa,
comunque, è che l’estrema destra europea ha una sua non trascurabile variante ucraina.
45
Il boomerang delle leggi “anti-protesta”
Il Manifesto, 18 gennaio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Non sempre la politica è questione di matematica, ma oggi si guarderà anche ai numeri. È la
prima domenica dall’approvazione delle cosiddette «leggi anti-proteste» e sarà anche la piazza di
Kiev a chiarire quanta rabbia questo pacchetto, voluto dal presidente Viktor Yanukovich e votato
in fretta e furia in parlamento, ha inoculato nelle pieghe della società civile. L’opposizione,
inviperita, ha chiamato alla mobilitazione. Sulla carta ci si aspetterebbe di vedere qualche
persona in più rispetto a quelle, all’incirca diecimila, che hanno continuato a protestare in queste
ultime domeniche. Poche, rispetto a quelle confluite in piazza dell’Indipendenza, l’ampio slargo di
Kiev, sul finire di novembre e nella prima parte di dicembre. Si arrivò al milione. Ma cosa
prevedono di preciso le leggi «anti-proteste»? In sostanza un forte inasprimento delle libertà di
espressione. Qualche esempio. Da adesso non si potranno più installare tende nel corso di una
manifestazione, a meno che non ci sia il disco verde del ministero dell’interno. La pena, in caso
contrario, è di quindici giorni. La stessa che verrà affibbiata a chi, durante una protesta, indosserà
maschere o elmetti che ne impediscano il riconoscimento. Ancora. Il blocco di un edificio
pubblico verrà punito con la reclusione fino a cinque anni, sei se il palazzo verrà invece occupato.
Due se verrà resa inagibile un’arteria di comunicazione. E così via.
È difficile non vedere un nesso con le manifestazioni di questi due mesi. Si sono infatti viste tende
in piazza, si sono visti elmetti sulle teste dei dimostrati, si sono visti blocchi e occupazioni di
palazzi. Le leggi mettono in discussione anche la libertà di stampa. La diffamazione assume un più
robusto profilo penale. C’è poi una serie di passaggi vaghi che, dicono i critici, offrono alle
autorità un potere discrezionale molto accentuato. È il caso del divieto - abbastanza generico - di
diffusione di materiale estremistico via stampa, punito con la reclusione fino a tre anni. In molti,
nell’opposizione, hanno bollato queste leggi come il passo definitivo di Yanukovich verso la
dittatura. Yuri Lutsenko, ministro degli interni al tempo del governo Tymoshenko, processato
e condannato poco dopo l’avvento alla presidenza di Yanukovich (2010), graziato qualche mese
fa e pestato nei giorni scorsi in piazza, ha invece sostenuto che il presidente conta poco o nulla. Il
potere vero ce l’hanno ormai in mano i servizi e sono loro, seguendo le istruzioni che arrivano
dall’estero, i coordinatori di questo putsch. Così ha detto l’ex ministro alludendo chiaramente alla
46
Russia, con cui Yanukovich, il 17 dicembre, ha siglato un accordo alternativo a quello proposto
dall’Ue. In base all’intesa Putin ha garantito corposi sconti sul gas e prestiti per 15 miliardi di
dollari: i soldi che servivano a Yanukovich per evitare la bancarotta - Kiev era davvero al tappeto
- e gestire la situazione fino alle presidenziali di inizio 2015.
Se questo era abbastanza evidente, resta invece poco comprensibile il motivo, tattico o strategico
che sia, delle brutte leggi approvate giovedì. Forse Yanukovich pensa che, tamponata l’emergenza
finanziaria e scesa l’intensità delle proteste, possa permettersi di fare l’uomo forte. In ogni caso in
questo modo può non solo inimicarsi del tutto Bruxelles, da dove stanno fioccando severe
critiche, ma dare ai dimostranti un’ottima carta per ridare linfa alla piazza. E la domanda che tutti
si pongono è se adesso avrà il coraggio di applicare alla lettera, facendo una gran bella retata, le
misure che lui stesso ha voluto.
La rivolta in mano agli estremisti
Lettera 43, 20 gennaio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Dopo due mesi esatti la piazza è esplosa. O perlomeno un pezzo di essa, quella più radicale e
nazionalista. Il 21 novembre, alla vigilia del vertice di Vilnius che sanciva con il suo fallimento la
svolta dell’Ucraina verso la Russia, erano iniziate le manifestazioni a Kiev che per otto settimane,
ogni domenica, avevano portato nelle strade pacificamente decine migliaia di persone. Solo a
dicembre e al principio di gennaio si era assistito a provocazioni e isolati scontri, alcuni molto
duri (come quello in cui è rimasto ferito l’ex ministro degli Interni Yuri Lutsenko), ma tutto
sommato la Maidan, la piazza dell’Indipendenza culla della Rivoluzione arancione del 2004, era
rimasta immune dalla violenza. I dimostranti che hanno occupato il cuore della capitale e le forze
dell’ordine, schierate per tutto il tempo davanti ai palazzi del potere, sono rimasti quasi congelati
in attesa di una soluzione politica che sbloccasse lo stallo. Ma se da una parte il presidente Victor
Yanukovich e il primo ministro Mykola Azarov non hanno arretrato di un millimetro la loro
posizione, rifiutandosi di dimettersi e di indire elezioni anticipate come richiesto
47
dall’opposizione, dall’altra la troika antiregime non è riuscita né a trovare unità d’intenti né a
tenere unita e calma la piazza, che alla fine è finita in mano agli estremisti di destra e ai
provocatori di professione, una sorta di black bloc in salsa ucraina. Sono loro che il 19 gennaio
hanno messo e ferro e fuoco il centro della capitale ucraina.
L’immagine di Vitaly Klitschko, aggredito con getti d’estintore mentre tentava di placare lo
zoccolo duro dei manifestanti davanti alle squadre speciali in tenuta antisommossa, è quella che
simboleggia non solo la degenerazione violenta della protesta, ma che dimostra come
l’opposizione abbia perso ormai il controllo della Maidan. I gruppi radicali vicini a Svoboda, il
partito nazionalista guidato dal populista antisemita Oleg Tiahnybok, hanno abbandonato ogni
cautela, spinti dall’immobilità della politica su ogni fronte. Il giro di vite annunciato la scorsa
settimana da Yanukovich ha esasperato ulteriormente gli animi più irrequieti, che hanno deciso
di agire in proprio. È stato comunque Klitschko, il volto della rivolta moderata, a tentare di
riportare il dialogo: il suo colloquio diretto con Yanukovich, che ha promesso l’istituzione di una
commissione speciale tra governo e opposizione per uscire dall’emergenza, è il primo passo per
evitare quello che l’ex pugile ha definito essere il rischio di una guerra civile. Anche se in realtà
l’escalation nella capitale non ha contagiato il resto del Paese, è comunque vero che il pericolo di
una degenerazione è reale se il muro contro muro tra le forze politiche non sarà ammorbidito e
l’iniziativa sottratta ai gruppi violenti.
Il confronto vira verso la violenza. I gruppi nazionalisti rompono ogni indugio.
A scatenare il corpo a corpo, a Kiev, sono le leggi “anti-protesta”
con cui Yanukovich pensava di chiudere la partita. Si è sbagliato di grosso.
Se Yanukovich è stato messo sotto pressione dalle critiche della comunità internazionale per il
pacchetto di leggi restrittive adottato in un momento così delicato, i tre leader dell’opposizione
sono accusati dall’ala più dura della Maidan di non aver ottenuto nulla con le buone e di non
essere nemmeno d’accordo tra di loro su quale sia la strategia da utilizzare. Il fatto che Klitschko
abbia ottenuto un canale diretto con Yanukovich è un segnale positivo per le forze moderate, ma
può portare sul sentiero di guerra i nazionalisti di Svoboda e soprattutto la galassia di movimenti
che gira intorno al partito di Tiahnybok. I vari Pravi Sektor, Cun (Congresso nazionalisti ucraini),
48
Stepan Bandera Trident o i Patrioti ucraini, sono tutti gruppi votati più allo scontro fine a se
stesso che non al dialogo politico. Anche la maretta nella formazione di Yulia Tymoshenko, dove
l’attuale numero uno Arseni Yatseniuk sarà sostituito nei colloqui con il governo da un altro
rappresentante del partito, indica che l’opposizione è ancora lontana da una linea che soddisfi sia
la base sia la piazza. I ministri degli Esteri dell’Unione europea riunitisi a Bruxelles hanno
deplorato le violenze a Kiev, affermando che Yanukovich ha commesso un errore adottando il
pugno di ferro nel tentativo di bloccare le manifestazioni ed è vero che la maggiore responsabilità
per la risoluzione della crisi sta più nella mani della Bankova che in quelle della Maidan. Lo
scivolamento verso il radicalismo nazionalista incline alla violenza di piazza è però il pericolo
maggiore che corre ora la stessa opposizione.
Finale di partita
Il Manifesto, 21 gennaio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov definisce la situazione «fuori controllo» e ne affibbia le
colpe all’Europa. Bruxelles, dal canto suo, chiede alle parti di negoziare una soluzione concordata.
Washington continua a ventilare, minacciosa, l’ipotesi delle sanzioni. Ma tutti sono impotenti
e attendono la resa dei conti in Ucraina.
La partita, in questa fase, non si lega alla competizione tra Mosca e l’Ue, per ora vinta dalla prima
con gli accordi - 15 miliardi di dollari in prestiti e sconti sull’import di gas - dello scorso
dicembre, che hanno scongiurato la bancarotta dell’ex repubblica sovietica, facendole (ri)puntare
la bussola sul Cremlino. Stavolta tutto dipende da variabili domestiche. Dal confronto, violento, in
corso sulle strade di Kiev. A partire da domenica, giorno in cui sono scese in piazza almeno
centomila persone, la capitale s’è trasformata in un campo di battaglia. Una pattuglia di facinorosi
s’è staccata dal corpo della protesta, assiepata in piazza dell’Indipendenza e rilanciata
dall’approvazione, avvenuta giovedì, di una serie di misure, promosse dal presidente Viktor
Yanukovich, che limitano il diritto a manifestare e impongono potenzialmente il bavaglio alla
49
stampa. Questa frangia radicale di manifestanti, intorno a ulica Grushevskoho, una strada del
centro, ha iniziato a lanciare bottiglie incendiarie contro i Berkut, i reparti speciali del ministero
dell’interno, che hanno risposto con lacrimogeni e proiettili di gomma. Il Kyiv Post ha rivelato che
i violenti fanno capo principalmente a Pravyi Sektor, gruppo formato da sigle della galassia
dell’estrema destra. È gente in prima linea dall’inizio delle manifestazioni (21 novembre) contro
Yanukovich e il governo. Non attendevano che un pretesto, forte, per scatenarsi. L’hanno trovato
con il varo del pacchetto anti-proteste.
Ma a distinguersi, nella mischia, proseguita anche lunedì, sarebbero stati anche alcune decine di
titushki, provocatori ingaggiati - così dice l’opposizione - dal governo. Lavrov, quindi, non ha
torto: lo scenario, sebbene ieri non ci siano state violenze di rilievo, sembra prendere una brutta
piega. Come evolverà? L’impressione è che si stia scivolando verso lo scontro finale. Diverse le
ragioni. Primo: l’opposizione non ha il controllo sugli estremisti di ulica Grushevskoho, che con le
loro intemperanze stanno togliendo legittimità alla protesta. Secondo: la soluzione concertata alla
crisi non sembra così facile da istruire, dato che i colloqui, in queste ore, non si tengono tra
Yanukovich e i capi dell’opposizione, ma tra i delegati nominati dall’uno e dagli altri.
L’opposizione chiede le dimissioni del governo, del presidente e l’azzeramento delle misure
restrittive. Pretese eccessive, secondo i più. Yanukovich non intenderebbe accoglierle. Terzo: gli
oligarchi, i veri arbitri del sistema economico-politico di Kiev, stanno nuovamente convergendo
su Yanukovich, dopo che, quando i Berkut caricarono i manifestanti, il 30 novembre, ne
criticarono l’operato. I loro referenti in parlamento hanno votato a favore delle leggi repressive;
i loro media stanno coprendo i fatti di Kiev in modo molto meno neutrale. Quarto, infine: oggi
entrano in vigore le brutte leggi votate giovedì scorso. Yanukovich dunque può procedere con la
repressione. La domanda che tutti si pongono è se avrà davvero lo stomaco per una cosa del
genere. E in ogni caso, sia che prediliga questa opzione, sia che decida di negoziare, il presidente
s’è incartato. Ha sì ottenuto i soldi di Mosca, provvidenziali. Ma da qui in avanti sarà sempre più
ricattabile. Un’anatra zoppa.
50
Via Azarov, ma non basterà
Europa, 28 gennaio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
C’è l’impressione che la crisi, in Ucraina, potrebbe spostarsi dalle strade al palazzo. Poco fa il
primo ministro Mykola Azarov, fedele scudiero del presidente Viktor Yanukovich, ha presentato
le sue dimissioni, cercando di incoraggiare la nascita di un governo alternativo. Che includa,
possibilmente, i rappresentanti dell’opposizione e riesca a traghettare il paese fuori dalle secche
di una situazione che, nel corso delle settimane, ha preso sempre più la forma di una rivolta
aperta, diluendo quella di una semplice - benché prolungata e rumorosa - protesta. Si capirà nei
prossimi giorni, forse nelle prossime ore, che tipo di fisionomia avrà, eventualmente, la nuova
squadra di governo. Ad ogni modo è in corso, proprio adesso, una sessione speciale del
parlamento (Rada), in cui oltre alle dimissioni di Azarov ci sono sul tavolo diverse altre cose. È il
caso della cancellazione della «legge anti-proteste» che sono state abrogate, un pacchetto di
misure da stato di polizia approvato una dozzina di giorni fa dalla maggioranza parlamentare, su
impulso di Yanukovich. Si discute anche della possibile revisione della costituzione, con
spostamento dell’asse istituzionale dalla presidenza al parlamento.
Yanukovich avrebbe aperto, su questi due punti. Ma pretenderebbe che i dimostranti si schiodino
dalla piazza e dai palazzi del potere di Kiev (comune, sede sindacati, ministeri dell’energia e
dell’agricoltura) che risultano occupati, togliendo inoltre l’assedio alle sedi dei governatorati
regionali, alcune delle quali sono nelle loro mani. Yanukovich tiene inoltre ancora in mano, allo
scopo di esercitare pressione, la carta dello stato d’emergenza.
L’opposizione, così dicono le notizie in arrivo dall’Ucraina, sostiene che le dimissioni di Azarov
siano solo un modo per salvare la faccia del presidente. Così ha spiegato Vitali Klitschko, l’ex
pugile, a capo del partito centrista Udar, che è emerso come alfiere del campo rivoluzionario.
Mentre Arseni Yatseniuk, il luogotenente della Tymoshenko, a cui Yanukovich sabato scorso ha
offerto il ruolo di primo ministro, continua a dire di non essere interessato a questo incarico.
La sensazione è che l’opposizione stia cercando di alzare la posta e ghermire il suo principale
obiettivo: l’uscita di scena di Yanukovich e la convocazioni di elezioni presidenziali anticipate (si
dovrebbero tenere altrimenti a inizio 2015), in modo da capitalizzare politicamente la protesta e
51
il concomitante calo di consenso, drastico, di Yanukovich. Nelle prossime ore emergerà qualcosa
di più preciso. Forse. Ma intanto, sempre ipotizzando che si arrivi a un’intesa, emergono dei nodi.
Uno riguarda la posizione del movimento di protesta. Molta gente sembra ostile al compromesso
e propensa a continuare la battaglia sulle strade. Klitschko e soci, dovessero sancire la tregua con
Yanukovich, riusciranno a convincerlo a sbaraccare?
Un altro punto concerne la Russia. Mosca ha un approccio molto chiaro sull’Ucraina. Gli Accordi
di associazione proposti dall’Ue e rifiutati da Yanukovich a novembre (questo il fattore
scatenante della protesta) sono stati visti come un tentativo di trascinare nello spazio occidentale
il paese, che Mosca, invece, vuole portare - pienamente o parzialmente - nell’Unione eurasiatica,
progetto strategico promosso da Putin nell’area ex sovietica. Il prestito da 15 miliardi e gli sconti
sull’import di gas concessi a dicembre a Kiev rientrano in questa cornice. Putin li ha erogati non
perché gli stia simpatico Yanukovich, ma in virtù dell’esigenza di tenere l’Ucraina legata alla
Russia. La forma che prenderà la trattativa in corso, con l’Ue che sta cercando di mediare (la
Ashton è attesa a Kiev), dovrà tenere conto anche delle «esigenze» di Mosca. In tutto questo non è
stata presa in considerazione l’ipotesi che la discussione salti del tutto. Non c’è bisogno di
segnalare che si spalancherebbe uno scenario disastroso.
L’Europa è solo un pretesto
Linkiesta, 29 gennaio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
A scatenare la protesta in Ucraina è stata la decisione del presidente Victor Yanukovich, lo scorso
novembre, di non firmare l’Accordo di associazione (Aa) con l’Unione Europea, facendo fallire il
vertice dell’Eastern partnership a Vilnius. Anziché svoltare verso Bruxelles, il capo di Stato ha
preso la strada di Mosca, firmando a metà dicembre consistenti accordi economici con Vladimir
Putin. La Russia ha l’obiettivo di integrare prossimamente l’Ucraina nell’Unione euroasiatica. Ma
la rivolta di Kiev, iniziata sotto la stella europeista, si è trasformata dopo oltre due mesi in
qualcosa di ben diverso.
52
Il braccio di ferro tra Yanukovich e la troika dell’opposizione formata da Vitaly Klitschko, Arseni
Yatseniuk e Oleg Tiahnybok è una lotta interna di potere che solo di riflesso ha a che fare con
l’Unione Europea e il cui esito non è legato certo agli sforzi tardivi di Bruxelles di mediare di
fronte a una situazione diventata quasi incontrollabile, né alla presunta influenza del Cremlino su
Yanukovich: sono gli oligarchi ucraini a spostare gli equilibri interni e a gestire da dietro le quinte
le mosse per la risoluzione della crisi. Il nuovo governo e il nuovo presidente a Kiev saranno
espressione della volontà dei poteri forti, come è accaduto ogni volta a ogni passaggio critico
nella storia dell’Ucraina dalla sua indipendenza (1991) ad oggi. La piazza che si ribella (Maidan,
in rappresentanza di tutte quelle che si sono agitate negli anni in ogni regione, dell’Est o
dell’Ovest dell’Ucraina) è una costante, i motivi iniziali mutano di volta in volta, legati
principalmente a questioni interne (2002, 2004); se questa volta il fattore scatenante è stato il
posizionamento internazionale, in fondo il problema rimane lo stesso: la volontà di cambiamento
di fronte a una classe dirigente cleptocrate e a un sistema economico oligarchico che ha bloccato
lo sviluppo del Paese, lasciando gran parte della popolazione solo con l’illusione di essere uscita
dal tunnel del comunismo.
Gli ucraini sono scesi in strada in primo luogo per mandare a casa Victor Yanukovich, che non ha
mantenuto lo straccio di una promessa elettorale dopo la vittoria del 2010 e che ha ridotto il
Paese a una succursale della propria famiglia e degli oligarchi a lui vicini. In realtà, sulla
scacchiera continentale, ha spostato più lui Kiev verso Bruxelles che non il duetto arancione Yulia
Tymoshenko-Victor Yushchenko nei cinque anni precedenti. Nel marzo 2012 l’Aa è stato parafato
ed era pronto da firmare. È stata paradossalmente proprio l’Ue che con la cosiddetta «lista Fuele»
(le condizioni dettate dal Commissario per l’allargamento Stefan Fule per arrivare alla firma vera
e propria, che andavano da riforme in vari settori alla liberazione dell’eroina della rivoluzione del
2004) ha congelato l’Accordo, lasciando spazio a Yanukovich per alzare il pezzo e far rientrare in
gioco la Russia, che solo nell’estate del 2013 ha fiutato la preda.
La Maidan europeista di fine novembre è molto diversa dalla Maidan di fine gennaio. In mezzo ci
sono oltre due mesi in cui la piazza si è trasformata, in maniera autonoma, ma anche artificiale,
seguendo il contorto percorso che la politica ha tracciato. La protesta pacifica è sfuggita in parte
di mano ai leader dell’opposizione. Le limitatissime frange estremiste hanno monopolizzato la
scena soprattutto dopo che il presidente ha dato a metà gennaio il giro di vite con l’adozione delle
53
leggi restrittive che hanno condotto all’escalation e al sangue sulle strade. Delle oltre centomila
persone che hanno riempito ogni domenica a dicembre la Piazza dell’Indipendenza ne sono
rimaste poche, lo zoccolo duro della resistenza di Kiev e chi dalle regioni occidentali viene a
rotazione a presidiare quello che assomiglia a un campo di battaglia. Qualche centinaio
rimangono sulle barricate di via Grushevski, teatro degli scontri più violenti.
Mentre presidente e opposizione sono ancora alla ricerca del compromesso sotto la regia degli
oligarchi, le preoccupazioni degli ucraini non sono tanto quelle di sapere cosa fará il nuovo
governo, se ci sarà una nuova capriola e se nei prossimi mesi sarà magari firmato l’Accordo di
associazione con Bruxelles. Il sogno europeo è appunto un sogno. Le priorità concrete sono quelle
di dare veramente e finalmente una svolta, buttando giù un sistema che però ha tutta l’aria di
resistere. Le soluzioni tecniche che si prospettano (ritorno alla costituzione del 2004) e le
prospettive di un riassetto politico in cui i meccanismi di spartizione e gestione del potere
rimangono gli stessi di sempre non fanno presagire nulla di buono. La rivoluzione ucraina del
2013/2014 rischia insomma di finire seppellendo ancora una volta l’idealismo della Maidan.
Leopoli, l’enclave ribelle
Lettera 43, 29 gennaio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Sull’edificio del consiglio regionale di Leopoli sventola la bandiera ucraina. Come sempre. Ma in
questi giorni rivoluzionari i colori nazionali azzurro e giallo hanno un significato particolare,
visto che sono anche il simbolo della rivolta contro il potere centrale e il presidente Viktor
Yanukovich, considerato filo russo e accusato di aver spostato il baricentro del Paese verso Mosca
e non verso Bruxelles, come vorrebbe l’opposizione e la gente, almeno da queste parti.
Leopoli è una della mezza dozzina di capoluoghi di regione, dove i parlamenti locali sono stati
occupati dai manifestanti europeisti e antigovernativi. Da domenica 26 gennaio, dopo un breve
tafferuglio con la polizia, i dimostranti, qualche centinaia, si sono impadroniti del palazzo. Senza
troppa fatica, dato che amministrazione e forze dell’ordine stanno dalla parte dell’opposizione.
54
Non solo da oggi. La più grande città nell’Ovest dell’Ucraina è da ormai quattro anni la roccaforte
della resistenza a Yanukovich. Il Partito delle regioni che fa riferimento al capo dello Stato,
raccoglie in questo oblast (regione) e in quelli adiacenti solo briciole: la maggioranza l’hanno i
moderati di Udar (Vitaly Klitschko) e Arseni Yatseniuk (Patria) e soprattutto Svoboda, la
formazione di Oleg Tiahnybok.
Il leader della destra radicale alle elezioni amministrative del 2012 ha, infatti, sfondato quota
30%. Sono i nazionalisti e le loro propaggini più violente e inquietanti, i gruppi estremisti che
hanno puntato alla radicalizzazione dello scontro di fronte anche all’irremovibilità di Yanukovich,
a giocare un ruolo importante per la risoluzione pacifica della crisi.
Se Klitschko e Yatseniuk hanno tentato di gettare acqua sul fuoco, Tiahnybok non ci ha nemmeno
pensato e le piazze sembrano ogni giorno più incontrollabili. A Leopoli, a dire la verità, la calma è
piatta. E se dietro le barricate del palazzo alcuni dimostranti giocano a pallone, dentro la frangia
dura, i ribelli attendono con impazienza quello che deve essere deciso a Kiev.
Nella capitale, dopo l’incontro della serata di martedì 28 gennaio tra Yanukovich e l’opposizione,
è stato fatto qualche passo in avanti, ma non certo tutti quelli necessari per riportare la
normalità. Nella seduta straordinaria del parlamento dovrebbero essere abolite o quantomeno
significativamente emendate le leggi anti-protesta, la cui approvazione ha scatenato l’escalation
degli ultimi giorni. L’accordo c’è anche sulla scarcerazione dei manifestanti, che dovrebbe
avvenire dopo la fine dell’occupazione degli edifici governativi.
È però ancora tutto da chiarire ciò che possa succedere al governo. Se il presidente ha offerto la
testa del premier Mykola Azarov (che si è dimesso e l’incarico è stato affidato ad interim
a Serghei Arbuzov), il 28 gennaio Yatseniuk e Klitschko hanno dichiarato che non sono disposti
ora a guidare l’esecutivo. Almeno a queste condizioni. L’opposizione punta a elezioni
presidenziali anticipate e vuole costringere Yanukovich a lasciare lo scranno prima della
scadenza naturale, all’inizio del 2015. Molte sono dunque ancora le incognite e per tentare di
risolvere l’ingarbugliata matassa di Kiev arriva mercoledì 29 gennaio in Ucraina anche l’alto
rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Catherine Ashton. Bruxelles, dopo il
fallimento del vertici di Vilnius, il cui flop ha dato il via alle proteste nell’ex repubblica sovietica, è
alla ricerca di una mediazione che si annuncia difficile. La crisi ucraina è anche al centro dei
55
colloqui tra l’Ue e la Russia: da un lato il presidente russo Vladimir Putin con il ministro degli
Esteri Sergei Lavrov, dall’altro i presidenti di Consiglio e Commissione europea, Herman Van
Rompuy e Josè Manuel Barroso, con Ashton che deve portare le nuove poi direttamente a Kiev.
Pressioni per una risoluzione pacifica e l’invito a non imporre lo stato d’emergenza che potrebbe
far precipitare la situazione sono state fatte dal vicepresidente Usa Joe Biden, che ha auspicato la
collaborazione tra governo e opposizione. A Leopoli si attendono gli sviluppi con speranza, ma
anche con scetticismo. Nessuno qui è disposto al compromesso e Yanukovich non è più
considerato un presidente legittimo. All’interno del palazzo regionale, due poliziotti che hanno
ormai fraternizzato con gli occupanti, sono il simbolo che questa parte del Paese è
definitivamente scappata dalle mani del suo leader.
56
4
LA FINE DI YANUKOVICH
(febbraio 2014)
L’escalation di febbraio e il fallimento della mediazione europea, con l’accordo tra
governo e opposizione controfirmato dai ministri degli esteri di Germania, Francia
e Polonia che viene ribaltato dalla piazza, conducono al cambiamento di regime. Dopo quattro anni
alla Bankova, Victor Yanukovich lascia alla fine di febbraio il palazzo presidenziale. Il capo dello
Stato fugge in Russia dopo il bagno di sangue di Maidan. Viene insediato il nuovo governo
filoccidentale sostenuto apertamente dagli Stati Uniti e guidato da Arseni Yatseniuk. Si apre poi la
questione della Crimea, la penisola sul Mar Nero destinata a staccarsi definitivamente dall’Ucraina.
Dipinto murale raffigurante l’ex presidente ucraino Victor Yanukovich (Thierry Ehrmann / Flickr)
57
Fuck the EU
Il Manifesto, 7 febbraio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
In pubblico si dice una cosa, in privato si tessono trame. La diplomazia presenta sempre due
facce. Il problema è quando quello che si pensa dietro le quinte salta fuori e scompagina tutto,
come successo ieri, quando una recente conversazione tra Victoria Nuland e Geoffrey Piatt, la
prima assistente al segretariato di stato e il secondo ambasciatore americano a Kiev, è stata data
in pasto alla rete. L’oggetto del colloquio intercettato è la crisi che sta affliggendo ormai da più di
due mesi la repubblica ex sovietica. Che si sono detti, i due? Il discorso si concentrava sull’offerta
di «larghe intese» rivolta nelle scorse settimane dal presidente Viktor Yanukovich agli esponenti
dell’opposizione e volta a tamponare il clima tesissimo sulle strade di Kiev. Arseni Yatseniuk,
l’uomo che guida il partito Batkivschyna (Patria) in assenza di Yulia Tymoshenko, agli arresti, era
stato invitato a presiedere il governo. Anche all’ex pugile Vitali Klitschko, capo del partito
centrista Udar, era stato chiesto di entrare nella squadra. Nuland e Piatt, così rivela il file, si
dicono favorevoli alla presenza di Yatseniuk nell’esecutivo, ma non a quella di Klitschko. Perché,
si potrebbe azzardare, in un governo di transizione con il Partito delle regioni di Yanukovich
potrebbe annacquare il suo potenziale elettorale in vista delle presidenziali del febbraio 2015.
In ogni caso la proposta di Yanukovich è stata bocciata e attualmente, mentre i tumulti si sono
placati, si discute ancora sulla nascita di un possibile governo di unità, dato che quello presieduto
da Mykola Azarov, fedelissimo di Yanukovich, ha rassegnato le dimissioni. Si parla anche di
riforma costituzionale e di possibili elezioni, generali e presidenziali, anticipate. Ma, sempre che
questi non siano bluff di Yanukovich, non è questo il punto. Quello che dal leak emerge è che gli
americani, a giudicare dal loro tono, danno l’impressione di avere una certa influenza sui membri
dell’opposizione ucraina, bollati come «burattini» nelle scritte in sovrimpressione, in lingua
russa, che appaiono nel file finito in rete. Come a dire che Yatseniuk e Klitschko ricevono ordini
dal dipartimento di stato. Il che, potenzialmente, li scredita.
Non è questo, però, il passaggio forte dell’intercettazione, che, accusano gli americani, è tutta
opera dei russi. Fa molto più rumore il «fuck the Eu» che la Nuland pronuncia nel momento in cui
ipotizza un coinvolgimento dell’Onu nella trattativa sull’Ucraina, lasciando intendere che
58
Bruxelles può essere tenuta in disparte. La cosa conferma che gli americani diffidano degli
europei, quando si tratta di giocare una partita importante. Questo atteggiamento, sull’Ucraina,
può spaccare il fronte occidentale. Forse ha già lasciato il segno, a giudicare dalla reazione stizzita
di Angela Merkel, già infastidita, in tempi recenti, dal pasticcio del datagate. È «totalmente
inaccettabile», secondo la cancelliera, quanto detto dalla Nuland. I dissidi tra Washington
e l’Europa avvantaggiano Mosca, che strategicamente non può permettersi che l’Ucraina sposti il
suo baricentro verso occidente. Se questo avvenisse l’Unione eurasiatica, progetto con cui Putin
intende riaggregare lo spazio post-sovietico, nascerebbe zoppo. Kiev deve farne parte o restarvi
in qualche modo agganciata. Si spiega così la pressione che Putin ha esercitato in questi mesi su
Yanukovich, portandolo a novembre a rifiutare gli Accordi di associazione di Bruxelles.
Il compromesso minacciato
Tmnews, 14 febbraio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Le trattative per la formazione di un nuovo governo continuano a Kiev tra gli esponenti della
protesta di Maidan, il parlamento e soprattutto dietro le quinte, ossia al tavolo degli oligarchi. Ma
la situazione è incandescente e rischia di diventarlo sempre di più. Se da un lato regime e
opposizione moderata si stanno adoperando nel tentativo di un compromesso che potrebbe
essere battezzato già la prossima settimana con la nomina di un nuovo premier e il varo di un
governo di transizione, dall’altro c’è chi non smette di soffiare sul fuoco. E non mancano i punti
interrogativi su come la piazza, e le frange più estremiste, potrebbero reagire di fronte a un’intesa
gestita dai poteri forti e non pienamente soddisfacente per i manifestanti che occupano il cuore di
Kiev da quasi dodici settimane. È l’ala della destra radicale, quella più intransigente e meno
incline agli "inciuci", che promette battaglia. Non si tratta solo di Svoboda e del leader Oleg
Tiahnybok: nonostante il curriculum poco presentabile è diventato comunque parte integrante
dell’opposizione che in questi giorni ha incassato il sostegno dei mediatori statunitensi ed
europei. Si tratta piuttosto delle schegge nazionaliste estreme che in queste settimane hanno
organizzato la guerriglia con le forze dell’ordine dalle barricate di via Grushshevski.
59
Pravyi Sektor (Settore di destra) - che riunisce diversi gruppi come Tryzub (Tridente), Bilyi Molot
(Martello bianco) o i Patrioti ucraini - ha già annunciato di non essere certo spaventato di fronte a
una possibile guerra civile. Il leader Dmytri Yarosh ha dichiarato che gli obbiettivi di Pravi Sektor
sono immutati e vanno dalle dimissioni immediate del presidente Viktor Yanukovich alla messa
al bando del Partito delle regioni e di quello comunista. Precisando che il gruppo non si sente
obbligato a rispettare la tregua. I tre leader dell’opposizione, Vitali Klitschko, Arseni Yatseniuk,
ma in fondo anche lo stesso Tiahnybok, rischiano insomma di trovarsi di fronte a un grosso
problema: se la Maidan, la Piazza diventata simbolo della protesta, risponde in larghissima parte
ai loro appelli, proprio perché costituita da manifestanti pacifici, la nicchia ultrazionalista è ormai
fuori controllo e ci vorrà una dura opera di convincimento per fare scendere Pravyi Sektor e
compagnia dalle barricate. Soprattutto finché dall’altra parte ci saranno movimenti antitetici,
pronti a rispondere per le rime.
Ogni fattore induce a credere che la crisi ucraina stia scivolando
verso una soluzione violenta, senza compromessi. Non è ancora chiaro
chi se ne farà interprete: se Yanukovich, se la piazza o se sia l’uno che l’altra.
A livello politico, il contraltare di Svoboda è costituito dal Partito comunista, che in queste
settimane ha contribuito all’escalation, pur non schierandosi direttamente a fianco di
Yanukovich, proponendo un’uscita dall’a crisi perenne in cui si trova il Paese con una modifica
radicale della Costituzione e l’introduzione di un sistema federale. In sostanza la divisione in due
dell’Ucraina. Una provocazione per i nazionalisti e la sacralità dello stato unitario, ma solo un
piccolo pezzo nel puzzle del confronto tra le ali estreme.
Un ruolo maggiore e più pericoloso infatti, alla pari di quello delle brigate violente della destra
oltranzista, è giocato da quelli che sono definiti con un neologismo tutto ucraino "titushki" (dal
nome di Vadim Titushko, un giovane condannato per aver malmenato un giornalista durante una
manifestazione antigovernativa lo scorso anno). Sponsorizzati dall’esterno e proprio per questo
più controllati e controllabili, i titushki non sono un gruppo autonomo, associato a un partito o a
una fazione politica. Ma agiscono come provocatori per conto terzi, scatenando scontri e
60
propagando violenza. Il rischio che la Maidan, e i suoi più immediati dintorni, a partire dal Parco
Marinski, quartier generale dei dimostranti pro Yanukovich, si trasformi ancor di più in una
polveriera non è solo in fondo un’ipotesi di scuola, soprattutto se la situazione politica dovesse
improvvisamente degenerare. Il presidente ha escluso un ricorso all’uso della forza per lo
sgombero del centro della capitale, ma le squadre speciali sono sempre pronte a intervenire. Per
domenica prossima è annunciata a Piazza dell’Indipendenza l’ennesima adunata durante la quale
la troika dell’opposizione illustrerà al popolo rivoluzionario le prossime mosse.
Il giorno più lungo
Il Manifesto, 18 febbraio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Nelle ultime settimane c’era stata una tensione calma, a Kiev. I dimostranti hanno frenato i loro
impulsi, tenendo d’occhio le trattative in corso tra il presidente Viktor Yanukovich e le
opposizioni parlamentari. Le forze di sicurezza non hanno ronzato nel centro della capitale. Era
fragile, ma era tregua. Ieri tutto è saltato. Bottiglie incendiarie, cariche, pestaggi e colpi d’arma da
fuoco, esplosi dall’una e dall’altra parte: è stata la giornata di scontri più feroce da quando, il 21
novembre, il paese ha preso la strada della crisi. L’origine dei guai è stato il no di Yanukovich agli
accordi commerciali offerti dall’Ue, orientati a rafforzare la cooperazione con Kiev e diluire di
conseguenza l’influenza russa. Ci sono stati diversi morti. C’è chi dice tre, chi cinque, chi dieci.
Due sarebbero poliziotti. Centinaia i feriti.
Il bollettino potrebbe aggravarsi. Le forze di sicurezza sono intervenute in piazza
dell’Indipendenza, la spianata dove finora l’opposizione aveva tenuto i suoi raduni di massa
pacifici. Il governo ne aveva intimato lo sgombero entro le sei del pomeriggio. È stata sparata
acqua sui dimostranti. S’è udita a un certo punto una forte esplosione. Ci sono fiamme
dappertutto e colonne viscose di fumo. Tutte le stazioni della metro sono state chiuse. Il traffico
bloccato. Le cose sono due: o è la resa dei conti o una prova di forza per dare a Yanukovich un
potere negoziale ancora più robusto.
61
Questa svolta violenta arriva dopo che lunedì le autorità avevano reso efficace una misura
d’amnistia, volta a cancellare i procedimenti a carico di più di duecento esponenti di Euromaidan
- così si chiama il fronte anti-Yanukovich - coinvolti negli scontri registrati tra il 27 dicembre e il
2 febbraio. In cambio, la stessa Euromaidan era tenuta a schiodarsi dai palazzi del potere
occupati a Kiev e nell’ovest del paese. Solo alcuni sono stati abbandonati. Una mossa per tenere
alta la pressione su Yanukovich in vista della sessione parlamentare di ieri, durante la quale
l’opposizione pretendeva una discussione sulla riforma della costituzione, per limare i poteri
della presidenza. È una delle richieste più incalzanti recapitate a Yanukovich, assieme alla
convocazione di elezioni presidenziali anticipate, rispetto alla data del febbraio 2015. Gli
emendamenti alla legge fondamentale non sono stati messi in agenda (in ogni caso non sarebbero
passati) e il campo anti-Yanukovich, come preannunciato, ha rilanciato la protesta sulle strade,
dirigendosi verso il parlamento con l’intenzione di esercitare un blocco. Dopodiché è scoppiato il
finimondo. Le frange radicali dei manifestati, ormai composte non più soltanto da militanti
dell’estrema destra (Pravyi Sektor la sigla più agguerrita), hanno assaltato un circolo di ufficiali
delle forze armate e la sede del Partito delle regioni, di cui Yanukovich è il numero uno. Le forze
di sicurezza, da parte loro, non sono rimaste ferme. Ci sono state zuffe furibonde, sono volate
pallottole. Poi gli agenti hanno spinto progressivamente indietro i dimostranti, praticamente fino
a piazza dell’Indipendenza.
Questa evoluzione rende difficile la ricerca di una soluzione negoziata alla crisi. Yanukovich,
secondo qualche analista, avrebbe pilotato la situazione verso questo esito. Finora ha concesso
all’opposizione solo misure palliative (ritiro delle leggi «anti-protesta», dimissioni del primo
ministro Mykola Azarov e amnistia «vincolata»). Ma su costituzione e voto anticipato non ne ha
voluto sapere. In questo modo ha lasciato che il nervosismo continuasse a serpeggiare tra i rivali,
lasciando buone scorte di benzina ai segmenti più intransigenti del movimento. In altre parole, si
sarebbe costruito l’opzione repressiva.
Si mormora che su questo ci sia il consenso del Cremlino. Non ha stima di Yanukovich, ma sa che
è l’unico che può garantire che la Russia conservi influenza in Ucraina, legandola in forma più
o meno intensa all’Unione eurasiatica, progetto strategico con cui Putin vuole potenziare
l’amalgama tra i paesi post-sovietici. L’annuncio dell’imminente liquidazione di una seconda rata
del prestito da 15 miliardi concesso all’Ucraina lo scorso dicembre, alternativo agli accordi targati
62
Ue e necessario a schivare lo spettro bancarotta a Kiev, può essere visto come l’incoraggiamento
a riprendere il controllo della situazione.
Yanukovich, oltre che a Mosca, guarda alla Crimea. È l’unica regione dove i russi, in Ucraina,
costituiscono la maggioranza etnica. In queste settimane i politici locali gli hanno chiesto di usare
il pugno duro, rivendicando al contempo maggiore autonomia amministrativa. Non va
dimenticato che nel ‘91, quando l’Ucraina divenne indipendente, in Crimea ci furono tensioni. Né
che a Sebastopoli, importante centro della regione, è ancorata la flotta russa sul Mar Nero. Se si
apre una faglia in Crimea la tenuta territoriale dell’Ucraina può essere messa a repentaglio. In
tutto questo sembra che Bruxelles, che esorta Yanukovich e l’opposizione al compromesso,
sostenendo però in modo tutt’altro che indiscreto la seconda, possa virare verso le sanzioni
finanziarie a Yanukovich e ai suoi fedelissimi. Dipenderà da cosa succederà nei prossimi giorni.
Ma le trattative, se riprenderanno, vedranno Yanukovich in chiaro vantaggio negoziale.
Ci sono davvero due Ucraine?
Il Manifesto, 20 febbraio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Il terremoto di Kiev non ha tardato a farsi sentire a Leopoli, la principale citt{ dell’occidente
ucraino. Alla notizia degli scontri furibondi di lunedì nella capitale, con la loro coda di sangue, il
campo anti-Yanukovich s’è scatenato, assaltando e occupando le sedi di governo regionale, polizia e procura generale. Leopoli non è nuova a queste fiammate. Ce ne sono state diverse, da
quando il 21 novembre, con il no di Yanukovich agli accordi commerciali proposti dall’Ue, è scoppiata la crisi. Impulso e coordinamento sono venuti principalmente da Svoboda, il segmento più a
destra dell’opposizione. Un partito ultra-nazionalista, con tendenze anche fasciste ma capace,
come per le politiche del 2012, quando andò in doppia cifra, di intercettare il voto di protesta.
Leopoli è la roccaforte di Svoboda. Anche gli altri partiti dell’opposizione, quelli di Yulia Tymoshenko (Patria) dell’ex pugile Vitali Klitschko (Udar), rastrellano comunque parecchi voti da
quelle parti. Scarso il radicamento del Partito delle regioni di Viktor Yanukovich, che a gennaio,
63
tra l’altro, ha chiuso i propri uffici cittadini. Una vera e propria ritirata. A ovest, Leopoli non è un
caso isolato. Pure Ivano-Frankivsk, Ternopil, Lutsk e Rivne, città dove le opposizioni hanno un
certo peso elettorale, schiumano rabbia contro il presidente e la sua cricca.
Sull’altro versante del paese, a est, i sentimenti sono opposti. Le proteste contro Yanukovich sono
state sporadiche e il Partito delle regioni, che qui è egemone, le ha contenute azionando la macchina della propaganda e mobilitando i militanti, spalleggiati dai titushki, provocatori in odore di
malavita. Euromaidan - il nome del movimento anti-presidente - è percepito come una rognosa
banda di golpisti. L’astio è ancora più esplicito in Crimea, nel sudest. È una regione particolare.
Fino al 1954 faceva parte della Russia sovietica. La maggioranza etnica è russa. L’unico caso, in
tutta l’Ucraina. Nel porto di Sebastopoli, inoltre, Mosca tiene ancorata la flotta sul Mar Nero,
secondo accordi stabiliti al tempo dell’indipendenza ucraina (1991) e rinnovati dopo che nel
2010 Yanukovich è salito alla presidenza. Durante la crisi i politici della Crimea hanno ripetutamente accusato Yanukovich di essere troppo morbido con Euromaidan, hanno votato la messa al
bando di Svoboda e rivendicato inoltre maggiore autonomia amministrativa. Qualcuno s’è spinto
a formulare la richiesta di unione con la Russia. Emerse anche al tempo nel periodo successivo
all’indipendenza, sopraggiunta nel 1991.
Non è difficile capire, osservando quanto avviene a Leopoli e in Crimea, che il solco che storicamente corre storicamente lungo l’asse est-ovest, temperato da una fascia mediana neutra che da
Kiev scende a sud seguendo grosso modo il corso del fiume Dnepr, si sta pericolosamente approfondendo. L’ovest ucraino è la culla di un’idea nazionale cucita in buona misura sul rifiuto
dell’influenza russa. Leopoli, a lungo controllata dalla Polonia, ne è il centro di irradiazione. La
chiesa greco-cattolica, di rito orientale ma subordinata al Vaticano, uno degli interpreti, nonché
grande fattore di discordia tra papato e patriarcato di Mosca. Secondo il quale i greco-cattolici,
che hanno esplicitamente sostenuto Euromaidan, sono la longa manus pontificia nelle terre
ortodosse. Sull’altro lato del paese, a est (con Odessa, nel sud), la Russia proietta la sua ombra,
con la Crimea a fare da avamposto. I legami tra queste regioni e Mosca sono industrialmente, economicamente e culturalmente strettissimi.
Di questi tempi si evoca lo spettro della secessione. Dell’ovest dall’est o viceversa. C’è chi vaticina
la ripetizione del dramma jugoslavo. Forse non s’arriver{ a tanto, ma è possibile che lo squilibrio
regionale si aggravi, con le due anime del paese decise a difendere con vigore le proprie specifi-
64
cità, rimarcando le diversità. Non è casuale, quindi, che si parli di riformare la costituzione in o
federale. L’hanno fatto i comunisti di Petro Symonenko, alleati in parlamento del Partito delle
regioni. Per Symonenko la federalizzazione è l’unico modo per tenere insieme, riconoscendone le
caratteristiche, i due polmoni ucraini. Anche qualche esponente del Partito delle regioni ha caldeggiato la prospettiva. Così come Viktor Medvedchuk, capo del movimento Scelta ucraina, ostentatamente filorusso. La cosa, dato che Medvedchuk è considerato il pasdaran di Putin a Kiev, ha
portato a pensare che il Cremlino sarebbe orientato a rinunciare all’influenza su tutta l’Ucraina,
riservandosi il controllo sullo spicchio più gestibile: l’est, logicamente.
Dall’altra parte della barricata la proposta è stata seccamente respinta. Da tutti. Per l’opposizione,
la federalizzazione ucciderebbe l’unit{ dell’Ucraina, ammesso che esista davvero. Quanto a Yanukovich, ha riferito che la rimodulazione dei rapporti centro-periferia non è in agenda. Tuttavia la
perorò dopo la rivoluzione arancione, con lo scopo di compensare la sconfitta inferta dal duo
Yushchenko-Tymoshenko. Una volta al potere, però, ha riposto il discorso. Forse perché l’idea di
governare tutto il paese dà adrenalina. Forse perché gli oligarchi, i veri padroni dell’ex repubblica
sovietica, con l’enorme peso industriale e mediatico che hanno, non vogliono erigere una staccionata in mezzo alla riserva di caccia.
Accordo senza soluzione
Linkiesta, 21 febbraio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
L’accordo a Kiev é stato raggiunto. Presidente e opposizione hanno siglato un documento che
contiene una road map per uscire dalla crisi dalla quale il Paese si è infilato esattamente tre mesi
fa. Il 21 novembre scorso erano infatti iniziate le prime manifestazioni sulla Maidan di Kiev e nel
resto del Paese, soprattutto all’Ovest, contro la svolta filorussa del presidente Victor Yanukovich
che non aveva firmato a Vilnius l’Accordo di associazione con l’Unione europea. C’è da chiedersi
se ci volevano veramente trentasei settimane e un centinaio di morti in tutta l’Ucraina per
partorire un compromesso del genere. Ma probabilmente non c’era altra via di uscita con lo
65
spettro di una guerra civile alle porte. L’intesa è in realtà una cornice dentro la quale i
protagonisti si possono muovere con una certa libertà e verte essenzialmente su sei punti: un
nuovo governo di unità nazionale con la partecipazione dell’opposizione che dovrebbe insediarsi
in una decina di giorni, la modifica in senso parlamentarista della Costituzione (subito il ritorno
alla Carta del 2004, con il ridimensionamento dei poteri del presidente a favore di quelli del
premier e della Rada, poi una riforma tutta da discutere entro settembre), elezioni presidenziali
anticipate da tenere entro la fine dell’anno, un’indagine sull’escalation della violenza sotto il
controllo europeo, il divieto per il governo di introdurre leggi di emergenza e utilizzare la forza,
associato allo sgombero degli edifici occupati dai manifestanti e alla deposizione delle armi, e la
cessazione immediata di ogni confronto e violenza.
Se i mediatori dell’Unione europea hanno valutato positivamente l’esito delle trattative che negli
ultimi due giorni hanno impegnato nella capitale un manipolo di ministri degli Esteri, in cui il
ruolo fondamentale è stato giocato dal tedesco Frank Walter Steinmeier, quello russo Vladimir
Lukin, arrivato la notte scorsa a Kiev su richiesta espressa di Yanukovich, non è sembrato
entusiasta e non ha messo neppure la firma sul documento finale. Ma già il suo invio da parte di
Vladimir Putin, e non quello del ministro degli Esteri Sergei Lavrov, buldozzer abituato alle crisi
internazionali, era stato il segnale che comunque la Russia sarebbe stata alla finestra, lasciando la
patata bollente all’Europa e Yanukovich nel suo brodo. Da Mosca hanno fatto sapere nel
frattempo che sono pronti a collaborare con il prossimo inquilino della Bankova e il prossimo
governo a Kiev, di qualunque colore esso sia.
La realtà è che se l’accordo aiuta a disinnescare l’emergenza, pone sul tavolo nuovi punti
interrogativi. La questione su chi guiderà il gabinetto di transizione è in fondo quella meno
rilevante, anche se simbolica. Il ritorno alla Costituzione del 2004, approvato oggi alla Rada in
seduta straordinaria, non è certo la soluzione a tutti i problemi del Paese, dato che la divisione di
competenze tra presidente e primo ministro realizza sì una divisione dei poteri, ma conduce
anche a blocchi istituzionali. Tutte cose già viste tra il 2005 e il 2010 che hanno portato al
naufragio della rivoluzione arancione, arenatasi nei conflitti tra il presidente Victor Yushchenko e
la premier Yulia Tymoshenko.
L’intesa odierna non impone un calendario preciso, per cui è prevedibile una lunga fase, appunto
almeno sino a settembre, in cui il presidente Yanukovich e il futuro primo ministro potranno
66
scontrarsi. La data delle elezioni sarà un altro motivo di screzi, dato che l’ala dura
dell’opposizione, sia parlamentare che extra, punterà i piedi per accelerare i tempi. I problemi
maggiori nascono proprio sul fronte dell’ala radicale della Maidan, dalle frange ultranazionaliste
radunate sotto l’ombrello di Pravy Sektor, che hanno già definito insoddisfacente l’accordo e
hanno annunciato il prosieguo della rivoluzione. Per ora si tratta di minacce, ma gli eventi
dell’ultima settimana dimostrano che il leader Dmitry Yarosh alle parole è abituato a far seguire i
fatti. A Kiev e nei capoluoghi delle regioni occidentali dell’Ucraina, da Leopoli a Ivano Frankivsk,
da Ternopil a Lutsk, sarà difficile far digerire agli ultranazionalisti il compromesso. E il compito di
Olegh Tiahnybok di contenere la galassia che gravita intorno al suo partito Svoboda non è
proprio dei più semplici, considerando il fatto che al populista destrorso antisemita il ruolo di
pompiere si addice poco.
Le incognite del dopo-Yanukovich
Lettera 43, 24 febbraio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Con il mandato di cattura per Viktor Yanukovich si chiude definitivamente in Ucraina l’era
cominciata quattro anni fa, quando l’allora presidente entrò trionfante alla Bankova dopo aver
battuto in elezioni democratiche la sua rivale di sempre Yulia Tymoshenko. Poi la svolta
autoritaria, la giustizia selettiva, il braccio di ferro per l’Accordo di associazione con Bruxelles e
quello sui prezzi del gas con la Russia, fino all’epilogo drammatico e il sangue sulla Maidan. In
attesa di vedere quando e dove possa spuntare l’ex presidente, che ha fatto perdere le sue tracce
da un paio di giorni, è iniziata lunedì 24 febbraio a Kiev la settimana decisiva per la formazione
del governo.
Un accordo parlamentare ancora non c’è, anche se adesso il compromesso va trovato all’interno
delle diverse anime di quella che era l’opposizione moderata e ora è diventata la maggioranza.
Sull’intesa pende però il veto della piazza e dei gruppi radicali che sono contrari a un inciucio con
lo zampino degli oligarchi. Tymoshenko, libera da un paio di giorni e che per sua bocca e dei suoi
67
fedelissimi aveva annunciato nelle prime ore dopo la scarcerazione di volersi candidare alla
presidenza e tornare subito alla politica attiva, ha dovuto fare marcia indietro. Fiutata l’aria
pesante e l’umore freddo della Maidan, insomma, è per sue parole già fuori dai giochi, mentre ha
comunque posizionato il suo braccio destro Olexander Turchinov alla guida della Rada (il
parlamento ucraino), e di riflesso del Paese, come presidente ad interim. Per il resto si deve
attendere la campagna elettorale per le elezioni del 25 maggio che ufficialmente è appena
iniziata. Il nodo più urgente è ora quello del nome del primo ministro. Sul tavolo rimangono i
nomi di Petro Poroshenko e Arseni Yatseniuk, rappresentanti in maniera diversa dei poteri forti,
ma che non godono di molto favore sulla Maidan. Anche Vitaly Klitschko è in corsa, su di lui fa
affidamento la Germania, con la quale l’ex pugile ha un rapporto molto stretto attraverso la
Konrad Adenauer Stiftung, la fondazione cristianodemocratica della Cdu, il partito della
cancelliera Angela Merkel. Al terzo leader della vecchia opposizione, il populista di destra Oleg
Tyhanybok, spetta il compito di far digerire alle frange ultranazionaliste l’inevitabile futuro
compromesso, che rischia di tramutarsi nel solito mercato delle vacche: lo stesso Yatseniuk si è
detto disposto a offrire poltrone ministeriali e amministrative ai rappresentanti della Maidan.
Yanukovich si dà alla fuga. Si apre una fase incerta, dove si cercherà
di trovare nuovi equilibri di potere, tanto a Kiev quanto a livello internazionale.
Occhi puntati, intanto, sulla Crimea.
Resta da vedere quale ruolo possa avere in un futuro governo Svoboda, l’ala estrema che in
Europa sarebbe impresentabile e che Bruxelles in questi mesi di protesta ha di fatto ignorato,
sino al dramma finale, salvo poi ricordare - come ha fatto domenica 23 febbraio la cancelliera
tedesca nella sua telefonata con Tymoshenko - che il problema dell’integrità territoriale è ancora
all’ordine del giorno.
Merkel ha invitato l’eroina della rivoluzione arancione a non soffiare sul fuoco, alimentando il
vento nazionalista e antirusso che dalle roccaforti occidentali e dalla Maidan di Kiev ha spirato in
queste settimane. La questione della spaccatura dell’Ucraina è tornata all’ordine del giorno, dopo
che di riflesso in Crimea si sono risvegliati gli spiriti indipendentisti rinfocolati da Mosca. Qui la
68
maggioranza è russa, dal punto di vista etnico e linguistico, e vicina al Cremlino da quello politico.
A Sebastopoli c’è la base della flotta russa, importante chiave strategica ed economica per la
regione. Tensioni già vissute 10 anni fa, quando nel 1994 si arrivò quasi al punto di rottura e i
movimenti separatisti e filorussi dovettero allora accettare la nuova costituzione che poi regolò i
rapporti tra Kiev e la penisola diventata ucraina ai tempi dell’Unione sovietica. Regalata da Nikita
Krusciov nel 1954, 60 anni dopo la Crimea rischia di diventare una nuova polveriera. Per il futuro
governo di Kiev la sfida per il mantenimento dell’unità dello Stato comincia proprio dalle sponde
del Mar Nero.
Ritratto di un vinto
Il Manifesto, 24 febbraio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Viktor Yanukovich è ufficialmente ricercato. I vincitori vogliono trascinare il vinto al banco degli
imputati, assieme ai principali responsabili delle stragi di Kiev. Ma devono stanarlo. Non si sa
dove sia. Il deposto presidente ucraino ha cercato goffamente di svignarsela in Russia, ma è stato
fermato alla frontiera. Magari ci ha riprovato, riuscendoci, sempre che chi alloggia al Cremlino lo
voglia accogliere, visto il disastro che ha combinato. Ma potrebbe anche essere in qualche lembo
dell’est ucraino o della Crimea, coperto da chi non gli ha ancora voltato le spalle. Ammesso che
abbia ancora sponde, che siano nei servizi o nel Partito delle regioni, che lo ha ripudiato, in tutta
fretta, dopo averlo sostenuto compattamente fino a qualche giorno fa. Qualcuno, infine, mormora
che già sia stato arrestato. Le voci si moltiplicano. Le tracce sono tante, tutte poco chiare. Le uniche sicure sono quelle che l’ex capo dello stato ha lasciato nel corso della sua lunga carriera politica. Proviamo a seguirle. Ripercorriamo la sua parabola.
Viktor Yanukovich nasce nel 1950 a Yenakieve, centro urbano che conta oggi centomila abitanti,
situato nell’oblast (regione) di Donetsk, il più grande bacino industriale dell’ex repubblica sovietica. Il cosiddetto Donbass. Carbone e metalli le due attività che ne trainano l’economia. Perde
a due anni la madre, un’infermiera. Poco più tardi muore anche il padre. Viene cresciuto dalla
69
nonna. In età adolescenziale subisce due condanne penali, nel 1967 e nel 1970. Rapina e rissa.
Inizia poi a lavorare nell’industria del Donbass, ramo trasporti. Si laurea, prende la tessera comunista, diventa anche dirigente d’azienda.
Nel 1991 crolla l’Urss, nasce l’Ucraina indipendente e l’economia passa dallo stato a una ristretta
cerchia di privati, non senza processi opachi, se non criminali. È la genesi del sistema oligarchico
ucraino, dove a differenza della Russia di Putin non sono gli affari a dipendere dalla politica, ma
quest’ultima a prendere ordini dai primi. L’area di Donetsk, con la sua concentrazione di miniere
e fabbriche, si afferma come il centro principale del potere oligarchico. Rinat Akhmetov è l’uomo
che più di ogni altro accumula risorse.
Gli oligarchi del Donbass, a met{ degli anni ’90, realizzano che per contare ancora di più a Kiev
serve un vero partito e servono dei deputati. Nel 1997 viene fondato il Partito della rinascita
regionale (diverrà Partito delle regioni nel 2001), legato alla finanza oligarchica e propenso
a mantenere rapporti forti con Mosca, anche se non di totale vassallaggio. In quello stesso anno
Yanukovich diventa il governatore dell’oblast di Donetsk, dopo essere stato cooptato
nell’esecutivo regionale, come numero due, da appena qualche mese. Prima di allora non aveva
avuto cariche politiche. È chiaro: Yanukovich è l’uomo di Akhmetov e degli altri industriali,
è manovrabile. Ma ha anche ambiziosi personali enormi, come vedremo tra poco.
L’esperienza a Donetsk dura fino a quando nel 2002 il presidente Leonid Kuchma, sotto il quale il
sistema oligarchico ha assunto la sua forma pervasiva, lo nomina primo ministro. Nel 2004 Yanukovich si candida alla presidenza. Va al ballottaggio contro Viktor Yushchenko, vince. Ma scoppia
la protesta, si grida alla manipolazione del voto. Yushchenko e l’alleata Yulia Tymoshenko portano migliaia di persone in piazza. Si pretende, ottenendola, la ripetizione del ballottaggio. Stavolta la conta premia Yushchenko.
La stagione arancione evapora rapidamente. I ricatti energetici dei russi e la rivalità tra Yushchenko e la Tymoshenko, nominata primo ministro, fanno saltare la coalizione. Si va alle urne.
Yanukovich si afferma e va a fare il primo ministro. È il 2006. Seguono mesi infuocati, di presunte
compravendite di deputati e tensioni con il presidente Yushchenko, che nell’autunno del 2007
scioglie il parlamento e rimanda tutti a votare. Il Partito delle regioni si assicura la maggioranza
relativa, ma non riesce a formare una coalizione. Tocca ancora alla Tymoshenko, che governa fino
70
al 2010, quando a inizio anno si tengono le presidenziali: il vero, grande obiettivo di Yanukovich.
Riesce a centrarlo, anche grazie a una campagna che punta a svincolarlo dall’immagine di uomo
legato alla Russia. Sconfigge la Tymoshenko al secondo turno e prende possesso delle stanze
della Bankova, sede della presidenza.
Da capo dello stato sdogana la sua voglia incontenibile di strapotere e di soldi. La storia della sua
presidenza dice che ogni decisione, ogni manovra, ogni nomina, è stata organica a questo scopo.
Yanukovich ha cercato innanzitutto di diluire il peso di Akhmetov, concedendo sempre più spazio, nel Partito delle regioni, in parlamento e nelle istituzioni, a Dmytro Firtash, barone
dell’energia. Non è della cricca del Donbass. Perché tutto questo? Semplice. Mettendo un contrappeso a quelli del Donbass, che hanno comunque continuato a lucrare pesantemente, Yanukovich
ha cercato di ritagliarsi spazi di manovra maggiori.
Rientra in questa logica il ritorno alla costituzione presidenzialista in vigore prima della rivoluzione arancione, che impresse invece una svolta parlamentarista. Rafforzati formalmente i suoi
poteri, Yanukovich ha iniziato a piazzare i suoi uomini nei posti che contano. Solo due esempi.
Serhiy Arbuzov, ritenuto il suo ragioniere, è andato alla Banca centrale. Al vertice del fisco è stato
messo invece Oleksandr Klimenko, vicino a Oleksandr Yanukovich, uno dei due rampolli dell’ex
capo dello stato. Su Oleksandr Yanukovich va fatto un discorso più ampio. È il titolare della holding di famiglia (Mako) e in questi anni le sue fortune sono lievitate notevolmente. C’è quasi
l’impressione che gli Yanukovich abbiano voluto elevarsi a oligarchia e che anche la politica
estera sia servita a questo. Yanukovich ha cercato di non farsi assorbire da Mosca e di potenziare
il dialogo con l’Europa, tentando tutto sommato di restare nel limbo e dunque di evitare controllori esterni troppo curiosi. Ma è finita malissimo.
71
La penisola della discordia
Il Manifesto, 26 febbraio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
I nazionalisti stanno mettendo il timbro, politico e simbolico, alla loro ascesa. Danno la caccia
a Yanukovich, diffondono le sue carte e buttano giù le statue di Lenin e del generale Kutuzov.
Dall’altra parte, nell’est del paese, si risponde gridando al golpe nazista, all’antisemitismo dei
segmenti più radicali della rivolta e alle trame degli occidentali, oltre che ribadendo il legame con
Mosca. L’Ucraina è lacerata e c’è chi ne ipotizza la scissione, ricordando che anche in Jugoslavia le
cose erano iniziate più o meno così. Ma, non è automatico che l’ex repubblica sovietica si scinda.
Al momento, fino a prova contraria, pare di assistere a una sfida di posture, orientata a tracciare
nuovi equilibri, in cui ognuno lambisce la linea rossa senza superarla. Il punto di tensione
maggiore è la Crimea, contesto già storicamente sensibile. È l’unico lembo d’Ucraina dove i russi
sono maggioranza etnica. Il loro peso demografico è all’incirca del 60% e c’è una lunga storia di
frizioni con le minoranze ucraina e tatara, quest’ultima pari grosso modo al 15% della
popolazione. Nel porto di Sebastopoli è inoltre ancorata la flotta russa sul Mar Nero, sulla base di
accordi contratti dopo il crollo dell’Urss (1991) e rinnovati all’indomani della vittoria di
Yanukovich nel 2010. L’intesa prevede che le navi di Mosca restino a Sebastopoli fino al 2042.
I russi arrivano a chiedere l’unione con Mosca. L’hanno fatto anche ieri a Simferopoli, il capoluogo
regionale, trovandosi però davanti un altro corteo, con una discreta presenza tatara, che ha
rivendicato la coesione territoriale. Le due manifestazioni si sono tenute davanti all’assemblea
regionale, dove si discuteva sulla posizione da assumere davanti al regime change di Kiev. Non s’è
messa agli atti l’ipotesi dello scisma, ma c’è chi vorrebbe ripristinare l’assetto dei primi anni ‘90,
che assicurava un tasso di autonomia maggiore rispetto a quello odierno e prevedeva l’elezione
di un presidente. Questa proposta è sul tavolo da prima che le cose a Kiev precipitassero.
I politici russi della Crimea, già all’indomani dell’inizio delle proteste, lo scorso novembre,
avevano chiesto a Yanukovich di reprimere senza indugi, rivendicando al tempo stesso più
funzioni amministrative. Una doppia forma di pressione sul deposto capo dello stato,
assecondata, come riportato da Radio Free Europe, da una campagna martellante organizzata da
un’associazione, finanziata da non si sa chi, ma dal nome inequivocabile: Stop Maidan. I suoi
72
attivisti hanno appiccicato sui muri delle città della Crimea manifesti in cui si denunciavano le
pulsioni eversive del fronte anti-Yanukovich. Non basta. Il consolato russo a Simferopoli, negli
ultimi tempi, ha intensificato la tradizionale politica di concessione allegra di passaporti russi,
sebbene le autorità di Mosca smentiscano. Mentre a Sebastopoli la gente è scesa in piazza e ha
preteso, a inizio settimana, la nomina di un russo a sindaco. La scelta è caduta su Alexei Chaliy,
uomo d’affari, che ha subito annunciato la costituzione di ronde civili di autodifesa. Il fatto che
Chaliy abbia passaporto russo, cosa che poneva qualche problema legale alla sua nomina, è stato
tranquillamente bypassato. Radio Free Europe ha riferito che verso il 10 di febbraio è giunto
a Simferopoli Vladislav Surkov, eminenza grigia del putinismo. Il che suggerirebbe che Mosca,
fiutando la fine di Yanukovich, abbia suggerito ai suoi referenti in loco di fare baccano, nel
tentativo di usare la Crimea come grimaldello nella partita in corso sui nuovi equilibri politici del
paese. Ma il Cremlino dispone di altre leve capaci di impedire ai nazionalisti di spostare
radicalmente il baricentro verso l’Europa: l’energia, il debito che vanta verso Kiev, i rapporti
commerciali, industriali e finanziari, come il potere degli oligarchi, che non vogliono troppe
seccature con le riforme, né perdere la sponda del mercato russo. Verrebbe da pensare che la
secessione della Crimea sia più una storia di tattica che un’opzione fondata, fermo restando che
nulla va scartato.
Ciò che è certo è che sembra d’assistere a una replica di quanto avvenne nei primi anni ‘90, sulla
scia del crollo dell’Urss e della contestuale indipendenza ucraina. Nella regione, passata nel 1954
dalla Russia all’Ucraina per volere di Nikita Krusciov, che scaricò su Kiev il fardello del
mantenimento della Crimea (all’epoca l’economia locale era a terra), emersero spinte
centrifughe. I russi temevano l’ucrainizzazione e propugnavano l’unione con Mosca, con
l’economia scricchiolante a cementare questo sentimento. Gli ucraini, dal canto loro, si
opponevano. I tatari lo stesso, se possibile con maggiore fermezza: non volevano farsi governare
da chi, durante la seconda guerra mondiale, li aveva deportati. L’accusa, si sa, fu quella di
collaborazionismo con i nazisti. Allora l’emergenza rientrò. Stavolta?
73
Il ritorno di Yulia
Pagina 99, 27 febbraio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
I primi giorni del dopo Yanukovich non promettono nulla di buono. Forse perché il dittatore
spazzato dalla Maidan era ritenuto tale solo in metà del Paese. Nell’altra, Victor Federovich, pur
corrotto fino al midollo, era pur sempre considerato il capo di Stato legittimo. In attesa di vedere
in quale parte dello spazio post-sovietico l’ex presidente spunterà, l’Ucraina si trova di fronte alla
grande sfida di rimanere unita. Non si tratta tanto del rischio che l’ex repubblica sovietica si
spacchi in due, quanto di quello di perdere un pezzo, con la Crimea che ribolle in seguito a un
cambio di regime in cui il ruolo degli ultranazionalisti di Svoboda e dei gruppi paramilitari legati
a Pravyi Sektor ha giocato un ruolo determinante nell’accelerazione dell’ultima settimana.
Il governo che ha appena preso forma è ancora un’incognita: ma anche senza l’ombra del Partito
delle regioni, ridotto a una esile pattuglia senza generale alla Rada, le tensioni tra le varie forze
che prima erano all’opposizione e ora devono dividersi poteri e responsabilità mettono grossi
punti interrogativi sull’uscita breve e indolore dalla transizione. Considerando anche i problemi
sul tavolo, dall’emergenza economica alla Crimea che freme. Mentre Vitaly Klitschko si è
chiamato fuori dalle questioni governative, annunciando la sua candidatura alle presidenziali del
25 maggio e Yulia Tymoshenko ha fatto altrettanto e dopo le cannonate sparate dalla Maidan ha
deciso di tenere un basso profilo, a Kiev il bandolo della matassa è in mano a tre gruppi che più
eterogenei non potrebbero essere: i moderati di Arseni Yatseniuk, gli oligarchi capeggiati da
Petro Poroshenko e i nazionalisti divisi sulle posizioni estremiste di Oleg Tiahnynibok e quelle
militareggianti di Dmitri Yarosh. Gli equilibri non potranno essere che di breve respiro, se tutte le
forze non scenderanno a compromessi. Il rischio di un appiattimento sulle posizioni dell’estrema
destra antirussa, avviato con la revisione della legge sulla lingua che impone l’ucraino come
lingua ufficiale in tutto il Paese, ha già fatto squillare il campanello d’allarme non solo a
Sebastopoli, ma anche a Bruxelles. Le istanze indipendentiste e filorusse della Crimea, che
esattamente vent’anni fa, nel 1994, hanno condotto già una volta quasi alla frattura definitiva tra
Kiev e la penisola regalata nel 1954 da Nikita Krushchov all’allora Repubblica dell’Unione
sovietica, sono la minaccia imminente all’unità del Paese. Le sparate di Pravyi Sektor di marciare
sul Mar Nero per ridurre all’obbedienza la Crimea e scovare pure Yanukovich che si sarebbe
74
ancora rifugiato da queste parti, suonano inquietanti in Europa. Per non dire al Cremlino, che non
esiterebbe certo a mobilitare le proprie forze militari se da Kiev si ordinasse un’operazione di
forza per sedare gli spiriti separatisti.
A Sebastopoli c’è la base della flotta russa e la città, come tutta la regione, gode comunque di una
certa autonomia. Anche se dal parlamentino locale è arrivata mercoledì la conferma che la
secessione non è certo all’ordine del giorno, gli sviluppi possono essere imprevedibili. Le tensioni
tra la maggioranza filorussa e la minoranza musulmana tatara hanno portato nel passato a
frizioni che ora da una parte o dall’altra potrebbero essere rinfocolate con il pericolo di una
degenerazione. I tafferugli di ieri a Simferopoli, sede del consiglio della repubblica autonoma,
sono insomma solo l’aperitivo. Ecco perché più voci, da Bruxelles a Berlino, da Varsavia a
Washington, hanno invitato i reggenti a Kiev a evitare ulteriori escalation. Dopo gli appelli alla
moderazione arrivati nei giorni scorsi dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal ministro degli
esteri polacco Radoslaw Sikorski, che si sono rivolti alle forze governative chiedendo di mettere
le briglie agli ultranazionalisti, è stata la volta segretario della Nato, il norvegese Anders Fogh
Rasmussen che mercoledì ha sottolineato come il compito di tutte le forze in campo sia quello di
preservare l’integrità territoriale dell’Ucraina. Dall’altra parte la Russia ha espresso le sue
preoccupazioni di fronte alle tendenze estremiste (concretizzatisi nella distribuzione di poltrone
governative ai radicali della Maidan e di Pravi Sektor) e ha ordinato un test immediato per
verificare la prontezza delle truppe al confine: segnale che il Cremlino non ha intenzione di stare
a guardare e considera la Crimea - anche solo per la presenza della sua flotta, la cui permanenza è
stata messa in dubbio dai nazionalisti di Svoboda - un perno strategico irrinunciabile anche nella
nuova Ucraina.
75
5
CRIMEA ADDIO
(marzo 2014)
La rivoluzione di febbraio, democratica per l’Occidente, è considerata dalla
Russia un colpo di Stato. La reazione del Cremlino non si fa attendere e mentre a
Kiev il nuovo governo è impegnato a tentare di riordinare parlamento e piazza, la Crimea se ne va
per la propria strada, verso Mosca. Bastano poche giorni alla Russia per controllare militarmente la
penisola, indire un referendum e annettere un lembo di Ucraina, sollevando le proteste anche
dell’Occidente, che tra Stati Uniti e Unione Europea non può fare altro che prendere atto di ciò che
accade sul Mar Nero. La firma dell’Accordo di associazione tra Kiev e Bruxelles è un passo simbolico
che aprirà la via a nuove lacerazioni interne.
“Omini verdi” nella base militare di Perevalne, in Crimea (Anton Holoborodko / Wikpedia)
76
Putin si prende la Crimea
Linkiesta, 1 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
La Russia ha deciso di riprendersi il regalo che aveva fatto all’Ucraina nel 1954. Allora Nikita
Krushchov, appena succeduto a Josef Stalin, servì su un piatto d’argento la Crimea all’Ucraina nel
trecentesimo anniversario degli accordi di Pereyaslav, in cui venne siglata al tempo dello zar
Alessio I l’unità tra Russia e Ucraina. Nell’Urss, allora, il gesto del segretario del Partito
comunista, cresciuto politicamente proprio nel Donbass ucraino, ebbe essenzialmente una
valenza simbolica, dato che sotto l’ombrello sovietico la distinzione tra una repubblica e l’altra
era puramente nominale. Il centralismo di Mosca ebbe però fine con il crollo del comunismo e
l’indipendenza degli stati che costituivano l’Unione. Fu già all’inizio degli anni Novanta che tra
Kiev, capitale della nuova Ucraina, e la Crimea, iniziarono i primi conflitti. Nel 1994, quarant’anni
dopo il regalo di Krushchov e venti prima dell’arrivo delle truppe di Vladimir Putin, Simferopoli
fu a un passo dalla rottura con il potere centrale. Le istanze separatiste, allora supportate meno
focosamente di oggi da Mosca (che aveva problemi in casa propria: la Russia usciva dai due colpi
di stato nel 1991 e 1993 e aveva alle porte la guerra in Cecenia, che sarebbe partita nel dicembre
del 1994), trovarono in Yuri Meshkov un portavoce capace di mettere quasi in scacco Kiev. Lo
spettro di una Crimea indipendente si estinse solo quando la nuova costituzione ucraina del 1996
stabilì in maniera definitiva che la penisola sul Mar Nero faceva parte integrante dell’Ucraina. Per
quasi due anni, comunque, tra proclamazioni d’indipendenza, referendum mai tenuti, ma senza
scontri armati, la Crimea fu al centro di un braccio di ferro che si concluse pacificamente.
I fattori di frizione fra centro e periferia sono però rimasti gli stessi, così come gli interessi della
Russia che in quattro lustri è passata dalla debolezza congenita del sistema di Boris Eltsin alla
rinnovata forza di quello costruito da Vladimir Putin. La base della flotta russa a Sebastopoli è
l’emblema del legame che unisce la Russia al Mar Nero sin dal 1783, quando la Crimea venne
annessa all’impero di Caterina II dopo la vittoria sugli ottomani. Non si tratta solo di una
questione militare: la base è ancora oggi fondamentale per le operazioni limitate alle sponde del
Mar Nero, che comunque è da considerarsi un mare chiuso per uscire dal quale, e addentrarsi nel
Mediterraneo, le navi russe devono sempre passare lo stretto dei Dardanelli, controllato dalla
Turchia, paese membro della Nato.
77
Sebastopoli è importante, perché è fondamentalmente una città russa che ha sempre vissuto in
parallelo con la sua flotta. Dei circa due milioni abitanti della Crimea (secondo l’ultimo
censimento che risale al 2001) i russi costituiscono la maggioranza (circa il 60%), gli ucraini
nemmeno un quarto (circa il 24%) e i tatari (minoranza musulmana con un passato turbolento,
fatti deportare in massa da Stalin nel 1944, sono tornati a partire dalla fine degli anni Ottanta)
poco più di un decimo (12%).
Nel passato le tensioni tra nazionalisti russi e tatari sono sfociate in screzi che non sono andati al
di là di problemi di ordine pubblico, anche se la rivolta contro Victor Yanukovich, il sanguinoso
epilogo conclusosi con la fuga del presidente e l’insediamento a Kiev di un governo in cui sono
entrati i nazionalisti antirussi di Svoboda ed è nato sulla spinta dei movimenti radicali come
Pravyi Sekton, ha riacceso pericolosamente la miccia. La minoranza tatara, schieratasi
apertamente con il governo di Arseni Yatseniuk e contraria a una separazione della Crimea
dall’Ucraina, ha trovato come alleati proprio i movimenti ultranazionalisti che da dietro le quinte,
come avvenuto sulla Maidan di Kiev, sono abituati a soffiare sul fuoco.
A Simferopoli la maggioranza politica è chiaramente filorussa e il fatto che il governatore Sergei
Aksyonov abbia assunto il potere esecutivo e indetto un referendum sullo status della Crimea per
il prossimo 30 marzo, indica che lo scenario è come quello del 1994, con la differenza che stavolta
la Russia si è militarmente mossa, rispondendo formalmente alle richieste di appoggio giunte dal
Mar Nero (in realtà i gruppi paramilitari che negli scorsi giorni hanno occupato parlamento e
aeroporti hanno agito per conto del Cremlino). Per Mosca il gioco è ormai fatto. E il regalo del
1954 è di nuovo a casa.
Arseni Yatseniuk e il presidente Alexander Turchynov, di fronte al dato compiuto, non hanno in
realtà molte alternative, al di là della retorica e degli appelli diplomatici. Sono le stesse che ha la
comunità internazionale, che ha assecondato il cambio di regime a Kiev senza calcolarne le
conseguenze. Per tre mesi da Mosca sono arrivati gli avvertimenti del rischio che comportava una
soluzione delle crisi non condivisa da tutti. L’accordo sottoscritto con Victor Yanukovich il 21
febbraio sotto la supervisione dell’Unione Europea e la firma dei tre ministri degli esteri di
Francia, Germania e Francia è diventato carta straccia dodici ore dopo sotto la spinta estremista
di Pravyi Sektor. Il vento anti-russo soffiato dalla Maidan, non è piaciuto non solo a Mosca, ma
nemmeno, e prima di tutto, a Simferopoli.
78
Ora Kiev, Bruxelles e Washington possono scegliere: o accettare che la Crimea se ne vada per la
sua strada, di nuovo nella braccia russe, aspettando un referendum dall’esito scontato, o
rispondere militarmente e ingaggiare uno scontro armato. Dato che la seconda ipotesi è quella
meno realistica, visto che è improbabile che le truppe ucraine di terra vengano inviate da Kiev o
che le navi statunitensi che pattugliano il Mar nero si mettano ad assediare Sebastopoli come
fecero quelle tedesche durante la Seconda guerra mondiale, la partita sul campo è a vantaggio di
Vladimir Putin. Quali conseguenze si possano avere a livello diplomatico internazionale e
soprattutto sulla tenuta interna dell’Ucraina come stato unitario è invece ancora tutto da vedere.
Lo scacco del Cremlino
Pagina 99, 2 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
L’Operazione Crimea non è certo una sorpresa. O qualcuno si aspettava che Vladimir Putin
facesse un inchino e ringraziasse dopo che per tre mesi nessuno ha ascoltato la Russia e la crisi a
Kiev è stata risolta con un pasticcio al quale ovviamente nemmeno un moderato come Vladimir
Lukin, il mediatore russo a Kiev, nonché delegato (uscente) di Putin per i diritti umani, poteva
mettere la firma? Venerdì 21 gennaio l’allora presidente Victor Yanukovich e l’allora trio
dell’opposizione formato da Vitaly Klitschko, Arseni Yatseniuk e Olegh Tiahnybok hanno firmato
un accordo sull’uscita dalla crisi che durava dalla fine di novembre. Intesa avallata dai tre
ministri degli Esteri di Germania, Francia e Polonia. Dodici ore dopo, in seguito all’ultimatum
dato dagli estremisti di Pravyi Sektor a Yanukovich (dimissioni subito o rivoluzione permanente),
l’accordo è diventato carta straccia. L’Unione Europea, che non ha visto o ha fatto finto di non
vedere il ruolo della destra radicale e paramilitare (minoranza esiguissima, ma decisiva
nell’escalation), ha accettato un governo nato sotto la spinta estremista e il vento antirusso. Da
Mosca il ministero degli Esteri, nella sua dichiarazione del 24 febbraio, ha evidenziato
esplicitamente come il posizionamento di alcuni stati occidentali nella crisi sia stato dettato da
calcoli geopolitici e la tacita alleanza con il blocco estremista sia divenuta un mezzo per realizzare
un cambio di regime e mettere tutti di fronti al fatto compiuto.
79
Tra il 28 febbraio e il primo marzo, in Crimea è stato Putin ad aver fatto il salto in avanti e,
prevedibilmente appunto, a giocare d’anticipo su una scacchiera che per ragioni storiche è
filorussa. La penisola sul Mar Nero è stata solo incidentalmente negli ultimi sessant’anni ucraina,
per il fatto che Nikita Krushchov la regalò alla sua amata patria ai tempi dell’Urss. Ma ora l’Unione
non c’è più e il Cremlino vuole riportare a casa i doni elargiti frettolosamente nel passato. Con il
benestare dei diretti interessati, s’intende, visto che la maggioranza in Crimea è russa e
Simferopoli è più vicina a Mosca che a Kiev. Questione di cuore, lingua e portafoglio. La base della
flotta russa, strategicamente e simbolicamente importante per la Russia, è un fattore economico
fondamentale per la regione, insieme con tutti gli investimenti Made in Moscow, fatti nell’ultimo
ventennio. Se il nuovo governo ucraino Kiev avesse avuto intenzione di rivedere subito gli
accordi che consentono la permanenza della flotta sino al 2042 (come annunciato in passato dai
nazionalisti di Svoboda, che hanno fatto già approvare alla prima seduta del parlamento la legge
che vieta il russo come seconda lingua ufficiale), la mossa di Putin mette una pietra sopra ogni
velleità in questo senso.
Sulla Crimea Putin ha corso rischi politici enormi, ma ha ottenuto
l’obiettivo di mettere l’Occidente davanti al fatto compiuto, spiazzandolo.
Con la ri-presa della Crimea, manu militari e attraverso il referendum indetto per il 30 marzo che
sancirà la separazione dall’Ucraina, Mosca mette di fatto sia il nuovo governo di Kiev che la
comunità internazionale, da Washington a Bruxelles, davanti alla realtà. Difficile pensare che per
ribaltare la situazione il premier Yatseniuk e il presidente Olexander Turchynov pensino di
inviare l’esercito per liberare la Crimea dai russi. Altrettanto improbabile che in Occidente venga
supportata in qualsiasi modo una soluzione del genere. Lo sa benissimo Putin che però ha messo
sicuramente in conto altre opzioni, come quella di un forte inasprimento delle relazioni
diplomatiche che potrebbero sfociare in una nuova Guerra fredda (che comunque nessuno vuole,
se non i falchi che circolano sia a Washington che a Mosca). Ma è altrettanto certo che Stati Uniti
e, soprattutto, Unione Europea, faranno fatica a trovare unità d’intenti per rispondere in maniera
unisona al Cremlino. La verità è che a Putin non importa nulla di quello che pensa l’Occidente,
80
come è vero che la voce della Russia è stata l’ultima ad essere ascoltata per tentare di risolvere il
rebus di Kiev. Gravi saranno, e già lo sono, le conseguenze per l’Ucraina, che perderà de facto la
Crimea, ma non otterrà certo subito l’ammissione nell’Unione europea: al di là del possibile
effetto domino nelle regioni orientali russofone, il nuovo blocco di potere a Kiev dovrà continuare
a fare i conti con Mosca, nel senso letterale della parole. Difficile che i rapporti economici e
commerciali corrano sui binari della distensione: se Gazprom è abituata a fare prezzi di favore
agli amici (la Bielorussia, l’Armenia e l’Ucraina di Yanukovich grazie agli accordi sottoscritti lo
scorso dicembre), agli altri sono riservati i prezzi di mercato. Passare dai 268 dollari per 1000
metri cubi attuali a quasi il doppio, rischia di spingere l’Ucraina nel baratro. Come se non
bastasse il resto.
Le chiese cristiane in un Paese diviso
Popoli, 3 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Ogni protesta, ogni rivoluzione, ha bisogno di immagini emblematiche che la fissino nel tempo.
Forse la recente crisi ucraina, esplosa a novembre a causa del rifiuto del presidente Viktor
Yanukovich degli incentivi economico-commerciali europei, non è stata propriamente una
rivoluzione. Ma neanche una semplice protesta, vista la piega violenta che ha preso. In ogni caso,
a prescindere dall’esito, ancora incerto mentre scriviamo, ha gi{ i suoi fotogrammi simbolici:
quelli dei religiosi armati di croci, testi sacri e icone che si frappongono tra manifestanti e forze di
sicurezza o che presidiano la Maidan Nezalezhnosti, la piazza di Kiev dove anche questa storia,
come la rivoluzione arancione del 2004-2005, è cominciata.
I religiosi appartengono a due comunità: la Chiesa ortodossa - patriarcato di Kiev - e quella grecocattolica. Perché erano in piazza? Il fatto è che l’Ucraina è una terra complessa, attraversata da
faglie di civilizzazione che, quando sale la tensione, tendono a dilatarsi e così facendo rendono
più netti i punti di vista. Insomma, ci si schiera. Fu così al tempo della rivoluzione
arancione (2004), è così adesso. In entrambi i casi, i cattolici di rito orientale e il patriarcato di
81
Kiev hanno sostenuto il blocco nazionalista-europeista. Ha assunto la stessa posizione la Chiesa
autocefala ucraina, un’altra comunit{ ortodossa. La terza componente dell’ortodossia, la Chiesa
ortodossa ucraina-patriarcato di Mosca, la più influente e l’unica riconosciuta canonicamente dal
patriarcato di Costantinopoli, ha invece scelto di non ripudiare Yanukovich e il segmento di
Ucraina che lo sostiene, tendenzialmente favorevole a rapporti stretti con la Russia.
Gli approcci delle Chiese ucraine si intrecciano con le rispettive proiezioni geografiche. La
tradizione greco-cattolica affonda le radici nelle regioni dell’Ovest, in modo particolare in Galizia.
È lo spicchio di terra, a lungo sotto dominazione polacca e poi asburgica e con Leopoli capoluogo,
che costituisce il centro d’irradiazione del pensiero nazionalista ucraino. Orientamento politico
che, logicamente, sottende un’avversione alla Russia. I greco-cattolici a loro modo se ne fanno
interpreti. La Chiesa ortodossa-patriarcato di Kiev e quella autocefala si posizionano grosso
modo sulla stessa lunghezza d’onda e tra l’altro curano anch’esse più anime nei distretti
occidentali che in quelli orientali.
Al contrario la Chiesa ortodossa-patriarcato di Mosca, guidata dal metropolita Volodymir, ha i
piedi piantati a Est e Sud, dove i legami storici e linguistici con la Russia si manifestano con più
evidenza. Questo non significa che non sia presente anche a Occidente: del resto, come detto, è la
principale comunità ortodossa del Paese. Ha più parrocchie delle altre e più seguito tra i
monasteri, che negli equilibri ortodossi contano molto. Contrariamente a quello che si crede ha
anche una certa autonomia. Non è il «clone» ucraino del patriarcato di Mosca.
Fede, politica e culture: i fili sono difficili da sciogliere. Occorre andare indietro nel tempo, fino
all’ultima parte degli anni Novanta, alla vigilia del crollo dell’Urss, se si vogliono capire le origini
del confronto ucraino e del coinvolgimento delle Chiese. Partiamo da quelle ortodosse. Con
l’eccezione della Chiesa autocefala, che è marginale, all’epoca gli ortodossi ucraini erano in
comunione con il patriarcato russo. Il loro metropolita, Filaret Denysenko, molto legato agli
ecclesiastici di Mosca, aveva sempre promosso il contenimento del nazionalismo ucraino e della
Chiesa greco-cattolica, che trovarono un’inattesa linfa nella perestrojka di Gorbaciov. Oggi Filaret
è a capo della Chiesa ortodossa-patriarcato di Kiev, schierato in politica con coloro che aveva
combattuto duramente in passato. È diventato nazionalista. La svolta matura nel maggio 1990,
quando muore il patriarca di Mosca Pimen. Filaret si candida alla successione, convinto di farcela,
82
ma viene affossato. Reagisce duramente e pianifica lo strappo, sfruttando il fatto che nel
frattempo l’Ucraina è diventata indipendente (1991) e il suo primo presidente, Leonid Kravchuk,
deve «rifarsi il trucco», smarcandosi dai lunghi trascorsi nel Partito comunista sovietico, di cui
era il luogotenente a Kiev. Dà così impulso al discorso nazionale, fino a quel momento tenuto a
freno dall’ideologia marxista-leninista.
A questo scopo anche una Chiesa che limiti quella russa e dunque l’influenza di Mosca, può
tornare utile. È così che Filaret, portandosi dietro i suoi sostenitori, confluisce in quella ortodossa
ucraina autocefala, che negli anni della perestrojka stava rinascendo in forma semiclandestina,
dopo essere stata tenuta in vita dagli esuli, soprattutto in Nord America. Pare che in quella
operazione ci fosse la mano del Kgb, che voleva un contrappeso ai greco-cattolici in grado di
indebolire la coesione del rinascente fronte nazionalista e indipendentista. Ma tant’è. La notizia è
che Filaret contribuisce a creare una Chiesa «alternativa». Nel corso di pochi anni anche questa
stessa Chiesa si spacca, in seguito all’elezione a patriarca di Filaret nel 1995. Qualcuno,
ricordandone il passato da fustigatore dell’ucrainit{, prende le valigie e ritorna allo schema della
Chiesa ortodossa autocefala.
In questi anni Filaret ha cercato di ottenere il riconoscimento canonico della sua Chiesa, contando
sull’appoggio prima di Kravchuk e poi di Viktor Yushchenko, anima della rivoluzione arancione.
Sforzo vano: il patriarca di Costantinopoli - colui che ha titolo di riconoscere una Chiesa - non l’ha
accontentato, anche perché ha sempre riscontrato la dura opposizione delle gerarchie moscovite.
Dal loro punto di vista i piani di Filaret sviliscono la santit{ di Kiev, dove ai tempi della Rus’, il
primo Stato russo della storia, avvenne la conversione dei russi al cristianesimo orientale.
Kiev è irrinunciabile anche per il Cremlino. Un’Ucraina agganciata all’Occidente sarebbe un
disastro strategico, dato che porterebbe gli euro-atlantici a ridosso delle frontiere della Russia,
facendole perdere il rango di potenza. C’è dunque una convergenza di interessi tra Cremlino e
patriarcato, che si esplicita nella comune propensione, tuttavia non acritica, a sostenere
Yanukovich contro l’asse europeista-nazionalista.
E la Chiesa greco-cattolica? Vissuta in forma catacombale durante l’epoca comunista, con
l’indipendenza ha sposato la causa nazionale, come gli ultimi eventi hanno (ri)testimoniato.
Nazionale è anche il respiro che la comunit{, guidata dal 2011 dall’arcivescovo maggiore
83
Sviatoslav Shevchuk, sta cercando di darsi. Lo spostamento della sede da Leopoli a Kiev, avvenuto
nel 2005, riflette l’ambizione di allargare il raggio d’azione oltre il tradizionale perimetro delle
regioni occidentali del Paese. Il patriarcato di Mosca ne è disturbato. Si apre perciò un’altra
questione, perché la contesa tra greco-cattolici e ortodossi non riguarda solo la politica interna
ucraina, ma investe i rapporti tra Vaticano e patriarcato di Mosca. Quest’ultimo vede negli
«uniati» (termine con cui spesso vengono chiamati i cattolici di rito orientale) una longa manus
pontificia, un’insidia nell’area di influenza ortodossa. È il nodo critico tra le due confessioni, che
comunque, negli ultimi tempi, hanno cercato di dare impulso al dialogo. Non senza costrutto.
Ma Roma, nell’ex repubblica sovietica, deve guardare anche a un’altra faccenda delicata, tutta
interna al suo gregge. E cioè iol fatto che, a conferma di quanto lo scenario ucraino sia frastagliato
e non facilmente riconducibile a schemi rigidi, tra greco-cattolici e cattolici latini non esiste
grande sintonia. I secondi, circa quattro milioni, sono legati alla tradizione storico-culturale
polacca. Si dà il caso che nel Novecento polacchi e ucraini, in Galizia e nella vicina Volinia, si sono
combattuti senza pietà. Il nazionalismo ucraino trae origine anche da quelle esperienze.
La storia porta in dote elementi di diffidenza, quindi. Politicamente si sono tradotti, all’epoca
della rivoluzione arancione come oggi, con una posizione molto guardinga da parte dei cattolici
latini. Questi hanno osservato con qualche riserva l’enfasi greco-cattolica sul discorso nazionale,
ricordando che l’Ucraina è multietnica e multiconfessionale. Come a dire che gli squarci, se
troppo profondi, non possono essere più rammendati.
Gli errori del nuovo potere
Il Manifesto, 4 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
La partenza del governo di Maidan è stata negativa, marcata da erroracci tattici. Il blocco
nazionalista che ha preso il potere a Kiev - il governo auto-proclamato, come lo chiama la stampa
di Mosca - ha cercato di mettere il sigillo alla sua vittoria, facilitata dalla resa di Yanukovich. Una
cosa politicamente anche legittima. Ma ha messo, in tutto questo, una foga eccessiva. Evitando tra
84
l’altro di frenare gli impulsi più radicali della piazza. È il caso della furia iconoclasta, evidente
nell’abbattimento delle statue di Lenin disseminate nelle regioni occidentali del paese, il
serbatoio della rivoluzione. Nell’immaginario del nazionalismo ucraino quei bestioni di pietra
o bronzo erano il simbolo del dominio di Mosca, a prescindere dalle stagioni politiche e dalle ere
ideologiche. Il governo non ha arginato queste iniziative, che hanno permesso a Mosca di dare
impulso alla tesi propagandata in modo tambureggiante da settimane, secondo cui il movimento
della Majdan è un’accozzaglia di estremisti pronti a scagliarsi contro i russi d’Ucraina. Ancora più
inopportuna è stata la decisione di azzerare la legge con cui Yanukovich aveva innalzato il russo
a lingua ufficiale nelle regioni - circa la metà di quelle del paese - in cui è parlato da almeno il
10% della popolazione. La cosa ha spinto sulla difensiva la popolazione russofona del paese,
dando a Putin ottimi pretesti in vista dell’offensiva in Crimea e della tattica, portata avanti senza
ripiegamenti, di spaccare il paese. C’è un ulteriore passo falso, da parte del nuovo potere di Kiev.
L’Ue, nell’intento di evitare che le tensioni regionali si inasprissero, aveva auspicato che il nuovo
governo fosse il quanto più possibile inclusivo, politicamente e a livello regionale. È vero che
i deputati dell’est e del sud, le aree più legate all’influenza russa, non sono stati al gioco. Ma al
tempo stesso balza agli occhi il fatto che l’esecutivo, benché non siano presenti figure
particolarmente divisive, annota l’Istituto polacco per gli affari internazionali, think tank di
Varsavia, non è certo un governo a trazione tecnica, come forse ci si sarebbe dovuto aspettare.
Piuttosto, è un riflesso dell’idea nazionale-nazionalista alla base della rivoluzione.
Il nuovo potere di Kiev ha promosso misure nette, poco inclusive.
È comprensibile, tenuto conto dello scenario molto teso.
Ma il rischio è dividere ancora di più, e definitivamente, il paese.
Forte è il peso di Batkivschyna, il partito di Yulia Tymoshenko (il primo ministro Arseni
Yatseniuk ne è il reggente). C’è qualche innesto di Svoboda e c’è anche chi ha preso parte
direttamente al movimento di piazza, sebbene restando a distanza dall’estrema destra. Ora, il
governo della Maidan e il movimento che gli dà linfa si sono accorti che forse, con l’aria che tira
nel paese, c’è bisogno di qualche passo indietro. Da qui la decisione del presidente ad interim
85
Oleksandr Turchynov, fedelissimo della Tymoshenko, di non firmare la legge che azzera il
provvedimento sulla lingua russa a suo tempo promosso da Yanukovich, non senza propositi
politici. Turchynov, seguendo anche le indicazioni arrivate da Bruxelles, che aveva sottolineato la
necessità di garantire i diritti delle minoranze etniche e linguistiche, ha annunciato la nascita di
un gruppo di esperti incaricato di redigere una nuova legge, che tuteli a dovere il pluralismo
culturale.
Sempre sul fronte dell’idioma russo, c’è da segnalare l’iniziativa presa nei giorni scorsi dalla città
di Leopoli, bastione del nazionalismo. Il 26 febbraio, nell’arco dell’intera giornata, i residenti
hanno deciso di passare dall’ucraino (la lingua parlata nella quotidianità) al russo, nel tentativo,
appoggiato dal sindaco della città Andriy Sadovyi, di sanare le fratture con l’altro segmento del
paese. A cosa è servito tutto questo? A niente. Quanto alle città dell’est e a Odessa, nel sud, la
situazione resta incandescente. Ma questo non toglie che la retromarcia sulla lingua, benché non
così decisiva in questa partita, sia stata tardiva. Parallelamente, il governo della Majdan ha
cercato di coinvolgere gli oligarchi: una mossa che avrebbe la sua logica, dato che molti dei
tycoon sono propensi a mantenere buoni rapporti con Mosca. Il problema, però, è che i due
oligarchi nominati governatori delle regioni di Dnepropetrovsk e Donetsk, Igor Kolomoysky
e Sergei Taruta sono ritenuti vicini al potere di Majdan. Kolomoysky, banchiere di origini
ebraiche, ha sostenuto in passato la Tymoshenko. Mentre di Taruta si dice che fosse vicino all’ex
presidente Viktor Yushchenko.
Chi comanda a Kiev
Il Manifesto, 5 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Per gli occidentali è il governo legittimo dell’Ucraina, per Mosca un esecutivo golpista. Ma
a prescindere dai rispettivi punti di vista, al momento nei ministeri di Kiev si sono piazzate
queste persone. Chi sono di preciso? Quali le loro biografie? A quali circoli di potere rispondono?
Più che da chi ricopre posizioni, si può partire da chi non ne ha. È il caso di Vitali Klitschko e del
86
suo partito, Udar, formazione centrista e filo-occidentale con status di osservatore nel Partito
popolare europeo. Dal quale, assieme alla fondazione Konrad Adenauer, filiazione della Cdu
tedesca, ha ricevuto lezioni di politica e tecnica parlamentare, scriveva a dicembre Der Spiegel. Ci
si chiederà come mai Klitschko, che ha cercato di accreditarsi come guida carismatica della
protesta, almeno prima che degenerasse, non ha voluto assumere responsabilità di governo. Per
qualche analista l’ex pugile, che punta alla presidenza, non intende sporcarsi le mani con
i provvedimenti impopolari che il pacchetto d’aiuti europeo, pronto a essere scongelato,
dovrebbe imporre. In più starebbe emergendo una contrapposizione sempre più marcata - ed era
prevedibile - tra Udar e Batkivschyna (Patria), il partito di Yulia Tymoshenko.
La formazione della pasionaria di Kiev ha fatto incetta di ministeri, probabilmente sulla base di
un ragionamento opposto a quello di Klitschko: dimostrare di sapersi caricare il paese sulle
spalle. A guidare la compagine ministeriale c’è Arseni Yatseniuk, luogotenente della Tymoshenko.
Nomina scontata. Nelle scorse settimane la evocò anche l’assistente al segretariato di stato
americano, Victoria Nuland, nel leak in cui si lasciò sfuggire il «fuck the Eu».
Accanto a Yatseniuk ci sono figure di spicco del partito. Pavlo Petrenko è andato alla giustizia,
Maksim Burbak alle infrastrutture e Ostap Semerak, consigliere di politica estera del primo
ministro, sarà un po’ un gran cerimoniere. Un ruolo chiave è quello di Vitali Yarema, ex capo della
polizia di Kiev. È vice primo ministro con delega al law enforcement.
Al blocco della Tymoshenko - lei non avrà cariche, la piazza ha mugugnato - afferisce anche il
ministro degli interni Arsen Avakov, un tempo alleato dell’ex presidente Viktor Yushchenko. È di
Kharkhiv, la seconda città del paese. La più grande, tra quelle dell’est. Non ha casacche, invece, il
ministro degli esteri Andriy Deshchytsia. Ma era stato tra i primi firmatari di un appello di alcuni
diplomatici ucraini contro le repressioni di Yanukovich.
Nella coalizione si delinea un ruolo notevole per l’oligarca Ihor Kolomoysky, numero uno di
PrivatBank, principale istituto di credito del paese. Del cerchio magico del banchiere, tra l’altro
appena nominato governatore di Dnepropetrovsk, farebbero parte il ministro dell’energia Yuriy
Prodan (personaggio chiacchierato) e quello delle finanze Oleksandr Shlapak. Non è un caso, si
direbbe, che si siano accaparrati due ministeri così cruciali.
87
Discreta è l’influenza della Myhola University di Kiev, accademia rispettata, con respiro
occidentalista. Il ministro dell’economia Pavlo Sheremeta e quello dell’educazione Serhiy Kvit
hanno insegnato lì. Ristretto, un po’ a sopresa, il peso di Petro Poroshenko, oligarca di tendenza
europeista. La sua pedina nel governo è Volodymir Grosyan, ex sindaco di Vinnitsa, nell’ovest del
paese. È il responsabile degli affari regionali. Una possibile mossa con cui, dato che Poroshenko
(pure lui di Vinnitsa) è stato anche ministro con Yanukovich, tranquillizzare la popolazione
russofona. Per quanto possibile.
Arriviamo alla destra-destra. A Svoboda. Gli ultranazionalisti, bollati come portatori di un verbo
estremista e antisemita, hanno diversi incarichi. Oleksandr Sych è vice primo ministro. In passato
fece clamore proponendo il divieto assoluto di aborto, persino in caso di stupro. Svoboda s’è
presa pure l’ambiente e l’agricoltura, con Andriy Mokhnyk e Ihor Shvaika, due che hanno
capeggiato le proteste contro le licenze sullo shale gas concesse da Yanukovich a compagnie
occidentali.
In quota Svoboda c’è anche Ihor Tenyukh, ex capo della marina. A lui la difesa. Mentre Andrei
Parubiy, ritenuto tra i fondatori di Svoboda, ma poi accasatosi presso la Tymoshenko e da ultimo
coordinatore delle barricata di piazza dell’Indipendenza, presiederà il consiglio nazionale per la
sicurezza. Dovrebbe avere come vice Dmytro Yarosh, comandante di Pravyi Sektor, le famigerate
bande paramilitari di estrema destra. A quanto pare non ha ancora assunto l’incarico, ma ciò non
toglie che si profila un monopolio della destra radicale sulla sicurezza. E la cosa ha allarmato ben
più di un osservatore. Infine, la piazza. Tetyana Chornovol e Yegor Sobolev, giornalisti e attivisti,
guideranno rispettivamente l’anticorruzione e la lustrazione. È la cambiale riscossa da
Euromaidan per il contributo alla rivoluzione.
88
Il bancomat di Bruxelles
Il Manifesto, 7 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Undici miliardi di euro. Tanto nei prossimi tempi l’Europa verserà a Kiev. A dire il vero Bruxelles
scucirà solo tre miliardi. Gli altri arriveranno dalla Banca europea per gli investimenti (tre)
e dalla Banca europea per la ricostruzione e per lo sviluppo (cinque).
La stazza del pacchetto di aiuti, a prescindere dalle ripartizione delle quote, ha stupito: nessuno
s’aspettava che fosse così imponente. È stata la svolta in Crimea, con lo spostamento del referendum dal 30 al 16 marzo e la rimodulazione del quesito (ora si parla di adesione alla Russia),
a spingere gli europei a collocare più in alto l’asticella. Una reazione al gioco duro di Mosca. Condita da un dettaglio che non lascia indifferenti. L’importo del sostegno è lo stesso che Vladimir
Putin aveva accordato a Viktor Yanukovich a dicembre. Quell’intesa scacciò da Kiev lo spettro
della bancarotta e offrì ossigeno all’ex capo di Stato ucraino, dandogli modo di temperare le proteste e accendere la macchina elettorale in vista delle presidenziali (dovevano tenersi a febbraio
2015). Poi è andata com’è andata e l’accordo è venuto meno. Adesso il piano è rovesciato, con
l’Europa a offrire all’Ucraina, un’altra Ucraina, la propria sponda.
Questi soldi verranno versati progressivamente e serviranno, stando al comunicato diffuso al termine del Consiglio europeo di giovedì, a ridare stabilità macroeconomica. La baracca ucraina
è più che mai fragile, d’altronde. La fuga di Yanukovich, il cambio della guardia a palazzo e la faccenda della Crimea hanno aggravato una situazione che era già ballerina. Il paese ha sia un elevato deficit pubblico (il Financial Times lo stima all’8%) che di bilancia commerciale (intorno al
9%), la crescita è stagnante da due anni, il peso dei mutui non performanti si fa sempre più sentire, gli investitori stanno togliendo il disturbo e la hryvnia, la moneta nazionale, perde valore in
modo molto rapido.
L’Ue sosterr{ l’Ucraina anche a livello energetico, dal momento che la Russia non ha più intenzione di rispettare il taglio sulla tariffa, abbassata da 400 a 268 dollari per mille metri cubi, con
cui aveva accompagnato il prestito firmato a dicembre. Insomma, Gazprom chiederà un conto
salato. Bruxelles lo compenserà dirottando su Kiev una quota del gas che importa dalla Russia,
oltre a garantire la quanto più rapida firma degli Accordi di associazione e delle misure sul libero
89
scambio che Yanukovich, a novembre, aveva respinto. Fu quello a scaraventare la gente in piazza.
Il sostegno europeo non sarà senza contropartite. Bruxelles pretende riforme strutturali, specie
sui fronti della lotta alla corruzione e della trasparenza. Un messaggio chiaro: Kiev deve prendere
a martellate il suo sistema economico, contraddistinto da forte opacit{, segnato dall’intreccio tra
politica e oligarchie, allergico a parole come competitività e concorrenza. Comunque sia il menu
europeo, a cui s’aggiunge il miliardo di dollari in arrivo da Washington, non è sufficiente a mettere al riparo l’ex repubblica sovietica dai guai. Servono più quattrini. Li metterà il Fondo monetario internazionale, è scontato.
Qui si apre un’altra partita. Diversi analisti sostengono che mentre il prestito europeo non comporta problemi, anzi, è stato accolto a braccia spalancate, l’intervento del Fmi preoccupa il
governo e le oligarchie. Il fatto è che Kiev ha sempre manifestato fastidio nei confronti della
ricetta austera dell’istituzione attualmente diretta dalla francese Christine Lagarde. Quando scoppiò la crisi globale l’Ucraina fu tra i primi paesi a cadere al tappeto e il Fmi arrivò a Kiev con i cordoni della borsa allargati, pretendendo però interventi su salari pubblici e pensioni, come sul gas,
i cui prezzi sono sempre stati tenuti artificiosamente e populisticamente bassi da chiunque abbia
governato. In due occasioni gli accordi sono saltati. La prima volta con la Tymoshenko al potere;
la seconda nell’era Yanukovich.
Entrambi, contravvenendo a impegni presi formalmente, si sono rifiutati di impugnare le forbici
o caricare eccessivamente le bollette. Il gioco riprende da qui. Il negoziato con il Fmi dovrà tenere
conto di una duplice esigenza. Da una parte c’è bisogno di aggredire i monopoli ucraini, creare
una classe media e ridistribuire la ricchezza. Il 50% del Pil è in mano a 50 baroni dell’economia,
con la complicità della politica. Dall’altra le misure, in una situazione emergenziale, non dovrebbero ricadere su una popolazione che boccheggia, non da ieri. La trattativa si svolgerà su un filo
piuttosto sottile.
90
Dalle barricate nasce la guardia nazionale
Il Manifesto, 13 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
La Rada, il parlamento monocamerale ucraino, ha licenziato ieri una legge che istituisce una
guardia nazionale. La misura è stata proposta dal presidente dell’assemblea, nonché capo
provvisorio dello stato, Oleksandr Turchynov. Sono stati 262 i voti a favore, sui 330 deputati in
aula. Il provvedimento era in cantiere da giorni e Turchynov stesso l’aveva preannunciato,
motivandolo come urgente, a fronte della pressione russa sulla Crimea, sulla via della secessione.
L’esito della consultazione referendaria che si tiene dopodomani nella penisola appare infatti
scontato e le marionette di Mosca a Simferopoli hanno lavorato in queste settimane affinché la
strada che portasse verso questa conclusione fosse sempre più rettilinea. Anche grazie
all’appoggio di bande armate. Il Cremlino le ha sempre definite come forze di autodifesa,
smentendo il coinvolgimento di militari russi. Ma ieri Leonid Slutsky, presidente della
commissione della Duma sull’Eurasia e sui rapporti con i russi all’estero, ha praticamente
ammesso che i militari di Mosca, in Crimea, sono stati mobilitati.
Al di là delle ragioni fornite da Turchynov e del fatto che ormai si gioca sempre più duro, sia da
una parte che dall’altra, la creazione della guardia nazionale ucraina va letta anche sulla base di
un’esigenza fisiologica di ogni rivoluzione: l’istituzionalizzazione del nuovo ordine e la
costruzione di strutture di controllo dotate di prerogative coercitive. La guardia nazionale potrà
contare su sessantamila effettivi. Numero che non passa inosservato. Si tratterà di una struttura
pesante, che presumibilmente verrà distribuita su ogni palmo di territorio. Chi ne farà parte? Qui
si apre un’altra questione non certo priva di significato. La guardia dovrebbe essere formata da
graduati provenienti dalle accademie, da altri militari muniti di patente di lealtà nei confronti
delle autorit{ (così ha riportato l’agenzia Ria Novosti sentendo una fonte governativa) e da coloro
che, a Kiev, hanno lottato sulle barricate.
Diversi i gruppi che ci hanno messo faccia e corpo, a partire dalle forze di autodifesa di
Euromaidan, organizzate da Andrei Parubiy, ora a capo del Consiglio nazionale per la difesa e la
sicurezza. Anche gli attivisti di Svoboda, la compagine parlamentare più radicale del
nazionalismo ucraino, da molti bollata come neonazista, ma capace anche di incamerare tanti voti
91
di protesta alle elezioni del 2012, si sono dati da fare. Come i miliziani di Pravyi Sektor, il
movimento paramilitare, guidato da Dmitry Yarosh, che ha fornito più uomini e più linfa
battagliera alla rivoluzione nazionalista.
Nei prossimi giorni, hanno annunciato le autorità, inizieranno i reclutamenti. Non è chiaro se gli
esponenti di Pravyi Sektor verranno integrati nella guardia, ma a giudicare da una recente
intervista rilasciata da Yarosh a Newsweek sembrerebbe proprio di sì. «Stiamo coordinando le
nostre azioni con il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa, oltre che con il comando delle
forze armate. Attualmente negoziamo per dare appoggio legale alle nostre forze». Sono composte
da diecimila uomini – secondo lo stesso Yarosh – tra volontari, membri della sicurezza, militari
congedati e in attività.
La guardia nazionale si configura come un folto gruppo di pretoriani a disposizione e a
protezione del potere centrale, ma c’è l’impressione che la sua natura sia anche quella di un
esercito se non alternativo, complementare. Come ammesso da Turchynov le forze armate
ucraine sono impreparate e attualmente ci sarebbero soltanto seimila effettivi appropriatamente
addestrati al combattimento. Al tempo stesso, il battesimo della guardia nazionale potrebbe
riflettere una fiducia non piena nutrita dal governo nei confronti delle stesse forze armate. Resta
il fatto che il nuovo corpo necessita di addestramento. Chi glielo fornirà?
Un’altra possibile interpretazione, relativa alla costituzione della guardia, sta nel fatto che il
governo potrebbe coltivare l’obiettivo di schiodare dalla piazza i membri delle brigate formatesi
nel corso della rivoluzione. Reclutandoli ci riuscirebbe. Dopo la caduta di Yanukovich in molti
sono rimasti a presidiare il cuore di Kiev, con l’intenzione di tutelare il nuovo potere da possibili
provocazioni ordite dal vecchio e tenere alta la pressione sulla squadra di Yatseniuk, in modo da
indurla a non ignorare le istanze dei reduci della rivoluzione, ha riportato in questi giorni il Los
Angeles Times in un articolo firmato da Carol J. Williams.
Questa presenza può iniziare sia a essere scomoda sia sotto il profilo politico, sia in termini
d’immagine. D’altronde l’esecutivo di Kiev, si può ipotizzare, manifesta il bisogno di togliere
munizioni alla propaganda russa, che continua a diffondere senza soluzione di continuità la tesi
che la rivoluzione di Kiev sia stata orchestrata da forze armate di matrice fascista.
92
Scrittori e rivoluzione
Europa, 16 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Scrittori con l’elmetto. Filosofi in battaglia. Romanzieri colpiti dal virus della rivoluzione. Cinque
intellettuali ucraini raccontano la loro esperienza dell’inferno di Kiev, dopo esser stati catapultati
in poche ore dalla Maidan ai saloni futuristici della nuova fiera di Lipsia, dove oggi si chiude la
seconda rassegna del libro più importante della Germania. Il luogo non potrebbe essere più
adatto. Fin dalla sua nascita, la fiera di Lipsia si è distinta per la grande attenzione al mondo
culturale dell’Est europeo, sia nella prima metà del Novecento che durante gli anni della Ddr. E
dopo la riunificazione questa tradizione è stata il motore del rilancio della fiera, che aveva
bisogno di un marchio distintivo rispetto a Francoforte.
Ma soprattutto da qui, nell’autunno del 1989, partì la rivoluzione pacifica che in poche settimane
portò alla caduta del Muro di Berlino e al collasso della Ddr. Lipsia si fregia orgogliosa del titolo di
citt{ degli eroi e oggi rimarca la sua solidariet{ con l’Ucraina sventolando una gigantesca
bandiera gialla e blu sulla facciata della Nikolaikirche, la chiesa da cui partirono le
leggendarie Montagsdemonstrationen, le manifestazioni del lunedì che abbatterono il regime.
E con altri eroi hanno avuto a che fare questi uomini di lettere e pensiero, laggiù nell’inverno
ucraino: uomini e donne che a 25 anni di distanza hanno provato a dare una spallata finale a un
regime che lentamente aveva finito con l’assomigliare a quello di Honecker. Un paio di nomi sono
noti anche al pubblico italiano: Andrei Kurkov e Juri Andrukhowych, il primo autore russofono
diAngelo del Caucaso e L’ultimo amore del presidente (pubblicati da Garzanti), il secondo artefice
della lettera aperta ai giornalisti stranieri, scritta in diretta dal campo di battaglia, un moderno
messaggio in bottiglia digitale che ha raggiunto tutte le redazioni estere. Gli altri sono un
filosofo, Taras Lyutyj, e due donne: la giornalista Iryna Slavinska e la scrittrice Irena Karpa,
famosa invece solo in Ucraina e un po’ in Germania, nonostante la scena letteraria di Kiev sia oggi
un dominio femminile: in Italia attende ancora qualche editore coraggioso.
Karpa è un fenomeno tutto da scoprire: prima musicista, poi attrice, infine giornalista e
romanziera, è diventata uno dei volti più popolari della rivoluzione di Kiev. Abituata a far parlare
di sé per gossip e provocazioni, si è scoperta sulla Maidan una natura di pasionaria. E gli ucraini
93
le hanno perdonato futilità ed eccessi passati, riconoscendola come una di loro. «È stata
un’esperienza commovente, mi ha colpito la solidarietà fra persone di diverse regioni e di ogni
ceto sociale. Ho visto ricche signore in pelliccia che medicavano i feriti, disabili che a 20 gradi
sottozero distribuivano tè caldo ai dimostranti, persone che non si sono spostate di un
centimetro quando i poliziotti li colpivano con getti di acqua gelida e poi quando hanno iniziato a
sparare». Nella narrazione letteraria di Karpa la rivolta assume toni epici, tutto diventa bianco o
nero: i buoni di qua, i cattivi dall’altra parte.
Ma è così che l’ha vissuta anche Andrukhowych: «Lo slogan dei primi giorni era “una goccia
nell’oceano”, un concetto importante perché dava valore all’azione individuale nella costruzione
di un movimento di massa. Noi intellettuali ci siamo trovati dentro spontaneamente e abbiamo
speso le nostre parole perché era importante farsi capire. Soprattutto all’esterno. Quando ho
scritto l’appello ai giornalisti stranieri, poi tradotto in sei lingue, volevo far sapere all’esterno che
i delinquenti avevano iniziato a sparare ai diritti civili».
Kurkov scrive in russo, la lingua parlata da gran parte degli ucraini. «La lingua è una questione
strumentalizzata, molti ucraini saltano da un idioma all’altro senza farsi troppi problemi. A Kiev
l’80 per cento parla russo, ma non mi sono note percentuali simili di sostegno alla Russia».
Kurkov è un fanatico di Facebook. Nei giorni più caldi aveva lanciato un messaggio straziante:
«Vedo il cuore della mia Kiev bruciare nel fuoco». Poi ha utilizzato lo stesso social network per
scrivere un messaggio aperto a Putin: «Io che sono russofono, ti chiedo di non venire a salvarmi,
perché la mia situazione potrebbe solo peggiorare».
Il futuro è aperto, la crisi non è finita. «Non è ancora il tempo di rientrare a casa», dice battagliera
Karpa. E l’Europa? Lyutyj il filosofo è sarcastico: «All’inizio abbiamo cercato l’Europa, alla fine
abbiamo trovato soltanto gli ucraini». Bruxelles è lontana, un po’ pure Berlino. Solo Lipsia, la citt{
degli eroi, riesce a scaldare il cuore.
94
La lingua degli ucraini
Il Manifesto, 18 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Nei giorni scorsi il ministero degli esteri russo ha diffuso un pacchetto di proposte, rivolto al
blocco euro-occidentale, sul futuro assetto dell’Ucraina. La necessit{ di passare a una forma
federale di stato ne è uno dei pilastri. Molti, non solo in Russia, sono convinti che questa sia la
formula, forse l’unica, capace di tenere insieme una nazione così spezzata.
Mosca ha toccato anche il tema della lingua. «Accanto all’ucraino, il russo dovr{ avere il rango di
secondo idioma ufficiale», si precisava nel documento. È stato rigettato dagli occidentali, ma è
comunque chiaro che al netto della forma che prenderà la trattativa, ammesso che parta, la
pacificazione dell’Ucraina passa anche dagli idiomi, argomento da sempre molto sensibile.
Lo si è visto quando il 23 febbraio il parlamento di Kiev, dopo la fuga di Yanukovich, ha azzerato
la legge varata nel 2012 dallo stesso Yanukovich che eleva il russo a lingua ufficiale nelle regioni
dove almeno il 10% della popolazione lo parla.
Quell’atto ha fatto contribuito a precipitare la situazione. Mosca l’ha sfruttato per rilanciare la sua
tesi: il governo della Maidan discrimina, dunque dobbiamo difendere i nostri concittadini. Pochi
giorni dopo Putin – è lecito pensare che l’avrebbe fatto lo stesso – ha fatto scattare l’operazione
Crimea. A nulla è servita la decisione del presidente del parlamento e capo provvisorio dello
stato, Oleksandr Turchynov, di non firmare la misura, lasciando in vita l’attuale legge e istituendo
una commissione di esperti, anche su consiglio dell’Ue, incaricata di elaborarne una nuova.
Al di là delle recenti cronache il tema della lingua, in Ucraina, s’insinua da sempre nelle fenditure
che attraversano cultura e territorio dell’ex repubblica sovietica, da quanto è diventata
indipendente. Correva l’anno 1991. Allora la leadership di Kiev vide nella lingua uno strumento
con cui rafforzare l’identit{ del nuovo stato. Si oppose al bilinguismo e fece dell’ucraino, parlato
dai due terzi della popolazione secondo il censimento del 2001, l’ultimo effettuato, la lingua
ufficiale. Postura, questa, che derivava da ragioni storiche e politiche. Si trattava di marcare la
rottura con l’esperienza sovietica, quando il russo era stata la lingua dominante. Emerse
parallelamente il timore che, riconoscendo al russo pari dignit{, la lingua ucraina e l’identit{
95
nazionale potessero perdere smalto, lasciando il fianco scoperto all’influenza di Mosca. Questa è
la tesi che alberga nel campo influenzato dal pensiero nazionale-nazionalista, dal partito della
Tymoshenko (russofona di nascita, ha imparato l’ucraino in et{ adulta) alle destre radicali.
Questa lettura è stata costantemente contrastata dalle forze politiche più sensibili al rapporto
stretto con Mosca. Il loro ragionamento, almeno a livello pubblico, è che è giusto che ognuno usi
la lingua che pratica nella quotidianità.
La questione della lingua ufficiale è stata strumentalizzata per anni,
ma nel vissuto quotidiano gli abitanti dell’ex repubblica sovietica
si capiscono perfettamente, che parlino in ucraino o in russo.
La battaglia, negli anni seguenti, s’è srotolata lungo questi due binari, innescando periodicamente
scontri politici. Ma la lingua è stata anche usata strumentalmente, a scopi elettorali, secondo le
varie circostanze. Yanukovich approvò la legge del 2012 non perché volesse potenziare i diritti
delle minoranze linguistiche. Piuttosto, intendeva mettere benzina nella macchina elettorale,
visto che il provvedimento fu varato in agosto e in ottobre si tennero le politiche.
Tutta questa bagarre politica sulla lingua, tuttavia, stona con il contesto di ogni giorno. Gli ucraini
comprendono perfettamente il russo, che è più diffuso rispetto al peso demografico della
componente russa (circa il 20%) e si spalma nelle regioni centrali, orientali e meridionali del
paese. I russi, dal canto loro, capiscono senza problemi l’ucraino, che fu sdoganato nell’800 dal
letterato Taras Shevchenko nel contesto del processo di formazione della coscienza nazionale
ucraina e trova nella regione di Poltava, nel versante centro-orientale del paese, il suo polo in
assoluto più purista.
In mezzo, tra le due lingue, c’è poi una sorta di idioma franco, il surzhyk. Ha diverse gradazioni, a
seconda dei territori. Lo mastica chi non conosce alla perfezione né il russo e né l’ucraino. In
generale, sebbene si stia semplificando, è la lingua degli strati meno istruiti della popolazione. Ma
nel complesso la gente salta senza problemi da un idioma all’altro. Il bilinguismo è radicato nel
vissuto di tutti i giorni. La lingua, tra le persone, favorisce relazioni e commerci. Tra i politici solo
incomprensioni. Uno dei tanti paradossi dell’Ucraina
96
Primavera rimandata
Linkiesta, 21 marzo 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Venerdì 21 marzo l’Ucraina ha firmato la parte politica dell’Accordo di associazione (AA) con
l’Unione europea. Per quella economica non è stato previsto un calendario preciso, anche se
Bruxelles ha promesso a Kiev un supporto finanziario che, insieme a quello degli Stati Uniti e del
Fondo monetario internazionale, dovrebbe consentire la stabilizzazione del Paese e condurre
successivamente all’intesa con l’Ue. Il condizionale è d’obbligo, dato che è ancora l’emergenza
interna a dettare l’agenda e gli effetti collaterali della crisi internazionale sono ancora tutti da
vedere. È certo comunque che con la sottoscrizione della parte politica dell’accordo si è
completato l’ennesimo ribaltamento: esattamente quattro mesi dopo l’inizio delle proteste nella
capitale ucraina contro il presidente Victor Yanukovich - cominciate il 21 novembre del 2013,
quando il governo dell’allora premier Mykola Azarov aveva annunciato che il processo per la
firma dell’accordo di associazione era stato ufficialmente sospeso - si è compiuto anche il
paradosso della seconda rivoluzione di Maidan. Se la sottoscrizione della parte politica era stata
congelata dall’Unione ai tempi di Yanukovich a causa del caso di Yulia Tymoshenko e su quella
economica in realtà era stata fatta chiarezza sin dal marzo del 2012, quando l’accordo era stato
parafato a Bruxelles, ora le parti si sono invertite.
Il governo di Arseni Yatseniuk ha raggiunto l’intesa politica, ma quella economica è finita in
freezer: nuove trattative saranno necessarie alla luce della disastrosa situazione in cui versa l’ex
repubblica sovietica per facilitare l’eventuale passaggio verso l’area comune di libero scambio
che con le regole attuali potrebbe costringere Kiev e soprattutto qualche oligarca a sacrifici di
troppo. Il paradosso all’interno del paradosso è che lo stesso Yanukovich, nel suo gioco al rialzo
tra Bruxelles e Mosca, aveva chiesto modifiche alla parte dell’accordo che, prima negate con
motivazioni politiche, saranno probabilmente concesse grazie a ragioni analoghe. La firma di
venerdì 21 marzo a Bruxelles è stata in sostanza un «gesto di solidarietà» verso l’Ucraina, come
l’ha definito la cancelliera Angela Merkel, anche per dimostrare una certa compattezza europea
verso la Russia. È evidente però che la linea europea non potrà diventare troppo dura nei
confronti di Mosca: in primo luogo perché le sanzioni di quella che è prospettata come la «fase 3»
(provvedimenti economici e finanziari a largo raggio) sarebbe controproducente per la stessa
97
Europa, e soprattutto per la Germania che con la Russia ha i più stretti rapporti; in secondo luogo
perché dalle probabili contromisure del Cremlino sarebbe proprio l’Ucraina a soffrire per prima.
E con i tempi che corrono, Kiev non si può permettere, al di là della retorica, di arrivare alla
completa degenerazione dei rapporti con la Russia.
Oltre al duello sulla scacchiera internazionale, nel quale Yatseniuk ha ricevuto le pacche sulle
spalle delle cancellerie occidentali - gli aiuti finanziari promessi sul medio-lungo periodo tra
Bruxelles e Washington non sono però a fondo perso e legati a riforme che richiederanno lacrime
e sangue agli ucraini - l’Ucraina rischia presto di scollarsi sul versante interno. L’opposizione che
ha cacciato Yanukovich e ora ha le redini del potere sta mostrando le sue prime divisioni.
Preventivabili, sotto certi aspetti inevitabili.
Il governo di Arseni Yatseniuk è costituito da due blocchi, quello di Patria (YatseniukTymoshenko) e Svoboda (Oleg Tiahnybok). Udar di Vitaly Kitschko è rimasto sin dall’inizio fuori
dai giochi per scelta propria: l’ex campione dei pesi massimi correrà per le presidenziali del 25
maggio nelle quali si troverà di fronte come sfidanti più quotati l’oligarca Petro Poroshenko e
l’eroina della rivoluzione arancione che se fino a poco tempo fa era ridotta su una sedia a rotelle,
dopo un breve soggiorno a Berlino, è tornata a Kiev per riprendersi qualche rivincita. Se le acque
tra i moderati sono agitate - adesso che non c’è più il nemico comune e la lotta è interna - le cose
non vanno certo meglio tra questi ultimi e l’ala dura sia del governo che dell’opposizione
extraparlamentare e paramilitare, quella che si è istituzionalizzata sulle barricate nei mesi scorsi
e ora con Dmitri Yarosh e il suo Pravyi Sektor si appresta a combattere anche nell’arena politica.
Il primo screzio istituzionale si è avuto quando il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale,
Andrei Parubyi, ex comandante di Maidan e legato alla destra radicale, ha scavalcato Yatseniuk,
annunciando l’introduzione del visto per i cittadini russi, misura che il governo ha dovuto
smentire il giorno dopo per non provocare un disastro.
L’aggressione di un gruppo di deputati di Svoboda al direttore di un canale televisivo accusato di
essere filoputinaino ha irritato Klitschko, e se Yatseniuk si è limitato a condannare l’episodio, il
leader di Udar ha chiesto le dimissioni dei parlamentari coinvolti. Le vicende sono sintomatiche
ed evidenziano come al suo interno il blocco di potere sia a dir poco molto eterogeneo e la
campagna elettorale, che non è entrata ancora nel vivo, presto riscalderà ulteriormente
98
l’atmosfera, soprattutto tra Klitschko e Tymoshenko. Senza contare che gli oligarchi hanno
mantenuto le loro posizioni e Pravyi Sektor ha dichiarato che è pronto a una seconda rivoluzione
se il nuovo governo e il nuovo presidente non manterranno le promesse fatte su Maidan. La
primavera a Kiev tarderà a sbocciare.
99
6
L’EST CONTRO
(aprile 2014)
Dopo l’arrivo del nuovo governo a Kiev e l’annessione della Crimea da parte della
Russia, si apre un altro capitolo della crisi ucraina, quello più intricato e lungo. Nel
Donbass, regione industriale da sempre fedele al blocco di potere più allineato a Mosca, movimenti e
gruppi separatisti scatenano le prime turbolenze, Che presto, da un’occupazione dei palazzi del
potere, sfoceranno in una vera propria guerra guerreggiata con il governo centrale. A vuoto vanno i
tentativi della comunità internazionale di mettere un coperchio alla pentola che bolle, mentre nella
capitale Kiev ci si prepara alle elezioni presidenziali, con gli oligarchi a tessere la tela dietro le
quinte e Petro Poroshenko, uomo che da questo ambiente proviene, pronto a mietere consensi.
Logo della Repubblica popolare di Donetsk (Dalla pagina Facebook di Euromaidanpress)
100
Il Donbass non è la Crimea
Lettera 43, 8 aprile 2014
________________________________________________________________________________________________________________
È l’effetto Crimea. Dopo il referendum che ha sancito la separazione della penisola sul Mar Nero
dall’Ucraina, e la successiva annessione dal parte della Russia, altri centri del Sud-Est si sono
sollevati contro il potere centrale. Le sedi dei consigli regionali di Donetsk e Kharkiv sono in
mano a gruppi di estremisti filorussi che hanno annunciato la creazione di repubbliche
indipendenti sul modello di ciò che è successo a Simferopoli. A breve si dovrebbero tenere anche
delle consultazioni popolari per sancire l’autonomia da Kiev. Il condizionale è più che d’obbligo,
dato che la situazione nel Donbass è molto diversa da quella della Crimea. Le insurrezioni dello
scorso fine settimana e le proclamazioni d’indipendenza sono in realtà più minacce che opzioni
reali: chi vuole staccarsi dall’Ucraina è solo un’esigua minoranza teleguidata e un referendum
sarebbe impossibile da tenere senza l’autorizzazione non tanto di Kiev, quanto delle autorità
locali, che sono ancora sotto il controllo dei poteri forti che gestiscono il territorio attraverso la
leva economica, ossia gli oligarchi.
Le vicende della Crimea non sono in sostanza replicabili a Donetsk a Dnipropetrovsk, da Kharkiv
a Lugansk. È certo però che i gruppuscoli separatisti possono accelerare una dinamica alla quale
il governo di Kiev non riesce a far fronte. Si sta ripetendo ciò che a gennaio è successo nelle
regioni occidentali dell’Ucraina, quando manipoli di poche centinaia di persone hanno assaltato i
palazzi del potere da Leopoli a Ivano Frankivsk, da Rivne a Ternopil, creando centri di potere
alternativi contro l’allora presidente Victor Yanukovich. Come allora a Ovest in un paio di casi vi
sono state dichiarazioni di sovranità, allo stesso modo ora a Est si assiste alla stessa scena: con la
differenza che questa volta le parti sono invertite e la coppia che guida ora l’Ucraina, il premier
Arseni Yatseniuk e il presidente ad interim Olexandr Turchynov, deve fare i conti non solo con
movimenti di protesta più o meno consistenti, ma soprattutto con chi li appoggia.
E la questione è ben differente da prima, visto che se durante la rivolta contro Yanukovich il
supporto dell’Occidente alla causa dell’allora opposizione è stato passivo, adesso il Cremlino è
parte attiva nel gioco. Kiev ha denunciato le interferenze di Mosca, affermando che la longa
manus di Vladimir Putin sta cercando l’effetto domino dalla Crimea al Donbass e, anche se il
101
Cremlino ha smentito ogni coinvolgimento, è vero comunque che l’instabilità dell’Ucraina fa il
gioco della Russia. Dopo la perdita della Crimea, il Paese è sull’orlo del collasso, sia a causa delle
forze centrifughe pilotate, sia per una situazione politica ed economica interna che è già
disastrosa di suo.
In primo luogo le forze uscite vincitrici dalla rivoluzione di febbraio hanno già terminato la
tregua e tra i blocchi maggiori, da una parte il duo Petro Poroshenko-Vitaly Klitschko, dall’altro
Arseni Yatseniuk e Yulia Tymoshenko, e ai margini i movimenti della destra radicale
parlamentare (Svoboda) e paramilitare (Pravyi Sektor), è ormai guerra aperta. In secondo luogo
la situazione economica è drammatica e dopo l’arrivo della prima tranche del programma di aiuti
del Fondo monetario internazionale inizierà il periodo di austerity che metterà a dura prova non
solo la tenuta della maggioranza, ma quella dell’intera Ucraina.
Fondamentale, accanto al piano di riforme economiche che prevede lacrime e sangue, la nuova
Costituzione: oltre alla ristrutturazione già avviata del sistema, da presidenziale a parlamentare,
sul tavolo c’è anche quella che Yatseniuk e Turchynov hanno chiamato sino ad ora
decentralizzazione. Primo ministro e presidente hanno annunciato maggiore autonomia anche
finanziaria per le regioni, tentando così di sopire i bollori separatisti. Non si è mai parlato a Kiev
di federalizzazione, la parola magica che piace molto a Mosca e per la quale la Russia spinge nel
tentativo di agganciare le regioni del Sudest, ma è chiaro che l’Ucraina può stare unita solo se
arrivano cambiamenti che tengano conto delle esigenze sia delle élite regionali, cioè di quegli
oligarchi che con il cambio di regime sono rimasti dall’altra parte della barricata, sia di quelle
degli ucraini che considerano i nuovi governanti, a ragione o a torto, inadatti a guidare il Paese.
Le vicende di Kharkiv e Donetsk sono in fondo il segnale che la Russia vuole dire ancora la sua
nella costruzione dell’Ucraina del dopo Yanukovich, non lasciando carta bianca a Bruxelles e
Washington. La prossima conferenza a quattro annunciata dal ministro degli Esteri russo Serghei
Lavrov e dal segretario di Stato americano John Kerry, alla quale partecipa oltre all’Ucraina anche
l’Unione Europea, è il primo banco di prova alla ricerca di un compromesso.
102
La spartizione degli oligarchi
Linkiesta, 10 aprile 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Il tavolo a Vienna sarà per quattro. Solo così si può infatti risolvere la crisi, con tutti gli attori
ufficiali coinvolti nelle trattative, nessuno escluso. O quasi. Tra qualche giorno nella capitale
austriaca si troveranno i rappresentanti di Ucraina, Russia, Unione Europea e Stati Uniti, non solo
perché le conseguenze di un’escalation riguarderebbero tutti, ma perché nel portare
all’emergenza ognuno ha fatto la sua parte. Non è solo la questione della longa manus del
Cremlino nei moti insurrezionali delle regioni del sudest dell’ex repubblica sovietica, ma del
come e del perché si è arrivati a una situazione del genere, partendo dal fatto che meno di cinque
mesi fa la protesta a Kiev contro Victor Yanukovich era cominciata a causa della svolta filorussa
dell’inquilino del palazzo presidenziale in via Bankova. Dalla pacifica rivolta di Euromaidan si è
passati a un epilogo bagnato dal sangue, poi a un cambio di regime non proprio trasparente,
passando successivamente all’annessione da parte della Russia della Crimea, per finire con il
rischio di un conflitto internazionale e il collasso di uno Stato che non riesce a stare in piedi da
solo, strattonato inoltre da Est e da Ovest.
La sfida non è solo tra Ucraina e Russia, con Stati Uniti e Ue a fare da spettatori: se a Kiev sul lato
interno i player sono molti, su quello esterno Mosca e Washington si fronteggiano con Bruxelles
che tenta come di consueto, priva di forza e con tante anime, la mediazione. In palio c’è
l’indipendenza di un paese nato meno di cinque lustri fa e che ha già perso un pezzo per strada. E
la battaglia non è unicamente «in Ucraina» tra ucraini, ma è «per l’Ucraina» tra la Russia e
l’Occidente: dopo la vicenda della Crimea, a Vienna si cercheranno di spegnere le tensioni nelle
regioni orientali cercando un compromesso che accontenti non solo tutti e quattro i soggetti in
questione, ma anche i convitati di pietra, e cioè gli oligarchi che a Donetsk e dintorni sono coloro
che hanno ancora molto da dire: riferimento principale a Rinat Akhmetov, uomo più ricco del
Paese, indiscusso burattinaio, emblema dei poteri forti a cavallo tra politica ed economia.
Dopo la cacciata di Yanukovich gli equilibri sono cambiati e mentre alcuni magnati sono finiti
cooptati dal potere centrale - Sergei Taruta e Igor Kolomoisky i due esempi più eclatanti, finiti a
fare i governatori a Donetsk e Dnipropetrovsk - altri hanno deciso di non salire sul carro dei
103
vincitori (Akhmetov) e altri ancora vogliono direttamente entrare nel palazzo presidenziale di via
Bankova (Petro Poroshenko, Yulia Tymoshenko). Nessuno di questi sarà a Vienna, ma alla fine dei
conti chi li rappresenterà dovrà in qualche modo tenere conto dei rispettivi interessi, che non
sempre coincidono con quelli del paese. L’idea dell’Ucraina come Stato unitario è già finita con
l’abbraccio della Crimea a Mosca e le spinte centrifughe dell’Est non sono solo da addebitare alle
provocazioni del Cremlino: gli ultimi mesi hanno certificato la nascita di un nazionalismo
filorusso in Ucraina, nelle regioni del sudest, in reazione alla protesta contro Yanukovich sospinta
proprio dal vento antirusso soffiato su Maidan dalla destra radicale di Svoboda e dai gruppi
estremisti trainati da Pravyi Sektor.
Tavoli internazionali, riforme costituzionali, economia.
Ma gli equilibri in Ucraina, come sempre, dipenderanno anche
dai rapporti di forza tra le oligarchie.
In regioni in cui il 40% della popolazione è di etnia russa, oltre il 70% di madrelingua russa,
praticamente il 100% è ortodosso è stato inevitabile che gli eventi di Kiev non fossero assorbiti in
maniera indolore, indipendentemente dal fatto che Yanukovich fosse a capo di un governo
cleptocrate. E se da una parte, quella occidentale, il classico nazionalismo ucraino si è sempre
contraddistinto per i suoi tratti antirussi, a oriente l’idea del separatismo coincide con il ritorno
sotto l’ombrello di Mosca. Il Donbass non è comunque la Crimea e se il primo ministro Arseni
Yatseniuk dovrà fare attenzione a non lasciare troppo spazio a Svoboda, evitando la
radicalizzazione, chi vuole che Donetsk diventi il capoluogo di una nuova provincia russa è solo
un’esigua minoranza. Che però c’è. Il governo non ha molte alternative: usare la forza rischia sia
di irritare Mosca che le regioni: nemmeno Yanukovich aveva mandato le forze speciali a Ternopil
o Ivano Frankivsk. Scendere a patti è dunque inevitabile.
Le vie di Vladimir Putin sono infinite e la pressione che la Russia ha messo sulle regioni orientali
dell’Ucraina, ben accetta in parte dell’élite politica e dell’oligarchia, non è solo un fattore di
instabilità, ma anche un’arma per la contrattazione. Quello che Yatseniuk e il presidente ad
interim Olexandr Turchynov hanno già chiamato decentramento regionale, per il Cremlino
104
significa federalizzazione spinta, magari con l’obbiettivo presto o tardi di inglobare nella
Federazione russa gli oblast (regioni, ndr) separatisti. A Vienna tra qualche giorno si discuterà in
sostanza di due punti: la nuova architettura costituzionale ucraina e la collocazione
internazionale di Kiev (fuori dalla Nato), nella prospettiva di tenere insieme un Paese che ha una
storia indipendente breve e un lungo passato fatto di dominazioni e confini sempre ridisegnati. Il
nuovo governo ucraino non pare in grado, non almeno da solo, di risolvere le contraddizioni
interne e di tenere testa alla pressioni esterne e anche questa volta Kiev avrà sul tavolo meno
voce in capitolo di tutti gli altri.
Le mani sull’est
Il Manifesto, 15 aprile 2014
________________________________________________________________________________________________________________
La battaglia ucraina ha una caratura politica, strategica e persino emotiva, tanto un pezzo di
paese vuole svincolarsi dall’influenza russa e tanto Mosca, con la sponda dei suoi lealisti nell’est,
non intende cedere la presa su Kiev, dove la storia statuale e religiosa dei russi, tanti secoli fa,
ebbe inizio. Ma il confronto in corso, già dalle prime battute, quando Yanukovich ciondolò tra
Bruxelles e Mosca cercando di carpire la più ampia mole di denaro possibile, è stato anche intriso
di risvolti economici, che non mancano neanche in queste ore. Il fatto è che l’est ucraino, l’attuale
terreno di scontro, è il baricentro produttivo del paese. Ed è irrinunciabile sia dal punto di vista
di Kiev che da quello della Russia e dei filorussi. Negli oblast (regioni) dell’est si concentra la
parte più lunga della spina dorsale industriale dell’ex repubblica sovietica. La regione di Donetsk,
ex roccaforte di Yanukovich e del Partito delle regioni, nonché bastione demografico del paese
(quasi cinque milioni gli abitanti), è la vertebra più importante. Metallurgia e carbone risultano
i due settori chiave.
Nel 2013 ha garantito il 12,4% del Pil nazionale: tanto quanto ne hanno messo insieme cinque
regioni dell’ovest (Transcarpazia, Ivano-Frankivsk, Leopoli, Volyn e Ternopil), dove l’economia
è meno ingessata, ma anche molto più leggera. Ma questi numeri vanno letti anche in controluce.
105
L’industria dell’est è pesante, vecchia, stantia. È sempre vissuta grazie ai finanziamenti dello
Stato. Questo ha comportato la sopravvivenza dei grossi conglomerati, controllati dagli oligarchi.
Quelli di stazza minore si sono estinti alla spicciolata dopo il crollo dell’Urss, nel 1991. Ci sono
state conseguenze devastanti sul lato dell’occupazione. Molta gente è rimasta a spasso. Sul fronte
del carbone è nata un’industria informale, strutturata intorno ai kopanki, piccoli bacini illegali,
controllati spesso dal potere criminale, dove si lavora con paghe misere e senza uno straccio di
sicurezza. Centinaia e centinaia di operai, nel corso degli anni, sono stati ingoiati dalla terra. Il
paradosso dell’est è proprio questo: da una parte è economicamente indispensabile, dall’altra ha
bisogno di una massiccia iniezione di riformismo industriale. Quella che gli oligarchi, abituati
a vivere senza concorrenza, agganciati ai fondi pubblici e capaci di assicurarseli grazie alla loro
capacità di comprare amicizie, non hanno mai voluto infondere.
Il Donbass è l’area più produttiva del paese. Il che rende lo scenario
ancora più complicato, sia nel caso di una (ri)saldatura con Kiev,
sia se dovesse esserci una scissione, formale o de facto.
Sul futuro dell’est, politico ed economico, non si possono tracciare scenari certi. Si possono però
squadernare due ipotesi. Se l’Ucraina restasse unita - primo scenario - il governo di Kiev dovrà in
qualche modo garantire che la produttività dell’est resti alta, vuoi perché ha bisogno di export
e vuoi perché le grandi industrie, ma anche le strutture carbonifere informali, danno lavoro
a migliaia di persone. La macelleria sociale potrebbe solo ampliare la fronda, spostando sempre
più gente dalla parte della Russia. L’esecutivo deve poi tenere conto delle indicazioni dell’Ue e del
Fmi, che hanno stanziato diversi miliardi di dollari in prestiti, pretendendo riforme. Potrebbero
indispettire gli oligarchi, non abituati a masticare il gergo del cambiamento, ma anche propensi
a evitare la scissione del paese, visto che farebbero fatica a reggere la concorrenza con i grandi
capitali della Russia.
Anche i lavoratori sono agitati. I minatori sono sul piede di guerra. Quelli dei kopanki in modo
particolare, si può presumere, dato che è da poco passata una misura sullo smantellamento delle
miniere abusive, benché non sia chiaro il reale impatto che potrebbe avere. La cosa certa è che
106
Yatseniuk cammina sul filo del rasoio. La carta della federalizzazione e le riforme a piccole dosi
potrebbero non bastare a governare la situazione nell’est. Sempre che l’offensiva del governo non
scateni la rissa totale.
Scenario numero due: la Russia si prende l’est, replicando il caso Crimea o procedendo secondo
schemi informali. Anche in questo caso ai vantaggi si affiancano costi ingenti. Sul Washington
Post il direttore del Centro per gli studi post-industriali di Mosca, Vladislav Inozemtsev, ha
stimato che il mantenimento dell’ossatura industriale dell’est ucraino potrebbe equivalere a un
esborso da una ventina di miliardi di dollari l’anno. Una cifra enorme, considerato i tempi non
così floridi dell’economia russa. Il Pil ristagna, i capitali vanno all’estero. Putin vuole correre il
rischio fino in fondo o pensa a conquistare posizioni di forza in vista della federalizzazione
dell’Ucraina, ammesso che vada in porto?
I piani di Mosca
Lettera 43, 16 aprile 2014
________________________________________________________________________________________________________________
È passato un mese dall’annessione della Crimea da parte della Russia. Il 16 marzo vi è stato
referendum nella penisola sul Mar Nero, il 18 la firma al Cremlino tra Vladimir Putin e il nuovo
governatore Serghei Aksyonov, il 21 il presidente russo ha siglato la legge che incorpora l’ex
lembo di terra ucraina nella Federazione Russa. Poco importa che la comunità internazionale non
abbia riconosciuto giuridicamente legittimi questi passi: la Crimea de facto è russa e i rating di
Putin a casa propria alle stelle. Quattro settimane dopo questi eventi e l’escalation nelle regioni
orientali dell’Ucraina ci si chiede ora quale sia il piano dello zar: usare lo stesso modello per
smembrare con la forza l’ex repubblica sovietica? Mandare i tank sino a Kiev, scatenando una
guerra vera e propria e approfittando degli inevitabili effetti collaterali che sta producendo
l’azione antiterroristica contro i separatisti filorussi lanciata all’inizio della settimana dal
presidente Olexandr Turchynov? Oppure la strategia del Cremlino è più soft e consisterà
solamente nello stare alla finestra, agendo in sostanza come ha fatto nel passato, tra azioni di
107
disturbo tecno-politico e utilizzo delle leve energetico-commerciali, per tenere agganciata
l’Ucraina alla propria orbita?
I piani nel cassetto di Putin sono probabilmente molti. Come si è visto nel passato l’utilizzo di uno
o dell’altro dipende molto da ciò che in realtà fa la controparte e su cui lo stratega del Cremlino
non ha in ultima analisi molta influenza. Nel caso specifico la Russia ora attende come agirà il
governo di Kiev per riportare l’ordine nel Donbass. I gruppi separatisti, teleguidati in parte da
Mosca, ma costituiti in larga parte da ucraini (una truppa raccolta tra le ex forze speciali Berkut,
sciolte dopo l’epilogo sanguinoso di Maidan, e bande locali al soldo degli oligarchi, ma anche da
estremisti filorussi politicamente motivati), non hanno per ora manifestato alcuna intenzione di
voler deporre le armi.
Se la gran parte della popolazione delle regioni del Sud Est si è astenuta dalla rivolta e, secondo i
sondaggi, non vuole certo un’annessione alla Russia, è però vero che le frizioni con il nuovo
governo di Kiev sono reali: la popolazione degli oblast orientali ha visto con scetticismo la
rivoluzione di Maidan e ancor peggio il cambio di regime. L’invio di truppe per sedare i moti
separatisti e liquidare i terroristi che non si piegano - parole del comandante delle forze
governative - potrebbe sfociare in una guerra civile - parole di Vladimir Putin. Il rischio è reale,
visto che comunque i terroristi, o separatisti che dir si voglia, sono ucraini e, se non dovessero
arrendersi, un bagno di sangue anche peggiore di quello visto a febbraio a Kiev è programmato. A
Maidan Yanukovich si era affidato ai Berkut, e ucraini hanno sparato su manifestanti ucraini.
Stavolta Turchynov si affida agli Alpha, oltre che alla improvvisata Guardia Nazionale nella quale
sono confluite parte delle milizie della destra radicale provenienti dalle regioni occidentali. Gli
ingredienti perché la situazione precipiti, tra provocazioni da una parte e reazioni spropositate
dall’altra, ci sono insomma tutti. A seconda di come andrà a finire nel Donbass, Putin ha sulla
carta le due solite opzioni: intervenire militarmente oppure lasciare che in Ucraina scoppi il caos.
Oltre a quello che c’è già.
Al momento, alla vigilia dei colloqui a quattro di Givevra del 17 aprile, dove intorno allo stesso
tavolo dovrebbero sedersi i rappresentanti di Ucraina, Russia, Stati uniti e Unione Europea,
sembra che il Cremlino abbia scelto lo stand by. In questi giorni Mosca ha respinto le accuse di
aver istigato il separatismo ucraino, quando in realtà, lo zampino ce lo ha messo, ma d’altra parte
se il capo della Cia John Brennan si è fatto pescare sotto falso nome in visita a Kiev è chiaro che
108
non sono solo i russi ha giocare a carte coperte. Se gli Stati Uniti hanno dato il sostegno al
governo ucraino per l’operazione militare nel Sud Est, come confermato dal Dipartimento di
Stato, è chiaro che la soluzione della crisi non può che essere trovata sull’asse Washington-Mosca.
E in questa ottica è da leggere il ‘Piano F’ in tasca di Vladimir Putin. F come federalizzazione, la
struttura sulla quale costruire l’Ucraina del dopo Yanukovich: un paese a forte autonomia
regionale, vicino anche all’Europa, ma assolutamente fuori dalla Nato. È questo quello che vuole
la Russia che non sembra disposta a scendere ad altri patti. Le trattative di Ginevra, sulle quali
non bisogna certo farsi illusioni, possono avere un senso solo se tutti gli attori in gioco
abbandoneranno, almeno a porte chiuse, la propaganda e si concentreranno sull’uscita dalla crisi,
prima che gli eventi nel Donbass prendano una dinamica incontrollabile come accaduto a Maidan.
Il progetto di una federalizzazione dell’Ucraina è da tempo nell’agenda del Cremlino. Ne parlò
Victor Medvedchuk, longa manus dello Zar in Ucraina (sua figlia ha come padrino Vladimir
Vladimirovich) nel 2012. Il presidente ad interim Turchynov e il premier Arseni Yatseniuk hanno
parlato di decentramento e di un possibile referendum. Il punto di incontro è insomma possibile.
Prima che l’Ucraina sprofondi.
Perché i russi stanno con Putin
Il Manifesto, 16 aprile 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Senza girarci troppo intorno: la stragrande maggioranza dei russi approva l’operato di Putin in
Ucraina. Ha visto con favore l’annessione della Crimea e percepisce le aree orientali dell’ex
repubblica sovietica, come una costola della stessa Russia. Queste impressioni trovano conferma
nei numeri. Il Levada Centre di Mosca, istituto sociologico che scodella sondaggi con discreta
costanza e che non ha la fama di uno strumento di regime, ha da poco diffuso un sunto delle
rilevazioni effettuate nel corso degli ultimi mesi su come i russi inquadrano la vertenza ucraina.
Una, condotta a marzo, ha evidenziato che il 57% degli intervistati ha «assolutamente» sostenuto
l’adesione della Crimea alla Federazione russa, mentre il 31% l’ha «sostanzialmente» appoggiata.
109
Quanto all’est dell’Ucraina, il 67% ha sostenuto l’allargamento della Russia a questi distretti,
giustificando l’eventuale uso della forza. Solo il 19% si è espresso contro l’espansione territoriale.
Molti, tuttavia, hanno manifestato riserve sul contributo economico che i russi dovrebbero
fornire. In compenso il tasso di consenso di Putin è letteralmente schizzato verso l’alto. A metà
marzo il Centro ricerche sull’opinione pubblica (Vciom) lo ha dato al 71,6%: il dato più
significativo degli ultimi tre anni.
Ci si chiede quali siano i fattori che guidano l’approccio dei russi all’Ucraina. Uno, senza dubbi,
è la campagna mediatica orchestrata dal Cremlino. In tempi recenti le autorità hanno promosso
un giro di vite e dato impulso a una serie di nuove nomine, allineando più strettamente le
direzioni delle principali testate pubbliche - ma anche le private sono state travolte da questo
processo - al verbo del potere. Il Levada Centre riscontrava che il 67% delle persone intervistate
ha dato la colpa delle turbolenze emerse in Crimea ai nazionalisti radicali ucraini.
Ma la propaganda, intensa, non basta. Ci sono altre faccende di cui tenere conto, che affondano le
radici nella cultura politica del paese, più o meno recente. Sul sito di Al Jazeera, Elena Minina, una
ricercatrice dell’università di Helsinki con dottorato conseguito a Oxford, ha spiegato che
a partire dal diciannovesimo secolo nella cultura russa s’è radicata l’idea che russi e ucraini siano
due popoli inseparabili. Questo concetto, sopravvissuto anche durante la stagione marxistaleninista, trae linfa dal fatto che Kiev è stata, secoli fa, la culla della civilizzazione russa. Lì nacque
il primo stato russo della storia, la Rus’. Lì i russi si sono convertiti al cristianesimo orientale. La
questione della fratellanza russo-ucraina è diffusa nella mentalità russa (non così in quella
ucraina dove l’identità nazionale post-sovietica s’è in larga parte sviluppata seguendo un
percorso opposto) e riconoscere a Kiev il diritto alla scelta del proprio destino politico,
significherebbe smontare la cultura politica di Mosca.
Altro elemento che spinge i russi ad appoggiare Putin è la visione che hanno dell’occidente e del
suo attore principale: gli Usa. Mosca è uscita a pezzi dal crollo dell’Urss. Gli anni ‘90 sono stati
economicamente disastrosi.
La Russia era un paese incapace di giocare un ruolo sulla scena internazionale, fu esposto ai
paradigmi liberali, smarrendo il senso della sua identità. La restaurazione putiniana s’è fondata
sull’accentramento dei poteri, sul ruolo forte dello Stato e sull’idea che la Russia non deve né
110
vuole assorbire culture politiche altre rispetto alla propria. Ne è conseguita una spinta alla critica
dell’occidente e degli Usa, vista come potenza viziata dalla volontà di interferire nelle vicende
altrui. La crisi ucraina ha ridato slancio a tutto questo. Le mosse di Putin sulla Crimea e sull’est
vengono interpretate anche come una forma di difesa dall’ultra-protagonismo americano.
Dunque riscuotono seguito.
Guerra civile
Linkiesta, 17 aprile 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Il premier ucraino Arseni Yatseniuk ha detto che ormai la Russia ha iniziato a esportare
terrorismo. Probabilmente ha ragione. Il problema, però, è che l’export va a gonfie vele poiché
nelle regioni orientali dell’Ucraina i compratori sono molti e anziché diminuire sembrano essere,
col passare del tempo, in aumento. I primi tre giorni dell’offensiva annunciata domenica sera dal
presidente ad interim Olexandr Turchynov hanno mostrato il dilemma in cui Kiev si trova: il solo
fatto di aver mandato l’esercito, le forze speciali Alpha, la guardia nazionale appena battezzata e
anche le milizie di Pravyi Sektor, è stato il segnale che a Donestk e dintorni ha preoccupato buona
parte della popolazione, anche quella - la maggioranza - che non vuole certo un’annessione alla
Russia. I separatisti filorussi, teleguidati da Mosca, sono però ucraini: ex militari del Berkut, le
forze speciali sciolte dopo la rivoluzione di febbraio e il massacro di Maidan, bande pagate dagli
oligarchi, giovani estremisti nazionalisti orgogliosi di portare al petto l’ordine di San Giorgio, e
sono circondanti da gente normale. Se la gran parte è silenziosa, chi scende in piazza a fianco
degli autonomisti lo fa soprattutto perché è contro l’attuale governo, che in questi due mesi ha
contribuito a far sprofondare il paese nel caos. Polizia e funzionari amministrativi hanno lasciato
spazio agli occupanti e spesso hanno dato loro una mano.
Se a febbraio nel Donbass la fiducia verso Turchynov e Yatseniuk era bassa, ora è scesa sottozero.
Così si spiega che per Pasqua qualcuno si augura la resurrezione di Victor Yanukovich, che ladro
era, ma almeno non aveva portato il paese sull’orlo della guerra civile, quando in realtà avrebbe
111
potuto farlo, mandando i carri armati a liberare i palazzi del potere occupati dai nazionalisti nelle
regioni occidentali. Ora è nel sudest, dove la situazione è differente da quella in Crimea, che gli
ucraini si trovano di fronte ai tank. E molti si lamentano di venire trattati alle stregua di terroristi.
Il governo di Kiev sa benissimo che un bagno di sangue non solo offrirebbe su un piatto d’argento
la scusa al Cremlino di intervenire militarmente a fianco della minoranza russa, che è nelle
regioni in questione in realtà una maggioranza, sia etnica che linguistica, ma è consapevole che il
pugno duro aumenterebbe in ogni caso la distanza tra centro e periferia, difficile da colmare
anche con l’aiuto degli oligarchi messi senza troppo successo alla guida degli oblast per tentare di
bloccare i moti autonomisti. Ammesso e non concesso che l’operazione antiterrorismo si
concluda con effetti collaterali limitati, i cocci da raccogliere saranno numerosi e rimarranno
comunque per lungo tempo.
L’offensiva dei governativi nel Donbass e il muro eretto dai filorussi
non sono “questioni tattiche”. Lo spettro del conflitto è ormai realtà.
Kiev è condizionata evidentemente della mosse di Mosca, anche se ha fatto del suo peggio per
complicare la situazione. In otto settimane al potere, il nuovo establishment si è dimostrato
impotente di fronte agli eventi e le diverse anime del nuovo governo, unite nella fase
rivoluzionaria contro Yanukovich, hanno seguito strategie diverse, contraddittorie e
controproducenti. Come era stato previsto. Una delle prime mosse del governo di Yatseniuk,
appena insediato in un parlamento non eletto, ma trasformista, è stata l’abolizione della legge
sull’utilizzo ufficiale della lingua russa. Se la Rada l’ha approvata, poi Turchynov non l’ha firmata,
ma ormai il danno era fatto, accendendo le prime micce in Crimea. Lo scioglimento del Berkut è
stato siglato all’unanimità, vale a dire dalle due formazioni governative (Patria, di Yatseniuk e
Yulia Tymoshenko, e Svoboda di Oleg Tiahnybok), mentre Vital Klitschko (Udar) metteva in
guardia che la mossa avrebbe potuto rivelarsi errata. Non c’era bisogno della sfera di cristallo per
prevedere che le tre forze che avevano costretto alla fuga Yanukovich si sarebbero poi scontrate:
quando il nuovo presidente del Consiglio di sicurezza nazionale Andrei Paruby (fondatore con
Tiahnybok del Partito social-nazionalista ucraino) ha annunciato l’introduzione del visto per i
112
cittadini russi, il giorno dopo è stato smentito a Bruxelles dallo stesso Yatseniuk. A Kiev una mano
non sa spesso cosa fa l’altra e quando lo capisce non c’è tempo e voglia per rimediare. E questi
sono solo gli esempi più evidenti. Quando un gruppo di deputati della destra radicale ha
malmenato il direttore del primo canale televisivo per costringerlo alle dimissioni, Kitschko ha
chiesto a Tiahnybok di far dimettere i parlamentari esagitati e Yatseniuk non ha potuto fare altro
che voltare la faccia, visto che Svoboda è comunque fondamentale per la tenuta del governo.
La compagine che guida il paese ha già perso per strada il ministro della Difesa, senza citare la
girandola di poltrone che Turchynov ha avviato tra amministrazione e servizi, e quello degli
Interni Arsen Avakov, abituato a comunicare più via Facebook che attraverso i canali ufficiali,
anche per quel riguarda le operazioni militari, è da un paio di settimane sotto pressione. I radicali
di Pravyi Sektor chiedono la sua testa dopo l’uccisione di uno di loro, Sasha il Bianco, durante una
operazione della polizia che tentava di arrestarlo. Secondo la versione di Avakov si sarebbe
ucciso, per Pravyi Sektor si è trattato di un’esecuzione. Visto che i colpi mortali al cuore sono stati
due, qualcosa da chiarire forse c’è. I gruppi paramilitari, che non solo sono stati inviati all’est,
arruolati accanto alle truppe ufficiali, ma continuano a presidiare a Kiev Maidan e dintorni, sono
il simbolo che il governo non ha proprio tutto sotto controllo e, se da un lato si appoggia, o non
può fare a meno di appoggiarsi, alle camicie nere guidate da Dmitri Yarosh, dall’altro rischia di
gettare con questa alleanza ancora più benzina sul fuoco del Donbass.
Al di là di tutto questo e dell’emergenza prima in Crimea e ora nel sudest, il governo è davanti al
compito immane di non far sprofondare il paese economicamente. Da questo punto di vista non è
stato fatto nulla e si aspetta in sostanza l’arrivo dei fondi internazionali. Intanto le casse delle
stato si sono svuotate, la grivna ha perso il 40 per cento nel giro di due mesi, industria e finanze
sono bloccate.
Se si aggiunge il fatto che il problema del gas con la Russia è passato in secondo piano solo perché
è primavera, si capisce come Turchynov e Yatseniuk e tutti gli ucraini siano in realtà seduti su
una bomba a orologeria. Alla fine di maggio sarà eletto un nuovo presidente, a dar retta ai
sondaggi l’oligarca Petro Poroshenko, e anche il governo subirà necessariamente un rimpasto,
soprattutto se il re del cioccolato non sfonderà davvero e dovrà condividere il successo anche con
il suo alleato che si è ritirato in corsa, Klitschko. Il decentramento e le modifiche della
costituzione promesse da presidente e governo entro l’appuntamento elettorale sono rimaste per
113
ora lettera morta, ma la crisi del sudest non lascia spazio a ulteriori ritardi. Cosa e da chi in realtà
verrà deciso a Kiev rimane però ancora un mistero.
L’Ucraina dilaniata
Linkiesta, 26 aprile 2014
________________________________________________________________________________________________________________
L’offensiva lanciata dal governo ucraino contro i separatisti filorussi nelle regioni del sudest va
avanti a singhiozzo. E non potrebbe essere altrimenti. Sostanzialmente per due motivi. Da un lato
si tratta davvero, per ora, di un’operazione antiterrorismo che ha lo scopo di disinnescare la
minaccia dei gruppi armati che occupano edifici pubblici e palazzi del potere in diversi centri del
Donbass. La strategia è quella di condurre interventi chirurgici evitando il coinvolgimento della
popolazione. Dall’altro lato c’è il fatto che a Kiev pochi sanno veramente che pesci pigliare e si è
sostanzialmente in balia degli eventi. Il premier Arseni Yatseniuk e il presidente ad interim
Olexandr Turchynov non fanno passo senza consultarsi con i soli che si sono schierati senza se e
senza ma al loro fianco, gli Stati Uniti. Nelle ultime settimane, con i picchi delle visite a Kiev del
capo della Cia John Brennan e del vice presidente Joe Biden, la consulenza e il supporto a stelle
strisce sono stati evidenti e, anche a livello internazionale, la Casa Bianca è parsa il megafono
della Bankova, con questa impossibilitata e inadeguata a tener testa al Cremlino. Non solo. A
meno di un mese dalle elezioni presidenziali, il nuovo establishment ucraino appare frammentato
al suo interno e assediato all’esterno dalla destra ultranazionalista di Pravy Sektor, che, pur
numericamente insignificante, gioca un ruolo strategicamente determinante. E il peggio deve
probabilmente ancora venire, se si dà retta a Dmitri Yarosh, candidato alle presidenziali e leader
dei paramilitari del Settore di destra, che ha annunciato la creazione di un battaglione di 800
miliziani che andrà ad affiancare le truppe regolari di Kiev.
Nonostante il ministro degli interni Arsen Avakov abbia smentito, come suo uso e costume, via
Facebook, Pravy Sektor rimane una variabile incontrollabile nello scenario che nei prossimi
giorni, con l’inizio di maggio, potrebbe precipitare in maniera definitiva. Le elezioni presidenziali
114
del 25 sono vicinissime, ma sembrano lontane perché nel giro di un paio di settimane lo scenario
potrebbe cambiare radicalmente, soprattutto se nei prossimi giorni continuerà la tensione nel
Donbass e la cosiddetta operazione antiterrorismo governativa deraglierà in uno scontro aperto,
con Mosca che dovrà decidere se rimanere alla finestra o in qualche modo intervenire. Le nuove
esercitazioni russe vicino al confine non promettono nulla di buono.
Per l’11 maggio è previsto il referendum sull’autonomia indetto dai ribelli della autonominatasi
Repubblica di Donetsk: si tratta in realtà di una farsa, nel senso che una consultazione popolare
regolare è di fatto irrealistica, ma la data rimane come un simbolo per le richieste che arrivano
dal sudest. Tanto più che il consiglio regionale del capoluogo regionale del Donbass, come quelli
di Lugansk e Odessa, ha chiesto al potere centrale di venire incontro alle istanze di maggiore
autonomia finanziaria e di garanzie per l’utilizzo della lingua russa che arrivano non solo da chi
ha impugnato le armi, ma da buona parte della popolazione. Anche il governatore dell’oblast di
Donetsk, l’oligarca Sergei Taruta, nominato dal capo di stato proprio per sedare i bollori
separatisti, si è espresso a favore di un referendum su questi due temi da tenere il 25 maggio.
Nelle scorse settimane, sia Yatseniuk che Turchynov avevano già ventilato l’ipotesi, che però è
rimasta sino ad oggi solo sulla carta.
Il parlamento lavora a corrente alternata, la maggioranza è divisa, i candidati alle presidenziali,
da Petro Poroshenko e Yulia Tymoshenko, hanno fallito nei loro tentativi di mediazione. E il
tempo stringe. Anche in vista delle prossime festività, che rischiano di diventare il palcoscenico
per la definitiva escalation. Tradizionalmente il 9 maggio si festeggia in Ucraina, e in tutte le ex
repubbliche sovietiche, la vittoria sul nazismo in quella che è chiamata la Grande guerra
patriottica (1941-45) che coincide in sostanza con la Seconda guerra mondiale. La percezione di
questa data è però per ragioni storiche molto differente tra est ed ovest del paese e nel passato
recente si è assistito un po’ ovunque, dai Carpazi al Mar Nero, a scontri tra nazionalisti ucraini e
militanti filorussi. Incidenti e provocazioni si sono registrati regolarmente ogni anno a Leopoli,
Odessa e altrove, dovunque si sono trovati di fronte gli estremisti abituati a celebrare i
collaborazionisti nazisti e i nostalgici del comunismo stalinista. Quest’anno la situazione di fondo
è ben peggiore e gli ingredienti per il worst case si stanno accumulando giorno dopo giorno, sia in
Ucraina che sulla scacchiera internazionale. Gli accordi di Ginevra sono diventati terreno di sfida
tra Stati Uniti e Russia. Se i primi rinfacciano a Mosca di continuare a fomentare la rivolta armata,
115
i secondo accusano Washington di stare al fianco non solo di un governo illegittimo, ma pure
degli ultra-nazionalisti di Pravy Sektor che le armi le hanno deposte solo a parole. Chi spera di
evitare il tracollo è ancora la Germania, impegnata a tessere con l’Osce una tela per fermare i
venti di guerra, ma i tentativi di mediazione del ministro degli esteri tedesco Frank Walter
Steinmeier e del consigliere federale svizzero Didier Burkhalter rischiano di bruciarsi con l’arrivo
del maggio di fuoco.
Kiev si affida ai super ricchi
Lettera 43, 29 aprile 2014
________________________________________________________________________________________________________________
L’agguato a Gennady Kernes, sindaco e padrone di Kharkiv, rappresenta lo spaccato dell’Ucraina:
di oggi e di ieri. Un politico discusso, quasi un oligarca con legami non proprio trasparenti anche
negli ambienti della criminalità organizzata, si dice, prima uomo forte nella squadra dell’ex
presidente Viktor Yanukovich, ora mediatore spostato a fianco del governo di Arseni Yatseniuk,
con il compito di non far precipitare nel caos una delle città e delle regioni chiave del sud Est in
rivolta. Kernes è stato preso a pistolettate nella schiena e non si sa ancora perché. C’è chi dice che
siano stati i filorussi, chi gli oscuri rivali nella lotta sottotraccia per il controllo di territorio e
risorse finanziarie, un regolamento di conti tra bande come negli Anni 90, quando non solo nel
Donbass, ma in tutta l’Ucraina, il metodo migliore per fare affari era quello di eliminare
fisicamente gli avversari. Storie sporche e leggende metropolitane, attraverso le quali sono
passati un po’ tutti gli esponenti della classe oligarchica e politica: da Kernes a Yanukovich, da
Yulia Tymoshenko a Rinat Akhmetov. I robber baron di 20 anni fa, nati e cresciuti alla corte di
Leonid Kuchma, il capo di Stato mentore di Yanukovich, si sono poi trasformati in brillanti
businessman, global player sulla scacchiera economico-finanziaria europea e internazionale, e in
politici a tutto tondo, a capo non solo nelle loro aziende, ma del Paese.
In una fase come quella in corso, con l’Ucraina allo sbando, sottoposta a forze centrifughe interne
e laceranti pressioni esterne, gli oligarchi sono tornati protagonisti, nel tentativo di salvare il
116
Paese che nel passato - recente e lontano - hanno contribuito ad affossare. Alla fine del 2013,
quando Yanukovich era ancora in sella, ma stava già traballando, quasi tutti gli sponsor dell’ex
presidente hanno cominciato a cambiare casacca. Nel corso delle settimane, sino al sanguinoso
epilogo di Maidan, tutti si sono chiamati sostanzialmente fuori, chi più, chi meno. Se Rinat
Akhmetov e Dmitri Firtash sono rimasti però lontani dal nuovo blocco di potere, altri hanno fatto
il salto completo della barricata. Il presidente ad interim Alexander Turchynov, delfino di
Tymoshenko dai tempi in cui l’ex premier era chiamata la «principessa del gas», ha cooptato
proprio due pezzi da novanta dell’oligarchia a capo dei governi nelle regioni di Donetsk e
Dnipropetrovsk. Sergei Taruta e Igor Kolomoisky, il primo presidente dell’Unione degli
industriali del Donbass, il secondo sempre in testa alle classifiche degli uomini più ricchi del
Paese (dopo Akhmetov e Victor Pinchuk, genero di Kutschma), hanno tentato in queste settimane
di mettere un coperchio ai bollori filorussi nei rispettivi oblast. Se a Kolomoisky la cosa è riuscita,
almeno per ora, Taruta è finito nel ciclone separatista che ha il suo epicentro tra Donestk e
Slaviansk. Con il risultato che l’oligarca equilibrista è diventato uno dei promotori del
referendum sull’autonomia chiesto al potere centrale.
Un altro esponente dell’ex team di Yanukovich, che ha mantenuto comunque sempre una certa
indipendenza, è Sergei Tigipko, impegnato nella trattative con i ribelli armati a Lugansk.
Candidato alle presidenziali, già terzo nel 2010 dietro Yanukovich e Tymoshenko, Tigipko,
ricchissimo ex governatore della Banca centrale, è uno dei moderati che godono di un consenso
trasversale, esattamente come Petro Poroshenko, il re del cioccolato, che i sondaggi danno
strafavorito per il 25 maggio, tanto che il ballottaggio potrebbe rivelarsi non necessario. Sesto
uomo più ricco d’Ucraina secondo la classifica di Forbes, Poroshenko è l’oligarca del momento:
sulle barricate durante la protesta contro Yanukovich, ha accumulato consenso sempre crescente
in tutte le regioni, da Est a Ovest. L’alleanza con Vitaly Klitschko, ritiratosi dalla corsa alle
presidenziali ripiegando su quelle per il sindaco di Kiev, gli ha dato maggior forza e la sua rivale
più accreditata, Tymoshenko, non sembra proprio in grado di contrastarlo. Fra quattro
domeniche, insomma, un oligarca è destinato a entrare alla Bankova, primo nella breve storia
dell’Ucraina. E con la riforma della Costituzione allo studio in parlamento, le promesse di
decentramento già fatte dal governo di Yatseniuk e la possibilità di un referendum
sull’autonomia, saranno altri oligarchi ad accentrare il potere nelle regioni, lasciando in sostanza
il destino del Paese in mano ai pochi soliti noti.
117
7
GUERRA E VOTO
(maggio 2014)
Nel Donbass si tengono i referendum sull’indipendenza, appoggiati da Mosca e non
riconosciuti da Kiev e dall’Occidente. Rispetto al modello della Crimea, non si
assiste a nessuna annessione, con il Cremlino che consiglia ai separatisti di soprassedere alla
questione. Le elezioni presidenziali di fine porteranno alla presidenza Petro Poroshenko, dopo che
Vitaly Klitschko si è ritirato dalla competizione, lasciando via libera all’oligarca del cioccolato.
Dietro le quinte sono i poteri forti a muovere le loro pedine, mentre la tensione da Donetsk e
Lugansk si allarga sino al Mar Nero, con la strage di Odessa. Gli sforzi diplomatici della comunità
internazionale si infrangono sul muro di Kiev, deciso a riconquistare i territori perduti manu
militari, e su quello di Mosca, con Vladimir Putin che non molla la presa. Il paese è sempre più
lacerato e il disastro economico ormai alle porte.
Inaugurazione presidenziale di Petro Poroshenko (president.gov.ua)
118
Le mosse del Fondo
Il Manifesto, 2 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Le fondamenta dell’economia di Kiev erano già fragili, da prima che scoppiasse la protesta contro
Yanukovich, il 21 novembre scorso. È il giorno in cui l’ex presidente ucraino rifiutò gli Accordi di
associazione targati Ue, pacchetto di importanti incentivi commerciali. Da allora è successo di
tutto. La rabbia popolare s’è trasformata in rivoluzione, la Crimea ha preso la strada di Mosca
e l’est del paese è diventato il teatro di una guerra, per ora a bassa intensità: da una parte
l’esercito di Kiev, dall’altra i ribelli filorussi. Questa catena di avvenimenti ha fatto molto male
all’ex repubblica sovietica. Diversi investitori stanno portando via i loro capitali, anche a costo di
svendere, come ha fatto Intesa San Paolo. La hryvnia ha perso dall’inizio dell’anno il 29% sul
dollaro. Nessun’altra moneta al mondo ha avuto un andamento così disastroso. Quanto alla
crescita, il Fmi stima che quest’anno Kiev perderà cinque punti di Pil. Un’altra botta devastante,
dopo i 15 punti bruciati nel 2009, causa crisi globale. È lo stesso Fmi che cercherà di evitare che
l’Ucraina capitoli. Insieme all’Ue le presterà all’incirca 23 miliardi di euro. Una somma che
rappresenta il 15% del Pil (dato 2013). La prima rata dell’importo, da due miliardi e 300 milioni,
è stata già scongelata.
Il soccorso del Fondo monetario è ingente, ma la sua efficacia è soggetta
a variabili interne: in che misura le riforme chieste da Christine Lagarde attecchiranno,
tenuto conto anche dei precedenti non così edificanti?
Lo stanziamento fa parte della partita internazionale in corso. Il Fmi, strumento a trazione
occidentale, se si guarda al contributo fornito dai paesi membri (quello americano s’aggira sul
15%) e dal peso relativo che ne deriva in termini di voti, ha deciso di intervenire in Ucraina dopo
che Mosca, una volta imploso il sistema predatorio di Yanukovich, ha annullato il prestito da 15
miliardi di dollari e il taglio sul gas accordati a dicembre all’ex repubblica sovietica. Quell’intesa
ne spostò il baricentro verso la Russia, facendo evaporare definitivamente l’ipotesi di firmare gli
Accordi di associazione, a loro volta legati a un possibile sostegno del Fmi. Una delle ragioni
119
a monte del no di Yanukovich sta nel fatto che il Fmi chiedeva di aumentare la tariffa del gas,
tenuta artificiosamente bassa, per motivi di consenso elettorale, da tutti i governi che si sono
succeduti al potere a Kiev. Da qui, tutto sommato, si riparte. La condizione più stringente che
Lagarde, la direttrice del Fmi, ha chiesto al governo del primo ministro Yatseniuk è proprio la
rettifica al rialzo delle bollette. Naftogaz, l’azienda statale del gas, ha i conti profondo rosso. Deve
più due miliardi di euro a Mosca. I soldi del Fmi serviranno anche a coprire questa voragine, ma
Kiev è tenuta - appunto - a caricare la bolletta. Il che può avere evidenti contraccolpi sociali, in un
paese dove il reddito medio annuale non supera i 4000 dollari (in Russia è 14000, in Polonia
quasi 13000). Lagarde ha comunque spiegato che verranno licenziati provvedimenti orientati
a tutelare le fasce deboli. Le altre misure che il Fmi reputa urgenti riguardano il contenimento del
deficit e dell’inflazione, il mantenimento del tasso di cambio variabile della hryvnia (adottato
a febbraio), una serie di riforme a favore della trasparenza economica, qualche taglio e qualche
balzello in più.
Al di là dei contenuti della ricetta, il vero punto è se questo piano sarà capace di progredire.
Diverse sono le incognite. Una, ovviamente, è la situazione dell’est. Se il conflitto tra forze
governative e milizie filorusse dovesse aggravarsi, determinando persino variazione territoriali il
Fmi dovrebbe rivedere, aumentandolo, l’importo del bailout. E poi ci sono gli oligarchi, la razza
padrona del paese. Ricchissimi, refrattari alle riforme e al principio della concorrenza, il loro
obiettivo storico è sempre stato quello di salvaguardare i loro monopoli industriali. Dosano forza
mediatica e influenza sulla politica. Saltano, quando necessario, da un partito all’altro. Non
disdegnano l’Europa, ma temono le riforme che l’Ue e il Fmi squadernano. Vogliono mantenere
intatto il flusso di affari con la Russia (è il loro mercato principale) evitando però che l’ipoteca
esterna di Mosca s’ingigantisca. La loro indole, sotto certi aspetti, è gattopardesca. L’azione del
Fmi li disturba. Tanto che, si dice in questi giorni, pur in assenza di prove, qualche tycoon avrebbe
foraggiato i ribelli di Donetsk. La strategia può portare all’indebolimento del governo e a rendere
inefficace l’azione del Fmi, che ha già prestato molti soldi, nel corso degli anni, a Kiev. Ma
l’Ucraina s’è rivelata un buco nero. Le riforme non hanno attecchito, non s’è creata una classe
media, gli oligarchi hanno continuato a bivaccare.
120
Gli oligarchi con Yatseniuk
Il Manifesto, 8 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Potenzialmente la regione di Dnepropetrovsk è uno snodo sensibile nel contesto della partita in
corso nell’ex repubblica sovietica. Potrebbe saltare in ogni momento. Gli elementi ci sarebbero
tutti. A partire da un apparato industriale importante e a seguire con il fatto che nel distretto si
parla prevalentemente russo (la lingua è diventata uno dei fattori della contesa). Senza contare la
prossimità con le regioni di Kharkiv e soprattutto di Donetsk. L’insurrezione è a due passi. Lo
spettro del contagio è concreto. Ma Dnepropetrovsk ha mantenuto una sua stabilità.
Tra le varie ragioni c’è senz’altro la nomina a governatore, avvenuta a inizio marzo, del potente
oligarca di origini ebraiche Igor Kolomoisky. Controlla Privat Bank, primo istituto di credito del
paese. La sua scalata finanziaria è avvenuta in modo opaco, come del resto quella di tutti i suoi
pari. Kolomoisky ha fatto una scelta di campo, schierandosi con l’esecutivo di Arseni Yatseniuk.
Mai prima d’ora aveva ricoperto cariche politiche, sebbene abbia sempre manifestato una
simpatia, anche staccando assegni, verso Tymoshenko. Kolomoisky sta portando avanti una
politica dal duplice respiro. Da una parte fa il falco, esibendo tolleranza zero verso i filorussi.
L’altro approccio di Kolomoisky è quello tipico che gli oligarchi esibiscono. Blandire, promettere,
comprare consenso. Kolomoisky non è l’unico tycoon che Kiev ha ingaggiato, in questo senso.
A governare Donetsk c’è Sergei Taruta, socio principale dell’Unione industriale del Donbass,
colosso metallurgico. Ma Taruta, a differenza di Kolomoisky, non ha tenuto a freno i filorussi.
Anche un altro oligarca, Igor Palytsa, ha ottenuto le chiavi del palazzo, di Odessa. Kiev ce l’ha
spedito dopo il massacro alla sede dei sindacati. Palytsa è vicino a Kolomoisky e si pensa che
anche a Odessa lo schema delle ricompense e della delega dello Stato alle strutture oligarchiche alla faccia della rottura morale e politica di cui questo governo è sulla carta portatore - possa
andare in scena. Kolomoisky, Taruta e Palytsa stanno con il governo, ma prima di ogni altra cosa
vogliono difendere i loro interessi. È questa la costante storica degli oligarchi, la classe dominante
dell’Ucraina. In cinquanta controllano mezzo Pil. La tendenza non è stata smentita. Tutti si sono
mossi per salvaguardare il conto in banca, tutti hanno preso le distanze da Yanukovich. Non tutti
però hanno preso possesso delle stanze dei bottoni, come nel caso Firtash, che ha dominato il
comparto del gas in questi anni. È stato arrestato a Vienna, su mandato di cattura americano (è
121
sospettato di legami con la mafia russa). Ha pagato una cauzione e ora attende di capire se verrà
estradato o meno. Quanto alle mosse in Ucraina, Firtash, che aveva finanziato Yanukovich, è stato
lesto a sintonizzarsi con il cambiamento. Ha investito su Klitschko e Poroshenko, il candidato che
più di ogni altri può vincere le presidenziali del 25 maggio. Klitschko farà convergere su di lui
i suoi voti. Poroshenko, se vincesse, potrebbe tutelare Firtash. Che intanto starebbe finanziando
anche agli insorti filorussi. Così, almeno, si sussurra. C’è poi Pinchuk, genero dell’ex presidente
Leonid Kuchma. L’uomo durante il quale il sistema oligarchico ha preso compiutamente forma.
Pinchuk, sulle prime, ha accordato sostegno al governo di Yatseniuk. Ma ha rifiutato di assumere
incarichi, benché richiesto. Segno che, secondo gli analisti, intende riservarsi margini di manovra,
se mai il governo di Kiev dovesse fare una brutta fine. La stessa linea di Akhmetov, il più ricco di
tutti. È di Donetsk. Il pilastro del suo impero economico sono i metalli. Akhmetov ha prima
sostenuto i negoziati tra Yanukovich e l’opposizione. Capitolato Yanukovich, ha appoggiato il
governo. Qualche tempo fa ha mediato tra Kiev e i ribelli filorussi. L’ideale, dal suo punto di vista,
sarebbe che l’Ucraina resti in sospeso tra l’Europa e la Russia.
Cosa vuole Putin?
Linkiesta, 8 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Due sono gli appuntamenti fondamentali da cui si capirà quale potrà essere il prosieguo della
crisi ucraina, una vicenda incominciata quasi sei mesi fa e che si concluderà se e solo quando tutti
gli attori coinvolti decideranno di sedersi intorno a un tavolo giocando a carte scoperte. La
soluzione del rebus, e il futuro dell’Ucraina, non dipendono certo solo dalle scelte del Cremlino,
ma da quelle sia del blocco di potere al momento al governo a Kiev sia di chi lo sostiene, in primis
gli Stati Uniti.
Perché la guerra “in” Ucraina è anche una guerra “per” l’Ucraina. Perché di guerra si tratta,
seppure solo a episodi. Sia quella che si combatte sul campo, nel bacino limitato della regione di
Donetsk, tra i centri della rivolta filorussa armata, da Slaviansk a Kramatorsk. Sia quella
122
nemmeno tanto sottotraccia, tra Russia e Occidente, o più precisamente tra Russia e Stati Uniti:
un rigurgito di Guerra fredda in salsa da terzo millennio. In più c’è la guerra civile, quella tra
ucraini che non indossano uniformi nè imbracciano le armi di professione, ma si scannano tra di
loro come è successo qualche giorno fa a Odessa, prendendosi semplicemente a fucilate e
scatenando roghi mortali.
Gli eventi di questa guerra che ogni giorno offrono diverse prospettive di lettura si inseriscono
comunque in una cornice che non è solo quella dei confini dell’ex repubblica sovietica e
dell’Europa, ma arriva anche al di là dell’Atlantico. Washington al fianco di Kiev, o meglio gli Usa
accanto al governo di Arseni Yatseniuk, contro Mosca e Vladimir Putin. E l’Europa dalle tante
anime nel mezzo un po’ a guardare, un po’ a mediare, soprattutto nel caso della Germania, i cui
rapporti con la Russia vanno al di là dei tubi del gas. L’Ucraina è sull’orlo del baratro: e ora?
Ebbene, gli eventi cruciali sono questi. Il referendum dell’11 maggio, che i separatisti sono decisi
a tenere nonostante il Cremlino abbia chiesto almeno il posticipo, e le elezioni presidenziali il 25.
Costituiscono lo spartiacque di questa fase della crisi che va avanti a strappi, tra improvvise
escalation e speranze di appianamento. La consultazione popolare nei distretti di Donetsk e
Lugansk è una farsa, come ha detto Yatseniuk, ma ciò non toglie che se sarà tenuto avrà una
valenza di cui il governo non potrà tener conto, soprattutto per il processo futuro di riforme.
Il premier ha detto di non voler trattare con i terroristi e ha accusato Putin di vendere aria fritta,
ma il problema è che sino ad oggi Kiev ha ignorato qualsiasi richiesta proveniente dal Sudest: le
promesse di decentramento e modifica della costituzione sono rimaste bloccate in parlamento
Le proposte fatte da Sergei Taruta, l’oligarca messo dal presidente ad interim Olexandr
Turchynov alla guida della regione di Donestk, sono finite nel cestino. Sia Yatseniuk che
Turchynov hanno accusato da un lato da Russia di essere la causa di tutte le disgrazie ucraine,
dall’altro non hanno però fatto mezzo passo concreto per andare incontro ai cittadini ucraini del
Sudest.
Gli avvenimenti di Odessa hanno dimostrato che il potere centrale non solo non ha sotto
controllo la situazione negli oblast orientali dove i separatisti dettano legge, ma nemmeno
altrove: la liberazione di circa settanta manifestanti filorussi arrestati il 2 maggio, ottenuta da una
folla inferocita che ha assaltato la sede della polizia costringendo le autorità a spalancare la
123
saracinesca è stata la consacrazione dell’impotenza governativa. E poco c’entra in questo caso
Vladimir Putin. Il Cremlino, con la sua tattica a elastico, vuole indebolire un governo che
considera illegittimo, e che un po’ in realtà lo è davvero, sostenuto da chi non ha fatto mistero
durante la rivolta contro Yanukovich, di augurarsi un epilogo del genere. La telefonata del vice
segretario di Stato americano Victoria Nuland in cui si definiva in sostanza Yatseniuk come
l’uomo di Washington è stata la rivelazione di un segreto di Pulcinella. La Russia è interessata a
mantenere la sua influenza in Ucraina e sta facendo di tutto, e continuerà a farlo, per ribaltare la
situazione. L’annessione della Crimea è stato un passo previsto e facile, ma nel Donbass le cose
sono diverse. Un’operazione militare su larga scala, con effetti collaterali catastrofici a tutti i
livelli non solo in Ucraina ma anche in Russia, è l’ipotesi meno realistica, nonostante i toni da
propaganda che si sentono dalla Casa Bianca al Cremlino passando per la Bankova, che ha
evocato la terza guerra mondiale.
Il referendum dell’11 maggio è in sostanza un’altra tappa verso quello scenario di
smembramento dell’Ucraina che il 25 maggio, se le elezioni si terranno più o meno regolarmente
e se saranno riconosciute da tutti, potrà subire un rallentamento o un’altra accelerazione.
Guardando i sondaggi, l’elezione al primo turno dell’oligarca Petro Poroshenko, appare cosa
scontata. Se nel frattempo la situazione non sarà precipitata, il nuovo capo di Stato si troverà di
fronte al difficile compito di prendere in mano il Paese e cercare con Yatseniuk il modo migliore
per raccogliere i cocci e fare in fretta le riforme in senso autonomista che sono state promesse e
che nessuno ha ancora visto. Poroshenko, un pragmatico capace di parlare con tutti, anche con il
Cremlino, dovrà mediare con l’attuale premier, la cui sedia non è mai stata stabilissima, e con
Yulia Tymoshenko, che vuole tornare protagonista e al di là della maschera da combattimento sa
benissimo che l’arte della politica sta nel compromesso. Meno ideologica di Yatseniuk ha con
Putin un rapporto controverso, ma i fatti dicono che il migliore contratto sul gas per la Russia è
quello che ha firmato lei nel 2009 a Mosca. Se fosse per la Russia, insomma, i venti di guerra
potrebbero sopirsi in maniera definitiva, a patto che dagli Stati Uniti non si voglia rimanere
attaccati a tutti i costi a un governo nato da un colpo di stato e sostenuto da un parlamento che
non è stato ancora rinnovato. La soluzione sul breve periodo sta in un’Ucraina federale e fuori
dalla Nato: lo aveva già suggerito Herry Kissinger, non Vladimir Putin.
124
Odessa e la guerra del popolo
Lettera 43, 9 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Se a Kiev c’è Maidan Nezalezhnosti, Piazza dell’Indipendenza (quella da Mosca del 1991), a
Odessa c’è Kulikovo Pole, il Campo di Kulikovo (dove i russi vinsero una storica battaglia contro i
mongoli nel 1380). La prima è il simbolo della rivolta contro Viktor Yanukovich e del bagno di
sangue di febbraio, il secondo è stato il teatro della carneficina in cui sono morte quasi 50
persone a inizio maggio. Questa volta manifestanti non europeisti, ma filorussi. La tragedia della
sede dei sindacati andata in fiamme ha spaccato la metropoli sul Mar Nero: da una parte chi
accusa i dimostranti filogovernativi che hanno assediato l’edificio e lanciato le molotov, dall’altra
chi vede dietro tutto una macchinazione del Cremlino e l’origine del disastro nell’attacco degli
estremisti alla manifestazione per l’Ucraina unita che si stava svolgendo poco distante.
Tutti comunque a criticare governo e forze dell’ordine che non hanno fatto nulla per evitare un
massacro annunciato. È strano il destino di Odessa, la città più cosmopolita del paese, che si è
trasformata in pochi giorni in palcoscenico per l’odio tra ultranazionalisti e filorussi.
La perla sul Mar Nero è diventata suo malgrado il simbolo dell’Ucraina che non trova più se
stessa. Fiorita ai tempi degli zar, alla fine del Settecento, è sempre stata legata con doppio filo da
un lato a Mosca, ma dall’altro al mondo intero: grande porto, centro dei traffici verso il
Mediterraneo e l’Oriente, influenze e culture dall’Europa all’Asia, una folta comunità ebraica.
Durante la seconda guerra mondiale fu occupata per quattro anni dai tedeschi, che non
lasciarono un bel ricordo. Massacri e rappresaglie, con i partigiani a nascondersi nelle catacombe
che si possono visitare ancora adesso. Oggi, a oltre 20 anni dall’indipendenza dall’Unione
sovietica, la maggior parte degli abitanti è ucraina, circa il 60%; il 30% è russa, ma praticamente
tutti usano la lingua di Pushkin, il padre della letteratura russa che qui e nella vicina Crimea
soggiornò a lungo.
Se però il russo si sente dappertutto, dalla spiaggia di Langeron alla scalinata in centro resa
famosa dalla Corazzata Potemkin, il film simbolo della rivoluzione del 1905, ciò non vuol dire che
gli odessiti vogliano tornare sotto l’ombrello del Cremlino.
125
La Russia fa parte del passato, e inevitabilmente del presente, soprattutto per le vecchie
generazioni. I ragazzi sono ucraini e vogliono rimanere tali. Lo scontro non è insomma solo tra
Mosca e Kiev, ma all’interno delle famiglie, con i provocatori e gli estremisti che da una parte e
dall’altra hanno gioco facile. A Kulikovo Pole sono morti odessiti pro Mosca, per ora nelle indagini
ufficiali non c’è traccia di infiltrati dalla Russia o dalla vicina Transnistria e sembra così non
reggere la teoria di un complotto esterno. Di Odessa sono anche le vittime pro Europa di via
Deribasovskaya, uccise dalle pallottole degli assalitori. Premeditazione e reazione, così si spiega il
venerdì nero di una città che si è trovata di colpo in mezzo alla guerra civile. È infatti questa una
situazione completamente diversa da quella dell’Est del Paese, dove il confronto tra separatisti
armati e truppe governative è a tutti gli effetti militare.
Qui, rispetto a Donetsk o Lugansk, non ci sono palazzi del potere occupati e uffici governativi
assediati, le forze speciali non devono affrontare estremisti incappucciati che imbracciano
kalashnikov. La violenza e l’odio sono esplosi tra la gente: giovani politicizzati, ultrà, provocatori
di professione, studenti che giocano a fare la rivoluzione, anime ingenue o che sanno benissimo
quello che fanno. Quelle tra Derbasovskaya e Kulikovo Pole non sono state insomma scene come
a Maidan, dove da una parte le forze speciali e i cecchini hanno sparato sulla folla e dall’altra i
gruppi paramilitari come Pravi Sektor hanno organizzato la risposta armata. È questo un altro dei
problemi del governo di Kiev, ora e per il futuro prossimo: non avere il controllo delle frange più
estremiste della società pronte a mettere a ferro e fuoco una città in nome di ideali distorti. Eroi e
sempre presenti a Maidan, a Odessa premier e presidente sono stati i grandi assenti: Arseni
Yatseniuk è arrivato per un paio d’ore, Olexandr Turchynov non si è fatto nemmeno vedere.
Sono rotolate le teste dei capi della polizia e dei servizi segreti locali, come quella del governatore
regionale, sostituito da un oligarca arrivato da fuori, Igor Palitsa. Ma come hanno mostrato anche
le vicende degli oblast di Donetsk, Lugansk e Kharkiv, cambiando semplicemente i fattori il
prodotto non cambia: l’odio e la violenza non si combattono solo sostituendo qualche pezzo
grosso. Odessa è scivolata nel baratro, anche se solo per un giorno, e per risollevarla difficilmente
basterà un nuovo governatore. Come per l’Ucraina non sarà sufficiente un nuovo presidente.
126
Leopoli alla finestra
Lettera 43, 10 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Leopoli la sua parte l’ha già fatta. Ora sta guardare quello che succede a Est, incerta sul futuro di
un Paese scardinato e di cui sarà in ogni caso difficile rimettere insieme i pezzi. La roccaforte dei
nazionalisti nell’Ovest dell’Ucraina è stata simbolicamente, e non solo, in prima linea sulla Maidan
e nella cacciata di Victor Yanukovich. Da qui e dagli altri capoluoghi dell’occidente, da Ivano
Frankivsk a Ternopil, è arrivata la spinta a ingrossare la rivolta che se ha avuto come centro Kiev,
ha tratto la sua linfa dalla periferia ai confini con l’Unione europea. A Leopoli come altrove sono
stati occupati tra dicembre e febbraio i palazzi del potere, simbolo del regime corrotto del
vecchio presidente. Nessuna voglia di separatismo ma un’aria antirussa che, convogliata dai
nazionalisti di Svoboda e dai paramilitari di Pravi Sektor, ha spazzato Yanukovich dopo il bagno
di sangue nella capitale. In questi primi giorni di maggio non c’è traccia delle barricate e degli
incappucciati che lo scorso inverno hanno guidato l’insurrezione. Si festeggia l’anniversario della
fondazione della città e ci si gode il primo lungo ponte primaverile dell’anno.
Con Kiev i rapporti sono cambiati, presidente e governo non sono più nemici, i problemi li hanno
adesso altri. Se non fosse per qualche gazebo e i manifesti della campagna elettorale per le
elezioni presidenziali del 25 maggio le questioni politiche sarebbero lontane, per non parlare dei
venti di guerra. L’oligarca Petro Poroshenko, superfavorito, e la solita Yulia Tymoshenko, in
rincorsa, si giocano i favori di un elettorato comunque preoccupato per la stabilità del Paese.
Anche se qualche candidato di secondo piano calca il solco della russofobia (lo slogan di Oleg
Lyashko, leader del Partito radicale democratico ucraino è «Morte agli occupanti» e mezza
Leopoli ne è tappezzata), la sopravvivenza dell’Ucraina come stato unitario è legata alla
riconciliazione delle due parti del Paese, impossibile senza una mediazione di un presidente e di
un governo veramente legittimati. Ecco perché oltre al nuovo capo di Stato, ci vorrà presto un
nuovo gabinetto di solidarietà nazionale, dove siano rappresentate tutte le anime e soprattutto
tutti gli interessi dell’Ucraina. Al momento la squadra del premier Arseni Yatseniuk è sbilanciata
sul lato occidentale e sono rimasti fuori gli esponenti delle regioni orientali, difetto congenito sin
dalla sua nascita dal bagno di sangue di Maidan. Il presidente ad interim Olexandr Turchynov ha
cercato di mettere una pezza con la nomina di alcuni governatori, invano. Oltre ai rappresentanti
127
del partito di Yatseniuk e Tymoshenko sono presenti i ministri di Svoboda, il partito nazionalista
che comanda negli oblast dell’Ovest. Da Leopoli e dintorni sono partite ancora ai tempi di
Yanukovich le iniziative per mettere al bando il Partito delle regioni e quello comunista. A Kiev
non se ne è fatto nulla, ma nel Sud Est si guarda con sospetto a un governo che nell’emergenza ha
promesso molto e fatto ben poco. Da Donestk a Odessa si inveisce contro i fascisti dell’Ovest,
mettendo in un unico pentolone Yatseniuk, Svoboda e Pravi Sektor.
Inevitabile risultato della propaganda, sintesi pericolosa, contenente però più di un germe di
verità. Svoboda e Pravi Sektor si richiamano a Stepan Bandera, partigiano ucraino e collaboratore
nazista, ucciso nel 1959 dal Kgb: a Leopoli, dove una sua grande statua poco distante dal centro
storico lo ricorda come un eroe tralasciando le stragi di ebrei e polacchi, la concezione della
democrazia degli ultranazionalisti ha un carattere particolare. Dettagli su cui ha sorvolato anche
tutto l’occidente, quello europeo e transatlantico, aggiungendo frecce alla faretra del Cremlino.
Nel giorno dell’anniversario della vittoria sovietica sul nazismo nella seconda guerra mondiale,
Vladimir Putin non ha perso occasione di ricordare che «la Russia ha sempre vinto contro i
fascisti», riferimento al passato, ma messaggio trasversale anche all’Ucraina di Yatseniuk e
banderisti vari. Il referendum nell’Est, già definito dal governo ucraino una farsa e che i
separatisti hanno deciso improvvisamente di spalmare su due turni dopo l’invito di Putin per un
rinvio (si vota l’11 per il riconoscimento della Repubblica di Donetsk, il 18 per l’annessione alla
Russia) è un altro segnale per il resto del Paese che in ogni caso il nuovo potere centrale dovrà
fare i conti con le istanze degli oblast orientali. Il destino di Leopoli e dell’Ucraina si gioca nel
Donbass.
128
Rivoluzione permanente
Linkiesta, 11 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Sulla Piazza dell’indipendenza di Kiev ci sono ancora le tende dei manifestanti. Gruppi
paramilitari - Samoobrona (Autodifesa), Pravi Sektor (Settore di destra) e ultranazionalisti affini
presidiano il centro: davanti alla Rada (il parlamento ucraino) e al palazzo del governo.
Ufficialmente hanno deposto le armi, ma in questi giorni di inizio maggio, tra allarme
provocazioni per le festività e il referendum sull’autonomia programmato a Donetsk, qualcuno ce
le ha a portata di mano. Non si sa mai cosa può succedere, basta vedere il recente massacro di
Odessa, anche se lì sono stati i filorussi a morire tra le fiamme. Le sedi del potere centrale nella
capitale sono controllate all’esterno sia dalle forze regolari sia da quelle “del popolo”. Lo avevano
detto, dopo la cacciata di Victor Yanukovich alla fine di febbraio: rimarremo qui almeno sino alle
elezioni, fino a che la rivoluzione non sarà completata. E la rivolta con il tiranno si è trasformata
in uno strano film tra il drammatico e il giallo, condito con episodi di guerra.
Quasi sei mesi fa Kiev era immersa nella normalità, poi la rivolta europeista, nata alla fine di
novembre a Maidan dopo la svolta filorussa di Yanukovich, ha dato il via alla trasformazione: il
momento della protesta più o meno pacifica è durato sino a metà gennaio; le settimane degli
scontri con l’epilogo sanguinoso di febbraio hanno concluso la seconda fase con il cambio di
regime e l’arrivo del nuovo governo; da marzo è in corso il terzo tempo, tra il confronto con la
Russia e l’annessione della Crimea e l’insurrezione armata nel sudest. Difficile dire quando e
come si concluderà. Alla fine di maggio le elezioni presidenziali saranno un momento
fondamentale, sia per l’arrivo del nuovo presidente e il molto probabile rimpasto di governo, sia
per vedere come reagir{ “il popolo”, che ora occupa Maidan. I problemi dell’Ucraina nascono
naturalmente dalla questione con la Russia, dalle pressioni del Cremlino e da quelle che arrivano
dall’Occidente, con gli Stati Uniti a spingere il premier Arseni Yatseniuk per ragioni che vanno al
di là del solito brodo ideologico riscaldato, quello degli interessi geopolitici a condurre il valzer.
Ma sono anche e soprattutto problemi interni, di un paese che in pochi mesi è passato dall’apatia
alla rivoluzione permanente, lacerandosi e lasciando spazio agli estremismi, con il rischio di
perdersi definitivamente. Maidan Nezalezhnosti non è più una piazza europeista, è una piazza
129
antirussa ed esplosivamente, in parte, anti-ucraina: così è percepita in diverse regioni del paese,
sia in quell’est che è insorto con le armi, dove se gli estremisti filorussi sono teleguidati, buona
parte del resto della popolazione non ha condiviso l’arrivo di Yatseniuk e di un governo con la
partecipazione della destra ultranazionalista di Svoboda.
Non c’è bisogno di andare nel Donbass, basta arrivare a Odessa, per capire che Euromaidan non è
la piazza dei miracoli e delle speranze di tutti. Nella metropoli sul Mar nero è accaduto quello che
non si sbaglia a definire un episodio di guerra civile: il rogo della sede dei sindacati dove sono
morti una cinquantina di militanti filorussi è il simbolo di come l’odio politico si possa
trasformare in tragedia anche nella città più cosmopolita e tollerante del paese. Il Campo di
Kulikovo a Odessa è l’equivalente di Maidan a Kiev: due piazze dove ora si respira la morte e dove
rischia di essere seppellita la speranza di una riconciliazione. Soprattutto se saranno gli
estremisti ad avere la meglio in una situazione che l’attuale governo sembra proprio non avere
sotto controllo. Le tende in piazza sono state bruciate, il fuoco ha devastato l’edificio con i
filorussi imprigionati: adesso gli odessiti del lato antigovernativo accusano le forze dell’ordine
che non hanno fatto nulla e i fascisti di Kiev, in cui vengono compresi sia Yatseniuk che i
paramilitari di Pravi Sektor e camerati vari. Dall’altra parte c’è chi si difende parlando della lunga
mano del Cremlino che è arrivata sin qui per provocare e complottare. Odessa è una città divisa,
esattamente come tutto il Paese.
Per trovare unità di vedute, bisogna andare nei Carpazi e arrivare a Leopoli, quasi al confine con
la Polonia. All’inizio di gennaio i palazzi del potere erano occupati qui, nella roccaforte dei
nazionalisti che guidavano la rivolta contro Yanukovich. Oggi Svoboda, il partito della destra
radicale guidato dall’eroe di casa Oleg Tiahnybok, ha piazzato un pugno di ministri del governo,
controlla la procura generale con Oleg Machnitzky e ha ottimi rapporti con il Consiglio di
sicurezza nazionale, guidato da Andrei Parubi, che all’inizio degli anni novanta aveva fondato
proprio con Tiahnybok il Partito social-nazionalista ucraino.
A Leopoli e negli altri oblast occidentali, dopo la cacciata del vecchio presidente, si attende ora
quello che accadrà a est e a sud. La perla dei Carpazi non ha né Maidan né Kulikovo Pole, qui nella
Piazza del mercato che ricorda il passato asburgico. La gente fa la fila in questi giorni di festa per
entrare al Kriivka, il ristorante più famoso della città, dedicato ai partigiani nazionalisti che
combatterono nella seconda guerra mondiale contro l’Armata rossa. L’altra faccia della medaglia
130
è però che l’Upa, l’esercito insurrezionale ucraino, collaborò anche coi nazisti e fece stragi di ebrei
e polacchi in tutta la Galizia. Pezzi di storia finiti del dimenticatoio, in un paese che non ha
imparato a fare i conti con il passato e che anche proprio per questo si sta giocando il futuro.
La mediazione tedesca
Linkiesta, 13 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Tra poco più di dieci giorni (il 25 maggio) in Ucraina si vota per le presidenziali. Lo stesso fine
settimana (22-24 maggio) si svolge in Russia, a San Pietroburgo, il tradizionale Forum economico
internazionale. La connessione tra i due eventi non è diretta, ma è chiaro che ciò che succede
nell’ex repubblica sovietica a livello politico ha riflessi sull’economia non solo nei due principali
Paesi interessati dalla crisi, ma anche in Europa. E al di fuori. L’economia della Russia si è
contratta nel primo trimestre dello 0,5 per cento, la crescita alla fine dell’anno si aggirerà se va
bene su cifre decimali, le preoccupazioni sulle sanzioni hanno già danneggiato gli investimenti e
causato la fuga dei capitali, circa 60 miliardi di dollari nelle prima parte di quest’anno, più di tutto
il 2013, e il rublo è ai minimi storici. La crisi russa, se peggiorerà, non farà bene nemmeno
all’Europa.
I rapporti commerciali e finanziari tra Russia ed Ucraina sono molto stretti, così come quelli tra
Russia e Unione Europea e in particolare tra Mosca e Berlino. Se i Ceo americani boicotteranno
così su consiglio di Barack Obama il forum russo, i tedeschi non lo faranno. La Germania è un
partner strategico per la Russia, non solo per le questioni energetiche, e viceversa. Non è dunque
un caso che, come ha scritto il settimanale Der Spiegel, gli amministratori delegati delle maggiori
aziende tedesche, da Eon a Metro, da Basf a Daimler, andranno a San Pietroburgo in
pellegrinaggio per applaudire Vladimir Putin, il padrone di casa.
E non è certo una coincidenza che la Germania di Angela Merkel abbia assunto il ruolo di
mediatore nella crisi ucraina, tentando ogni via per raggiungere un compromesso sul tavolo delle
trattative tra Russia e Ucraina e ammorbidendo i falchi occidentali, soprattutto l’ala belligerante
131
dell’amministrazione a stelle e strisce, che tra sanzioni e interventismo ha spinto per una linea
intransigente nei confronti del Cremlino. Berlino sta insomma tra Mosca e Kiev-Washington, dove
quest’ultimo binomio si riferisce al governo temporaneo del premier Arseni Yatseniuk sostenuto
a spada tratta dalla Casa Bianca.
Se la Germania ha comunque appoggiato il nuovo esecutivo ucraino nato dopo la cacciata di
Victor Yanukovich, la posizione tedesca è sempre stata più conciliante nei confronti di Mosca
rispetto a quella degli Usa, sia per le questioni economiche, sia perché la fiducia verso il nuovo
establishment a Kiev e i suoi principali sostenitori non è certo incondizionata. Non è una sorpresa
che il Bnd, il servizio segreto tedesco, abbia confermato al Kanzleramt la presenza dei mercenari
dell’americana Academy (ex Blackwater) nel Donbass a fianco delle truppe ucraine, ma è un
segnale che la notizia vecchia di un mese sia stata confermata e fatta trapelare sui mass media in
un momento delicato come quello a ridosso dei referendum nel sudest e delle tavole rotonde di
riconciliazione nazionale in partenza.
La Germania, forte dei legami economici che vanta con la Russia,
sta cercando di condurre la partita negoziale. Conscia che difficilmente,
senza coinvolgere Mosca, arriverà una soluzione.
Per queste si sta spendendo non solo l’Osce (Organizzazione per la sicurezza e lo sviluppo in
Europa) a guida svizzera con Didier Burkhalter, ma proprio la Germania con il ministro degli
esteri Frank Walter Steinmeier. Quest’ultimo è alla ricerca della quadratura del cerchio e per un
successo è necessario che tutti giochino a carte scoperte. Basta insomma coi trucchi sporchi e le
accuse incrociate quando lo spazio prima del baratro è questione di centimetri. In ballo c’è
l’esistenza dell’Ucraina come stato unitario, anche se la Crimea è già persa, e il rischio è che, senza
un compromesso tra attori esterni (Mosca e Washington) e interni (separatisti, governo e
oligarchi), il paese si spacchi davvero. Negli ultimi giorni sono arrivati segnali contrastanti: da
una parte gli autonomisti hanno annunciato di voler richiedere l’annessione alla Russia e in
questa direzione va il secondo atto del referendum che dovrebbe andare in scena domenica
prossima, quando ai cittadini del Donbass verrà chiesto se dopo l’addio a Kiev vorranno ora
abbracciare Mosca. D’altra parte da Mosca sono arrivati nuovi suggerimenti agli insorti: in
132
sostanza, se Kiev interrompesse l’offensiva, anche referendum e armi finirebbero nel cassetto. Il
problema è che l’operazione militare lanciata dal governo sta andando avanti con nuovi scontri e
altre vittime e il piano dell’Osce che prevede il cessate il fuoco sembra già andare a rotoli.
Il capo della diplomazia tedesca Steinmeier ha avuto tra l’altro a Kiev un colloquio con Rinat
Akhmetov, l’oligarca più potente del Paese. Senza il suo aiuto sarà difficile ricondurre l’est alla
quiete. E a guidare l’ultimo tentativo sotto l’egida dell’Osce, prima di vedere se le elezioni
presidenziali segneranno il punto d’avvio per la riconciliazione o quello ultimo prima del
disastro, sarà Wolfgang Ischinger. Nemmeno questa volta è un caso che la scelta sia caduta su un
tedesco: Ischinger ha buoni contatti con gli Stati Uniti, dove è stato ambasciatore, ma è anche
stato membro della commissione bilaterale strategica tedesco-russa messa in piedi dall’allora
cancelliere Gerhard Schröder e Vladimir Putin. Se la polveriera ucraina sarà disinnescata sarà
anche per merito dell’attivismo tedesco. Se i piani di Berlino falliranno, ognuno dovrà prendersi
le proprie colpe.
La crisi corre nei tubi
Europa, 15 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Nei corridoi di Bruxelles s’è fatta strada l’idea di mettere i bastoni tra le ruote a Gazprom e di
annacquare il progetto South Stream. È il grande gasdotto, voluto da Mosca, che passando dal
fondale del Mar Nero, risalendo i Balcani e concludendo la corsa in Austria, porterà
prossimamente in Europa talmente tanto gas da rendere marginali le pipeline che attraversano
l’Ucraina, il cui ruolo di snodo energetico tra Mosca e lo spazio comunitario è già stato
depotenziato dall’altro gasdotto targato Gazprom. Si tratta di Nord Stream. S’inabissa nel Baltico
e sbuca in Germania. Gerhard Schröder ne presiede il consiglio di amministrazione.
La Commissione europea pensa che facendo leva sulle leggi sulla concorrenza possa non solo
limitare il volume di gas che transiterà dai tubi di South Stream, ma persino indurre Mosca a
congelare il progetto. È superfluo registrare che questa posizione si salda chiaramente alla crisi
133
ucraina e potrebbe assicurare, sulla carta, quello che le sanzioni leggere decise dal Consiglio
europeo finora non hanno garantito: spingere il Cremlino a non forzare troppo nell’ex repubblica
sovietica. Ma Putin, su South Stream, non intende minimamente cedere. È una priorità. La Russia
s’è mossa sul fronte legale, presentando ricorso presso l’Organizzazione mondiale per il
commercio, di cui è fresco membro. E soprattutto ha messo sul piatto una serie di nuovi, lucrosi
contratti finalizzati a dare un’accelerata a South Stream.
Una di queste intese è stata firmata con l’Austria, la cui Omv, società statale attiva nei comparti
del gas e del petrolio, s’è messa d’accordo con Gazprom per fare passare l’ultimo tratto di South
Stream in territorio austriaco. S’allaccerà ai depositi situati alle porte di Vienna. Cade dunque
l’opzione Tarvisio, quella pensata originariamente. Ma a quel che si dice l’Italia non ci rimetterà
molto, se è vero che le condotte che collegano Vienna al Tarvisio sono controllate dalla Cassa
depositi e prestiti. Senza contare che Gazprom ha appena incaricato Saipem per la posa dei tubi
sul Mar Nero (l’Eni è tra i soci del segmento offshore). Quelli terrestri sono invece manufatti,
principalmente, dei tedeschi di Europipe. Una delle tante cose che spiegano la cautela di Berlino
sulle sanzioni da comminare a Mosca a causa della sua politica in Ucraina. Cautela assecondata da
Roma e Vienna. Così come da Budapest e Sofia. I loro territori sono attraversati da South Stream e
tanto l’una quanto l’altra non hanno troppa voglia di riaprire una partita già chiusa.
Come se non bastasse, Mosca sta minacciando di tagliare i rifornimenti del gas all’Ucraina, che ha
molti debiti verso Gazprom. Se i rubinetti si chiudessero l’Europa si ritroverebbe a corto di
energia. In questo modo Putin vuole dimostrare che l’ex repubblica sovietica non è una cinghia di
trasmissione sicura e che South Stream è irrinunciabile. A questo punto c’è solo da capire se la
Commissione continuerà a stare sull’offensiva o se batterà in ritirata, rendendo vano il voto
espresso qualche settimana fa dall’europarlamento, secondo cui South Stream va bloccato.
134
Le leggerezze di Kiev
Lettera 43, 15 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Mancano esattamente dieci giorni alle presidenziali, ma non è ancora sicuro che le elezioni si
possano tenere in tutto il paese. Le regioni di Donetsk e Lugansk sono in mano ai separatisti,
difficile che qui si possa votare il 25 maggio. In altre, da Kharkiv a Odessa, il potere centrale ha
formalmente il controllo, ma basta una scintilla per ribaltare la situazione, con buona parte della
popolazione schierata contro Kiev. Il premier Arseni Yatseniuk e il presidente Olexadr
Turchynov, che guidano a braccetto il paese dalla fine di febbraio dopo la cacciata di Victor
Yanukovich, non sono riusciti in questi mesi a ricucire gli strappi tra centro e periferia. Senza
dubbio la condotta del nuovo establishment è stata condizionata da fattori esterni e dalla
pressioni della Russia, ma la strategia di governo e capo di Stato non ha aiutato certo la deescalation. Il risultato è che il malcontento tra la gente è cresciuto. E anche negli oblast dove la
rivolta armata non ha preso il sopravvento, la coppia Yatseniuk-Turchynov è stata guardata con
scetticismo sin dal suo arrivo. La tavola rotonda nazionale di mercoledì 14 maggio, avviata per
giungere a una rapida normalizzazione in vista del voto, non è servita a nulla. Troppo distanti le
posizioni degli attori in campo e senza i separatisti filorussi è mancato il necessario dialogo.
Si è trattato comunque solo del primo appuntamento, altri dovrebbero seguire a ritmo serrato,
già fra un paio di giorni, probabilmente a Donetsk, come ha suggerito Yulia Tymoshenko. Secondo
l’eroina della rivoluzione arancione, candidata alle presidenziali, la soluzione della crisi non può
essere raggiunta però senza l’aiuto della comunità internazionale. E anche per Sergei Tigipko,
uomo forte dell’Est che negli ultimi sondaggi è salito al secondo posto dietro all’oligarca Petro
Poroshenko e davanti a Tymoshenko, sarebbe necessario un vertice come quello già tenuto a
Ginevra con la partecipazione di Unione Europea, Stati Uniti e Russia. Ma il tempo stringe e il
governo di Kiev non sembra preoccuparsi troppo del piano dell’Osce, l’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa, che prevede il cessate il fuoco. La cosiddetta operazione
antiterrorismo è ripartita e i separatisti hanno dato un ultimatum alle truppe governative per
lasciare le regioni che domenica scorsa hanno proclamato l’indipendenza, minacciando a loro
volta di lanciare un’offensiva se la loro richiesta non verrà soddisfatta. Non solo dalla Russia, ma
anche dalla Germania, che ha assunto un ruolo guida nella mediazione della crisi, sono arrivate in
135
questi giorni voci critiche nei confronti di Turchynov e Yatseniuk, che non solo non hanno offerto
una piattaforma per il dialogo ai separatisti filorussi, ma non hanno voluto agganciare nel
tentativo di salvataggio del paese personaggi fondamentali come Rinat Akhmetov, l’oligarca con
grandi interessi nel Donbass che non ha partecipato alla prima tavola rotonda di Kiev.
I proclami e le promesse di decentramento e riforma della Costituzione, fatte da premier e
presidente sin dal loro insediamento, sono rimaste sulla carta. Il parlamento, rimasto quello dei
tempi di Yanukovich, ha lavorato a singhiozzo, bloccato tra le nuove e vecchie fazioni e senza che
i capi dell’esecutivo abbiano avuto sui deputati un vero potere per la realizzazione delle riforme.
Lo stallo è dovuto a molteplici ragioni, prima di tutto sul fatto che il governo Yatseniuk e la
presidenza Turchynov sono nati senza una solida legittimazione. L’accordo di fine febbraio tra
Yanukovich e opposizione, avallato dalla comunità internazionale, prevedeva la formazione di un
governo di solidarietà nazionale e riforme costituzionali in breve tempo. Diventato carta straccia
grazie all’intervento di Pravi Sektor che ha costretto l’ex presidente alla fuga, l’esecutivo è stato
formato nel vecchio parlamento trasformista senza tenere conto dei patti siglati in precedenza.
Non solo: dei tre partiti della vecchia opposizione, solo due (Patria di Yulia Tymoshenko e
Svoboda di Oleg Tiahnybok) si sono divisi i compiti, sbilanciando geograficamente a ovest e
politicamente a destra un governo che avrebbe dovuto tener conto delle istanze e delle
peculiarità delle regioni orientali.
Udar, il partito di Vitaly Klitschko, è rimasto per proprio volere fuori dai giochi, indebolendo il
nuovo blocco di potere. Le diatribe tra Pravi Sektor e il ministro dell’Interno Arsen Avakov
(fedelissimo di Tymoshenko) sono state una spina nel fianco che ha influito sulla credibilità del
governo. La girandola di poltrone, dai governatori regionali ai capi delle varie amministrazioni,
dai servizi segreti all’esercito (il ministro della Difesa si è dimesso a una settimana dalla nomina)
ha rispecchiato la mancanza di una visione generale per la riconciliazione nazionale, sostituita da
un sistema di spoil system confuso e inefficace.
La speranza del governo e del presidente ucraini che bastasse l’appoggio dell’Europa e
soprattutto degli Stati Uniti per far fronte a una crisi interna che ha radici molto profonde, e che
vanno oltre il bagno di sangue di febbraio a Maidan, si è rivelata subito un’illusione. La realtà è
che i problemi interni dell’Ucraina non possono essere risolti senza quel vero dialogo anche con i
136
moderati del sudest che Yatseniuk e Turchynov hanno sbandierato senza concretizzare: le accuse
di destabilizzazione a Mosca da parte di Kiev, pur contenendo verità, sono diventate l’alibi per
nascondere i propri errori e la disastrosa gestione della crisi attuata sino a ora.
La danza degli oligarchi
Limes, 20 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
La crisi ucraina ha costretto i due oligarchi che negli anni passati avevano più d’ogni altro
lubrificato la macchina del Partito delle regioni, la formazione dell’ex presidente Viktor
Yanukovich, a schierarsi con il blocco nazionalista che ha preso il potere a Kiev. Sia Rinat
Akhmetov che Dmitri Firtash, l’uomo in assoluto più ricco del paese e quello che in tempi recenti
s’è assicurato i maggiori profitti nel comparto dell’energia, hanno comunicato di appoggiare il
governo provvisorio presieduto da Arsenij Yatseniuk, esponente di Patria, il partito di Yulia
Tymoshenko. Ciò non ha peraltro evitato a Firtash l’arresto per corruzione, a Vienna, il 12 marzo,
su mandato dell’Fbi, subito dopo la fuga di Yanukovich in Russia. Il 21 marzo, grazie a una
cauzione da 125 milioni di euro, la più alta mai pagata in Austria, l’oligarca è uscito di cella,
promettendo di rimanere nel paese. Nel momento in cui scriviamo non è stata ancora presa
alcuna decisione sulla sua eventuale estradizione negli Stati Uniti.
Difficilmente i grandi oligarchi potevano fare altrimenti. I ladrocini di Yanukovich, puntualmente
dati in pasto al pubblico a regime change avvenuto, uniti al precipitare della situazione in Crimea
e al sostegno accordato da Mosca al fuggitivo ex capo di Stato - benché esclusivamente
strumentale alla delegittimazione di Yatseniuk e della sua squadra - li avrebbero messi in una
posizione indifendibile se non avessero preso con nettezza le distanze dal passato recente.
Questo non significa che Akhmetov e Firtash abbiano sposato acriticamente la linea del nuovo
governo, né che guardino con entusiasmo agli incentivi economici che Kiev, in cambio di riforme
strutturali, riceverà dall’Ue e dal Fondo monetario internazionale. La scelta di approvare il nuovo
corso è più che altro pragmatica. Akhmetov e Firtash hanno attività in ogni lembo del paese. Più
137
la Russia lacera l’Ucraina, più i rispettivi affari possono risentirne. La loro è una posizione ispirata
prima di tutto alla necessità di tutelare conti in banca e attività industriali. Non solo. Questa
posizione è diventata esplicita solo dopo che Yanukovich, con la sua fuga, ha aperto una crepa
sempre più grande: a livello di potere e lungo l’asse Est-Ovest del paese. Prima che il presidente
capitolasse, Akhmetov e Firtash erano stati guardinghi. Ne avevano criticato la gestione della crisi
politica, stando però attenti a rimanere a metà del guado, senza rompere con il potere e senza
aprire ai nazionalisti. La soluzione ideale, dal loro punto di vista, sarebbe stata il compromesso
tra le due fazioni.
Molti altri oligarchi, a prescindere dall’orientamento politico, si sono mossi lungo lo stesso solco,
auspicando fintanto che è stato possibile il negoziato tra i contendenti. Uno di questi è Viktor
Pinchuk, genero dell’ex presidente Leonid Kuchma; durante i mandati di Kuchma la sua
compagnia, Interpipe, che realizza tubi per gasdotti e oleodotti, ha espanso notevolmente il
fatturato. Dopo la rivoluzione arancione del 2004-5 Pinchuk s’è defilato dalla scena politica (era
stato diversi anni in parlamento), dandosi alla filantropia ed esibendosi come uno dei principali
tifosi dell’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, quanto meno in termini di assorbimento di
regole e valori. Anche Petro Poroshenko, magnate dell’industria dolciaria, vicino a Viktor
Yushchenko all’epoca della rivoluzione arancione, favorevole all’integrazione europea ma capace
di indossare l’abito da ministro anche con Yanukovich (Commercio e sviluppo), dopo l’esperienza
agli Esteri nel governo Tymoshenko, ha invocato la trattativa. Qualche osservatore, proprio in
virtù di questo muoversi tra le linee e del fatto che a suo tempo fu tra i promotori della nascita
del Partito delle regioni, aveva visto in lui doti da capo di una coalizione traghettatrice. In
compenso potrà fare il capo dello Stato. Poroshenko è quello, tra i candidati alle presidenziali del
25 maggio, che ha più possibilità. I sondaggi gli mettono il vento in poppa. A Firtash l’idea che
Poroshenko si insedi alla Bankova in fin dei conti non dispiace. Il re delle praline potrebbe
garantire la pax oligarchica.
Igor Kolomoisky è l’oligarca che più s’è legato al nuovo potere. Di origini ebraiche, come Pinchuk,
è tra i soci del potente conglomerato Privat, che controlla tra l’altro Privat Bank, principale
istituto di credito del paese. Gli sono vicini sia il ministro dell’Energia Jurij Prodan che quello
delle Finanze Oleksandr Shlapak. Lo stesso Kolomoisky è sceso direttamente in campo.
L’esecutivo l’ha nominato governatore della regione di Dnepropetrovsk, la città più
138
industrialmente avanzata del paese. Kolomojs’kyj, finora, non aveva mai ricoperto cariche
politiche, ma aveva sempre mostrato una certa simpatia, anche staccando assegni, verso il campo
di Tymoshenko. È considerato uno dei membri di quello che fu il gruppo di Dnepropetrovsk, la
lobby che dominò la scena oligarchica e politica a metà degli anni Novanta. Da questa città
vengono anche Pinchuk, Tymoshenko, Kuchma e l’ex primo ministro Pavlo Lazarenko. Si
potrebbe immaginare che il peso di Kolomoisky nel governo e la carica che ha assunto a
Dnepropetrovsk riflettano l’esigenza, da parte di Yatseniuk, di mobilitare in prima persona gli
oligarchi, con il loro potere economico e la loro capacità di fare consenso. La stessa logica ha
portato a nominare un altro pezzo grosso del gotha finanziario, Sergei Taruta, a governatore della
regione di Donetsk, in parte in mano a ribelli filorussi eterodiretti da Mosca. Anche Taruta,
numero uno dell’Unione industriale del Donbass, attiva nel settore dei metalli, ha elargito a suo
tempo consenso e denaro all’area arancione, dopo che insieme ad Akhmetov aveva dato vita al
gruppo di Donetsk, scegliendo Yanukovich come burattino. I rapporti tra i due magnati si sono
incrinati a causa di alcune vertenze industriali, che hanno visto Akhmetov prevalere.
Ci si può chiedere se tutte queste manovre non siano la spia di un ritorno pomposo sulla scena
dei potenti di Dnepropetrovsk e se a Donetsk non sia in corso una rimodulazione dei rapporti di
forza, tale da diluire lo strapotere di Akhmetov. Che però, almeno in pubblico, ha apprezzato
l’investitura di Taruta. L’unica certezza al momento è che gli oligarchi sono saliti tutti sulla stessa
barca, con la stessa idea: proteggere i loro asset. D’altra parte questa è la loro missione storica.
Malgrado i periodici scontri economici, politici e giudiziari (nel 2013 Pinchuk ha fatto causa a
Kolomoisky), le oligarchie hanno sempre cercato di blindare lo status quo. Come? Frenando le
riforme, impedendo la nascita di una classe media, bandendo concetti chiave del libero mercato
come competitività, concorrenza e innovazione. Tutto perché ci si deve spartire la torta,
limitando gli inviti al banchetto. Questa strategia si rispecchia nei numeri. L’economia ucraina è
guardata a vista dagli oligarchi. Incrociando qualche dato, il Council on Foreign Relations ha
recentemente dimostrato che le cinquanta persone più facoltose del paese detengono una quota
di pil pari a 67,7 miliardi di dollari, quasi la metà del totale. In Russia la percentuale di pil in
mano agli oligarchi si ferma al 15%.
Dall’indipendenza del 1991 gli oligarchi hanno accumulato asset e boicottato le riforme, mentre i
cittadini si sono andati impoverendo. Ciò balza agli occhi se si comparano i redditi individuali
139
degli ucraini con quelli dei vicini. Dal database della Banca mondiale emerge come nel 1991, al
momento dell’indipendenza, il Pil pro capite ucraino fosse pari a 1.490 dollari. Nel 2012 s’è
attestato sui 3.867. Nello stesso periodo, in Polonia si è passati da 2.187 a 12.708 dollari, in
Russia da 3.427 a 14.037. La discrepanza tra punti di partenza simili e approdi così divergenti
dipende proprio dal fatto che mentre a Kiev non s’è mai fatta una riforma, a Varsavia e a Mosca,
pur con gradazioni diverse, c’è stata una terapia d’urto e un adeguamento alle regole del mercato
globale. La genesi dell’oligarchia ucraina è analoga a quella dei potentati economici russi. Sono
stati i processi di privatizzazione a favorire l’ascesa dei tycoons. Molti di costoro stoccarono
capitali al tempo delle riforme di Gorbaciov, sfruttando gli agganci nel partito e il fiuto per gli
affari. Con questa base finanziaria poterono rilevare i grandi conglomerati di Stato. Si scatenò, a
Kiev come a Mosca, una grande battaglia per il potere economico, segnata da tendenze predatorie
e non immune da collusioni di alto livello tra politica, finanza e mafie.
Gli anni Novanta furono la fase più selvaggia di questa congiuntura, che ebbe delle code anche nel
decennio successivo, a testimonianza del fatto che l’economia ucraina non s’è ancora liberata
dalla presenza ingombrante della criminalità. Lo dimostra l’ascesa di Dmitri Firtash. Fattosi da
solo nel settore alimentare, egli ha spiccato il volo all’inizio del decennio scorso avventurandosi
nel grande affare del gas. Per sua stessa ammissione ha dovuto cercare il consenso di Semion
Mogilevich, uno dei grandi padrini della mafia russa, ucraino di nascita, ebreo di origini. Scrive
Sławomir Matuszak - autore di The Oligarch Democracy: The Influence of Business Groups on
Ukrainian Politics, una ricerca molto preziosa e articolata - che Leonid Kuchma è stato un po’ lo
Eltsin di Kiev. Nel senso che durante i suoi due mandati (1994-2004) ha fatto da arbitro nelle
dispute tra i vari gruppi oligarchici, impedendo che uno prendesse il totale sopravvento sull’altro,
ma anche permettendo che gli stessi oligarchi assumessero sempre più potere economico,
mediatico e politico. L’era Kuchma è stata segnata da una relazione competitiva e cooperativa,
una sorta di consociativismo, molto corrotto, tra famiglie di oligarchi. Quella di Kiev, forte nel
settore finanziario, ma poco presente nel manifatturiero, ebbe come proiezione politica il Partito
socialdemocratico. Una formazione che non andò mai oltre il 10%, ma fornì sempre sostegno al
presidente, sintonizzandosi su frequenze filorusse. L’uomo di punta del gruppo di Kiev fu Viktor
Medvedchuk, che guidò il Partito socialdemocratico e l’amministrazione presidenziale a partire
dal 2002. Attualmente è coordinatore di Scelta ucraina, partito schiacciato su posizioni
sfacciatamente pro-Cremlino. Ininfluente, tuttavia, a livello elettorale.
140
Il gruppo di Dnepropetrovsk ebbe il suo momento di massimo potere quando Pavlo Lazarenko,
già governatore dell’omonima regione dal 1992 al 1995, assunse la guida del governo nel 1996.
Sotto la sua regia fu istituita la United Energy Systems of Ukraine, compagnia monopolista delle
importazioni di gas dalla Russia. Al vertice andò Yulia Tymoshenko. Scelta naturale. La Eisu fu
infatti la riorganizzazione in senso nazionale di una società, fondata da Tymoshenko all’inizio
degli anni Novanta, che riforniva di energia il sistema industriale e agricolo di Dnepropetrovsk.
La stessa Tymoshenko, che in quell’epoca si guadagnò il soprannome di «principessa del gas»,
divenne il braccio destro di Lazarenko. In breve tempo l’azienda prosperò incredibilmente,
facendo acquisizioni anche nella metallurgia e nella finanza. Divenne talmente potente da aprire
un conflitto molto intenso tra oligarchi. Evgen Scherban, uno dei più accaniti oppositori di
Lazarenko, fu assassinato nel 1996. A più riprese, in merito a quella vicenda, la magistratura di
Kiev ha aperto inchieste sia su Lazarenko sia su Tymoshenko, senza conseguenze penali.
L’ascesa prepotente del gruppo di Deipropetrovsk, tale da destabilizzare gli equilibri
intraoligarchici, indusse Kuchma a sbarazzarsi di Lazarenko. Il quale perse la poltrona da primo
ministro, subì l’accusa di corruzione e riciclaggio, fuggì in America. Lì è stato condannato a 9 anni,
nel 2006. La sua caduta determinò la fine di Hromada, il partito che serviva gli interessi del
gruppo di Dnepropetrovsk. Fu allora che Tymoshenko promosse la nascita di Batkivshchyna. La
terza costellazione oligarchica strutturatasi durante l’era Kuchma fu quella di Donetsk, di cui
Rinat Akhmetov divenne primus inter pares. Viktor Yanukovich fu scelto come rappresentante
politico del gruppo e nel 1997 catapultato al vertice dell’amministrazione regionale di Donetsk,
benché non avesse mai avuto cariche politiche. Nel 2002 fu chiamato a presiedere il governo
nazionale da Kuchma, che nell’ultimo scorcio della sua seconda presidenza si legò sempre di più
alla cricca di Donetsk. L’anno prima questa lobby aveva promosso la nascita del Partito delle
regioni, operazione di fusione a freddo tra una manciata di piccoli partiti, volta a creare una
fazione parlamentare che potesse servire al meglio gli interessi di Akhmetov e degli altri oligarchi
della regione.
Con la fine dell’era Kuchma, i blocchi oligarchici regionali si sono parzialmente scomposti, a
eccezione di quello di Donetsk, che ha invece rafforzato l’identità regionale e la sovrapposizione
con il Partito delle regioni. A livello politico, invece, s’è fatta più netta la distinzione tra gli assi
Nord-Ovest e Nord-Est del paese, l’uno interprete del nazionalismo ucraino, l’altro del rapporto
141
solido con la Russia. La rivoluzione arancione lo ha certificato. Nel frattempo, con il cambiamento
dettato da Putin a Mosca e con il ribaltamento del rapporto tra il potere centrale e le oligarchie,
l’Ucraina è rimasta un caso sui generis: non c’è verticale del potere e sono i grandi interessi
economici a tenere sotto scacco la politica.
La rivoluzione arancione, potenzialmente, avrebbe potuto rimescolare le carte, configurandosi
come una «rivolta dei milionari contro i miliardari». Yushchenko e Tymoshenko proposero
alcune riforme che avrebbero aggredito i grandi monopoli, favorendo la redistribuzione degli
asset e la nascita di una borghesia imprenditoriale. Ma i propositi sfumarono. La nettezza con cui
Tymoshenko cercò di portare avanti misure radicali come la revoca dei processi di
privatizzazione di oltre trecento società spinse gli oligarchi a fare muro. Yushchenko, propenso al
compromesso con i grandi poteri economici, decise di silurare Tymoshenko nel settembre del
2005, pochi mesi dopo che era stata nominata primo ministro. Si andò al voto anticipato, che
sancì l’affermazione di Yanukovich, elevato alla carica di capo del governo. La sua coalizione durò
poco e si tornò nuovamente alle urne, con Tymoshenko che riprese le redini del paese,
mantenendole fino al 2010.
In quest’arco di tempo gli oligarchi hanno lavorato affinché lo spirito riformista restasse una
mera espressione concettuale, appoggiando l’uno o l’altro campo, a volte persino entrambi, come
nel caso di Dmitri Firtash, che ha continuato a versare soldi nelle casse del Partito delle regioni
ma ha anche sviluppato buone relazioni con Yushchenko. L’obiettivo era coprirsi il fianco con
Tymoshenko, che s’era posta l’obiettivo di smantellare RosUkrEnergo, l’opaca holding russoucraina con cui Firtash s’è arricchito smisuratamente, facendo da mediatore nell’acquisto di gas
russo da parte dello Stato ucraino. Nel 2009 Tymoshenko riuscirà a raggiungere l’obiettivo,
ponendo fine all’intermediazione di RosUkrEnergo e ripristinando la compravendita diretta tra
Gazprom e Naftohaz, le compagnie statali del gas dell’uno e dell’altro paese. Ciò le è costato
molto, visto che è stato quell’accordo, ritenuto troppo salato per i conti di Kiev, a portare la
magistratura ucraina a istruire un processo a suo carico, dal sapore molto politico, culminato nel
2011 in una condanna a 7 anni.
L’avvento al potere dei nazionalisti, lo scorso febbraio, ha portato alla scarcerazione della
«pasionaria di Kiev». Firtash intanto aveva accumulato notevoli capitali e investito a destra e a
manca, al punto che la fine di RosUkrEnergo non ne aveva scombussolato più di tanto gli affari. La
142
vittoria di Yanukovich alle presidenziali del 2010 ha mutato gli equilibri fra oligarchi nel Partito
delle regioni. Yanukovich ha tentato di smarcarsi da Akhmetov, dando a Firtash, che non fa parte
del nucleo storico di Donetsk, molto potere e una discreta pattuglia di deputati. Al tempo stesso
ha radunato intorno a sé un gruppo di lealisti, assegnando loro cariche e dividendi.
Gli analisti hanno bollato il cerchio magico di Yanukovich, un’oligarchia in divenire, con una sola,
eloquente parola: «Famiglia». Anche perché il coordinatore di tutte le incursioni predatorie del
gruppo è stato uno dei figli dell’ex presidente, Oleksandr. Gli inquirenti ucraini stanno ora
passando al setaccio i suoi conti e quelli dei suoi cortigiani. In Europa si fa lo stesso. Il prossimo
capitolo della storia della democrazia oligarchica è tutto da scrivere. Akhmetov, Firtash (almeno
fino all’arresto), Poroshenko, Taruta, Kolomoisky, Pinchuk e gli altri si ritrovano sintonizzati sulla
stessa frequenza. È possibile che, quando si tornerà a votare, qualcuno di loro foraggerà il Partito
delle regioni, che ha imboccato la strada della ricostruzione: nell’organico e nell’immagine. Ma la
vera partita si giocherà sulle riforme. Stavolta sarà difficile contrastarle. L’esito delle rivoluzione
ha portato l’Ue a sostenere il governo Yatseniuk. Bruxelles ha annunciato di voler stanziare 11
miliardi di euro a favore di Kiev, allo scopo di stabilizzarne il quadro economico, totalmente
devastato. È lo stesso importo che Putin aveva concesso a dicembre a Yanukovich, nel tentativo di
dargli ossigeno a livello finanziario e benzina sul piano politico. Quell’intesa non esiste più. La
differenza tra l’aiuto europeo e quello russo è che il primo, in confronto al secondo, è vincolato ad
alcune riforme strutturali. Ma è ancora niente, rispetto alla ricetta che l’Fmi prescriverà in cambio
dell’iniezione di denaro aggiuntiva di cui l’Ucraina abbisogna.
La cifra stanziata dall’organismo retto da Christine Lagarde è pari a quella che verserà l’Ue,
grosso modo. Insomma, stavolta la strada delle riforme sembra rettilinea. C’è da capire come si
muoveranno gli oligarchi. Cercheranno di condizionare Yatseniuk, così da negoziare una terapia
d’urto che non sia così dura (tra l’altro si dice che gli oligarchi finanzino i ribelli filorussi)?
Oppure si adegueranno alle nuove regole del gioco, ristrutturando le loro attività in funzione del
mercato europeo e rinunciando a esportare massicciamente i loro prodotti verso quelli russi e
post-sovietici, capaci di assorbirne volumi maggiori? Nel frattempo è interessante registrare che i
baroni dell’economia potrebbero presentarsi a questo banco di prova con posizioni rafforzate. La
crisi economica globale ha martellato senza pietà l’Ucraina, portando diversi investitori stranieri
a fare le valigie, o a pensare di farlo. È il caso del comparto del credito, dove il capitale ucraino ha
143
già una quota rilevante (70%). Unicredit e Raiffeisen intendono liberarsi delle loro controllate
ucraine, Ukrsotsbank e Aval. Intesa San Paolo ha già ceduto Pravex. La pagò 500 milioni di dollari,
l’ha venduta a meno di 100. Se l’è aggiudicata Dmitri Firtash. Come lui, altri oligarchi attendono il
momento migliore per fare shopping, non solo nel bancario.
Il gattopardo di Kiev
Il Manifesto, 23 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Dmitri Firtash non è il più ricco tra gli oligarchi ucraini, ma in s’è ritagliato grandi margini di
manovra. La sua è una presenza costante, nella gestione degli equilibri politico-economici a Kiev.
Seguirne le mosse aiuta a capire le dinamiche in corso nell’ex repubblica sovietica. Nella crisi che
sta incrinando la fragile stabilità del paese il suo nome non ha tardato a balzare in testa alle
cronache. Firtash ha sempre perorato la causa dell’unità nazionale. In linea con tutti gli altri suoi
pari. Agli oligarchi fa comodo un’Ucraina equidistante dall’Europa e dalla Russia o integrata nello
spazio europeo e capace di fare buoni affari con il vicino orientale. Il concetto è stato espresso
ancora una volta nelle ultime ore, con un intervento sul Kyiv Post. Il magnate s’è augurato che
l’Ucraina possa diventare «la Svizzera dell’Eurasia». Firtash da due mesi è a Vienna, arrestato
dalla polizia austriaca il 12 marzo dopo mandato di cattura emesso dalle autorità americane. Da
tempo sospettato di legami con la mafia russa, ha ammesso che il suo ingresso nel settore del gas
avvenne anche grazie alla sponda di personaggi poco raccomandabili. Uno di questi sarebbe
Mogilevich, potente capomafia russo-ucraino, di origini ebraiche. Il mandato di cattura non arriva
però a coprire le vicende legate all’ascesa di Firtash, ma si concentra su un investimento sospetto
in India nel 2006.
In questo gli analisti hanno visto un avvertimento, sostenendo che Washington, facendogli
sentire il fiato sul collo ma senza esagerare, ha voluto spaventare Firtash e indurlo a usare le sue
leve in funzione dell’unità dell’Ucraina, nella consapevolezza che a Kiev i giochi si fanno anche
con i tycoon. Una settimana dopo l’arresto di Firtash, Klitschko ha deciso di non correre alle
144
presidenziali e «regalare» a Poroshenko i suoi voti (e non sono pochi). C’è chi ha visto lo zampino
di Firtash. Primo sospetto: l’oligarca ha investito su Klitschko quando ha compreso la fine di
Yanukovich, che aveva foraggiato. Secondo: Poroshenko, che dovrebbe stravincere, è un oligarca
che punta a cambiare le cose senza strappi e questo va bene a Firtash, a tutti gli altri oligarchi,
agli euro-americani e forse non dispiace neanche a Mosca, benché abbia preso di mira i suoi
prodotti dolciari con embarghi. Se i sospetti non bastassero, Klitschko e Poroshenko sono andati
a fare visita a Firtash a Vienna. Se la fine di questa storia rischia di lasciarlo al centro della scena,
l’inizio dice che Firtash ha mosso i primi passi nel settore alimentare. Ambizioso, ha frequentato
i circoli che contano e s’è aperto un varco nel settore dell’energia. Fuori dall’Ucraina è stato
a lungo sconosciuto, finché nel 2009, quando Mosca chiuse i rubinetti a Kiev, aprendo un’altra
«guerra del gas», saltò fuori che a mediare le compravendite di oro blu tra i due paesi era una
misteriosa holding, RosUkrEnergo. Il 50% delle quote era di Gazprom, l’altro di soci ucraini, con
Firtash al 45%. Tymoshenko si mise in testa di smantellare a tutti i costi RosUkrEnergo. Firtash
ha reagito con intrighi di corte. Ha sviluppato relazioni cordiali con l’ex presidente Yushchenko
e ha dato tanti soldi a Yanukovich. Quando quest’ultimo ha vinto presidenziali e politiche nel
2010 lo ha ricompensato con una bella pattuglia di parlamentari e tanti favori. Prima, comunque,
Tymoshenko era riuscita a chiudere RosUkrEnergo. Ma Firtash, prevedendo da tempo la fine
della pacchia, aveva diversificato le sue attività. Ora spera di fare lo stesso in politica. Investire su
altri, sperando gattopardescamente che nulla più di tanto cambi.
La Bankova di Poroshenko
Linkiesta, 23 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Alla vigilia delle elezioni del 25 maggio la tensione ha ripreso a crescere in Ucraina. Scontri e
morti nel sudest, con il Donbass sempre sottoposto a spinte centrifughe, e toni accesi tra governo
e opposizione. Le tre tavole rotonde di riconciliazione organizzate sotto l’egida dell’Osce
(l’Organizzazione per la sicurezze e lo sviluppo in Europa) sono naufragate nel nulla, come era
successo a quelle organizzate a dicembre dal presidente Victor Yanukovich che pensava ancora di
145
poter controllare la protesta di Maidan con slogan di benevolenza. Allora come oggi il capo di
Stato ad interim Olexandr Turchynov e il premier Arseni Yatseniuk hanno adottato la strategia
dell’illusione, convinti che i disastri dell’Ucraina siano solo colpa della Russia. La verità è che la
spaccatura tra il nuovo blocco di potere e l’opposizione è profonda, anche senza i separatisti
seduti al tavolo delle trattative. Tanto profonda quanto la lacerazione tra gli oblast
indipendentisti a Est e Kiev, frattura che il fallimento delle prove di riconciliazione non ha fatto
altro che confermare.
Il voto di domenica rappresenta dunque uno spartiacque, arrivando come punto finale del
periodo rivoluzionario iniziato nel novembre del 2013 e ponendosi come punto iniziale per la
ricostruzione di un paese che dopo l’annessione delle Crimea da parte della Russia rischia di
perdere ulteriori pezzi ed è sempre sull’orlo del tracollo politico ed economico interno.
Superfavorito per l’ingresso al palazzo presidenziale in via Bankova a Kiev è l’oligarca Petro
Poroshenko, detto il “re del cioccolato” per avere creato la sua fortuna all’inizio degli anni
Novanta commerciando in cacao. Ora il suo impero va oltre cioccolatini e biscotti e raggruppa
attività nei più disparati settori, dai media agli armamenti, dai trasporti all’agricoltura. Visti i
sondaggi non ci sarà probabilmente nemmeno bisogno del ballottaggio, eventualmente previsto
per il 15 giugno, per stabilire chi sarà il quinto capo di Stato nell’Ucraina indipendente. Sarà la
prima volta di un oligarca al comando, dopo le presidenze politiche dei due Leondid, Kravchuk e
Kuchma, e dei due Victor, Yushchenko e Yanukovich.
Le poche speranze di arrivare al secondo turno le hanno Yulia Tymoshenko e Sergei Tigipko.
L’eroina della rivoluzione arancione, uscita di galera solo a fine febbraio dopo la cacciata di
Yanukovich, è tornata in corsa, ma la ruggine accumulata a Kharkiv ha pesato notevolmente in
campagna elettorale. L’ex principessa del gas è vista ormai come un ferro vecchio da buona parte
dell’elettorato, che sembra preferire di gran lunga Poroshenko benché anche quest’ultimo non sia
proprio un homo novus sul palcoscenico della politica ucraina. Ma su Tymoshenko pesa il
fallimento della rivoluzione arancione e poco importa che sia stata vittima della giustizia selettiva
di Yanukovich. Secondo gli ultimi sondaggi rischia addirittura di finire dietro Tigipko, candidato
moderato indipendente che tenta di coagulare l’elettorato del sudest tradito dall’attuale coppia al
potere, costituita da Yatseniuk e Turchynov. Tra la ventina di candidati in lizza per la presidenza,
l’unica donna accanto a Tymoshenko è Olga Bogomolets, cantante e medico diventata popolare
146
durante la protesta di Euromaidan. Poche briciole raccoglieranno i rappresentanti della destra
radicale, dal leader di Svoboda Oleg Tiahnybok a quello di Pravi Sektor Dmitri Yarosh. Altri
estremisti come Oleg Lyashko, che ha spedito un proprio battaglione a combattere nel Donbass, e
Anatoly Grizenko, ex ministro della difesa che aveva chiamato alle armi i manifestanti di piazza
indipendenza poco prima del bagno di sangue, catalizzeranno il voto antirusso e di protesta,
mentre fuori dai giochi si è chiamato Petro Symonenko, capo del Partito comunista, che ha
ritirato la candidatura a pochi giorni dal voto. Il Partito delle regioni, la formazione dell’ex
presidente Yanukovich, si presenta con Mikhail Dobkin, ex governatore di Kharkiv, ma anche per
lui si tratta solo di una partecipazione simbolica.
Tutto sta a indicare insomma che per Petro Poroshenko sarà tutto facile. Il difficile comincerà
subito dopo il suo ingresso alla Bankova. I poteri del presidente, dopo il ritorno alla costituzione
del 2004, sono stati ridimensionati e il capo di Stato reggerà il paese in coabitazione con il primo
ministro. Anche se Poroshenko e Yatseniuk sono stati dalla stessa parte delle barricate contro
Yanukovich, altra cosa sarà governare insieme. L’attuale premier è alla guida di un gabinetto in
cui solo due dei partiti della maggioranza sono rappresentati, Patria (Yatseniuk-Tymoshenko) e
Svoboda (Tiahnybok). Udar di Vitaly Klitscho è rimasto per volontà propria sin dall’inizio fuori
dai giochi. L’ex pugile si avvia però a conquistare la poltrona di sindaco di Kiev - domenica si vota
anche per il borgomastro della capitale - e il suo supporto a livello nazionale per Poroshenko si
trasformerà in caso di vittoria anche in un probabile ingresso nel nuovo governo. Dal
rimescolamento di carte dovrà uscire il nuovo assetto di potere che avrà il difficile compito di
tenere insieme il paese.
147
Strada in salita
Linkiesta, 25 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Tutto come previsto. I sondaggi della vigilia non hanno fallito e Petro Poroshenko ha vinto al
primo turno le elezioni presidenziali. Sarà dunque lui, il re del cioccolato, il Willy Wonka in
versione ucraina, ad entrare nel palazzo presidenziale in via Bankova a Kiev. Il successo, come
hanno fatto capire gli exit poll che lo hanno dato subito oltre il 55%, è stato chiaro e
inequivocabile. Nessun presidente nella breve storia dell’Ucraina indipendente è mai stato eletto
al primo turno. Né negli anni novanta Leonid Kravchuk e Leonid Kuchma, né nello scorso
decennio Victor Yushchenko e Victor Yanukovich. Gli ucraini, in questo difficile momento di
transizione, con le regioni orientali sconquassate dai moti separatisti e l’economia dell’interno
Paese allo sbando, hanno dato fiducia all’oligarca moderato, che in campagna elettorale ha
promesso di rimettere in sesto la nazione, combattere la piaga della corruzione e ricucire gli
strappi con la Russia.
Un trionfo al quale si è dovuta inchinare Yulia Tymoshenko, le cui possibilità di arrivare al
ballottaggio erano minime, ma che non ha mai abbandonato la speranza di un miracolo. Gli
elettori non le hanno però concesso molto credito: poco più del 12% secondo le proiezioni, a
grande distanza da Poroshenko. Una sconfitta annunciata e che con grande probabilità l’eroina
della rivoluzione arancione cercherà di recuperare al più presto, tentando magari di entrare al
governo facendo le scarpe proprio al collega di partito Arseni Yatseniuk, la cui posizione di
premier nelle ultime settimane si è indebolita.
I giochi di potere partiranno quindi a Kiev molto presto. Il voto ha comunque mostrato, alle spalle
dei due maggiori contendenti che rappresentano in sostanza il nuovo-vecchio establishment al
potere oggi nell’ex repubblica sovietica, un panorama diversificato. Poco successo hanno avuto i
candidati legati alle regioni meridionali e orientali, forse anche condizionati dalla minore
partecipazione negli oblast in questione. Poco più del 2% ha raccolto Mikhail Dobkin, ex
governatore di Kharkiv ed erede di Yanukovich nel Partito delle regioni. La formazione dell’ex
presidente è ormai sfilacciata e senza l’appoggio del suo principale sponsor di un tempo, il padre
padrone del Donbass Rinat Akhmetov, sembra avviata all’inesorabile dissoluzione. Anche Sergei
148
Tigipko, ex governatore della Banca centrale e alfiere degli elettori moderati del sudest, ha deluso
le aspettative, sorpassando di poco il 4%.
Allo stesso modo, sull’altro versante, politico e geografico, sono naufragati gli uomini della destra
radicale forti a occidente, da Oleg Tiahnybok, leader dei nazionalisti di Svoboda che è al governo
con Yatseniuk, a Dimitri Yarosh, capo del gruppo paramilitare Pravi Sektor, a cui l’aver smesso la
mimetica e indossato il doppiopetto non ha portato molta fortuna. Poche briciole, tra l’1 e il 1,5%,
hanno coagulato le ali estreme, segnale chiaro che gli ucraini non credono ai nuovi Führer. Meglio
di loro, sul 2%, hanno fatto la cantante e coordinatrice dei medici a Maidan Olga Bogomolets e
Vadim Rabinovic, magnate con passaporto israeliano dal passato poco pulito che si era buttato in
corsa per fare dell’Ucraina la Svizzera dell’est.
Poroshenko, come da copione, stravince le presidenziali.
Ma ora viene il difficile: ricostruire il paese.
La protesta antirussa si è incanalata invece su altri candidati, da Anatoly Grizenko (6%), ex
ministro della Difesa che aveva chiamato alle armi i cittadini poco prima del bagno di sangue di
febbraio a Maidan, e soprattutto Oleg Lyashko (8%). Il numero uno del Partito radicale, popolare
soprattutto nelle regioni occidentali, si è piazzato al terzo posto dietro Poroshenko e
Tymoshenko, grazie ad una campagna aggressiva con lo slogan di “morte agli occupanti”, al quale
sono seguiti i fatti. Alla faccia degli accordi di Ginevra del 17 aprile che chiedevano il disarmo dei
gruppi armati su entrambi i fronti, Lyashko ha dato il nome a un proprio battaglione di mercenari
che la scorsa settimana ha rivendicato tra l’altro l’esecuzione di un comandante filorusso.
Archiviato il voto, in attesa dei risultati definitivi che arriveranno con la consueta calma ucraina,
senza contare le difficoltà registrate nelle regioni orientali, i problemi per Petro Poroshenko
cominciano adesso. Ha annunciato che i primi passi da presidente li farà nel Donbass separatista,
per cercare di mettere fine a una crisi che dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia
rischia ulteriormente di precipitare. I suoi buoni canali con il Cremlino e il fatto che Vladimir
Putin aveva già anticipato che avrebbe riconosciuto il voto costituiscono la base perché gli sforzi
di riconciliazione abbiano successo.
149
Ma la strada è in salita, proprio perché non si tratta di fare i conti solo con gli autonomisti
teleguidati da Mosca, ma con un arcipelago di gruppi che rappresentano diversi interessi.
Poroshenko è un pragmatico e non può permettersi il rischio di fallire, visto che sul piatto c’è una
cosa seria come l’unità del paese.
Il fronte del gas
Il Manifesto, 27 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Gli scontri armati nell’est. La propaganda alimentata da tutti, senza sosta. La sensibilità storica,
con i suoi tic non facilmente controllabili. La battaglia russo-ucraina corre lungo tanti fronti. C’è
anche, ovviamente, quello del gas. Con una deadline imminente e sensibilissima. Entro domani
a mezzanotte Naftogaz, l’azienda di stato ucraina che gestisce il comparto, è tenuta a saldare una
parte del debito che ha accumulato tra novembre e marzo nei confronti della controparte russa,
Gazprom. La cifra ammonta a due miliardi di dollari, su un totale di tre e mezzo. Un altro assegno,
da 500 milioni, va staccato entro il 7 giugno. È per le forniture di maggio. Così s’è deciso lunedì
a Berlino, quando ucraini e russi si sono accomodati a un tavolo convocato dal commissario
europeo per l’energia, il tedesco Guenther Oettinger. Venerdì, se Naftogaz pagherà Gazprom, si
tornerà a discutere. Sempre a Berlino e sempre con la regia di Oettinger. Stavolta l’oggetto
saranno i prezzi, con Kiev che chiede a Mosca di abbassarli. In caso contrario i russi potrebbero
chiudere i rubinetti. Con conseguenze importanti a livello industriale, tanto per l’Ucraina quanto
per l’Europa, che dalla Russia importa tanto gas, e lo fa attraverso i tubi dell’ex repubblica
sovietica. Si capisce, così, l’interesse di Oettinger a prendere il pallino in mano.
La strada per l’accordo è meno lineare di quel che sembra. Ieri Kiev ha calato una carta
a sorpresa, spiegando che il Cremlino, annettendo la Crimea, s’è preso anche due miliardi e più di
metri cubi di gas stoccato, per un valore di un miliardo di dollari. Il primo ministro in carica dopo
Maidan, Arseni Yatseniuk, ha esplicitamente chiesto che Mosca pompi verso l’Ucraina quanto
saccheggiato. La Russia, dal canto suo, fa sapere che non ha sottratto alcunché. Due sono le
150
possibili ragioni a monte della rivendicazione di Yatseniuk. Da un lato, si ipotizza, si cerca di
spuntare qualcosa in extremis su quando dovuto. Le casse dello stato sono allo stremo, e l’idea di
bruciare i primi soldi prestati dal Fondo monetario per mettersi in regola con i pagamenti non
è certo esaltante. Dall’altro lato si può credere che il governo ucraino voglia legare questa
faccenda ai combattimenti in corso nell’est del paese, che nelle scorse ore, a Donetsk, sono stati
particolarmente duri. Sconto sul debito e sulle future forniture in cambio dell’allentamento della
pressione militare sui ribelli filorussi, se non della loro smobilitazione: potrebbe essere questa la
richiesta di Kiev. Anche Mosca, comunque, dà l’impressione di tenere i due piani appaiati - quelli
del gas e dell’est ucraino - per indurre Kiev a far tacere i cannoni e promuovere una riforma
federale. Ci sono tante leve da azionare, insomma. Ma lo spazio di manovra è angusto.
Intanto si apre la questione del gas. L’evoluzione del conflitto del Donbass
e l’assetto complessivo del paese passano anche dall’energia.
Nel frattempo Yatseniuk ha anticipato l’ipotesi dell’arbitrato internazionale, se entro mercoledì
non si trovasse l’accordo sul gas. Se invece arrivasse, il prossimo passaggio sarà trattare sul
prezzo. Kiev paga una tariffa più alta di quelle applicate da Gazprom ai clienti comunitari. È di
485 dollari per mille metri cubi e si rifà agli accordi del 2009 tra Vladimir Putin e Yulia
Tymoshenko, quando quest’ultima era primo ministro. L’intesa pose fine al blocco delle forniture
all’epoca deciso dalla Russia, ma aprì anche la strada al processo e alla successiva condanna
comminata durante la presidenza Yanukovich all’ex pasionaria di Kiev, accusata di aver firmato
accordi così svantaggiosi da spingere il paese sul lastrico. Ma questa è una storia vecchia. Adesso
Kiev chiede a Mosca di pagare 268,5 dollari per mille metri cubi, cioè la tariffa concordata
a dicembre da Putin e Yanukovich. Fu annullata, riportando in vigore quella del 2009, dopo che lo
stesso Yanukovich fuggì dal palazzo. E il paradosso, uno dei tanti di questa crisi ucraina, è che
quando fu siglata il movimento della Maidan gridò al patto con il diavolo.
151
Progetto Eurasia
Linkiesta, 30 maggio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
EaEU, acronimo inglese per Eurasian Economic Union, è l’Unione economica euroasiatica,
battezzata il 29 maggio 2014 ad Astana, Kazakistan. Ne fanno parte per ora Russia, Bielorussia e
appunto Kazakistan. Tre ex repubbliche sovietiche cui presto si aggiungeranno con grande
probabilità Armenia, Kirghizistan, Tagikistan e forse pure l’Uzbekistan. Cosa è? Solo una nuova
sigla tra le tante che lo spazio post-comunista ha sfornato negli ultimi vent’anni? Una specie di
Urss in formato leggero? La risposta di Vladimir Putin all’Unione Europea? Un bluff che maschera
la fragilità di una potenza regionale che non vuole rassegnarsi a un simile status? Un club di
autocrati e di poveracci?
«Una nuova realtà geopolitica è nata nel Ventunesimo secolo». Questa la dichiarazione neutrale
del padrone di casa Nazarbayev che ha firmato, insieme con Vladimir Putin e Alexandr
Lukashenko, il trattato di fondazione. L’Unione partirà operativamente dall’inizio del prossimo
anno e il nuovo spazio unico economico garantirà la libera circolazione di prodotti, servizi,
capitali, lavoratori e metterà in opera una politica concertata nei settori chiave dell’economia dei
paesi partecipanti, dall’energia all’industria, dall’agricoltura ai trasporti. Così quanto meno
sostengono i fondatori.
Il Cremlino ha parlato della formazione di un importante mercato comune nello spazio della
Comunità degli stati indipendenti (Csi) che diventerà un potente centro di sviluppo economico
con 170 milioni di persone e un Pil complessivo di 2,7 trilioni di dollari. All’appello di Putin
manca quell’Ucraina che Mosca voleva tenere legata a sé, ma che la rivoluzione di febbraio e la
guerra nel Donbass non stanno tanto avvicinando all’Europa, quanto spingendo verso il baratro.
E Vladimir Vladimirovich non sembra preoccuparsene più di tanto. Il momento in cui è arrivato il
battesimo di Astana, con la crisi ucraina che ha allontanato Russia e Stati Uniti, un po’ meno
l’Europa, è significativo, proprio perché è il segnale che Mosca persegue il progetto di
integrazione euroasiatica in maniera indipendente, accelerando verso oriente e non verso
occidente. Ma la tempistica non è certo da sopravvalutare, visto che il progetto dell’Unione parte
da lontano, prima del conflitto in Ucraina e anche di quello in Georgia del 2008.
152
Il fatto che il piano di riallineamento delle ex repubbliche sovietiche continui senza Kiev,
considerato inizialmente un anello fondamentale per la realizzazione dell’EaEU, mostra come il
Cremlino se ne infischi della più popolosa delle vecchie sorelle. E in questo momento forse si
capisce anche perché.
L’Ucraina non è solo un paese in guerra e sulla via di un possibile smembramento, ma sull’orlo
del tracollo economico-finanziario. Non si è ancora ripresa dalla crisi del 2009, quando il Pil è
crollato del 15%, e che quest’anno cadrà ancora più in basso, con un tonfo dell’8%, se non peggio.
E chissà quando si rimetterà veramente in sesto. Al confronto, gli aspiranti all’ingresso nell’EaEU,
i piccoli e poveri Armenia, Kirghizistan e Tagikistan (l’Uzbekistan è a parte, visto che sembra non
avere troppa fretta di unirsi al gruppo), sono in condizioni smaglianti. Da questo punto di vista,
proprio per loro, entrare nell’Unione sarebbe un vantaggio, mentre la Russia, che non sta proprio
bene, avrebbe comunque il compito poco remunerante di fare da traino. I problemi si
relativizzano proprio per il fatto che le economie in questione sono leggere. Il fardello ucraino
graverebbe invece non poco, ma allo stato attuale delle cose sembra che la questione sia ormai da
risolvere tra Washington e Bruxelles. E il conto andrà a finire alle cancellerie occidentali.
L’asse economico che conta e intorno al quale si muoverà tutta l’Unione è ovviamente quello tra
Mosca e Astana, con tutto il rispetto per Minsk, che sta nel club perché a Lukashenko manca ogni
praticabile alternativa. Russia e Kazakistan sono potenze energetiche non necessariamente
concorrenti ed entrambe guardano sia a ovest che a est, dove la Cina assetata di gas e petrolio ha
già cominciato a ordinare da bere.
Come l’Unione Europea è scaturita dalla Ceca, la vecchia comunità del carbone e dell’acciaio, così
la nuova Urss rinasce nel nome dell’energia. E come nel corso degli anni l’Europa è cresciuta sotto
il ruolo egemone della Germania, così l’EaEU sarà guidata dalla Russia, il paese più grande con
l’economia più forte.
È presto per prevedere cosa diventerà davvero l’Unione voluta da Putin, è però certo che si tratta
di un progetto, non solo economico, ma geopolitico, che sta nell’ordine delle cose e segue la stessa
linea che ha percorso l’Europa occidentale dopo la seconda guerra mondiale. La disgregazione
dell’Urss, «la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo» secondo la definizione putiniana, ha
creato un vuoto in Eurasia che la volontà di potenza del Cremlino e il corso della globalizzazione
153
stanno portando di nuovo a colmare. Stretta tra l’Europa e la Cina, la Russia conduce insomma il
riassemblaggio delle ex repubbliche sovietiche come se fosse un processo quasi fisiologico. E se
l’Ucraina non ci sarà, Mosca se ne farà una ragione.
154
8
L’ANCORA EUROPEA
(giugno 2014)
Petro Poroshenko non fa in tempo a insediarsi alla Bankova che gli cadono le
prime tegole sulla testa. La Russia taglia le forniture di gas. Il fronte della guerra
preoccupa, ma c’è anche l’economia da salvare. Le previsioni sono da subito catastrofiche. La firma
dell’Accordo di associazione con l’Unione Europea dà qualche speranza in più, ma in realtà si tratta
solo di una panacea, dato che da un lato i tempi per la sua implementazione si presentano lunghi e
dall’altro tra Bruxelles, Kiev e Mosca non tutto è chiarito, come dimostrerà la decisione trilaterale di
posticiparne l’entrata in vigore all’inizio del 2017.
Petro Poroshenko a Bruxelles (president.gov.ua)
155
Il piatto vuoto di Kiev
Rassegna est, 9 giugno 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Se il 2014 per l’Ucraina è iniziato male, finirà sicuramente peggio. Dalla stagnazione sostanziale
del biennio passato si passerà a una fase di recessione vera e propria. Secondo le previsioni del
Fondo monetario internazionale, fatte in relazione al pacchetto di aiuti approvato ad aprile, la
caduta del Pil è quantificata nel 5%. Ma per altre fonti il calo potrebbe essere ben peggiore e ad
esempio per la Ebrd, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, si aggirerebbe oltre il
7%. Si tratta in ogni caso di previsioni che potrebbero ulteriormente peggiorare, a seconda di
come si svilupperà la crisi nell’est del paese, dove l’operazione antiterroristica lanciata dal
governo all’inizio di aprile si è di fatto trasformata in guerra. Soprattutto il peggioramento dei
rapporti con la Russia andrebbe influenzare l’andamento già disastroso dell’economia ucraina.
Nel 2014 l’Ucraina perderà dai cinque ai sette punti di Pil.
Crollo di produzione industriale e moneta.
L’emergenza è anche di natura economico-finanziaria.
La produzione industriale nel primo trimestre del 2014 ha subito un arretramento del 5%,
dovuto in larga parte proprio alla critica situazione nel Donbass. L’Ucraina, reduce da un triennio
di stasi sotto Victor Yanukovich, non era tornata nemmeno ai livelli prima della crisi del 20082009 (-15% del Pil). Ora è in arrivo la prossima catastrofe. La svalutazione della grivnia, che negli
ultimi mesi ha perso quasi il 40%, farà crescere l’inflazione oltre l’8% (-0,3 nel 2013) ed è
previsto un aumento consistente del debito pubblico, che passerà dal 40,9% al 56,5% del Pil alla
fine di quest’anno.
I futuri sviluppi economici sono legati naturalmente a quelli politici e alla capacità della nuova
élite di Kiev, guidata alla presidenza dall’oligarca Petro Poroshenko, di disinnescare l’emergenza
separatista per riportare il paese verso la normalità. L’eventuale firma della parte economica
dell’Accordo di associazione con l’Unione Europea - dopo la sottoscrizione della parte politica
avvenuta a marzo - potrebbe contribuire alla stabilizzazione iniziale, insieme con il pacchetto di
156
aiuti concordato tra Ue, Fmi e Stati Uniti che nel suo complesso si aggira sui 18 miliardi di dollari
per i prossimi due anni. Fondamentali sono in ogni caso le riforme, politiche ed economiche, che
Kiev dovrà affrontare nei prossimi mesi, senza le quali anche gli aiuti occidentali potrebbero
essere rallentati, come già successo in precedenti programmi negli ultimi due lustri sia con
Yanukovich che con Yulia Tymoshenko. La normalizzazione dei rapporti con la Russia sul breve
periodo, soprattutto in relazione alla questione insoluta del gas, appare altrettanto importante
per evitare pericolosi impasse che, al di là delle possibile conseguenze per i consumatori europei,
si rifletterebbero in maniera ancora più negativa sull’economia ucraina.
I tubi congelati
Tmnews, 18 giugno 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Dopo il blocco delle trattative sul gas con la Russia e la chiusura dei rubinetti da parte di Mosca,
l’Ucraina si trova in un vicolo cieco dal quale cerca ancora di uscire con il sostegno finanziario
dell’Europa. La mediazione di Bruxelles non è sinora riuscita ad avvicinare i due contendenti,
Gazprom e Naftogaz, che rimangono distanti in un duello che non è altro che l’appendice di quello
avviato già nel 2011 tra Victor Yanukovich e Vladimir Putin, conclusosi provvisoriamente nel
dicembre dello scorso anno.
La posizione attuale di Kiev, che spera di trovare inoltre ragione alla corte di arbitrato di
Stoccolma, non è però delle più comode e nonostante il premier Arseni Yatseniuk oggi al
parlamento abbia sfoderato ottimismo, è solo il fatto che questa guerra del gas sia stia svolgendo
nei mesi caldi dell’anno a non creare allarmi concreti. L’estate però passa in fretta e se non sarà
raggiunto un compromesso stabile nelle prossime settimane, l’autunno e soprattutto l’inverno
potrebbero diventare critici non solo per l’ex repubblica sovietica, ma anche per alcuni paesi
europei. Attualmente non vi sono problemi per il passaggio del gas russo verso l’Europa e sia
Mosca che Kiev hanno assicurato il rispetto degli attuali contratti di transito, validi comunque
solo sino alla fine del 2014. Secondo Gazprom gli impianti di stoccaggio ucraini contengono 9
157
miliardi di metri cubi di gas, sufficienti per affrontare l’estate, ne sarebbero invece necessari più
del doppio per garantire regolari forniture durante la stagione invernale.
Yatseniuk si è rivolto oggi alla Rada snocciolando «buone e cattive notizie». Tra le prime ha
ricordato come da ieri le forniture di gas russo verso l’Ucraina siano state bloccate, fra le seconde
il ricorso di Naftogaz alla corte di arbitrato a Stoccolma per chiedere le revisione dell’accordo
firmato cinque anni fa tra Yulia Tymoshenko e Vladimir Putin alla fine dell’ennesima guerra del
gas. Lo stesso ha già fatto però anche Gazprom, che ha annunciato a sua volta di voler ricorrere al
tribunale svedese, che secondo i contratti del 2009 è responsabile per risolvere le diatribe, per
fare chiarezza sulla questione del debito di Kiev, che ammonta a 4,5 miliardi di dollari. Il numero
uno di Gazprom Alexei Miller ha fatto in aggiunta sapere che potrebbe essere intentata anche
un’altra causa per 18 miliardi relativi agli anni 2012 e 2013 in cui l’Ucraina non avrebbe
completamente soddisfatto gli accordi take or pay.
In sostanza i punti che dividono Russia e Ucraina sono due: riguardano da una parte il volume e il
modo di appianamento del debito, che comunque, come già evidenziato nel corso dei tentativi di
mediazione dal commissario europeo per l’Energia Guenther Oettinger, deve essere in ogni caso
saldato, e dall’altro il prezzo, fissato nel 2009 e poi sottoposto a revisione nel 2010 con gli accordi
di Kharkiv e nel dicembre del 2013. Già dal 2011 Kiev aveva cercato di rivedere i contratti firmati
da Tymoshenko, a causa dei quali l’ex premier era poi finita in carcere per abuso di potere. Il tira
e molla era terminato sei mesi fa, quando con la rivoluzione di Maidan al suo inizio Putin e
Yanukovich avevano stabilito il prezzo di 268 dollari per 1000 metri cubi nell’ambito del
pacchetto di aiuti di Mosca per Kiev, poi ritirato con il cambio di regime a febbraio e la svolta
europeista del nuovo governo. Yatseniuk vorrebbe ora proprio quel prezzo che nemmeno
Yanukovich è riuscito di fatto a pagare e si è inevitabilmente scontrato contro il muro del
Cremlino.
Paradossalmente il ministro dell’energia ucraino che oggi guida la crociata contro Gazprom è lo
stesso Yuri Prodan che nel 2009 a fianco dell’eroina della rivoluzione arancione aveva
sottoscritto l’intesa con Mosca. La Russia è disposta a concedere prezzi politici all’interno della
Csi (Comunità degli Stati Indipendenti) e nell’ambito dell’Unione Euroasiatica, ma non pare voler
fare sconti a nessun altro. Se quindi Bielorussia e Armenia pagano meno di 200 dollari, l’Ucraina
si dovrà adattare ai prezzi europei, che mediamente si aggirano intorno ai 380 dollari, con paesi
158
che pagano poco più di 300 e altri oltre 450. Yatseniuk, che a parole sta ricalcando gli slogan del
suo predecessore Mykola Azarov, dagli impegni per la diversificazione delle vie e delle fonti a
quelli per una maggiore efficienza energetica, buoni solo da qui a dieci anni, è legato sul breve
periodo agli aiuti dell’occidente, che si trova di fatto a dover aprire il portafoglio sia per evitare il
collasso dell’Ucraina sia per coprirsi le spalle in vista del prossimo grande freddo.
L’illusione antifascista del Donbass
Il Manifesto, 25 giugno 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________
Chi sono i ribelli dell’est ucraino? Per Kiev sono terroristi secessionisti manovrati da Mosca, per
i media russi forze di autodifesa che resistono ai golpisti della Majdan. Definizioni schematiche di
un universo ben più articolato. In linea con lo scenario ucraino nel suo complesso.
In attesa di capire se il piano di pace di Poroshenko non è un foglio di carta, si può partire da
destra. L’insurrezione a Donetsk, come nella vicina Lugansk, registra la presenza di personaggi
riconducibili all’estremismo russo e russo-ucraino.
Uno è Pavel Gubarev. Trentunenne, imprenditore, ha una storia di militanza in Unità nazionale
russa, formazione con venature xenofobe. È stato lui, a marzo, in concomitanza con lo scoppio
della crisi di Crimea, a guidare la presa dei palazzi, fregiandosi poi della carica di governatore
della Repubblica di Donetsk. Arrestato, è stato rilasciato a maggio. In quei giorni sono state attive
altre sigle radicali, tra cui l’Unione eurasiatica della gioventù, braccio giovanile di Eurasia, movimento presieduto dall’accademico russo Aleksandr Dugin, uomo dal provato pensiero radicale.
Da poco ha invitato a parlare alla Lomonosov, l’universit{ moscovita dove insegna, Gabor Vona.
È il numero uno di Jobbik, la destra ungherese più becera. Sempre a proposito di destre internazionali s’è venuto a sapere che i polacchi di Falanga e gli italiani di Millennium hanno inviato loro
rappresentanti a Donetsk. Il che rivela che la famiglia nera europea s’è schierata dall’una
e dall’altra parte della barricata ucraina. Non soltanto a Kiev, con Pravyi Sektor e le altre bande
159
della Majdan. Nell’est ucraino un’altra personalità che si colloca a destra è Alexander Borodai, un
russo, il capo del governo della Repubblica di Donetsk. A Mosca Borodai ha la fama di uno dei più
noti interpreti dell’ultranazionalismo e commenta spesso sulla rivista Zavtra, cassa di risonanza
di questi ambienti, che ha recentemente pubblicato una sorta di manifesto della Nuova Russia.
È il nome di quella che dovrebbe essere un’entit{ statuale composta dalle aree di Donetsk
e Lugansk, possibilmente allargata alla Transnistria e a Odessa. Il discorso sulla Nuova Russia
allarga il campo dell’analisi, svincolandola dal solo tema, limitante, della collocazione politica. In
ballo ci sono sentimenti, persone in carne e ossa. Alcune delle quali percepiscono il rapporto tra
Ucraina e Russia come una cosa intima. Ci si arruola nelle milizie filorusse anche in nome di
quest’idea, che trova ampi riscontri nella storia, nella cultura e nella letteratura. Sulla Majdan
è accaduta grosso modo la stessa cosa.
La rivolta ha avuto una sua importante pulsione storica e culturale, identificabile nel pensiero
nazionale-nazionalista ucraino, forgiato nell’ovest del paese e proteso a separare la vicenda biografica ucraina da quella russa.
Nell’insurrezione dell’est influiscono, restando sul piano della storia, anche i retaggi della
seconda guerra mondiale. In questo senso la Maidan e la sua componente ultranazionalista ha
assunto il sapore di una replica a scoppio ritardato delle attività dispiegate nell’Ucraina occidentale dai miliziani di Stepan Bandera, fautori di uno stato ucraino etnico. Contrassero un’alleanza
tattica con Hitler in funzione antisovietica e antipolacca. Oggi la figura di Bandera spacca il paese.
I circoli nazionalisti lo elevano al rango di eroe. L’est, sensibile alla Russia e alla tradizione della
grande guerra patriottica, lo bolla come un nazista.
Nel guazzabuglio di Donetsk non manca un fattore banditesco. Ci sono personaggi senza scrupoli
che si sono buttati nella mischia perché c’è da guadagnare. Si sta cercando di fare pulizia. Significativo l’episodio di fine maggio, quando il battaglione Vostok, impegnato in prima linea e composto da russi, ucraini e ceceni, ha fatto irruzione nel quartier generale della repubblica di Donetsk
con l’obiettivo di liquidare elementi anarchici. Recentemente è invece arrivata la notizia della
deposizione di Vyacheslav Ponomarev, sindaco di Sloviansk. Igor Strelkov, il capo della difesa di
Donetsk, altro russo al potere delle strutture dell’est ucraino, ha spiegato che la decisione
è dovuta a incompatibilità con i compiti dell’amministrazione civile.
160
Diversi analisti hanno intravisto in questa vicenda una riprova della volontà di epurare le frange
ingestibili della ribellione. Foreign Policy suggerisce tra le righe anche un’altra lettura, fondata
sull’idea che l’est è un serbatoio di anarchia dove i gruppi più equipaggiati stanno progressivamente prendendo il sopravvento. È il caso del battaglione Vostok, ma anche dell’Esercito ortodosso russo e di Oplot, movimento sorto a Kharkhiv.
In molti si chiedono se e fino a che punto la Russia controlla i ribelli. Non esistono risposte chiare.
Qualche indizio porta a pensare che il filo sia diretto. A Donetsk il potere è soprattutto nelle mani
del duo Borodai-Strelkov. Entrambi sono stati attivi in Crimea, prima di spostarsi nel Donbass. In
più tra le file degli insorti, riferisce chi è stato a est a seguire la guerra civile, hanno iniziato a confluire sempre più russi, con chiaro know-how militare. Ma questo non costituisce una prova
inconfutabile.
Su soldi e armi, stessi dubbi. I miliziani dell’est, che comunque sia amministrano più di cento chilometri di frontiera, dicono che le armi sono state requisite dagli arsenali ucraini e che Mosca non
ha erogato un rublo. Negli ambienti atlantici sono tutti convinti, invece, che la rivolta sia foraggiata dal Cremlino. Si mormora infine che i finanziamenti giungano da Yanukovich e dalla sua
cricca, che negli ultimi anni ha rubato l’indicibile.
Accordo tra speranze e timori
Tmnews, 27 giugno 2104
________________________________________________________________________________________________________________
L’Ucraina ha firmato l’Accordo di associazione con l’Unione Europea. E’ stato lo stesso presidente
ucraino Petro Poroshenko a sottoscrivere la parte economica dell’intesa, dopo che quella politica
era stata già siglata a marzo dal primo ministro Arseni Yatseniuk. Si conclude formalmente così il
travagliato capitolo iniziato alla fine di novembre del 2013, quando l’allora capo di stato Viktor
Yanukovich aveva dato lo stop al processo di avvicinamento all’Europa, scegliendo la
collaborazione con la Russia e scatenando le proteste che hanno portato alla rivoluzione di
febbraio. Il patto con l’Ue rischia però di condurre a ulteriori problemi con la Federazione russa,
161
che con l’ingresso dell’Ucraina nello spazio economico europeo potrebbe reagire imponendo
restrizioni alle esportazioni di Kiev verso Mosca, mettendo in difficoltà presidente e governo
impegnati nel tenere a galla il paese. Già oggi Mosca ha preannunciato tali mosse, per bocca del
viceministro degli Esteri Grigory Karasin, il quale ha parlato di «misure».
La firma dell’accordo arriva infatti in un momento particolarmente difficile per l’Ucraina: da un
lato c’è la situazione politica interna destabilizzata a causa dell’annessione della Crimea da parte
della Russia e dei venti separatisti nelle regioni del sudest e dall’altro un quadro economico
disastroso, con le previsioni di un anno di grave recessione che potrà essere superato senza il
tracollo solo grazie agli aiuti della comunità internazionale. Dal punto di vista simbolico la firma
dell’Accordo di associazione con l’Ue è una vittoria per il nuovo blocco di potere a Kiev, anche se
la strada verso l’integrazione e l’ingresso a titolo pieno nell’Unione rimane un miraggio sia sul
medio che sul lungo periodo. Parafato nel marzo 2012, poi congelato per il caso di Yulia
Tymoshenko e diventato il pomo della discordia alla base della crisi internazionale tra Russia e
Occidente, l’accordo comporta la sottoscrizione di una serie di valori e regole europee e, in
sostanza, suggella la scelta filo-occidentale delle nuove autorità ucraine.
La sottoscrizione di accordi di associazione e di cooperazione economica (Dcfta) non spalancano
automaticamente le porte di Bruxelles e Kiev ha di fronte come prima una strada in salita con i
soliti problemi, politici ed economici, da risolvere con la Russia. L’intesa porta tra l’altro con sé la
creazione di una zona di libero scambio che all’inizio potrebbe addirittura penalizzare l’economia
ucraina. Il neo ministro degli esteri Pavlo Klimkin ha parlato della volontà di entrare nel club
europeo tra dieci anni. Al di là del poco entusiasmo per ulteriori allargamenti che si respira nelle
capitali europee, ciò che può succedere da qui al 2024 in Ucraina e sulla scacchiera Ue è
altamente imprevedibile. I rapporti con Mosca, con cui Poroshenko sta cercando di ricucire gli
strappi per risolvere il rebus indipendentista nel Donbass, sono imprescindibili al di là del fatto
che l’Ucraina stia per entrare in uno spazio economico comune con l’Europa. Il Cremlino ha dato
il via al progetto di Unione Euroasiatica con Bielorussia e Kazakistan malgrado il rifiuto di Kiev e i
nodi scottanti da risolvere tra i due Paesi rimangono gli stessi di sempre, a partire dal dossier del
gas che si trascina da anni. L’Accordo di associazione con Bruxelles offre sicuramente vantaggi,
ma crea anche difficoltà nelle relazioni con Mosca e sia Poroshenko che Yatseniuk - nella
complicata coabitazione in cui sono obbligati dalla costituzione, con il primo responsabile in
162
sostanza per la politica estera, il secondo per quella economica - dovranno sfoderare eccezionali
doti di equilibrismo per non cascare nel baratro. Non è un caso che Yatseniuk si sia detto oggi
disponibile a discutere con Mosca questioni tecniche che potrebbero far sorgere problemi tra i
due paesi con l’implementazione da parte ucraina degli obblighi dell’accordo. In sostanza Kiev
teme per l’export dei propri prodotti nella Federazione russa e nell’area dell’Unione euroasiatica
che avrebbe effetti negativi soprattutto per alcuni settori e per alcune regioni. Da parte sua,
Mosca dichiara di temere un’invasione di prodotti europei in arrivo da un "corridoio ucraino"
improvvisamente ancorato allo spazio commerciale Ue. I timori di Kiev sono fondati. Le
esportazioni verso la Russia incidono su oltre l’8% del pil ucraino, il 22% della produzione di
macchinari e il 14% dell’output dell’industria metallurgica prende la via della Federazione Russa.
Le regioni che hanno maggiori rapporti con Mosca sono quelle di Lugansk, Zaporizha, Mikolayv e
Sumy, dove tra l’8% e il 10% della produzione viene esportato in Russia.
Kiev, e adesso?
Europa, 29 giugno 2014
________________________________________________________________________________________________________________
L’Ucraina ha firmato venerdì scorso gli Accordi di associazione con l’Unione europea e il Deep
and Comprehensive Free Trade Agreement (Dcfta), un’intesa sugli scambi commerciali. Le due
misure sono il volàno con cui Bruxelles punta a rafforzare i rapporti con Kiev, come con le altre
nazioni ex sovietiche che rientrano nello schema della Eastern Partnership, programma di conio
polacco-svedese lanciato qualche anno fa. Anche Georgia e Moldova hanno vergato, sempre nella
giornata di venerdì, questi protocolli. I due accordi sono gli stessi che l’ex presidente Viktor
Yanukovich fu sul punto di firmare, l’anno scorso. Poi, all’ultimo momento, decise di scartare
questa opzione e di non scarcerare Yulia Tymoshenko, condizione posta da Bruxelles. Proprio in
quell’istante scoppiò la protesta che, prendendo successivamente la forma di una rivoluzione di
matrice nazionalista, lo ha allontanato dal potere. È come se si fosse tornati a quel bivio, indietro
nel tempo, scegliendo la seconda delle due strade a disposizione. Con la differenza che, nel
frattempo, l’Ucraina si è avvitata nella più grave crisi vissuta dall’indipendenza del 1991 a oggi.
163
Cosa significano questi accordi? Partiamo dal loro respiro tecnico. L’Ucraina e gli altri contraenti,
Georgia e Moldova, hanno la possibilità di accedere al mercato europeo, esportandovi i loro
prodotti attraverso una graduale riduzione dei dazi. Al tempo stesso i loro mercati interni si
aprono alle merci europee, ma in modo ancora più progressivo, dato che l’export comunitario, in
termini di qualità, dimensioni e competizione, può creare squilibri in alcuni settori, soprattutto
quello alimentare, che risulta essere il maggiormente coinvolto negli scambi, quanto meno in
questa primissima fase.
La firma degli Accordi di associazione non significa integrazione
rapida in Europa. Ma rappresenta una chiara scelta politica:
spostare il baricentro del paese verso occidente.
L’entrata in vigore delle intese genera inoltre una spinta alle riforme e alla competitività.
Necessarie a rendere i sistemi economici post-sovietici più complementari con quello europeo.
Ma gli Accordi di associazione (Kiev ne aveva già firmato qualche settimana fa la parte politica) e
sul libero scambio hanno anche un registro altamente politico. Kiev, firmandoli, ha scelto di
proseguire sulla rotta europea, benché questo non spiani la strada a una futura adesione. Difficile
d’altro canto immaginarla, sia nel breve che nel lungo periodo.
L’Europa, da parte sua, ha invece espresso la volontà di continuare a esercitare una proiezione
nello spazio post-sovietico, pur se la strategia di fondo non appare chiarissima e se i pesi massimi
del continente hanno qualche dubbio a riguardo, dato che tutto questo alimenta chiaramente
degli attriti con la Russia.
Adesso bisogna attendere la reazione di Mosca e dei ribelli filorussi che, nell’est del paese, dov’è
in corso da settimane un confronto militare con le forze armate e i gruppi paramilitari di Kiev,
controllano discrete fette degli oblast di Donetsk e Lugansk. Venerdì scadeva la tregua concordata
dalle parti sulla base del piano di pace in 15 punti proposto dal presidente ucraino Petro
Poroshenko. È stata rinnovata di altre 72 ore. Spirerà quindi martedì. Nel frattempo Putin ha
chiesto al parlamento russo di revocare il decreto con cui, in precedenza, l’esercito russo era
stato autorizzato a sconfinare e intervenire in Ucraina. Un passo non privo di valore politico.
164
L’impressione è che Mosca voglia trattare, cercare una normalizzazione. Anche perché l’est
dell’Ucraina è molto più stratificato e molto più economicamente complesso rispetto alla Crimea,
annessa con facilità imbarazzante.
Ma non tutto è così lineare. Va capito se i ribelli dell’est si adegueranno alle posizioni che il
Cremlino assumerà. Appunto: quali posizioni? Una possibilità è quella di varare misure restrittive
verso l’export ucraino. Non tanto perché, come dicono i russi, gli accordi economici tra Kiev e
Bruxelles fanno dell’Ucraina un corridoio attraverso il quale le merci europee possono accedere
al mercato russo, danneggiandolo. Piuttosto si tratta di contrastare il legame politico che
l’Ucraina e l’Ue hanno stabilito. Cozza contro il disegno strategico di Mosca, quell’Unione
eurasiatica che dovrebbe, nelle intenzioni di Putin, creare una massa critica post-sovietica a
trazione russa. Ma non è solo questo. Il Cremlino, sussurra qualcuno, percepisce l’avvicinamento
tra Kiev e Bruxelles come una possibile anticamera di un allargamento Nato. Le cose sono troppo
cambiate, sul terreno, per rendere reversibile la firma degli accordi euro-ucraini. Ma Putin ha
molte armi con cui condizionare il vicino, impedendo che la manovra di avvicinamento all’Ue sia
così risoluta. Una è l’energia. Le forniture di gas a Kiev sono state interrotte il 16 giugno. Un’altra
leva è l’est. Mosca, apparentemente, controlla i ribelli. Se si continuasse a combattere verrebbe
confermata l’instabilità del paese e la portata delle intese siglate ieri da Poroshenko ne
risulterebbe annacquata.
Non tutto però dipende da Putin. Anche Poroshenko - nonché l’Ue - dovrà mostrare una chiara
volontà politica, finora un po’ mancata, per normalizzare lo scenario. Il capo di stato ucraino sa
che il paese non può prescindere, politicamente, energeticamente e commercialmente, da una
relazione cordiale con la Russia. Ne sono coscienti anche gli oligarchi, i veri padroni di Kiev
(Poroshenko fa parte di questo cerchio). I loro affari, se dovessero svilupparsi con la sola Europa,
perderebbero intensità. Al contempo, se venissero fatti con la sola Russia, non sarebbero
sostenibili. La soluzione, come dire, sta nel mezzo. Scendendo ancora nel dettaglio, il nodo
cruciale sembra essere il futuro assetto costituzionale del paese.
La Russia ha chiesto esplicitamente una riforma in senso federale. Kiev è disposta a concedere un
largo tasso di autonomia all’est, ma rifiuta la federalizzazione, argomentando che essa
spingerebbe verso la nascita di uno stato nello stato.
165
In sostanza, gli accordi firmati ieri da Kiev e Bruxelles non cambiano così clamorosamente il
segno delle cose. Il quadro ucraino è ancora molto teso. L’ipotesi che ci si stia incamminando
verso la soluzione va presa con le dovute cautele. Tutto può succedere, anche il peggio. Intanto si
sta aggravando la situazione umanitaria. Ci sarebbero più di cinquantamila che hanno lasciato
l’est del paese riparando nelle regioni dell’ovest. Il doppio, sempre dall’est, s’è spostato in Russia.
166
9
IL MISTERO DEL BOING MALESE
(luglio 2014)
Chi si aspettava un’estate tranquilla è riportato alla realtà dall’abbattimento del
volo MH17 della Malaysia Airlines il 17 luglio. La tragedia, ancora oggi non
completamente chiarita nei suoi dettagli, aumenta la tensione tra Russia e Occidente e avvita la
spirale delle sanzioni contro Mosca. Mentre si combatte nel Donbass e le regioni di Donetsk e
Lugansk diventano l’epicentro di una vera emergenza per la popolazione civile, a Kiev il governo
Yatseniuk salta, con la maggioranza di governo che va a pezzi come previsto. Udar e Patria, cioè
Klitschko e Tymoshenko, tolgono la fiducia al premier, che rimarrà in sella ancora per qualche
settimana prima che il presidente ad agosto sciolga il parlamento e indica nuove elezioni.
Investigatori australiani e olandesi sul luogo del disastro aereo (Ministero della Difesa olandese)
167
Morire per Donetsk?
Europa, 8 luglio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Ore decisive, in Ucraina. C’è aria di battaglia finale. L’esercito regolare di Kiev s’è schierato alle
porte di Donetsk, dove hanno battuto in ritirata le milizie filorusse, cacciate nei giorni scorsi da
alcune delle loro roccaforti. Su tutte Mariupol e Sloviansk. Quest’ultima è stata il principale teatro
del conflitto civile che ha contagiato l’ex repubblica sovietica. Tutto è cominciato da metà aprile,
quando Kiev ha lanciato l’offensiva militare nei territori delle regioni dell’est finiti a marzo, in
concomitanza con lo scoppio della crisi di Crimea, sotto il controllo dei separatisti. Oltre a una
discreta fetta di quello di Donetsk, i filorussi hanno piazzato la bandierina anche in una porzione
dell’oblast di Lugansk. L’offensiva di Kiev, che ha causato la fuga di più di 150mila persone - molte
delle quali riparate oltre confine, in Russia - ha segnato uno scatto in avanti nel momento in cui,
lunedì scorso, il presidente ucraino Petro Poroshenko ha posto fine alla tregua, da lui stesso
proclamata, unilateralmente, il 20 giugno.
Due sono le domande che ci si pone, in questo momento potenzialmente critico e decisivo. Da una
parte si cerca di capire come Kiev cercherà di espugnare Donetsk. Dall’altra si guarda a Mosca.
Alle contromosse di Vladimir Putin. Andiamo in ordine, partendo dalle carte che Poroshenko ha a
disposizione. Il presidente ha approvato il piano per la liberazione di Donetsk, nonché di
Lugansk. Non ne sono filtrati i dettagli. Si possono comunque avanzare due ipotesi. La prima è un
possibile attacco senza esclusione di colpi. È rischiosissima. Potrebbe causare la morte di
numerosi civili, danneggiando irreparabilmente la reputazione del governo e alienando ancora di
più la popolazione locale, una discreta parte della quale tende verso la causa dei filorussi. L’altra
carta è applicare un blocco. Isolare i ribelli, insomma, sperando che prima o poi alzino bandiera
bianca e consegnino le armi. L’impressione è che Kiev, al momento, prediliga questa strada. Ma
bisogna vedere, ovviamente, la reazione del campo opposto. I ribelli non sembrano propensi alla
resa. Invocano al contempo l’aiuto della Russia.
E qui s’annida il più grande degli interrogativi. C’è da capire cosa frulla nella testa di Putin. Il capo
dello stato russo finora non s’è pronunciato. Si possono tracciare degli scenari, anche in questo
caso. Il primo vede Putin accorrere in aiuto dei ribelli, che a detta degli occidentali sono armati
168
dal Cremlino (che smentisce seccamente). Prospettiva molto insidiosa, questa. La Russia, se
mettesse piede in Ucraina, scatenerebbe una crisi senza precedenti. Più grave di quella in atto, già
di suo serissima. C’è da credere che Putin non lo voglia. Anche perché nei giorni scorsi ha fatto
revocare dal parlamento il decreto con cui egli stesso aveva chiesto, a marzo, l’autorizzazione a
inviare le truppe oltre confine. Una misura deterrente, da usare come strumento di pressione. La
prospettiva più verosimile è che Putin intenda negoziare. Sul tavolo c’è l’idea di aprire una
discussione a tre - Kiev, Mosca e i ribelli - che aiuti a porre fine al conflitto armato. È anche
l’auspicio dell’Europa, che nei giorni scorsi, mobilitando l’asse franco-tedesco, ha cercato di
mediare tra Putin e Poroshenko. La soluzione passa anche, forse soprattutto, dal futuro assetto
costituzionale del paese. Mosca e i filorussi vogliono una federazione. Poroshenko teme che possa
aprire alla balcanizzazione formale dell’Ucraina e offre non più di una larga autonomia. Ma prima
di arrivare a questo c’è il delicatissimo passaggio di Donetsk. Come si sbloccherà, se si
sbloccherà?
In apparenza Kiev sembra avvantaggiata, dato che ha spinto i ribelli nelle sacche di Donetsk e
Lugansk. Ma non è così semplice come sembra. Si sono infatti create le condizioni per un conflitto
asimmetrico, come registra il sito della Bbc. L’esercito ucraino, se vuole liberare le due città, è in
teoria chiamato a stringerle d’assedio, dovesse il blocco essere insufficiente, con tutte le
conseguenze che questo comporta. Significherebbe infatti colpire nel mucchio, senza distinguere
tra civili e rivoltosi in armi. È questa la carta calata da Putin e dai filorussi? E come risponderà
Kiev? Bombarderà a tappeto? Sguinzaglierà i paramilitari, dando loro carta bianca e puntando sul
gioco sporco? Oppure eviterà il bagno di sangue, consentendo ai ribelli di uscire a testa alta dal
confronto e con qualche punto in più in termini negoziali? Le prossime ore chiariranno questi
enigmi. Oppure no. Intanto, intorno a Donetsk, soffia un brutto vento. Kiev ha annunciato che non
ci sarà tregua finché i ribelli non deporranno le armi e tre ponti, nei pressi della città, sono saltati
in aria. Non si capisce chi li abbia distrutti. Il senso di accerchiamento o di isolamento, a seconda
dei punti di vista, ne risulta in ogni caso rafforzato.
169
Chi ha abbattuto l’MH17?
Pagina 99, 17 luglio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Il Boing 777 malese molto probabilmente è stato abbattuto. Su questo vi sono pochi dubbi. Come
sul fatto che sia stato un missile terra-aria Buk a centrarlo quando era in volo a 10 mila metri di
altezza sul territorio ucraino. Nella regione al confine con la Russia è il terzo caso nel giro di pochi
giorni di un aereo coinvolto negli scontri tra separatisti filorussi e truppe governative. Lunedì un
A-26 da trasporto ucraino era stato colpito a 6.500 metri di altezza e il governo di Kiev aveva
accusato direttamente Mosca, dichiarando che i separatisti non erano in grado di arrivare così in
alto con i lanciarazzi a loro disposizione.
Mercoledì sera è stata la volta di un caccia ucraino a precipitare, colpito da un altro velivolo
russo, almeno stando a quanto sostenuto dalle autorità di Kiev.
In entrambi i casi il Cremlino ha rispedito le accuse al mittente e lo stesso ha fatto oggi nel caso
del volo MH17. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha escluso che siano state le forze ucraine
a far precipitare il Boing e lo stesso hanno fatto i separatisti filorussi. Lo scaricabarile insomma
continua, con la differenza che ora non si tratta di vittime militari russe, filorusse o ucraine, ma di
civili: ignare parti terze che hanno avuto solo la sfortuna di sorvolare al momento sbagliato il
lembo di terra sbagliato. Resta da capire come e perché si è arrivati alla tragedia: chi ha lanciato il
missile (250 Buk sono in possesso dell’esercito russo, circa 60 di quello ucraino, i separatisti ne
avrebbero almeno uno, sottratto recentemente agli ucraini) e se si è trattato di un atto
consapevole oppure di un incidente. Vista la battaglia di propaganda di cui è imbevuta la crisi
ucraina, sia sul versante russo che su quello occidentale e ovviamente su quello interno ucraino,
la verità la sanno adesso in pochi.
Quello che è possibile sottolineare sino ad ora è che le prime notizie sono arrivate da Mosca e il
presidente Vladimir Putin ha preso subito la cornetta per sentire Barack Obama proprio nel
giorno in cui la Casa Bianca ha annunciato nuove dure sanzioni nei confronti della Russia. È certo
che in ogni caso la strage pesa sullo sviluppo di una crisi che si fa sempre più intricata e da un lato
rischia di allargare ulteriormente il fossato che si è aperto tra Mosca e Washington, dall’altro di
far precipitare definitivamente il Donbass nel baratro.
170
Senza una tregua il sudest dell’Ucraina è vicino al tracollo: secondo il governo di Kiev, sono oltre
43mila i profughi che hanno lasciato le zone del conflitto. Dalla settimana scorsa sono aperti tre
corridoi su rotaia per l’evacuazione dei civili verso la capitale. Molti prendono però la direzione
della Russia, verso Rostov sul Don, dove sono allestiti campi di accoglienza. Lunedì sono stati i
ministri degli esteri di Ucraina, Russia, Germania e Francia a mettere nero su bianco una mini
road map che avrebbe previsto a breve colloqui diretti tra le parti, come avvenuto in realtà già
qualche settimana fa nel primo vertice, quando era stata stabilita la tregua rimasta solo sulla
carta. Questa è però solo la teoria, superata adesso dalla realtà sul campo. Poroshenko si è
incontrato oggi simbolicamente con una delegazione di famiglie dei soldati che partecipano a
quella che viene ancora ufficialmente chiamata operazione antiterrorismo: dall’inizio di aprile
sono morti nel Donbass circa 300 militari ucraini e oltre 500 civili. Cifre da correggere comunque
verso l’alto, dato che non si conoscono i numeri sul versante filorusso. Ai quali vanno aggiunti ora
i 298 innocenti del volo della Malaysia Airlines.
Mosca al bivio
Lettera 43, 18 luglio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Il luogo dello schianto del Boeing della Malaysia Airlines è a una manciata di chilometri dal
confine con la Russia, in una delle zone controllate dai separatisti. Sono stati loro ad arrivare per
primi, il pomeriggio del 17 luglio, pescando subito tra i rottami fumanti una delle due scatole
nere, che avrebbero consegnato secondo le prime notizie già alle autorità russe. La seconda è
stata ritrovata invece la mattina del 18 dai soccorritori ucraini che hanno il compito di setacciare
la zona del disastro che si estende per una quindicina di chilometri quadrati. L’analisi delle black
boxes potrebbe essere utile per definire la responsabilità dell’accaduto e una delle domande
fondamentali in proposito è se la Russia farà muro o collaborerà per chiarire la dinamica. L’Osce,
l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che era entrata la sera del 17 luglio
in contatto diretto con i leader indipendentisti, ha chiesto e ottenuto di isolare l’area della strage
e i ribelli si sono impegnati a cooperare con le autorità ucraine e a consentire il libero accesso agli
171
ispettori internazionali. Gesti di buona volontà, che potrebbero celare un segreto. Pur non
essendo ancora note le cause ufficiali, la versione più probabile è infatti che l’aereo malese sia
stato abbattuto per errore proprio dai separatisti che volevano invece centrare un velivolo
militare ucraino. E mentre lo spazio aereo nel sudest dell’ex repubblica sovietica è stato chiuso, è
iniziata anche una tregua nei combattimenti che dovrebbe durare un paio di giorni, almeno a
quanto annunciato dagli insorti.
Resta da vedere, passato lo choc iniziale, quali effetti avrà la tragedia del volo MH17 nella crisi
ucraina. In sostanza, se anche con l’aiuto della Russia sarà chiarita la responsabilità dei ribelli e di
Igor Strelkov, il leader che via Vkontakte, il Facebook russo, aveva annunciato l’abbattimento di
un aereo da trasporto ucraino nella stessa zona dove poco dopo sarebbe precipitato quello
passeggeri malese, la comunità internazionale occidentale si schiererà in maniera ancora più
netta a fianco dell’Ucraina, pretendendo da Mosca un distanziamento netto nei confronti della
galassia separatista, non solo a parole, ma anche nei fatti.
Il disastro aereo può rivelarsi un momento chiave della crisi.
Non è da escludere che l’Occidente assuma posture
ancora più dure nei confronti della Russia di Putin.
Se i gruppi filorussi non dipendono direttamente dal Cremlino, nelle settimane precedenti
l’incidente è risultato evidente come alcune questioni (dalla liberazione degli ostaggi dell’Osce,
all’avvio delle tregua e delle prime trattative poi finite nel nulla) siano state gestite con il fiato di
Vladimir Putin sul collo. A questo punto si aprono per il presidente russo due opzioni: rimanere
arroccato sulla posizione tenuta sino al 17 luglio, facendo finta che non sia successo nulla e
continuando a tollerare il gioco sporco nel Donbass, oppure dare un taglio netto all’opaco
cordone che lega Mosca ai ribelli in Ucraina e lasciare che il duello tra potere centrale a Kiev e
separatisti si risolva senza intrusioni. In questo caso, Strelkov e compagni, come ammesso
recentemente, non potrebbero resistere a lungo a livello di confronto miliare. Dopo la perdita di
Sloviansk, Kramatorsk e altre roccaforti la resistenza tra Donetsk e Lugansk potrebbe durare
poche settimane o un paio di mesi al massimo.
172
In seguito all’abbattimento del Boeing la pressione sul Cremlino è aumentata in maniera enorme
e sebbene Putin non sia il tipo da farsi condizionare troppo dagli avvenimenti esterni, le prossime
mosse toccano a Mosca. Dopo l’incidente Vladimir Vladimirovich ha telefonato immediatamente a
Barack Obama, non solo per discutere del problema delle sanzioni, che aveva già commentato
duramente in precedenza, ma anche per chiarire la vicenda del Boeing malese. Segnale che
comunque i canali di comunicazione sono aperti e la collaborazione internazionale rimane
all’ordine del giorno. Lo scenario più ottimistico prevede insomma dopo la tragedia uno sviluppo
verso la de-escalation, nel quale l’isolamento dei ribelli nel Donbass potrebbe da un lato
disinnescare lentamente l’emergenza e dall’altro lasciare a Kiev la sfida per il recupero
economico e sociale di un territorio sull’orlo del baratro dopo quattro mesi di guerra. Quello
opposto darebbe un’ennesima accelerazione al conflitto, aumentando il rischio di un’ulteriore
disgregazione dell’Ucraina.
Le chance della diplomazia
Europa, 19 luglio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Attendere il risultato dell’indagine di una commissione indipendente e solo dopo giudicare e
decidere le contromisure. La posizione del governo tedesco sull’abbattimento dell’aereo malese
nei cieli dell’Ucraina orientale è stata declinata all’unisono dalla cancelliera e dal ministro degli
esteri. Angela Merkel da Berlino, nel corso della consueta conferenza stampa estiva, che
solitamente inaugura la stagione delle ferie. Frank-Walter Steinmeier da Città del Messico, tappa
attuale dell’ennesimo viaggio di lavoro. Di ferie ce ne saranno poche però, visto il precipitare
degli eventi a oriente. La prudenza con cui Berlino ancora una volta invita ad attendere prove
certe prima di individuare responsabili e applicare sanzioni, sembrerebbe ricalcare la posizione
di equilibrio che ha finora contraddistinto il governo di Grosse Koalition nella lunga crisi ucraina.
Ma i due vertici della politica estera tedesca sanno che questa volta, se gli indizi che portano dalle
parti dei separatisti filo-Mosca dovessero essere confermati, sarà necessario trovare il modo di
far capire a Putin che le cose si sono spinte troppo in avanti.
173
L’emozione per i passeggeri del Boeing malese è palpabile, anche per la solidità dei legami con la
confinante Olanda, che ha pagato il tributo di vittime più alto. «Non c’è dubbio che la tensione
nell’Ucraina orientale non si sia affatto allentata nelle ultime settimane, come avevamo
sollecitato», ha ammesso Merkel, «anche se le aree occupate dai separatisti si sono ridotte. Ma
non esiste alcuna alternativa alla faticosa e difficile ricerca di una soluzione politica del conflitto».
La Germania non favorirà alcuna fuga in avanti nell’individuazione dei colpevoli: «Le
investigazioni devono essere affidate a una commissione indipendente», ha aggiunto la
cancelliera pensando ai funzionari dell’Osce, «e il mio governo non intende fare alcuna
dichiarazione prima che siano stati accertati i fatti». I canali diplomatici sono sempre aperti.
Merkel ha parlato a telefono con Putin e ha chiesto che si adoperasse per prolungare il cessate il
fuoco da parte dei separatisti. Cosa che il capo del Cremlino ha puntualmente fatto, lanciando un
appello alle due parti in causa: magari servirà anche a capire quanta influenza abbia ancora
Mosca sugli uomini che combattono in suo nome.
Ma l’atteggiamento di prudenza e attesa è il massimo che Berlino può concedere. Se le
responsabilità ricadranno sui separatisti, come tutto lascia intendere, Putin dovrà sciogliere i
nodi finora lasciati intricati: tagliare il cordone ombelicale con i separatisti, abbandonarli al loro
destino, lavorare seriamente a una de-escalation del conflitto, abbandonare l’idea di una divisione
dell’Ucraina. Il momento più luttuoso e drammatico della lunga crisi a oriente potrebbe
paradossalmente accelerare la fine del conflitto. In caso contrario, assieme all’inasprimento della
guerra e alla prospettiva di una disgregazione dell’Ucraina, anche la Germania sarebbe costretta
ad abbandonare ogni prudenza e a imbarcarsi sul carro di sanzioni economiche sempre più dure.
174
Ma il Cremlino non cederà
Europa, 19 luglio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
A parte l’Ucraina, nessuno osa puntare l’indice senza indugi. Ma a livello internazionale sembra
comunque farsi strada l’idea che la responsabilità dell’abbattimento del volo di linea malese nei
cieli dell’est ucraino - quasi trecento le persone morte - sia tutta dei ribelli filorussi che
controllano una parte delle regioni di Donetsk e Lugansk, nonostante l’offensiva dell’esercito
ucraino abbia ridotto di recente il loro raggio d’azione. Ragionando sulla base della proprietà
transitiva, è evidente che Vladimir Putin diventa il principale imputato di questa storia, da prima
che si producano prove certe, e sempre ammesso che arrivino. D’altro canto il Cremlino ha finora
fornito assistenza indiretta ai separatisti. Così almeno si crede in molte cancellerie occidentali,
alcune delle quali potrebbero essere tenute a dare una risposta alla domanda che nelle loro
opinioni pubbliche si sta già sollevando: punire la Russia.
Insomma, sotto certi aspetti Putin è accerchiato e la credibilità di Mosca, non certo granitica di
questi tempi, è fortemente messa in discussione. Bisogna capire come l’inquilino del Cremlino
reagirà. Se in altre parole cercherà di alleggerire il conflitto in corso in Ucraina, accettando un
percorso negoziale o addirittura scaricando i ribelli filorussi dell’est. Nessuno delle due ipotesi è
scontata, né tanto meno rettilinea. Putin potrebbe pubblicamente condannare i ribelli filorussi,
ma questo non cambierebbe drasticamente il quadro. Da Mosca del resto si tende a sostenere che
gli insorti agiscono solo sulla base delle loro scelte. Non sono eterodiretti, volendo tagliare corto.
Il che significa che se anche Mosca li sconfessasse potrebbero continuare a starsene sulla
barricata.
Quanto al negoziato, c’è da credere che Putin, nel caso in cui la tragedia aerea di due giorni fa
dovesse davvero condurre verso una trattativa, non vorrà chiuderla senza risultati. Attualmente
la discussione è concentrata sull’assetto costituzionale dell’Ucraina. La Russia vuole una
soluzione federale, ma a Kiev temono che questo schema dia all’est del paese prerogative tali da
creare uno stato nello stato. L’alternativa proposta dal presidente ucraino Petro Poroshenko è
un’ampia autonomia. Poco, secondo Mosca. In sostanza il negoziato non dipende solo da Putin,
ma anche da Kiev. Se non altro perché le operazioni militari condotte dall’esercito ucraino,
175
spalleggiato da milizie paramilitari, hanno creato nell’est del paese una voragine economica e
demografica. Sono centocinquantamila le persone che hanno lasciato le loro case e più di
centomila, tra queste, sono riparate in Russia. Numeri che potrebbero pesare, sul tavolo.
Sicuramente a svantaggio di Kiev.
Putin, sull’Ucraina, ha deciso di giocare duro.
È difficile che accetti l’idea che Kiev esca dal “cortile di casa”,
anche se il costo fossero sanzioni aggravate e recessione.
Al di là di questo, non esiste l’ipotesi che vede Putin cedere unilateralmente. Neanche tenendo
conto delle ripercussioni economiche delle sanzioni, che la faccenda del volo malese potrebbe
ulteriormente aggravare, rendendole finalmente incisive. Putin, quando ha deciso di giocare fino
in fondo la partita ucraina, sapeva benissimo che c’erano dei rischi a livello economico. Ha deciso
di correrli. Il fatto è che l’Ucraina è la linea rossa del Cremlino. Il baricentro del paese non può
tendere troppo a ovest, e anche immaginando per assurdo che la questione del Boeing di
Malaysia Airlines lo induca a una clamorosa ritirata, lasciando i ribelli al proprio destino e
cedendo alle proposte negoziali di Kiev e degli occidentali, Putin ha pur sempre carte
importantissime - il gas, il commercio, gli investimenti - con cui condizionare il corso politico
dell’ex repubblica sovietica, inzavorrandolo.
And now, Mr. Putin?
Pagina 99, 21 luglio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
La comunità internazionale si chiede adesso cosa farà il Cremlino dopo l’abbattimento del Boeing
della Malaysia Airlines, dando ormai per scontato che dietro l’accaduto ci siano i separatisti
filorussi coadiuvati da Mosca. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha detto domenica a Kiev
di avere prove inconfutabili sulla responsabilità dei ribelli nell’abbattimento del Boeing malese,
176
senza però specificare quali. Anche il segretario di stato americano John Kerry in mondovisione
sulla Cnn ha puntato l’indice contro i filorussi, ma per ora non si va oltre gli indizi. Con gli occhi
dei satelliti e dei radar di mezzo mondo puntati da mesi sul Donbass forse un po’ poco per il
giudizio definitivo. L’indagine internazionale deve ancora in realtà prendere corpo e il giallo delle
scatole nere sparite e poi ritrovate non è ancora stato davvero risolto. Ma tant’è: il fatto è che,
indipendentemente dalla tragica fine del volo MH17 e da chi ne è responsabile, le carte in tavola
non cambiano comunque più di tanto, se non nel senso di una maggiore pressione, politica e
mediatica, sulla Russia. Le opzioni concrete per la gestione della crisi da parte di Vladimir Putin
rimangono le stesse di prima: supportare in maniera diretta e indiretta la galassia separatista nel
sudest dell’Ucraina oppure lasciare più o meno lentamente la presa, lasciando che la questione se
la sbrighino poi Poroshenko e compagni che avranno comunque un bel da fare nel ricostruire il
Donbass e tenere la periferia saldamente agganciata al centro.
L’Ucraina che esisteva nel novembre 2013, prima che iniziassero le proteste contro l’allora
presidente Victor Yanukovich poi sfociate nella rivoluzione e nel regime change di febbraio non
esiste più. E non si tratta solo dell’annessione della Crimea da parte della Russia. Se il focus
internazionale in questi giorni è in quel lembo di terra nei pressi di Donetsk dove si è schiantato il
Boeing 777 e per un paio di giorni è stata dichiarata la tregua per permettere le operazioni di
recupero, tutt’intorno la guerra in realtà continua e la battaglia infuria vicino a Lugansk, l’altro
capoluogo del Donbass, al confine con la Russia. Qui, da giorni, gli scontri fra insorti e truppe
governative sono aumentati d’intensità. Decine sono i civili morti, coinvolti in una battaglia che si
combatte a colpi di artiglieria pesante. Il governo di Kiev continua a parlare di operazione
antiterrorismo, mentre l’Osce ha annunciato da settimane la necessità di aprire corridoi
umanitari. Le 298 vittime di venerdì scorso si aggiungono semplicemente alle centinaia di altre
che dall’inizio di aprile si registrano nel sudest ucraino.
La vicenda del Boeing è dunque solo un elemento del puzzle, il cui sviluppo può far capire
comunque che direzione prenderà la crisi. Le prossime mosse del Cremlino sono in relazione
anche a quelle di Kiev e dell’Occidente, e cioè degli Stati Uniti in primo luogo. Le indagini della
commissione internazionale sull’abbattimento dell’aereo malese possono diventare il prossimo
terreno di scontro, se non ci saranno chiare evidenze e riscontri precisi che dovrebbero lasciare il
posto alle voci e alle immagini passate su Internet. La Casa Bianca sembra in ogni caso premere
177
per un maggiore isolamento del Cremlino e resta ora da vedere se questo sarà l’atteggiamento
giusto per ammorbidire Vladimir Putin. L’innalzamento dei muri e il gioco degli strateghi a
Washington e Mosca, fra retorica e provocazioni, rischiano non solo di schiacciare subito e
definitivamente l’Ucraina, ma di nuocere a tutti, soprattutto all’Europa.
La partita delle sanzioni
Europa, 22 luglio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
S’era pensato che lo schianto del Boeing malese fosse un evento talmente grave da indurre i
litiganti a mettersi al tavolo per trovare finalmente un’intesa capace di porre fine alla guerra in
Ucraina. Auspicio frustrato. Se mai il disastro aereo ha spinto verso un’altra strada. Molto stretta,
ai limiti del vicolo cieco. Ieri nell’est del paese s’è combattuto duramente a Donetsk, una delle due
città (l’altra è Lugansk) dove si concentra la resistenza dei ribelli filorussi. Si va quindi
configurando lo scenario scivolosissimo dell’assedio. Muovere battaglia in una città non è come
farlo in uno spazio aperto. Viene da pensare, fino a prova contraria, che il presidente ucraino
Petro Poroshenko ha intrapreso questa scelta sfruttando il polverone alzatosi dopo
l’abbattimento del Boeing di linea malese e le conseguenti accuse rivolte alla Russia a causa del
sostegno militare che avrebbe fornito ai ribelli, i presunti responsabili dello strike.
A livello internazionale il Cremlino è sotto pressione: mediatica, politica e potenzialmente anche
economica, se l’Europa dovesse approvare sanzioni più dure di quelle varate finora. Oggi a
Bruxelles si riuniranno i ministri degli esteri dei 28 e si capirà se si fa sul serio e se continuerà
l’approccio guardingo motivato dagli intrecci economici tra Mosca e alcuni paesi chiave
dell’Unione come Germania, Italia e Francia. Hanno evitato di seguire gli americani, che sulle
sanzioni sono stati decisamente più duri. Washington, tuttavia, non ha relazioni commerciali e
finanziarie così strette con i russi. Ciò non toglie che l’economia è il campo principale della
contesa, a livello internazionale. Come reagirà Mosca se l’Ue dovesse irrigidirsi? Putin ha già
messo in conto di incassare il colpo. Il presidente russo persegue l’obiettivo irrinunciabile di
ostacolare l’ancoraggio a occidente dell’Ucraina: una capitolazione storica e strategica, dal suo
178
punto di vista. Per sventarla ha già corso dei rischi, più o meno calcolati, come l’annessione della
Crimea e il coinvolgimento alla ribellione nell’est del paese, sempre negato ma secondo i più
innegabile. Anche le sanzioni economiche fanno parte di questo menu. La Russia attraversa una
congiuntura di crescita lenta, potrebbe persino andare in recessione se l’Ue, la cui tecnologia e i
cui investimenti sono una delle chiavi dello sviluppo russo, dovesse usare la mano pesante.
Putin sa però che il discorso degli schiaffoni economici non è a senso unico. Anche gli europei
potrebbero risentire dell’eventuale irrigidimento verso Mosca, dato che quest’ultima potrebbe
maneggiare l’arma dell’energia. In parte già lo ha fatto. Gazprom ha chiuso i rifornimenti
all’Ucraina. A scaldare Kiev, se l’interruzione andrà avanti anche in inverno, dovranno pensarci il
Fondo monetario internazionale e l’Ue. Il primo impiegherebbe in spese non preventivate una
parte del prestito accordato, in teoria indirizzato alle riforme. La seconda dovrebbe esportare
nell’ex repubblica sovietica il gas che importa dalla Russia. Sempre che Mosca non decida di
bloccare anche i flussi diretti verso l’Unione europea, che nel frattempo sta tentando in ogni
modo di bloccare South Stream, il maxi gasdotto russo che arriverà alle porte di Vienna via
Balcani. Il Cremlino, da parte sua, ha negoziato sull’export di gas un’intesa con la Cina. Come a
dire: abbiamo anche altri clienti. È su questa tela, complessa e fragile, che europei e russi
duellano, cercando al contempo di comporre i rispettivi interessi. Intanto l’Ucraina è sempre più
uno Stato fallito.
Governo in crisi
Pagina 99, 28 luglio
________________________________________________________________________________________________________________
Nel bel mezzo della guerra nel Donbass, in piena crisi internazionale con il muro contro muro tra
Russia e Occidente, in Ucraina non poteva mancare la crisi di governo a dimostrare che l’ex
repubblica sovietica è sull’orlo del tracollo. A differenza però del conflitto nel sudest, spinto dai
separatisti filorussi e in cui Mosca ha lo zampino, il caos a Kiev è tutto farina del sacco interno. E
largamente previsto e prevedibile, sin dai tempi di Maidan, quando era ben chiaro che il trio che
179
guidava la protesta contro Victor Yanukovich non aveva altro in comune che il nemico: per il
resto Arseni Yatseniuk (Patria), Vitaly Klitschko (Udar) e Oleg Tiahnybok (Svoboda) erano leader
di tre partiti che anche in condizioni normali difficilmente sarebbe stato possibile tenere insieme.
Figurarsi in periodo di guerra, con il paese sottoposto a pressioni centrifughe e i poteri oligarchici
a dettare legge. Nessuna sorpresa dunque le dimissioni di Yatseniuk da premier, considerando un
paio di fattori: al governo partecipavano solo due dei tre partiti in questione (Patria e Svoboda),
mentre Udar non aveva nessun rappresentante e Klitschko, alleandosi con il presidente Petro
Poroshenko aveva dimostrato già alla fine l’intesa raggiunta sulla piazza sarebbe stata di corto
respiro; la coalizione era solo parlamentare, in una Rada trasformista non rinnovata dopo la
rivoluzione di febbraio; il primo ministro, leader di una formazione (Fronte del cambiamento,
alleatasi con Patria) che aveva solo il 3% dei consensi ed era in sostanza l’anello debole
dell’alleanza, non aveva il sostegno popolare adeguato, né quello diretto degli oligarchi, né quello
della parte del partito che fa capo a Yulia Tymoshenko (ora in attesa di rientrare in gioco).
Che le dimissioni del primo ministro siano arrivate in questo momento è il segnale che l’Ucraina è
allo sbando: dal punto di vista teorico il governo poteva ancora tenere qualche mese e realizzare
che le riforme che sia premier che presidente hanno promesso e che invece sono rimaste sulla
carta. Il lavoro del parlamento è andato spedito quando si è trattato di fa passare un paio di leggi
che permettessero l’arrivo degli aiuti del Fondo monetario internazionale (18 miliardi di dollari
per due anni, la seconda tranche di 1,5 deve ancora essere confermata), mentre si è incagliato
sulle riforme strutturali. In pratica la coalizione è collassata su se stessa dimostrando per
l’ennesima volta come l’Ucraina non abbia bisogno di aiuti esterni per sprofondare
nell’instabilità. Yatseniuk ha gettato la spugna prendendosela con i suoi alleati, Poroshenko gli ha
chiesto di rimanere, ma intanto gli affari correnti sono passati a Vladimir Groisman, considerato
un fedelissimo del presidente.
Al nuovo blocco di potere, l’alleanza Poroshenko-Klitschko e gli oligarchi a loro vicini (Dmitri
Firtash), le elezioni anticipate possono servire per consolidare la base e alla luce dei primi
sondaggi è facile che ci riescano. Yatseniuk, a meno di sorprese, tornerà nell’ombra, dalla quale
uscirà probabilmente la solita Tymoshenko. I nazionalisti di Svoboda, appoggiati da altri oligarchi
(Igor Kolomoisky) riceveranno filo da torcere da Oleg Lyashko, stella ancora più a destra che
brilla di luce antirussa e che già alle presidenziali ha dimostrato di saper raccogliere l’elettorato
180
estremista. Tutto questo succederà in autunno inoltrato, quando si terranno le elezioni la cui data
deve essere in realtà ancora fissata. Intanto nel Donbass si continua a combattere e i profughi
sono quasi un quarto di milione, secondo i dati delle Nazioni Unite. Sebbene l’Osce e la comunità
internazionale avessero chiesto l’apertura di corridoi umanitari, nulla è stato fatto e a Kiev, dove
il parlamento si riunirà solo giovedì in sessione straordinaria, si discetta di come far tirare avanti
il governo e del prossimo rimpasto.
Nuovi, vecchi padroni
Askanews, 29 luglio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Le dimissioni del premier Arseni Yatseniuk hanno decretato la fine del governo di coalizione in
carica dalla fine di febbraio, sostenuto in parlamento da tre frazioni: Patria, il partito che fa capo a
Yulia Tymoshenko e di cui il primo ministro è entrato a far parte due anni fa insieme con il suo
Fronte del cambiamento, Udar di Vitaly Klitschko e i nazionalisti di Svoboda guidati da Oleg
Tiahnybok.
Le redini del governo sono state affidate ora ad interim a Vladimir Groisman, ex ministro dello
sviluppo regionale e fedelissimo del presidente Petro Poroshenko, in attesa di vedere se nella
seduta straordinaria della Rada che si terrà giovedì ci sarà spazio per ricomporre il puzzle, dato
che tecnicamente la fine del governo non è stata messa agli atti.
Se i margini per il rientro al comando di Yatseniuk sono molto ristretti, la crisi a Kiev, che non ha
nulla a che spartire con quella militare nel Donbass e quella internazionale che coinvolge la
Russia e l’Occidente, ufficializza l’inizio della nuova guerra politica per il controllo dell’Ucraina
alla quale partecipano i soliti noti, sotto vecchie e nuove spoglie. Dopo la cacciata di Victor
Yanukovich e il declino della Famiglia, gli schieramenti oligarchici si sono leggermente modificati,
ma in sostanza le linee corrono lungo gli stessi percorsi antecedenti alla rivoluzione di Maidan,
con blocchi in ascesa e altri in declino.
181
La caduta di Yatseniuk non è l’altro che l’esito dei prodromi di una battaglia che è appena iniziata
e i cui attori principali sono due oligarchi: Petro Poroshenko, diventato presidente a furore di
popolo alla fine di maggio, e Igor Kolomoisky, nominato a marzo governatore della regione di
Dnepropetrovsk dall’allora capo di stato ad interim, Olexandr Turchynov, delfino della
Tymoshenko. Accanto a loro due e alle loro variegate squadre tentano rientrare in gioco o di
rimanere a galla proprio l’eroina della rivoluzione e l’ormai ex padre padrone del Donbass,
l’industriale Rinat Akhmetov.
Non è stata certo una sorpresa che l’eterogenea coalizione sia andata a pezzi dopo poco più di
quattro mesi. Se lo stesso Yatseniuk aveva dichiarato nel giorno del suo insediamento come si
trattasse di un «governo kamikaze», il fatto che la situazione sia precipitata in un momento molto
delicato della crisi, indica però come le forze e gli interessi in campo che hanno mandato a rotoli
anzitempo le intese siglate sul sangue di Maidan siano più forti della necessità di fare fronte
comune. Il duello degli oligarchi è cominciato, adesso si tratta di vedere come proseguirà
l’operazione militare nel Donbass, il cui esito potrebbe pesare in positivo o in negativo sul
risultato dei partiti alle elezioni, e proprio quale sarà l’esito delle elezioni anticipate la cui data
sarà fissata entro il 24 agosto se alla Rada non verrà trovata nel frattempo un’altra maggioranza.
Intanto viene sciolto il governo a Kiev. Ampiamente prevedibile.
In autunno, con le parlamentari, si definiranno i nuovi equilibri del paese.
Gli schieramenti sono in ogni caso già chiari: da una parte c’è Poroshenko, il cui partito
Solidarietà è dato favorito nella tornata elettorale e che potrebbe beneficiare di un ulteriore
bonus se entro l’autunno le acque nel sudest si saranno placate. L’alleanza con Udar sarà in ogni
caso importante per ingrossare la frazione parlamentare alla Rada, nella quale potranno entrare
nuovi, vecchi attori. Il capo dello stato ha anche l’appoggio del blocco oligarchico costituito da
Dmitri Firtash e Sergei Levochkin, ex capo dell’amministrazione presidenziale ai tempi di
Yanukovich. Dall’altro lato Kolomoisky, che già controlla direttamente l’oblast di Dnepropetrovsk
e più indirettamente quelli limitrofi, a partire da quello di Odessa dove come governatore è
arrivato il suo alleato Igor Palitsa, può contare sul sostegno della destra ultranazionalista
182
antirussa, da quella di Tiahnybok a quella in grande ascesa di Oleg Lyashko. Yatseniuk, e per ora
Tymoshenko, sono stati schiacciati dai due blocchi e sarà complicato per i due ex premier
risorgere, a maggior ragione se affronteranno le urne separati. Compito ancora più difficile per
Rinat Akhmetov, che pare destinato a giocare un ruolo molto marginale rispetto a PoroshenkoKolomoisky nella futura Ucraina. Per l’oligarca una volta più potente del paese e secondo Forbes
ancora il più ricco in assoluto qualcuno profila addirittura una fine come quella di Boris
Berezovsky, il nemico numero uno in Russia di Vladimir Putin, costretto all’esilio dorato a
Londra. Akhmetov, a cui è stata fatale sia prima l’alleanza con Yanukovich che poi il
posizionamento anti-Kiev, rischia insomma di stare alla finestra e guadare dal Tamigi, dove
possiede una lussuosa residenza, come sta finendo il suo impero nel Donbass.
Chi sono i capetti del Donbass?
Lettera 43, 31 luglio 2014
________________________________________________________________________________________________________________
L’11 agosto le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk compiono tre mesi di vita. Novanta
giorni sono passati dai referendum per l’indipendenza tenutisi a maggio. Quelli programmati per
l’annessione a Mosca, sul modello della Crimea, sono andati invece persi, un po’ perché lo stesso
Vladimir Putin aveva sconsigliato la cosa, un po’ perché la crisi militare stava già sopravvenendo,
superando quella politica. Denominata Ato dal governo di Kiev, la cosiddetta Operazione
Antiterrorismo è sfociata in un vero e proprio conflitto armato. Novanta giorni di guerra hanno
dimostrato in vario modo il legame tra la galassia separatista ucraina e la Russia, simboleggiato
dai vari leader alla testa sia di alcuni gruppi armati, sia delle nuove strutture istituzionali, o
comunque considerate tali, delle due entità del Donbass che la comunità internazionale non
riconosce.
Durante la prima fase separatista spontanea, quella immediatamente successiva al crollo a
febbraio del regime di Victor Yanukovich, è stato Pavel Gubarev, autonominatosi governatore e
comandante della milizia popolare dopo le prime occupazioni a Donetsk, a guidare il movimento
183
filorusso nel Donbass. Ucraino, panslavista con il cuore a Mosca, Gubarev è sparito però presto
dalla circolazione, arrestato e poi rilasciato dall’Sbu (i servizi segreti ucraini). Al vertice della
Repubblica di Lugansk, lontano dai riflettori dei media internazionali, è arrivato il silenzioso
Valery Bolotov, ma sono stati i due capi della Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin e Alexander
Borodai, a gestire le danze politiche e mediatiche nel Sud Est. Il primo, ufficialmente speaker del
parlamento della Repubblica di Donetsk, è un cittadino ucraino dalle ambizioni politiche frustrate
convertitosi all’indipendentismo in cerca di gloria. Il secondo, con la carica di primo ministro, è
invece un russo che per anni ha affiancato in Crimea Sergei Aksionov, diventato a marzo primo
ministro nella fase del distaccamento della penisola sul Mar Nero da Kiev. Borodai, nazionalista
russo legato apparentemente anche all´Fsb (i servizi segreti russi), sarebbe anche legatissimo a
una delle figure chiave della galassia separatista, vale a dire Igor Girkin (meglio noto con lo
pseudonimo Strelkov), 43 anni, comandante a Sloviansk, una delle roccaforti dei ribelli caduta
solo a inizio luglio.
Borodai e Girkin si conoscerebbero sin dagli Anni 90 quando avrebbero combattuto insieme sia
in Transnistria sia in Bosnia. Il condizionale è d’obbligo visto che le tracce del passato si
confondono tra propaganda e realtà, dai vecchi massacri in Cecenia o nella ex Jugoslavia per
finire a quelli freschi nel Donbass. Quello che è certo è che Strelkov, con un trascorso provato nel
Gru (il servizio segreto militare di Mosca) è considerato un po’ la pistola fumante che prova di
legami tra il Cremlino e la rivolta armata in Ucraina e non per nulla è una delle quasi 100 persone
che Stati Uniti e Unione europea hanno incluso nella lista nera delle sanzioni. Girkin-Strekov è
secondo l’Ucraina il simbolo evidente che dietro la guerra ci sono la Russia e Putin in persona.
Il quadro non è però così semplice e se da una parte anche l’Osce, l’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa, ha identificato nel corso del conflitto almeno sei gruppi
principali e innumerevoli sottogruppi non sempre legati tra loro che combattono seguendo
diverse strategie nel Donbass, anche gli ucraini anti-Kiev continuano a fare la loro parte.
L´esempio più lampante è quello di Alexander Khodakovsky, comandante del battaglione Vostok
e inizialmente ministro della Difesa della Repubblica di Donetsk. Ex comandante del gruppo Alfa,
le forze speciali all’interno dell’Sbu, Khodakovsky era un fedelissimo di Yanukovich ed è stato la
guida per la folta schiera di uomini passati da servizi, forze armate e Berkut (i commando sciolti
dal nuovo governo di Kiev dopo Maidan) da una parte all’altra della barricata, appena dopo il
184
cambio di regime di febbraio. Se è vero dunque, come dice il presidente ucraino Petro
Poroshenko, che l’esercito del suo paese sta fronteggiando mercenari sostenuti dalla Russia, il
movimento separatista, al di là di Strelkov e Khodakovsky, appare molto complesso e sul campo
combattono anche ucraini contro ucraini. In quella che, a tutti gli effetti, ha i contorni di una
guerra civile.
185
10
SANZIONI E CONVOGLI
(agosto 2014)
Le truppe governative cominciano lentamente a guadagnare
terreno nel Donbass, dopo che in precedenza i separatisti erano
riusciti ad allargare il raggio d’azione. La situazione umanitaria si fa sempre più difficile e la Russia
decide di mandare aiuti tra Donetsk e Lugansk. La tensione internazionale aumenta, tra sanzioni e
controsanzioni. Mentre a Kiev Poroshenko e Yatseniuk celebrano la festa dell’indipendenza con il
paese sull’orlo del tracollo politico-economico. La pace è lontana e lo spazio della diplomazia
ristretto, ma dietro le quinte comincia a delinearsi quel compromesso che verrà poi siglato a
settembre a Minsk. Le elezioni parlamentari sono fissate per ottobre.
Convoglio umanitario russo per il Donbass (dall’account Twitter di Shaun Walker, inviato del Guardian)
186
La strage dimenticata
Tmnews, 1 agosto 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Sono passati tre mesi da quel 2 maggio in cui Odessa è diventata suo malgrado il simbolo
dell’Ucraina in preda alla guerra civile. Nel rogo della Casa dei sindacati al Campo di Kulikovo
morirono 42 persone, 35 uomini e sette donne, tutti filorussi, mentre altre sei, pro Kiev, persero
la vita negli scontri avvenuti in pieno centro cittadino, nella zona pedonale di via Deribasovskaya.
La strage di Odessa, diversamente da quella di Maidan a Kiev di febbraio, è però scivolata
ufficialmente nel dimenticatoio. Le indagini sono in alto mare. E la città sul mar Nero, con grande
tradizione multiculturale e di pacifica coabitazione tra etnie, è oggi più divisa che mai.
Le decine di morti in quel rogo di inizio maggio, ignorate allora come oggi dal potere centrale,
rappresentano la spaccatura di un intero paese che, al di là della guerra nel Donbass, ha ferite
molto difficili, se non impossibili da rimarginare in breve tempo. Che le vittime di Kulikovo Pole
siano di serie B è facile capirlo non appena si arriva davanti alla grande piazza dove sorge la Casa
dei sindacati. Qualche mazzo di fiori, niente più cartelli, insegne e fotografie. Dopo alcune
settimane è stato tolto tutto.
Esattamente il contrario di Maidan, diventata con via Grushevsky una sorta di gran cimitero, con
lapidi e monumenti. Le autorità di Odessa hanno invece vietato ogni esposizione, mandando su
tutte le furie gli abitanti, almeno la parte schierata contro Kiev, che vedono i loro morti bistrattati
in confronto a quelli che sono considerati eroi della capitale. «E’ il governo nazista centrale
sponsorizzato dagli americani che ha ordinato così, chi è morto bruciato non vale nulla», dice
Viktor, pensionato veterocomunista sulla sessantina che se la prende sia con il premier Arseni
Yatseniuk che con il nuovo governatore Igor Palitsa, un oligarca vicino a Igor Kolomoisky,
anch’egli oligarca, ma ancora più potente.
Viktor e il drappello filorusso che presidia Kulikovo Pole hanno dato appuntamento per sabato,
quando una piccola manifestazione ricorderà le vittime. Non ci sarà grande folla, la città é divisa
tra minoranze estremiste e la grande maggioranza silenziosa, che nella torrida estate si lascia
portare dal ritmo vacanziero che ha condotto come ogni anno migliaia di turisti da tutta l’Ucraina
sulle sponde del Mar Nero. Anzi, forse più, dato che in Crimea non va ora più nessuno. Che Odessa
187
sia una città spaccata e alla ricerca della verità sulla tragedia che ha acuito la tensione tra la
periferia e il centro lo conferma anche l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite sui diritti umani in
Ucraina. Il documento non si è soffermato solo sugli effetti collaterali del conflitto nel Donbass,
ma ha dedicato ampio spazio ai fatti del 2 maggio. L’Onu ha sottolineato come sulla strage della
Casa dei sindacati siano state aperte ben sei inchieste, dirette da differenti agenzie e istituzioni,
con il risultato che tre mesi dopo il fatto il caos investigativo è completo e a Odessa nessuno si
fida più di ciò che le autorità comunicano, anche perché le informazioni snocciolate dall’inizio
della vicenda si sono mostrate spesso false e contraddittorie.
Il rogo di Odessa, rimasto senza colpevoli,
è una ferita aperta per la storia tollerante e inclusiva della città.
Pesa inoltre sulle dinamiche centro-periferia del paese.
La popolazione di Odessa è in sostanza ancora all’oscuro di tutto ciò su cui si è indagato e il fatto
che il ministero dell’Interno e la Commissione speciale parlamentare abbiano richiesto l’aiuto di
esperti stranieri di mezzo mondo non ha in realtà aumentato la trasparenza e ha aggiunto
confusione. In più, la propaganda mediatica in un senso o nell’altro non aiuta certo a districarsi
nei meandri della verità: è facile quindi intuire come la carneficina del 2 maggio sia polarizzante
sino agli accessi. Per Nastia, giovane ragazza tra i filorussi del Campo di Kulikovo, i morti di
Odessa sono stati ignorati da Kiev come adesso vengono ignorate le vittime civili nel Donbass. E
l’Occidente lascia fare e non dice nulla, complice del presidente Petro Poroshenko, «uno che
bombarda il suo popolo», aggiunge Viktor, secondo cui la guerra potrebbe arrivare sino a Odessa.
In realtà, a parte le frequenti tensioni tra i gruppi estremisti di entrambi i campi, l’episodio della
Casa dei sindacati è rimasto unico. È evidente però il solco che ha scavato anche in una città
tradizionalmente aperta e tollerante come Odessa, come evidente è il differente trattamento che
viene riservato alle vittime.
Persino subito dopo la tragedia al ministro degli esteri tedesco Frank Walter Steinmeier, giunto a
Odessa in missione straordinaria, era stato vietato di apporre una corona di fiori sul luogo della
strage. Questioni di sicurezza, si era detto ufficialmente allora, le stesse che vengono addotte
188
ancora oggi dalle autorità che impediscono agli odessiti filorussi di tenere commemorazioni. Ma
se tre mesi dopo la tragedia del Campo di Kulikovo c’è chi vuole dimenticare in fretta, in altri
cresce un risentimento che non promette facili riconciliazioni.
Le sanzioni al microscopio
Europa, 3 agosto 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Da venerdì sono entrate in vigore le sanzioni varate dall’Unione Europea nei confronti della
Russia, accusata dai paesi comunitari, con toni più o meno acuti, di essere la grande responsabile
della crisi ucraina. Questo a causa del sostegno fornito ai ribelli filorussi insorti nell’est dell’ex
repubblica sovietica, dove Kiev ha avviato a metà aprile un’offensiva senza troppi sconti. In tempi
recenti i combattimenti sono diventati sempre più aspri. Il passo preso da Bruxelles, che così
facendo si allinea a Washington, è serio.
La prima vera decisione, dopo qualche misura ad hoc nei confronti di politici dell’est ucraino e
della stessa Russia, capace di incidere direttamente sull’economia di Mosca. I settori interessati
sono il bancario, le armi e l’energia. Le banche colpite sono cinque, tra cui VTB, Gazprombank e
Sberbank. Quest’ultima è la più grossa del paese. L’obiettivo è limitare l’accesso di questi istituti
al mercato finanziario europeo e limitare al tempo stesso la capacità di dispensare credito in
patria. Sul piano delle armi le aziende europee non potranno esportare, tra le altre cose, prodotti
tecnologici satellitari, motori destinati ai velivoli militari e fucili, oltre a tutti quei prodotti che
possono servire sia a scopi civili che militari. Quanto all’energia, il settore che risulterà
interessato è il petrolifero. La Russia non potrà comprare tecnologia europea: quella che,
fondamentalmente, le permette di gestire e sfruttare i propri giacimenti.
Ma in che misura tutto questo può condizionare l’economia del più grande paese al mondo? Ci
sono due scuole di pensiero. L’una è dell’avviso che i provvedimenti europei sono una severa
frustata che spingerà verso la recessione l’economia russa, che non passa certo il suo periodo
migliore. La crisi globale, a Mosca, ha picchiato duro. Ancora oggi se ne sentono gli strascichi. Il
189
cedimento del 2009, con gli otto punti di Pil persi, è lontano. Ma l’economia non mostra tutta
questa brillantezza. I consumi sono calati, l’industria riscontra ritardi strutturali, la dipendenza
dall’energia è sempre troppo evidente e la crisi ucraina, con tutto il carico di incertezze a essa
legata, sta facendo tagliare le stime sulla crescita, che già negli ultimi anni ha riscontrato una
flessione rispetto al 2010-2011. Dieci giorni fa il Fondo monetario le ha portate dall’1,3% allo
0,2%. L’altra scuola di pensiero segnala che dopotutto le sanzioni, benché sostanziose, non hanno
la forza di mandare la Russia gambe all’aria. In effetti quest’ultima tesi sembra più verosimile,
ammesso che le sanzioni non diventino più aggressive, quando a fine ottobre scadrà il periodo
d’applicazione e Bruxelles farà una verifica. Sono state previste diverse deroghe sui vari fronti
dove i provvedimenti andranno a insistere. A livello bancario le restrizioni europee contraggono
sì la capacità di accedere ai mercati finanziari comunitari, ma non in toto. Le controllate e le
divisioni europee (Sberbank e VTB ne hanno diverse) sono state risparmiate. Non potranno
emettere bond e trasferirli alle case madri, ma sarà loro permesso di erogare prestiti e spostare i
profitti in Russia.
La scelta non è irrilevante, se è vero che, come segnala il Wall Street Journal, queste ramificazioni
vantano asset per oltre 20 miliardi di euro. Oltre a questo c’è da considerare che, spiega sempre il
Wall Street Journal, le banche russe non matureranno così tanto debito nei prossimi mesi. Quindi
le operazioni di rifinanziamento non saranno così difficili da effettuare, anche a fronte delle
sanzioni dell’Unione europea.
Le armi. Qui le conseguenze sembrano più nette. Non tanto a livello di strumenti di guerra in
quanto tali (l’export europeo non vale tutti questi soldi), ma di tecnologie a doppio uso, civile e
militare. L’anno scorso questo mercato ha fatto girare qualcosa come venti miliardi di euro. In
ogni caso, a proposito di deroghe, il mega contratto siglato da Parigi e Mosca nel 2011,
riguardante la consegna di due portaerei Mistral di manifattura francese (il valore è pari a 1,5
miliardi di euro), non è stato messo in discussione, malgrado le proteste americane e britanniche.
L’energia, infine. Se il comparto petrolifero potrebbe risentire delle sanzioni, con ricadute anche
ragguardevoli, dato che la Russia non potrà acquistare tecnologia europea, quello del gas non
viene contemplato nel pacchetto entrato in vigore venerdì. Il che è degno di nota, visto che il gas è
un po’ una cartina di tornasole dei rapporti euro-russi. Mosca ci fa cassa, l’Europa ci si scalda e fa
lavorare le sue fabbriche. In sostanza: c’è mutua dipendenza.
190
Riallargando il quadro, proprio sulla base di questo dato, ci si deve chiedere non solo in che
misura la Russia andrà in difficoltà, ma anche fino a quando l’Europa potrà e vorrà tollerare le
sanzioni che essa stessa ha squadernato. Il punto infatti è che l’Unione europea sta uscendo solo
adesso dalle secche della grande crisi e il ritmo della ripresa è tutto fuorché intenso. Insomma,
bisognerà vedere se, passati i tre mesi durante i quali le sanzioni verranno applicate, i 28 saranno
disposti a continuare su questa strada, chiudendo alle loro aziende un po’ di preziose porte sul
mercato russo (intanto si sentono già i primi mugugni degli amministratori delegati) e
comportando dunque un rallentamento nel rilancio dell’economia. Alcuni paesi stanno già
rivedendo le stime al ribasso. Tra questi la Polonia, colpita dall’embargo russo su verdura e
frutta. Misura che Mosca potrebbe estendere a tutta l’Ue. Di rialzo delle bollette energetiche al
momento non se ne parla. Il Cremlino non vuole il muro contro muro, come forse - certamente? non lo desidera l’Europa.
Le sanzioni faranno male. Ma fino a quando dureranno?
Dipende anche dal fattore “tolleranza”: sia quella di Mosca alle restrizioni,
sia quella dell’Ue al probabile effetto boomerang sulla sua economia.
La soluzione a questa storia, va da sé, passa dall’Ucraina. Il conflitto a est va avanti e la conta delle
vittime e dei danni economici aumenta giorno dopo giorno, perentoriamente. Qualcuno dice che
ciò è quello che Putin cinicamente auspica. Il presidente russo intenderebbe dimostrare che
l’Ucraina è uno stato fallito, con le casse vuote, incapace di controllare il proprio territorio e di
tenere assieme le varie sensibilità del paese. Ma, se davvero così fosse, fino a che punto vale la
pena condurre questo gioco? Putin, già dall’inizio del braccio di ferro ucraino, aveva messo in
conto le sanzioni europee. Sapeva che prima o poi sarebbero arrivate. Ora gli si prospettano due
strade. La prima è lasciare che l’Ucraina resti un grosso pantano e attendere le mosse dell’Europa,
incluso un possibile aggravamento delle sanzioni, dopo ottobre. L’altra è evitare che si arrivi a
questo scenario e negoziare una via d’uscita dalla crisi: sia a livello ucraino-ucraino, con una
trattativa tra Kiev e i ribelli; sia sul piano internazionale. A questo proposito si parla di un piano
segreto russo-tedesco, che prevede la conferma del passaggio della Crimea alla Russia in cambio
191
della garanzia di Mosca sulle forniture (scontate) di gas a Kiev. Vero o no che sia, è scontato che
Angela Merkel ha tutto l’interesse - ricambiato - a trattare con Putin, tentando di sventare uno
scenario di aperta guerra commerciale. La Germania, infatti, pagherà più degli altri il peso delle
sanzioni appena lanciate. Il suo export verso la Russia vale 46 miliardi, più del triplo di quelli
italiano e francese (12 miliardi), quasi otto quello britannico (8 miliardi).
Il potere dei pochi
Lettera 43, 8 agosto 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Nonostante la guerra nel Donbass continui - probabilmente non per molto, se l’esercito ucraino
continuerà ad avanzare a buon ritmo come nelle ultime tre settimane e non ci saranno sorprese
sul versante russo - si può già affermare che la nuova Ucraina è destinata a essere uguale alla
vecchia. Almeno prendendo in considerazione la distribuzione del potere reale nel Paese.
Come prima della rivoluzione di febbraio che ha spodestato il presidente Viktor Yanukovich
erano infatti i vari Rinat Akhmetov, Victor Pinchuk, Igor Kolomoisky e affini a dettare dietro le
quinte le regole della politica e dell’economia, ora la saga dei super ricchi e dei potenti continua,
con i soliti nomi protagonisti. Solo uno non è più in gioco, ed è proprio Yanukovich, capo di Stato
un po’ ingordo diventato scomodo per tutti coloro che prima l’avevano sostenuto e
accompagnato verso la scalata alla Bankova e che poi l’hanno scaricato quando ormai il sangue di
Maidan era versato.
Esiliato forzatamente a Mosca il vecchio presidente, il nuovo quadro di potere dell’ex repubblica
sovietica si presenta sei mesi dopo la rivoluzione esattamente come prima, con gli oligarchi a
gestire il Paese, in nuove o vecchie posizioni.
Le facce sono le stesse, a partire da quella di chi ha preso il posto di Yanukovich e cioè Petro
Poroshenko, settimo uomo più ricco dell’Ucraina secondo Forbes, finanziatore della rivoluzione
arancione del 2004, ministro nel governo di Yulia Tymoshenko e poi in quello di Mykola Azarov.
192
Poroshenko, eletto a furore di popolo a maggio, punta ora alle elezioni parlamentari che si
terranno probabilmente a ottobre per sancire la sua posizione di forza nei confronti degli
avversari di sempre.
Se come pare la cosiddetta operazione antiterrorismo nel Donbass fra qualche settimana sarà
esaurita e i ribelli filorussi rispediti al mittente, Poroshenko incasserà, nell’immediata tornata
elettorale, una vittoria che gli permetterà di avere una maggioranza relativa parlamentare e un
governo più che amico. Gli equilibri in Ucraina si creano e si distruggono, però, in realtà non tanto
in parlamento quanto sottotraccia e il re del cioccolato sembra destinato a non essere l’assoluto
protagonista del nuovo paese: come, infatti, prima di Yanukovich nel gruppo dominante
oligarchico c’era un primus inter pares (Rinat Akhmetov, numero uno secondo Forbes), adesso
con Poroshenko alla Bankova il ruolo principale è ricoperto da Igor Kolomoisky. Se il regno di
Akhmetov in Ucraina è finito, almeno momentaneamente, è scoccata l’ora del governatore di
Dnepropetrovsk, quarto uomo più ricco del Paese.
Nominato a marzo dall’allora presidente ad interim Oleksandr Turchynov al vertice della regione
confinante con il Donbass, Kolomoisky, vuole in sostanza sostituirsi ad Akmetov nel sudest, dove
l’oblast di Donetsk è retto ora dall’oligarca Sergei Taruta. Nella regione chiave di Odessa,
Kolomoisky ha già piazzato al comando un suo uomo fidato, Igor Palitsa. Lo scontro, anche
geografico, con Poroshenko è dunque aperto: se l’oligarca si è già accaparrato il sud, il presidente
può contare a Kiev su Vitali Klitschko, divenuto sindaco della capitale grazie al patto di non
belligeranza firmato per le presidenziali. Dietro i due principali protagonisti ci sono naturalmente
tutti gli altri, vecchia guardia compresa. Così il blocco filorusso vicino a Yanukovich, che ora vede
in prima linea l’oligarca Dmitri Firtash e l’ex capo dell’amministrazione presidenziale Sergei
Levochkin, è schierato in sostanza dalla parte del presidente. Tymoshenko, inoltre, non ha perso
la speranza di rientrare in gioco e molto dipenderà da quanto il suo partito guadagnerà alle
prossime parlamentari: l’ex principessa del gas ed eroina della rivoluzione arancione starà a
guardare il risultato alla Rada per poi cercare di saltare sul carro del vincitore e recuperare
qualche posizione di governo. In definitiva, l’Ucraina, dopo la fine della guerra nel Donbass, dovrà
ricostruire se stessa. Ma a gestire la nuova fase saranno gli stessi di sempre. Non certo una
garanzia di successo.
193
Arrivano i russi
Il Manifesto, 12 agosto 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Il convoglio umanitario organizzato dal governo russo, più di 250 autotreni carichi di aiuti, è in
marcia verso l’Ucraina. Partito dalle porte di Mosca, dovrebbe arrivare nelle prossime ore al
confine con l’ex repubblica sovietica. L’intenzione di Mosca è rifornire le popolazioni civili di
Donetsk e Lugansk, bisognose di tutto. Il confronto militare tra l’esercito di Kiev e le forze
separatiste filorusse, con il primo che attacca e le seconde che resistono, le ha lasciate senza
elettricità, servizi, cibo. Chi non è riuscito a fuggire - il governo ucraino ha aperto dei corridoi, ma
percorrerli è comunque rischioso - sconta sulla propria pelle tutta la durezza di una guerra che,
iniziata a metà aprile, è divenuta sempre più intensa. Dall’inizio degli scontri ci sono state più di
millecinquecento vittime, tra civili e combattenti dell’una e dell’altra parte. Centomila gli sfollati
sul territorio ucraino. Centosettantamila le persone riparate in Russia.
Le ultime dal fronte riferiscono che tra Donetsk e Lugansk, in pratica le ultime due sacche di
resistenza dei ribelli, è la seconda a registrare una situazione più drammatica. Mancano acqua,
elettricità e gas, scarseggia il cibo, piovono continuamente colpi d’artiglieria e lungo le strade ci
sono cadaveri ammassati, riporta il Telegraph, appoggiandosi alle testimonianze di chi è riuscito
a mettersi in salvo.
Ma in queste ore i fari della stampa, più che sul conflitto, sono puntati sul convoglio umanitario
imbastito da Mosca. Sta diventando un vero e proprio caso. La Russia ha spiegato che gli aiuti
sono stati concertati con la Croce rossa internazionale. Che tuttavia ha fatto capire che l’iniziativa
è stata unilaterale, precisando in un comunicato che, benché reputi indispensabile un’operazione
umanitaria nell’est ucraino, intende venire a conoscenza della quantità e della tipologia degli
aiuti, avere garanzie sulla sicurezza del proprio personale e muoversi solo in virtù di un accordo
condiviso da Ucraina e Russia.
Il governo di Kiev ha minacciato di bloccare il convoglio, dal momento che lo percepisce come
una sorta di cavallo di Troia, che cela l’intento di sbarcare oltre confine rifornimenti destinati alle
truppe separatiste, se non quello di intervenire direttamente. Timore condiviso da Stati Uniti,
Europa e Nato, che tra l’altro denuncia l’ammassamento di migliaia di truppe russe alla frontiera.
194
Washington e Bruxelles, da parte loro, ammoniscono che ogni mossa russa non concordata con la
Croce rossa e il governo ucraino è potenzialmente destinata a squadernare nuove, ulteriori
sanzioni. La domanda che tutti si pongono, in questi frangenti, riguarda il tratto di confine dove il
convoglio eventualmente transiterà e il modo in cui gli aiuti verranno portati ai civili di Donetsk
e Lugansk. Kiev ha posto tre condizioni, riferisce il sito della Bbc: la prima è che gli autotreni
passino da una dogana gestita dal governo (i separatisti controllano cento chilometri di
frontiera); la seconda è che il convoglio venga accompagnato da personale della Croce rossa; la
terza è che sia la quantità dei beni forniti che il tragitto effettuato dal convoglio vengano negoziati
a priori.
Una nota diffusa ieri dal ministero degli esteri russo ha comunicato che si sarebbe trovato un
accordo, fondato proprio sulle richieste ucraine. Mosca ha fatto sapere che gli autotreni
transiteranno dalla regione di Kharkhiv e gli aiuti, nella nota dettagliatamente elencati, verranno
indirizzati nelle aree di crisi secondo tragitti stabiliti da Kiev. Il convoglio, una volta superato il
varco doganale, procederà sotto l’egida della Croce rossa. La notizia deve ancora trovare un
chiaro riscontro, ma se le cose andassero così la Russia potrebbe riscuotere punti mediatici
e politici importanti. Il messaggio che potrebbe passare è che Mosca si è dovuta gioco forza
sostituire a Kiev, incapace di assicurare ai civili dell’est la dovuta assistenza. Putin potrebbe
sfruttare la cosa ribadendo la tesi che brandisce non senza cinismo da mesi e mesi: l’Ucraina
è uno stato fallito.
195
L’offensiva
Lettera 43, 22 agosto 2014
________________________________________________________________________________________________________________
La crisi nel Donbass è arrivata ormai a un punto di svolta. La cosiddetta operazione
antiterrorismo iniziata dal governo di Kiev ad aprile ha subito recentemente una notevole
accelerazione. Le truppe governative hanno ripreso il controllo di buona parte delle due regioni
di Lugansk e Donetsk e i due capoluoghi sono sotto assedio da giorni. I filorussi hanno perso
terreno: si sono arroccati in pochi strategici punti e hanno cambiato buona parte della
leadership: i vecchi capi se la sono data già a gambe, sostituiti da personaggi di secondo piano. Il
nuovo comandante Alexander Zakharchenko ha annunciato l’arrivo di rinforzi, ma gli insorti sono
sempre più alle corde.
L’avanzata di Kiev non è stata priva di effetti collaterali e il numero delle vittime dalla fine di
luglio è più che raddoppiato rispetto a tutto il periodo precedente. Secondo le Nazioni unite il
bilancio complessivo è ormai di oltre 2.100 morti, in realtà da correggere verso l’alto, visto che
dai territori controllati dai separatisti è difficile tirare fuori cifre precise. Anche per il numero dei
profughi manca l’esattezza, ma si va nell’ordine delle centinaia di migliaia, se non fino al milione.
Negli ultimi giorni, in concomitanza con il peggioramento della situazione soprattutto nel
distretto di Lugansk, l’emergenza umanitaria è diventata d’attualità non solo per la Russia.
Il braccio di ferro sul convoglio umanitario russo si è risolto con l’iniziativa unilaterale di Mosca
e, se Kiev ha fatto la voce grossa, ha detto comunque che lascerà transitare i camion e non ci sarà
nessun attacco. Gli autotreni devono passare in ogni caso nella striscia di territorio controllata
dai governativi che dal 14 agosto circondano completamente Lugansk.
La strategia è chiara da entrambe le parti: il Cremlino vuole stoppare l’offensiva ucraina, la
Bankova vuole chiudere la partita con i separatisti il più velocemente possibile e dare la spallata
finale, anche se il prezzo sarà alto. Nel braccio di ferro la propaganda gioca un ruolo
fondamentale e alla Russia l’Ucraina risponde per le rime. Gli episodi più recenti, dallo
sconfinamento di colonne di militari russi distrutte appena varcata la frontiera ai
bombardamenti di civili, fanno parte della guerra mediatica che si combatte tra Mosca e Kiev, ma
pure tra il Cremlino e l’Occidente.
196
Altra benzina sul fuoco è in arrivo, dopo che si è venuto a sapere che tra le vittime nelle fila del
battaglione filogovernativo Donbass, uno dei tanti sostenuti con il denaro dei gruppi oligarchici,
vi è stato un mercenario americano.
Anche la gazzarra sugli autotreni russi visti come cavalli di Troia non è stata altro che una
puntata della cinica telenovela trasmessa alla faccia di buona parte degli abitanti di Lugansk,
almeno quelli rimasti, che da due settimane non hanno acqua corrente ed energia elettrica: il
punto fondamentale non è stato tanto il timore che i tir portassero altri lanciarazzi ai separatisti,
quanto il fatto che con una pausa umanitaria l’offensiva avrebbe perso di slancio. Negli ultimi 10
giorni l’esercito ucraino ha cercato di dare la spallata definitiva.
Gli sviluppi recenti dimostrano che i ribelli non possono resistere ancora a lungo: se il piano di
Mosca fosse stato quello di prolungare la resistenza filorussa o invadere il Donbass questo
sarebbe già successo. Ma il punto è un altro: Vladimir Putin non ha certo come priorità quella di
far marciare il suo esercito fino a Donetsk e i 280 camion arrivati non stracolmi servirebbero per
trasportare indietro un po’ di materiale e di uomini attraverso i varchi di confine ancora
controllati dagli insorti. Si è arrivati quindi alla fase cruciale: i separatisti sono sulla via della
sconfitta che potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana, se non ci saranno sorprese. La
diplomazia internazionale è al lavoro proprio per evitarle.
Se l’incontro di Berlino tra i ministri degli Esteri di Ucraina, Russia, Germania e Francia non ha
condotto a molto, anche da questo punto di vista i movimenti indicano che le trattative per uscire
dal tunnel si sono intensificate. Sabato 23 agosto la cancelliera tedesca Angela Merkel è attesa
direttamente a Kiev per la prima volta dall’inizio della crisi e poi a Minsk è in programma il
secondo faccia a faccia tra il presidente ucraino Petro Poroshenko e Putin dopo quello di giugno
in Normandia. Poi il capo di Stato dell’Ucraina sarà a Bruxelles al vertice Nato in Galles. La
Bankova ha tutto l’interesse nel terminare velocemente e vittoriosamente la campagna nel
Donbass per arrivare con un bonus alle elezioni parlamentari anticipate che probabilmente si
devono tenere in ottobre e incassare una vittoria per rafforzare il controllo sul governo e
stabilizzare il paese. Ma per raggiungere questi obiettivi sul breve periodo, Poroshenko non può
fare a meno di Putin, con cui in ogni caso il duello proseguirà al di là del destino del Donbass.
197
Festa triste a Kiev
Lettera 43, 24 agosto 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Il 24 agosto 1991 la Rada, il parlamento ucraino, dichiarava l’indipendenza da Mosca che sarebbe
stata confermata con il referendum popolare del 1° dicembre. Allora la stragrande maggioranza
degli ucraini (90,32%) si espresse per il distacco dal Cremlino. In tutte le regioni del paese la
percentuale dei cittadini in favore dell’indipendenza fu al di sopra del 75%, senza grosse
differenze tra Nord e Sud o tra Est e Ovest. Solo in Crimea la percentuale fu del 54%, con una
spaccatura più evidente tra chi voleva imboccare una via propria e chi seguire ancora quella
russa. A 23 anni dallo storico passo, l’Ucraina celebra un anniversario dal sapore amaro, partendo
dal fatto che un altro referendum, quello tenuto in Crimea il 16 maggio, ha sancito di fatto la
separazione della penisola sul Mar Nero. Poco importa che la consultazione popolare, pilotata dal
Cremlino dopo l’occupazione manu militari delle forze filorusse, non sia stata riconosciuta dalla
comunità internazionale.
La sovranità ucraina è stata ferita in maniera indelebile e a Kiev come altrove poco si può fare di
fronte alla zampata dell’orso russo. Rispetto alle celebrazioni del 2013, avvenute in sordina
durante la presidenza di Viktor Yanukovich con il duello tra Unione europea e Russia sulla firma
dell’Accordo di associazione ormai in atto, l’Ucraina ha cambiato non solo faccia politica e
geografica, ma si è infilata in un tunnel dal quale, anche se presto emergerà, rimarrà comunque
segnata per qualche lustro. La guerra nel Donbass, indipendentemente da come vada a finire, è
destinata a rimanere in ogni caso uno spartiacque nella ricostruzione del rapporti tra centro
(Kiev) e periferia (Lugansk e Donetsk prima di tutto, ma non solo) nella nuova Ucraina che deve
far fronte a cambiamenti fondamentali per non rischiare di diventare un classico failed State, vale
a dire uno Stato fallito.
La breve storia dell’Ucraina dal 1991 a oggi è stata segnata da piccoli e grandi terremoti che ne
hanno minato la stabilità. A reggere le sorti del Paese è stato per oltre due decenni un sistema
politico-oligarchico che ha fagocitato le risorse dello Stato, lasciando la gran parte della
popolazione alla finestra: un quarto dei cittadini vive in sostanza al di sotto della soglia di povertà
(dato del 2010). Dopo il distacco da Mosca e la breve parentesi sotto la presidenza di Leonid
198
Kravchuk, è stato Leonid Kuchma (1994-2004) a gestire le danze interne e quelle tra Russia e
Occidente, badando a conservare gli equilibri con un occhio soprattutto per la propria
sopravvivenza. Gli attori sul palcoscenico caratterizzato da corruzione e cleptocrazia sono da
allora gli stessi, con l’aggiunta di quelli arrivati successivamente solo per motivi generazionali,
legati però ai soliti e consolidati poteri forti.
La rivoluzione del 2004, che in Ucraina è stata denominata «la rivoluzione dei milionari contro i
miliardari», ha dato l’illusione in Occidente che l’ex Repubblica sovietica potesse staccarsi dai
fantasmi del passato. Ma in breve tempo i vincitori Viktor Yushchenko e Yulia Tymoshenko sono
naufragati, rimanendo aggrappati alla barca sino al 2010. Poi l’arrivo di Yanukovich, delfino di
Kuchma che nel 2004 era stato accusato di ogni nefandezza, ha sancito il fallimento del
movimento arancione, spazzato via proprio da chi l’aveva fatto trionfare alle urne. Cioè gli
ucraini. Gli stessi che tre anni dopo, cioè alla fine di novembre 2013, hanno avviato un’altra fase
rivoluzionaria nella storia del paese.
Il resto è cosa recente: un cambio di regime macchiato di sangue e avallato dall’Occidente, la
reazione russa con l’annessione della Crimea e il conflitto nel Donbass. Il presidente Petro
Poroshenko, il quinto dall’indipendenza, ha sicuramente il compito più difficile rispetto ai suoi
predecessori: quello di tenere insieme un paese che è vicino a sfaldarsi. Nei piani del capo dello
Stato c’è la chiusura nella campagna nel sudest a breve, la vittoria alle elezioni parlamentari
anticipate con un blocco presidenziale che possa gestire la maggioranza alla Rada e l’avvio di
quelle riforme costituzionali e strutturali che ogni inquilino della Bankova ha promesso senza
realizzarle. Questa volta, però, c’è in ballo la tenuta stessa dell’Ucraina che, schiacciata tra Russia
e Occidente, rischia di implodere e di festeggiare a brandelli i prossimi anniversari.
199
Il difficile dopoguerra
Lettera 43, 27 agosto 2014
________________________________________________________________________________________________________________
L’incontro di martedì 26 agosto a Minsk tra il presidente ucraino Petro Poroshenko e quello
russo Vladimir Putin ha aperto lo spiraglio perché la crisi ucraina possa ancora avere una
soluzione politica e l’escalation militare lasci lo spazio al necessario dialogo per raggiungere la
pacificazione nel Donbass. I due leader si sono trovati più o meno d’accordo su una road map che
porti a passi veloci verso il cessate il fuoco e a una tregua duratura, ma le posizioni di Kiev e
Mosca rimangono sostanzialmente lontane.
Al di là dei buoni propositi - già per altro messi sul tavolo delle trattative nei vertici di Ginevra ad
aprile e di Berlino a luglio, quando sono stati non i capi di Stato, ma i ministri degli Esteri a
tentare il compromesso sotto la supervisione dell’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa - fino a ora si sono visti pochi passi concreti verso la de-escalation. Da
una parte la Russia, respingendo a parole le accuse di voler destabilizzare l’ex repubblica
sovietica foraggiando i separatisti, di fatto ha esercitato solo a singhiozzo la propria influenza per
scoraggiare i ribelli e gli episodi degli ultimi giorni hanno indicato un’intensificazione del
coinvolgimento russo. Dall’altra parte l’Ucraina solo sulla carta si è adoperata per il dialogo e ha
optato da subito per la risoluzione militare della crisi, mettendo in conto l’emergenza umanitaria
che tra Donetsk e Lugansk, che è ormai passata in secondo piano nonostante l’allarme lanciato da
settimane da Croce Rossa Internazionale e Osce. Ma anche vedendo il bicchiere mezzo pieno e
scorgendo all’orizzonte l’esaurimento del conflitto armato nel Donbass, entro qualche settimana
e prima delle elezioni parlamentari del 26 ottobre, la pacificazione del sudest ucraino non
coinciderà certo con la fine dei problemi, sia quelli interni ucraini, sia quelli tra Kiev e Mosca e
Russia e Occidente.
Ecco i rebus aperti in Ucraina. Il Donbass, con gli oblast di Donetsk e Lugansk, rimarrà a lungo
una brutta gatta da pelare per Kiev, anche se sarà trovata una soluzione per una maggiore
autonomia regionale, decentramento o federalizzazione che dir si voglia. Le ferite sociali,
economiche e politiche apertesi tra periferia e centro non saranno certo rimarginate con un
cambiamento costituzionale, se e quando arriverà. Governo e presidente hanno definito
200
«operazione terroristica» una guerra che vede sì in campo forze filorusse legate in qualche modo
a Mosca, ma buona parte di chi combatte nel Donbass è costituita da ucraini. La definizione di
«guerra civile» non è quindi molto lontana dalla realtà. L’élite politica ed economica della regione
non è certo schierata senza se e senza ma con Kiev e la ricerca di un equilibrio tra le esigenze
locali e quelle nazionali continuerà per un pezzo, anche perché la vicinanza geografica alla Russia
implica, per forza di cose, il raggiungimento di un compromesso, a meno che non si voglia tirare
la corda fino a che si spezzi.
Il Cremlino, anche se taglierà definitivamente il cordone ai separatisti lasciandoli affondare più o
meno lentamente, sarà pronto a intervenire nuovamente con i soliti mezzi poco ortodossi.
Ammesso e non concesso che Poroshenko trovi la giusta misura per uscire dal ginepraio del Sud
Est, a Kiev lo aspettano i problemi di sempre.
Putin e Poroshenko si incontrano ancora. Sembra emergere l’ipotesi tregua.
Ma, se anche le armi tacessero, la soluzione del rebus ucraino resta lontana.
Il sistema politico ucraino è sostanzialmente marcio, il Paese sull’orlo del tracollo economico.
Solo il supporto occidentale ha consentito sino a ora di non sprofondare, ma i guai interni
l’Ucraina deve risolverli da sola. Gli oligarchi continueranno a fare il bello e il cattivo tempo come
hanno fatto sinora, il cancro della corruzione è impossibile da estirpare. Le rivoluzioni hanno
fatto rotolare qualche testa, ma il paese non è cambiato. Le elezioni di ottobre possono portare
una rinfrescata, ma senza riforme strutturali, politiche ed economiche, la stabilità sarà difficile da
raggiungere e l’Ucraina continuerà la sua transizione cominciata con l’indipendenza da Mosca nel
1991 e di fatto non ancora terminata. Destinazione ignota.
Accanto ai rebus interni, ci sono quelli internazionali, vale a dire i rapporti da definire con la
Russia da una parte e l’Occidente dall’altra, che al momento si estrinsecano fondamentalmente in
due questioni, quella del gas e quella dell’implementazione dell’Accordo di associazioni che Kiev
e Bruxelles hanno firmato a giugno e che il parlamento ucraino deve a dire il vero ancora
sottoporre a processo di ratifica.
201
I problemi naturalmente sono collegati e, come dimostrano gli ultimi 20 anni, le soluzioni
definitive sono impossibili. Il nodo impellente è quello del gas, non fosse altro perché senza un
compromesso nel braccio di ferro tra Russia e Ucraina anche l’Europa potrebbe finire congelata.
Un accordo sulla revisione dei contratti, con un prezzo accettabile per entrambe le parti e il
pagamento degli arretrati, farebbe scongiurare il pericolo di una guerra per un paio d’anni, ma
senza una cornice adeguata il quadro crollerebbe alla prossima puntata. Per trovare un equilibrio
interno duraturo e diventare davvero quel ponte tra Russia ed Europa a cui di fatto la obbliga la
sua posizione geografica, l’Ucraina deve insomma prendere decisioni sì radicali, considerando
però il fatto che uno spostamento da un lato implica una reazione dall’altro. Se Poroshenko e il
futuro nuovo governo saranno in grado di farlo, è tutto da vedere: il rischio è che se il ponte viene
costruito su un solo pilastro, crolli in fretta trascinando con sé tutto il paese.
Il calcio ai tempi della rivoluzione
Il Manifesto, 29 agosto 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Nel derby di Crimea ha prevalso il Fk Skchf di Sebastopoli. Ha rifilato un secco due a zero al Fk
Tsk di Simferopoli. La Zhemchuzhina Yalta, altro undici dell’ex penisola ucraina, ha invece perso
contro il Sochi. Sempre di due a zero, al fischio finale, il risultato. Erano partite di coppa. Si sono
giocate il 12 agosto e hanno sancito l’esordio nel contesto calcistico russo di queste tre squadre
della Crimea, che in campionato partiranno dalla terza serie. Tutte con una rosa di atleti dal
passaporto appena cambiato, da ucraino a russo. Nel caso dei team di Sebastopoli e Simferopoli,
pure con nuove denominazioni. Ovviamente russificate. Le precedenti erano FC Sebastopoli
(l’attuale acronimo Skchf sta per «club sportivo della flotta sul Mr Nero») e SC Tavriya
Simferopoli. La Zhemchuzhina Yalta ha potuto conservare il nome, dato che era già russo.
Zhemchuzhina significa perla.
Tutto questo per dire che il calcio segue ancora una volta gli spostamenti di confine, più o meno
opinabili che siano. La Crimea è ora parte della Russia, e queste squadre ne seguono il destino. La
202
loro ammissione alla federazione russa è stata votata a Mosca, l’11 agosto, durante una dibattuta
riunione della federcalcio. Citando un’inchiesta della Novaya Gazeta, una delle ormai poche
testate non allineate al Cremlino (ci lavorava Anna Politkovskaya), il New York Times ha
riportato che qualcuno, in quell’occasione, ha espresso il timore che l’amissione delle squadre di
Crimea nella famiglia calcistica russa avrebbe procurato grattacapi di ordine finanziario.
Del tipo che la Uefa, presso cui la federazione di Kiev ha protestato contro il «furto» delle
formazioni crimeane, sarebbe in potere di escludere le squadre russe dalle competizioni europee.
Che, come noto, assicurano introiti importanti. Un’altra perplessità emersa nell’incontro ha
riguardato i mondiali del 2018. Si terranno in Russia, ma la crisi ucraina, con i suoi addentellati
calcistici, potrebbe condurre addirittura alla revoca. Se la Russia perdesse i mondiali andrebbero
in fumo contratti lucrosi sui quali gli oligarchi che fanno parte del gotha calcistico moscovita
hanno senz’altro messo già gli occhi, se non le mani.
In ogni caso l’11 agosto è passata la linea dura: Crimea alla Russia, anche calcisticamente. Quanto
a Uefa e Fifa, la prima s’è finora limitata a disconoscere l’ufficialità dei match delle tre squadre
crimeane (una misura tutt’altro che graffiante) e la seconda non ha messo in discussione
i mondiali del 2018. Intanto Putin ha appena battezzato la Otkrytie Arena di Mosca, uno degli
stadi che ne ospiteranno le partite. Com’è intuibile questa non è l’unica, complicata storia di
pallone che sgorga dalla vertenza ucraina. Prendi lo Shakhtar Donetsk, la blasonata formazione
presieduta da Rinat Akhmetov, il più ricco degli oligarchi dell’ex repubblica sovietica. Il
campionato è cominciato e lo Shakhtar è in testa alla classifica, come spesso capita da qualche
anno a questa parte. Ma la novità è che non gioca a Donetsk, dove la Donbass Arena, il suo catino,
è appena stato sfregiato dagli ordigni.
La guerra ha costretto la corazzata di Akhmetov a cambiare momentaneamente domicilio. S’è
accasata dall’altra parte del paese, a Leopoli. Il che suona un po’ paradossale, visto il precedente
sodalizio politico tra l’ex presidente Yanukovich (bollato come filorusso) e Akhmetov (ora
passato felpatamente dalla parte di Kiev), e tenuto conto del fatto che Leopoli è il centro di
irradiazione dell’idea nazionale-nazionalista di Ucraina, nonché la roccaforte di Svoboda, partito
saldamente ancorato a destra che sulla Majdan s’è dato molto da fare. Ma tant’è. Il Bleacher
Report, testata sportiva americana dal respiro globale, segnala comunque che la gente di Leopoli
sta un po’ snobbando le partite dell’undici di Donetsk. Un’altra squadra della metropoli dell’est,
203
che resta sempre sotto il controllo dei ribelli filorussi, è trasmigrata a causa del conflitto. Si tratta
dell’Olympia, promosso l’anno scorso in prima serie. Gioca a Kiev. Sempre nella capitale è di
scena lo Zarya Lugansk, l’altra città dell’est dove ribelli e governativi si sparano addosso da
mesi. Come Akhmetov, anche il presidente del Metalist Kharkhiv, Sergei Kurchenko, neanche
trent’anni, ma già ricco sfondato, era legato a Yanukovich. L’Europa ha bloccato i suoi conti
all’estero, Kiev ha congelato i beni del Metalist: dalla quote societarie allo stadio. Un altro caso in
cui calcio e crisi, nell’Ucraina lacerata, viaggiano a braccetto.
Unica soluzione: il compromesso
Linkiesta, 29 agosto 2104
________________________________________________________________________________________________________________
Invasione o incursione? Operazione antiterrorismo o guerra? Catastrofe umanitaria o inevitabili
effetti collaterali sulla popolazione civile? La crisi ucraina si gioca molto sulla prospettiva e sulla
propaganda. Gli ultimi giorni sono stati da questo punto di vista esemplari: prima le parole di
pace sussurrate al vertice di Minsk, poi l’annuncio dell’aggressione su larga scala da parte delle
truppe di Mosca. Da una parte si racconta che i paracadutisti russi catturati in territorio ucraino
hanno sconfinato per errore e che accanto ai separatisti combattono militari che invece di fare le
vacanze al mare arrivano in Ucraina per combattere per l’indipendenza della Nuova Russia.
Dall’altra la Nato fornisce foto satellitari che sembrano uscite da un B-movie bellico degli anni
Ottanta, vecchie per giunta di una settimana. Nessuno si preoccupa di ciò che succede a Lugansk,
giunta al ventottesimo giorno senza acqua corrente ed energia, nonostante il costante allarme
dell’Osce e della Croce Rossa Internazionale, imprigionate fra i due fuochi.
Dopo che ieri mattina il presidente ucraino Petro Poroshenko ha annunciato l’invasione, alla sera
è arrivato il contrordine: «La situazione è molto difficile, ma è sotto controllo». Parole uscite
durante la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale sugli sviluppi nel sudest del
paese. Il capo di stato non ha parlato direttamente di aggressione russa su larga scala, ma ha
affermato solo che mercenari e militari regolari hanno lanciato un’offensiva contro le truppe
204
governative. La battaglia più dura infuria a Ilovaisk, alle porte Donetsk, dove l’esercito di Kiev è in
difficoltà, per ammissione stessa del presidente, a causa dell’abbandono delle posizioni da parte
di due unità. Diserzioni, in altre parole. Da Mosca si è fatto sentire anche Vladimir Putin che con
un messaggio sul sito presidenziale ha invitato Kiev a sedersi al tavolo delle trattative con i
rappresentanti del Donbass, ribadendo che la crisi nel sudest non deve essere risolta con mezzi
militari e la via deve essere pacifica. Il Cremlino si è appellato anche ai separatisti perché aprano
corridoi umanitari nelle zone dove l’esercito ucraino, come a Ilovaisk, rischia gravi perdite. E il
capo dei ribelli Alexander Zakharchenko ha detto di voler obbedire subito agli ordini. Messaggi
trasversali per la Bankova, da tre giorni assediata da manifestanti che protestano contro i vertici
politici e militari accusati di aver mandato l’esercito alla sbaraglio.
Putin fa insomma un favore a Poroshenko, ma si aspetta qualcosa in cambio. Intanto Stati Uniti ed
Europa a scanso di equivoci si preparano a un altro giro di sanzioni, inutili: visto a cosa sono
servite quelle comminate sinora. Cosa succede in realtà, e soprattutto, come se ne esce?
Le posizioni di Russia e Ucraina sono ancora divergenti. Da una parte Mosca non molla l’osso e
vorrebbe congelare il conflitto, cioè assistere i separatisti, che non sono targati esclusivamente
Cremlino, ma sono una complessa galassia russo-ucraina sorta dal vecchio blocco di potere nel
Donbass che faceva riferimento all’ex presidente Victor Yanukovich, e continuare a destabilizzare
l’Ucraina che guarda a Occidente. Il segnale non è diretto solo a Kiev, ma soprattutto verso il
principale sponsor del governo uscito dalla rivoluzione di febbraio, cioè gli Stati Uniti. Dall’altro
lato la Bankova insiste sulla soluzione militare che non solo si è fatta sempre più problematica sul
campo, ma i cui costi umanitari si sono impennati nelle ultime settimane.
Mentre però in Russia la popolarità di Putin è salita alle stelle e la crociata nazionalista ha
rinserrato le fila, in Ucraina Poroshenko naviga in acque agitate, la maggioranza di governo è
andata in pezzi e le elezioni anticipate di ottobre sono un’incognita legata appunto al prosieguo
della campagna nel Donbass. Un rapido successo potrebbe far volare il presidente e i suoi alleati,
se invece il conflitto si trascinasse ad approfittarne sarebbero gli estremisti nazionalisti e
antirussi tipo Oleg Lyashko, già sorprendente terzo alle presidenziali di maggio.
Per evitare l’annunciata catastrofe, considerando anche che il paese non è ancora sprofondato
solo grazie agli aiuti della comunità internazionale, la via d’uscita non è che quella del dialogo con
205
la Russia e con i separatisti e il raggiungimento di un compromesso sullo status del Donbass. Il
rischio è enorme, visto che larga autonomia o federalizzazione possono costituire i prodromi per
una successiva separazione, ma l’alternativa, con Mosca che ha dimostrato di essere pronta a
tutto, è il tracollo a breve termine.
206
11
TREGUA FRAGILE
(settembre 2014)
Due sono gli eventi fondamentali che dopo l’estate rovente fanno
pensare a un allentamento della tensione. Da un lato l’intesa a
Minsk sotto la regia di Petro Poroshenko e Vladimir Putin, che stabilisce in sostanza la tregua nel
Donbass. Dall’altro, la ratifica dell’Accordo di associazione tra Kiev e Bruxelles, la cui entrata in
vigore viene però rimandata all’inizio del 2017 con il consenso anche di Mosca. La situazione in
Ucraina è comunque sempre precaria e con l’acqua alla gola su tutti i fronti ci si prepara alle
elezioni per il rinnovo del parlamento fissate per la fine di ottobre.
Volontari ucraini al fronte (Bo Svoboda / Wikipedia, Picasa)
207
Poroshenko senza alternative
Lettera 43, 2 settembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Nonostante l’escalation militare e le accuse alla Russia di essere passata dalla guerra ibrida a
quella aperta, anche se non dichiarata, proseguono gli sforzi diplomatici per arrivare a una tregua
nel sudest dell’Ucraina, dove ancora si combatte e l’apertura del fronte meridionale a Novoazovsk
ha messo in allerta Kiev che teme un ulteriore allargamento del conflitto sulla direttrice DonbassCrimea. Il 26 agosto a Minsk si è riunito il gruppo di contatto, che per oltre quattro ore ha
discusso a porte chiuse i possibili scenari. Se poco o nulla di ufficiale è trapelato alla fine dei
colloqui destinati a proseguire il 5 settembre, la presenza al tavolo delle trattative dei separatisti
filorussi è comunque un segnale da non sottovalutare sulla via del possibile compromesso. Oltre
infatti all’ex presidente ucraino Leonid Kuchma, all’ambasciatore russo a Kiev Mikhail Zurabov e
alla diplomatica svizzera Heidi Tagliavini, in rappresentanza dell’Osce, l’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa, due leader ribelli sono arrivati in Bielorussia, grazie anche
alle pressioni del Cremlino: Andrei Purgin, il vice primo ministro dell’autonominatasi Repubblica
popolare di Donetsk, e Alexei Kariakin, presidente del consiglio di Lugansk. L’uno informatico e
l’altro meccanico.
I due hanno consegnato un documento con le loro richieste tra le quali ci sarebbe la discussione
sul futuro status delle regioni occupate: la domanda è quella di un’ampia autonomia, ma non
dell’indipendenza totale da Kiev. In sostanza il piano del Cremlino che, al di là delle sparate di
Vladimir Putin sulla possibilità di arrivare a conquistare Kiev in due settimane, prosegue la sua
strategia di destabilizzazione senza preoccuparsi troppo della minaccia di nuove sanzioni da
parte di Unione Europea e Stati Uniti e delle iniziative della Nato sul fronte orientale.
Dal punto di vista di Kiev la situazione attuale pare essere senza speranza: i proclami del
presidente Petro Poroshenko e del premier Arseni Yatseniuk di una vittoria alle porte si sono
rivelati illusori non appena Mosca si è messa veramente a sostenere i separatisti. Nel giro di una
settimana le posizioni si sono ribaltate e l’impotenza ucraina deve ora fare i conti con gli appetiti
russi. Negli scorsi sei mesi, già a partire dall’insediamento a fine febbraio del governo postrivoluzionario, Kiev ha promesso autonomia e decentramento a piè sospinto senza però fare
208
nulla, né i referendum evocati ad aprile da Yatseniuk e dall’allora capo di Stato ad interim
Olexandr Turchynov, né le modifiche costituzionali promesse da Poroshenko a maggio.
La strategia è stata invece quella dell’operazione militare per riconquistare le regioni ribelli. Il
messaggio è arrivato chiaro sia nel Donbass sia a Mosca, con le conseguenze attuali. Il Cremlino
sembra avere l’intenzione di congelare il conflitto per costringere l’Ucraina a piegarsi verso un
decentramento - ancora tutto da definire nei tempi e nei modi - che pare l’unica via d’uscita per
stoppare una guerra che Kiev non può vincere. Senza contare il fatto che la situazione umanitaria
nelle due regioni interessate diventerebbe ancora più drammatica. Per non perdere ora e
definitivamente il Donbass, Poroshenko deve negoziare con Putin la via d’uscita meno lacerante e
comunque a scatola chiusa, dato che federalizzazione oggi potrebbe significare secessione
domani. Il presidente, in vista delle elezioni parlamentari di ottobre, ha però necessariamente
bisogno di sfoderare qualche successo, o presunto tale: lo può ottenere solo con la diplomazia,
non con le armi. E sempre che Putin non abbia altri piani per la testa.
L’alternativa è quella di infilarsi in un tunnel nel quale il Paese non potrebbe resistere a lungo,
alla luce del ventaglio dei problemi impellenti che pesano come macigni, da quello del tracollo
economico interno a quello del gas che toccherà l’Europa se non verranno trovati accordi
soddisfacenti. L’Occidente, con Stati Uniti ed Europa che non ingaggeranno un conflitto militare
diretto con la Russia, ha altrettanto poche opzioni. Il muro contro muro con la Russia e la via della
sanzioni non hanno condotto di fatto a nulla: se l’obiettivo era infatti quello di far inserire la
retromarcia al Cremlino, il risultato è stato opposto. La situazione di oggi è da ricondurre
insomma non solo a quella che a Ovest si definisce come la nuova volontà imperialistica di Putin,
ma sia alla strategia che Washington e Bruxelles hanno adottato nell’ultimi tre lustri nei confronti
dell’Ucraina, sia alla scarsa capacità di valutazione sulle possibili e in larga parte prevedibili
reazioni russe. I negoziati, anche quelli sottotraccia, come quelli recenti in Finlandia tra Russia e
Stati Uniti, sono in definitiva l’unica via perché la crisi ucraina possa rientrare. Poi ci saranno
comunque da raccogliere i cocci per lungo tempo.
209
Chi sta vincendo?
Pagina 99, 6 settembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Tregua. Non pace. L’intesa siglata a Minsk ha messo a tacere le armi, almeno ufficialmente, da
quando cioè il presidente ucraino Poroshenko e i comandanti militari delle repubbliche
separatiste hanno ordinato venerdì pomeriggio il cessate il fuoco nel Donbass. Ma non tutte le
parti in campo sembrano attenersi agli accordi. Normali scaramucce o prodromi dell’occupazione
definitiva russa del Sudest ucraino? Si vedrà, presto. Così come se la tregua si trasformerà
appunto in pace. Quello che è certo, ora, è però che la situazione rimane altamente instabile,
anche perché non si conoscono i dettagli di ciò che è concordato in Bielorussia, né tantomeno
quanto Poroshenko e Putin hanno discusso dietro le quinte alla vigilia del vertice, che in realtà ha
dovuto solo mettere nero su bianco, con qualche tinta grigia, le linee dettate dai due capi di Stato.
Do ut des, è questo il principio che ha retto i rapporti politico-economici tra Russia e Ucraina negli
ultimi vent’anni. In tempi di guerra la regola non fa eccezione. Di più: il piano uscito dai negoziati
tra gli inviati di Kiev, Mosca e dei ribelli è strutturato su 12 paragrafi, almeno come ha detto Heidi
Tagliavini, inviata speciale per l’Ucraina dell’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa. I separatisti hanno parlato invece di 14. Da Mosca si è fatto sentire solo il
portavoce di Vladimir Putin, Dimitri Peskov, che ha auspicato il rispetto di tutti i punti del
documento firmato oggi. Forse già il primo giallo in vista dell’applicazione di un protocollo che si
annuncia tutt’altro che facile: gli insorti filorussi hanno già dichiarato che la tregua non significa
rinuncia alla lotta per l’autonomia del Donbass, ma è una misura obbligata per fermare il bagno
di sangue. In ogni caso, ammesso e non concesso che la tregua regga, il primo tempo della crisi
ucraina si è concluso.
E non si può certo dire che Kiev stia vincendo la partita. Sino a due settimane fa sembrava che le
truppe governative potessero avere la meglio sui separatisti. Il supporto diretto di Mosca ai
ribelli ha però ribaltato velocemente le posizioni. Lo status quo indica che un buon terzo del
Donbass è in mano ai filorussi, compresi ovviamente i due capoluoghi Donetsk e Lugansk. In vista
delle elezioni anticipate di ottobre, Poroshenko ha bisogno di vendere la tregua come una vittoria
per coagulare attorno a sé l’elettorato moderato e conquistare la maggioranza relativa in
210
parlamento. Il presidente è incalzato dall’ala nazionalista, sia alla Rada, che, soprattutto, fuori: le
frange antirusse guidate da Oleg Lyashko e Anatoly Gritsenko, date in grande ascesa, e quelle
legate più direttamente ai battaglioni di volontari che hanno combattuto nel Donbass,
costituiscono ancora un’incognita, ma se la situazione di pace non verrà consolidata, la stabilità
della Bankova verrà messa seriamente in pericolo. Poroshenko ha anche necessità di arrivare a
un veloce accordo con Putin sulla questione del gas, che rischia di diventare esplosiva con l’arrivo
dell’inverno. L’Ucraina al gelo non sosterrà a lungo presidente e governo, al di là di come sarà la
nuova maggioranza alla Rada. La situazione economica del Paese è catastrofica, e la verità è che
tale sarebbe anche senza la guerra.
L’accordo di Minsk serve a Kiev per bloccare lo spettro della disgregazione.
Ma anche a Mosca, per capire che tattica prediligere
in funzione dell’obiettivo noto: mantenere l’instabilità in Ucraina.
Diverso il discorso in Russia. Se i rating di Putin sono alle stelle e il Cremlino ha consolidato il
potere interno facendo leva sulle cerchie conservative, l’Ucraina è comunque un problema.
L’accordo di Minsk concede un po’ di tempo per riflettere su una strategia che in questi mesi non
è stata lineare. In ogni caso rimangono teoricamente le opzioni iniziali: l’occupazione militare
totale nel Donbass e la creazione della Novorossia (improbabile), il mantenimento delle
condizioni attuali (stile Transnistria, possibile), l’accordo con Kiev per un status di autonomia
ampia della regione, in attesa di vedere come evolverà la situazione politica e quali forze
prenderanno il sopravvento (altrettanto possibile). Il Cremlino, il cui obiettivo è evitare che
l’Ucraina, intera, se ne vada verso la Nato, continuerà a destabilizzare il Paese. Il prezzo per
essere in vantaggio alla fine del primo tempo è però molto alto.
Separatisti. La galassia ribelle, ucraino-russa, dal punto di vista militare è resuscitata grazie al
sostegno delle forze di Mosca, ma senza di esse non sarebbe riuscita a consolidare le proprie
posizioni e sarebbe stata costretta molto probabilmente alla resa. Dai separatisti sono sempre
arrivate dichiarazioni contraddittorie sugli obiettivi: certo è che l’annessione alla Russia non è sul
tavolo, a differenza della richiesta di un’indipendenza che potrebbe però essere ridotta a quella di
uno status speciale autonomo all’interno del Paese. È su questo punto che si gioca il futuro del
211
Donbass e quello dell’Ucraina stessa, già profondamente lacerata dopo l’annessione della Crimea
da parte della Russia e sempre a rischio di collasso totale, nonostante le aspettative che hanno
preso un po’ di consistenza con gli accordi di Minsk. Chi trae subito beneficio dalla tregua è
comunque la popolazione civile, che dopo cinque mesi di guerra può tornare a respirare e
sperare. Almeno per un po’.
Le proposte di Kiev
Europa, 16 settembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Il parlamento ucraino ha approvato una serie di misure che assicurano l’autogoverno alle aree
controllate dai ribelli filorussi. L’autogoverno, che ha il sapore di una via di mezzo tra la
devoluzione proposta da Kiev e l’opzione federale tout court caldeggiata più volte da Mosca,
durerà tre anni. Nel pacchetto licenziato alla Rada, l’assemblea monocamerale ucraina, figurano
alcune concessioni che non erano incluse nel piano di pace presentato a giugno dal presidente
Petro Poroshenko, riferisce il New York Times. Si tratta del potere di organizzare la giustizia e la
polizia locale. Tutto da copione. Il passo era largamente atteso e volendo tagliare corto si motiva
con il fatto che l’Ucraina, sul campo di battaglia, ha al momento perso il confronto con i ribelli. I
quali, nelle ultime settimane, hanno recuperato potenziale militare (si dice perché aiutati dalla
Russia) e terreno, oltre a difendere con successo le roccaforti di Donetsk e Lugansk, che a un
certo punto pareva potessero cadere.
Davanti all’evoluzione dello scenario di guerra Poroshenko è stato messo davanti a un bivio.
Poteva insistere con l’offensiva, con il rischio di perdere tutto l’est. Oppure blandire i ribelli,
cercando di mantenere in qualche misura l’unità territoriale del paese (esclusa ovviamente la
Crimea). Ma anche qui le incognite sono dietro l’angolo. La concessione dell’autogoverno può
potenzialmente portare verso un “conflitto congelato”, non dissimile da una serie di situazioni
ibride e tese che si registrano lungo tutto l’arco post-sovietico: Transnistria, Abkhazia, Ossezia
del sud, Nagorno-Karabakh.
212
In ogni caso non è scontato che il piano di Kiev dia così tanti frutti. A quanto pare i ribelli dell’est che beneficeranno anche di un’amnistia, non estesa però ai presunti responsabili
dell’abbattimento del Boeing malese - non sono affatto interessati all’offerta. Molti dei loro capi
spingono più su l’asticella, verso una vera e propria indipendenza che dia vita a un nuovo
soggetto statuale, la Nuova Russia: è così che l’entità composta dalle aree da loro gestite è stata
ribattezzata. Molto dipenderà dagli sviluppi legati a tutte le altre variabili del confronto in
Ucraina. A partire dal collocamento internazionale di Kiev. Ieri, su questo fronte, c’è stato un
nuovo passo in avanti. Il parlamento ucraino e quello europeo hanno ratificato gli Accordi di
associazione, benché la parte riguardante il libero scambio è stata messa in congelatore. Entrerà
in vigore non prima del 2016, s’è stabilito. Il senso è chiaro. Bruxelles, da una parte, vuole aiutare
Kiev a spostare il proprio baricentro a occidente. Dall’altra cerca di mantenere con Mosca una
forma di dialogo, anche a fronte delle nuove sanzioni varate qualche giorno fa. La Russia infatti
ritiene che gli Accordi di associazione penalizzino la sua economia e quella in generale del blocco
doganale (a breve anche politico) eurasiatico, fortemente sponsorizzato dal Cremlino. Ne fanno
parte, oltre alla Russia, la Bielorussia e il Kazakhstan. Dovrebbe aggiungersi prossimamente
l’Armenia, che però sta temporeggiando.
Sempre in questi giorni è giunta dall’Ucraina un’altra notizia che indica la volontà di rimodulare
l’asse della politica estera dell’ex repubblica sovietica, che costituzionalmente si dichiara neutrale
ma che, davanti agli avvenimento degli ultimi mesi, intenderebbe ricalibrare l’assetto. Nell’area di
Leopoli, nella parte occidentale del paese, si sta tenendo un’importante esercitazione della Nato.
Vi prendono parte 1500 effettivi, da quindici paesi diversi, compresi alcuni che non fanno parte
del blocco atlantico ma che hanno attivato accordi di collaborazione con esso. Parallelamente la
Russia, assai critica verso le manovra della Nato, ha annunciato che intende rafforzare la
presenza militare in Crimea, dove Russia Unita, il partito putiniano, ha appena incassato il 70% al
voto che ha ridisegnato e blindato la composizione dell’assemblea regionale, dopo l’annessione
dello scorso marzo operata dalla Russia. Mosca, al tempo stesso, ha usato toni minacciosi nei
confronti dei paesi baltici, che hanno chiesto e ottenuto una maggiore copertura della Nato.
Potranno esserci “spiacevoli conseguenze”, ha fatto sapere Kostantin Dolgov, l’alto funzionario
governativo con delega ai diritti umani. Il timore delle repubbliche baltiche è che Mosca possa
manovrare le minoranze russe presenti nella regione, in particolare in Estonia e Lettonia,
usandole come cavallo di Troia.
213
Come se non bastasse, la Russia potrebbe a breve approvare una serie di contromisure, che
fungano da risposta all’aggravamento delle sanzioni euro-americane, che tra le altre cose hanno
aggredito con maggiore forza il comparto petrolifero di Mosca. Nel frattempo la Polonia ha
riferito che Gazprom ha limitato i flussi di gas diretti a Varsavia. E proprio il gas è una delle leve
con cui Mosca può tenere sotto scacco Kiev, dove - altro fattore d’incertezza - a ottobre si tengono
le elezioni parlamentari e i partiti più vocati al nazionalismo, assieme ai reduci del fronte,
promettono battaglia. Insomma, lo scenario resta molto teso. L’autogoverno concesso da Kiev
all’est, viene da dire, non sposta di troppo gli equilibri delicati e instabili della tenzone. La partita
è ancora apertissima. Intanto al fronte la tregua stipulata undici giorni fa regge, ma
periodicamente si sente qualche colpo d’artiglieria.
Il conflitto congelato
Europa, 26 settembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
È da venti giorni che in Ucraina non si combatte. O meglio, non ci si massacra. C’è stato qualche
sporadico scontro, ma in compenso la tregua siglata il 5 settembre ha retto. Di più, è stata
irrobustita. Qualche giorno fa il governo di Kiev e i ribelli filorussi, acquartierati nelle loro
roccaforti dell’est del paese, hanno infatti concordato la creazione di una zona cuscinetto larga
trenta chilometri: quindici per ogni versante del fronte. All’interno di questo corridoio non ci
saranno né armi pesanti, né combattimenti. Fino a prova contraria. L’impressione, ovviamente
reversibile, è che ci si incammini verso la fine del conflitto armato. Qualche analista è dell’avviso
che questi ultimi passi restituiscono la sensazione che tanto il presidente ucraino Petro
Poroshenko quanto i ribelli, spalleggiati da Mosca, hanno riscosso al momento il massimo che
potessero ottenere.
Il presidente ha evitato la disgregazione del paese. Se avesse insistito con l’offensiva avrebbe
corso il serio rischio di secessione, rapida e dolorosa, delle regioni dell’est. Le recenti cronache
dal fronte dicono d’altro canto che i ribelli hanno riconquistato forza, morale e posizioni.
214
Avrebbero potuto continuare. Ma, realisticamente parlando, anche a loro è convenuto fermarsi.
L’insofferenza delle popolazioni dell’est verso il conflitto (che non si manifesta solo contro Kiev)
avrebbe potuto generare ricadute negative sul consenso, non certo vastissimo, dei filorussi. È una
cosa nota. Il progetto della Nuova Russia, così si chiama la striscia di terra che comprende le
autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, non può reggersi solo sulla
propaganda e sulla denuncia, ripetuta ossessivamente, degli assalti dei fascisti di Kiev (di fascisti
ce ne sono tanti anche a est). La gestione del potere, in quelle terre ricche di industrie, passa
anche dai rapporti con le élite, prime tra tutte quelle industriali. Non è che si registri tutta questa
affinità tra i ribelli e gli oligarchi.
È anche guardando alle recenti dichiarazioni dei vertici Nato, che hanno confermato che la Russia
sta ritirando i propri soldati dall’Ucraina (l’Alleanza sostiene che i militari russi siano presenti
oltre confine), che viene da pensare che lo scenario si stia ammorbidendo. Ma se anche così fosse,
l’Ucraina rimane comunque una fonte di grandi tensioni e di notevoli incognite. Kiev non ha
molto spazio negoziale, in questo calderone. Mosca le ha tagliato i rifornimenti del gas e la
stagione invernale si avvicina. L’economia è al collasso. Casse vuote, moneta debolissima,
recessione che quest’anno potrebbe rasentare persino la doppia cifra.
A fronte di questo quadro le notizie che arrivano sull’aumento del 25 per cento delle esportazioni
verso l’Europa non sono troppo confortanti. A questa impennata corrisponde infatti una
riduzione, di misura pressoché uguale, nell’export diretto in Russia. Senza contare che Kiev non
gode di tutti i benefici che l’Accordo di associazione con l’Ue, firmato da poco, spalanca. La parte
economica è stata congelata fino a fine 2015. Una concessione ai russi, secondo i quali l’intesa
lede il loro mercato. Poroshenko e il governo ucraino, in tutto questo, non possono che sperare
che il sostegno occidentale non venga meno. Tanto che al di là dei fattori legati alla sicurezza, una
misura come la chiusura temporanea delle frontiere con la Russia, in procinto di essere adottata
presto, è anche un messaggio chiaro rivolto a Occidente. Si chiede, in altri termini, che
Washington e Bruxelles continuino a perorare la causa ucraina e non siano indotte a revocare le
sanzioni nei confronti di Mosca (ricambiate), che stanno sì mettendo in difficoltà il Cremlino, ma
hanno avuto anche impatti non insignificanti sulle economie comunitarie. Poroshenko fa leva
anche sulla prospettiva europea. L’Ucraina chiederà di aderirvi nel 2020, ha fatto sapere.
Scenario difficilmente realizzabile. L’ex repubblica sovietica ha le gomme a terra, volendo essere
215
eufemistici. Prima di intraprendere un simile passo servono tonnellate di riforme. Che
necessitano di volontà politica. I circoli oligarchici di Kiev, detentori di larghe fette di potere
economico e politico, dovrebbero rivoluzionare i loro complessi industriali, antiquati, con tutto
quello che ne consegue a livello di portafoglio e costi sociali.
La rincorsa all’Europa profuma però soprattutto di elezioni. Il ventisei ottobre si va alle urne e
Poroshenko, se vuole respingere i gruppi nazionalistici e i reduci del fronte, facendo sì che il
parlamento non sia disallineato dalla presidenza, deve offrire agli elettori anche dei bei sogni. Ci
si muove anche sull’altro fronte. I ribelli hanno praticamente rigettato la proposta offerta qualche
giorno fa da Poroshenko, fondata sulla concessione di una larghissima autonomia
amministrativa. Il piano prevedeva anche l’organizzazione di elezioni locali, il 7 dicembre. Chiaro
l’obiettivo: delocalizzare il potere, ma continuare a esercitare una sovranità, per quanto flebile.
Ebbene, i ribelli hanno deciso di andare al voto, a Donetsk e Lugansk, il 2 novembre.
Simultaneamente. Una scelta che indicherebbe che la possibile pax con Kiev, nell’est ucraino e a
Mosca, passa non da una maggiore autonomia, quanto piuttosto da una fotografia tipica dei
conflitti congelati.
A Mosca potrebbe anche andare bene, dato che la cosa terrebbe l’Ucraina sotto scacco, incapace
di spostare il suo baricentro politico, se non nella sua porzione occidentale di territorio. Ma non
tutto farebbe rima con vittoria. L’Ucraina è fondamentale, vista dal Cremlino. Fa da cuscinetto nei
confronti dell’occidente, è strategica nella costruzione di uno spazio post-sovietico integrato
commercialmente e sotto molti aspetti è l’affaccio russo sull’Europa. Ne consegue che più è
stabile, migliori possono essere i rapporti con il blocco comunitario. Non è detto, quindi, che
pensarla come un’entità binaria significhi avere il bicchiere mezzo pieno. In ogni caso, in questa
partita Putin ha dimostrato una tolleranza al rischio molto più elevato di quella degli occidentali.
216
12
LA NUOVA RADA
(ottobre 2014)
Le previsioni che vedono un trionfo annunciato di Petro
Poroshenko e del suo Blocco vengono relativizzate dal
sorprendente risultato di Arseni Yatseniuk, il premier che con il Fronte popolare riesce a catalizzare
l’ampio elettorato nazionalista, lasciando poche briciole alla destra radicale. La maggioranza
relativa alla Rada è comunque del partito del presidente, che deve iniziare la coabitazione con il
nuovo-vecchio premier rinvigorito dal successo. Le trattative per la formazione del governo si
mostrano però da subito complicate e gli equilibri vengono regolati come al solito dai poteri forti
dietro le quinte. I problemi dell’Ucraina, dall’economia alla sbando al Donbass per nulla quieto, sono
sempre gli stessi e per il tandem Poroshenko-Yatseniuk la strada è fin dal principio in salita.
Arseni Yatseniuk (Archivio Rassegna Est)
217
I signori di Kiev
Europa, 23 ottobre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Domenica l’Ucraina va al voto, ma una parte del suo territorio - i distretti dell’est controllati dai
ribelli - non parteciperà al rito collettivo delle urne. Non solo. Le repubbliche popolari di Donetsk
e Lugansk, le due entità autoproclamate che formano la cosiddetta Nuova Russia, terranno il due
novembre una propria tornata elettorale. Un gesto di sfida nei confronti del governo centrale, che
qualche settimana fa aveva proposto ai filorussi un pacchetto di incentivi orientato a calmierare
gli impeti scissionisti e fondato su un autogoverno della durata di tre anni, legittimato
dall’organizzazione del voto locale. Kiev aveva suggerito di indirlo a dicembre. L’uomo forte di
Mosca continua però a dire che la situazione in Ucraina va risolta dagli stessi ucraini. La grande
faglia che attraversa l’ex repubblica sovietica contamina non si limita ai soli aspetti elettorali. Si
continua a guerreggiare, infatti. La tregua concordata lo scorso cinque settembre è stata più volte
infranta, benché gli scontri - Kiev ha persino usato bombe a grappolo, secondo Human Rights
Watch - non abbiano spostato per ora la linea del fronte.
Si va al voto, infine, senza un accordo sul gas. Mosca ha tagliato i rifornimenti lo scorso giugno,
chiamando Kiev a saldare gli arretrati. L’altro giorno Bruxelles ha mediato ancora una volta tra i
due contendenti. Sono state fissate nuove tariffe, corrette in parte verso il basso. Ma i russi
vogliono assicurazioni chiare su come incasseranno i soldi. Questo è lo scenario, spigoloso, che
anticipa le elezioni, convocate anticipatamente dal presidente ucraino Petro Poroshenko (nella
foto in alto) con l’intenzione di avere una Rada (il parlamento monocamerale) più allineata e
svuotata dagli uomini che, nella passata stagione, hanno compartecipato alla gestione predatoria
del potere da parte di Viktor Yanukovich. La maggioranza relativa dovrebbe andare al Blocco
Poroshenko. È il cartello voluto dal presidente. Tra i soci c’è Udar, il partito centrista fondato dal
sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il Blocco Poroshenko dovrebbe rastrellare più del 30 per cento
delle preferenze. Cosa che renderà necessaria la formazione di una coalizione. Quale si vedrà.
Il principale avversario di Poroshenko sembra essere Oleg Lyashko. Il suo Partito radicale andrà
quasi sicuramente in doppia cifra. Un exploit, dovuto al fatto che Lyashko, unico esponente
radicale nella passata legislatura, piace tanto ai reduci del fronte quanto a quelli della Maidan,
218
una parte dei quali denuncia la mancata rottura, da parte di Poroshenko, con il potere oligarchico.
In effetti il capo dello stato ha coinvolto molti tycoon nel governo centrale e a livello periferico.
Scelta inevitabile, se si considera che i capitali degli oligarchi, in un paese economicamente allo
sfascio e territorialmente sfibrato, servono (anche) a sostenere lo sforzo militare. Tuttavia il
circolo vizioso tra potere politico e potere economico, forse la causa principale del cronico deficit
di riforme dell’ex repubblica sovietica, non è stato spezzato, come la Maidan reclamava.
Altri partiti dovrebbero superare la soglia di sbarramento del 5 per cento. Tra questi Patria e il
Fronte popolare. Il primo è la formazione di Yulia Tymoshenko, il secondo un’alleanza promossa
dal primo ministro e dal presidente della Rada uscenti, Arseni Yatseniuk e Oleksandr Turchynov.
Si sono sfilati da Patria, dato che la “pasionaria di Kiev”, sgradita alla Maidan, non sembra più la
leonessa di una volta (lo conferma il deludente 12 per cento conquistato alle presidenziali di
maggio). Ma anche in questa occasione ha trovato il modo di garantirsi un posto nelle istituzioni.
La sua mossa è stata quella di candidare come capolista Nadiya Savchenko, pilota di caccia
arrestata dai filorussi, consegnata alla giustizia di Mosca e divenuta la grande eroina della
resistenza dell’Ucraina.
Altri partiti che probabilmente entreranno nella Rada sono Posizione civile e Ucraina forte. Sono
rispettivamente guidati da Anatoly Hrytsenko (ex ministro della difesa con Tymoshenko) e Sergei
Tigipko, che ha rotto con il Partito delle regioni (sciolto), ma cerca comunque di intercettare il
voto dell’est sostenendo sì rapporti più robusti con l’Europa, ma senza compromettere quelli con
la Russia. Rischiano di non avere deputati, invece, il Partito comunista e gli ultranazionalisti di
Svoboda. I comunisti affrontano un processo: Kiev vuole metterli fuori legge. L’accusa è quella di
sostegno diretto ai separatisti dell’est. Quando a Svoboda, la concorrenza dei radicali di Lyashko
si fa sentire. Al netto dei sondaggi, l’impressione è che comunque la prossima Rada rifletterà il
cambio di paradigma politico a Kiev, epurando le forze più propense a guardare alla Russia e
lasciando il pallino in mano al blocco nazionalista, con le sue varie gradazioni.
Ma non tutto è così automatico. La legge elettorale assegna metà dei seggi tramite il sistema
proporzionale e l’altra attraverso la competizione maggioritaria nelle singole circoscrizioni. È qui
che personaggi legati al vecchio regime o vicini ai potentati oligarchici possono prevalere,
dispensando privilegi e denaro. Un esempio arriva da Dnepropetrovsk, la città più prospera del
paese. Alle scorse elezioni il Partito delle regioni ottenne diciassette seggi tramite il
219
maggioritario. Furono eletti candidati indipendenti, che poi confluirono nella fazione
parlamentare yanukovichiana. Tredici di loro, questa domenica, si ripresentano. Agguerriti.
L’incognita degli indipendenti
Europa, 23 ottobre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Come, con chi e in che tempi costruire una coalizione che dia all’Ucraina la forza di legiferare,
riformarsi e negoziare con i ribelli dell’est e con Mosca? Petro Poroshenko, il capo dello stato,
pensa già a queste cose, da prima che le urne - domenica - si aprano. Il difficile in effetti verrà
dopo. Mentre vincere, a quanto pare, sarà facile. Il Blocco Poroshenko, cartello elettorale del
presidente strutturato intorno al suo vecchio partito (Solidarietà) e all’Alleanza per le riforme
(Udar), la formazione del sindaco di Kiev Vitali Klitschko, dovrebbe riscuotere il 30% delle
preferenze. Forse qualcosa in più. Oltre la metà, stando ai sondaggi, del bottino che andranno a
incamerare le altre forze che competono per entrare alla Rada. Così si chiama il parlamento
monocamerale di Kiev.
L’alleato più complementare del Blocco Poroshenko sarebbe il Fronte popolare, partito di conio
recente lanciato da Arseni Yatseniuk e Oleksandr Turchynov. Stanno lasciando le loro cariche
(primo ministro e presidente della Rada) e hanno mollato Patria, il gruppo parlamentare di Yulia
Tymoshenko. La scissione riflette sia le storiche frizioni tra Yatseniuk e la Tymoshenko, sia la
centrifuga di idee e linee politiche in corso, alimentata dalla rivoluzione della Maidan e dal
conflitto militare con i separatisti. Come registra il Centre for Eastern Studies di Varsavia (Osw), a
Kiev sembrano emergere due polarità. Da una parte c’è l’arco nazionale-nazionalista,
compartecipato da Poroshenko e Yatseniuk, con il primo più ragionevole e il secondo più
aggressivo. Potrebbe essere una sorta di gioco delle parti studiato a tavolino, sostiene l’Osw, in
vista del patto di coalizione. Che comunque non sembra così semplice da firmare.
Dall’altro lato, c’è il ceppo radicale. La figura emergente è quella di Oleg Lyashko, rimasto in
disparte sulla Maidan e scatenatosi nel momento in cui s’è aperto il fronte dell’est, da lui più volte
220
presidiato. Lyashko, che forse andrà in doppia cifra, è anche molto critico verso il potere
oligarchico. Come Yulia Tymoshenko, che sta riposizionandosi proprio nel settore radicale.
Esclusa ogni collaborazione con Poroshenko, fino a prova contraria. Altre forze politiche a cui il
blocco del presidente potrebbe guardare con interesse sono Samopomich e Ucraina forte,
rispettivamente guidati dal sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi e da Sergei Tigipko, ex membro del
Partito delle regioni di Viktor Yanukovich. Tanto l’uno quanto l’altro possono rivelarsi
interlocutori pragmatici. Ammesso che superino la soglia di sbarramento del 5%.
La quota di seggi assegnata attraverso il maggioritario farà sì che a est
molti reduci dell’era Yanukovich trovino ancora posto alla Rada.
I giochi non si faranno solo sulla base dei risultati dei singoli partiti. Il sistema elettorale ucraino
assegna la metà dei seggi con il proporzionale e l’altra con una competizione maggioritaria nelle
singole circoscrizioni. È l’esito di questa seconda contesa che alla fine fornirà il quadro definitivo,
dal momento che le candidature indipendenti sono numerose e legate alle solite logiche di potere.
Il sito del Washington Post, nella sezione Monkey Cage, dedicata ai processi elettorali, pubblica un
articolo dove si mette in luce come nelle regioni dell’est in cui si vota (quelle non occupate dai
ribelli) diversi seggi verranno contesi da personaggi vicini ai circoli oligarchici o che alle scorse
elezioni, quelle del 2012, si candidarono come indipendenti e confluirono in seguito nel Partito
delle regioni, la formazione dell’ex presidente Viktor Yanukovich: una macchina politica e
finanziaria, organica ai potentati industriali dell’est. Tra questi, il principale è quello di Rinat
Akhmetov, magnate dei metalli e uomo più ricco dell’Ucraina. Ha rinnegato Yanukovich,
schierandosi con il nuovo potere di Kiev, anche se discretamente. In vista di questa tornata ha
creato un partito, Ucraina industriale. A est qualcuno dei suoi uomini vincerà sicuramente
qualche buon seggio.
Il Kyiv Post, alla questione delle candidature indipendenti a est, ha dedicato due articoli. Il primo è
sulla battaglia elettorale a Dnepropetrovsk, dove tredici dei diciassette indipendenti eletti nel
2012 e schieratisi alla Rada con il Partito delle regioni si ripresentano. Altri candidati sono vicini
invece a Igor Kolomoisky, l’oligarca che governa con i pugno di ferro l’omonima regione, la più
221
avanzata del paese. Kolomoisky, tra l’altro, ha finanziato i battaglioni paramilitari che integrano
l’esercito regolare al fronte. L’altro pezzo del Kyiv Post riguarda le aree del Donbass controllate
dal governo centrale. Anche qui, ci sarà una sfida condotta tutta all’interno del perimetro della
gens oligarchica dell’est. Insomma, alla nuova Rada entrerà una nutrita pattuglia di parlamentari
indipendenti, espressione dei vari potentati che da un quarto di secolo controllano l’economia e il
sistema politico del paese. Si schiereranno con Poroshenko, se quest’ultimo fornirà le dovute
garanzie. Altrimenti siederanno all’opposizione.
In ogni caso, il paradosso è evidente. La Maidan aveva tra le sue parole d’ordine quella di
comprimerne lo spazio di manovra, ma gli oligarchi continueranno a esercitare la loro influenza.
In parte è inevitabile: senza i loro soldi Kiev non può sostenere lo sforzo bellico; senza le loro
attività industriali sarebbe bancarotta all’istante. Sotto altri aspetti, la nuova Ucraina non è così
radicalmente diversa dalla vecchia. Non ancora.
Urne chiuse, questioni aperte
Limes, 24 ottobre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
In Ucraina, l’alleanza del presidente Petro Poroshenko, costituita dal suo partito Solidarietà e da
Udar di Vitaly Klitschko, è data come grande favorita alle elezioni parlamentari anticipate di
domenica 26 ottobre. L’oligarca, noto anche come “il re del cioccolato”, ha trionfato alle
presidenziali di maggio. Ora la coalizione che prende il suo nome (Blocco Poroshenko) si
appresta a conquistare la maggioranza relativa alla Rada, il parlamento ucraino.
Secondo i sondaggi della vigilia saranno pochi i partiti che supereranno la soglia di sbarramento
del 5%. Oltre al Blocco (dato intorno al 30%), dovrebbero farcela il Partito radicale di Oleg
Lyashko (10-12%), il Fronte Popolare di Arseni Yatseniuk e Patria di Yulia Tymoshenko
(entrambi sul 7-9%), Posizione civica di Anatoly Gritsenko (6-7%), Ucraina Forte di Sergei
Tigipko (6-7%), il Blocco d’opposizione di Sergei Liovochkin, Samopomich di Andrei Sadovy (56%), sindaco di Leopoli.
222
C’è incertezza sui nazionalisti di Svoboda guidati da Oleg Tiahnybok, mentre i comunisti di Petro
Simonenko e i paramilitari di Pravy Sektor guidati da Dmitri Yarosh dovrebbero rimanere fuori.
Il sistema elettorale ucraino prevede che metà dei 450 deputati venga eletta con il proporzionale,
l’altra metà con il maggioritario. Bisognerà attendere dunque la conta finale e soprattutto vedere
come si schiereranno i candidati per così dire “indipendenti”, che faranno il loro ingresso alla
Rada senza essere legati inizialmente ad alcun partito. I problemi per Poroshenko cominceranno
dopo le elezioni, quando dovrà cercare un partner per formare la coalizione di governo. La
Costituzione ucraina prevede che il potere esecutivo sia diviso fra capo dello Stato e premier,
cosicché l’insediamento di un gabinetto presidenziale forte è necessario per evitare futuri blocchi
istituzionali.In questo modo si è arenata la rivoluzione arancione nel 2005 e il ritorno alla vecchia
carta costituzionale del 2004, mutata da Victor Yanukovich in senso presidenzialista, rischia di
bloccare nuovamente il paese. Poroshenko, in relazione ai risultati, avrà due possibilità: creare
una maggioranza euro-nazionalista, affidandosi al sostegno dei partiti che sono nati dopo la
rivoluzione di febbraio sul versante antirusso, a partire dal Fronte popolare di Yatseniuk per
arrivare a Samopomich del sindaco di Leopoli Sadovy; oppure inventare una sorta di governo di
unità nazionale, imbarcando gli eredi moderati dell’ex presidente, cercando un compromesso
oligarchico con Tigipko e Liovochkin. Se l’Ucraina si trovasse in una situazione ordinaria, le
prospettive rientrerebbero nella normale dialettica politica. Ma per il paese è in ballo la sua
stessa esistenza: il conflitto nel Donbas è solo congelato e il default è sempre a un passo. Il rischio
è che dopo le elezioni del 26 ottobre Kiev si ritrovi invischiata nei soliti giochi tra i poteri forti,
dentro e fuori i propri confini, sprofondando ancora di più nella crisi.
223
Vittoria dimezzata
Europa, 27 ottobre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Lo iato tra il risultato reale del voto e i sondaggi che lo hanno preceduto rischia di essere molto
largo. I secondi indicavano una vittoria chiara del Blocco Poroshenko, il partito presidenziale,
preannunciando al tempo stesso l’ascesa del Partito radicale di Oleg Lyashko, che ha impostato la
sua campagna su un doppio messaggio: onore agli uomini del fronte (Lyashko ha compiuto
diverse ricognizioni), in particolare ai volontari; lotta allo strapotere dei circoli oligarchici. Non è
andata proprio così. Il Blocco Poroshenko, strutturato intorno al vecchio partito del presidente
(Solidarietà) e all’Alleanza per le riforme (Udar), la formazione del sindaco di Kiev Vitali
Klitschko, potrebbe persino non essere il primo partito della Rada, il parlamento monocamerale
dell’Ucraina. Sia gli exit poll che lo scrutinio delle schede (ne sono state contate il 15% al
momento in cui scriviamo) indicano che dovrà vedersela con il Fronte popolare, formazione
lanciata di recente da Arseni Yatseniuk e Oleksandr Turchynov, primo ministro e presidente del
Parlamento uscenti. Entrambe le forze sarebbero al di sopra del 20%.
Scarto netto tra i pronostici e il reale dato delle urne:
il Fronte popolare supera il Blocco Poroshenko, i radicali di Lyaschko
non sfondano, Andriy Sadovyi oltre le aspettative.
Il ceppo radicale è invece uscito ridimensionato dalle urne. Oleg Lyashko entrerà alla Rada, ma a
quanto pare non andrà in doppia cifra. Rimasto in disparte sulla Maidan, s’è scatenato nel
momento in cui s’è aperto il fronte dell’est, cercando di sfruttare elettoralmente
l’estremizzazione dei sentimenti. Yulia Tymoshenko, riposizionatasi nel settore radicale, avrebbe
ottenuto poco più del 5%, la soglia minima utile a entrare nella Rada. Risultato certamente
modesto, ma stavolta la Tymoshenko, tutt’altro che amata dalla Maidan, non aveva molte carte da
giocare. Quella più forte è stata la candidatura come capolista di Nadiya Savchenko, aviatrice
catturata dai filorussi e consegnata a Mosca, dov’è attualmente detenuta. Candidare la gente del
224
fronte è stata un’usanza comune, in queste elezioni. I partiti dell’arco nazionalista hanno incluso
nelle loro liste comandanti dei gruppi paramilitari, integrati nelle strutture ufficiali di
combattimento, attivi al fronte. In tutto ce ne sono una quarantina. Molte di queste unità sono
finanziate direttamente dagli oligarchi, che hanno capito come, nell’Ucraina in guerra, i
paramilitari siano uno strumento di pressione importante su Kiev.
Un’altra sorpresa di questo voto viene da Samopomich, partito guidato da Andriy Sadovyi. È il
sindaco di Leopoli, centro d’irradiazione della cultura nazionale-nazionalista. Samopomich,
formazione ritenuta di stampo pragmatico, potrebbe superare il 10%.
Alla Rada entrerà quasi sicuramente anche il Blocco dell’opposizione, che a quanto pare è riuscito
a vincere la sfida tutta interna ai reduci del Partito delle regioni (discioltosi qualche mese fa)
dell’ex presidente Viktor Yanukovich. Da cui esce sconfitto Sergei Tigipko, se la conta finale non si
distanzierà troppo da quella parziale. Il suo partito, Ucraina forte, si colloca a metà del guado: più
Europa, ma senza che questo significhi meno Russia. Messaggio che a est, dove l’affluenza è stata
più bassa, non è passato. Quello del Blocco dell’opposizione, schierato nettamente contro i nuovi
padroni di Kiev, ha fatto più breccia.
Già da oggi si guarderà alla costruzione del governo. Dovrà avere la forza di legiferare, riformare
e negoziare con i ribelli dell’est e Mosca. Un’ipotesi potrebbe essere una coalizione a tre, tra
Poroshenko, Yatseniuk-Turchynov e Sadovyi. Il vantaggio è che darebbe stabilità, tenendo alla
larga dal governo i radicali. Lo svantaggio è che una simile coalizione continuerebbe a essere
sbilanciata, nel senso che, geograficamente parlando, corrisponderebbe alla parte di Ucraina che
più spinge verso una direzione nuova, in senso culturale e strategico. I giochi non si faranno solo
sulla base dei risultati dei singoli partiti. Il sistema elettorale ucraino assegna la metà dei seggi
con il proporzionale e l’altra con una competizione maggioritaria nelle singole circoscrizioni,
benché alcune di esse, ricadendo nei territori controllati dai ribelli filorussi, non daranno
parlamentari. È comunque l’esito di questa seconda contesa che, alla fine del processo, andrà a
indicare il quadro definitivo.
225
I guai di Poroshenko
Lettera 43, 27 ottobre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Le elezioni di domenica 26 ottobre hanno riservato qualche sorpresa. Rispetto alle previsioni
della vigilia, con tutti i sondaggi che davano una chiara vittoria per il blocco Poroshenko, il
successo dell’alleanza presidenziale è stata invece più contenuta. Anche lo sfondamento
ultranazionalista di Oleg Lyashko è rimasto sulla carta e il populista antirusso, già terzo alle
Presidenziali di maggio, si è dovuto accontentare delle posizioni di rincalzo. Stessa sorte per
Patria di Yulia Tymoshenko: l’eroina della rivoluzione arancione ha ceduto terreno al Fronte
Popolare di Arseni Yatseniuk, il premier che ha imboccato la linea dura patriottica e si è piazzato
con la sua nuova formazione appena dietro Poroshenko. Almeno secondo gli sondaggi e i risultati
dello spoglio ancora in corso. Un risultato non previsto in queste dimensioni che ha rilanciato le
pretese del leader di rimanere alla guida del prossimo governo.
Tra i vincitori della tornata elettorale c’è anche il sindaco di Leopoli Andrei Sadovy che con il suo
Samopomich (Auto aiuto) entra per la prima volta in parlamento. Dalla Rada spariscono invece
dopo 20 anni i comunisti, mentre gli eredi di Victor Yanukovich, riuniti dietro il Blocco
d’opposizione, tengono alta la bandiera del Donbass. Tutto sommato quindi il quadro è
abbastanza chiaro: le forze europeiste e antirusse escono complessivamente vincenti dal voto,
anche se nelle regioni del sud-est i filorussi rimangono i più votati. Almeno questo indicano i
risultati nel proporzionale e la distribuzione delle forze nei 225 seggi assegnati con questo
sistema non ha bisogno di commenti. Diversa è la questione per il resto dei 450 seggi (meno di
200, visto che in diverse circoscrizioni del Donbass e ovviamente in Crimea non si è votato)
assegnati con il maggioritario: per vedere i vincitori bisognerà attendere i risultati definitivi, così
come per osservare come si schiereranno i nuovi parlamentari, legati o meno ai partiti e spesso e
volentieri manovrati dagli oligarchi. I nuovi equilibri alla Rada dipenderanno da come saranno
costituite le frazioni parlamentari e i conti esatti verranno fatti quindi fra qualche giorno.
Nel frattempo è però chiaro che la formazione del governo riguarderà in pratica tutte le forze
entrate con il proporzionale a accezione del Blocco d’opposizione e molto probabilmente del
Partito radicale di Lyashko con il quale Poroshenko aveva escluso alleanze sin da principio. La
226
maggior parte di queste (Bp, Patria, Fronte popolare e Svoboda) ha già sostenuto il governo di
Yatseniuk, almeno sino all’estate, prima che la maggioranza si frantumasse. In aggiunta c’è come
possibile nuovo alleato Samopomich. Domenica sera il presidente si è appellato a tutte le forze
«europeiste e pro-ucraine» perché sostengano il nuovo governo e ha promesso la sua formazione
in tempi rapidi. Non è in realtà ancora chiaro chi farà parte della coalizione di maggioranza e chi
avrà il ruolo di premier: i giochi interni sono appena iniziati e nonostante l’ottimismo sfoggiato
dopo la vittoria, Poroshenko avrà probabilmente qualche gatta da pelare.
La crisi di governo estiva, tutta interna ai partiti filoccidentali usciti vincitori dalla rivoluzione di
febbraio, è il chiaro esempio che al di là della facciata, tra presidente, premier e alleati vari le
differenze esistono e sono spesso insormontabili. La convergenza ideologica su Bruxelles non è
insomma sufficiente per governare un paese vicino al baratro. Il nuovo governo, sia nel caso di
un’ammucchiata, sia in quello di una coalizione molto asciutta, dovrà affrontare compiti di
enorme difficoltà in un contesto quantomeno complicato. Il conflitto nel Donbass è solamente
congelato e la situazione economica è sempre sull’orlo del collasso: senza riforme urgenti e
sostanziali Poroshenko e il prossimo governo rischiano di schiantarsi ai primi ostacoli. La bassa
affluenza alle urne, poco più del 50%, indica inoltre che metà del paese è in qualche modo passiva
e rassegnata di fronte a ciò che succede a Kiev. Dieci anni fa era stata la rivoluzione arancione a
dare l’illusione agli ucraini di una svolta che non è mai arrivata. Oggi il pericolo è che se alle
promesse non seguiranno i fatti e gli oligarchi non troveranno un nuovo equilibrio, la terza
Maidan sarà prima o poi inevitabile.
227
Al tavolo dei tycoon
Linkiesta, 29 ottobre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Sul gigantesco pannello che ricopre lo scheletro in muratura dello Zum (Zentralny Univermag), lo
storico magazzino centrale in ricostruzione sul Kreshchatik, il vialone che porta a Maidan, la
scritta è inequivocabile: Ucraina, Edina Strana (Paese unito). I colori sono l’azzurro e il giallo del
vessillo nazionale. I lavori stanno andando avanti da un paio d’anni, da quando alla Bankova, la
residenza del capo dello Stato distante solo qualche centinaio di metri in linea d’aria, c’era ancora
Victor Yanukovich. L’appalto per il rifacimento dello Zum, ereditato dai tempi dell’Unione
Sovietica e più facile da ricostruire ex novo che da ristrutturare, se l’era aggiudicato Rinat
Akhmetov, l’oligarca più potente dell’Ucraina e principale sponsor filopresidenziale del Partito
delle regioni. La rivoluzione iniziata ormai quasi un anno fa ha spazzato via Yanukovich, ma non
Akhmetov; né tantomeno il partito che è risorto alle scorse elezioni parlamentari con il nome di
Blocco d’opposizione, conquistando quasi il 10% a livello nazionale e rimanendo la prima
formazione in cinque regioni del sudest, lasciando dietro di sé l’alleanza di Petro Poroshenko e
Vitaly Klitschko e il Fronte popolare di Arseni Yatseniuk.
A spingere gli eredi di Yanukovich in prima fila c’è ovviamente Akhmetov, che ha lasciato la sua
residenza di Donetsk e si è spostato nella più tranquilla Kiev, ma è ancora il padrone del Donbass.
Accusato di aver sovvenzionato inizialmente i separatisti, il presidente dello Shakhtar, che ora
segue la squadra a Leopoli, visto che nell’Arena di Donetsk, poco distante dall’aeroporto conteso
tra ribelli e governativi, ogni tanto ci piovono bombe, è rimasto uno dei grandi giocatori allo
sconquassato tavolo ucraino. Le elezioni sono servite anche per rimescolare le carte con le quali
gli oligarchi si presentano sul tavolo politico. Gli altri sono altrettanto identificabili: se Dmitri
Firtash, pezzo grosso del gas con buone connection verso la Russia se ne sta a Vienna seguendo
comunque da vicino il progetto del Blocco d’opposizione, pilotato dal vecchio capo
dell’amministrazione presidenziale Sergei Liovochkin e dall’ex ministro dell’energia Yuri Boiko, il
maggiore rivale è Igor Kolomoisky, governatore di Dnepropetrovsk e responsabile della grande
ascesa di Arseni Yatseniuk e del suo partito della guerra. Nemico numero uno in Ucraina di
Vladimir Putin, Kolomoisky è il finanziatore anche di alcuni battaglioni di combattono nel
Donbass e ha pure speso di tasca propria per lanciare Ukraine Today, la risposta propagandista
228
alla più illustre Russia Today controllata dal Cremlino. Ha cercato di mettere in un angolo
Akhemtov, senza però riuscirci sino in fondo, e ora si trova a duellare nemmeno a troppa distanza
con Petro Poroshenko, l’oligarca che ha fatto il salto dal business alla politica, eletto presidente
della repubblica a maggio.
Poroshenko, il re del cioccolato, è ora impegnato a formare un governo di coalizione con l’intento
di tenere a bada il fronte guerraiolo di Yatseniuk e di Andrey Sadovy, sindaco di Leopoli di per sé
moderato, ma che ha arricchito il suo nuovo partito con i kalashnikov, a partire da quello di
Semion Semenchenko, numero due di una lista alquanto variegata, guarda caso fondatore del
battaglione Donbass finanziato da Kolomoisky. A differenza di quest’ultimo, Poroshenko che non
è certo un amante del Cremlino, ma è un moderato pragmatico, è alla ricerca della via di mezzo
per non finire male, magari come il suo predecessore Yanukovich, abbattuto da un’altra
rivoluzione ad hoc. Se al tavolo degli oligarchi non verrà trovata insomma una pax oligarchica per
traghettare il Paese verso lidi più tranquilli, il rischio è che l’Ucraina, che ha già perso la Crimea e
di fatto una fetta del Donbass, si laceri ancor di più. Rendendo la patriottica gigantografia sullo
Zum di Akhmetov solo un’illusione.
Putin vuole che l’Ucraina resti un pantano
Europa, 29 ottobre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Chiuso il processo elettorale per il rinnovo della Rada, il parlamento ucraino, si aprono le urne
nelle aree controllate dai separatisti filorussi. Le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, così
sono chiamate le entità scissioniste, vanno al voto questa domenica. Sceglieranno i loro
rappresentanti e Mosca ha già fatto sapere che riconoscer{ l’esito della tornata. La frattura che
spacca l’ex repubblica sovietica resta profonda. A Donetsk e Lugansk il voto si celebra con largo
anticipo e in evidente opposizione alla data proposta da Kiev (dicembre), che un mese e mezzo fa
aveva licenziato un pacchetto di misure orientato a blandire i ribelli e strutturato intorno al
concetto di autogoverno. Insieme alla convocazione del voto locale, Kiev aveva garantito
229
un’amnistia nei confronti di coloro coinvolti nei combattimenti e la possibilità di organizzare con
ampia autonomia discrezionale polizia e giustizia. Il voto di domenica sconfessa questa offerta.
La scelta di riconoscere legittimit{ al voto e la reiterazione dell’idea che il confronto tra Kiev e i
separatisti è un affare interno dell’Ucraina, conferma quella che secondo diversi analisti è la
strategia del Cremlino: spingere il vicino verso il fallimento.
Fallimento che non si misura solo sulla base del disgregamento territoriale, fotografato dallo
strappo della Crimea e dal conflitto congelato creatosi a est, che va a sommarsi ai tanti casi simili
che si annidano lungo l’arco post-sovietico. L’Ucraina, infatti, sta collassando anche sul piano
economico. Quest’anno il Pil è destinato a calare di oltre sei punti. La produzione industriale, a
settembre, ne ha persi 16,6. Addirittura 21,4 nel mese di agosto. A tutto questo s’aggiunge il
crollo della hryvnia (la moneta locale) e il fatto che Gazprom non ha ancora riaperto i rubinetti.
L’inverno è alle porte.
Lacerazione territoriale e crisi finanziaria acuta. Un’Ucraina ammaccata sta più che
bene al Cremlino, date la piega che sta prendendo il quadro internazionale.
Un simile scenario rischia di trasformare l’Ucraina, per l’Occidente, in un pozzo senza fondo.
Tenerla a galla può avere costi ancora maggiori rispetto a quelli preventivati, non certo marginali,
con il rischio che i soldi incanalati verso Kiev servano a salvare la baracca, più che a fare le
riforme indispensabili per ristrutturare un sistema marcio e inefficiente, controllato da pochi,
potentissimi oligarchi. Gli stessi che stanno finanziando la guerra, armando i battaglioni
paramilitari. Poroshenko non può sostenere lo sforzo bellico senza il loro appoggio, ma così
facendo dà alle milizie e ai tycoon un importante potere di ricatto, che può inceppare il discorso
delle riforme. Anche a fronte della solidità, sulla quale è lecito nutrire dubbi, che la nuova
coalizione potrebbe avere.
Le manovre della Russia hanno senza dubbio un costo. Le sanzioni europee stanno avendo effetti
non irrilevanti sull’economia russa, gi{ provata da una fase di crescita al lumicino. Ma Putin, in
questa partita, sta dimostrando una tolleranza al rischio spaventosamente alta. All’Europa manca.
230
Il presidente russo fa leva anche su questo. Intanto la tregua tra Kiev e i ribelli regge e non regge.
Gli scontri continuano. Sembra persino che sia in atto un gioco delle parti. A Putin sta bene così,
fintanto che l’Ucraina resta un pantano. Poroshenko ha spazi di manovra limitati. La guerra gli
serve per dimostrare che il paese è sotto attacco e chiedere agli occidentali sforzi finanziari
maggiori. La pace, dovesse firmarla, lo porterebbe a subire l’accusa di remissivit{. Vie d’uscita, al
momento, non è facile vederne.
231
13
COMBATTERE D’INVERNO
(novembre 2014)
Il governo non c’è ancora, nel Donbass si combatte nonostante la
tregua, i dati economici mostrano un paese vicino al default. Il
risultato delle proteste contro Victor Yanukovich, iniziate nel novembre del 2013, non tende al
positivo. L’Ucraina, che ricorda anche il decimo anniversario della rivoluzione arancione, si è
incagliata su se stessa, imprigionata in una guerra senza sbocco e con un sistema gestito ancora in
maniera oligarchica. La diplomazia internazionale è impotente, le sanzioni dell’Occidente contro la
Russia non sbloccano la situazione e hanno come effetto solo quello di aggravare la crisi economica
sia a Mosca che di riflesso a Kiev.
Membro della Guardia nazionale durante un’esercitazione (Joshua Leonard / defenseimagery.mil)
232
Sull’orlo del baratro
Rassegna Est, 3 novembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Dopo i referendum di maggio, sei mesi di guerra, gli accordi di Minsk a settembre e una fragile
tregua stabilita con la regia di Petro Poroshenko e Vladimir Putin, le elezioni del 2 novembre
nelle repubbliche indipendentiste nel sudest dell’Ucraina allontanano ancor di più il Donbass da
Kiev. Il dialogo tra periferia e centro si è impiantato ancor prima di cominciare e a questo punto il
piano di pace voluto dalla Bankova rischia di andare a rotoli. Le elezioni locali in programma per
dicembre diventano più incerte, anche perché senza la collaborazione con i due nuovi presidenti
a Donetsk e Lugansk, dove si sono tenute ieri elezioni parallele, Poroshenko non ha molte
alternative. Nonostante il voto non venga riconosciuto da nessuno, se non simbolicamente dalla
Russia - che comunque ha parlato solo le rispetto della volontà dei cittadini del sudest ucraino - le
carte sul tavolo sono chiare e Kiev, oltre alla voce grossa, poco può fare. Escludendo ovviamente
l’idea di una ripresa in grande stile dell’offensiva delle truppe governative per riconquistare i
territori occupati che in questo momento appare un’ipotesi di scuola.
Dopo le elezioni parlamentari del 26 ottobre si attende intanto la formazione del nuovo governo.
Le premesse non sono certo incoraggianti, dato che i due maggiori partiti, quello del presidente e
quello dell’attuale premier Arseni Yatseniuk, non sono ancora riusciti a mettersi d’accordo su chi
guiderà la coalizione e su come saranno spartite le poltrone. La questione potrebbe andare avanti
per settimane, come accaduto in passato. Dietro il collante europeista il Blocco Poroshenko e il
Fronte popolare perseguono strategie diverse, sostenuti da alleati differenti. Dopo la rivoluzione
d febbraio gli schemi oligarchici nel Paese sono rimasti gli stessi, con la sola differenza che il clan
dell’ex capo di stato Victor Yanukovich è stato messo fuori dai giochi. Sul tavolo continuano però
a muovere le loro pedine i soliti noti, da Rinat Akhmetov a Igor Kolomoisky, in un contesto
politico ed economico molto fragile.
Nonostante sia arrivato in extremis un accordo sul gas con la Russia - provvisorio e che lascia
solo l’inverno di pausa - l’Ucraina naviga in acque pericolose ed è tenuta a galla solo dagli aiuti
della comunità internazionale. Le previsioni per la chiusura dell’anno sono catastrofiche e le
speranze di ripresa sono legate agli sviluppi della situazione nel Donbas. Il fatto che la parte
233
economica dell’Accordo di associazione con l’Unione Europea entrerà in vigore di fatto solo nel
2016 è indicativo di come le condizioni del Paese siano peggiorate, oltre al paradossale fatto che
il posticipo che aveva chiesto anche Yanukovich, dopo che l’intesa era già stata parafata nel
marzo 2012, è stato ora accordato per forza di cose a Poroshenko. Nonostante il quadro sia poco
roseo e il futuro incerto, legato sia alla situazione sul terreno tra Kiev e il Donbass, ma anche agli
equilibri interazionali che coinvolgono Mosca, Bruxelles e Washington, l’Ucraina rimane, forse
proprio per questo, un paese interessante per gli investitori che possono sopportare gradi di
rischio medio-alto. Nella classifica del Doing Business del 2014-2015 Kiev segna un’ascesa di 16
posizioni (dalla 112esima alla 96esima). L’Italia in confronto ne ha perse 4 (dalla 56esima alla
52esima).
I cyborg
Europa, 19 novembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
È costato più di 500 milioni di euro e la sua ristrutturazione, tutta all’insegna dell’efficienza e
della più aggiornata modernità architettonica, è stato uno dei vanti che l’Ucraina ha potuto
esibire al mondo, quando si sono disputati gli europei di calcio del 2012, organizzati
congiuntamente con la Polonia. Ma l’aeroporto di Donetsk ha simboleggiato anche il potere delle
oligarchie dell’est del paese e il loro rapporto organico con il deposto presidente Viktor
Yanukovich e la sua formazione politica, il Partito delle regioni. I lavori se li aggiudicò la Altkom,
colosso delle costruzioni del Donbass. Uno dei cinque gruppi industriali che nel 2012, da soli, si
accaparrarono più della metà dei fondi pubblici destinati a infrastrutture e progetti di vaste
dimensioni. A suo tempo, il sito Business New Europe definì l’azienda vicina al Partito delle regioni
e governata in modo opaco.
Oggi non c’è più Yanukovich (fuggito in Russia), e non c’è più il Partito delle regioni, disciolto
qualche mese fa. Ma non c’è neanche lo scalo aeroportuale di Donetsk, intitolato al compositore
russo Sergei Prokofiev. È stato totalmente distrutto dalla guerra. La testata televisiva russa RT è
234
giunta a paragonarne le rovine a Pripyat, il borgo fantasma situato nei dintorni di Chernobyl.
Tutto molto giornalistico, funzionale al click. Ma il colpo d’occhio, netto, testimonia
indubbiamente lo sfacelo. Fucili, cannoni e mortai, tra l’altro, non hanno mai smesso di tacere. In
questo fazzoletto di terra la tregua concordata tra Kiev e i separatisti filorussi non è mai entrata
in vigore. Gli scontri sono iniziati a maggio, quando i filorussi hanno occupato momentaneamente
la struttura. Kiev rispose con durezza, riprendendone il controllo. Da allora le milizie della Nuova
Russia - così si definisce la parte di Ucraina che aspira alla secessione - hanno spinto indietro i
soldati di Kiev, schiacciandoli infine nel terminal centrale. Poi, più niente. Fermo immagine.
Le forze governative e i volontari, diversi dei quali in quota Settore destro (Praviy Sektor),
gruppo di estrema destra protagonista sulle barricate della Maidan, restano lì acquartierati.
Resistono strenuamente, tanto che sono stati ribattezzati cyborg dalla stampa di Kiev, divenendo
veri e propri eroi nazionali. Al netto delle narrazioni mitologiche, che a Kiev sono assai gettonate,
inevitabilmente e comprensibilmente, è lecito chiedersi la ragione per cui si difende questa
posizione. Dopotutto l’aeroporto di Donetsk non ha più il minimo significato strategico,
scarnificato com’è. Lo ha ammesso anche Yuriy Biriukov, consigliere del presidente Petro
Poroshenko e fondatore di Krila Feniksa, associazione che raccoglie donazioni per l’esercito e
alcuni dei gruppi volontari, posti sotto il controllo del ministero dell’interno, che lo spalleggiano
sulla linea del fronte. «La situazione all’aeroporto è abbastanza monotona. Ci sono scontri
quotidiani e i nostri ragazzi, sfortunatamente, muoiono. Anche se non così frequentemente,
grazie a dio. Da una prospettiva strategica, lo scalo non ha valore. […] Non è un punto critico per
la difesa del fronte», ha affermato Biriukov in una recente intervista a Hromadske, una televisione
web di area Maidan.
Dal canto loro, i filorussi non sferrano l’assalto decisivo. Sono schierati a semicerchio. Hanno
piazzato qualche cecchino. Sembra che ci siano le condizioni per chiudere la partita. Che però
resta aperta. L’aeroporto di Donetsk è un ammasso di macerie, ma anche un simbolo di questo
conflitto e in quanto tale tutti vogliono averlo. Gli ucraini, così, resistono con le unghie e con i
denti, facendosi cyborg. Mentre i filorussi non tolgono l’assedio. Questa, tuttavia, è solo una delle
letture: quella ammantata, appunto, di elementi simbolici. Ce ne sono altre. Ad esempio, The
Vineyard of the Saker, un blogger molto seguito che analizza il conflitto da posizioni vicine a
quelle dei ribelli, ha scritto a inizio ottobre che l’unico motivo per cui gli ucraini non si schiodano
235
è che usano quest’ultimo per avere un affaccio su Donetsk e terrorizzarne la popolazione. È dal
terminal che, secondo il blogger, i soldati di Kiev scagliano ogni tipo di ordigno sulla città. Sparare
nel mucchio è una scelta, ma anche una necessità. La loro artiglieria, infatti, non è sofisticata.
Quanto ai filorussi, si legge ancora su The Vineyard of the Saker, non hanno al momento
intelligenza e strumenti tali da cacciare gli ucraini. Per quanto sia vero che la guerra, sul fronte
ucraino, è una guerra imprecisa e dunque sporca, cosa che vale per entrambe le parti,
un’interpretazione del genere non ha fondamenta troppo salde.
La battaglia per l’aeroporto di Donetsk è strategicamente
poco rilevante, ma ha un forte valore simbolico, da ambo le parti.
Lì la tregua non ha mai retto. Neanche un giorno.
E se fosse che sia agli uni che agli altri faccia comodo che lo scenario resti congelato? Kiev può
dimostrare che i suoi guerrieri sono eroi che si contrappongono a un nemico cinico, potente,
foraggiato dal Cremlino. Discorso rivolto sia all’opinione pubblica, sia all’Occidente, dal cui
sostegno politico e finanziario l’Ucraina dipende. I filorussi, a loro volta, hanno la possibilità di
spiegare alla loro gente che gli ucraini tengono Donetsk nel mirino e che la lotta di liberazione nei
confronti di Kiev è giusta e sacrosanta. E qui, manco a dirlo, si sconfina nella propaganda: una
costante, tambureggiante e al tempo stesso disturbante, di questa crisi. The Vineyard of the Saker,
nello stesso post prima citato, afferma che i soldati ucraini appollaiati nel terminal dell’aeroporto
di Donetsk ricordano le SS che al tempo della seconda guerra mondiale gridavano «Heil Hitler!»
davanti ai plotoni d’esecuzione sovietici. Un parallelo che si salda alla tesi che equipara la
ribellione del Donbass a una guerra di liberazione dal fascismo, snocciolata da mesi dai media
russi e filorussi. Era stato lo stesso al momento della secessione della Crimea.
Non scherza nemmeno Kiev, sul piano della propaganda. Il sito dell’emittente Ukraine Today,
lanciata da poco anche sulla piattaforma satellitare italiana, ha pubblicato una storia
multimediale - c’è pure la versione italiana, seppure con diverse sbavature - sulla battaglia per
l’aeroporto. È molto articolata, come fitta di passaggi esasperati. I filorussi sono descritti come
«feroci ribelli sostenuti dal Cremlino». E sarebbero stati loro a coniare l’appellativo di cyborg.
236
«Increduli per l’eroismo senza precedenti dei loro avversari, li hanno chiamati cyborg», si legge.
Senza contare che Praviy Sektor viene catalogato come «un partito patriottico». E se piuttosto la
battaglia per l’aeroporto non fosse che un pretesto con cui arrivare a uno scambio di territori?
Opzione non del tutto infondata, a quanto sembra. Yuriy Biriukov, nell’intervista a Hromadske tv,
ha argomentato che sarebbe sensato lasciare ai filorussi l’aeroporto, in cambio di un pezzo di
terra. Possibilmente un’area urbana. «Se si trattasse delle aride steppe della regione di Donetsk,
invece, non ci sarebbe motivo per procedere allo scambio», ha detto. Sul lato opposto della
barricata circolano un po’ le stesse idee. Sentito telefonicamente dal Wall Street Journal, il sindaco
di Donetsk, Igor Martynov, messo a palazzo dai ribelli, ha riferito che se Kiev si ritirasse da tutta
la regione di Donetsk (i governativi ne occupano più della metà), allora non ci sarebbero più
problemi. Messa in altri termini, si pretende che Kiev faccia tornare a casa i cyborg e si ritiri di
qualche buon chilometro, come condizione per bagnare le polveri e farla finita con la guerra. Non
verrà mai accettata.
Dieci anni dopo
Lettera 43, 20 novembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Era il 21 novembre del 2004, in Ucraina si teneva il ballottaggio delle elezioni presidenziali tra
Victor Yanukovich e Victor Yushchenko. Vinse il primo, ricorrendo al trucco, e la rivoluzione
arancione portò nel giro di poche settimane alla ripetizione del voto, che ribaltò l’esito delle urne
e vide la scontata vittoria del secondo.
Come la storia proseguì è noto, con il naufragio in pochi mesi della strana coppia formata dal
nuovo capo di Stato e dal primo ministro Yulia Tymoshenko. Il disastro fu tale che Yanukovich
tornò al potere nel 2010 senza bisogno di aiuti esterni. Negli ultimi quattro anni a Kiev si è
assistito prima all’ascesa del clan presidenziale e poi alla sua rapida deriva, spazzato da Maidan.
Ora il paese è in guerra, con se stesso e con la Russia, alla Bankova c’è Petro Poroshenko, un
oligarca che dieci anni fa era stato al fianco dei rivoluzionari, e il futuro è appeso a un filo.
237
L’Ucraina è sempre nella terra di mezzo, tra Mosca e Bruxelles, la geografia non si cambia con
nuovi governi. Già nel 2004 la rivoluzione arancione non era stata solo un affare interno: da una
parte la Russia e dall’altra l’Unione europea, come al solito in ordine sparso, insieme con gli Stati
Uniti avevano duellato per mantenere o accrescere la propria influenza sull’ex repubblica
sovietica. Il gioco è andato avanti per due lustri, senza che nessuno dei contendenti mollasse la
corda e i risultati sono sotto ora gli occhi di tutti.
Vista dal Cremlino la partita per l’Ucraina è molto più importante e simbolica rispetto a chi sta
dall’altra parte del tavolo. E questa è la ragione per cui Vladimir Putin anche oggi non si lascia
convincere facilmente a lasciare quieto il Donbass. Quello del 2004 è stato solo il primo tempo: la
Russia allora era ancora in una fase di assestamento, sia interno che esterno. Da una parte Putin
aveva appena iniziato il suo secondo mandato, la risalita economica dopo gli anni critici di Boris
Eltsin e il default del 1998 era cominciata, ma non consolidata, la verticale del potere in fase di
finalizzazione. Dall’altra parte la rivoluzione in Georgia del 2003 aveva anticipato quello che
sarebbe successo a Kiev poco dopo, il Caucaso nel consueto stato di anarchia e in Asia centrale
ognuno faceva i fatti suoi (in Kirghizistan la rivoluzione dei tulipani sarebbe arrivata nel 2005).
Nel marzo 2004 sette Paesi est-europei (Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania,
Slovacchia e Slovenia) erano entrati nella Nato. Da Mosca l’avanzata dell’Alleanza atlantica non
poteva non suscitare scetticismo: nel 2009 arrivarono Croazia e Albania e gli ingressi di Georgia e
Ucraina furono bloccati in extremis da Germania e Francia. Putin, con la guerra nel 2008 che
portò all’indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud aveva in fondo tracciato la linea rossa oltre
la quale l’Occidente non si sarebbe dovuto spingere. Ma a Bruxelles e Washington i segnali di
Mosca, anche quelli più chiari, non sono tenuti in considerazione.
E se per un verso i programmi di partnership Nato sono stati intensificati, per l’altro quello di
partenariato orientale dell’Unione europea che ha coinvolto a partire dal 2009 sei ex repubbliche
sovietiche (Ucraina, Georgia, Bielorussia, Moldavia Azerbaigian e Armenia) è entrato per forza di
cose in rotta di collisione con i piani russi. L’Ucraina, dopo l’arrivo alla Bankova di Yanukovich nel
2010 e lo scivolamento verso Mosca nel 2013, è diventata il teatro di una nuova rivoluzione in cui
il cambio di governo non è stato altro che l’obiettivo per riportare verso i binari occidentali il
paese. Visti i precedenti, nessuno poteva pensare che al Cremlino stessero a guardare. Putin si è
messo così a restituire tutto con gli interessi, partendo dalla Crimea e passando per il Donbass. E
238
non è ancora finita. La Russia colpita dalle sanzioni si è rinchiusa in se stessa, lasciando aperto
solo il lato orientale dove da Pechino nessuno fa lo schizzinoso. Parte del business energetico
russo sarà deviato nei prossimi decenni su altre direttrici, ma i legami con l’Europa non potranno
saltare, dato che la dipendenza è in qualche modo simmetrica. Il secondo tempo della partita
ucraina non è terminato, dato che sarà anche ciò che succederà a Kiev a determinare i prossimi
sviluppi nel contesto internazionale. L’Occidente sembra interessarsi poco dei giochi di potere
interni ucraini, esattamente come successo dopo la rivoluzione arancione. Anche se alcuni fattori
in Ucraina sono cambiati, il prodotto finale difficilmente cambierà e a qualcuno dovrà raccogliere
i cocci di un paese a pezzi.
A che servono le sanzioni?
Rassegna Est, 26 novembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
A ormai sei mesi dall’introduzione delle prime sanzioni di Unione Europea e Stati Uniti contro la
Russia è possibile fare un bilancio provvisorio sulla strategia occidentale nei confronti di Mosca
nella cornice della crisi ucraina, basandosi da un lato sugli aspetti economici, dall’altro sugli
sviluppi politici. Dal primo punto di vista è evidente che gli effetti dei provvedimenti hanno
creato notevoli problemi, appesantendo sia la situazione congiunturale in Russia, sia provocando
danni a settori di alcuni economie europee ben legate a Mosca, soprattutto Germania e Italia, ma
non solo. Meno evidenti per non dire nulli sono i rimbalzi sugli Stati Uniti.
Dal secondo punto di vista è altrettanto chiaro che il Cremlino non si è certo impressionato e non
ha cambiato linea nella propria politica nei confronti di Kiev. C’è dunque da chiedersi se e a cosa
servono le sanzioni. Se l’obbiettivo è quello di costringere Vladimir Putin a fare dietrofront e
ripensare l’approccio verso l’ex repubblica sovietica, sei mesi non sono stati certo sufficienti. Ed è
difficile che nei prossimi sei si concretizzi un cambiamento. Se invece lo scopo è quello di
indebolire ulteriormente l’economia russa, allora pare che il gioco valga la candela, soprattutto
tirando le fila da Oltreoceano.
239
In questa prospettiva rientrano le accuse mosse da Mosca a Washington di puntare ad un cambio
di regime in Russia. «L’Occidente sta dimostrando senza ambiguità non di voler costringere la
Russia a cambiare politica: vuole arrivare ad un cambio di regime», ha detto recentemente il
ministro degli esteri Sergei Lavrov, che citato dalle agenzie ha espresso chiaramente il parere
condiviso da Putin che le sanzioni devono essere tali da distruggere l’economia e provocare
proteste popolari. Per Mosca l’Occidente non punta insomma «a cambiare la politica» russa, «cosa
di per sé illusoria», ma a «cambiare il governo».
Le sanzioni occidentali hanno ferito l’economia della Russia,
ma non hanno fatto ancora cambiare idea a Putin sull’Ucraina.
L’interpretazione del Cremlino è sicuramente discutibile, ma il dato di fatto è proprio che le
sanzioni a livello politico non hanno avuto nessun effetto positivo per la soluzione della crisi
ucraina e hanno spinto anzi la Russia su posizioni più nazionaliste, rafforzando lo stesso Putin e
marginalizzando indirettamente la già debolissima opposizione liberale. Ufficialmente l’Unione
Europea mantiene ancora una linea dura e unitaria sulle sanzioni, ma è palese già ora che non
tutti sono d’accordo, non solo con un eventuale altro giro di vite, ma nemmeno con il
mantenimento, alla luce del fatto che gli effetti sono negativi su tutto il fronte. Prima vengono
allentate, meglio è. Per tutti, anche per l’Ucraina.
240
14
LA PAUSA
(dicembre 2014)
L’inverno blocca il conflitto nel Donbass e nella capitale nasce il
nuovo governo Yatseniuk, con la novità, appoggiata anche da
Poroshenko, di tre ministri stranieri. A simboleggiare in qualche modo l’impotenza di Kiev di
sollevarsi con le proprie forze, ma anche la scelta di campo che il nuovo potere sta tentando di fare.
L’economia continua a sprofondare, ma le riforme strutturali non sono ancora all’orizzonte e di
fronte a un anno che si chiude in maniera disastrosa le prospettive per quello nuovo non sono certo
rosee. Il governo si preoccupa più della politica estera che di quella interna e se da un lato si
abolisce lo status di paese neutrale per fare un passo verso la Nato, dall’altro le questioni
fondamentali della riforma della Costituzione e del decentramento rimangono al palo.
Accampamento ucraino sul fronte del Donbass (Bo Svoboda / Wikipedia, Picasa)
241
Il governo straniero
Limes, 3 dicembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Natalia Jaresko, Aivaras Abromavicius e Alexander Kvitashvili, un’americana, un lituano e un
georgiano. Sono i membri stranieri del nuovo governo di Kiev, nominato ieri. Li ha voluti il
presidente Petro Poroshenko, che ha concesso al terzetto la cittadinanza dell’ex repubblica
sovietica. Abramavicius e la Jaresko, che vengono dal mondo degli investimenti privati, sono
andati a presiedere i ministeri dell’economia e delle finanze. Kvitashvili s’è preso la sanità, uno
dei settori più corrotti del paese. Il terzetto ricopre ruoli delicati e importantissimi, dunque.
Tanto che qualcuno, tenuto conto che Abramavicus e la Jaresko provengono da paesi schierati
senza indugi con Kiev, mentre Kvitashvili è stato ministro a Tbilisi ai tempi della presidenza
Saakashvili, considera che il governo sia eterodiretto. Nel nuovo esecutivo ci saranno altri
stranieri, a quanto pare circa venticinque. Serviranno nei ministeri e sono stati reclutati da
rinomati cacciatori di teste internazionali. Il processo è stato sostenuto finanziariamente dalla
Reinassance Foundation, organizzazione con sede a Kiev. Fa parte della costellazione di gruppi
patrocinati dalla Soros Foundation. I teorici del complottismo hanno davvero molto pane da
mettere sotto i denti.
Poroshenko ha messo il timbro anche su un’altra novità, a dire il vero molto contestata: la
creazione di un ministero dell’informazione. È andato a Yuriy Stets, esponente del Blocco
Poroshenko, il partito presidenziale. Alle elezioni dello scorso ottobre ha ottenuto la seconda
piazza, scavalcato a sorpresa dal Fronte popolare, formazione nata da una scissione consumatasi
all’interno di Patria, il partito di Yulia Tymoshenko. La guida Arseni Yatseniuk, primo ministro
uscente e rientrante. È stato confermato al vertice del governo.
Non poteva essere altrimenti. La scelta dei posti che contano, in questo governo, sostenuto da
una coalizione a cinque che tiene dentro anche i partiti della Tymoshenko e di Oleg Lyashko,
nuovo campione del radicalismo nazionalista, uscito tuttavia ridimensionato dal voto, riflette la
volontà di lanciare al tempo stesso messaggi di continuità e rottura. Il primo elemento è
assicurato dal fatto che i responsabili di esteri, interno e difesa, Pavlo Klimkin, Stepan Poltorak e
Arsen Avakov, sono rimasti al loro posto. Mossa suggerita dalla triplice necessità di negoziare a
242
livello internazionale, gestire la situazione al fronte e mantenere gli equilibri tra forze armate e
gruppi volontari, la nuova cartina di tornasole dei rapporti tra autorità centrale e potentati
oligarchici (che armano i paramilitari).
Quanto al discorso sulla rottura, il campo in cui teoricamente va a dispiegarsi è l’economia. Kiev
deve fare riforme incisive, se intende dare una scossa all’intera impalcatura economica,
penalizzata da scarsa redistribuzione (tutto è in mano agli oligarchi e manca una vera classe
media), corruzione cronica e apparati produttivi inefficienti. Natalia Jaresko e Aivaras
Abramavicus dovranno dare un senso e un verso all’economia, che nel frattempo si sta sempre
più sfasciando. Sette i punti di Pil che andranno persi quest’anno. Moneta svalutatissima. Riserve
quasi esaurite. Capitali in fuga.
Oltre che di riforme, Kiev abbisogna di una montagna di soldi. Almeno una dozzina di miliardi di
dollari in più, secondo il Financial Times, rispetto a quelli finora messi in conto dal Fondo
monetario e da altri donatori internazionali. Pena il fallimento. Ma questi finanziamenti non sono
facili da garantire, proprio in virtù di uno scenario fragilissimo, che non predispone a toccare i
cordoni della borsa. Si chiude con il ministero dell’informazione. Essendo in guerra, Kiev nutre
l’esigenza di trattare le notizie. Ma la cosa ha sollevato notevoli polemiche nella comunità
giornalistica, sia perché la misura è stata discussa senza consultare la categoria, sia perché si
ritiene la libertà di stampa resti imbrigliata, impedendo al paese di fare su questo piano uno
scatto in avanti, rispetto alla poco edificante epoca contrassegnata dal potere di Yanukovich.
L’istituzione del ministero dell’informazione è stata affiancata da un altro provvedimento recente
che i giornalisti hanno duramente criticato: la scorta obbligatoria a chi si reca al fronte, alla
ricerca di notizie e di storie. Kiev dice che è una misura temporanea, ma non ha precisato per
quanto tempo resterà in vigore.
243
Nuovo esecutivo, vecchi problemi
Askanews, 3 dicembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
A Kiev è stato battezzato il governo guidato da Arseni Yatseniuk, sostenuto da un’ampia
maggioranza parlamentare. Il nuovo esecutivo ha il difficile compito di risollevare il Paese dal
baratro politico-economico, tra la guerra nel Donbass che con l’arrivo dell’inverno sta dando i
segni di effettivo congelamento e lo spettro del default, evitato per ora sola grazie agli aiuti
dell’Occidente. È un governo che nasce tra le perplessità di chi vede più le divisioni che la
coesione richiesta dal delicato momento. L’arrivo di tre ministri stranieri nella nuova compagine,
di cui due rappresentanti di fondi d’investimento alla guida di ministeri economici chiave, come
anticipato nei giorni scorsi dallo stesso presidente Petro Poroshenko, è inoltre un segnale che si
presta alle più diverse interpretazioni: da quelle più positive, di chi sottolinea la volontà del
tandem al comando Poroshenko-Yatseniuk di cambiare passo a tutti i costi affidandosi ad esperti
internazionali, a quelle negative di chi al contrario denuncia a gran voce una sorta di
commissariamento occidentale.
L’alleanza tra i due maggiori partiti della coalizione, il Fronte Popolare di Yatseniuk e il Blocco del
presidente Petro Poroshenko, non sembra in ogni caso solidissima e gli attriti di fondo che negli
scorsi mesi hanno caratterizzato il rapporto tra premier e capo dello Stato si sono espressi anche
nella fase di formazione del governo, mentre i tre partiti minori, Samopomich di Andrei Sadovy, il
Partito radicale di Oleg Lyashko e Patria di Yulia Tymoshenko, hanno fatto in sostanza da
spettatori. Alla fine ne è uscito un governo che il quotidiano indipendente Ukrainskaya Pravda ha
definito «del dissenso», sottolineando come per Yatseniuk II abbiano votato 288 deputati, ben
oltre sì la maggioranza assoluta (225+1), ma anche 43 in meno di Yatseniuk I, nato a fine febbraio
dopo il bagno di sangue di Maidan con un parlamento trasformista, e con 14 voti mancanti sulla
base di tutti la coalizione che ha in realtà a disposizione 302 seggi.
Non solo: la maggioranza si è spaccata già sulla decisione che ha riguardato il via libera al
governo, cioè la scelta di promuovere in blocco la nuova squadra o votare la fiducia sui singoli
ministri. La scelta del voto complessivo è stata approvata sul filo di lana con 228 voti, con i primi
malumori in seno a tutte le frazioni.
244
Il governo Yatseniuk II si presenta con facce vecchie e nuove, rispettando in sostanza gli equilibri
usciti dopo le elezioni parlamentari del 26 ottobre ed è fondato sui pilastri del Blocco Poroshenko
(Bpp) e del Fronte Popolare (Fp). Dopo che il delfino di Poroshenko Volodymyr Groisman è stato
nominato la scorsa settimana presidente del parlamento, terza carica dello Stato, i ministeri
chiave sono andati ai due partiti più forti: agli Esteri è rimasto Pavel Klimkin, già ex ambasciatore
in Germania ai tempi di Victor Yanukovich, ma considerato elemento fondamentale da
Poroshenko per i curare i rapporti diplomatici soprattutto in Europa. In quota presidenziale ci
sono anche i nuovi arrivati, i tre stranieri che ricopriranno incarichi fondamentali: l’americana
Natalia Yaresko, proveniente da Horizon Capital, gruppo finanziario che opera in Europa centroorientale, alle Finanze; il lituano Aivaras Abromavicius, in arrivo dal fondo svedese
d’investimento East Capital, all’Economia; il georgiano Alexander Kvitashvili, ex ministro della
salute sotto Saakashvili a Tbilisi, alla Sanità. Durante il suo discorso in parlamento il presidente
ha motivato la scelta di cooptare per la prima volta cittadini stranieri al governo sottolineando
l’assoluta necessità di portare in Ucraina leve provenienti dai paesi alleati occidentali.
Un segnale evidente dell’orientamento europeista e filoamericano di Kiev a discapito del dialogo
con la Russia e in sostanza un’arma a doppio taglio. Da un lato l’affidamento di due ministeri
come finanze ed economia ad ex rappresentanti di fondi privati d’investimento dovrebbe
secondo gli intenti facilitare la ripresa dell’economia ucraina grazie anche a migliori rapporti con
il Fondo monetario e gli investitori internazionali; dall’altro il marcato orientamento non
faciliterà certo le relazioni con la Russia, sia nell’ottica di breve periodo per la risoluzione della
crisi nel Donbass, che in quella del lungo, con lo sguardo ai rapporti commerciali ed energetici tra
Mosca e Kiev che non potranno essere messi nel cassetto. Nel governo rimangono al loro posto il
generale Stepan Poltorak alla Difesa, Arsen Avakov, alleato stretto di Yatseniuk, agli Interni e
Pavel Petrenko, sempre del Fronte popolare alla giustizia. Nuovi volti filopresidenziali sono
inoltre quelli di Vladimir Demcishin al delicato settore dell’Energia e di Yuri Stez al nuovo
ministero dell’Informazione politica, la cui creazione, contestata anche all’interno della stessa
coalizione di maggioranza, è stata difesa dal capo della frazione parlamentare del Bbp Yuri
Lutsenko che ha affermato che si tratterà di qualcosa di diverso da un ministero per la
propaganda di stile sovietico. In sostanza, rispetto al precedente, il governo Yatseniuk II risulta
ancora più sbilanciato verso occidente: se infatti come negli scorsi mesi rimangono esclusi per
forza di cose uomini provenienti dalle regioni dell’est, l’affidamento a tre stranieri di ruoli
245
fondamentali soprattutto nel settore economico finanziario dà un’impronta ben precisa al nuovo
esecutivo. Resta da vedere se le forze centrifughe interne potranno essere placate nei prossimi
mesi grazie a un lavoro di riforme rapido ed efficiente, con uno sguardo a quel dialogo nazionale
tra centro e periferia sino ad ora dimenticato, o se invece la coalizione di maggioranza, e nel
peggiore dei casi la stessa Ucraina, perderanno di nuovo qualche pezzo.
Lo spettro del default
Europa, 17 dicembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Una buona notizia dall’Ucraina. Cosa rarissima, di questi tempi. Nel 2013-2014 l’export di cereali
è cresciuto sensibilmente, stando ai dati forniti dai produttori. Sono state piazzate sui mercati
esteri venti milioni di tonnellate di grano e circa dieci di frumento. Nel biennio precedente ci si
era fermati a tredici e sette, rispettivamente. Non tutto ciò che luccica è oro, a ogni modo. L’ex
repubblica sovietica conferma il suo profilo da granaio. Eppure la curva delle esportazioni, più
che all’espansione della produzione, si lega alla perdita di valore della moneta, la hryvnia. Non si
tratta di una svalutazione competitiva, bensì di un vero e proprio crollo. Il primo gennaio di
quest’anno il rapporto tra dollaro e hryvnia, tralasciando i decimali, era di uno a otto. Ora è di uno
a sedici. In pratica, la valuta ucraina ha perso in dodici mesi il 100% del suo valore, affondata
dalla crisi politica e militare che il paese sta vivendo. Anche se significativo, la caduta della
hryvnia è un solo un dettaglio. È l’intero telaio dell’economia di Kiev, già messo a dura prova al
terremoto finanziario del 2008-2009, che sta infatti perdendo pezzi. Davanti a tutto questo i dati
sull’export di grano e frumento sono poca cosa. Non spostano di un centimetro il quadro. La
buona notizia è relativa.
Fallimento: tutto sembra portare verso questo epilogo. Il Pil, nel 2014, è destinato a perdere circa
sette punti percentuali. Dieci circa ne ha persi la produzione industriale, tra gennaio e ottobre.
L’inflazione, proprio in virtù del rendimento pessimo della moneta, ha sfondato il tetto del 20%,
procedendo di male in peggio. Il paese, da qualche mese, s’è messo inoltre a importare carbone.
246
Prima era totalmente autosufficiente, ma la guerra nelle regioni dell’est ha determinato la
chiusura di diversi impianti, ribaltando l’equilibrio della bilancia commerciale del settore e
causando persino qualche blackout. Il numero che più in assoluto preoccupa è tuttavia quello
delle riserve. Recentemente sono scese sotto i dieci miliardi di dollari. Livello critico, da default.
Servono soldi e servono subito.
Il denaro deve arrivare necessariamente da Occidente e il suo flusso dovrà essere maggiore, a
quanto pare, rispetto a quello stabilito lo scorso aprile dal Fondo monetario internazionale, il
maggiore tra i prestatori internazionali dell’Ucraina. L’istituzione diretta da Christine Lagarde
mise sul piatto diciassette miliardi di dollari in due anni, a cui si sono aggiunti finanziamenti di
taglia minore da parte di Stati Uniti e Unione europea.
Il patto, che chiedeva in cambio massicce dosi di riforme, è stato siglato in aprile. Da allora la crisi
nell’est del paese s’è evoluta in peggio, spingendo ulteriormente verso il basso i fondamentali
dell’economia. Le riforme varate, invece, sono state di portata limitata. Conseguentemente il Fmi
(che ha già assistito Kiev nel 2009 salvo poi sospendere il prestito) non si fida più di tanto. Teme
che l’Ucraina, dovesse rimandare le consegne, diventi una gola senza fondo. Discorso condiviso
dall’Unione europea.
È anche vero, in ogni caso, che Kiev, alle prese con il costoso sforzo bellico, potrebbe dichiarare la
bancarotta in assenza di una rapida iniezione di liquidità. Se così fosse, il senso dello sforzo con
cui l’Occidente ha deciso di sostenere politicamente l’Ucraina evaporerebbe. È quindi probabile
che nei forzieri di Kiev venga dirottata un’ulteriore somma, ancora non quantificabile (si parla di
almeno una dozzina di miliardi). Stavolta Christine Lagarde e l’Ue pretenderanno zelo riformista.
Non a caso una delegazione del Fmi s’è recata a Kiev, in questi giorni, in cerca di certezze.
Si direbbe che gli inviati della Lagarde abbiano saputo spiegarsi, se è vero che il governo ucraino
è in procinto di fare quello che ha sempre evitato: aumentare la bolletta del metano, tenuta
artificiosamente bassa da tutti i governi che si sono succeduti alla guida del paese. Questioni di
consenso e di voti. Salirà dalle tre alle cinque volte, ha spiegato Andrei Kobolev, il numero uno di
Naftogaz, l’azienda statale del gas.
247
Un altro segnale che deporrebbe a favore della volontà di fare le riforme sta nella presenza, nel
nuovo governo, di tre tecnici non ucraini. Sono l’americana Natalia Jaresko, il lituano Aivaras
Abromavicius e il georgiano Alexander Kvitashvili. La prima è ministro dell’economia. Il secondo
è andato alle finanze. Il terzo alla sanità, bastione della corruzione endemica di cui soffre il paese.
Tre dicasteri chiave, dunque, su cui si misurerà la volontà del duo Poroshenko-Yatseniuk di
costruire l’Ucraina post-sovietica e aderire alle richieste dei prestatori.
La strada è però anche lastricata di ostacoli, insidie, dubbi. Le riforme infatti vanno a incidere in
un tessuto economico dominato da poche, potenti oligarchie che di liberalizzazioni e
competitività non ne hanno mai voluto sentire e che oggi, in tempi di conflitto armato, esercitano
su Kiev una nuova forma di pressione. Gli oligarchi, infatti, finanziano i battaglioni paramilitari
che affiancano sul fronte dell’est l’esercito regolare. Senza queste milizie l’Ucraina non
riuscirebbe a tenere testa ai ribelli filorussi. Il potere di ricatto dei tycoon è quindi molto forte e
potrebbe tradursi proprio nell’annacquamento delle riforme.
Le riforme sono vitali, per incassare i prestiti occidentali, evitare il crack
e imprimere il ritmo del cambiamento.
Ma non è scontato che incidano in tempi rapidi.
Ma riforme significa anche tagli, austerità, cura draconiana. E Foreign Policy s’è chiesto se sia
questa la ricetta idonea, tenuto conto che l’Ucraina, malmessa com’è, avrebbe bisogno più di
stabilit{ che di austerit{. Ma stabilizzare, visto che l’Ucraina sta andando alla deriva, può
significare gettare soldi all’infinito nel pozzo. C’è da considerare anche questo aspetto.
Qui si torna ai piedi dell’albero. Da una parte c’è Kiev che deve spendere soldi per sostenere la
guerra e chiederne di aggiuntivi per fare le riforme, motivando la cosa proprio in virtù della crisi
militare (si può dire che sia tatticamente conveniente continuare la guerra?). Dall’altra
l’Occidente, che appoggia il cambio di direzione politica che Kiev sta prendendo, ma rischia anche
di spendere più del dovuto. Intanto il tempo stringe e il fallimento non è un fattore fantapolitico.
248
L’Ucraina non è più neutrale
Europa, 23 dicembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
L’Ucraina abbandona lo status di neutralità e fa un altro passo per tracciare una linea rossa tra
vecchio e nuovo. Tra l’era Yanukovich (fu lui a volere lo status neutrale nel 2010) e la stagione
incominciata con la Maidan, proseguita con l’ascesa alla presidenza di Petro Poroshenko,
rafforzata con il rinnovo del parlamento e l’uscita di scena, dall’assemblea, dei comunisti e del
Partito delle regioni, la formazione capitanata un tempo da Yanukovich. Tanti sono i fattori che
pesano sul paese, a partire da un’economia accartocciata, dall’influenza che giocano le élite
oligarchiche e - logicamente - dallo scenario nell’est del paese, dove la guerra è meno intensa,
rispetto ai mesi addietro, ma la situazione resta in bilico.
L’abbandono dello status di neutralità non significa adesione alla Nato.
L’esercito ucraino, per essere pronto, ha bisogno di tempi lunghi.
La scelta indica però che Kiev ha intenzione di ancorarsi all’Occidente.
La scelta di disfarsi del rango di paese non allineato - solo otto parlamentari hanno votato contro
- non va vista come l’anticamera di un’adesione alla Nato. La stessa Alleanza atlantica si guarda
bene dal discutere questa opzione. L’Ucraina è uno stato lacerato, debole, quasi fallito. Cooptarlo
sarebbe una forzatura enorme, tenendo conto del fatto che la prassi prevede, prima del disco
verde formale e finale all’accesso, il pieno rispetto di criteri politici e democratici, oltre a una
grossa iniezione di riforme militari.
L’esercito ucraino, sotto questo aspetto, è molto indietro. In molti, tra ufficiali e truppa, sono
passati dall’altra parte, nelle file dei ribelli. Armi e munizioni sono spariti dai depositi. La guerra a
est, senza l’appoggio dei battaglioni di volontari, pagati dagli oligarchi, sarebbe impossibile da
sostenere. La Nato è molto lontana, in altre parole.
Il passaggio parlamentare di ieri significa altro. Testimonia come il crinale tra un’Ucraina e l’altra,
tra l’Occidente e la Russia, si stia facendo più impervio. Kiev va da una parte, le regioni controllate
249
dai filorussi dall’altra. L’Europa, incredibilmente, è riuscita a restare coesa, malgrado vari
mugugni, nel mantenere le sanzioni che stanno affondando l’economia russa (oggi una nota di
Standard & Poor’s fa sapere che l’agenzia ha messo sotto osservazione il debito russo, per
valutare un declassamento da BBB a BBB-). Mosca, da parte sua, ha rinunciato al rapporto
privilegiato con l’Europa e - notizia fresca - ha aperto anche al Kirghizistan le porte dell’Unione
doganale eurasiatica. Il progetto di coesione politico-economica nel cortile di casa, voluto
fortemente da Putin, va avanti. È mutilato, dato che l’Ucraina doveva esserne un pilastro. Ma va
avanti.
Domani e nel giorno di Santo Stefano si terrà a Minsk, in Bielorussia, un’altra tornata di colloqui
internazionali sull’Ucraina. È evidente che in questo modo non si può continuare, sia dal punto di
vista strategico che in relazione alle questioni economiche. Tutti dicono di volere la pace e il
compromesso, ma nel frattempo s’aspetta che l’avversario dia segni di cedimento e si mette
qualche altra pietra, pesante, in cima al muro. Non sarà facile buttarlo giù.
Annus horribilis
Rassegna Est, 31 dicembre 2014
________________________________________________________________________________________________________________
Si chiude per il paese un anno disastroso, dal punto di vista politico ed economico. L’Ucraina che
esisteva nel dicembre 2013 ora non esiste più e quella di oggi non sarà uguale a quella di domani.
Rispetto a un anno fa la Crimea è stata annessa dalla Russia e Kiev non ha più il controllo sul
Donbass, con parte del sudest occupata da separatisti filorussi. Altre regioni sono a rischio e da
Kharkiv a Odessa il prossimo anno si annuncia tutt’altro che quieto.
Nella capitale il presidente eletto a maggio è stato affiancato dal nuovo primo ministro, uscito
dopo la tornata elettorale di ottobre: Petro Poroshenko e Arseni Yatseniuk costituiscono il
tandem che dovrebbe tenere insieme il Paese. A livello politico l’unità di intenti, al di là della
propaganda, è solo la facciata di una realtà molto più complessa, che ricalca schemi e meccanismi
dell’Ucraina di sempre.
250
Il sistema oligarchico è ancora quello portante, con tutti i suoi effetti collaterali, amplificati dal
fatto che Kiev si trova in uno stato di guerra. Alla Rada la maggioranza è adesso larga, ma gli
equilibri sono fragili: le posizioni del capo dello stato e del premier sono complicate e su di loro
pende la spada di Damocle delle riforme. Oltre a quelle economiche, da implementare sotto la
supervisione del Fondo monetario internazionale, fondamentali sono quelle costituzionali e
amministrative, da quella della Costituzione al decentramento. Senza di esse e senza risposte
concrete all’elettorato, la nuova élite sarà sempre più sotto pressione, in relazione soprattutto a
quello che succederà nel Donbass, quando la situazione militare inizierà a scongelarsi.
L’Europa, intesa come Unione Europea, è ancora un miraggio. L’Accordo di Associazione, che lo
stesso Victor Yanukovich avrebbe voluto rimandare, è stato sì firmato, ma la sua entrata in vigore
è stata procrastinata all’inizio del 2017 dopo un’intesa trilaterale tra Bruxelles, Kiev e Mosca. I
rapporti con la Russia saranno fondamentali per la tenuta dell’Ucraina anche sul breve periodo.
Senza un avvicinamento delle posizioni tra Bankova e Cremlino, l’Ucraina rischia di precipitare
ancora di più verso il fondo: da questo punto di vista la linea antirussa di Yatseniuk è molto più
pericolosa di quella più moderata di Poroshenko. Il Paese è lacerato e lo scivolamento sul lato
nazionalista, se da un lato è servito in un primo momento a rinserrare le fila, dall’altro non può
che portare a ulteriori strappi, dentro e fuori.
Difficile dire dove sarà l’Ucraina tra un anno, dipende da quale scenario (pessimistico o
ottimistico) si vuole prendere in considerazione: realisticamente i primi tre-sei mesi del 2015
non dovrebbero produrre novità dal punto di vista politico ed è probabile che da un lato la
situazione del Donbass rimanga congelata (salvo esplodere nel secondo trimestre) e dall’altro a
Kiev governo e presidente proseguano su un unico binario. I fondi della comunità internazionale,
Fmi e Unione Europea, eviteranno il crollo in attesa della realizzazione delle riforme, ma
l’economia risentirà inevitabilmente degli sviluppi della situazione geopolitica, sia interna che
internazionale. L’annus horribilis per l’Ucraina è passato, ma il prossimo potrebbe essere
altrettanto devastante.
251
15
PRIMA E DOPO MINSK
(gennaio-febbraio 2015)
Il 2015 inizia nel peggiore dei modi. Il cessate il fuoco stabilito a
Minsk a settembre, mai rispettato appieno, salta definitivamente.
Gli scontri conoscono un’ulteriore escalation. La diplomazia si attiva in fretta per evitare il disastro
totale. Ci si ritrova nella capitale bielorussa. Angela Merkel, Francois Hollande, Petro Poroshenko e
Vladimir Putin negoziano una nuova tregua e le basi per la stabilizzazione dell’ex repubblica
sovietica. L’intesa servirebbe sia a Kiev che a Mosca, se non altro per tornare a concentrarsi
sull’economia, tema molto problematico su entrambi i lati della barricata. La Russia soffre sanzioni
e crollo dei prezzi del petrolio. L’Ucraina sta in piedi solo grazie all’intervento, rinnovato tra l’altro
nel giorno del vertice di Minsk, del Fondo monetario internazionale. La situazione resta comunque
“ibrida”. In questa crisi non s’intravede ancora la parola fine.
I negoziatori degli accordi di Minsk (Kremlin.ru)
252
La guerra dei media
Lettera 43, 18 gennaio 2015
________________________________________________________________________________________________________________
Al principio era Radio Londra: ancora prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale la Bbc
aveva iniziato a trasmettere programmi radiofonici di propaganda in diverse lingue nei Paesi
dell’Europa continentale. Dopo il 1945 e con l’inizio della Guerra fredda partirono quelli in russo
indirizzati all’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti non furono da meno e dal 1949 cominciarono la
lotta mediatica con Radio Free Europe/Radio Liberty (Rferl) dal quartiere generale di Monaco di
Baviera. La Germania stessa non perse tempo e dal 1953, da Colonia, la Deutsche Welle prese a
martellare a tappeto tutta l’Europa dell’Est. Il 1989 e il crollo del comunismo furono un po’ anche
la vittoria dell’Occidente nel conflitto via radio, anche perché dall’altra parte non c’era nemmeno
lo straccio di un avversario.
Se negli ultimi cinque lustri pareva che il nuovo ordine scaturito dopo la caduta del Muro di
Berlino non dovesse subire scossoni, la crisi in Ucraina ha riportato l’Europa invece alla realt{ e
aperto la nuova fase della guerra dei media. Con la differenza che stavolta non si tratta di
combattere sulle onde corte. Il terreno di battaglia è il villaggio globale, in tutte le sue sfumature:
dalla radio alla televisione, dalla carta stampata a internet.
La guerra vera si vince o si perde ancora sul campo, ma con la manipolazione dell’opinione
pubblica si fa già un passo avanti per esaltare un trionfo o addolcire una sconfitta. Ecco perché
sin dal suo inizio la questione ucraina è stata al centro della propaganda di ciascun attore
coinvolto - Kiev, Mosca, Bruxelles e Washington - e su ogni lato la narrazione degli eventi è
sempre stata funzionale agli scopi politici. Non per nulla la prima cosa che hanno fatto i
separatisti filorussi quando hanno occupato Donetsk e Lugansk è stata quella di controllare le
stazioni televisive, mentre da Kiev allo stesso tempo sono stati oscurati i canali russi.
Se da Mosca si è lanciato il nuovo canale Sputnik, affiancato all’ormai affermata Russia
Today (entrambe in lingue differenti) in Ucraina la contromossa è stata quella dell’oligarca Igor
Kolomoisky, gran nemico di Vladimir Putin, che ha pensato di investire qualche miliardo di
grivne in Ukraine Today, la risposta al network del Cremlino, per ora solo in inglese.
253
Naturalmente gli operatori storici sul versante occidentale lavorano a pieno ritmo e sia Bbc sia
Rferl informano in russo e in ucraino, oltre che in inglese. Lo stesso fa la Deutsche Welle che, che
spinta dalla volontà di mediazione di Angela Merkel ha investito per i prossimi anni milioni di
euro per il potenziamento dei programmi in due lingue tra Mosca e Kiev.
Lo scorso dicembre è circolata la notizia che anche l’Unione europea vorrebbe presto entrare nel
gioco, sponsorizzando una tivù satellitare in russo per contrastare la propaganda in arrivo da
Mosca sul continente. Promotori dell’idea sarebbero i paesi antirussi per eccellenza, dalla Gran
Bretagna ai Paesi baltici. L’iniziativa potrebbe trovare concretezza proprio nel semestre appena
iniziato sotto la presidenza lettone. Il nuovo canale dovrebbe trasmettere anche nelle ex
Repubbliche sovietiche legate a Bruxelles dalla partnership orientale (Ucraina, Georgia, Moldavia,
Bielorussia, Armenia e Azerbaigian).
Come andrà a finire la guerra dei media tra Russia e Occidente? Rispetto ai tempi di Radio
Londra di cose ne sono cambiate e l’avvento di internet ha scombussolato le carte in tavola, su
tutti i fronti. In Russia e nelle ex Repubbliche sovietiche il web rimane in sostanza uno spazio
ancora libero, cioè non strettamente controllato come in Cina o in Corea del Nord, e la
manipolazione dell’opinione pubblica avviene attraverso la televisione, a Mosca come a Kiev. Se
la Russia secondo Reporter senza frontiere è al 148esimo posto nella classifica della libertà di
stampa, l’Ucraina è al 127esimo: la differenza insomma è minima. Ovunque in tutta l’ex Urss sono
i grandi gruppi, pubblici o privati, a detenere un quasi-monopolio dell’informazione, declinata
politicamente a seconda delle esigenze. In questo quadro l’Occidente si inserisce combattendo la
propaganda con la propaganda, sancendo il principio che nella guerra dei media la prima vittima
è come sempre la verità, perché la storia raccontata a metà rimane comunque una bugia.
254
Escalation
Lettera 43, 4 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________________
A quasi un anno dal bagno di sangue di Maidan (18-20 febbraio 2014) l’Ucraina rischia di
sprofondare nella guerra totale. L’escalation militare delle ultime settimane nel Donbass e il
fallimento della diplomazia internazionale nel mettere il coperchio alla pentola che bolle
(comunque sia in queste ore Merkel e Holland stanno ancora provando a mediare con Mosca)
stanno prospettando uno scenario catastrofico per l’ex repubblica sovietica, che dopo la cacciata
dell’ex presidente Victor Yanukovich si è avvitata in una spirale bellica dalla quale non è più
uscita. Prima l’annessione della Crimea da parte della Russia, in seguito la sollevazione del SudEst e l’ondata separatista avevano gi{ portato lo scorso anno il Paese sull’orlo del collasso. La
tregua di Minsk, concordata a settembre 2013 sotto la regia dei presidenti di Ucraina e Russia,
Petro Poroshenko e Vladimir Putin, aveva fatto sperare poi in un possibile compromesso.
La fragile tregua stabilita a settembre è saltata, a Est si ricombatte duramente.
Dietro le quinte la diplomazia è al lavoro per rammendare gli squarci.
Dopo l’illusione autunnale e la breve pausa invernale, quando a dicembre le due parti avevano
ribadito la volont{ di mantenere l’armistizio e provare a cercare l’uscita dal tunnel, l’inizio del
2015 si è aperto nel peggiore dei modi: la ripresa delle ostilità nel Donbass ha coinciso con la
crescita della tensione a livello internazionale e il pericolo di un allargamento della guerra, in cui
da una parte la Russia sostiene i separatisti delle Repubbliche autonome di Donetsk e Lugansk e
dall’altra gli Stati Uniti affiancano il governo di Kiev. Il presidente americano, nonostante le
timide smentite, valuta persino l’invio di armi all’Ucraina. E il suo omologo da Kiev si dice certo
che arriveranno. Ma se la situazione è molto fluida e gli scenari futuri sono diversi è perché agli
attori in campo mancano, per varie ragioni, strategie precise e univoche.
Tra marzo e aprile 2014 i ribelli filorussi hanno occupato mezzo Donbass tra l’indifferenza e la
complicità delle istituzioni amministrative, militari e civili, e gli applausi della maggioranza della
popolazione locale. Dopo i referendum per l’indipendenza di Donetsk e Lugansk e l’inizio di
quella che il governo di Kiev ha definito un’operazione antiterrorismo (15 aprile 2014) per
riconquistare i territori perduti, le regioni si sono trasformate in un teatro di guerra. I separasti
ucraini non sono mai stati un blocco monolitico, ma hanno avuto sin dall’inizio diverse anime e
255
diverse finanziatori. A gestire la rivolta contro il governo centrale sono stati i poteri forti locali,
gli oligarchi legati al vecchio establishment, a cui si sono aggiunti presto variegati gruppi, da quelli
della criminalit{ organizzata a quelli pilotati dall’esterno, dai mercenari russi e ceceni ai volontari
provenienti da diverse repubbliche dell’ex Urss.
La Russia, con il passare dei mesi e l’inasprirsi del conflitto, è scesa in campo sottotraccia, in
maniera diretta e indiretta, a fianco dei separatisti, senza però assumere il controllo militare della
situazione. In sostanza i leader delle due repubbliche autonomiste Alexander Zakharchenko e
Igor Plotnitsky e i vari comandanti sul campo agiscono un po’ per contro proprio e un po’ per
conto terzi, e proprio per questo è difficile prevedere quali saranno le loro prossime mosse.
Al di là della propaganda è comunque un fatto che dalla ripresa del conflitto hanno guadagnato
terreno, conquistando l’aeroporto di Donetsk. A Debaltseve si sta assistendo a ciò che è accaduto
l’estate scorsa a Ilovaisk, con la disfatta delle truppe di Kiev, e Mariupol, porto strategico sul Mar
Nero, potrebbe essere il nuovo obiettivo.
Nella capitale la situazione è complicata. Da una parte il presidente Petro Poroshenko cerca
ancora il dialogo, dall’altra il premier Arseni Yatseniuk preme per la soluzione militare del
conflitto. Il partito della guerra a Kiev tenta con insistenza di coinvolgere l’Occidente nel conflitto
e la richiesta di sostegno armato è stata fatta ormai in tutte le sedi, da Washington a Berlino,
passando per la Nato. Per ora le truppe governative e i vari battaglioni di volontari che sono stati
più o meno integrati o nell’esercito o nella guardia nazionale sono però rimasti sostanzialmente
all’asciutto. L’engagement occidentale si è limitato al supporto attraverso cosiddette armi non
letali e a consulenze militari e d’intelligence.
Al di là però delle questioni militari il vero problema è lo stallo delle riforme, che non riguardano
solo il Donbass, ma anche altre regioni che dalla rivoluzione di febbraio 2014 aspettano di vedere
mantenute le promesse di decentramento e autonomia. Nulla di concreto è stato fatto e basta
guardare i rating di piena approvazione di Poroshenko (13%) e Yatsenik (11%) per capire che gli
elettori ucraini non sono proprio soddisfatti. Se c’è la guerra a mettere i bastoni tra le ruote alla
ripresa dell’economia, le riforme costituzionali si fanno in parlamento e alla Rada il governo è
stato eletto a dicembre con la maggioranza di due terzi. Il fatto che tutto stia andando a rotoli
rientra nei meccanismi tipici della politica ucraina, dominata dagli stessi poteri oligarchici.
La soluzione della crisi sta ovviamente a Kiev, ma soprattutto tra Mosca e Washington. Senza un
accordo sostanziale sull’Ucraina tra il Cremlino e la Casa Bianca, il Donbass corre il pericolo di
finire peggio della Transnistria.
256
Sino ad ora nessuno dei due contendenti ha preso in considerazione l’idea di fare un passo
indietro: non la Russia, decisa a supportare il separatismo e mantenere un piede in Ucraina, non
gli Usa, che dopo il cambio di regime dello scorso anno si sono schierati con i falchi di Kiev e
hanno alzato il tiro contro Mosca spingendo per le sanzioni
L’Europa da parte sua si è attaccata al treno americano, ma i vagoni di Bruxelles non seguono
tutti lo stesso binario: nonostante la facciata, numerose sono le differenze tra il gruppo
intransigente filoamericano, con Gran Bretagna, Polonia, baltici e scandinavi, e quello più
accomodante verso la Russia, con Francia, Italia, Austria e Ungheria. La Germania della Grosse
Koalition sta nel mezzo e cerca sempre una soluzione diplomatica, con la conservatrice Angela
Merkel che un giorno picchia duro contro Vladimir Putin, e il socialdemocratico Frank Walter
Steinmeier che il giorno dopo lascia aperta la porta per il dialogo con il Cremlino.
Intanto però l’Ucraina continua a sprofondare e alla Conferenza internazionale sulla sicurezza di
Monaco (6-8 febbraio), dove sono attesi i rappresentanti di tutti i Paesi coinvolti nel caotico
puzzle, si cercher{ un’altra volta una difficile via d’uscita.
I rischi che Christine Lagarde corre a Kiev
Rassegna Est, 7 febbraio 2015
________________________________________________________________________________________________________________
Mentre la diplomazia europea si muove per gestire la crisi tra Kiev e Mosca, l’economia ucraina è
al collasso. Pochi giorni fa la banca centrale ha dovuto lasciar fluttuare liberamente la hryvnia e
ha alzato i tassi di cinque punti e mezzo, portandoli al 19.5%. Una manovra disperata per evitare
di perdere ulteriori riserve valutarie. All’inizio del 2014 un dollaro poteva essere scambiato con
8 hryvnia; poche settimane fa ne servivano almeno 16; ora oltre 25. Ed il cambio sul mercato
nero è ormai da mesi costantemente diverso da quello ufficiale. Il costo di qualunque bene
importato dall’estero è tre volte superiore ad un anno fa.
Due settimane fa le autorità di Kiev hanno chiesto nuovamente l’aiuto finanziario del Fondo
monetario internazionale. L’obiettivo è quello di poter aumentare la cifra disponibile rispetto a
quanto gi{ promesso in precedenza dallo stesso Fondo. In pratica l’Ucraina chiede un prestito
EFF di quattro anni (Extended Fund Facility) per sostituire quello SBA (Stand-By Arrangement),
che è biennale e non basta a coprire le necessit{. L’istituto presieduto da Christine Lagarde e gli
altri donatori stanno ancora discutendo sul da farsi.
La situazione dell’Ucraina è molto particolare. Il Fmi dovrebbe infatti finanziare, secondo il suo
statuto, paesi che possono comunque assicurare una certa sostenibilità della loro situazione
debitoria (avrebbe poco senso dare dei soldi ad un paese che comunque andrà in fallimento),
anche perché il Fondo non è un ente di beneficienza e vive anche grazie agli introiti derivanti dai
prestiti che eroga. Ma prestare denaro a uno stato in guerra appare come una situazione
inusuale: è infatti molto complesso poter valutare la sostenibilità del debito in un contesto in cui
lo stato ucraino deve sostenere lo sforzo bellico e l’economia del paese non d{ cenni di ripresa. E
in ogni caso sta divenendo sempre più chiaro che l’Ucraina non è in grado di onorare appieno gli
impegni verso i prestatori. Deve in pratica ristrutturare il debito, per esempio allungandone le
scadenze. Nel gergo del ministero delle finanze ucraino, “verranno consultati i creditori per
migliorare la sostenibilità di medio-lungo termine del debito ucraino”.
Alcuni indicatori economici spiegano come si sia arrivati a pensare al default come una delle
possibili alternative. Le riserve della Banca Centrale sono in fase di esaurimento, intorno ai 6
miliardi di dollari, rispetto ai 35 miliardi del 2011 e ai 15 miliardi del 2014. Una costante
emorragia che ha reso incontrollabile il cambio e riduce ogni capacità di poter ricapitalizzare il
sistema bancario. Il Pil è collassato di circa 7 punti nel 2014. Il debito pubblico si è mosso dal
40% del Pil nel 2013 (un livello considerato sostenibile) verso il 60% e potrebbe raggiungere tra
qualche mese l’80%. Anche le imprese sono indebitate ed alcune di loro avranno bisogno del
sostegno pubblico: due terzi del debito con l’estero è legato alla posizione debitoria delle grandi
imprese ucraine. Tutto ciò ha avuto effetto sulla valuta.
Ma torniamo al Fondo monetario: l’attuale pacchetto di aiuti è di 27 miliardi di dollari (di cui
meno di 10 miliardi già erogati), ma non basta. Il nuovo pacchetto sarà di almeno 25 miliardi (34
quindi se vi sommiamo quanto già erogato). Il Fondo Monetario è disposto a dare una tale cifra
alla disastrata economia ucraina, ancora in guerra e senza ancore di salvezza? Probabilmente
sì. E basterà l’ammontare erogato dal Fondo per far uscire in breve tempo l’Ucraina dalle secche
della recessione? Probabilmente no. Questo balletto di cifre e di successivi aggiustamenti si è già
visto con la Grecia e con altri paesi. Dapprima il Fondo monetario interviene, eroga una certa
somma, che si basa però su assunti troppo ottimistici e l’ipotesi di un grande impeto riformatore
del paese in questione; poi però è costretto a mettere di nuovo mano al portafoglio, o è il debito
che deve essere ristrutturato in qualche modo.
Ed è bene ricordare, per una eventuale ristrutturazione del debito, se fatta in modo “ordinato” ed
“amichevole”, ha bisogno del consenso dei creditori. Ed uno dei maggiori creditori è la Russia
(che possiede un bond di 3 miliardi di dollari in scadenza a dicembre). Il supporto finanziario è
una condizione importante per tentare di rimettere in sesto l’economia ucraina, ma non è
sufficiente finché la guerra non alleggerisce la pressione sull’economia. Anche perché le zone in
guerra pesano per il 20% dell’economia ucraina ed un terzo del suo export.
Quale negoziato?
Reset, 7 febbraio 2015
________________________________________________________________________________________________________________
Queste dovevano essere le settimane del negoziato tra Kiev e i ribelli filorussi. Ma tutto è finito,
già prima di iniziare. Quel che è peggio è che nell’est dell’ex repubblica sovietica i combattimenti
hanno avuto un’accelerazione violentissima. «Fermate dei bus, mercati, scuole, asili, ospedali e
aree residenziali sono divenuti normali campi di battaglia nelle regioni di Donetsk e Lugansk», ha
puntualizzato Zeid Ra’ad Al Hussein, l’Alto commissario dell’Onu per i diritti umani, ricordando il
tipo di guerra che ormai si combatte in Ucraina. Alla jugoslava, viene da dire. Ed è forse per
questo che Angela Merkel e Francois Hollande hanno deciso di andare prima a Kiev e poi a Mosca,
per riaprire una finestra di dialogo ed evitare il disastro totale.
Il già critico scenario è appesantito dalle prospettive di ulteriore militarizzazione. Aleksandr
Zakharchenko, numero uno della Repubblica popolare di Donetsk, che assieme alla Repubblica
popolare di Lugansk compone la Nuova Russia, l’entit{ secessionista ucraina, ha annunciato una
grossa mobilitazione. Si parla di centomila uomini, anche se il numero appare davvero
improbabile. Si sta reclutando anche all’altra parte della barricata, a Kiev. Il governo vuole
rafforzare le prime linee e recuperare il terreno perso negli scontri delle ultime settimane. Ma
deve fare i conti con le diserzioni, fenomeno in evidente crescita.
Il difficile momento di Kiev sta portando l’amministrazione Obama (ma anche la Nato) a meditare
seriamente sull’invio di aiuti militari. Su questo è stata appena sollecitata dalla Brookings
Institution, una cui analisi invita proprio a sostenere militarmente Kiev “con armamenti letali ma
non offensivi”. La stessa convinzione di Timothy Garton Ash. Lo storico britannico, influente
opinionista del Guardian, ha esortato l’Occidente a rompere gli indugi e fornire moderni
259
armamenti all’Ucraina di modo che possa difendersi dall’aggressione della Russia. Perché la tesi è
proprio questa: la guerra in Ucraina non la combattono due fazioni, bensì due stati, dato che i
ribelli del Donbass non sono che un’emanazione di Mosca.
Da parte sua la Russia sostiene che l’esercito ucraino è una legione straniera della Nato e che la
rivoluzione della Maidan, iniziata nel novembre del 2013 e culminata con la fuga di Yanukovich lo
scorso febbraio, è stata pilotata dall’Occidente. C’è poi uno stuolo di mezzibusti, opinionisti,
analisti e pensatori di corte che alza ancora di più i toni. Sergei Markov, politologo, propone il
rovesciamento governo ucraino e l’occupazione di Odessa e Kharkiv. Sono rimaste sotto il
controllo di Kiev, ma sono attraversate da tensioni. Il rogo impunito di Odessa è una delle ferite
aperte di questa crisi. Kharkiv, quando iniziò la crisi, è stata teatro di duri confronti tra
sostenitori e detrattori della Maidan.
Qualcuno considera l’ennesimo innalzamento degli scontri e della tensione internazionale come
un modo per alzare la posta e guadagnare punti negoziali nel momento in cui ci si siederà a
discutere. È lecito però nutrire dubbi sia sul quando, sia soprattutto sul come. La sintesi tra Kiev e
i filorussi, come tra l’Occidente e Mosca, è difficile. La Russia vuole un’Ucraina federale e neutrale,
ma Kiev fatica a pensarsi tale. Teme da una parte che l’evoluzione federale dei rapporti centroperiferia dia vita a uno stato nello stato, tenuto conto non soltanto del modo spiccio con cui i
filorussi hanno preso e gestiscono il potere a Donetsk e Lugansk, ma anche del caso della Crimea:
afferrata e portata a casa dai russi come fosse un soprammobile. Dall’altra parte, e proprio sulla
scorta di questo, Kiev è dell’avviso che tornare alla neutralit{, fino a poco tempo fa sancita
costituzionalmente, esporrebbe il paese al revisionismo russo, cui si imputa la rottura degli
accordi sanciti con il memorandum di Budapest del 1994. Allora, nella capitale ungherese, si
stabilì (firmatari i russi, gli americani e i britannici) che l’Ucraina avrebbe rinunciato al suo
arsenale nucleare in cambio di garanzie sull’integrit{ territoriale, anche se non furono
configurate soluzioni legali nette. Ma tant’è.
L’altra opzione negoziale è quella di un’Ucraina decentrata amministrativamente e libera di
scegliersi le alleanze che più le aggradano (il che non significa automatica adesione alla Nato).
Schema che non incontra il favore dei filorussi e del Cremlino. Sul primo punto si rimarca che
l’offensiva militare dei governativi ha guastato del tutto i rapporti centro-periferia, rendendo
necessario un ripensamento radicale dell’architettura dello stato. Quando al secondo, entra in
gioco l’ipotesi che la Nato coopti prima o poi Kiev, cambiando ulteriormente gli equilibri
nell’Europa orientale. A svantaggio di Mosca, s’intende.
260
Queste recriminazioni non sono prive di senso. Le operazioni militari dell’esercito regolare,
affiancati dai battaglioni paramilitari, sono state durissime. La popolazione civile non è stata
protetta adeguatamente. Né il governo ha fatto granché affinché l’est, dopo la caduta di
Yanukovich, non si sentisse stretto alle corde. Anzi, più volte s’è avuta l’impressione che la
costruzione dell’Ucraina post-sovietica, legittima aspirazione della rivoluzione della Maidan,
passasse attraverso forme nevrotiche di rivincita espresse da una parte del paese sull’altra.
Quanto alla Russia, che piaccia o meno e al di là dei mezzi usati, è fuori discussione che, in quanto
potenza, voglia opporsi alla compressione del cortile di casa, di cui l’Ucraina è senza ombra di
dubbio la zolla più importante.
Senza troppi giri di parole: siamo all’incartamento. Una condizione che va oltre il perimetro degli
stessi negoziati. È quasi esistenziale. Kiev è al verde. Senza i battaglioni paramilitari non
riuscirebbe a sostenere la guerra. Ma i battaglioni sono finanziati dagli oligarchi, che così facendo
tengono sotto ricatto il governo, timorosi delle infusioni massicce di riforme economiche che il
Fondo monetario internazionale e l’Unione europea hanno chiesto in cambio della concessione di
prestiti. Che intanto lievitano: il salvataggio dell’Ucraina si sta rivelando più salato del previsto.
Il Cremlino lavora ai fianchi il vicino, con l’intenzione di dimostrare che è uno stato del tutto
fallito e suggerire così agli euro-americani che Kiev non vale tutto questo ardore. Ma il prezzo da
pagare è altissimo, in termini economici. Nel breve periodo è sostenibile, più in là nel tempo
chissà. A ogni modo Washington e Bruxelles tengono duro: nessuna ritirata. Ma anche qui il costo
dell’impegno si impenna. Gli americani meditano di imboccare la strada incerta e pericolosa degli
aiuti militari. L’Europa, tra sanzioni e relative contro-sanzioni russe sull’agroalimentare, ha
mandato in fumo tanti affari e perso quote di mercato.
Le letture sull’approccio di Bruxelles alla crisi ucraina sono contrastanti. C’è chi lo bolla come
un’ennesima prova di nanismo politico e chi al contrario vede nella decisione di insistere con le
sanzioni alla Russia – diverse capitali le hanno criticate, salvo poi votarle – la volontà di affermare
il diritto a offrire inclusione a paesi terzi, in linea con la missione dell’allargamento.
Il tempo dir{ se è vera la prima o la seconda teoria, se c’è un po’ dell’una e dell’altra insieme. Ma
già da ora una conclusione si può azzardare. La crisi ucraina ha demolito quell’idea, coltivata in
certi ambienti del vecchio continente, secondo cui l’Europa e la Russia sarebbero complementari,
come destinate a creare qualcosa di più strutturato di una semplice benché intensa relazione di
mercato. Questa lettura non ha tenuto nella debita considerazione l’asset dei diritti e dei valori. I
legami forti s’instaurano anche grazie a questo ingrediente.
261
La Russia non ne è ricca. Anzi, da quando Putin è al potere (2000) la sfera dei diritti è stata limata
progressivamente. Il Cremlino ha dato ai russi migliori condizioni di vita, ma ha preteso in
cambio che su libertà civili e politiche non si levassero troppe obiezioni. Non solo. Con Putin la
Russia ha vissuto una trasformazione di cultura politica che l’ha portata a ripudiare i paradigmi
liberali assorbiti confusamente durante l’era Eltsin e a virare verso una visione conservatrice
della società e del mondo. Parlare di complementarietà diventa difficile, davanti a questi aspetti.
Ma questa miopia è anche alla base dell’approccio europeo alla faccenda ucraina. Non avendo
capito la marcia intrapresa dalla Russia s’è come creduto che la storia avesse un andamento
lineare e che il modello economico e democratico europeo fosse esportabile ovunque, con i
consueti schemi e senza incontrare opposizioni. S’è visto invece che Putin ha fatto ciò che ha
fatto. Sarebbe tuttavia riduttivo considerare la Russia come unico freno allo sviluppo di rapporti
più solidi tra Europa e Ucraina. L’ex repubblica sovietica è sì vittima della geografia, ma nel corso
del tempo ha più volte dimostrato di essere refrattaria a ogni stimolo riformista e di non essere
capace di spostare il proprio baricentro politico accortamente, giocando di furbizia sia con gli
europei che con i russi, senza evitare scosse devastanti. Così anche questa volta è stato.
Le vere sfide del dopo-Minsk
Rassegna Est, 14 febbraio 2015
________________________________________________________________________________________________________________
A mezzanotte entrerà in vigore il cessate il fuoco in Ucraina, concordato al recente vertice di
Minsk. Ci si domanda se reggerà e se, oltre a questo, verranno garantiti anche gli altri punti
dell’accordo siglato nella capitale bielorussa.
Sono dubbi legittimi. Da una parte c’è il precedente tutt’altro che esaltante della tregua stabilita
lo scorso settembre, sempre a Minsk. Non è mai stata rispettata. Dall’altra, la lettura dei passaggi
messi nero su bianco (qui la traduzione di East Journal) indica che il futuro dell’Ucraina resta
delicato, incerto, variabile. Temi cruciali quali il controllo delle frontiere con la Russia e il grado
di autonomia concesso ai territori ribelli (dovrà essere sancito costituzionalmente), nonché i
trasferimenti finanziari dal centro alla periferia, andranno resi efficaci: sta qui la vera sfida. Molto
262
incerta, a dire il vero, è la tregua stessa. In queste ore, a quanto pare, si sta combattendo
duramente. Ma immaginiamo che tutto vada bene e proviamo a tracciare uno scenario.
Realisticamente parlando, sia la Russia che l’Ucraina possono trarre vantaggi dagli accordi, se essi
verranno immersi in una cornice legale. Sono vantaggi limitati, se comparati ai massimi obiettivi
che i due paesi rispettivamente si pongono. Ma è quanto di meglio in questo momento si può
ottenere. Decodifichiamo. Kiev vorrebbe svincolarsi del tutto dall’influenza della Russia, ma non
può che accettare la perdita della Crimea e tollerare l’esistenza di un Donbass fortemente
autonomo. Dal canto suo Mosca deve rinunciare al sogno di un’Ucraina integrata pienamente
nello spazio economico post-sovietico che Putin sta costruendo (senza Kiev si svuota in parte di
significato), ma guadagna una sorta di diritto di veto su ogni strappo o tentazione troppo filooccidentale da parte di Kiev. A questo servirà il Donbass. Assumerà il profilo di un conflitto
congelato mascherato. L’Ucraina come una Bosnia post-sovietica, se il paragone può servire
almeno a semplificare il quadro.
Se le armi tacessero realmente, la vera sfida sarà dare attuazione
e concretezza alle riforme costituzionali.
In tutto questo è interessante mettere a fuoco la dimensione economica. È decisiva e contribuisce
a spiegare il senso degli accordi. L’Ucraina non può più permettersi lo sforzo bellico, che la
vedrebbe comunque soccombere. L’economia è al collasso. Qualche giorno fa la Banca centrale ha
alzato i tassi di cinque punti, al 19,5%, autorizzando la fluttuazione della moneta, la hryvnia. È
svalutatissima e questo implica che ogni cosa importata dall’estero costi tre volte in più rispetto a
quanto veniva pagata un anno fa. Il tasso di cambio tra dollaro e hryvnia è infatti passato da uno a
otto a uno a venticinque nel corso degli ultimi dodici mesi. Tutto questo è economicamente
devastante. Porta alla glaciazione dei consumi e brucia le riserve (una cui parte è stata usata
vanamente allo scopo di tenere su la hryvnia). La Banca centrale ha ormai a disposizione solo sei
miliardi di dollari: livello da fallimento.
Non sembra dunque casuale che nello stesso giorno in cui Putin, Poroshenko, Merkel e Hollande
si sono riuniti a Minsk il Fondo monetario internazionale abbia concesso a Kiev un altro prestito,
che fa salire a quaranta miliardi di dollari l’ammontare di denaro che l’istituzione diretta da
Christine Lagarde verser{ nelle casse dell’ex repubblica sovietica. Varia anche la tipologia della
linea di finanziamento. Si passa da un prestito SBA (Stand-By Arrangement a uno EFF (Extended
263
Fund Facility). Il primo è biennale e ha carattere abbastanza vincolante. Il secondo è
quadriennale e risulta più flessibile.
A insistere sulla rimodulazione è stata Kiev, che in questo modo sventa la bancarotta e, se
l’accordo di Minsk assicurer{ davvero la fine delle ostilit{, potr{ concentrarsi sulla ripresa
economica e sulle riforme. La strada è stretta e impervia. C’è da considerare il freno
potenzialmente rappresentato dal blocco oligarchico, che più volte in passato ha sabotato il
cambiamento. Ma al tempo stesso non è da escludere che i poteri forti scelgano le riforme, che
sono senza dubbio preferibili alla distruzione totale o all’immobilismo assoluto, che lascerebbe il
paese (quindi anche il ceppo oligarchico) troppo esposto verso la Russia. Kiev non entrerà nella
Nato, né in Europa. Su questo non è il caso di nutrire troppe illusioni. Ma dovrà cambiare,
emendarsi e innovarsi di continuo, se vuole tenere Mosca a distanza, per quanto possibile.
In tempi recenti qualche segnale sulle riforme è arrivato. I prezzi dell’energia sono sensibilmente
saliti, come il Fondo monetario richiedeva (il costo sociale di questa variazione non è
trascurabile). È stata presa inoltre qualche misura anti-corruzione. Christine Lagarde, anche su
questo punto, era stata chiara. Tuttavia è ancora poco, rispetto alla montagna di leggi che
dovranno essere licenziate prossimamente. Il Fmi, c’è da pensare, sar{ inflessibile. D’altro canto
si è assunto rischi notevoli. Se la guerra nel Donbass non si fermasse o riprendesse in futuro non
sarà facile recuperare gli interessi sui prestiti concessi.
Anche Mosca, economicamente parlando, può assicurarsi benefici dalla fine del conflitto caldo in
Ucraina. L’effetto combinato del crollo dei prezzi del petrolio e delle sanzioni comminate da Stati
Uniti e Unione europea l’hanno messa in difficolt{. Rublo svalutato, recessione, contrazione dei
consumi. Questo è sostenibile nel breve periodo, anche grazie alla “risorsa popolazione”. Il
sentimento patriottico dei russi, che si sentono accerchiati, si è impennato. Quindi il momentaccio
viene tollerato. Ma nel lungo termine la cosa potrebbe diventare pericolosa. La Russia potrà
anche giocare su più fronti, flirtando con i cinesi, con gli indiani, con gli egiziani, con chiunque. Ma
la sua economia non è diversificata, né flessibile. Quindi avanti di questo passo potrebbero
arrivare problemi davvero seri.
Che l’economia spaventi lo indica il riflesso nervoso scattato all’ipotesi di escludere Mosca dal
sistema dei pagamenti bancari internazionali, ventilata nei giorni scorsi. Il primo ministro Dmitry
Medvedev ha spiegato che la reazione del suo paese a questa misura sarebbe senza limiti. Lo
riporta il giornalista Fareed Zakaria, che in un articolo apparso sul Washington Post sostiene
proprio la tesi secondo cui la Russia teme più l’aggravarsi del confronto economico che l’invio di
armi americane all’Ucraina, di cui s’è abbondantemente discusso in questi giorni.
264
In effetti non sembra una variabile capace di fare la differenza. Queste armi verrebbero
maneggiate da un esercito impreparato, scarso, demotivato. Inoltre Putin non si farebbe
impressionare da qualche morto e da qualche costo militare in più. La guerra in Ucraina non è
così dispendiosa, non gli impone revisioni di bilancio dall’impatto così micidiale. Se gli americani
e l’occidente volessero davvero terrorizzarlo dovrebbero mobilitare la forza e le strutture della
Nato. Ma qui si sconfina nel terreno della fantasia.
Al presidente russo, al momento, va bene così. Ha tolto all’Ucraina la Crimea, senza che nessuno
dicesse o facesse nulla davanti a una tale spropositata “reazione” alla Maidan (che al contrario
dell’operazione dei russi nella penisola non presupponeva alcuna variazione territoriale). Ha
ordito la ribellione del Donbass e foraggiato la guerra dei ribelli, ottenendo il riconoscimento
della loro autonomia e dunque il potenziale diritto di veto sul futuro ucraino di cui si diceva
prima. Parallelamente, l’accordo di Minsk gli permette di riaprire il dialogo con gli europei e di
gettare le basi affinché le sanzioni economiche vengano progressivamente riviste.
Questo è anche nell’interesse europeo, visto che la guerra commerciale con Mosca ha mandato in
fumo contratti e fatto perdere punti a livello di esportazioni. Al momento, comunque sia, le
sanzioni sono confermate. Bruxelles, prima di allentarle, vuole vedere se Mosca rispetterà o meno
gli accordi di Minsk, a partire dal cessate il fuoco, che inizia tra poche ore. Se non verrà rispettato
tutto ciò che è stato scritto potrà tranquillamente essere dimenticato.
Sacrificio per cosa?
Linkiesta, 14 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________________
A Kiev, via Institutska è ancora chiusa al traffico. È più di un anno che da Maidan, Piazza
dell’Indipendenza, si può salire solo a piedi verso Via Bankova, dove il palazzo presidenziale è
occupato non più da Victor Yanukovich, ma dal suo successore Petro Poroshenko. Ai lati della
strada, per qualche centinaio di metri, ci sono lapidi, fiori, candele, fotografie, caschi e altro
ancora: tutto in ricordo di tutti coloro che tra il 18 e il 20 febbraio dello scorso anno persero la
vita nel bagno di sangue che segnò l’apice delle proteste iniziate nella capitale ucraina nel
novembre del 2013.
265
A dire il vero Via Institutska non si chiama più nemmeno così: è stata rinominata ufficialmente
Via dei Cento eroi del cielo, con riferimento appunto al numero dei caduti sul selciato. In questi
mesi è stata sempre oggetto di pellegrinaggio per tutti quelli che volevano rendere omaggio alle
vittime della rivolta contro l’ex presidente. Su Maidan adesso cartelloni ricordano gli scontri tra
manifestanti e polizia che per oltre due mesi misero in stato d’assedio il cuore di Kiev. Ma non
solo: le immagini più recenti rammentano che nel sud-est c’è una guerra in corso e che l’Ucraina,
dopo l’annessione della Russia, non è gi{ più quella che era un anno fa.
Nella capitale dell'Ucraina e nel resto del Paese c’è poco da celebrare e il futuro appare più
incerto che mai, nonostante gli accordi sottoscritti la scorsa settimana a Minsk. La tregua
concordata in Bielorussia è in bilico e il baratro, politico ed economico, dietro l’angolo. La
rivoluzione e il sacrificio umano di un anno fa avrebbero voluto essere la chiusura tragica dell’era
Yanukovich e l’inizio di un nuovo capitolo nella breve storia dell’Ucraina indipendente,
cominciata solo nel 1991 dopo il crollo dell’Urss. Si sono trasformati in una spirale di guerra che
sta devastando il Paese. Dopo il sangue versato a Kiev un anno fa è arrivato quello del Donbass, ai
Il primo anniversario della strage sulla Maidan è amaro.
Il massacro avrebbe dovuto chiudere l’era Yanukovich e aprire una fase nuova.
Ma ha sancito per ora l’inizio di una guerra.
Cento del cielo si sono aggiunti quasi seimila morti. Come nel caso della rivoluzione arancione del
2004, naufragata dopo pochi mesi di illusione, così Euromaidan e la chimera di un Paese diverso
si sono schiantati contro il muro della realtà, che da una parte è costituito dal conflitto ibrido
dove accanto ai separatisti la Russia gioca un ruolo diretto e indiretto non secondario e dall’altra
dal dna del sistema ucraino, dove poteri forti e oligarchie continuano a dettare legge.
Dopo il cleptocrate Yanukovich, alla Bankova è arrivato Poroshenko, che da vent’anni a questa
parte è uno dei tanti simboli di come politica e affari vadano di pari passo. Il nuovo presidente fa
coppia con Arseni Yatseniuk, primo ministro alfiere di interessi altrui, da quelli del rivale interno
numero uno del capo di Stato, Igor Kolomoisky, a quelli esterni targati Washington. La
Costituzione ucraina, sulle cui modifiche era stato addirittura basato l’accordo del 21 febbraio
2014 tra Yanukovich e l’allora opposizione, è rimasta tale e quale, con la divisione dei poteri tra
presidente e primo ministro che di fatto blocca il sistema.
266
Il parlamento rinnovato lo scorso ottobre è dominato come al solito dalle fazioni oligarchiche e i
cinque partiti di governo hanno in comune solo l’etichetta “europeista” che era stata affibbiata a
tutti i rivali di Yanukovich, dai moderati ai neonazisti. Le riforme strutturali, di autonomia e
decentramento, promesse da Yatseniuk e dall’allora presidente ad interim Olexander Turchynov
quasi un anno fa, sono rimaste al palo. Il dialogo nazionale non è stato mantenuto e a parte il
Donbass, in qualche oblast (regione) tra Kharkiv e Odessa i focolai accesi la scorsa primavera non
sono stati certo spenti del tutto.
A Kiev la vecchia e la nuova Rada hanno lavorato facendo solo pochi passi tra quelli richiesti dalla
comunità internazionale, che ha pompato miliardi di dollari praticamente a fondo perso per
evitare quel collasso che è comunque alle porte. Fondo Monetario Internazionale, Stati Uniti ed
Europa hanno più volte modificato il volume di aiuti, l’ultima cifra è quella di 40 miliardi di
dollari spalmati nei prossimi quattro anni, senza andare troppo per il sottile. La concessione dei
fondi è legata teoricamente alla realizzazione di riforme, che se sulla carta si possono approvare
facilmente, sono impossibili o quasi da realizzare sul campo.
L’Ucraina è il Paese più corrotto d’Europa e lo rimarr{ per un pezzo. Poroshenko e Yatseniuk non
godono di buona popolarità, i sondaggi li condannano come condannavano lo scorso anno
Poroshenko e l’allora premier Mykola Azarov. La fiducia degli ucraini è minima, ma almeno per
ora non ci sono alternative. Difficilmente il tandem al comando potr{ reggere l’urto di una nuova
escalation nel Donbass, se gli accordi di Minsk andranno a rotoli, e il prossimo rimescolamento di
carte guidato dagli oligarchi e dagli attori esterni è già programmato. Passeggiando tra Maidan e
via Institutska l’impressione è che i Cento eroi del cielo siano morti davvero per nulla.
267
La redazione di Rassegna Est
Matteo Tacconi
Perugino, nato nel 1978, è il coordinatore di Rassegna Est. Scrive su diverse testate e commenta alla radio.
Sull’Est ha scritto quattro libri. I primi due, Kosovo: la storia, la guerra, il futuro e C’era una volta il Muro:
viaggio nell’Europa ex comunista, sono stati editi da Castelvecchi. Il terzo, Me ne vado a Est, cofirmato con
Matteo Ferrazzi, il presidente del Comitato editoriale di Rassegna Est, è stato pubblicato da Infinito
Edizioni. L’ultimo volume, Verde cortina, un reportage lungo il vecchio crinale tra le due Germanie e le due
Europe, è stato prodotto con il fotografo Ignacio Maria Coccia.
Stefano Grazioli
Nato a Sondrio nel 1969. Dopo la maturità classica ha studiato a Berlino e Milano, laureandosi in Scienze
Politiche alla Cattolica. Dal 1993 al 1997 ha lavorato in Germania per media italiani e tedeschi (Deutsche
Welle), prima di trasferirsi in Austria, dove nel 1999 ha conseguito il Master in European Journalism alla
Donau Universität. A Vienna ha diretto tra l’altro la redazione online del quotidiano Kurier. Da oltre
quindici anni si occupa di spazio post-sovietico, lavorando come freelance per testate italiane e straniere.
È autore, tra l’altro, di diversi saggi.
Pierluigi Mennitti
Brindisino, nato nel 1966. Dopo la maturità classica ha studiato a Roma, laureandosi in scienze politiche
alla Sapienza. Dal 1990 al 1994 ha lavorato per diversi quotidiani a Napoli e Roma, dal 1995 al 2008 per la
rivista di cultura politica Ideazione, di cui è stato direttore dal 2004 al 2006, diventando poi
corrispondente dalla Germania. Dal 2001 al 2006 ha diretto la rivista di geopolitica online Emporion. Dal
2007 vive a Berlino. È membro della Verein der Ausländischen Presse (VAP), l’associazione della stampa
estera tedesca e del Deutscher Journalisten-Verband (DJV), la federazione tedesca dei giornalisti.
Collabora come freelance per giornali italiani occupandosi di Germania, Europa centro-orientale,
Scandinavia e area balcanica.
Rodolfo Toè
Nato nel 1985 a Conegliano, in provincia di Treviso. Si è laureato in relazioni internazionali, studiando a
Trieste e a Parigi. Vive a Sarajevo, da dove lavora come corrispondente per Osservatorio Balcani e Caucaso
e il portale in lingua francese Le Courrier des Balkans, dedicato all’Europa sud-orientale. Ha scritto anche
per La Stampa, Il Riformista, Lettera 43, Il Foglio, Il Piccolo, Linkiesta e Rolling Stone. Ha collaborato anche
con le francesi Médiapart e Radio France Internationale.