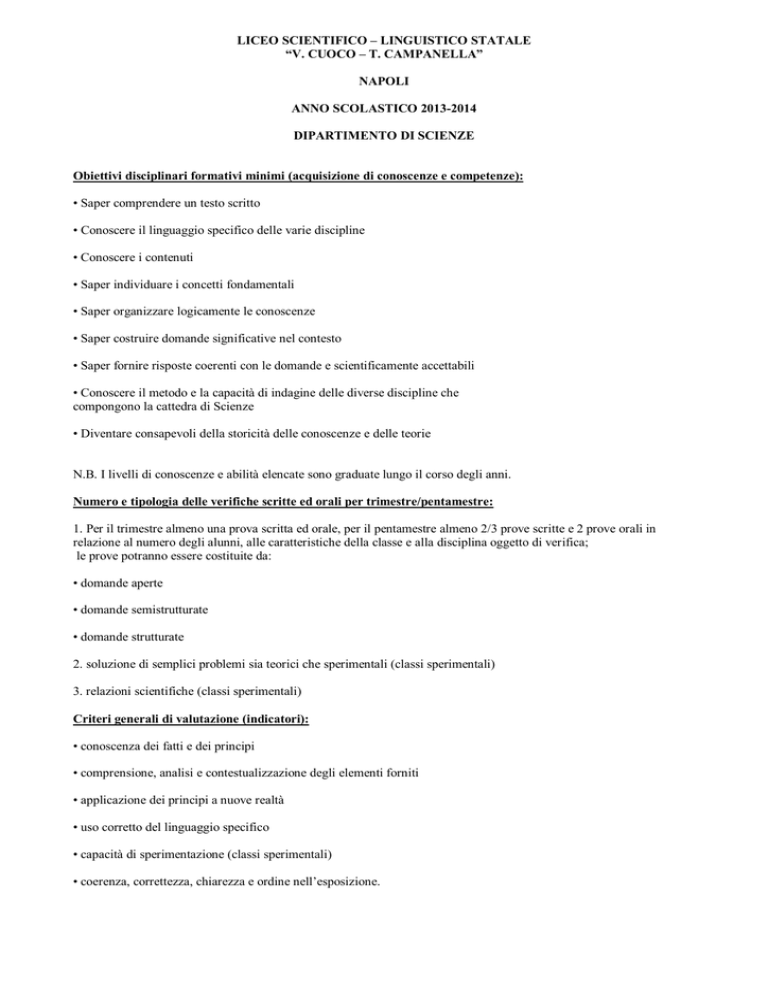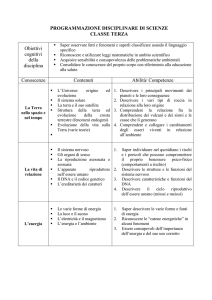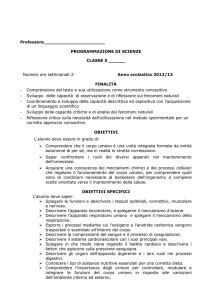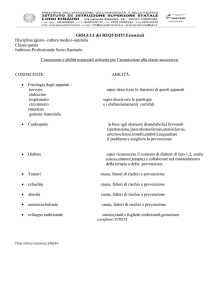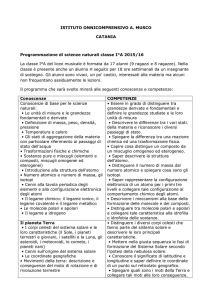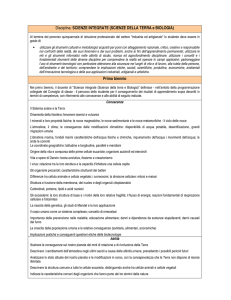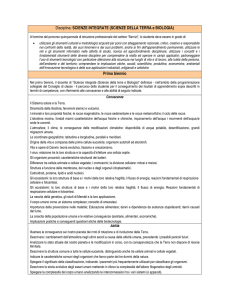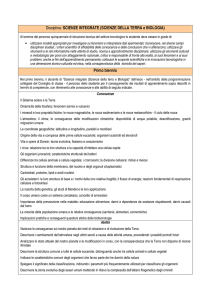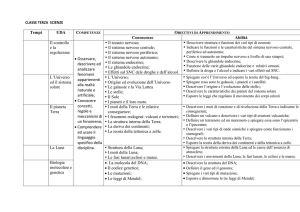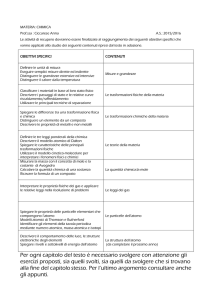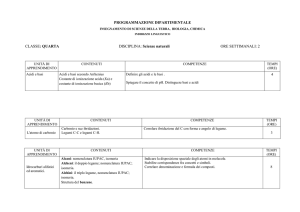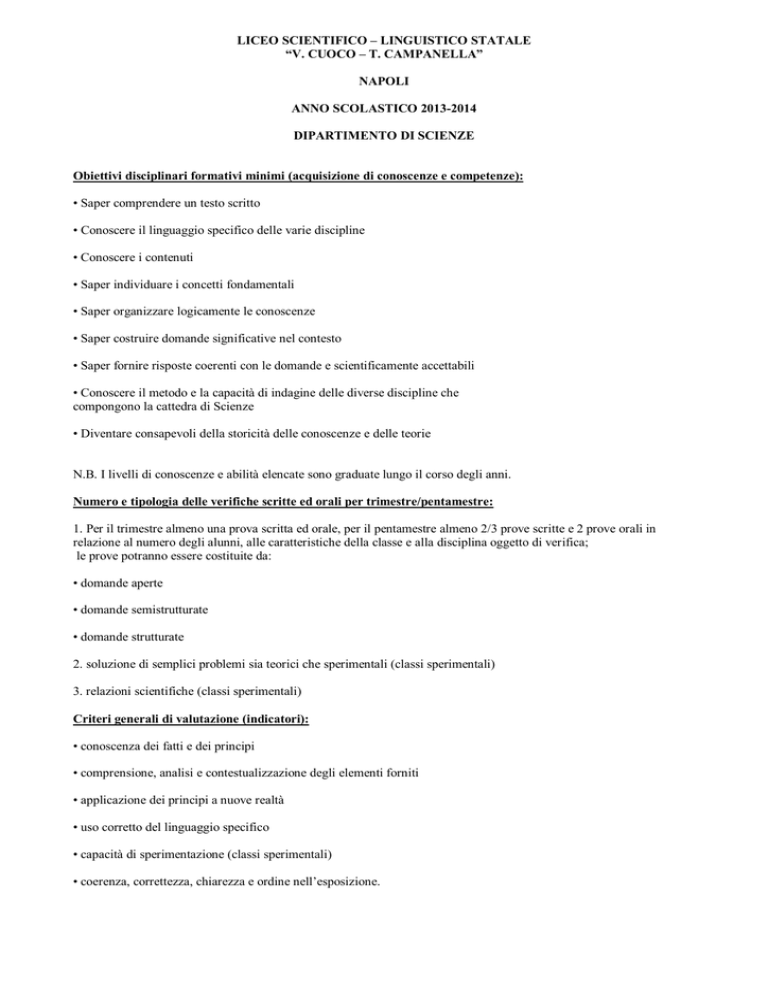
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO STATALE
“V. CUOCO – T. CAMPANELLA”
NAPOLI
ANNO SCOLASTICO 2013-2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
Obiettivi disciplinari formativi minimi (acquisizione di conoscenze e competenze):
• Saper comprendere un testo scritto
• Conoscere il linguaggio specifico delle varie discipline
• Conoscere i contenuti
• Saper individuare i concetti fondamentali
• Saper organizzare logicamente le conoscenze
• Saper costruire domande significative nel contesto
• Saper fornire risposte coerenti con le domande e scientificamente accettabili
• Conoscere il metodo e la capacità di indagine delle diverse discipline che
compongono la cattedra di Scienze
• Diventare consapevoli della storicità delle conoscenze e delle teorie
N.B. I livelli di conoscenze e abilità elencate sono graduate lungo il corso degli anni.
Numero e tipologia delle verifiche scritte ed orali per trimestre/pentamestre:
1. Per il trimestre almeno una prova scritta ed orale, per il pentamestre almeno 2/3 prove scritte e 2 prove orali in
relazione al numero degli alunni, alle caratteristiche della classe e alla disciplina oggetto di verifica;
le prove potranno essere costituite da:
• domande aperte
• domande semistrutturate
• domande strutturate
2. soluzione di semplici problemi sia teorici che sperimentali (classi sperimentali)
3. relazioni scientifiche (classi sperimentali)
Criteri generali di valutazione (indicatori):
• conoscenza dei fatti e dei principi
• comprensione, analisi e contestualizzazione degli elementi forniti
• applicazione dei principi a nuove realtà
• uso corretto del linguaggio specifico
• capacità di sperimentazione (classi sperimentali)
• coerenza, correttezza, chiarezza e ordine nell’esposizione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI SCIENZE
Cognome e Nome………………………………………………Classe ……………
.
INDICATORI
DESCRITTORI
Domande aperte
e
semistrutturate
Domande
strutturate
PUNTI
PUNTI
Completezza,
precisione,
pertinenza dei
contenuti
Correttezza e
proprietà
dell’espressione
padronanza della
lingua
italiana e dello
specifico
linguaggio disciplinare
Analisi, sintesi,
rielaborazione
personale
• Insufficiente
• Mediocre
• Sufficiente
• Discreto
• Ottimo
2
3
4
5
6
3
4,5
5
6
8
• Insufficiente
• Mediocre
• Sufficiente
• Discreto
• Ottimo
0
0,5
1
1,5
2
0
0,5
1
1,5
2
• Insufficiente
• Mediocre
• Sufficiente
• Discreto
• Ottimo
0
0,5
1
1,5
2
Il voto finale risulta dalla somma dei tre indicatori.
PUNTEGGIO TOTALE …………/ 10
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI SCIENZE
Cognome e Nome………………………………………………Classe …………………………..
OTTIMO
(10/9)
BUONO
8
DISCRETO
7
Il candidato conosce approfonditamente i dati; pone autonomamente relazioni
tra essi, ricollega in schemi coerenti e logici e li valuta criticamente sia in
termini di evidenza interna che di criteri esterni culturalmente fondati.
Padroneggia il linguaggio dal punto di vista tecnico e semantico.
Il candidato conosce ampiamente i dati, li propone in modo chiaro e
dettagliato; espone con scioltezza, riorganizza e rielabora i concetti, trae
deduzioni, dimostra padronanza di metodi e strumenti, procede a nuove
applicazioni
Il candidato conosce i dati e li espone correttamente; collega i concetti con
sicurezza e li sa spiegare; utilizza adeguatamente metodi e strumenti talvolta
anche in situazioni nuove
SUFFICIENTE
6
Il candidato riconosce i dati, li descrive in modo semplice, anche se non
sempre rigoroso; coglie il senso essenziale dell’informazione, applica le
conoscenze in situazioni note e produce in modo elementare ma nel complesso
corretto.
MEDIOCRE
5
Il candidato conosce dati e nozioni in modo parziale, spiega i concetti in
maniera imprecisa e non autonomamente; applica le conoscenze in suo
possesso solo in situazioni semplici.
INSUFFICIENTE
4
Il candidato fatica a riconoscere dati e nozioni e li descrive
in modo frammentario, fraintende concetti fondamentali, non sa
utilizzare gli strumenti in suo possesso
GRAVEMENTE
INSUFF.
(da 3 a 1)
Il candidato non riconosce dati e nozioni e non arriva a descriverli neppure in
modo meccanico, mancando degli strumenti basilari
Voto ___________/10
PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI
AS 2013-2014
SCIENZE DELLA TERRA - CLASSI PRIME
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
Prerequisiti allo
studio delle scienze
della Terra
Il metodo scientifico
Significato della misura
Grandezze fondamentali e derivate
Unità di misura e Sistema Internazionale
Multipli e sottomultipli della misura,
notazione scientifica
Saper formulare ipotesi
sulla base delle
osservazioni.
Saper raccogliere ed
organizzare in modo
guidato i dati durante le
esperienze di laboratorio,
usando correttamente le
unità di misura.
La Terra
nell’Universo
Dall’Universo al Sistema Solare
Caratteristiche fondamentali dei pianeti del
Sistema Solare: pianeti terrestri e gioviani
Leggi di Keplero e legge della Gravitazione
Universale di Newton
Storia del modello eliocentrico
Saper utilizzare in modo
semplice il linguaggio
dell'astronomia.
Saper riconoscere le
principali caratteristiche
dei pianeti terrestri e
gioviani.
Generalità del
Sistema Terra
Concetto di Sistema (sistemi aperti, chiusi e
isolati)
Omeostasi di un sistema (circuiti di
retroazione negativa e positiva)
Il Sistema Terra e le sfere della Terra
Moti della Terra (rotazione e rivoluzione) e
loro conseguenze
La misura del tempo
Il modello a strati geocentrici della Terra
Il campo magnetico terrestre
Saper descrivere le
principali caratteristiche
del pianeta Terra.
Saper descrivere i
principali moti, le
relative prove e
conseguenze.
L’idrosfera
e lo studio
geomorfologico della
superficie terrestre
Idrosfera continentale
Idrosfera marina
Fattori esogeni ed endogeni della
geomorfologia della superficie terrestre
La degradazione fisica e chimica delle rocce
Pedogenesi
Carsismo
Descrivere il ciclo
dell’acqua e le
caratteristiche di fiumi,
laghi, ghiacciai, falde
idriche .
Distinguere tra oceani e
mari e spiegare i
movimenti del mare
Riconoscere gli aspetti
chimico/fisici
responsabili dei
fenomeni
geomorfologici e le
dinamiche correlate ai
principali elementi del
paesaggio.
CONOSCENZE
COMPETENZE
Introduzione alla chimica:
Elementi, composti e miscugli
Fenomeni fisici e chimici
Atomi e molecole
Cenni della Tavola Periodica degli elementi
Saper distinguere le
principali trasformazioni
fisiche e chimiche della
materia.
Saper distinguere
elementi da composti.
Saper riconoscere
l'organizzazione della
CHIMICA
NUCLEI FONDANTI
Elementi di chimica
tavola periodica.
Le trasformazioni
fisiche e chimiche
della materia
Le teorie della
materia e la struttura
della materia
Le proprietà fisiche della materia.
Gli stati fisici e le trasformazioni fisiche
della
materia
Classificare i materiali come sostanze pure e
miscugli
Distinguere tra trasformazioni chimiche e
reazioni chimiche
Le leggi ponderali di Lavoisier. Proust ,
Dalton
e il principio di conservazione dell’energia.
L’organizzazione della materia: sistemi
omogenei ed eterogenei Elementi e composti
Reazioni chimiche ed equazioni chimiche
Classificare i materiali in
base al loro stato fisico.
Descrivere i passaggi di
stato delle sostanze pure
e disegnare le curve di
riscaldamento e di
raffreddamento.
Utilizzare le principali
tecniche di separazione
dei miscugli (filtrazione,
distillazione,
cromatografia ecc.).
Spiegare le differenze tra
una trasformazione fisica
e una trasformazione
chimica.
Distinguere un elemento
da un composto.
Descrivere le proprietà di
metalli e non metalli.
Verificare le leggi
ponderali
Saper bilanciare una
equazione chimica
La teoria atomica di Dalton.
Distinguere tra atomi e molecole
Distinguere tra numero atomico e numero di
massa. Gli isotopi.
Distinguere tra massa atomica, massa
molecolare, mole.
Utilizzare la teoria
atomica di Dalton per
interpretare le leggi
ponderali
Descrivere le particelle
che costituiscono l’atomo
CHIMICA E BIOLOGIA - CLASSI SECONDE
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
I legami chimici
La disposizione degli
elettroni nei livelli
energetici e gli elettroni di
valenza
Distinguere tra un legame
ionico e un legame
covalente
Distinguere tra formule
chimiche di struttura e
molecolari. Distinguere tra
molecole polari e
apolari.
I diversi tipi di legami
intermolecolari
Spiegare i motivi per cui
si forma un legame
ionico o un legame
covalente
Rappresentare il legame
a idrogeno
Spiegare perché l’acqua è
una molecola polare
Le proprietà fisiche e
chimiche dell’acqua
Le soluzioni acquose e il
comportamento dei
soluti ionici e molecolari in
acqua.
Rappresentare la
geometria della molecola
dell’acqua
Rappresentare il legame
a idrogeno tra molecole
d’acqua
Mettere in relazione la
struttura molecolare
dell’acqua con le sue
proprietà
L’acqua e le soluzioni
acquose
Distinguere una sostanza
idrofila da una idrofobica
Spiegare le differenze tra
dissociazione e
ionizzazione di una
sostanza in acqua.
Distinguere le
caratteristiche comuni a
tutti gli organismi
viventi.
Introduzione alla
Biologia
Le proprietà degli organismi
viventi e i regni
della natura
Origine, evoluzione e
classificazione degli
organismi viventi
Le teorie sull’origine della
vita.
Le prime teorie evolutive, la
teoria evolutiva di
Darwin e le teorie evolutive
dopo Darwin
Il sistema di classificazione
di Linneo
Filogenesi e classificazione
Saper spiegare il
passaggio da organismi
procarioti a organismi
eucarioti
Saper cogliere lo
sviluppo storico delle
teorie evolutive
evidenziando la novità e
complessità della teoria
darwiniana
Definire la filogenesi
mettendola in relazione
con la classificazione
I Procarioti
La classificazione e le
caratteristiche dei batteri
e degli archei
Spiegare struttura,
riproduzione e
metabolismo dei
Procarioti
Gli Eucarioti:Protisti
La classificazione e le
caratteristiche dei Protisti
Distinguere i diversi
gruppi di protisti in base
alle diverse modalità di
movimento e di
nutrimento
Gli Eucarioti: Piante
Piante non vascolari e piante
vascolari
Spiegare l’anatomia di:
Briofite, Pteridofite,
Gimnosperme e
Angiosperme.
Le biomolecole
Struttura e funzione di
Carboidrati, Lipidi,
Proteine, Acidi nucleici
Reazioni di condensazione e
di idrolisi
Spiegare le funzioni che
svolgono le biomolecole
negli organismi viventi in
base alla loro struttura
La cellula
Le dimensioni delle cellule.
Microscopio ottico e
microscopio elettronico
Struttura e funzioni della
cellula procariotica
Struttura e funzioni della
cellula eucariotica
Scambi di energia e materia
con l’ambiente:
reazioni esoergoniche ed
endoergoniche;
metabolismo cellulare;
metabolismo energetico;
attività enzimatica e
metabolismo.
Struttura delle membrane
biologiche e
meccanismi di trasporto
Saper individuare la
sostanziale unitarietà dei
viventi riconoscendo
nella cellula l’unità
costitutiva fondamentale
di tutti gli organismi
Distinguere tra
anabolismo e
catabolismo. Spiegare il
ruolo dell’ATP nel
metabolismo. Spiegare la
funzione degli enzimi
nelle reazioni chimiche.
Distinguere i diversi
passaggi di sostanze
attraverso le membrane
La cellula
e l’energia
•
•
•
Le vie metaboliche
Il
metabolismo
glucosio
Reazioni
redox
trasporto di energia
•
del
•
e
•
•
•
La glicolisi:
dal glucosio
al piruvato
•
•
Le due fasi della glicolisi
Il bilancio energetico
della glicolisi
La fermentazione rigenera il
NAD+ consumato
dalla glicolisi
•La fermentazione lattica
•La fermentazione alcolica
•La resa energetica della
glicolisi
e
della
fermentazione
•
•
•
•
•
•
La respirazione cellulare:
il ciclo di Krebs
•Laformazione dell’acetilCoA
•Le tappe del ciclo di Krebs
•
•
•
•
La respirazione cellulare:
il trasporto
degli elettroni
e la fosforilazione ossidativa
•
•
•
La catena di trasporto
degli elettroni
La
teoria
della
chemiosmosi
La resa energetica della
respirazione cellulare
•
•
•
•
I collegamenti
tra le vie metaboliche
•
•
•
La fotosintesi: energia dal Sole
•
•
•
La
demolizione
di
molecole com-plesse
La sintesi delle molecole
complesse
Le
relazioni
tra
catabolismo
e
anabolismo
Le due fasi della
fotosintesi
L’energia luminosa
I pigmenti e il loro
spettro d’assorbimento
•
•
•
•
•
•
•
•
La fase luminosa della
fotosintesi trasforma l’energia
della luce
in energia chimica
•
•
•
I fotosistemi
Il flusso di elettroni
dall’acqua al NADPH
La produzione di ATP
per chemiosmosi
•
•
•
Elencare i principi comuni che seguono tutte le
vie metaboliche
Scrivere la reazione generale di demolizione del
glucosio in presenza di ossigeno
Distinguere il metabolismo aerobico da quello
anaerobico
Associare il trasferimento di elettroni in una
reazione di ossido-riduzione al trasferimento di
energia
Spiegare che ruolo svolgono i trasportatori di
elettroni nel metabolismo del glucosio
Riassumere le reazioni della glicolisi
Distinguere la fase preparatoria da quella di
recupero energetico
Spiegare il processo di fosforilazione a livello
di substrato che porta alla formazione di ATP
durante la glicolisi
Spiegare
la
funzione
delle
diverse
fermentazioni
Distinguere la fermentazione lattica da quella
alcolica specificando i tipi di organismi nei
quali si verificano questi processi
Riassumere la resa energetica della glicolisi e
della fermentazione
Spiegare come si forma l’acetil-CoA
Individuare nei mitocondri la sede del ciclo di
Krebs
Analizzare le tappe fondamentali del ciclo di
Krebs evidenziando quelle esoergoniche
Mettere in evidenza che al termine del ciclo di
Krebs l’ossidazione del glucosio è completa
Descrivere i componenti della catena di
trasporto degli elettroni e il luogo in cui si
trovano
Spiegare il ruolo fondamentale dell’ossigeno al
termine del trasporto di elettroni
Correlare il processo chemiosmotico con la
produzione di ATP
Calcolare il guadagno energetico complessivo
che si ottiene al termine dalla demolizione
completa di una mole di glucosio
Evidenziare il ruolo centrale della glicolisi e del
ciclo di Krebs nella rete delle vie metaboliche
Mettere in relazione le vie cataboliche con
quelle anaboliche
Descrivere l’omeostasi metabolica
Scrivere la reazione generale della fotosintesi
Distinguere le reazioni dipendenti dall’energia
luminosa da quelle indipendenti
Mettere in relazione le diverse tappe della
fotosintesi con la struttura dei cloroplasti
Spiegare le interazioni tra luce e molecole
Spiegare la funzione dei pigmenti e la relazione
tra spettro d’assorbimento e spettro d’azione
Spiegare la funzione dei due fotosistemi
Spiegare la provenienza e il percorso che
compiono
gli
elettroni
per
giungere
all’accettore finale
Spiegare come viene prodotto l’ATP nei
La fase indipendente dalla luce
utilizza l’energia chimica
per la sintesi
di carboidrati
•
•
Il ciclo di Calvin
Il
destino
della
gliceraldeide 3-fosfato
•
•
cloroplasti evidenziando le analogie con la
produzione di ATP nei mitocondri
Analizzare le tappe fondamentali del ciclo di
Calvin evidenziando quelle endoergoniche
Spiegare come viene utilizzata dalla pianta la
gliceraldeide 3-fosfato
BIOLOGIA - CLASSI TERZE
•
•
•
•
Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica molecolare comprendendo come viene applicato il metodo
scientifico in questa disciplina
Acquisire la consapevolezza che tutte le informazioni per dare origine a nuove cellule sono contenute nel DNA
Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica molecolare comprendendo come viene applicato il metodo
scientifico in questa disciplina
Acquisire la consapevolezza che le informazioni contenute nel DNA sono trasformate in proteine
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
La prima
e la seconda legge
di Mendel
•
Le
conoscenze
sull’ereditarietà
dei
caratteri ai tempi di
Gregor Mendel
La
legge
della
dominanza
La
legge
della
segregazione
dei
caratteri
•
Il quadrato di Punnett
Le basi molecolari
dell’ereditarietà
Il testcross
•
•
•
Le conseguenze della seconda legge
di Mendel
•
•
•
•
•
•
•
•
La terza legge
di Mendel
•
•
•
Come interagiscono
gli alleli?
•
•
•
•
•
La
legge
dell’assortimento
indipendente
dei
caratteri
Gli alberi genealogici
Le malattie genetiche
•
Mutazioni e nuovi
alleli
Poliallelia
Dominanza incompleta
Codominanza
Pleiotropia
•
•
•
•
•
•
•
Identificare il periodo storico e le
conoscenze scientifiche in cui si
inquadrano gli studi di Mendel
Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di
Mendel
Distinguere un carattere dominante da uno
recessivo, un gene da un allele
Enunciare le leggi della dominanza e della
segregazione
Distinguere omozigote da eterozigote,
fenotipo da genotipo
Prevedere le combinazioni alleliche
risultanti da un incrocio costruendo il
quadrato di Punnet
Applicare il test cross per determinare il
genotipo di un individuo a fenotipo
dominante
Mettere in relazione il rapporto fenotipico
9:3:3:1 con la terza legge di Mendel
Collegare
la
meiosi
alla
legge
dell’assortimento
indipendente
dei
caratteri
Costruire un albero genealogico
Spiegare la differenza tra una malattia
genetica determinata da un allele recessivo
e quella determinata da un allele
dominante
Distinguere gli alleli selvatici da quelli
mutati
Spiegare il fenomeno della poliallelia
mettendolo in relazione all’esistenza di più
fenotipi
Differenziare la dominanza incompleta
dalla codomianza
Spiegare come un singolo allele può
influenzare più di un fenotipo
Come interagiscono
i geni?
•
•
•
•
Epistasi
Geni soppressori
Il vigore degli ibridi
Eredità poligenica
•
•
•
•
In che rapporto stanno geni
e cromosomi
•
•
•
Geni associati
La
ricombinazione
genetica dovuta al
crossing-over
Le mappe genetiche
•
•
•
•
La determinazione cromosomica
del sesso
•
•
Autosomi e cromosomi
sessuali
L’eredità dei caratteri
legati al sesso
•
•
•
Come
si dimostra
che i geni sono fatti di DNA?
•
•
•
•
Qual è
la struttura
del DNA?
•
•
•
Le basi molecolari
dell’ereditarietà
Il
«fattore
di
trasformazione»
di
Griffith
L’esperimento
di
Avery
Gli esperimenti di
Hershey e Chase
•
La
composizione
chimica del DNA
Il modello a doppia
elica di Watson e Crick
La struttura del DNA
•
•
•
•
•
La duplicazione
del DNA
è semiconservativa
•
•
•
•
•
•
I geni guidano
la costruzione
•
•
Le due fasi della
duplicazione del DNA
Il
complesso
di
duplicazione
Le DNA polimerasi
Il filamento veloce e il
filamento lento
I telomeri
I
meccanismi
di
riparazione del DNA
•
Gli esperimenti di
Beadle e Tatum
La relazione tra geni e
•
•
•
•
•
•
•
Spiegare come un gene può influenzare
l’espressione fenotipica di un altro gene
Definire gli alleli soppressori
Spiegare in che cosa consiste il fenomeno
del vigore degli ibridi
Spiegare come mai alcuni caratteri
compaiono in una popolazione con una
enorme gradazione di fenotipi differenti
Definire un gruppo di associazione genica
Spiegare perché alcuni alleli non seguono
la legge dell’assortimento indipendente
Collegare il crossing-over con la frequenza
di ricombinazione genica
Descrivere come si come si costruiscono le
mappe genetiche
Distinguere gli autosomi dai cromosomi
sessuali
Distinguere
il
genotipo
emizigote
dall’eterozigote e dall’omozigote
Descrivere le modalità di trasmissione dei
caratteri legati al sesso
Ripercorrere le tappe che hanno portato gli
scienziati a identificare nel DNA il
materiale genetico
Illustrare gli esperimenti di Griffith, di
Avery, di Hershey e Chase
Illustrare i dati sperimentali forniti da
Rosalind Franklin, Maurice Wilkins,
Erwin Chagraff che hanno contribuito alla
decifrazione della struttura del DNA
Descrivere il modello a doppia elica di
Watson e Crick
Identificare
nel
nucleotide
l’unità
fondamentale del DNA
Correlare la struttura del DNA con la sua
funzione
Spiegare perché la duplicazione del DNA
si dice semiconservativa
Descrivere i meccanismi di duplicazione
del DNA
Spiegare come funzionano le DNA
polimerasi
Descrivere le modalità di copiatura del
filamento veloce e del filamento lento
Spiegare la funzione dei telomeri
Descrivere
i
possibili
errori
di
duplicazione e le modalità di riparazione
messe in atto dalla cellula
Illustrare gli esperimenti di Beadle e
Tatum
Ripercorrere le tappe che hanno portato gli
polipeptidi
delle proteine
In che modo
l’informazione passa
dal DNA
alle proteine?
•
La trascrizione:
dal DNA all’RNA
•
•
•
•
•
Che cosa sono
le mutazioni?
Il «dogma centrale
della biologia»
La struttura dell’RNA
•
•
•
La traduzione: dall’RNA
alle proteine
scienziati a collegare i geni ai polipeptidi
•
•
•
•
•
•
•
La trascrizione
DNA
Il codice genetico
del
•
•
•
Il ruolo del tRNA e
quello dei ribosomi
Le
tappe
della
traduzione:
inizio,
allungamento
e
terminazione
La formazione di una
proteina funzionante
•
Mutazioni somatiche e
mutazioni ereditarie
Mutazioni puntiformi,
cromosomiche
e
genomiche
Mutazioni
silenti,
mutazioni di senso,
mutazioni non senso,
mutazioni
per
scorrimento
della
finestra di lettura
I quattro tipi di
mutazioni
cromosomiche
Le malattie genetiche
umane causate da
mutazioni
cromosomiche
Mutazioni spontanee e
indotte
Mutazioni
ed
evoluzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Illustrare le due ipotesi di Crick su come
l’informazione genetica fluisce dal DNA
alle proteine
Descrivere struttura e funzioni dell’RNA
messaggero, tranfert e ribosomiale
Descrivere le tre tappe in cui può essere
suddivisa la trascrizione
Spiegare la relazione tra DNA e proteine
Descrivere le caratteristiche del codice
genetico
Distinguere il codone dall’anticodone
spiegandone i rispettivi ruoli
Descrivere struttura e funzioni dei
ribosomi
Illustrare le tre tappe della traduzione
Spiegare come si ottiene dal polipeptide
una proteina funzionante
Distinguere le mutazioni somatiche da
quelle ereditarie
Distinguere le mutazioni puntiformi da
quelle cromosomiche e da quelle
genomiche
Spiegare perché una mutazione può essere
silente
Distinguere le mutazioni di senso da quelle
non senso
Spiegare gli esiti di una mutazione per
scorrimento della finestra di lettura
Distinguere le mutazioni cromosomiche
per delezione da quelle dovute a una
duplicazione o a un’inversione oppure a
una traslocazione
Illustrare le caratteristiche delle malattie
genetiche umane dovute a mutazioni
cromosomiche
Spiegare la differenza tra mutazione
spontanea e mutazione indotta
Descrivere i fattori che possono
determinare mutazioni spontanee
Elencare alcuni degli agenti mutageni più
comuni
Spiegare i legami tra mutazioni ed
evoluzione
IL CORPO UMANO
• Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da sistemi autonomi ma strettamente correlati
• Saper mettere in relazione il buon funzionamento del proprio corpo con il mantenimento di condizioni fisiologiche
costanti
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
Il corpo umano presenta
un’organizzazione gerarchica
•
L’organizzazione dei
tessuti
La funzione degli
epiteli
I principali tipi di
tessuti epiteliali
La funzione del tessuto
muscolare
Il tessuto muscolare
liscio e striato
Le funzioni del tessuto
connettivo
I
connettivi
propriamente detti
I
connettivi
specializzati
Il tessuto nervoso
•
Gli organi e i sistemi
che formano il corpo
umano
I
sistemi
di
coordinamento
del
corpo umano: nervoso
ed endocrino
Le membrane interne
La cute
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organi, sistemi
e apparati:
uno sguardo d’insieme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La comunicazione
tra le cellule
e la regolazione dell’attività cellulare
•
•
•
•
Nel corpo umano
la rigenerazione
dei tessuti
è controllata
•
•
•
•
Le
modalità
di
comunicazione
tra
cellule
Recettori e molecole
segnale
La trasduzione del
segnale
Le giunzioni serrate
•
La
capacità
di
rigenerazione
dei
tessuti
Le cellule staminali
Le cellule tumorali
Le
sostanze
cancerogene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’omeostasi: come mantenere
costante l’ambiente interno
•
Le
condizioni
mantenere costanti
da
•
Descrivere l’organizzazione strutturale dei
tessuti
Elencare i tipi e le rispettive funzioni dei
tessuti presenti nel corpo umano
Distinguere gli epiteli di rivestimento da
quelli ghiandolari e sensoriali
Distinguere le ghiandole esocrine da quelle
endocrine
Descrivere e distinguere i tre tipi di tessuto
muscolare
Classificare i tessuti connettivi in base alla
loro funzione e alla composizione della
matrice
Descrivere il tessuto nervoso distinguendo
i neuroni dalle cellule gliali
Descrivere l’organizzazione strutturale del
corpo umano
Elencare i diversi tipi di sistemi che
compongono
l’organismo
umano
indicandone le funzioni
Indicare le diverse modalità con cui il
sistema nervoso e quello endocrino
garantiscono l’equilibrio interno e
l’adattamento alle condizioni ambientali
Illustrare le funzioni delle membrane
interne distinguendo le sierose da quelle
mucose
Descrivere la struttura e le funzioni svolte
dalla cute
Illustrare come si svolge la comunicazione
tra cellule
Spiegare la trasduzione del segnale
Descrivere le giunzioni serrate
Distinguere i tessuti in base alla loro
capacità rigenerativa
Classificare le cellule staminali in base alle
loro caratteristiche
Distinguere le staminali embrionali da
quelle adulte
Illustrare le caratteristiche delle cellule
tumorali
Distinguere i tumori benigni da quelli
maligni
Spiegare che cosa s’intende per metastasi
Spiegare come agiscono le sostanze
cancerogene
Elencare le variabili da mantenere costanti
nel nostro organismo
•
•
I
meccanismi
dell’omeostasi
La regolazione della
temperatura corporea
•
•
•
Illustrare come lavora il sistema di
controllo delle variabili
Distinguere i sistemi a feedback negativo
da quelli a feedback positivo
Descrivere la regolazione a feedback
negativo della temperatura corporea
L’apparato cardiovascolare e il sangue
COMPETENZE
•
•
Comprendere il ruolo fondamentale svolto dal cuore nel sistema cardiovascolare e l’importanza di una perfetta
coordinazione dei meccanismi che lo azionano e lo regolano
Mettere in relazione l’efficienza della circolazione con il proprio stato di salute
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione dell’apparato
cardiovascolare
•
•
•
Un sistema chiuso con
una
doppia
circolazione
L’anatomia
dell’apparato
cardiovascolare
I movimenti del sangue
•
•
•
L’anatomia del cuore
Il ciclo cardiaco
Il battito cardiaco
•
•
Il cuore è il motore dell’apparato
cardiovascolare
•
•
•
•
•
•
I vasi sanguigni
e il movimento
del sangue
•
•
•
Struttura e
delle arterie
I capillari
Struttura e
delle vene
funzione
•
funzione
•
•
I meccanismi
di scambio
e la regolazione
del flusso sanguigno
•
•
La composizione
e le funzioni
del sangue
•
•
•
•
•
Gli scambi nei capillari
La
funzione delle
arteriole
Il controllo del flusso
sanguigno
•
Gli elementi figurati e
il plasma
Gli eritrociti
I leucociti
Le piastrine
•
•
•
•
•
•
Descrivere la circolazione doppia e
completa
Descrivere la struttura del cuore
Distinguere le arterie dalle vene
Spiegare il percorso del sangue nel corpo
umano partendo dal lato destro del cuore
Descrivere i tre strati che formano la
parete del cuore
Descrivere gli eventi del ciclo cardiaco
distinguendo la sistole dalla diastole
Indicare la funzione delle valvole
cardiache e i problemi derivanti da loro
malfunzionamento
Spiegare come insorge e si propaga il
battito cardiaco
Descrivere la struttura delle arterie e delle
vene in relazione alle loro rispettive
funzioni
Descrivere la rete capillare correlandola
con gli scambi effettuati tra il sangue in
essa contenuto e le cellule
Evidenziare i meccanismi che consentono
al sangue di ritornare al cuore
Indicare le sostanze che attraversano
liberamente la parete dei capillari
Spiegare come è mantenuto costante il
volume del sangue nei capillari
Spiegare come il sistema endocrino e
quello nervoso controllano il flusso
sanguigno
Elencare gli elementi figurati e le loro
rispettive funzioni
Descrivere la composizione del plasma e
le sue funzioni
Descrivere gli eritrociti e il trasporto dei
gas respiratori
Distinguere i diversi tipi di leucociti e le
•
•
rispettive funzioni
Spiegare il processo di coagulazione del
sangue
Descrivere l’emopoiesi
L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi
COMPETENZE
• Comprendere le relazioni tra le strutture e le funzioni delle diverse parti dell’apparato respiratorio
• Saper mettere in relazione le funzioni dell’apparato respiratorio con quelle dell’apparato cardiovascolare
comprendendo la stretta interdipendenza di questi due apparati
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione e la funzione
dell’apparato respiratorio
•
I due processi della
respirazione polmonare
L’anatomia
dell’apparato
respiratorio umano
Le
relazioni
tra
polmoni
e
cavità
toracica
•
•
Inspirazione
ed
espirazione
Le secrezioni del tratto
respiratorio
Il
controllo
della
ventilazione
•
•
•
La meccanica della respirazione: la
ventilazione polmonare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Il sangue
e gli scambi
dei gas respiratori
•
•
•
•
•
•
Scambi gassosi per
diffusione
Lo scambio polmonare
dei gas
Lo scambio sistemico
dei gas
Il
trasporto
dell’ossigeno
Il trasporto del diossido
di carbonio
La mioglobina
•
•
•
•
•
Distinguere l’inspirazione dall’espirazione
Spiegare gli scambi gassosi a livello
polmonare e dei tessuti
Descrivere i diversi tratti dell’apparato
respiratorio
Spiegare le relazioni anatomiche e
funzionali tra la cavità toracica, la cavità
pleurica e i polmoni
Descrivere l’inspirazione come un
processo attivo e l’espirazione come un
processo passivo
Spiegare come varia la pressione nella
ventilazione polmonare
Descrivere il ruolo svolto dal muco e dal
surfactante
Spiegare come il sistema nervoso centrale
controlla il normale alternarsi di
inspirazioni ed espirazioni
Evidenziare la stretta relazione tra sistema
nervoso,
recettori,
apparato
cardiovascolare e respiratorio per garantire
un adeguato apporto di ossigeno ai tessuti
Descrivere come i gas respiratori passano
dall’aria al sangue e viceversa
Descrivere gli scambi gassosi a livello dei
tessuti
Spiegare come viene trasportato l’ossigeno
nel sangue
Spiegare come viene trasportato il diossido
di carbonio nel sangue
Illustrare il ruolo della mioglobina nei
muscoli
L’apparato digerente e l’alimentazione
COMPETENZE
• Comprendere che il processo digestivo ha la funzioni elaborare gli alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili
dalle nostre cellule
• Saper mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato digerente con le rispettive funzioni
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione e la funzione
dell’apparato digerente
•
Le
fasi
della
trasformazione del cibo
Lo
scopo
della
digestione
I nutrienti essenziali
I macronutrienti e i
micronutrienti
Le vitamine
L’organizzazione
dell’apparato digerente
L’anatomia
dell’apparato digerente
•
La digestione in bocca
La digestione nello
stomaco
Il passaggio del chimo
nell’intestino tenue
•
•
•
•
•
•
•
Dalla bocca
allo stomaco:
le prime fasi
della digestione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’intestino lavora
in sinergia
con il pancreas
e il fegato
•
•
•
•
•
•
La
digestione
nell’intestino tenue
Struttura e funzione
digestiva del fegato
Le altre funzioni del
fegato
Il pancreas ghiandola
esocrina ed endocrina
L’assorbimento
all’interno dell’intestino
tenue
Struttura e funzioni
dell’intestino crasso
•
•
•
•
•
•
•
•
Il controllo
della digestione
e il metabolismo
•
•
Il
controllo
della
digestione da parte del
sistema nervoso e di
ormoni
Il
controllo
della
glicemia
•
•
•
Descrivere le diverse fasi della
trasformazione del cibo
Spiegare a che cosa serve la digestione
Individuare tra le sostanze presenti nel
cibo quelle indispensabili per il corpo
umano
Distinguere il ruolo svolto da minerali e
vitamine da quello di carboidrati, proteine
e lipidi
Descrivere la struttura della parete del
canale alimentare e i diversi tratti
dell’apparato digerente
Descrivere le fasi della digestione che si
svolgono in bocca
Descrivere la struttura dello stomaco
elencando i secreti prodotti dalle fossette
gastriche
Spiegare le funzioni dell’acido cloridrico,
della pepsina e del muco
Descrivere il passaggio del chimo dallo
stomaco all’intestino tenue
Illustrare i processi digestivi che si
svolgono nell’intestino tenue
Descrivere la struttura del fegato e le
funzioni della bile
Spiegare le funzioni del fegato collegate al
metabolismo
Distinguere le LDL dalle HDL e dalle
VLDL evidenziando il loro ruolo nella
regolazione del colesterolo e dei
trigliceridi nel sangue
Descrivere il pancreas e la funzione delle
sostanze che produce
Distinguere tra le diverse modalità di
assorbimento delle sostanze nutritive
Descrivere la struttura dell’intestino crasso
e le funzioni della flora batterica
intestinale
Spiegare le conseguenze di un anomalo
riassorbimento di acqua
Spiegare come il sistema nervoso
intrinseco coordina le attività del tratto
digestivo
Spiegare come agiscono secretina,
colecistochinina e gastrina
Spiegare come la parte endocrina del
pancreas regola la glicemia
L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino
COMPETENZE
• Comprendere la complessità e l’importanza per la salute dei meccanismi messi in atto dai reni per mantenere
l’equilibrio idrosalino e per eliminare i rifiuti metabolici azotati
• Saper mettere in relazione i diversi tratti del nefrone con le rispettive funzioni
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
e le funzioni dell’apparato urinario
•
•
•
•
•
Gli organi che formano
l’apparato urinario
Le funzioni dei reni
L’equilibrio idrico e
salino
L’eliminazione delle
sostanze azotate
•
•
•
Il nefrone
è l’unità funzionale
del rene
•
•
I nefroni modulano la loro attività in
relazione alle esigenze
dell’organismo
•
•
•
•
•
•
•
I meccanismi
che regolano
le funzioni dei reni
•
•
•
La struttura del rene
Il glomerulo e la
capsula di Bowman
Il tubulo renale
I capillari peritubolari
Le tre tappe della
formazione dell’urina
•
•
La regolazione della
concentrazione
dei
liquidi corporei
La
moltiplicazione
controcorrente
Lo
scambio
controcorrente
Il
mantenimento
dell’equilibrio acidobase nel sangue
•
I
fattori
che
influenzano
la
filtrazione glomerulare
Gli
effetti
di
angiotensina
e
aldosterone
L’ormone antidiuretico
•
•
•
•
•
•
•
•
Descrivere la struttura dell’apparato
urinario
Elencare i processi che portano alla
formazione dell’urina
Spiegare perché il controllo dell’equilibrio
idrico è legato al controllo della
concentrazione salina
Individuare nell’urea il catabolita azotato
eliminato dai reni umani
Descrivere la struttura del rene
Mettere in relazione le diverse parti del
nefrone con le rispettive funzioni
Descrivere i processi che dal filtrato
glomerulare portano alla formazione
dell’urina
Spiegare cosa si intende per osmolarità e
come viene regolata
Spiegare
il
meccanismo
della
moltiplicazione controcorrente
Elencare i vantaggi della moltiplicazione
controcorrente
Mettere in relazione lo scambio
controcorrente con il gradiente osmotico
verticale
Spiegare in che modo i reni controllano il
pH del sangue
Elencare i fattori che influenzano la
velocità di filtrazione glomerulare
Spiegare come agiscono gli ormoni
angiotensina e aldosterone
Spiegare come l’ADH regola la pressione
sanguigna e l’osmolarità del sangue
Il sistema linfatico e l’immunità
COMPETENZE
• Acquisire le informazioni essenziali per comprendere l’importanza della tutela della propria salute, nonché la
complessità dei meccanismi messi in atto dal nostro corpo per combattere le malattie
• Comprendere l’importanza per il corpo umano di mettere in atto meccanismi in grado di operare una precisa
distinzione tra self e non self
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
Il sistema linfatico e gli organi
linfatici sono importanti
per la difesa
immunitaria
•
•
•
•
L’immunità innata e
l’immunità adattativa
I vasi linfatici e i
linfonodi
Gli organi linfatici
•
•
Distinguere l’immunità innata da quella
adattativa
Descrivere
il
sistema
linfatico
distinguendo i vasi linfatici dai linfonodi
Differenziare gli organi linfatici in primari
primari e secondari
L’immunità innata:
la prima linea
di difesa dell’organismo
•
•
•
Le barriere superficiali
Le difese aspecifiche
cellulari e chimiche
L’infiammazione
e secondari
•
•
•
I linfociti: responsabili
dell’immunità adattativa
•
•
•
•
Il
processo
di
riconoscimento degli
antigeni
I recettori antigenici
La selezione clonale
I linfociti T e i linfociti
B
•
•
•
•
•
La risposta immunitaria umorale
•
•
La risposta immunitaria cellulare
•
•
•
•
•
La memoria immunologica
•
•
•
•
•
Che cosa succede quando l’immunità
non funziona?
•
•
La
risposta
immunitaria primaria
Gli anticorpi
•
I linfociti T helper e
citotossici
Le proteine MHC di
classe I e di classe II
Il ruolo delle proteine
MHC II e dei linfociti
T helper nella risposta
umorale
Il ruolo delle proteine
MHC I e dei linfociti T
citotossici
nella
risposta cellulare
La
tolleranza
nei
confronti del self
•
La
risposta
immunitaria secondaria
L’immunità acquisita
I vaccini
Le vaccinazioni
L’immunità passiva
•
Le allergie
Immunodeficienze
e
malattie autoimmuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Descrivere i sistemi di difesa costituiti
dalla cute, dalle membrane e dai loro
secreti
Elencare le difese aspecifiche di natura
chimica e cellulare
Descrivere il processo infiammatorio
evidenziando il ruolo della febbre e
dell’istamina
Distinguere il self dal non-self
Spiegare come l’organismo riconosce gli
antigeni
Mettere in relazione la varietà dei
determinanti antigenici con la variabilità
genetica
Spiegare come si formano i linfociti per
selezione clonale distinguendo le cellule
effettrici dalle cellule della memoria
Distinguere
l’immunità
umorale
dall’immunità cellulare
Spiegare la sequenza di passaggi che dà
luogo alla risposta primaria
Descrivere la struttura degli anticorpi
Spiegare come gli anticorpi neutralizzano
gli antigeni
Distinguere i linfociti T helper dai
citotossici
Distinguere le proteine MHC di classe I da
quelle di classe II
Individuare nelle proteine MHC le
strutture in grado di presentare gli antigeni
Spiegare come i linfociti T helper
intervengono
nell’attuazione
dell’immunità umorale
Spiegare come i linfociti T citotossici
riconoscono e contribuiscono ad eliminare
le cellule infettate da virus e le cellule
tumorali
Spiegare i rapporti tra proteine MHC e
trapianti di organi
Spiegare come si acquisisce la memoria
immunologica
Spiegare perché la risposta secondaria è
più rapida di quella primaria
Distinguere tra immunità attiva e passiva
Descrivere i diversi tipi di vaccini
Spiegare come agiscono i vaccini
Distinguere tra vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate
Definire gli allergeni
Distinguere tra ipersensibilità immediata e
ritardata
Descrivere le immunodeficienze primarie
distinguendole dalle malattie autoimmuni
Elencare le più comuni malattie
autoimmuni
Il sistema endocrino
COMPETENZE
• Comprendere l’importanza degli ormoni per controllare, modulare e integrare le funzioni del corpo umano in
risposta alle variazioni dell’ambiente interno ed esterno
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
e la funzione
del sistema endocrino
•
•
•
•
•
•
•
Gli
ormoni
come
messaggeri chimici
La natura chimica dei
diversi ormoni
Ormoni idrosolubili e
liposolubili
Ghiandole e cellule
secretrici
Il controllo a feedback
della
secrezione
ormonale
•
•
•
•
•
•
L’integrazione
tra funzioni nervose
ed endocrine avviene
a livello dell’ipofisi
e dell’ipotalamo
•
Tiroide
e paratiroidi regolano
il metabolismo
e l’omeostasi
•
•
•
•
•
•
Il rilascio di ADH e
ossitocina da parte
della neuroipofisi
Gli ormoni prodotti
dall’adenoipofisi
Gli ormoni ipotalamici
•
La
struttura
della
tiroide
L’ormone tiroideo
Calcitonina
e
paratormone
La vitamina D
•
•
•
•
•
•
Il pancreas endocrino
e il controllo
della glicemia
•
•
•
La
struttura
pancreas
L’insulina
e
glucagone
La somatostatina
del
•
il
•
•
Il surrene
è costituito
da due ghiandole endocrine distinte
•
•
•
Le ghiandole surrenali
Adrenalina
e
noradrenalina
Glucocorticoidi,
mineralcorticoidi,
steroidi sessuali
•
•
•
Descrivere le caratteristiche di un ormone
Distinguere le cellule endocrine dalle
cellule bersaglio
Distinguere tra ormoni peptidici, ormoni
steroidei e ormoni derivati da amminoacidi
Spiegare il meccanismo d’azione degli
ormoni idrosolubili e di quelli liposolubili
Descrivere le ghiandole endocrine
Elencare le ghiandole endocrine del corpo
umano associandole alle rispettive
funzioni
Spiegare come viene regolata la secrezione
ormonale distinguendo la regolazione a
feedback negativo da quella a feedback
positivo
Individuare i legami tra sistema nervoso e
sistema endocrino
Descrivere le azioni dell’ADH e
dell’ossitocina
Elencare
gli
ormoni
secreti
dall’adenoipofisi distinguendo le tropine
dagli ormoni ad azione diretta
Spiegare le relazioni tra ipotalamo e ipofisi
Descrivere la tiroide, gli ormoni da essa
secreti e le relazioni con ipotalamo e
ipofisi
Spiegare come l’ormone tiroideo regola il
metabolismo
Spiegare come calcitonina e paratormone
interagiscono
per
regolare
la
concentrazione del calcio nel sangue
Distinguere la vitamina D dalle altre
vitamine descrivendone le azioni
Descrivere la struttura del pancreas
endocrino
Spiegare come avviene, per opera di
insulina e glucagone, la regolazione della
glicemia
Spiegare come la somatostatina partecipa
al controllo della glicemia
Descrivere le ghiandole surrenali,
distinguendo tra regione midollare e
corticale
Spiegare
gli
effetti
differenti
dell’adrenalina su diverse cellule bersaglio
Descrivere le azioni delle tre classi di
ormoni steroidei prodotti dalla corticale
surrenale
Le gonadi producono ormoni
sessuali
•
•
•
•
La determinazione dei
caratteri
sessuali
primari e secondari
Ormoni sessuali e
sviluppo embrionale
Ormoni sessuali e
cambiamenti puberali
Gli ormoni prodotti
dall’epifisi e dal timo
•
•
•
•
•
•
Elencare gli ormoni prodotti dalle gonadi
maschili e femminili
Distinguere i caratteri sessuali primari da
quelli secondari, associandoli agli ormoni
che li determinano
Spiegare come gli androgeni inducono il
differenziamento embrionale in senso
maschile
Mettere in relazione l’azione degli ormoni
ipofisari con lo sviluppo in età puberale
Descrivere gli effetti della melatonina
nella regolazione dei ritmi biologici
Elencare gli ormoni prodotti dal timo e
loro funzioni
La riproduzione e lo sviluppo
COMPETENZE
• Comprendere le differenze e la complementarietà degli apparati riproduttori maschile e femminile che permettono la
formazione e l’incontro dei gameti per consentire la nascita di un nuovo individuo
• Acquisire la consapevolezza che il processo di fecondazione innesca nella donna una complessa serie di eventi che
portano allo sviluppo di un organismo completo e autonomo
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
e le funzioni
degli apparati
riproduttori maschile
e femminile
•
Le caratteristiche della
riproduzione umana
L’anatomia
dell’apparato
riproduttore maschile
L’anatomia
dell’apparato
riproduttore femminile
•
La spermatogenesi
L’oogenesi
•
La gametogenesi produce gameti
aploidi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Come funzionano l’apparato
riproduttore maschile
e femminile?
•
•
•
•
•
•
Il controllo ormonale
dell’attività sessuale
Il controllo ormonale
nel maschio
Il ciclo ovarico e il
ciclo uterino
Il controllo ormonale
del ciclo femminile
L’età fertile femminile
Gli aspetti fisiologici
dell’accoppiamento
•
•
•
•
Descrivere le tre caratteristiche della
riproduzione umana
Descrivere gli organi dell’apparato
riproduttore maschile e le ghiandole
annesse
Spiegare perché i testicoli si trovano in
una cavità esterna rispetto al corpo
Descrivere gli organi dell’apparato
riproduttore femminile
Descrivere le tappe che portano alla
formazione degli spermatozoi partendo
dagli spermatogoni
Spiegare la funzione dei tubuli seminiferi,
delle cellule di Sertoli e delle cellule
interstiziali
Descrivere le tappe che portano alla
formazione delle cellule uovo partendo
dagli oogoni
Confrontare la spermatogenesi con
l’oogenesi evidenziando analogie e
differenze tra i due processi
Individuare gli ormoni ipofisari e
ipotalamici che controllano la produzione
sia degli ormoni femminili sia di quelli
maschili
Descrivere gli effetti del testosterone a
partire dalla pubertà
Spiegare il significato del termine
menopausa
Spiegare come variano le attività
fisiologiche durante le quattro fasi
dell’accoppiamento
La fecondazione
e lo sviluppo embrionale
•
•
•
•
•
Fecondazione
e
sviluppo embrionale
Le
fasi
della
fecondazione
La segmentazione e
l’impianto
La gastrulazione
Il ruolo della placenta
•
•
•
•
•
•
•
L’embrione diventa feto:
l’organogenesi
e le ultime fasi
dello sviluppo
•
•
•
L’organogenesi
L’accrescimento
feto
Il parto
•
del
•
•
•
Distinguere lo zigote dall’embrione e dal
feto
Spiegare la complessa sequenza di eventi
che porta alla fusione del nucleo maschile
con quello femminile e alla formazione
dello zigote
Descrivere le tappe della segmentazione
distinguendo la morula dalla blastocisti
Descrivere il processo di impianto
dell’embrione nell’utero
Spiegare il significato di gravidanza
ectopica
Descrivere la formazione dei foglietti
embrionali
e
delle
membrane
extraembrionali
Spiegare la struttura e la funzione della
placenta
Spiegare
le
tappe
principali
dell’organogenesi
Descrivere gli eventi legati al secondo e al
terzo trimestre di gravidanza
Elencare gli ormoni prodotti durante il
parto spiegandone le funzioni
Distinguere la fase di travaglio dalla fase
espulsiva
Il sistema nervoso
COMPETENZE
• Comprendere come il sistema nervoso controlla, modula e integra le funzioni del corpo umano in risposta alle
variazioni dell’ambiente interno ed esterno
• Saper riconoscere nell’encefalo e, in particolare, nella corteccia cerebrale una struttura sofisticata, sede delle
capacità mentali come la memoria e il ragionamento
• Comprendere che anche piccole alterazioni nel funzionamento dell’encefalo possono provocare notevoli anomalie
sia fisiche sia comportamentali
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
e la funzione
del sistema nervoso
•
•
•
•
•
•
Come opera il sistema
nervoso
Il sistema nervoso
degli animali vertebrati
Le unità funzionali del
sistema nervoso
Le cellule gliali
Il controllo a feed-back
della
secrezione
ormonale
•
•
•
•
•
I neuroni generano
e conducono segnali elettrici
•
•
•
•
•
Il
potenziale
di
membrana dei neuroni
Il potenziale di riposo
Il potenziale d’azione
La propagazione del
potenziale d’azione
I
fattori
che
condizionano
la
velocità
della
•
•
•
•
Elencare le tre fasi secondo cui opera il
sistema nervoso
Distinguere le funzioni del sistema
nervoso centrale da quelle del sistema
nervoso periferico nei vertebrati
Descrivere il neurone evidenziando le
funzioni delle diverse parti
Definire le sinapsi
Distinguere i neuroni sensoriali dai
neuroni efferenti e dagli interneuroni
Spiegare le funzioni delle cellule gliali e
della guaina mielinica
Spiegare da che cosa dipende l’eccitabilità
dei neuroni
Spiegare come viene mantenuto il
potenziale di riposo evidenziando il ruolo
delle proteine di membrana
Descrivere come vengono regolati i canali
ionici
Analizzare gli eventi che susseguendosi
rapidamente determinano il potenziale
•
propagazione
dell’impulso nervoso
Intensità dei potenziali
d’azio-ne
•
•
•
Le sinapsi trasmettono
lo stimolo nervoso
da una cellula all’altra
•
•
•
•
•
Il sistema nervoso centrale
•
•
•
•
•
•
•
La
giunzione
neuromuscolare
La
trasmissione
sinaptica
Le sinapsi tra neuroni
I neurotrasmettitori
Le sinapsi elettriche
•
Lo
sviluppo
del
sistema
nervoso
centrale nei vertebrati
L’organizzazione
funzionale del sistema
nervoso centrale
Il telencefalo
Il diencefalo
Il tronco encefalico
Il cervelletto
Le meningi e il liquido
cerebrospinale
•
Spiegare come funziona una sinapsi
chimica utilizzando come esempio la
giunzione neuromuscolare
• Distinguere una sinapsi eccitatoria da una
inibitoria
• Spiegare come il neurone postsinaptico
integra le informazioni
• Elencare i principali neurotrasmettitori
distinguendoli in classi
• Spiegare come funziona una sinapsi
elettrica
•
•
•
•
•
•
•
Il midollo spinale
e i nervi trasmettono informazioni
•
•
•
I nervi spinali
I riflessi spinali
I nervi cranici
•
•
•
•
Le divisioni
del sistema nervoso periferico
•
•
•
Il sistema nervoso
autonomo
La
divisione
ortosimpatica
La
divisione
parasimpatica
d’azione
Spiegare come si propaga l’impulso
nervoso distinguendo tra propagazione
continua e saltatoria
Evidenziare l’importanza della guaina
mielinica e del diametro degli assoni per
determinare la velocità di propagazione
dell’impulso nervoso
Spiegare perché i potenziali d’azione sono
sempre
uguali
indipendentemente
dall’intensità dello stimolo che li ha
prodotti
•
•
•
Descrivere lo sviluppo del sistema nervoso
dei vertebrati evidenziando le tre vescicole
da cui deriva l’encefalo
Distinguere l’encefalo dal midollo spinale
e la sostanza grigia dalla sostanza bianca
Spiegare l’organizzazione del telencefalo
descrivendo la struttura dei due emisferi e
della corteccia cerebrale
Individuare i nuclei di sostanza grigia
presenti all’interno di ogni emisfero
collegandoli alle rispettive funzioni
Distinguere nel diencefalo il talamo,
l’ipotalamo e l’epifisi collegandoli alle
rispettive funzioni
Indicare le tre regioni del tronco encefalico
spiegandone le funzioni
Spiegare come è organizzato il cervelletto
e quali funzioni svolge
Identificare nelle meningi e nel liquido
cerebrospinale i sistemi di protezione del
sistema nervoso centrale
Descrivere la funzione dei nervi spinali
Definire i nervi misti distinguendo la
componente afferente da quella efferente
Spiegare come funziona il riflesso spinale
Descrivere i nervi cranici e le rispettive
funzioni
Mettere in relazione il sistema nervoso
autonomo con il sistema nervoso centrale
Distinguere il sistema autonomo in
ortosimpatico, parasimpatico ed enterico
Spiegare le differenze anatomiche e
funzionali tra sistema ortosimpatico e
parasimpatico
La consapevolezza e il controllo
del comportamento derivano
dall’attività
del telencefalo
•
•
•
•
•
L’organizzazione della
corteccia cerebrale
Il lobo temporale
Il lobo frontale
Il lobo parietale
Il lobo occipitale
•
•
•
•
•
Le reti
di neuroni elaborano informazioni
•
•
Apprendimento
e
memoria
Le capacità linguistiche
•
•
•
Descrivere la struttura della corteccia
cerebrale, specificando i lobi determinati dai
solchi
Distinguere la corteccia motoria e sensoriale
da quella associativa
Identificare nel lobo temporale la capacità
di udire e di riconoscere i volti
Mettere in relazione la corteccia motoria
primaria e la corteccia somatoestesica
primaria con le diverse aree da esse
controllate
Identificare nel lobo occipitale la capacità di
ricevere ed elaborare gli stimoli visivi
Distinguere
l’apprendimento
dalla
memoria
Definire la lateralizzazione
Mettere in relazione la capacità linguistica
con le aree di Broca e di Wernicke
Gli organi di senso e il movimento
COMPETENZE
• Comprendere che le informazioni che giungono agli organi effettori dal sistema nervoso sono il risultato
dell’elaborazione dei segnali captati dall’ambiente esterno e interno dai recettori sensoriali
NUCLEI FONDANTI
CONOSCENZE
L’organizzazione
e le funzioni
del sistema sensoriale
•
•
•
Cellule
e
sensoriali
La
qualità
sensazione
L’adattamento
sensoriale
COMPETENZE
organi
•
della
•
•
•
Come fanno
i sistemi sensoriali
a percepire
gli stimoli chimici
e meccanici?
•
•
•
L’olfatto
Il gusto
I meccanocettori
•
•
•
•
L’orecchio
è l’organo dell’udito
e dell’equilibrio
L’occhio è l’organo della vista
•
•
•
•
Le tre parti che
formano l’orecchio
Il sistema acustico
L’organo
dell’equilibrio
•
Le
•
tre
parti
che
•
•
Elencare I diversi tipi di recettori
sensoriali distinguendoli dagli organi di
senso
Spiegare le proprietà delle cellule
sensoriali evidenziando la capacità di
trasformare lo stimolo percepito in
potenziale d’azione
Collegare l’intensità di una sensazione con
la frequenza dei potenziali d’azione
generati
Spiegare il fenomeno dell’adattamento
sensoriale
Spiegare da che cosa dipende il senso
dell’odorato e in che modo possiamo
percepire odori diversi
Spiegare da che cosa dipende il senso del
gusto e in che modo possiamo percepire
sapori diversi
Descrivere i cinque principali tipi di
meccanocettori
Spiegare
le
funzioni
dei
fusi
neuromuscolari e degli organi di Golgi
Descrivere l’orecchio esterno, l’orecchio
medio e l’orecchio interno
Individuare la componente acustica
dell’orecchio e spiegarne le funzioni
Spiegare come funziona l’apparato
vestibolare
distinguendo
l’equilibrio
statico dall’equilibrio dinamico
Descrivere
la
struttura
dell’occhio
•
•
•
Gli organi effettori: il muscolo
scheletrico
e il muscolo liscio
•
•
•
•
•
formano l’occhio
La retina
I pigmenti fotosensibili
Le cavità dell’occhio
Le caratteristiche dei
muscoli scheletrici
Le miofibrille
La
contrazione
muscolare
L’attivazione
della
contrazione muscolare
Le caratteristiche dei
muscoli lisci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lo scheletro
fornisce sostegno
per i muscoli
•
•
L’endoscheletro umano
Le articolazioni
•
•
•
•
specificando la funzione di ogni sua parte
Individuare nella retina la struttura che
riceve ed elabora le informazioni visive
Distinguere i coni dai bastoncelli
Definire la fovea
Spiegare il ruolo delle opsine
Descrivere la funzione di umor acqueo e
umor vitreo
Individuare le caratteristiche comuni a tutti
i muscoli scheletrici specificando le
peculiarità delle cellule muscolari
Identificare
nel
sarcomero
l’unità
funzionale del muscolo scheletrico
specificandone la struttura
Spiegare il meccanismo molecolare della
contrazione specificando la funzione di
ATP e ioni calcio
Spiegare
come
la
giunzione
neuromuscolare attiva la contrazione
Descrivere
la
muscolatura
liscia
sottolineando le differenze con la
muscolatura
Descrivere
l’organizzazione
dello
scheletro umano distinguendo tra scheletro
assile e appendicolare
Distinguere l’osso compatto dall’osso
spugnoso
Descrivere le diverse parti delle
articolazioni distinguendo i tendini dai
legamenti e i muscoli flessori da quelli
estensori
Elencare i vari tipi di articolazioni presenti
nello scheletro umano
CHIMICA - CLASSI QUARTE
Competenze
Unità
didattica
Saper
effettuare
connessioni
logiche.
La quantità
chimica: la
mole
Traguardi formativi
Indicatori
1a. Essere consapevole della differenza tra quantità
di materia e quantità di sostanza.
- Utilizza correttamente le unità di
misura
1b. Riconoscere il comportamento degli aeriformi
come strumento per la determinazione delle
formule molecolari e delle masse atomiche
- Sa spiegare i rapporti di
combinazione tra volumi di
aeriformi
1c. Comprendere la relazione tra composizione
percentuale in massa e composizione atomica di un
composto.
- Comprende che il simbolismo
delle formule ha una
corrispondenza con grandezze
macroscopiche.
2a. Determinare la massa molare di una sostanza
nota la formula.
- Utilizza la tabella delle masse
atomiche per determinare le masse
molecolare/peso formula e molare
di una sostanza.
2b. Utilizzare il concetto di mole per convertire la
massa/il volume di una sostanza o il numero di
particelle elementari in moli e viceversa.
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
2c. Determinare la formula empirica e molecolare
di un composto.
- Applica le relazioni
stechiometriche che permettono il
passaggio dal mondo macroscopico
al mondo microscopico
- Esegue calcoli con cui
determinare la formula
minima/molecolare o la
composizione percentuale.
Le
particelle
dell’atomo
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
Traguardi formativi
Indicatori
1a. Comprendere come prove sperimentali abbiano
determinato il passaggio dal modello atomico di
Thomson a quello di Rutherford
- Individua i punti di forza e le
criticità del modello di Rutherford
1b. Spiegare come la composizione del nucleo
determina l’identità chimica dell’atomo
1c. Spiegare come il diverso numero di neutroni,
per un dato elemento, influenza la massa atomica
relativa
- Utilizza Z e A per stabilire quanti
nucleoni ed elettroni siano presenti
nell’atomo di una determinata
specie atomica e viceversa
- Determina la massa atomica come
valore medio in funzione della
composizione isotopica
dell’elemento
2c. Descrivere le reazioni nucleari di maggiore
interesse per la produzione di energia
- Valuta in maniera corretta la
misura, gli effetti e le applicazioni
delle radiazioni
- Correla il t1/2 di un isotopo al suo
utilizzo e a eventuali problemi di
smaltimento
- Spiega il meccanismo di reazione
a catena adoperando il concetto di
massa critica
Traguardi formativi
Indicatori
1a. Distinguere tra comportamento ondulatorio e
corpuscolare della radiazione elettromagnetica.
- Utilizza λ e ν per determinare la
posizione di una radiazione nello
spettro e stabilisce la relazione tra E
eν
2a. Descrivere le principali trasformazioni del
nucleo correlandole al diverso contenuto di
nucleoni
2b. Interpretare la legge del decadimento
radioattivo
Saper
applicare
conoscenze
acquisite alla
vita reale
Saper trarre
conclusioni
basate sui
risultati
ottenuti
1b. Riconoscere che il modello atomico di Bohr ha
come fondamento sperimentale l’analisi
spettroscopica della radiazione emessa dagli atomi.
1c. Comprendere come la teoria di de Broglie e il
principio di indeterminazione siano alla base di una
concezione probabilistica della materia
- Interpreta il concetto di
quantizzazione dell’energia e le
transizioni elettroniche nell’atomo
secondo il modello di Bohr
- Illustra la relazione di de Broglie e
il principio di Heisenberg
La
struttura
dell’atomo
Saper
risolvere
situazioni
problematiche
utilizzando
linguaggi
specifici
2a. Comprendere il significato di onda stazionaria e
l’importanza della funzione d’onda ψ
- Utilizza i numeri quantici per
descrivere gli elettroni di un atomo
2b. Essere consapevole dell’esistenza di livelli e
sottolivelli energetici e della loro disposizione in
ordine di energia crescente verso l’esterno
- Attribuisce a ogni corretta terna
di numeri quantici il
corrispondente orbitale.
2c. Utilizzare la simbologia specifica e le regole di
riempimento degli orbitali per la scrittura delle
configurazioni elettroniche di tutti gli atomi
- Scrive la configurazione degli
atomi polielettronici in base al
principio di Aufbau, di Pauli e alla
regola di Hund
Traguardi formativi
Indicatori
Saper
classificare
Il sistema
periodico
1a. Descrivere le principali proprietà di metalli,
semimetalli e non metalli
- Classifica un elemento sulla base
delle sue principali proprietà
1b. Individuare la posizione delle varie famiglie di
elementi nella tavola periodica
- Classifica un elemento in base alla
posizione che occupa nella tavola
periodica
1c. Spiegare la relazione fra Z, struttura elettronica
e posizione degli elementi sulla tavola periodica
2a. Comprendere che la legge della periodicità è
stata strumento sia di classificazione sia di
predizione di elementi
Saper
effettuare
connessioni
logiche
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
2b. Discutere lo sviluppo storico del concetto di
periodicità.
2c. Spiegare gli andamenti delle proprietà
periodiche degli elementi nei gruppi e nei periodi
- Classifica un elemento in base alla
sua struttura elettronica
- Descrive come Mendeleev arrivò
a ordinare gli elementi
- Mette a confronto i criteri di
classificazione del 19° secolo con
l’ordinamento in base a Z
crescente
- Mette in relazione la struttura
elettronica, la posizione degli
elementi e le loro proprietà
periodiche
Traguardi formativi
Indicatori
1a. Distinguere e confrontare i diversi legami
chimici (ionico, covalente, metallico)
- Riconosce il tipo di legame
esistente tra gli atomi, data la
formula di alcuni composti
1b. Stabilire in base alla configurazione elettronica
esterna il numero e il tipo di legami che un atomo
può formare
1c. Definire la natura di un legame sulla base della
differenza di elettronegatività
- Scrive la struttura di Lewis di
semplici specie chimiche che si
formano per combinazione dei
primi 20 elementi
- Individua le cariche parziali in un
legame covalente polare
2a. Descrivere le proprietà osservabili dei materiali,
sulla base della loro struttura microscopica
I legami
chimici
Saper
formulare
ipotesi in base
ai dati forniti
2b. Prevedere, in base alla posizione nella tavola
periodica, il tipo di legame che si può formare tra
due atomi.
2c. Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la
geometria di semplici molecole
- Formula ipotesi, a partire dalle
proprietà fisiche, sulla struttura
microscopica di alcune semplici
specie chimiche
- Utilizza la tavola periodica per
prevedere la formazione di specie
chimiche e la loro natura
- Spiega la geometria assunta da
una molecola nello spazio in base al
numero di coppie solitarie e di
legame dell’atomo centrale
Traguardi formativi
Indicatori
1a. Comprendere il concetto di risonanza
- Scrive le formule limite di una
determinata struttura chimica
1b. Spiegare la teoria del legame di valenza e
l’ibridazione degli orbitali atomici
Saper
formulare
ipotesi in base
ai dati forniti
Le nuove
teorie del
legame
1c. Comprendere i diagrammi di energia degli
orbitali molecolari
- Utilizza il diagramma dell’energia
degli orbitali molecolari per
spiegare le proprietà magnetiche
dell’ossigeno
2a. Utilizzare le diverse teorie sui legami chimici
per spiegare le proprietà e le strutture delle
molecole
Saper
risolvere
situazioni
problematiche
utilizzando
linguaggi
specifici
- Utilizza il modello
dell’ibridazione degli orbitali per
prevedere la geometria di una
molecola e viceversa
2b. Aver compreso il concetto di modello in ambito
scientifico
2c. Aver compreso l’evoluzione storica dei modelli
riguardanti la formazione dei legami chimici
Traguardi formativi
- Individua i casi limite in cui la
teoria di Lewis non è in grado di
spiegare dati sperimentali e propone
adeguati correttivi
- Attribuisce il corretto significato
alle diverse teorie di legame
- È in grado di individuare punti di
forza e punti di debolezza delle
diverse teorie di legame
Indicatori
Le forze
intermoleco
lari e gli
stati
condensati
della
materia
1a. Individuare se una molecola è polare o apolare,
dopo averne determinato la geometria in base al
modello VSEPR
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
1b. Correlare le forze che si stabiliscono tra le
molecole alla loro eventuale miscibilità
1c. Correlare le proprietà fisiche dei solidi e dei
liquidi alle interazioni interatomiche e
intermolecolari
2a. Prevedere la miscibilità di due sostanze tra loro
Saper
applicare le
conoscenze
acquisite alla
vita reale
2b. Comprendere l’importanza del legame a
idrogeno in natura
2c. Comprendere come la diversa natura delle forze
interatomiche e intermolecolari determini stati di
aggregazione diversi a parità di temperatura
- Stabilisce la polarità di una
molecola sulla base delle differenze
di elettronegatività e della
geometria
- Spiega la miscibilità di due o più
sostanze in base alla natura delle
forze intermolecolari
- Mette in relazione le proprietà
fisiche delle sostanze alle forze di
legame
- Prende in esame le interazioni fra
le molecole per stabilire se due
sostanze sono miscibili
- Giustifica le proprietà fisiche
dell’acqua, la struttura delle
proteine e di altre molecole in base
alla presenza del legame a idrogeno
-Riconduce a un modello il
comportamento dello stato solido e
dello stato liquido
Classificazi
one e
nomenclatu
ra dei
composti
Saper
classificare
Traguardi formativi
Indicatori
1a. Classificare le principali categorie di composti
inorganici in binari/ternari, ionici/molecolari
- Riconosce la classe di
appartenenza dati la formula o il
nome di un composto
1b. Raggruppare gli ossidi in base al loro
comportamento chimico
1c. Raggruppare gli idruri in base al loro
comportamento chimico
- Distingue gli ossidi acidi, gli
ossidi basici e gli ossidi con
proprietà anfotere
- Distingue gli idruri ionici e
molecolari
2a. Applicare le regole della nomenclatura IUPAC
e tradizionale per assegnare il nome a semplici
composti e viceversa
Saper
risolvere
situazioni
problematiche
utilizzando
linguaggi
specifici
- Assegna il nome IUPAC e
tradizionale ai principali composti
inorganici
2b. Scrivere le formule di semplici composti
- Utilizza il numero di ossidazione
degli elementi per determinare la
formula di composti
2c. Scrivere la formula di sali ternari
- Scrive la formula di un composto
ionico ternario utilizzando le tabelle
degli ioni più comuni
Saper trarre
conclusioni
basate sui
risultati
ottenuti
Le
proprietà
delle
soluzioni
Traguardi formativi
Indicatori
1a Interpretare i processi di dissoluzione in base
alle forze intermolecolari che si possono stabilire
tra le particelle di soluto e di solvente
- Riconosce la natura del soluto in
base a prove di conducibilità
elettrica
1b. Organizzare dati e applicare il concetto di
concentrazione e di proprietà colligative
- Determina la massa molare di un
soluto a partire da valori delle
proprietà colligative
1c. Leggere diagrammi di solubilità
(solubilità/temperatura; solubilità/pressione)
2a. Conoscere i vari modi di esprimere le
concentrazioni delle soluzioni
Saper
applicare le
conoscenze
acquisite alla
vita reale
2b. Comprendere le proprietà colligative delle
soluzioni
2c. Comprendere l’influenza della temperatura e
della pressione sulla solubilità
- Stabilisce, in base ad un grafico,
le condizioni necessarie per
ottenere una soluzione satura
- Valuta correttamente informazioni
sui livelli di inquinanti presenti in
alcuni fluidi
- Utilizza il concetto di pressione
osmotica per spiegare la necessità
di un ambiente ipertonico al fine di
impedire la decomposizione
batterica dei cibi
-E’ in grado di spiegare il rischio di
embolia gassosa per chi pratica
attività subacquea
Traguardi formativi
Indicatori
1a. Interpretare un’equazione chimica in base alla
legge della conservazione di massa
Le reazioni
chimiche
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
1b. Interpretare un’equazione chimica in termini di
quantità di sostanza
1c. Mettere in relazione dati teorici e dati
sperimentali
- Bilancia una reazione chimica
- Utilizza i coefficienti
stechiometrici per la risoluzione di
problemi che chiedono di
determinare massa/volume delle
specie chimiche coinvolte
- Riconosce il reagente limitante e
determina la resa di una reazione
2a. Conoscere i vari tipi di reazioni chimiche
Saper
classificare
2b. Individuare le reazioni di doppio scambio in cui
si forma un precipitato
2c. Riconoscere una reazione di neutralizzazione
- Riconduce una reazione chimica a
uno dei quattro tipi fondamentali
(sintesi, decomposizione, scambio
semplice, doppio scambio)
- Scrive l’equazione ionica netta, a
partire dall’equazione molecolar
- Individua i reagenti in grado di
dare origine alla formazione di un
sale e acqua
Traguardi formativi
Indicatori
1a Descrivere come variano l’energia potenziale e
l’energia cinetica durante una trasformazione
- Spiega come varia l’energia
chimica di un sistema durante una
trasformazione endo/esotermica
1b. Comprendere il significato della variazione di
entalpia durante una trasformazione
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
L’energia si
trasferisce
1c. Mettere in relazione la spontaneità di una
reazione con la variazione di entalpia e di entropia
- Mette in relazione il segno della
variazione dell’entalpia con la
quantità di calore scambiato con
l’ambiente
- Prevede la spontaneità di una
reazione, attraverso la variazione di
energia libera del sistema
Saper
applicare le
conoscenze
acquisite alla
vita reale
2a. Conoscere il diverso potere calorifico dei
combustibili
- Mette a confronto i combustibili
fossili con biocombustibili
2b. Comprendere il diverso potere calorifico degli
alimenti e il loro ruolo nel metabolismo energetico
- E’ in grado di valutare il diverso
fabbisogno energetico degli
organismi viventi in relazione alla
loro attività
2c. Distinguere le trasformazioni spontanee con
riferimento a fenomeni della vita quotidiana
- Individua nella fusione spontanea
del ghiaccio, la variazione entalpica
e entropica
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
Traguardi formativi
Indicatori
1a. Riconoscere il carattere sperimentale
dell’equazione cinetica, non deducibile
dall’equazione chimica bilanciata di reazione
Interpreta l’equazione cinetica di
una reazione e sa definirne l’ordine
1b. Spiegare la cinetica di reazione alla luce della
teoria degli urti
1c. Riconoscere nell’equazione cinetica lo
strumento per definire il meccanismo di una
reazione
2a. Interpretare grafici concentrazione/tempo
2b. Costruire il profilo energetico a partire dai
valori di Eatt e ΔH
La velocità
di reazione
Saper trarre
conclusioni
basate sui
risultati
ottenuti
2c. Comprendere in quale stadio intervenire con un
catalizzatore per accelerare la reazione
Traguardi formativi
- Illustra il ruolo dei fattori che
determinano la velocità di reazione
- Sa definire la molecolarità di una
reazione elementare
- Utilizza i dati sperimentali per
stabilire l’ordine di reazione
- Distingue fra energia di reazione
ed energia di attivazione
- Interpreta il grafico del profilo
energetico di una reazione con
meccanismo a più stadi
Indicatori
Saper
trarre
conclusioni
basate
sui
risultati
ottenuti
1a. Comprendere che il valore di Keq di un sistema
chimico non dipende dalle concentrazioni iniziali
- Applica la legge dell’azione di
massa
1b. Interpretare la relazione fra i valori di Keq e le
diverse temperature
- Riconosce il carattere
endo/esotermico di una reazione
nota la dipendenza di Keq dalla
temperatura
1c. Conoscere la relazione fra kc e kp
- Individua le reazioni in cui i valori
di kc e kp coincidono
L’equilibri
o chimico
Saper
formulare
ipotesi in base
ai dati forniti
2a. Prevedere l’evoluzione di un sistema, noti i
valori di Keq e Q
- Stabilisce il senso in cui procede
una reazione noti i valori di Keq e Q
2b. Acquisire il significato concettuale del principio
di Le Chatelier
- Valuta gli effetti sull’equilibrio
della variazione di uno dei
parametri indicati dal principio di
Le Chatelier
3b. Conoscere la relazione fra kps e solubilità di una
sostanza
- Prevede la solubilità di un
composto in acqua pura o in
soluzione
Traguardi formativi
Indicatori
1a. Comprendere l’evoluzione storica e concettuale
delle teorie acido – base
- Classifica correttamente una
sostanza come acido/base di
Arrhenius, Bronsted – Lowry,
Lewis
1b. Individuare il pH di una soluzione
Acidi e basi
si
scambiano
protoni
Saper
classificare
1c. Stabilire la forza di un acido/base, noto il valore
di ka/kb
- Assegna il carattere acido o basico
di una soluzione in base ai valori di
[H+] o [OH-]
- Ordina una serie di specie chimica
in base al criterio di acidità
crescente
2a. Scegliere la relazione opportuna per
determinare il pH
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
2b. Comprendere i meccanismi dell’idrolisi salina
2c. Individuare i casi in cui è conveniente esprimere
la concentrazione di un acido o di una base come
normalità
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
- Applica la relazione NAVA =
NBVB e determina, in base ai dati, il
titolo di una soluzione
Indicatori
1a. Riconoscere il significato e l’importanza delle
reazioni ossido – riduttive nel mondo biologico
- Scrive e interpreta le equazioni
della fotosintesi e della respirazione
cellulare, con riferimento alle
energie in gioco
2a. Riconoscere in una reazione di ossido –
riduzione, l’agente che si ossida e quello che si
riduce
- Individua l’agente ossidante e
riducente applicando le regole per
la determinazione del n.o.
2b. Scrivere le equazioni redox bilanciate sia in
forma molecolare sia in forma ionica
- Bilancia le reazioni redox col
metodo della variazione del n.o. e
con il metodo ionico – elettronico
2c. Esprimere la concentrazione delle soluzioni che
partecipano a reazioni redox in termini di normalità,
N
Traguardi formativi
L’elettrochi
- Spiega il carattere acido, neutro o
basico di una soluzione salina
Traguardi formativi
Saper
applicare le
conoscenze
acquisite alla
vita reale
Le reazioni
di ossido –
riduzione
- Calcola il pH di soluzioni di
acidi/basi forti e deboli o di
soluzioni tampone
- Utilizza il concetto di equivalente
per mettere in relazione normalità e
molarità
Indicatori
mica
Saper
riconoscere e
stabilire
relazioni
1a. Comprendere che le reazioni redox spontanee
possono generare un flusso di elettroni
- Spiega il funzionamento della pila
Daniell
1b. Avere consapevolezza della relazione fra
energia libera e potenziale standard di una pila
- Utilizza la scala dei potenziali
standard per stabilire la spontaneità
di un processo
1c. Conoscere i fattori da cui dipende il valore della
differenza di potenziale agli elettrodi di una pila
2a. Collegare la posizione di una specie chimica
nella tabella dei potenziali standard alla sua
capacità riducente
Sa applicare le
conoscenze
acquisite alla
vita reale
2b. Stabilire confronti fra le celle galvaniche e le
celle elettrolitiche
2b. Comprendere l’importanza delle reazioni redox
nella produzione di energia elettrica
BIOLOGIA – CLASSE QUINTA --
- Applica l’equazione di Nernst
- Interpreta correttamente i
fenomeni di corrosione
- Riconosce il ruolo dei processi
ossidoriduttivi nei metodi di
isolamento e purificazione di specie
chimiche
- Analizza le prestazione dei diversi
tipi di pile in commercio
LICEO LINGUISTICO
IL CORPO UMANO
• Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da sistemi autonomi ma strettamente correlati
• Saper mettere in relazione il buon funzionamento del proprio corpo con il mantenimento di condizioni fisiologiche
costanti
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
Il corpo umano
presenta
un’organizzazione
gerarchica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L’organizzazione dei tessuti
La funzione degli epiteli
I principali tipi di tessuti epiteliali
La funzione del tessuto muscolare
Il tessuto muscolare liscio e striato
Le funzioni del tessuto connettivo
I connettivi propriamente detti
I connettivi specializzati
Il tessuto nervoso
•
•
•
•
•
•
Descrivere l’organizzazione strutturale dei
tessuti
Elencare i tipi e le rispettive funzioni dei
tessuti presenti nel corpo umano
Distinguere gli epiteli di rivestimento da
quelli ghiandolari e sensoriali
Distinguere le ghiandole esocrine da quelle
endocrine
Descrivere e distinguere i tre tipi di tessuto
muscolare
Classificare i tessuti connettivi in base alla
loro funzione e alla composizione della
matrice
Descrivere il tessuto nervoso distinguendo i
neuroni dalle cellule gliali
Organi, sistemi
e apparati:
uno sguardo
d’insieme
•
•
•
•
Gli organi e i sistemi che formano il corpo
umano
I sistemi di coordinamento del corpo
umano: nervoso ed endocrino
Le membrane interne
La cute
•
•
•
•
•
La comunicazione
tra le cellule
e la regolazione
dell’attività
cellulare
•
•
•
•
Le modalità di comunicazione tra cellule
Recettori e molecole segnale
La trasduzione del segnale
Le giunzioni serrate
•
L’omeostasi: come
mantenere costante
l’ambiente interno
•
•
•
Le condizioni da mantenere costanti
I meccanismi dell’omeostasi
La regolazione della temperatura corporea
•
•
•
•
•
•
Descrivere l’organizzazione strutturale del
corpo umano
Elencare i diversi tipi di sistemi che
compongono
l’organismo
umano
indicandone le funzioni
Indicare le diverse modalità con cui il
sistema nervoso e quello endocrino
garantiscono
l’equilibrio
interno
e
l’adattamento alle condizioni ambientali
Illustrare le funzioni delle membrane interne
distinguendo le sierose da quelle mucose
Descrivere la struttura e le funzioni svolte
dalla cute
Illustrare come si svolge la comunicazione
tra cellule
Spiegare la trasduzione del segnale
Descrivere le giunzioni serrate
Elencare le variabili da mantenere costanti
nel nostro organismo
Illustrare come lavora il sistema di controllo
delle variabili
Distinguere i sistemi a feedback negativo da
quelli a feedback positivo
Descrivere la regolazione a feedback
negativo della temperatura corporea
L’apparato cardiovascolare e il sangue
COMPETENZE
•
•
Comprendere il ruolo fondamentale svolto dal cuore nel sistema cardiovascolare e l’importanza di una perfetta
coordinazione dei meccanismi che lo azionano e lo regolano
Mettere in relazione l’efficienza della circolazione con il proprio stato di salute
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
dell’apparato
cardiovascolare
•
•
•
•
Un sistema chiuso con una doppia
circolazione
L’anatomia dell’apparato cardiovascolare
I movimenti del sangue
Il cuore è il motore
dell’apparato
cardiovascolare
•
•
•
L’anatomia del cuore
Il ciclo cardiaco
Il battito cardiaco
•
•
•
•
•
•
•
I vasi sanguigni
e il movimento
•
•
Struttura e funzione delle arterie
I capillari
•
Descrivere la circolazione doppia e
completa
Descrivere la struttura del cuore
Distinguere le arterie dalle vene
Spiegare il percorso del sangue nel corpo
umano partendo dal lato destro del cuore
Descrivere i tre strati che formano la parete
del cuore
Descrivere gli eventi del ciclo cardiaco
distinguendo la sistole dalla diastole
Indicare la funzione delle valvole cardiache
e i
problemi
derivanti
da
loro
malfunzionamento
Spiegare come insorge e si propaga il battito
cardiaco
Descrivere la struttura delle arterie e delle
vene in relazione alle loro rispettive funzioni
del sangue
•
Struttura e funzione delle vene
•
•
I meccanismi
di scambio
e la regolazione
del flusso sanguigno
•
•
•
La composizione
e le funzioni
del sangue
•
•
•
•
Gli scambi nei capillari
La funzione delle arteriole
Il controllo del flusso sanguigno
•
•
•
Gli elementi figurati e il plasma
Gli eritrociti
I leucociti
Le piastrine
•
•
•
•
•
•
Descrivere la rete capillare correlandola con
gli scambi effettuati tra il sangue in essa
contenuto e le cellule
Evidenziare i meccanismi che consentono al
sangue di ritornare al cuore
Indicare le sostanze che attraversano
liberamente la parete dei capillari
Spiegare come è mantenuto costante il
volume del sangue nei capillari
Spiegare come il sistema endocrino e quello
nervoso controllano il flusso sanguigno
Elencare gli elementi figurati e le loro
rispettive funzioni
Descrivere la composizione del plasma e le
sue funzioni
Descrivere gli eritrociti e il trasporto dei gas
respiratori
Distinguere i diversi tipi di leucociti e le
rispettive funzioni
Spiegare il processo di coagulazione del
sangue
Descrivere l’emopoiesi
L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi
Competenze
• Comprendere le relazioni tra le strutture e le funzioni delle diverse parti dell’apparato respiratorio
• Saper mettere in relazione le funzioni dell’apparato respiratorio con quelle dell’apparato cardiovascolare
comprendendo la stretta interdipendenza di questi due apparati
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione e
la funzione
dell’apparato
respiratorio
•
•
•
•
•
I due processi della respirazione
polmonare
L’anatomia dell’apparato respiratorio
umano
Le relazioni tra polmoni e cavità toracica
•
•
La meccanica della
respirazione: la
ventilazione
polmonare
•
•
•
Inspirazione ed espirazione
Le secrezioni del tratto respiratorio
Il controllo della ventilazione
•
•
•
•
•
Il sangue
e gli scambi
•
•
Scambi gassosi per diffusione
Lo scambio polmonare dei gas
•
Distinguere l’inspirazione dall’espirazione
Spiegare gli scambi gassosi a livello
polmonare e dei tessuti
Descrivere i diversi tratti dell’apparato
respiratorio
Spiegare le relazioni anatomiche e
funzionali tra la cavità toracica, la cavità
pleurica e i polmoni
Descrivere l’inspirazione come un processo
attivo e l’espirazione come un processo
passivo
Spiegare come varia la pressione nella
ventilazione polmonare
Descrivere il ruolo svolto dal muco e dal
surfactante
Spiegare come il sistema nervoso centrale
controlla il normale alternarsi di inspirazioni
ed espirazioni
Evidenziare la stretta relazione tra sistema
nervoso, recettori, apparato cardiovascolare
e respiratorio per garantire un adeguato
apporto di ossigeno ai tessuti
Descrivere come i gas respiratori passano
dall’aria al sangue e viceversa
dei gas respiratori
•
•
•
•
Lo scambio sistemico dei gas
Il trasporto dell’ossigeno
Il trasporto del diossido di carbonio
La mioglobina
•
•
•
•
Descrivere gli scambi gassosi a livello dei
tessuti
Spiegare come viene trasportato l’ossigeno
nel sangue
Spiegare come viene trasportato il diossido
di carbonio nel sangue
Illustrare il ruolo della mioglobina nei
muscoli
L’apparato digerente e l’alimentazione
COMPETENZE
• Comprendere che il processo digestivo ha la funzioni elaborare gli alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili
dalle nostre cellule
• Saper mettere in relazione i diversi organi che compongono l’apparato digerente con le rispettive funzioni
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione e
la funzione
dell’apparato
digerente
•
•
•
•
•
•
•
•
Le fasi della trasformazione del cibo
Lo scopo della digestione
I nutrienti essenziali
I macronutrienti e i micronutrienti
Le vitamine
L’organizzazione dell’apparato digerente
L’anatomia dell’apparato digerente
•
•
•
•
Dalla bocca
allo stomaco:
le prime fasi
della digestione
•
•
•
La digestione in bocca
La digestione nello stomaco
Il passaggio del chimo nell’intestino tenue
•
•
•
•
L’intestino lavora
in sinergia
con il pancreas
e il fegato
•
•
•
•
•
•
La digestione nell’intestino tenue
Struttura e funzione digestiva del fegato
Le altre funzioni del fegato
Il pancreas ghiandola esocrina ed endocrina
L’assorbimento all’interno dell’intestino
tenue
Struttura e funzioni dell’intestino crasso
•
•
•
•
•
•
•
•
Il controllo
della digestione
e il metabolismo
•
•
Il controllo della digestione da parte del
sistema nervoso e di ormoni
Il controllo della glicemia
•
•
•
Descrivere le diverse fasi della
trasformazione del cibo
Spiegare a che cosa serve la digestione
Individuare tra le sostanze presenti nel
cibo quelle indispensabili per il corpo
umano
Distinguere il ruolo svolto da minerali e
vitamine da quello di carboidrati, proteine
e lipidi
Descrivere la struttura della parete del
canale alimentare e i diversi tratti
dell’apparato digerente
Descrivere le fasi della digestione che si
svolgono in bocca
Descrivere la struttura dello stomaco
elencando i secreti prodotti dalle fossette
gastriche
Spiegare le funzioni dell’acido cloridrico,
della pepsina e del muco
Descrivere il passaggio del chimo dallo
stomaco all’intestino tenue
Illustrare i processi digestivi che si
svolgono nell’intestino tenue
Descrivere la struttura del fegato e le
funzioni della bile
Spiegare le funzioni del fegato collegate al
metabolismo
Distinguere le LDL dalle HDL e dalle
VLDL evidenziando il loro ruolo nella
regolazione del colesterolo e dei
trigliceridi nel sangue
Descrivere il pancreas e la funzione delle
sostanze che produce
Distinguere tra le diverse modalità di
assorbimento delle sostanze nutritive
Descrivere la struttura dell’intestino crasso
e le funzioni della flora batterica
intestinale
Spiegare le conseguenze di un anomalo
riassorbimento di acqua
Spiegare come il sistema nervoso
intrinseco coordina le attività del tratto
digestivo
Spiegare come agiscono secretina,
colecistochinina e gastrina
Spiegare come la parte endocrina del
pancreas regola la glicemia
L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino
COMPETENZE
• Comprendere la complessità e l’importanza per la salute dei meccanismi messi in atto dai reni per mantenere
l’equilibrio idrosalino e per eliminare i rifiuti metabolici azotati
• Saper mettere in relazione i diversi tratti del nefrone con le rispettive funzioni
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
e le funzioni
dell’apparato
urinario
•
•
•
•
•
Gli organi che formano l’apparato urinario
Le funzioni dei reni
L’equilibrio idrico e salino
L’eliminazione delle sostanze azotate
•
•
•
Il nefrone
è l’unità funzionale
del rene
•
•
•
•
•
La struttura del rene
Il glomerulo e la capsula di Bowman
Il tubulo renale
I capillari peritubolari
Le tre tappe della formazione dell’urina
•
•
I nefroni modulano
la loro attività in
relazione alle
esigenze
dell’organismo
•
La regolazione della concentrazione dei
liquidi corporei
La moltiplicazione controcorrente
Lo scambio controcorrente
Il mantenimento dell’equilibrio acido-base
nel sangue
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I meccanismi
che regolano
le funzioni dei reni
•
•
•
I fattori che influenzano la filtrazione
glomerulare
Gli effetti di angiotensina e aldosterone
L’ormone antidiuretico
•
•
•
Descrivere la struttura dell’apparato
urinario
Elencare i processi che portano alla
formazione dell’urina
Spiegare perché il controllo dell’equilibrio
idrico è legato al controllo della
concentrazione salina
Individuare nell’urea il catabolita azotato
eliminato dai reni umani
Descrivere la struttura del rene
Mettere in relazione le diverse parti del
nefrone con le rispettive funzioni
Descrivere i processi che dal filtrato
glomerulare portano alla formazione
dell’urina
Spiegare cosa si intende per osmolarità e
come viene regolata
Spiegare
il
meccanismo
della
moltiplicazione controcorrente
Elencare i vantaggi della moltiplicazione
controcorrente
Mettere in relazione lo scambio
controcorrente con il gradiente osmotico
verticale
Spiegare in che modo i reni controllano il
pH del sangue
Elencare i fattori che influenzano la
velocità di filtrazione glomerulare
Spiegare come agiscono gli ormoni
angiotensina e aldosterone
Spiegare come l’ADH regola la pressione
sanguigna e l’osmolarità del sangue
Il sistema linfatico e l’immunità
COMPETENZE
• Acquisire le informazioni essenziali per comprendere l’importanza della tutela della propria salute, nonché la
complessità dei meccanismi messi in atto dal nostro corpo per combattere le malattie
• Comprendere l’importanza per il corpo umano di mettere in atto meccanismi in grado di operare una precisa
distinzione tra self e non self
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
Il sistema linfatico e
gli organi linfatici
sono importanti
per la difesa
•
•
•
•
L’immunità innata e l’immunità adattativa
I vasi linfatici e i linfonodi
Gli organi linfatici primari e secondari
•
Distinguere l’immunità innata da quella
adattativa
Descrivere
il
sistema
linfatico
distinguendo i vasi linfatici dai linfonodi
immunitaria
L’immunità innata:
la prima linea
di difesa
dell’organismo
•
•
•
Le barriere superficiali
Le difese aspecifiche cellulari e chimiche
L’infiammazione
•
Differenziare gli organi linfatici in primari
e secondari
•
Descrivere i sistemi di difesa costituiti
dalla cute, dalle membrane e dai loro
secreti
Elencare le difese aspecifiche di natura
chimica e cellulare
Descrivere il processo infiammatorio
evidenziando il ruolo della febbre e
dell’istamina
•
•
I linfociti:
responsabili
dell’immunità
adattativa
•
•
•
•
Il processo di riconoscimento degli antigeni
I recettori antigenici
La selezione clonale
I linfociti T e i linfociti B
•
•
•
•
•
La risposta
immunitaria
umorale
•
•
La risposta
immunitaria
cellulare
•
•
•
La risposta immunitaria primaria
Gli anticorpi
•
•
•
•
•
I linfociti T helper e citotossici
Le proteine MHC di classe I e di classe II
Il ruolo delle proteine MHC II e dei linfociti
T helper nella risposta umorale
Il ruolo delle proteine MHC I e dei linfociti
T citotossici nella risposta cellulare
La tolleranza nei confronti del self
•
•
•
•
•
•
La memoria
immunologica
Che cosa succede
quando l’immunità
non funziona?
•
•
•
•
•
La risposta immunitaria secondaria
L’immunità acquisita
I vaccini
Le vaccinazioni
L’immunità passiva
•
•
•
Le allergie
Immunodeficienze e malattie autoimmuni
•
•
•
•
•
•
•
•
Distinguere il self dal non-self
Spiegare come l’organismo riconosce gli
antigeni
Mettere in relazione la varietà dei
determinanti antigenici con la variabilità
genetica
Spiegare come si formano i linfociti per
selezione clonale distinguendo le cellule
effettrici dalle cellule della memoria
Distinguere
l’immunità
umorale
dall’immunità cellulare
Spiegare la sequenza di passaggi che dà
luogo alla risposta primaria
Descrivere la struttura degli anticorpi
Spiegare come gli anticorpi neutralizzano
gli antigeni
Distinguere i linfociti T helper dai
citotossici
Distinguere le proteine MHC di classe I da
quelle di classe II
Individuare nelle proteine MHC le
strutture in grado di presentare gli antigeni
Spiegare come i linfociti T helper
intervengono
nell’attuazione
dell’immunità umorale
Spiegare come i linfociti T citotossici
riconoscono e contribuiscono ad eliminare
le cellule infettate da virus e le cellule
tumorali
Spiegare i rapporti tra proteine MHC e
trapianti di organi
Spiegare come si acquisisce la memoria
immunologica
Spiegare perché la risposta secondaria è
più rapida di quella primaria
Distinguere tra immunità attiva e passiva
Descrivere i diversi tipi di vaccini
Spiegare come agiscono i vaccini
Distinguere tra vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate
Definire gli allergeni
Distinguere tra ipersensibilità immediata e
ritardata
Descrivere le immunodeficienze primarie
distinguendole dalle malattie autoimmuni
•
Elencare le
autoimmuni
più
comuni
malattie
Il sistema endocrino
COMPETENZE
• Comprendere l’importanza degli ormoni per controllare, modulare e integrare le funzioni del corpo umano in
risposta alle variazioni dell’ambiente interno ed esterno
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
e la funzione
del sistema
endocrino
•
•
•
•
•
•
•
Gli ormoni come messaggeri chimici
La natura chimica dei diversi ormoni
Ormoni idrosolubili e liposolubili
Ghiandole e cellule secretrici
Il controllo a feedback della secrezione
ormonale
•
•
•
•
•
•
L’integrazione
tra funzioni nervose
ed endocrine
avviene
a livello dell’ipofisi
e dell’ipotalamo
•
Tiroide
e paratiroidi
regolano
il metabolismo
e l’omeostasi
•
•
•
•
•
•
Il rilascio di ADH e ossitocina da parte della
neuroipofisi
Gli ormoni prodotti dall’adenoipofisi
Gli ormoni ipotalamici
•
•
•
La struttura della tiroide
L’ormone tiroideo
Calcitonina e paratormone
La vitamina D
•
•
•
•
Il pancreas
endocrino
e il controllo
della glicemia
•
•
•
La struttura del pancreas
L’insulina e il glucagone
La somatostatina
•
•
•
Il surrene
è costituito
da due ghiandole
•
•
•
Le ghiandole surrenali
Adrenalina e noradrenalina
Glucocorticoidi, mineralcorticoidi,
sessuali
•
steroidi
•
Descrivere le caratteristiche di un ormone
Distinguere le cellule endocrine dalle
cellule bersaglio
Distinguere tra ormoni peptidici, ormoni
steroidei e ormoni derivati da amminoacidi
Spiegare il meccanismo d’azione degli
ormoni idrosolubili e di quelli liposolubili
Descrivere le ghiandole endocrine
Elencare le ghiandole endocrine del corpo
umano associandole alle rispettive
funzioni
Spiegare come viene regolata la secrezione
ormonale distinguendo la regolazione a
feedback negativo da quella a feedback
positivo
Individuare i legami tra sistema nervoso e
sistema endocrino
Descrivere le azioni dell’ADH e
dell’ossitocina
Elencare
gli
ormoni
secreti
dall’adenoipofisi distinguendo le tropine
dagli ormoni ad azione diretta
Spiegare le relazioni tra ipotalamo e ipofisi
Descrivere la tiroide, gli ormoni da essa
secreti e le relazioni con ipotalamo e
ipofisi
Spiegare come l’ormone tiroideo regola il
metabolismo
Spiegare come calcitonina e paratormone
interagiscono
per
regolare
la
concentrazione del calcio nel sangue
Distinguere la vitamina D dalle altre
vitamine descrivendone le azioni
Descrivere la struttura del pancreas
endocrino
Spiegare come avviene, per opera di
insulina e glucagone, la regolazione della
glicemia
Spiegare come la somatostatina partecipa
al controllo della glicemia
Descrivere le ghiandole surrenali,
distinguendo tra regione midollare e
corticale
Spiegare
gli
effetti
differenti
endocrine distinte
•
Le gonadi
producono ormoni
sessuali
•
•
•
•
La determinazione dei caratteri sessuali
primari e secondari
Ormoni sessuali e sviluppo embrionale
Ormoni sessuali e cambiamenti puberali
Gli ormoni prodotti dall’epifisi e dal timo
•
•
•
•
•
•
dell’adrenalina su diverse cellule bersaglio
Descrivere le azioni delle tre classi di
ormoni steroidei prodotti dalla corticale
surrenale
Elencare gli ormoni prodotti dalle gonadi
maschili e femminili
Distinguere i caratteri sessuali primari da
quelli secondari, associandoli agli ormoni
che li determinano
Spiegare come gli androgeni inducono il
differenziamento embrionale in senso
maschile
Mettere in relazione l’azione degli ormoni
ipofisari con lo sviluppo in età puberale
Descrivere gli effetti della melatonina
nella regolazione dei ritmi biologici
Elencare gli ormoni prodotti dal timo e
loro funzioni
La riproduzione e lo sviluppo
COMPETENZE
• Comprendere le differenze e la complementarietà degli apparati riproduttori maschile e femminile che permettono la
formazione e l’incontro dei gameti per consentire la nascita di un nuovo individuo
• Acquisire la consapevolezza che il processo di fecondazione innesca nella donna una complessa serie di eventi che
portano allo sviluppo di un organismo completo e autonomo
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
e le funzioni
degli apparati
riproduttori
maschile
e femminile
•
•
•
•
Le caratteristiche della riproduzione umana
L’anatomia
dell’apparato
riproduttore
maschile
L’anatomia
dell’apparato
riproduttore
femminile
•
•
•
La gametogenesi
produce gameti
aploidi
•
•
La spermatogenesi
L’oogenesi
•
•
•
•
Come funzionano
l’apparato
riproduttore
maschile
e femminile?
•
•
•
•
•
•
Il controllo ormonale dell’attività sessuale
Il controllo ormonale nel maschio
Il ciclo ovarico e il ciclo uterino
Il controllo ormonale del ciclo femminile
L’età fertile femminile
Gli aspetti fisiologici dell’accoppiamento
•
•
•
Descrivere le tre caratteristiche della
riproduzione umana
Descrivere gli organi dell’apparato
riproduttore maschile e le ghiandole
annesse
Spiegare perché i testicoli si trovano in
una cavità esterna rispetto al corpo
Descrivere gli organi dell’apparato
riproduttore femminile
Descrivere le tappe che portano alla
formazione degli spermatozoi partendo
dagli spermatogoni
Spiegare la funzione dei tubuli seminiferi,
delle cellule di Sertoli e delle cellule
interstiziali
Descrivere le tappe che portano alla
formazione delle cellule uovo partendo
dagli oogoni
Confrontare la spermatogenesi con
l’oogenesi evidenziando analogie e
differenze tra i due processi
Individuare gli ormoni ipofisari e
ipotalamici che controllano la produzione
sia degli ormoni femminili sia di quelli
maschili
Descrivere gli effetti del testosterone a
partire dalla pubertà
Spiegare il significato del termine
•
La fecondazione
e lo sviluppo
embrionale
•
•
•
•
•
Fecondazione e sviluppo embrionale
Le fasi della fecondazione
La segmentazione e l’impianto
La gastrulazione
Il ruolo della placenta
•
•
•
•
•
•
•
L’embrione diventa
feto: l’organogenesi
e le ultime fasi
dello sviluppo
•
•
•
L’organogenesi
L’accrescimento del feto
Il parto
•
•
•
•
menopausa
Spiegare come variano le attività
fisiologiche durante le quattro fasi
dell’accoppiamento
Distinguere lo zigote dall’embrione e dal
feto
Spiegare la complessa sequenza di eventi
che porta alla fusione del nucleo maschile
con quello femminile e alla formazione
dello zigote
Descrivere le tappe della segmentazione
distinguendo la morula dalla blastocisti
Descrivere il processo di impianto
dell’embrione nell’utero
Spiegare il significato di gravidanza
ectopica
Descrivere la formazione dei foglietti
embrionali
e
delle
membrane
extraembrionali
Spiegare la struttura e la funzione della
placenta
Spiegare
le
tappe
principali
dell’organogenesi
Descrivere gli eventi legati al secondo e al
terzo trimestre di gravidanza
Elencare gli ormoni prodotti durante il
parto spiegandone le funzioni
Distinguere la fase di travaglio dalla fase
espulsiva
Il sistema nervoso
COMPETENZE
• Comprendere come il sistema nervoso controlla, modula e integra le funzioni del corpo umano in risposta alle
variazioni dell’ambiente interno ed esterno
• Saper riconoscere nell’encefalo e, in particolare, nella corteccia cerebrale una struttura sofisticata, sede delle
capacità mentali come la memoria e il ragionamento
• Comprendere che anche piccole alterazioni nel funzionamento dell’encefalo possono provocare notevoli anomalie
sia fisiche sia comportamentali
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
e la funzione
del sistema nervoso
•
•
•
•
•
•
Come opera il sistema nervoso
Il sistema nervoso degli animali vertebrati
Le unità funzionali del sistema nervoso
Le cellule gliali
Il controllo a feed-back della secrezione
ormonale
•
•
•
•
•
I neuroni generano
e conducono segnali
elettrici
•
•
•
Il potenziale di membrana dei neuroni
Il potenziale di riposo
Il potenziale d’azione
•
•
Elencare le tre fasi secondo cui opera il
sistema nervoso
Distinguere le funzioni del sistema
nervoso centrale da quelle del sistema
nervoso periferico nei vertebrati
Descrivere il neurone evidenziando le
funzioni delle diverse parti
Definire le sinapsi
Distinguere i neuroni sensoriali dai
neuroni efferenti e dagli interneuroni
Spiegare le funzioni delle cellule gliali e
della guaina mielinica
Spiegare da che cosa dipende l’eccitabilità
dei neuroni
Spiegare come viene mantenuto il
•
•
•
La propagazione del potenziale d’azione
I fattori che condizionano la velocità della
propagazione dell’impulso nervoso
Intensità dei potenziali d’azio-ne
•
•
•
•
•
Le sinapsi
trasmettono
lo stimolo nervoso
da una cellula
all’altra
•
•
•
•
•
La giunzione neuromuscolare
La trasmissione sinaptica
Le sinapsi tra neuroni
I neurotrasmettitori
Le sinapsi elettriche
•
Il sistema nervoso
centrale
•
Lo sviluppo del sistema nervoso centrale nei
vertebrati
L’organizzazione funzionale del sistema
nervoso centrale
Il telencefalo
Il diencefalo
Il tronco encefalico
Il cervelletto
Le meningi e il liquido cerebrospinale
•
•
•
•
•
•
•
Spiegare come funziona una sinapsi
chimica utilizzando come esempio la
giunzione neuromuscolare
• Distinguere una sinapsi eccitatoria da una
inibitoria
• Spiegare come il neurone postsinaptico
integra le informazioni
• Elencare i principali neurotrasmettitori
distinguendoli in classi
• Spiegare come funziona una sinapsi
elettrica
•
•
•
•
•
•
•
Il midollo spinale
e i nervi
trasmettono
informazioni
•
•
•
Le divisioni
•
I nervi spinali
I riflessi spinali
I nervi cranici
•
•
•
•
Il sistema nervoso autonomo
potenziale di riposo evidenziando il ruolo
delle proteine di membrana
Descrivere come vengono regolati i canali
ionici
Analizzare gli eventi che susseguendosi
rapidamente determinano il potenziale
d’azione
Spiegare come si propaga l’impulso
nervoso distinguendo tra propagazione
continua e saltatoria
Evidenziare l’importanza della guaina
mielinica e del diametro degli assoni per
determinare la velocità di propagazione
dell’impulso nervoso
Spiegare perché i potenziali d’azione sono
sempre
uguali
indipendentemente
dall’intensità dello stimolo che li ha
prodotti
•
Descrivere lo sviluppo del sistema nervoso
dei vertebrati evidenziando le tre vescicole
da cui deriva l’encefalo
Distinguere l’encefalo dal midollo spinale
e la sostanza grigia dalla sostanza bianca
Spiegare l’organizzazione del telencefalo
descrivendo la struttura dei due emisferi e
della corteccia cerebrale
Individuare i nuclei di sostanza grigia
presenti all’interno di ogni emisfero
collegandoli alle rispettive funzioni
Distinguere nel diencefalo il talamo,
l’ipotalamo e l’epifisi collegandoli alle
rispettive funzioni
Indicare le tre regioni del tronco encefalico
spiegandone le funzioni
Spiegare come è organizzato il cervelletto
e quali funzioni svolge
Identificare nelle meningi e nel liquido
cerebrospinale i sistemi di protezione del
sistema nervoso centrale
Descrivere la funzione dei nervi spinali
Definire i nervi misti distinguendo la
componente afferente da quella efferente
Spiegare come funziona il riflesso spinale
Descrivere i nervi cranici e le rispettive
funzioni
Mettere in relazione il sistema nervoso
del sistema nervoso
periferico
•
•
La divisione ortosimpatica
La divisione parasimpatica
•
•
La consapevolezza e il
controllo
del comportamento
derivano
dall’attività
del telencefalo
•
•
•
•
•
L’organizzazione della corteccia cerebrale
Il lobo temporale
Il lobo frontale
Il lobo parietale
Il lobo occipitale
•
•
•
•
•
Le reti
di neuroni
elaborano
informazioni
•
•
Apprendimento e memoria
Le capacità linguistiche
•
•
•
autonomo con il sistema nervoso centrale
Distinguere il sistema autonomo in
ortosimpatico, parasimpatico ed enterico
Spiegare le differenze anatomiche e
funzionali tra sistema ortosimpatico e
parasimpatico
Descrivere la struttura della corteccia
cerebrale, specificando i lobi determinati dai
solchi
Distinguere la corteccia motoria e sensoriale
da quella associativa
Identificare nel lobo temporale la capacità
di udire e di riconoscere i volti
Mettere in relazione la corteccia motoria
primaria e la corteccia somatoestesica
primaria con le diverse aree da esse
controllate
Identificare nel lobo occipitale la capacità di
ricevere ed elaborare gli stimoli visivi
Distinguere
l’apprendimento
dalla
memoria
Definire la lateralizzazione
Mettere in relazione la capacità linguistica
con le aree di Broca e di Wernicke
Gli organi di senso e il movimento
COMPETENZE
•
Comprendere che le informazioni che giungono agli organi effettori dal sistema nervoso sono il risultato
dell’elaborazione dei segnali captati dall’ambiente esterno e interno dai recettori sensoriali
NUCLEI
FONDANTI
CONOSCENZE
COMPETENZE
L’organizzazione
e le funzioni
del sistema
sensoriale
•
•
•
•
Cellule e organi sensoriali
La qualità della sensazione
L’adattamento sensoriale
•
•
•
Come fanno
i sistemi sensoriali
a percepire
gli stimoli chimici
e meccanici?
•
•
•
L’olfatto
Il gusto
I meccanocettori
•
•
•
•
L’orecchio
•
Le tre parti che formano l’orecchio
•
Elencare I diversi tipi di recettori
sensoriali distinguendoli dagli organi di
senso
Spiegare le proprietà delle cellule
sensoriali evidenziando la capacità di
trasformare lo stimolo percepito in
potenziale d’azione
Collegare l’intensità di una sensazione con
la frequenza dei potenziali d’azione
generati
Spiegare il fenomeno dell’adattamento
sensoriale
Spiegare da che cosa dipende il senso
dell’odorato e in che modo possiamo
percepire odori diversi
Spiegare da che cosa dipende il senso del
gusto e in che modo possiamo percepire
sapori diversi
Descrivere i cinque principali tipi di
meccanocettori
Spiegare
le
funzioni
dei
fusi
neuromuscolari e degli organi di Golgi
Descrivere l’orecchio esterno, l’orecchio
è l’organo dell’udito
e dell’equilibrio
•
•
Il sistema acustico
L’organo dell’equilibrio
•
•
L’occhio è l’organo
della vista
•
•
•
•
Le tre parti che formano l’occhio
La retina
I pigmenti fotosensibili
Le cavità dell’occhio
•
•
•
•
•
•
Gli organi effettori:
il muscolo
scheletrico
e il muscolo liscio
•
•
•
•
•
Le caratteristiche dei muscoli scheletrici
Le miofibrille
La contrazione muscolare
L’attivazione della contrazione muscolare
Le caratteristiche dei muscoli lisci
•
•
•
•
•
Lo scheletro
fornisce sostegno
per i muscoli
•
•
L’endoscheletro umano
Le articolazioni
•
•
•
•
medio e l’orecchio interno
Individuare la componente acustica
dell’orecchio e spiegarne le funzioni
Spiegare come funziona l’apparato
vestibolare
distinguendo
l’equilibrio
statico dall’equilibrio dinamico
Descrivere la struttura dell’occhio
specificando la funzione di ogni sua parte
Individuare nella retina la struttura che
riceve ed elabora le informazioni visive
Distinguere i coni dai bastoncelli
Definire la fovea
Spiegare il ruolo delle opsine
Descrivere la funzione di umor acqueo e
umor vitreo
Individuare le caratteristiche comuni a tutti
i muscoli scheletrici specificando le
peculiarità delle cellule muscolari
Identificare
nel
sarcomero
l’unità
funzionale del muscolo scheletrico
specificandone la struttura
Spiegare il meccanismo molecolare della
contrazione specificando la funzione di
ATP e ioni calcio
Spiegare
come
la
giunzione
neuromuscolare attiva la contrazione
Descrivere
la
muscolatura
liscia
sottolineando le differenze con la
muscolatura
Descrivere
l’organizzazione
dello
scheletro umano distinguendo tra scheletro
assile e appendicolare
Distinguere l’osso compatto dall’osso
spugnoso
Descrivere le diverse parti delle
articolazioni distinguendo i tendini dai
legamenti e i muscoli flessori da quelli
estensori
Elencare i vari tipi di articolazioni presenti
nello scheletro umano
SCIENZE DELLA TERRA- CLASSI QUINTE LICEO SCIENTIFICO
Le competenze, richiamate mediante i numeri all’interno del piano di lavoro, sono le seguenti:
1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi
2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni
3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà
4. Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica
5. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le modificazioni ambientali di
origine antropica e comprenderne le ricadute future
6. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale
7. Comunicare nella propria lingua e nelle lingue straniere, utilizzando un lessico specifico
UNITÀ
OBIETTIVI
conoscenze
L’ambiente
– Le caratteristiche delle stelle e la
abilità
– Stabilire la luminosità relativa di due stelle
competenze
1, 3, 5, 7
celeste
loro luminosità
– I raggruppamenti di stelle: le
galassie
– La posizione delle stelle
– L’origine dell’Universo
– Com’è fatto il Sistema solare
– Com’è fatto il Sole
– Le leggi di Keplero
– La legge della gravitazione
universale
– Le caratteristiche dei pianeti del
Sistema solare
conoscendo la loro magnitudine apparente
– Individuare la Stella polare nel cielo notturno
– Calcolare il valore della forza di attrazione
gravitazionale tra due corpi
– Ricondurre le caratteristiche dei pianeti alla
tipologia cui appartengono
La Terra e la
Luna
– La forma e le dimensioni della
Terra
– Le coordinate geografiche
– Il moto di rotazione della Terra
attorno al proprio asse
– Il moto di rivoluzione della Terra
attorno al Sole
– Le stagioni
– I moti millenari della Terra
– Le caratteristiche della Luna
– I moti della Luna e le loro
conseguenze
– Individuare la posizione di un oggetto sulla
superficie terrestre attraverso le sue
coordinate geografiche
– Individuare le zone astronomiche su un
planisfero
L’orientamen – I punti cardinali
to e la misura – La misura delle coordinate
geografiche
del tempo
– La forma e la probabile origine del
campo magnetico terrestre
– Come si determina la durata del
giorno
– Come si determina la durata
dell’anno
– I sistemi di posizionamento
satellitari
I materiali
della Terra
solida
– Le caratteristiche e le proprietà dei
minerali
– I principali gruppi di minerali
– I tre gruppi principali di rocce
– Il ciclo litogenetico
– Formazione delle rocce magmatiche
– Formazione delle rocce
sedimentarie
– Formazione delle rocce
metamorfiche
– I metodi per stabilire l’età di una
roccia
– I principi della Stratigrafia
– Il significato del termine
radioattività riferito ad alcuni elementi
chimici
1, 3, 7
– Posizionare i punti cardinali sull’orizzonte
1, 3, 5, 7
– Orientarsi con le stelle
– Calcolare la longitudine di un punto della
superficie terrestre conoscendo l’ora locale e
quella del meridiano di riferimento
– Calcolare la latitudine di un punto della
superficie terrestre conoscendo l’altezza
della Stella polare o del Sole sull’orizzonte
– Orientarsi con la bussola
– Distinguere le rocce magmatiche, le
sedimentarie e le metamorfiche
– Distinguere una roccia magmatica intrusiva
da una effusiva
– Classificare una roccia sedimentaria clastica
in base alle dimensioni dei frammenti che la
costituiscono
– Risalire all’ambiente di sedimentazione di
una roccia sedimentaria clastica
– Stabilire se una roccia metamorfica è
scistosa o meno
– Stabilire l’età relativa di una roccia
sedimentaria che contiene un fossile guida
1, 3, 7
– Che cosa sono i vulcani
– Quali sono i prodotti dell’attività
vulcanica
– Che forme hanno i vulcani
– I diversi tipi di eruzioni vulcaniche
– I fenomeni legati all’attività
vulcanica
– La distribuzione dei vulcani sulla
superficie terrestre
– Distinguere un vulcano centrale da uno
lineare
– Riconoscere un vulcano a scudo, un
vulcano-strato, un cono di scorie
– Leggere la carta che riporta la distribuzione
dei vulcani attivi sulla superficie terrestre
I fenomeni
sismici
– Il meccanismo all’origine dei
terremoti
– I tipi di onde sismiche e il
sismografo
– Come vengono utilizzate le onde
sismiche nello studio dell’interno
della Terra
– La magnitudo
– La scala Richter
– L’intensità di un terremoto
– La scala MCS
– La distribuzione degli ipocentri dei
terremoti sulla Terra
– I possibili interventi di difesa dai
terremoti
– Determinare la posizione dell’epicentro di
1, 3, 6, 7
un terremoto dai sismogrammi di tre stazioni
sismiche
– Determinare la magnitudo di un sisma da un
sismogramma usando la scala Richter
– Interpretare la carta della distribuzione dei
terremoti
– Tenere i comportamenti adeguati in caso di
terremoto
La struttura
della Terra
– La struttura interna della Terra
– Il meccanismo di espansione dei
fondi oceanici
– Le placche litosferiche
– I tipi di margini tra placche
litosferiche e i movimenti delle
placche a essi associati
– Come si originano una catena
montuosa e un oceano
– Le modalità di propagazione del
calore all’interno della Terra
– Le probabili cause del movimento
delle placche
– Le forme più comuni della
deformazione delle rocce
– Calcolare la velocità di separazione di due
1, 3, 5, 7
continenti conoscendo l’età delle rocce del
fondo oceanico per le quali è nota la distanza
da una dorsale
– Collegare fenomeni sismici e vulcanici al
movimento delle placche
– Riconoscere sul campo diaclasi e faglie nelle
formazioni rocciose
– Distinguere faglie dirette e faglie inverse
– Riconoscere formazioni rocciose piegate
– Distinguere anticlinali e sinclinali
I fenomeni
vulcanici
1, 3, 7
PROGRAMMAZIONE SCIENZE
OBIETTIVI MINIMI
CLASSI PRIME
-Conoscere i contenuti.
-Comprendere il testo scientifico.
-Conoscere i termini tecnici trattati.
-Comprendere le tappe essenziali del metodo scientifico-sperimentale.
-Saper osservare ed analizzare i fenomeni naturali che riguardano il nostro Pianeta.
-Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni.
-Saper risolvere semplici esercizi, anche numerici, relativi agli argomenti trattati.
SCIENZE DELLA TERRA
CONTENUTI
OBIETTIVI MINIMI
Le distanze astronomiche
Saper valutare l'entità delle distanze
astronomiche facendo riferimento alle
opportune unità di misura: Unità
Astronomica e anno luce.
Stelle. Galassie. Pianeti
Acquisire conoscenze generali sulla struttura
dell’Universo. Conoscere la differenza tra
stelle e pianeti
Sistema solare. Il Sole
Saper descrivere la struttura del Sistema
Solare e del Sole. saper descrivere le
principali caratteristiche dei moti planetari e
le leggi che li governano.
Forma della Terra. Reticolato geografico.
Coordinate geografiche.
Saper descrivere la forma della Terra. Saper
disegnare il reticolato geografico, conoscere
il significato e l’uso di latitudine e
longitudine.
Moto di rotazione e rivoluzione terrestre
Saper illustrare le caratteristiche dei moti
terrestri.
Conoscere le prove e le conseguenze dei
moti terrestri
Saper descrivere le reciproche posizioni di
Terra e Sole nei giorni degli equinozi e dei
solstizi.
Riconoscere le cause della diversa durata del
dì e della notte durante l'anno e della
diversa insolazione della superficie terrestre.
Caratteristiche della Luna e suoi movimenti
Conoscere le caratteristiche morfologiche
superficiali della Luna .
Saper descrivere i moti della Luna e le fasi
lunari.
Idrosfera
Conoscere le differenze tra acque
continentali e marine. Conoscere le
caratteristiche e le cause del moto ondoso,
delle correnti e delle maree.
Comprendere le fasi principali del ciclo
dell’acqua.
CHIMICA
CONTENUTI
Il metodo scientifico-sperimentale
OBIETTIVI MINIMI
Conoscere le tappe del metodo scientificosperimentale.
Comprendere l’importanza
del metodo come strumento fondamentale
delle scienze.
Grandezze e misure. La materia e le sue
proprietà
Conoscere le grandezze che caratterizzano
la materia e saperne esprimere le misure
correttamente. Saper distinguere tyra
elementi, composti, miscugli.
Simboli degli elementi e formule dei
composti
Riconoscere i simboli degli elementi più
comuni e saper interpretare le formule dei
composti.
La tavola periodica degli elementi
Saper leggere la tavola periodica per una
prima classificazione degli elementi.
Le trasformazioni chimiche e fisiche
Saper distinguere tra fenomeni fisici e
chimici. Conoscere i cambiamenti di stato.
Saper indicare una reazione chimica con la
corretta equazione chimica.
Leggi ponderali e teoria atomica di Dalton
Conoscere gli enunciati ed i significati delle
leggi ponderali, saperle riconoscere ed
applicare in semplici esercizi
CLASSI SECONDE
-Conoscere i contenuti.
-Comprendere il testo scientifico.
-Conoscere i termini tecnici trattati.
-Comprendere le tappe essenziali del metodo scientifico sperimentale.
-Acquisire capacità di compiere semplici osservazioni con il microscopio ottico.
-Comprendere la basi cellulari della vita.
-Conoscere i meccanismi della riproduzione e dell’eredità dei caratteri.
BIOLOGIA
CONTENUTI
Caratteristiche dei viventi
Le interazioni tra i viventi
Evoluzione dei viventi
I tre Domini dei viventi
Le caratteristiche dei Procarioti
OBIETTIVI MINIMI
Conoscere le caratteristiche comuni ai
viventi
Individuare nella cellula l’unità
fondamentale dei viventi
Elencare i livelli di organizzazione dei viventi.
Individuare le relazioni fondamentali tra i
viventi in un ecosistema.
Comprendere come l’evoluzione avvenga
attraverso la selezione naturale.
Individuare nella evoluzione per selezione
naturale uno dei principi unificanti della
biologia
Raggruppare i Viventi in tre Domini.
Conoscere i criteri di diversificazione nei
Procarioti; individuare il ruolo biologico dei
Procarioti
Classificazione generale degli Eucarioti
Evoluzione della cell.eucariote
I Protisti unicell.
I Funghi
Elencare i criteri che permettono di
distinguere gli Eucarioti in 4 Regni
Differenziare gli Eucarioti unicellulari in base
alle modalità di nutrimento e movimento
Descrivere la struttura base dei funghi ed
indicare la loro valenza ecologica
Le alghe
Le piante non vascolari e vascolari
Descrivere la struttura delle alghe e il loro
ruolo biologico
Distinguere tra briofite e tracheofite
Descrivere le parti fondamentali di una
tracheofita
Distinguere tra gimnosperme ed
angioseprme
Caratteri generali degli animali
Evidenziare gli aspetti fondamentali degli
animali
Distinguere tra Invertebrati e Vertebrati.
Elencare i principali phyla di Invertebrati.
Evidenziare glie aspetti evolutivi nei phyla
più significativi.
Evidenziare gli aspetti fondamentali delle
classi dei Vertebrati.
Forma e dimensioni delle cellule
Microscopio ottico.
Caratteristiche generali delle cellule
procariote
Conoscere il microscopio ottico
Descrivere la struttura delle cellule
procariote.
Caratteristiche delle cellule eucariote
Descrivere la struttura generale di una
cellula eucariota
Elencare gli organuli e le rispettive funzioni
Distinguere la cellula animale da quella
vegetale
Il nucleo e il ciclo cellulare
Descrivere la struttura del nucleo e dei
cromosomi
Distinguere tra riproduzione sessuata e
asessuata
Evidenziare il ruolo della mitosi nella crescita
degli organismi
Distinguere tra mitosi e scissione binaria
Elencare le fasi del ciclo cellulare e della
mitosi
La riproduzione sessuata e la produzione dei
gameti
Distinguere tra cellule somatiche e
riproduttive
Spiegare le tappe della mitosi
Individuare le differenze tra mitosi e meiosi
Comprendere il ruolo della meiosi.
Conoscere le principali patologie legata ad
anomalie nella meiosi
CHIMICA
CONTENUTI
I legami chimici
OBIETTIVI MINIMI
Comprendere la natura delle forze che
determinano le interazioni tra atomi e
molecole, sapendo distinguere tra legame
covalente, ionico, dipolare.
CLASSI TERZE
-Conoscere i contenuti relativi agli argomenti affrontati.
-Conoscere ed usare correttamente la terminologia scientifica.
-Acquisire capacità di operare collegamenti all’interno della disciplina.
-Conoscere i meccanismi e le basi molecolari dell’eredità.
-Acquisire conoscenze sulla forma e le funzioni degli organismi viventi
-Conoscere l’organizzazione del corpo umano e l’anatomia e la fisiologia dei principali apparati
BIOLOGIA
CONTENUTI
OBIETTIVI MINIMI
Mendel e i modelli di eredità
Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di
Mendel
Distinguere tra carattere dominante e
recessivo, tra gene e allele e tra genotipo e
fenotipo.
Enunciare le leggi di Mendel e i principali
casi di malattie causate da geni con eredità
mendeliana
GENETICA MOLECOLARE
Struttura e funzioni degli acidi nucleici
Codice genetico
Duplicazione del DNA, sintesi proteica
Conoscere la struttura degli acidi nucleici
Comprendere il ruolo degli acidi nucleici nell’eredità
dei caratteri e nella sintesi delle proteine.
Conoscere il meccanismo della duplicazione del
DNA.
Conoscere il codice genetico.
Conoscere gli aspetti fondamentali della sintesi
proteica
ANATOMIA E FISIOLOGIA
Forme e funzioni degli organismi viventi.
Anatomia e fisiologia di apparati del corpo umano:
riproduttore, digerente, circolatorio, immunitario
(endocrino, respiratorio, escretore, nervoso)
Sapere elencare e descrivere le principali strutture
anatomiche di apparati del corpo umano e degli
altri viventi.
Conoscerne i principali meccanismi di
funzionamento degli apparati del corpo umano.
CLASSI QUARTE
-Conoscere i contenuti.
-Acquisire sicurezza nell’uso del linguaggio tecnico-scientifico.
-Possedere abilità nel collegare ed analizzare i fenomeni chimico-fisici e biologici.
-Acquisire capacità di risolvere quesiti numerici relativi al programma di chimica.
-Conoscere le trasformazioni della materia e le leggi fondamentali che le governano.
CHIMICA
CONTENUTI
OBIETTIVI MINIMI
La materia e le sue proprietà
Conoscere le grandezze che caratterizzano
la materia. Saper distinguere tra elementi,
composti, miscugli
Teoria atomica di Dalton, leggi ponderali e
dei volumi
Conoscere gli enunciati ed i significati delle
leggi ponderali, saperle applicare in semplici
esercizi
Saper ricavare le formule dalle composizioni
percentuali e viceversa
La mole
Comprensione e uso della mole. Saper
eseguire le conversioni massa-mole-volume
(per i gas in condizioni STP)
Struttura atomica ed evoluzione dei modelli
atomici
Conoscere la struttura atomica: il numero
atomico, il numero di massa. Saper
determinare e scrivere la configurazione
elettronica di un elemento
La tavola periodica
Saper utilizzare la tavola periodica.
Soluzioni e loro concentrazione
Conoscere le soluzioni. Saper calcolare la
molarità di una soluzione
I legami chimici
Saper distinguere tra legame ionico,
covalente, metallico. Saper trovare e
scrivere le formule di struttura e molecolari
dei composti.
Legami intermolecolari
Comprendere la relazione tra interazioni
intermolecolari, stato della materia e
proprietà macroscopiche
Nomenclatura e formule dei principali
composti inorganici
Conoscere la nomenclatura dei principali
composti inorganici
Reazioni chimiche di sintesi e bilanciamento
delle equazioni chimiche. Applicazioni
stechiometriche
Saper scrivere e bilanciare le reazioni
chimiche e saper eseguire semplici calcoli
stechiometrici.
Soluzioni
Conoscere le caratteristiche e le proprietà
delle soluzioni. Comprendere il meccanismo
della solvatazione, della dissociazione ionica
e della ionizzazione. Saper calcolare la
molarità di una soluzione.
Cinetica chimica ed equilibrio chimico
Il principio di Le Chatelier
Conoscere i fattori che influenzano la
velocità di reazione.
Capire il ruolo dei catalizzatori e degli enzimi
nei sistemi biologici
Comprendere il significato di equilibrio
chimico. Saper scrivere l’espressione della
Keq e saperne utilizzare il valore numerico
per fare deduzioni sulla posizione
dell’equilibrio.
Conoscere il principio di Le Chatelier
Acidi e basi
Sapere cosa sono gli acidi e le basi.
Comprendere la differenza tra acidi/basi
forti e deboli. Saper calcolare il pH di
soluzioni di acidi e basi forti.
Capire il fenomeno della neutralizzazione
Reazioni di ossidoriduzione
Comprendere le reazioni di ossidoriduzione,
sapendo distinguere tra specie che si
ossidano e specie che si riducono.
La pila Daniell
Conoscere il meccanismo di produzione di
energia dai processi ossidoriduttivi nella
pila.
Elettrolisi
Elettrolisi Capire i meccanismi dei processi
elettrochimici. Conoscere l’elettrolisi del
cloruro di sodio fuso
CLASSI QUINTE LICEO SCIENTIFICO
-Conoscere i contenuti.
-Saper usare il linguaggio proprio della disciplina.
-Acquisire capacità analitico-sintetiche e logiche relative alle diverse tematiche
-Conoscere le caratteristiche naturali chimiche e fisiche del nostro Pianeta, comprendendone gli equilibri e
le dinamiche che lo governano.
GEOGRAFIA GENERALE ED ASTRONOMIA
CONTENUTI
OBIETTIVI MINIMI
Le distanze astronomiche
Saper valutare l'entità delle distanze
astronomiche facendo riferimento alle
opportune unità di misura.
Il diagramma H-R
Saper descrivere le caratteristiche di una
stella e capire la sua posizione nel
diagramma H-R.
L’evoluzione stellare
Conoscere il processo di evoluzione stellare
e saper collegare gli oggetti celesti
particolari alle tappe di tale evoluzione.
Il Sole
Saper descrivere le caratteristiche fisiche, la
struttura e l'attività del Sole
Struttura dell’Universo
Saper descrivere la struttura dell’Universo
La teoria del big-bang
Saper esporre la teoria del big-bang e le
prove che la sostengono
La forma della Terra
Descrivere la forma del nostro pianeta e
conoscerne le dimensioni
Moto di rotazione, rivoluzione, precessione
luni-solare
Saper illustrare le caratteristiche dei moti
terrestri.
Conoscere le prove e le conseguenze dei
moti terrestri
Saper descrivere le reciproche posizioni di
Terra e Sole nei giorni degli equinozi e dei
solstizi.
Riconoscere le cause della diversa durata del
dì e della notte durante l'anno e della
diversa insolazione della superficie terrestre.
Caratteristiche della Luna e suoi movimenti
Conoscere le caratteristiche della Luna e dei
suoi moti.
Saper descrivere la successione delle fasi
lunari.
I minerali
Saper definire le specie mineralogiche più
comuni
Conoscere il criterio di classificazione dei
silicati ed i gruppi che ne derivano
Le rocce
Conoscere la classificazione delle rocce
Riconoscere le caratteristiche delle rocce più
comuni.
Conoscere il ciclo delle rocce.
I fenomeni vulcanici
Comprendere la relazione tra i tipi di
magma, gli stili eruttivi, gli edifici vulcanici, i
materiali eruttati
I fenomeni sismici
Conoscere le cause dei sismi. Saper
distinguere tra la scala MCS e la scala
Richter per la classificazione dei terremoti
L’interno della Terra
Il calore interno della Terra
Conoscere il modello a strati concentrici del
Pianeta e le caratteristiche chimiche e
fisiche degli strati.
Conoscere le modalità di trasferimento del
calore all'interno della Terra e comprendere
come queste influenzino la dinamica
litosferica
La teoria di Wegener e la teoria
Conoscere le principali teorie che hanno
dell’espansione dei fondali oceanici
portato alla teoria della tettonica delle
placche
Saper illustrare le ricerche geofisiche e
oceanografiche che hanno dato un
fondamentale impulso alle teorie mobiliste
La teoria della tettonica delle placche
Saper descrivere le placche e i margini di
esse in relazione ai movimenti reciproci
Saper collegare i movimenti delle placche ed
i relativi margini con le grandi strutture
morfologiche del Pianeta e l’attività sismica
e vulcanica.
L’orogenesi
Conoscere i meccanismi orogenetici
CLASSI QUINTE LICEO LINGUISTICO
-Acquisire conoscenze sulla forma e le funzioni degli organismi viventi
-Conoscere l’organizzazione del corpo umano e l’anatomia e la fisiologia dei principali apparati
ANATOMIA E FISIOLOGIA
Forme e funzioni degli organismi viventi.
Anatomia e fisiologia di apparati del corpo umano:
riproduttore, digerente, circolatorio, immunitario
(endocrino, respiratorio, escretore, nervoso)
Sapere elencare e descrivere le principali strutture
anatomiche di apparati del corpo umano e degli
altri viventi.
Conoscerne i principali meccanismi di
funzionamento degli apparati del corpo umano.