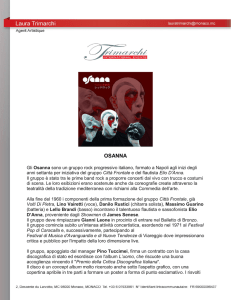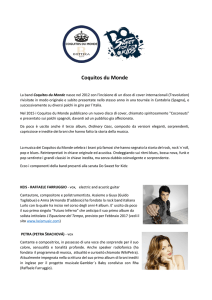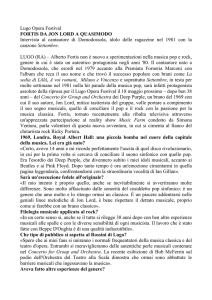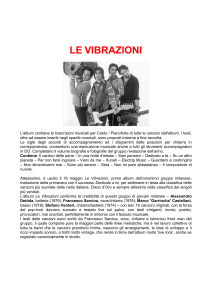digital magazine febbraio 2011
N.76
Royal Baths
Esben & The Witch
manzOni
Thus: Owls
Hanggai
Cristina Donà
Ad Bourke
James Blake
(Post-dubstep) Soul
Agoria
Primal Scream
Seefeel
Music for late night gardening
Turn On
p. 4
Royal Baths, Esben & The Witch, manzOni,
Thus: Owls, Hanggai, Cristina Donà, Ad Bourke
Tune IN
p. 16
Agoria
Drop Out
p. 20
James Blake, Seefeel
p. 38
Recensioni
p. 94
Rearview Mirror
Musica Improvvisa, Akron/Family, Animation, Anna Calvi, Aucan ....
Primal Scream
Rubriche
p. 86
p. 88
p. 90
p. 102
p. 103
Gimme some inches
Reboot
China Files
Campi Magnetici
Classic Album
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico
e
Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi,
Stefano Solventi, Teresa Greco,
Staff: Marco Boscolo, Edoardo Bridda, , Luca Barachetti, Marco Braggion, Gabriele Marino, Stefano Pifferi, Stefano
Solventi, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca Barachetti, Andrea Napoli, Diego Ballani, Mauro Crocenzi, Fabrizio
Zampighi, Giulia Cavaliere, Giancarlo Turra
Guida
spirituale:
Adriano Trauber (1966-2004)
—The season
of the witch—
—Oppio e litania—
I Crystal Stilts sono in vacanza?
Presto fatto, arrivano i Royal Baths,
garage nella miglior tradizione
psych oppiacea di Brian Jonestown e
naturalmente Spacemen 3.
N
elle schiere di oscure band lo-fi sixties-oriented
fuoriuscite da quel pozzo senza fondo che sono
gli States, si sono fatti strada loro: i Royal Baths, da San
Francisco. Un quartetto (Jigmae Baer e Jeremy Cox a
voce e chitarre, Eden Savage alle pelli e Nathan Grice
al basso) con all’attivo solo un 7” e un full-length targato Woodsist che ha attirato l’attenzione di molti in
virtù di un suono debitore dei Velvet più deviati, del
sixties-pop più oscuro e inacidito e di una trasversale passione per la psichedelia riverberata e oppiacea
come la potrebbero intendere Brian Jonestown Massacre o Spacemen 3.
Io e Jigmae, racconta Jeremy, abbiamo cominciato
a suonare insieme in una band chiamata Tea Ellers appena trasferiti a San Francisco; una volta sciolti abbiamo
continuato in due come Baths con roba più lenta, drammatica e liricamente più complessa. Abbiamo registrato
un 7” prima di diventare un quartetto, cambiare nome
(l’assonanza col losangelino progetto glitch-hypnapop Baths era troppo evidente) e pubblicare Litanies.
Un disco notevole, l’esordio. Di quelli capaci di mettere d’accordo l’arty-addicted di Williamsburg con gli
appassionati dello Smell, sfoggiando un suono accattivante e eterogeneo, ipnotico e suadente in cui esperienze e riferimenti vari si fondono in una proposta
4
Turn On
Esben
& The Witch
Turn On
Royal Baths
Paesaggi sinistri e suggestioni
ossianiche per un trio che da solo
potrebbe inaugurare il nuovo trend
del "nightmare pop"
personale. San Francisco è un posto pieno di gente intenta a cercare e condividere musica, perciò è facile avere
contatti con generi e musicisti vari. Ci piace molto il blues
del Delta, gente come Robert Johnson, Skip James, Blind
Willie Johnson.
Il cuore del disco, pur tra dissonanze garagey d’ordinanza e ambientazioni umbratili, non batte però
esclusivamente nei sixties, come sarebbe lecito aspettarsi: I 60s sono una influenza innegabile per il nostro
suono ma pur ascoltando molta musica di quella decade
non siamo intenzionalmente focalizzati su quello quando componiamo: ricreare un suono già noto è qualcosa
che preferiamo evitare.
E infatti è la componente psichedelica e acida a
fare la differenza rispetto ad un suono ormai quasi paradigmatico. Prendete come esempio il circolare ragarock drogato e plumbeo di Pleasant Feeling o il piccolo
capolavoro Sitting In My Room (La canzone narra di una
notte di eccessi e scivola avanti e indietro tra sentimenti di malessere e paranoia e sicurezza e appagamento,
confida Jeremy) che proietta verso lontani paesaggi
esotici ed estatici. Il trono di Crystal Stilts et similia non
è mai stato così a rischio.
Stefano Pifferi
S
embra davvero che le streghe siano tornate in
questo primo scorcio di millennio. Dalle visioni orrorifiche della Witch House al liricismo gotico di
Zola Jesus e U.S. Girls, stiamo assistendo alla rinascita di un immaginario esoterico che è fin troppo facile
collegare alla sensazione immanente di crisi sociale e
spirituale.
A complicare il quadro arriva la più curiosa fra le
next big things che infestano le pagine delle riviste.
Apparsi praticamente dal nulla e con un nome mutuato da una fiaba danese, quello degli Esben & The
Witch è un sound apparentemente alieno alla realtà
che li circonda: “Non credo che la nostra musica sia indicativa della scena di Brighton. Naturalmente amiamo la
nostra città, la sua tranquillità, il mare e il fatto che pulluli di progetti creativi”. A parlare è Rachel Davies, erinni
dalla vocalità potente ed evocativa. Il suo salmodiare
solenne su paesaggi sonori costituiti da gelide lastre
electro e perforanti rumorismi, contribuisce in maniera determinante all’atmosfera da bosco infestato che
si respira nei brani della band.
Il 2010 è stato un anno prodigo di soddisfazioni
per i tre: hanno catalizzato l’attenzione aprendo, fra
gli altri, per XX, Fiery Furnaces e Deerhunter, ovvero
alcune delle compagini più interessanti (ed hyped) del
panorama indipendente: “Sono tutti gruppi che amia-
mo - precisa Rachel - ma da cui ci sentiamo profondamente differenti”.
Dovendo dare un nome alle loro influenze non
temono di citare i Godspeed You! Black Emperor,
ma anche HEALTH e Aphex Twin, a cui si devono le
estremità più sperimentali del loro sound. A colpire
però sono i testi d’ispirazione ossianica, che rifiutano
la pompa pre-raffaellita delle band del ghetto goth.
“Vogliamo solo creare musica interessante e le sonorità
più oscure risultano per noi le più intriganti.”
Ai richiami letterari si collega poi un uso spregiudicato della messa in scena che dal vivo si esprime in
una raffigurazione teatrale della loro musica (“Ci piace
creare suspense e oscurità - afferma Rachel - tentare di
separare gli spettatori dall’ambiente che li circonda”);
mentre su video da sfogo al lato più cinematico del
progetto, portandone a compimento l’estetica, come
testimonia il corto di Marching Song, scioccante cronaca della progressiva tumefazione dei volti dei tre.
“Nasce tutto da una mia idea. - conclude Rachel - Confronto, forza, resistenza: sono tutte emozioni che volevamo comunicare con efficacia e semplicità. Siamo felici di
esserci riusciti.”
Diego Ballani
5
Turn On
manzOni
— Dalla parte dei
deboli —
Da Piero Manzoni passando per
Pascoli per raggiungere, soprattutto,
gli affanni del grigio quotidiano.
Un'intervista a più voci per
raccontarvi la poetica manzOniana
“Io non so di Massimo Volume o de Le luci della centrale elettrica! So che piacciono, che tanti nelle loro liriche si riconoscono... non so se le nostre “parolesuoni” semplici siano altrettanto accattivanti quanto le loro.”
Che i ManzOni fossero una realtà rara e nuova in Italia, per una capacità che diremmo selvaggia e immediata
di unire alla prosa recitata un sound di natura varia e spesso imprevedibile, è stato subito chiaro a noi di SA. Abbiamo colto nella poetica del gruppo profonde attinenze autorali capaci di segnare la giusta e dovuta distanza
con progetti apparentemente analoghi, e ne abbiamo ammirato il souno stratificato, tanto preciso quanto feroce
e innovativo che non dimentica pagine intere di musica d’autore italiana. Accanto a una voce poetica alla Ciampi
o alla Pelosi (E scrivo) e a un riaffiorare vago di Fossati (Scappi), ricontestualizzati in terreni anche lontani dai tradizionalismi della nostra canzone, troviamo una vocalità cupa, di un buio rigido, muoversi su un tessuto sonoro
diviso tra noise e spazi tutti elettronici, rumorismi e campionamenti. La voglia di intraprendere, con una band a
così tante facce, un discorso che andasse a indagare in modo quanto più possibile approfondito sui retroscena è
stata quindi ineludibile.
“Sono tutti autori, quelli che citi, che noi ManzOni conosciamo e rispettiamo” sostiene Ummer Fregula, uno dei
chitarristi, “ma che non sono stati punti di partenza espliciti come invece possono essere stati gruppi di cui ci nutriamo
con maggior frequenza come Portishead, Mogwai, Arab Strap, Yo la tengo, Piano magic. Quanto al discorso di
6
certi riferimenti ci tengo a dire che la voce di Gigi, il suo
modo di intonarla, insomma il suo modo di esprimersi,
sono sempre stati uguali, ancora prima, quando militava in progetti musicali precedenti a questo (ad esempio
nei Maladives) che i Massimo Volume arrivassero a un
successo “di massa” e che esplodesse il fenomeno Le luci
della centrale elettrica, un modo di raccontare, il suo,
che non si è mai granché modificato e che è sempre stato
quello, scevro di riferimenti netti, che si può ascoltare sul
nostro disco.”
Gigi Tenca è colonna portante del gruppo, scrive
liriche spesso strazianti e molto intimiste che vanno
a unirsi a un gioco di suoni vario e stratificato, nato e
messo a punto dal lavoro dei quattro chitarristi che
lo affiancano nel progetto: il risultato è un suono che
viaggia come scheggia impazzita capace di attingere
allo stesso modo dal blues e dai Suicide e in grado di
non sacrificare le possibilità melodiche anche in una
struttura dei brani così lontana dalla canzone pop italiana tradizionale. “E’ un lavoro di sintesi e trasformazione di suoni prodotti da strumenti diversi: loro usano le
chitarre” dice Tenca, “io il mio corpo come cassa di risonanza, e la voce. Al contrario di quello che molti credono,
la musica viene per prima e poi si scrivono le parole. Un
chitarrista, uno dei quattro, porta un “giro” in sala prove
e su quello si accordano i pensieri liberi del giorno trascritti con una penna bic su un foglio bianco. Le parole
e i suoni si incontrano in diretta; a casa si aggiusta solamente e ci si occupa dei ritocchi. La magia però è tra le
quattro mura di uno stanzino perso in campagna, nella
nebbia o all’afa. Essendo il gruppo composto di quattro
chitarre, più molti loop (quasi sempre di chitarra), la varietà e la gamma dei suoni utilizzati o potenzialmente
utilizzabili, come potrai immaginare, è molto vasta. Va
detto che comporre un pezzo con tutta questa varietà
non è poi semplice come si possa immaginare”. “In merito alle modalità compositive” dice Fregula, “si parte
sempre da un giro di chitarra o da un loop che o Fiorenzo
o Carlo o Emilio (gli altri tre chitarristi) propongono, per
poi lavorare sulla struttura del pezzo scarnificando, togliendo, rendendolo quasi vuoto, riuscendo al contempo
a coprire una vasta gamma di frequenze. Poi, se il pezzo
lo richiede, Carlo o Fiorenzo, di solito, si siedono dietro ai
tamburi”.
Discorso a sé va poi fatto in merito al raro valore
dei testi di Gigi Tenca che paiono essere piccole liriche
che hanno scelto autonomamente la propria forma, la
prosa, senza rinunciare a un innato status poetico che
fa pensare dunque, di trovarsi davanti a un attento lettore di poesia: “La cultura costituisce parte dello sfondo,
ma a noi interessa la “vita”. Sì, si sono lette, tra gli altri, le
poesie di Pascoli e di Sanguineti, che consideriamo maestri, i giganti sulle spalle dei quali si deve salire se si vuol
riuscire a vedere qualcosa. Noi vogliamo parlare della
vita a nostro modo, come la sentiamo. La poesia ha le
sue regole, che non sono le nostre: le nostre canzoni sono
composte da parole in musica e vogliono raccontare la
vita, soprattutto dalla parte dei deboli. Parole semplici,
che suonano insieme alle chitarre e che parlano dei deboli, del loro mondo, di noi... di chi è alla ricerca di una
vita migliore... dell’amore ...della compagnia di qualcuno
quando si vive in una periferia grigia. Ci sono, nelle nostre parole, le paure di tutti giorni: dei rospi, di essere pazzi, del buio, dell’ultimo giorno dell’anno che si prevede
si passerà da soli! Non c’è, insomma, niente di nascosto
o volutamente studiato in quei termini “immediati”, che
potrebbero essere quelli che ognuno di noi ha in mente, e
che ognuno di noi potrebbe scrivere. Non c’è un modello
e nessun rimando a significati altri, volutamente ermetici
o d’effetto”.
Certo è che, con un nome dai richiami intellettuali
così forti è difficile pensare a un distacco da certi legami con la cultura italiana, un nome importante che
rimanda a due snodi essenziali, ognuno nel proprio
campo d’azione, si parla naturalmente di Alessandro
Manzoni e di Piero Manzoni “La scelta del nome della
band” ci racconta un altro chitarrista del gruppo, Fiorenzo Fuolega, “è stata abbastanza travagliata. Gigi
ama molto l’arte contemporanea, e Piero Manzoni in
particolare, con la sua attitudine provocatoria. La sua
proposta di chiamarci manzOni (con quella “o” grande,
come a indicare stupore davanti a un palloncino contenente “Fiato d’artista”), accettata nel tempo dal gruppo
mediante una sorta di silenzio-assenso, ha via via abbandonato il suo riferimento iniziale. Ora “manzOni” è
un nome “aperto”, in cui ciascuno può vedere i riferimenti
che vuole: l’artista che ho appena citato, il celeberrimo
scrittore ottocentesco, l’omonimo vino, o, ironicamente,
qualcosa che ha a che fare con le stalle, i campi, la vita
agreste... Tutte queste interpretazioni possono essere in
qualche modo attinenti alla nostra musica. In definitiva:
il significato del nome“manzOni” lo stabilisce, di volta in
volta, chi ci ascolta”.
La curiosità che ci vorremmo togliere quanto prima
è dunque quella di ascoltarli live.
Giulia Cavaliere
7
Turn On
Thus: Owls
— Storie di seduzione
cardiaca—
Thus: Owls sono creatività sulla
corda tesa tra sentimento e ragione e
tra sogno e inquietudine. Ne abbiamo
discusso con la “dea ex machina”,
un’entusiasta e disponibile Erika
Alexadersson.
I
Thus:Owls ruotano attorno a una modesta e iperattiva ragazza svedese, una polistrumentista dall’ugola di miele e stalattiti dotata di apertura mentale e chiarezza d’intenti. Per questa avventura all’insegna di fascino e mistero, ha scelto di circondarsi di gente abile e soprattutto sulla medesima lunghezza d’onda, così che Cardiac Malformations può ammaliare l’ascoltatore lungo cinquanta abbondanti minuti di cantautorato femminile vibrante
e appassionato, obliquo e mai schiavo di stereotipi; un panorama nel quale risaltano il canto evocativo, la cura per
gli arrangiamenti, una scrittura complessa capace di farsi largo nella mente e nell’anima. Qualcosa di ben superiore alla somma delle parti che lo compongono e dei nomi che potrebbero venire in mente (P.J. Harvey, Kate Bush,
8
Mary Margareth O’Hara, Lounge Lizards...; la Nostra,
nondimeno, vanta tra i preferiti Robert Wyatt, Nina
Simone, Björk, Cat Power, Timber Timbre, Wildbirds
& Pecedrums, Joni Mitchell e Beth Gibbons).
Magia della quale si può subito ricercare una ragione nei collaboratori scelti da Erika, eterogeneo
quartetto composto da Cecilia Persson (parte di un
combo prog-jazz alla ECM), Martin Höper (in tour con
i Koop), Ola Hultgren (anche nei Loney, Dear) e infine, unico straniero, il canadese Simon Angell che
ha trascorsi nel songwriting d’oltreoceano: “Come per
molti altri gruppi, siamo in primo luogo amici che si sono
precedentemente incontrati in luoghi e tempi differenti.
Quando decisi di allestire Thus:Owls, avevo pronte un
paio di tracce e dall’idea di suono che avevo in mente e
desideravo gente adatta. Tutti abbiamo dei valori e retroterra affini quando si tratta di far musica, a dispetto
della provenienza”.
E ciò, ovviamente, anche a prescindere dalla forma
che assumono i suddetti valori e background, fino a
comporre un mosaico dove ognuno aggiunge delle
tessere e il disegno punta a fondere per evocare e non
si limita a giustapporre elementi: “Credo che sia davvero un bel modo di descriverci, grazie! Quando iniziamo a
lavorare su un brano ci sono un pensiero, un’atmosfera
e una storia; la canzone possiede un tono proprio, ma la
maniera in cui la presentiamo si compone di noi cinque,
delle nostre prospettive, aspirazioni e bisogni che partecipano a qualcosa di più profondo e ricco“.
Ricchezza che emerge dagli abiti scelti per le composizioni, sontuosi ma al tempo stesso austeri, così
che la formazione classica di Erika di cui parlano i comunicati stampa assume una diversa valenza: “Non
più di tanto classici, nel senso che sin da bambina ero in
un coro e da adolescente ho studiato canto classico. Per
la maggior parte del tempo, però, mi sono concentrata
sull’improvvisazione e su cose mie. Sono molto attiva,
tuttavia dal mio punto di vista è naturale: ciò che faccio
possiede sempre lo spazio e l’energia che mi servono.
Devo continuamente evolvere come persona e musicista,
altrimenti mi annoio, per cui è importante che i miei progetti siano diversi per mantenere la mente fresca, aperta
e pronta alle sfide“.
Sfida condotta a termine in modo brillante, nel
caso specifico: Thus:Owls riescono nell’intento di offrire uno stile “totale” come è oggi voga, benché scevro
da gratuite stranezze: “Beh, se in ciò che fai ci sono uno
scopo e un perché, verranno fuori. Dopo di che puoi solo
sperare di trovare altri che vogliano ascoltare quello che
volevi ascoltare tu. L’unica via sta nel rimanere fedeli a sé
e affinare l’abilità a tradurre le tue visioni, sogni e impul-
si. Parlando per me, so che tutto ciò che scrivo è connesso
alle mie esperienze nella vita, e non conosco altro sistema che mescolare tutto assieme“.
Per questo Cardiac Malformations necessita tempo per mostrarsi con pienezza, pensando alla quale
un po’ stupisce che sia stato messo su nastro in pochi giorni: “In realtà le canzoni registrate esistevano da
tempo, le conoscevamo molto bene. Prima di entrare in
studio, però, ho scritto parecchie cose che mi giravano
in testa e che non eravamo in grado di fare prima perché privi degli strumenti necessari. Li abbiamo trovati in
studio: sembrava di essere in un parco giochi, con tutti
quei balocchi da suonare brano per brano. Il suono di
Thus:Owls è stato grossomodo costruito durante quei
quattro giorni in studio. C’erano le mie parole su carta
come linea guida, ma a parte quelle abbiamo seguito
l’intuito e preso decisioni rapidamente circa le sonorità
e tutto il resto. Solo perché eravamo obbliganti a farlo,
avendo quattro giorni a disposizione“.
Tipico caso in cui la necessità diventa madre dell’invenzione, ma pure di un felice equilibrio tra ragione e
istinto che Erika conferma, ribaltando in un certo senso il clichè di “freddezza” solitamente associato al nord
dell’Europa: ”E’ esattamente così: spero che si senta nella
nostra musica. Io devo organizzare il mio mondo a partire dalle emozioni: non conosco altro modo“.
Nell’attesa di poter vedere Thus:Owls all’opera nel
nostro paese, veniamo a sapere che “Al momento siamo nel pieno della lavorazione del prossimo album. Sul
palco cerchiamo di mantenere il concetto di ‘viaggio’
tramite il suono. In alcuni luoghi resti più a lungo, alcuni
sono più intesi e altri ancora fragili. Penso che la nostra
energia venga fuori meglio nella dimensione ‘live’: amo
avere un disco da far mio e portarlo ovunque come una
cosa personale, ciò nonostante Thus:Owls è un’esperienza che dal vivo richiede tutto l’apporto dei pubblico“.
Ci resta un’ultima curiosità, ovvero l’origine della
ragione sociale (traducibile con Perciò:Gufi), così favolistica e pertanto adatta alla musica: “Vero. I gufi sono
al contempo saggi e misteriosi. Sembrano essere a conoscenza di cose che noi ignoriamo, dunque ‘perciò’ - li
abbiamo scelti.” Cerchio perfetto, non vi pare?
Giancarlo Turra
9
Turn On
Hanggai
—Deserti, cavalli e
chitarre—
Genesi, vicende e prospettive culturali
degli Hanggai, primi e fino ad oggi unici
rappresentanti del country mongolico.
Genesi, vicende e prospettive culturali
degli Hanggai, primi e fino ad oggi unici
rappresentanti del country mongolico.
L
a storia è più o meno sempre la stessa. Una cultura dominante, imposta in modi diversamente asfissianti a
seconda del luogo e del tempo, con tutti i tipici effetti collaterali di sradicamento e spersonalizzazione al
seguito. E qualcuno che, ostinatamente, torna alle radici, di solito compiendo un viaggio, o quantomeno un percorso di riappropriazione di qualcosa che è stato tolto ma la cui ombra permane; e che, inevitabilmente, diventa
una rivendicazione d'esistenza, dunque politica per una volta in senso buono e onesto.
E' successo in Irlanda, è successo da noi al Sud come al Nord ben oltre il folklorismo più ignorante. Sta succedendo in Cina, sterminato calderone di etnie e culture che il regime definisce stato multietnico unitario ma che in
realtà vorrebbe omologato ad un unico grande costume nazionale. Cinquantasei gruppi etnici riconosciuti sommati ad "clandestini", per lo più in migrazione dalle campagne povere alle città ricche: la maggioranza Han, poi
Zhuang, Manchu, Uiguri, Tibetani e Mongoli. La genesi degli Hanggai parte da lì, dalle pianure del Gobi cui torna
- nei primi anni zero - il leader del gruppo Yiliqi, mongolo d'origine nato in Cina e affascinato dal celebre throat
singing di quelle zone. E nell'andirivieni tra Pechino e Ulan Bator, l'ex leader del gruppo punk cinese T9 incontra
10
quelli che saranno gli altri tre membri mongolici del
gruppo, a cui si aggiungeranno altri due musicisti di
origine cinese.
E' così che gli Hanggai prendono la musica tradizionale mongola, il canto bitonale, il flauto tsuur, il morin
khuur (o violino testa di cavallo, per la similitudine del
suono con il nitrito equino), il tobshur (uno strumento
a due corde da pizzicare) unendoli a chitarre, basso,
batteria e banjo. Loro lo chiamano "China grass", forse
per evitare d'introdurre la parola Mongol in un'autodefinizione buona soprattutto per la stampa (e dunque per il regime). Ma ascoltatelo: è bluegrass del
Gobi, folk-punk desertico, country mongolico.
Il nome Hanggai suggerisce l'idealizzazione arcadica dei luoghi d'origine, fra praterie sconfinate, fiumi
limpidi e cieli blu cobalto. La musica è nondimeno una
mescola di tradizioni che s'innerivano una con l'altra,
crogiolo dove il folk-rock occidentale trova linfa nuova
nel sangue caldo di nuovi, giovani cavalieri e la tradizione mongolica allontana qualsiasi possibilità folkloristica tramite il legno scricchiolante delle chitarre e
del banjo. Le canzoni riprendono, nell'impianto melodico e nelle liriche, i canti tradizionali, ma gli Hanggai
dichiarano tra le influenze Pink Floyd, Radiohead,
Rage Against The Machine e Neil Diamond; le liriche
superano ben presto le tematiche pastorali e raccontano il disagio migratorio di uomini e donne abituati agli
spazi aperti delle terre native e invece oggi costretti in
megalopoli e fabbriche.
Il debutto discografico in questa parte di mondo
è ad opera della World Music Network, che nel 2008
dedica agli Hanggai il capitolo centoundici della collana Introducing. Le dieci tracce di Introducing Hanggai
(7.4) si aprono con la quantomai programmatica My
Banjo and I, country saltellante e percussivo su cui si
innesta l'inquieto morin khuur e il gutturale di Yiliqi,
mentre la successiva Yekul song è una nenia fra l'indolenzito e il battagliero che all'orecchio occidentale
diventa subito spleen gengiskhaniano. Discorso che
vale anche per il capolavoro dell'intera raccolta, una
Five Heroes aperta dal cinemascope di tsuur, morin
khuur e più voci gutturali cui fa seguito l'incedere western di una chitarra morriconiana, il cantato muscoloso, (quella che pare) addirittura un'e-bow a stagliarsi
sulla pianura e la chiusa in splendida, corale epicità.
Scordatevi la Mongolia misticheggiante di Ferretti e
compagni: gli Hanggai lavorano, lottano, e poi festeggiano con una Drinking Song alcolica che è occasione
di baldoria in esibizioni d'energia e precisione tecnica
inarrivabili. Il gruppo si fa conoscere in Europa, gira i
festival, arriva allo Womad e a Roskilde concedendosi
anche una comparsata al metallaro Wacken e lo scorso anno a Italia Wave. Il feedback di pubblico e critica è sostanzioso, base ideale perché qualcuno – anzi
Qualcuno – si accorga di loro.
He Who Travels Far (7.5) arriva quasi alla fine 2010
su World Connection/Earthbeat. E' la ferma rivendicazione di una cultura che sta scomparendo, a partire dalla lingua, con lo stesso Yiliqi a spiegare che lui
- d'origine mongola ma nato in Cina - ha dovuto imparare da zero il proprio idioma nativo, schiacciato dal cinese mandarino senza il quale sopravvivere a Pechino
e altrove è impossibile. La produzione è di quelle eccellenti, vedi alla voce Ken Stringfellow (R.E.M., Neil
Young), l'uomo giusto che corregge un primo disco
talvolta poco corposo e non sufficientemente rappresentativo della resa live. Ma è nei credits il Qualcuno di
cui sopra: laddove vi sono possibilità nuove per una sei
corde è difficile che manchi sua maestà Marc Ribot.
Il chitarrista di Newark mette mandolino e solo di
elettrica sulla sincope blues di Dorov Moraril, undicesima traccia di diciassette con l'ombra lunga di Tom
Waits a profilarsi. A pensarci bene, è una specie di
chiusura del cerchio: difficile che le due entità si possano incontrare da qualche parte là nel deserto, più
facile al tavolo di una bettola fra Pomona e Ulan Bator.
Tuttavia, non è da ascrivere al fin troppo frequentato
immaginario waitsiano l'orizzonte di un album che, a
seconda degli episodi, sposta maggiormente il baricentro o sull'alveo molgolico o su quello folk-rock, con
una vaga vicinanza ai Pogues e una generale capacità
nel restare sé stessi.
L'innesto del nuovo vocalist Yalalata permette una
maggiore variabilità nell'intreccio vocale sia per quanto riguarda il canto “normale” che quello di gola; da
parte sua Stringfellow impasta e sigilla una serie di
take registrate per lo più live in studio, distribuendo
omogeneità di spessore e vigore a strumenti mongolici e occidentali, che è appunto ciò che serviva. Le
canzoni poi fanno ovviamente il resto, e sono le migliori scritte fino ad oggi da questi araldi solitari del
country mongolico. Vigorose e scalpitanti come cavalli
selvaggi, distese e penetranti come vento sulla pianura. Soprattutto fiere, nel loro essere corda legata stretta ad una cultura da trattenere e non disperdere.
Luca Barachetti
11
Turn On
Cristina
Donà
—Evoluzione
(senza rivoluzione)—
La voglia di classicità e leggerezza
della cantautrice milanese, fra origini
rispolverate e amore per i dettagli del
quotidiano.
“P
op non è una parolaccia, anzi il pop è una cosa nobilissima”. Anche il pop italiano, la tradizione più o meno
cantautorale del nostro Paese, che pare essere l'ultimo approdo di Cristina Donà. Almeno dal precedente La quinta stagione, ma con dei chiari segni di germinazione anche nello splendido Dove sei tu, la cantautrice
milanese ha abbandonato le irrequietudini avant di Tregua e Nido, come confermava lei stessa al nostro Stefano
Solventi in un'intervista proprio ai tempi dell'uscita de La quinta stagione. Oggi, con il nuovo Torno a casa a piedi,
il percorso è lo stesso, semmai ancora più accentuato verso una classicità che cita i nomi buoni degli ultimi quarant'anni di songwriting nostrano:
“Avevo voglia di rispolverare le mie origini italiane per quanto riguarda la musica. In questo recupero c'è sicuramente un qualcosa di anagrafico, dato che è tipico di tutti gli artisti che facevano parte dell'underground come me
12
l'aver combattuto in gioventù le proprie origini, magari
per trovare una strada più internazionale e apparentemente meno provincialista. Negli ultimi anni invece ho
ascoltato tanta musica italiana, Battisti, Conte e Battiato soprattutto, e a questo punto volevo inserirli nella
mia musica”.
Una così forte influenza cantautorale non poteva
non modificare qualcosa anche nei testi, oggi narrativi
come non mai: “Mentre iniziavo a scrivere le canzoni per
questo nuovo lavoro sentivo la necessità di trovare un
linguaggio un po' diverso dal mio solito, un qualcosa che
fosse meno legato alle immagini e più al raccontare. Le
immagini sono veloci, istantanee e più facili da gestire,
mentre narrare una storia nei pochi minuti di una canzone è più difficile. Comunque ci ho provato”.
Ma Torno a casa a piedi non è solo un voltarsi indietro verso le proprie origini. E' anche una ricerca di
nuove gradazioni, magari con aiuti inattesi: “Ho cercato di dare alle canzoni dei colori nuovi, che non ci fossero
mai stati prima d'ora nelle cose che ho fatto. A tal proposito l'incontro con Saverio Lanza è stato fondamentale:
Saverio è un musicista con il quale fino a qualche anno
fa non avrei mai pensato di collaborare perché aveva
sempre lavorato con artisti non esattamente sulle stesse
onde del mio percorso musicale (Biagio Antonacci, Piero
Pelù, Vasco Rossi, ndr). In realtà non lo conoscevo bene.
Mi sono fidata e lui ha lavorato molto bene sia sulla stesura musicale dei brani insieme a me sia su alcuni arrangiamenti”.
Come quello di In un soffio, sorta di marcetta al
crocevia di influenze varie che vanno dallo ska, al folk
dell'Est Europa, a Celentano (“L'intuizione di arrangiarla
in levare è venuta a lui seguendo l'atmosfera di Azzurro,
che non è in levare ma ha lo stesso senso di leggerezza”) o
ancor di più quello del primo singolo Miracoli, per certi
versi sorprendente: “Miracoli è un singolo che vuole rappresentare le intenzioni del disco. A partire dalla ricerca
di nuovi colori musicali arrivando all'uso dei fiati, che è
ricorrente anche in altre tracce. Qualcuno ha parlato di
arrangiamento beatlesiano, in realtà io ci sento molto
le sigle televisive delle trasmissioni della mia infanzia, ci
sento Quando la banda passò (titolo originale La banda, ndr) e altre canzoni italiane che fanno parte del mio
dna e che tutt'oggi risultano composizioni validissime al
di là di una certa leggerezza da intrattenimento”.
Arrivare a parlare di Miracoli con Cristina è anche
l'occasione per chiederle conto di un certo ottimismo
– parola abusata e come vedremo fuori centro – che
aleggia in alcuni dei testi di Torno a casa a piedi: “E'
vero che questo brano come altri ha al suo interno una
certa positività, ma non credo che ottimismo sia la pa-
rola giusta per definirne lo stato d'animo. Io non sono
ottimista, però in questo disco ho cercato di guardare il
bicchiere mezzo pieno, ho proprio fatto lo sforzo di osservare le cose da un punto di vista diverso e di raccontare
quelle totalmente negative con una vena di maggior leggerezza, in modo che il messaggio possa arrivare meglio,
senza pesantezze. Mi piace scommettere su questa cosa,
anzi per tutta una serie di motivi legati a questo periodo
della mia vita ho proprio deciso di essere così”.
Una lievità che si accompagna ad una concentrazione sempre maggiore sulla quotidianità e sui dettagli, scelta che si rivela quasi “politica” in tempi di banalizzazioni di massa e di contrapposizioni pro/contro
su ogni argomento: “Non è un periodo questo, e mi riferisco alla quotidianità di tutti i giorni come alla nostra
situazione politica, dove si badi molto ai dettagli e alle
sfumature. E invece credo che si dovrebbe tornare a queste cose. A me è sempre piaciuto osservare le situazioni
attraverso i particolari, ad esempio attraverso l'accostamento di immagini che dessero l'idea di essere dei dettagli di una fotografia. In questo disco, avendo scelto di
narrare, la cosa emerge ancora di più e fa la differenza”.
Quella di Cristina è una contrapposizione netta,
che si trasforma poi in un invito ad occuparsi del microscopisco in ogni situazione: “Oggi nella comunicazione pare che il macroscopico abbia vinto, io preferisco
fare un passo indietro decidendo non di perdermi ma
di non perdermi alcuni dettagli, perché i dettagli sono
importanti. E poi credo che si debba sempre partire dal
piccolo e prendersi cura delle piccole cose. Sono iscritta
ad Amnesty International e ad Emergency ma non serve
a nulla farlo se poi in casa si risponde male a qualcuno o
non ci si prende cura dei propri famigliari”.
Insomma la Cristina Donà di Torno a casa a piedi
pare aver scelto, piuttosto che la rivoluzione, un'evoluzione consapevole, in linea con la maturità e con le ultime importanti esperienze vissute – dopo la morte del
padre che ha dato il là ad alcune canzoni de La quinta
stagione, qui è la nascita di un figlio che riecheggia
in un brano come Bimbo dal sonno leggero. Eppure c'è
chi la definisce un'artista nuova: “Si sta parlando di una
nuova Cristina Donà ma in realtà per me tutto questo fa
parte di un percorso continuativo, non è una rivoluzione.
Ci sono delle cose in questo disco che prima non ci sono
mai state, ma anche negli altri album c'era qualcosa di
nuovo rispetto a prima. La mia è un'evoluzione. Oggi
sono tornata ad una scrittura classica, narrativa, con
il prossimo disco magari riprenderò a scrivere canzoni
storte come ai tempi di Nido. Chissà, vedremo...”.
Luca Barachetti
13
—Boogiefunk
chiama Italia—
Il suo è uno dei nomi più caldi tra
gli addetti ai lavori, Mirage il suo
secondo lavoro importante, il primo
fisico. Lo abbiamo intervistato...
14
Turn On
Ad Bourke
P
arlando con vari produttori italiani a cavallo tra
hip hop ed elettronica, il suo è stato praticamente l'unico nome a saltare fuori sistematicamente alla
domanda "c'è qualcuno in particolare che ti piace"?
Adam Bourke, romano di padre inglese, trent'anni, dj,
polistrumentista, produttore legato al suono analogico e caldo delle tastiere vintage, è uno dei nomi che
contano dentro la scena (una raccolta di sue produzioni in mp3 per la Treble-O-Records nel 2008, i suoi
pezzi passati da Gilles Peterson, set in festival come
Dissonanze, un workshop alla Redbull Music Academy,
collaborazioni con nomi come i mitologici Jolly Music, opener per l'unica data italiana di Flying Lotus) e
adesso pubblica su Citinite quello che è praticamente
il suo "long EP" di debutto su supporto fisico.
Raccontaci chi è Ad Bourke come produttore.
Quando hai cominciato, cosa ascoltavi, quali sono
stati e quali sono i tuoi riferimenti.
Il mio backround culturale in termini musicali è
molto vario ma le maggiori influenze sono sicuramente afroamericane. Il soul (dagli anni Sessanta ai metà
anni Ottanta) ha esercitato una forte influenza sulla
mia musica. Come produttore ho iniziato nel Duemila, periodo in cui ho iniziato a frequentare lo studio di
Marco Passarani, Francisco e Raiders Of The Lost
ARP, anche loro una grande influenza.
Il paragone o comunque l'accostamento con
uno come Dam-Funk è quasi immediato ascoltando il suono e le strutture di Mirage (anche se personalmente ti sento più progressive di Dam). Che
mi dici?
Ho conociuto Damon a Roma quando ho suonato
prima di lui al Circolo degli Artisti, poi di nuovo ci siamo incontrati al M.I.T Auditorium. Damon è una persona umilissima con una cultura musicale impressionante, ha sempre creduto nella musica che faceva solo
perchè sentiva il bisogno di esprimersi in quel modo,
tutto indipendentemente dall'hype del momento. Il
paragone è inevitabile per il fatto che evidentemente abbiamo un simile background in termini di ascolti
musicali. Dal punto di vista della produzione alcuni
suoni sono assimilabili perché anche lui usa lo stesso
strumento. I suoni delle ritmiche e gli arrangiamenti
però sono molto differenti. Ti anticipo che la prossima
uscita su Citinite sarà proprio un suo EP firmato come
Mynk Richardz.
Come produci? Mirage, visto il feel molto suonato, è tutto costruito a partire da synth? O ti interessa anche un approcio da laptop artist?
Non mi interessa no... Preferisco accendere gli strumenti, iniziare a suonare all'infinito, selezionare quello
che ho suonato e poi registrarlo sul software. In fase
di produzione lavoro sui i singoli take anche se a volte
registro tutto insieme. Un approccio solo sul laptop lo
vedo molto distante dal mio...
Artisti che ascolti e ti piacciono a livello internazionale, tanto sul versante electronico (non so,
Cobblestone Jazz), quando hip hop & derivati (Lotus, Gonjasufi, Madlib)?
Al momento Opolopo, Amalia, Tiger&Woods, DamFunk, Computer Jay, Slugabed, Chesca, Yorke, B Bravo,
Krystal Klear, Space Dimension, Controller, Ulysses82,
00 Genesis e tanti altri, ma ora mi vengono in mente
questi. Sicuramente Madlib (Madvillainy è un capolavoro). Anche Lotus sì.
E in Italia... c'è tutta una piccola sparpagliata
scena di produttori dal retroterra hip hop ma dalle
produzioni strumentali e capaci di mischiare computer e macchine analogiche. Qui su Sentireascoltare i nomi che abbiamo fatto più spesso sono Marco Acquaviva/UXO e Digi G'Alessio. Li conosci? Chi
ti piace in generale?
Digi G'alessio, Morpheground, UXO, Herrera. C'è
una bella schiera di produttori che fanno un sacco di
cose interessanti. Error Broadcast è un'etichetta da tenere sempre sott'occhio. Tutte le uscite sono sempre
di altissima qualità.
Hai in programma un long playing?
Sì, ci sto lavorando.
Gabriele Marino
15
Tune-In
Rifiuta Parigi e i salotti fighetti. Pubblica sulla sua
etichetta un concept house-melodico ubercool. Da
Lione, la rinascita di Sébastien Devaud
Agoria
—Away from French Touch—
Testo: Marco Braggion
16
P
aris, aujourd’hui
La Francia house negli ultimi anni ha partorito
personaggi che hanno cambiato il modo di pensare la
musica da ballo. I Daft Punk, il loro manager della prima
ora Pedro Winter con la sua cricca Ed Banger, l’epopea
F Communications, Laurent Garnier, Ludovic Navarre
con la bomba tech-jazz St. Germain, gli organetti retrò
degli Air e per finire le bordate post-hip-hop di Missill.
Tutti questi grandi nomi variano la declinazione della
musica da ballo verso coordinate divergenti, come i ricordi anni ‘80, le sparate fidget, le basi truzze, gli stili da
strada e chi più ne ha più ne metta. La loro proposta è
sì variegata, ma un minimo comune denominatore ce
l’ha: tutti ruotano infatti attorno alla capitale Parigi.
Le periferie che bruciano con i conflitti etnici, la
poshyness del Rex (guardatevi la patinata del sito,
please) e degli altri club blasonati, le passeggiate cool
sugli Champs-Élysées che ricordano il Tour de France
dei medagliati Kraftwerk. E molto, molto altro. Parigi,
come qualsiasi capitale è un marchio di fiducia, un simbolo inta(o)ccabile. A queste persone fa comodo essere dentro agli arrondissement, stare nel ‘giro giusto’ per
sopravvivere. Più alto è il numero della zona abitativa
più costa il biglietto della serata. Paris, noblesse oblige.
Chi viene da fuori probabilmente ammira, come in
una vetrina di un bel centro commerciale nuovo fiammante, le loro proposte glitterate che si autoalimentano fra passaparola, poke su Facebook ed elitismi snob.
Catalizzare l’hype dal ‘di dentro’ parigino non sembra
poi così difficile. La Tour Eiffel traguarda il paesaggio
sonico come una grande mamma cybertronica che
perdona tutti i peccati e per questo salva dall’oblìo,
quasi un grande totem verso cui rivolgere le preghiere
del sabato sera, un rifugio su cui convogliare energie e
speranze, un nido che protegge e che culla, con la sua
eterna pulsazione insonne.
Per gli estranei, i cosiddetti provinciali, Parigi non è
mai un sogno, anzi. In alcuni casi potrebbe essere un
vanto non appartenere a quella schiatta, quella stirpe
che fa notizia con un flyer, con un casco d’oro o d’argento. Dall’underground le spinte al riconoscimento tralasciano la moda, il bullismo fashion e si rinvigoriscono
con un’artigianalità che non guarda egoisticamente
solo al suo interno, ma che osa esibire un passaporto
apolide, ricco di spunti altri. Away, appunto.
First Agoria, Finally InFinè
Sébastien Devaud è uno di questi personaggi che
rischiano, promuovendo la diversità di suono dal canone french. Originario di Lione, il ragazzo fa da subito suo il moniker di Agoria (una vaga assonanza con
l’apertura dell’agorà greca) e già da giovanissimo in
consolle mette su dei pezzi che sono America. I nomi
che ama spinnare sono Jeff Mills, Kevin Saunderson,
Joey Beltram, Richie Hawtin e Carl Craig. Dopo un po’
di prove standard sull’asse oltreoceanico, Seb si mette
a ripensare alla sua figura di DJ e inizia a organizzare
uno dei festival più importanti del Sud della Francia.
Nuits Sonores porta il suo marchio di fiducia e sbanca
tra gli appassionati.
Ancora qualche singolo, qualche comparsata per
mixare le migliori compilation del decennio (vedi il
suo splendido At The Controls del 2007, osannato da
tutti i più grandi nomi del settore, compreso Resident
Advisor), qualche album che non sconvolge ma che gli
consente di farsi le ossa dal punto di vista compositivo. Nel 2006 si imbarca con Alexandre Cazac e Yannick
Matray nel progetto InFiné: un’etichetta che serve a
promuovere lavori di personaggi nuovi, gente come
Apparat, Clara Moto e Francesco Tristano, che sanno
il fatto loro e non si riconoscono nel suono del cosiddetto French Touch.
Abbiamo sentito Seb in occasione dell’uscita del suo
nuovo album Impermanence in uscita a febbraio 2011,
un disco che è “venuto fuori facilmente, quasi di getto”.
Se gli chiediamo come valuta il suo essere fuori dai giri
parigini ci dice che “ci sono dei posti che influenzano il
17
suono, come Parigi, Detroit, Berlino. Per quanto riguarda
la città dove vivo, Lione, mi sento di paragonarla a Torino.
Durante gli anni Novanta non abbiamo avuto molte possibilità di organizzare parties, così l’unico modo di esprimersi era di produrre musica e quindi da qui sono usciti
personaggi come Miss Kittin & The Hacker, Kiko e molti
altri”. Un paragone naturale viene da farlo anche con
Detroit: un posto che ha un background industriale solido, ma in cui è difficile fare parties: “è per questo che la
mia musica è diversa dal french touch, la musica dei ricchi
di Parigi. Un’altra ragione è una questione di connessioni
e amicizie. Vedi il caso di Pedro Winter: è lui che organizza
gli artisti e rende possibile questo tipo di musica. Loro lo
seguono, non seguono la sua musica, ma il suo potere di
emancipare la gente verso un suono unico. Non è la mia
musica. E non la voglio difendere. Ma ho rispetto per quello che hanno costruito”.
Instabilità permanente
Dopo aver detto chiaramente come la pensa sulla
musica house francese, passiamo ad analizzare il disco,
che ha in Carl Craig una collaborazione fondamentale
(nella traccia Speechless). Craig è uno degli idoli di Seb,
e guardacaso compare anche come una colonna portante nel disco di Francesco Tristano di qualche mese
fa: “Non abbiamo pianificato nulla con Carl, non c’è stato
un piano di marketing (ride, ndSA). È solo una questione
di gente che si piace rispettivamente. L’ho invitato per una
serata in un club a Lione e quando ho sentito la sua voce
ho detto: Wow! Quest’uomo ha qualcosa di carismatico,
così gli ho chiesto se gli potevo mandare un loop o l’inizio
di una traccia per parlarci o cantarci sopra e così è uscita
Speechless. Mi piace la sua musica e quello che rappresenta a Detroit. Quando ero al Movement (uno dei festival più importanti di musica elettronica di Detroit, ndSA)
mi ha presentato al sindaco della città; stava tentando di
sviluppare la cultura musicale elettronica. Questo modo
‘militante’ di Carl di fare cultura mi piace molto. Un po’ la
stessa cosa cerco di farla a Lione con i party che organizzo, come il Nuits Sonores”.
Gli altri protagonisti del disco sono Seth Troxler in
Souless Dreamer e Kid A in Kiss My Soul. Seth è uno dei
DJ più quotati al momento, e non sfigura nemmeno con
la sua voce. Americano, migrato a berlino e oggi London based, si insinua nel suono francese: “ha suonato a
Lione a Nuits Sonores, ha deciso di stare un giorno in più e
così siamo andati in studio e in un’ora abbiamo registrato
la canzone. Non è tanto una questione di influenza berlinese, quanto una questione di incontri e di networking di
amicizie. Mi ricordo per esempio che quando Seth è stato
a Lione gli ho regalato un paio di ciabatte! Lui è uno che
viene dalla scuola detroitiana, ma penso che il suono ere18
ditato da Seth sia un mix di influenze: un po’ di Berlino un
po’ di Detroit e un po’ di Londra”.
Kid A è una giovane di vent’anni che sembra con i
suoi toni lievi l’erede di Björk o Emiliana Torrini: “Ha
cantato una traccia (Too Hard to Breathe sul 12’’ Roller
Coaster del 2010, ndSA) con gli Spitzer su InFiné e appena
l’ho sentita la volevo conoscere. Ha una voce fantastica. e
anche se sembra svedese, viene da Washington ed è nera.
Assomiglia a Nina Simone, è molto carismatica e brava.
Abbiamo lavorato a distanza, ma poi quando è venuta
qui in Francia è stato facile finire tutto”.
Il disco in definitiva è un concept melodico sui suoni house: “oggi gli album non si ascoltano dall’inizio alla
fine. Invece io ho voluto fare una cosa organica, ascoltabile senza skipping o fastforward”. La non permanenza
dichiarata nel titolo è duplice “sia perché ogni traccia segue l’altra in modo naturale, sia perché non c’è niente di
fisso, tutto si può reinventare”. Ed è esattamente come è
Agoria nei suoi rapporti con la label. Non pensa di aver
mai trovato qualcosa, quando registra i pezzi non si definisce. In più cerca di essere eclettico nello scouting di
nuovi talenti, come fa con le sue tracce, che spaziano
su nuances diverse ma in fondo coerenti.
Una delle sonorità di fondo è il suono classico del
pianoforte: “non suono il pianoforte, ma ho incontrato
Francesco Tristano tre anni fa: mi ha fatto considerare
di inserire nell’elettronica degli elementi acustici, infatti
ho usato anche strumenti ad arco che poi ho rielaborato elettronicamente”. Lo vedremo presto in Italia: il 25
Febbraio a Roma e il 26 a Milano. Intanto ascoltiamo di
nuovo il suo disco. E occhio. Ad aprile esce il suo disco
di mix per il Fabric. Agoria professa un modo amicale
di fare elettronica e house. Classe con l’anima e con il
cuore.
19
James Blake
—(Post-dubstep) Soul—
Drop Out
Il ventiduenne londinese
esordisce con una epifania soul
minimalista e intensa che prende
in carico la lezione sonora di
Burial e compagni. Uno degli
album del 2011. E non solo...
Testo: Gabriele Marino
20
B elieve
the hype
L’anno scorso, proprio di questi tempi, scommettevamo su un nome conosciuto giusto da una ristretta cerchia di appassionati. Un personaggio
interessante, dalla personalità forte, bizzarro il giusto, inizialmente anche
abbastanza misterioso. Ma soprattutto un disco che era un bellissimo
esordio, con tante frecce al proprio arco e particolarmente la possibilità
essere apprezzato da tanti ascoltatori diversi: chi veniva dall’hip hop e chi
dall’elettronica, chi ascoltava rock e specialmente psych rock Sessanta (e
chi cercava nuove forme di psichedelia lo-fi), chi cercava il soul e il blues,
chi orecchiava il reggae, chi era interessato agli esotismi e ai terzomondismi madlibiani e così via. Quel nome lo avevamo scoperto tra i solchi di Los
Angeles di Flying Lotus, a cantare sulla bellissima conclusiva Testament, e
per il suo falsetto impolverato lo avevamo scambiato addirittura per una
vocalist miagolosa, forse un po’ arrochita dal tempo o dalle sigarette. Stiamo parlando ovviamente di Sumach Valentine aka Gonjasufi. Avevamo
scommesso bene.
Mutatis mutandis, James Blake potrebbe essere il nostro Sufi per il
2011. I parallelismi ci sono tutti: debutto sulla lunga distanza, tanto hype,
tanta qualità, personaggio altrettanto - e anzi, anche più - all purposes, con
quel taglio di revisionismo futuristico della tradizione molto amato dai nuovi cataloghi Warp e Hyperdub, tanto che ce li immaginiamo perfettamente
uno Steve Beckett o uno Steve Goodman (Kode9) che si mangiano le mani.
21
James poi può contare su un appeal, tanto di immagine (giovanissimo, quasi efebico, biondo e occhi cerulei, ciuffo che forse ammicca all’emo) quanto di scrittura musicale (canzoni, belle e romantiche) e quindi su sponsor
non solo influenti (Pitchfork, per dire) ma anche massicciamente influenti
(la BBC tutta), che lo spelacchiato Sufi si sarebbe sognato. E come e più di
Sufi, James è al centro di una ragnatela di riferimenti, di pratiche, di mondi
musicali che sempre più dialogano tra loro, si scambiano elementi, si confondono, si sovrappongono. Doveroso approfondire e ragionarci sopra.
From
school to char ts
James è nato il 26 settembre 1988 a Enfield, il distretto più a nord di Londra,
da padre musicista (chitarrista con trascorsi, pare, anche al fianco di Leo
Sayer) e madre grafica pubblicitaria di un certo successo. Figlio unico. Spronato dal padre, James ci prova con la chitarra, ma non imbrocca, e a sei anni
comincia a pasticciare con il piano (e a cantare). A quindici avrà già completato tutti i gradi del cursus istituzionale, anche se non si considererà mai
un virtuoso. Cresce a pane e classica (Bach), jazz (Art Tatum, Erol Garner) e
funk-soul americano (Stevie Wonder, Sly & The Family Stone, ma anche
D’Angelo). Le superiori le fa alla Latymer, una grammar school molto selettiva e molto attenta agli studenti musicalmente dotati, dove James esplora
l’improvvisazione sullo strumento. E’ in questi anni che comincia a registrare musica nella propria cameretta, solo piano & voce. Il passaggio tra liceo
(si diploma nel 2007) e università è cruciale: scopre l’elettronica (“prima di
allora non la consideravo musica seria, sentivo dire dance e pensavo solo a
certa brutta trance”) e il dubstep in particolare. Durante una serata in un
club, il FWD>>, James ascolta Haunted, un pezzo di Coki (metà Digital My-
stikz): è una folgorazione, il punto di non ritorno. James parla dell’episodio
con gli stessi toni epifanici con cui nel biopic su Ray Charles viene descritto
il momento in cui intimano al musicista, ancora diamante grezzo, di smetterla di scimmiottare Nat King Cole e seguire la propria strada. La strada di
James è il dubstep. Si tuffa a pesce nella scena di East London e contemporaneamente si iscrive alla Goldsmiths per studiare popular music (con
lecturer importanti come il fondatore della disciplina, Richard Middleton).
James si mette a produrre e i suoi primi pezzi cominciano a girare nelle
feste universitarie (nell’epicentrico FWD>> e al Mass). Il tocco evidentemente c’è ed è speciale perché tempo niente il ragazzo si trova sotto contratto
per la Hemlock di Untold, non proprio il primo arrivato, per la quale esce
il debutto su 12” pollici, Air & Lack Thereof (due pezzi, luglio 2009). Da qui
in avanti l’escalation è sorprendente, praticamente esponenziale. Il vinile
finisce sul bancone di Gilles Peterson, che lo passa e invita James a realizzare un mix per la sua trasmissione (mix che conterrà una esclusiva targata
Mount Kimbie, con i quali ha intanto stretto sodalizio, diventando in pratica loro membro aggiunto nei live). L’hype cresce e viene alimentanto anche
dai remix che il nostro realizza a nome proprio (Kimbie e Untold in prima
linea) e sotto il moniker Harmonimix (dal nome della casa produttrice di
Guitar Hero), rivelando ascolti blackofili (Lil Wayne, Snoop Dogg, Destiny’s
Child, Madlib/Quasimoto, Outkast) e una vena giocosa e deformante forse
inaspettati. L’anno accademico 2009-2010 è l’ultimo per James, che termina gli studi e si trasferisce a Deptford, sulla riva sud del Tamigi, più vicino al
cuore pulsante della scena. Il 2010 vede così l’uscita di una messe di piccole
e piccolissime produzioni, dalla circolazione fisica limitata per lo più alla
sola Inghilterra, tutti materiali ottimi e tutti ottimamente accolti dalla critica di settore: Pembroke (marzo; collaborazione con il producer Airhead,
due pezzi, sulla Braimath che ospita anche cose di Zomby e dello stesso
Untold); Bells Sketch (sempre marzo; tre pezzi, su Hessle Audio); Cmyk EP
(giugno; quattro pezzi, sulla belga R&S); Klavierwerke EP (ottobre; quattro
pezzi, sempre su R&S). Durante tutto l’anno, James registra quello che sarà
l’omonimo album di debutto.
A fine dicembre, la BBC rende nota la sua Sound Of..., la poll con i musicisti più quotati per l’anno successivo, realizzata a partire dalle preferenze
di centinaia tra critici, radiospeaker, blogger e addetti ai lavori. James è al
secondo posto, subito dopo il fenomeno “new-songwriting” Jessie J e subito prima dei chitarrosi Vaccines, copertinati dal NME. Il singolo di lancio
dell’album, una cover di Limit To Your Love di Feist descritta efficacemente
come una “topography of an heartbreak” (pare però che tanto lei quanto
Gonzales non abbiano gradito), uscita a novembre sulla neonata label del
musicista, Atlas (sovvenzionata, pare, da una non meglio specificata major), sbanca su Radio 1. James Blake, l’album, esce il sette febbraio, con un
taglio programmaticamente diverso - per quanto intuibile forse in prospettiva - da tutto quello fatto dal ragazzo finora.
From
dubstep...
James e il suo percorso, anche e soprattutto per la rapidità della loro
evoluzione, sono davvero segno dei tempi, sono un paradigma: un’istantanea - come si dice, in movimento, e si veda la copertina - di una buona fetta
del fare musica oggi e del fare la musica che ci interessa. Formatosi su uno
strumento classico, tanto studiato in modo accademico quanto esplorato
22
23
in maniera non convenzionale, ha poi scoperto il dubstep e si è messo a
produrre dubstep, un dubstep filtrato dalla sensibilità di chi viene “dalla
zona grigia tra classica e jazz”. Perfettamente calato però nel nerdismo/autismo homie Duemila: tutti i suoi EP sono registrati a casa. Il suo lavoro come
produttore, parabola forse già conclusa, sicuramente già matura, riflette
questa poliradicalità e polidirezionalità, pur suonando unitario e sintetico,
non eclettico, tanto da poter essere coerentemente inquadrato seguendo
le pertinenze più diverse, tutte comunque valide, tanto sul versante delle
elettroniche (glitch, ambient, trip hop) che della contemporanea (chamber) e della sperimentazione extra-colta (elettroacustica, field recordings).
Un percorso genuinamente e intensamente sperimentale, illuminato
dal faro dubstep più sotto il profilo squisitamente estetico che delle specifiche produttive dettate dal genere. Ma è ancora dubstep quello di James?
“Se la gente lo chiama dubstep, per me va benissimo, perché il dubstep ha in
sé tutto quello che voglio: ritmo, sound design, emozione vera, tutto insieme, tutto nello stesso posto. Il dubstep mi ha aiutato ad avere una compresione più profonda della musica in generale e quindi di me stesso. E poi, per me,
uno come Mala non fa ‘dubstep’, fa semplicemente della musica incredibile”.
Nell’arco di pochissimi pezzi, praticamente già canonizzati dalla critica, il
suono di James si è affinato per sottrazione, si è fatto sempre più attento
e misurato, più sottile, dalla naivete sperimentale dell’esordio patrocinato
da Untold (“cercavo di emulare Coki e Mala, ma ovviamente non ero e non
sono in grado, non potevo raggiungere i loro livelli di intensità, io non ho quel
background UK bass”), al minimalismo dubstep e ai suoni quasi Dimliteani delle prove successive, fino al funksoul ectoplasmico, agli stop&go e al
cut up vocale di Cmyk e alla perfezione formale, perfettamente inquadrata
da un titolo algido e austero come Klavierwerke, degli esercizi di stile strumentali dell’ultimo EP (registrato con il microfono di un Macbook), lavoro
molto più introspettivo e ancora più minimale di tutte le sue produzioni
precedenti.
Con Klavierwerke EP, James ha portato alle estreme conseguenze quella wave post-dubstep declinata altrove e con diverse specificità dai compagni di banco Mount Kimbie, Darkstar e, in un contesto molto più pop, dagli
xx dell’amico - sempre via cricca Kimbie - Jamie Smith. James è allora davvero un personaggio del post-dubstep, rappresenta davvero qualcosa che
parte da per poter fare proprio e superare. Ha colto l’essenza di fondo del
dubstep, ne ha colto lo spirito, quello che resta quando il dubstep non c’è
più, il suo retrogusto finale, la sua eco, e l’ha messa al servizio di un mondo
espressivo differente e realmente personale. “Con quest’ultima release non
mi sono voluto mettere alla prova come produttore, ho più pensato a fare della
musica bella, che mi sarebbe piaciuto ascoltare, che mi appartenesse di più.
Quando finalmente uscirà il mio album vocale, avrà tutto più senso”.
...
to soulness
Durante il suo veloce apprendistato dubstep, James ha lentamente scoperto la propria voce come strumento espressivo, dapprima giocando a scomporla e ricomporla, modificarla e filtrarla (accanto a sample anche celebri,
ma liofilizzati e resi irriconoscibili), fino alla decisione di “tornare a casa” (il
suo background soul) con un album “decisamente diverso, un album vocale
con produzioni elettroniche ma con la mia voce non-adulterata. Gli arrangiamenti saranno minimalisti e la produzione sarà al servizio del cantato, né più
24
25
né meno”. L’immersione nell’immaginario dubstep, nei suoi soundscape,
persino nella grafica dei software di composizione (un approccio diversissimo rispetto a quello sul pianoforte), ne ha liberato il potenziale anche
come autore di lyrics, compito nel quale James si sentiva originariamente
inadeguato: “dopo aver (ri)scoperto di saper cantare, quelle sensazioni che
prima cercavo cesellando il singolo suono, il singolo disturbo, la singola distorsione, ora cerco di renderle a parole. E vengono fuori come dei piccoli haiku”.
In I Never Learnt To Share James sussurra lo stesso verso solitario all’infinito:
“My brother and my sister won’t speak to me, but I don’t blame them”.
E’ questo mood molto indicativo della visione che ha James dell’essere
musicista e specialmente dell’essere un dj: una pratica solitaria, introspettiva, autoriflessiva, perfino egoista, perché mirata alla soddisfazione di sé,
poco interessata alle vicende del mondo esterno. Anche James Blake è
stato registrato “esattamente come è stato fatto a casa, nella mia camera. Ho
rifiutato tutte le label che mi suggerivano di ri-registrarlo in studio con un vero
produttore”. Una pratica d’altra parte purificatrice, quasi ascetica: il fare mu26
sica come qualcosa di - laicamente - sacro. “Non sono una persona religiosa
né tantomeno spirituale, ma mi rendo conto di essere irresistibilmente attratto
dalla spiritualità disperata di D’Angelo e dal bisogno di redenzione di Lil Wayne, e di percepire come profondamente spirituale l’atmosfera che si respira in
un club quando suoni, quando senti l’euforia di massa e tutti stanno provando
quella stessa sensazione. Il club, nelle serate giuste, è un po’ come una chiesa”.
Una chiesa dove si svolge un rito, con le sue fasi e le sue pause: “Spesso
mentre suono mi piace staccare tutto e sentire il rumore del niente. Per questo
scherzando dico di chiamarmi Dj Nothing. Ma il niente ovviamente non esiste
e, se stacchi, senti il suono delle persone dentro il club. Ed è bellissimo. Una
volta ho staccato all’improvviso e un tizio in quello stesso momento si è tirato
su la lampo della giacca: quel rumore è finito in primissimo piano, è stato come
sentire un gesso che cigolava sulla lavagna. Non funziona sempre, ma quando
stacchi al momento giusto, è un momento magico, di forte empatia con il pubblico”. Un culto delle pause e del silenzio perfettamente rispecchiato nei
dischi del nostro, a richiamare consapevolmente le lezioni di Debussy (“la
musica è nello spazio tra le note”) e del Cage filosofo di 4’33”.
Descritto dalla stampa UK come “una versione futuristica e soul del
Moby di Play” (paragone interessante ma fantasioso), con la voce del nostro accostata a quella di una “Beth Gibbons immersa in una eco da cattedrale” (paragone questo molto più acconcio), James Blake espone la nuova
piega evolutiva del percorso di questo ventiduenne londinese: un soul filtrato dalla sensibilità sonora del dubstep (e di un dubstep, come abbiamo visto, filtrato dalla sensibilità di uno che viene dalla classica e dal jazz).
Così come Windowlicker, Super Collider, Jamie Lidell erano stati il soul del
dopo-techno. James Blake è un cantautorato elettronico che guarda tanto a
Bonnie “Prince” Billy, Joni Mitchell e Bon Iver quanto a Thom Yorke, Arthur Russell e Burial, capace di aggiornare e fare proprio uno strumento
abusato e svilito come l’autotune, piegandolo alle proprie esigenze espressive, rendendolo - in una parola e finalmente - arty.
I primi di gennaio, James ha debuttato live, con la stessa - tutto sommato inaspettata - formazione a tre già vista alle promo session per la BBC,
lui piano-voce-tastiere e due “vecchi compagni di scuola” alla chitarra e alla
batteria elettronica. Un successone, bissato qualche giorno dopo con il set
di spalla al blockbuster Plan B, alla fine del quale ha anche presentato un
inedito, titolo Anti-war Dub (alla faccia dell’artista non-engagé rinchiuso nel
proprio guscio). Aspettiamo la tua prossima mossa, James. James che adesso, e ne è perfettamente consapevole, sta come in un purgatorio, sull’orlo
del successo commerciale, dopo aver sbancato tra la critica (sarà davvero
lui, come titolano i soliti UK journals, il responsabile dell’ingresso a gamba tesa del “dubstep into mainstream”?), indeciso se “tutto quello che mi sta
succedendo negli ultimi tempi sia il paradiso o l’inferno”. In un limbo, avvolto
dalle nebbie - sempre la copertina - di un guscio robotico che sublima in
superficie, scoprendo subito sotto quel che può restare oggi di un caldo e
umano nocciolo soul.
27
Seefeel
Drop Out
A inizio Novanta incarnarono
uno dei sogni ad occhi aperti
della musica britannica. Dopo
quattordici anni tornano con un
nuovo disco. Sapranno ancora
sognare?
—Music for late night gardening—
Testo: Marco Boscolo,
Edoardo Bridda
Erano una band indie, ma non volevano esserlo
(Paul Cox, fondatore della Too Pure)
Q
uel vecchio articolo di Simon Reynolds, in cui il guru del giornalismo musicale esplicitava un’embrionale idea del concetto di post-rock, viene ormai giustamente considerato un classico. Ma i
classici sono fatti per essere discussi, non subiti. Nell’anno in cui ritornano sulle scene i Seefeel, e
passato un periodo che sembra un’era geologica, possiamo con una certa pace affermare che la
portata teorica dello scritto rimane seminale e che troppo acerba era la capacità d’inquadrare all’epoca il contorno di riferimento. Il tempo ha dimostrato che la sua era una premessa ad un capitolo assai più vasto all’interno del quale proprio il gruppo inglese merita d’essere preso come casus privilegiato.
Dopo un intervallo di quattordici anni i Seefeel si rendono protagonisti dell’ennesima reunion e ci rendiamo conto che la loro musica ha dato più frutti di quanto ci si potesse aspettare all’epoca, quando il personale
incrocio di elettronica, ambient, shoegaze, dub e noise cominciò ad essere definito semplicemente post-rock,
proprio sulla scorta del famoso saggio.
Post-rock di matrice inglese certo, ovvero la metamorfosi di quel trend da “sogno ad occhi aperti” tutto britannico, in qualcosa di nuovo e diverso. Una nuova frontiera che la band capitanata da Mark Clifford e Sarah
Peacock ha contribuito fattivamente a costruire, traghettando il dream-pop e la shoegaze di fine ’80 in quella
28
29
nebulosa post ed elettronica di cui i ’90 (e oltre) si faranno carico.
Nella loro prima incarnazione, i Seefeel hanno finito pesantemente per
influenzare una nuova generazione di musicisti di stanza a Bristol (Third
Eye Foundation e Amp) diventando, al contempo, un rispettato termine
di paragone oltre atlantico (Jessamine, Bowery Electric e la cricca Kranky).
La loro musica, progressivamente più fluida nel binomio elettronica/dub,
ha posto le basi per tante sperimentazioni UK Bass a venire (Prime tra tutte,
il dubstep) e, non ultimo, la loro avventura si è formata in un contesto più
ampio, in una Londra che, vista con gli occhi di oggi, sembra aver vissuto in
pochissimo tempo l’equivalente di un decennio.
90-92: The
age of love ( less )
C’erano circostanze particolari e propizie, a inizio Novanta, in una società
all’indomani dell’era Thatcher (guerra delle Falkland, attacchi IRA, inflazione galoppante e recessione) che cercava nuove strade e non vedeva l’ora
di scrollarsi di dosso i lustrini e le patine degli 80s. A Londra - e nel mondo
- c’erano politici, industriali e commercianti che lo avevano capito e sotto la
metafora del muro abbattuto di Berlino auspicavano grossi cambiamenti e
nutrivano forti aspettative per il futuro. Poi c’erano i giovani, loro avevano
scoperto un nuovo modo di relazionarsi e intendere il divertimento notturno sotto il battito di quella che assumeva non solo i contorni ma anche i
connotati di una rivoluzione culturale trainata dalla musica.
All’epoca era un’avanguardia d’accordo, ma anche fuori di essa il fermento
è tanto: per esempio un folto nugolo di etichette indipendenti americane,
inglesi ed europee dai variegati set sonici si trovano in un lampo al centro
di riflettori potentissimi. Dal nulla compaiono non solo produzioni della
nuova dance ai vertici delle classifiche (Snap, Technotronic) ma anche una
30
strana alleanza tra mainstream e giovani che si trovano a trainare assieme
sia il caro e vecchio rock dichiarato morto poco prima (Nirvana, il grunge),
sia antiche rivalità pop nello stile dei Sessanta brit (Blur e Oasis come Stones e Beatles).
In un periodo così fervido accadde di tutto, miracoli compresi: i Primal
Scream con Screamadelica fondano uno standard postmoderno ancor
prima di un ibrido dance-rock, il segno di tempi e modi contaminati che
saranno un must durante la decade; ancora meglio, dall’ossessione per il
rumore (Jesus & Mary Chain) di una breve stagione sixties fatta di melodie
bubblegum in feedback, sboccia Loveless dei My Bloody Valentine, forse
l’ultimo capolavoro universalmente riconosciuto della storia del rock, un
affare di nuove tecniche (il pitch bending che permette microvariazioni di
intonazioni, le pedaliere per loop e reverse) e reinvenzioni dello strumento
chitarra che trasformano l’idea fino ad allora conosciuta di psichedelia in
un’esperienza fisica inedita dal carattere ineffabilmente messianico.
Il white noise da sangue alle orecchie di Kevin Shields tinge la tela di un
paradiso di luci e beatitudine totale. Un paradiso in terra che se fa propria
la lezione dream targata 4AD, riporta il concetto di sogno ad occhi aperti
britannico nel suo estremo opposto. Il capolavoro di Loveless sta proprio
qui: di tanto splendore si può anche morire (Reynolds, ancora lui, docet).
Al principio dei 90s, del resto, l’onda lunga della “Second Summer Of
Love” che aveva inaugurato i rave party e l’uso di un catalizzatore chimico
chiamato MDMA stava raggiungendo il suo apice e la droga dell’amoresenza-amore, un rituale di massa negli UK che rappresenta anche il perfetto
collante tra Loveless e Screamadelica, tra le feste nei boschi e una nascente scena elettronica che comincia a prendere piede sotto l’infausto nome di
IDM, la musica da ballo intelligente, marchio subito rifiutato dall’etichetta
che ne diventerà madrina, la Warp, ombrello sotto il quale finiscono per
gravitare una serie di personaggi che saranno propedeutici all’avventura
Seefeel, tra cui Aphex Twin protagonista, assieme agli Autechre, di una
fase tutta elettronica di un’esperienza out-rock che all’epoca viene vista
come l’avamposto per una futura fruizione su larga scala di queste sonorità.
H ere We G o
Per Mark Clifford e Sarah Peacock, Aphex Twin ebbe un’importanza ben
maggiore degli splendidi remix apparsi sul primo eppì Pure, Impure. “Aphex
ci ha influenzato enormemente”, ci ha dichiarato al telefono la stessa Sarah
che oltre a raccontarci delle frequentazioni rave, ci ricorda comunque che
le influenze chiave senza le quali la band non sarebbe esistita sono sempre
state My Bloody Valentine e Cocteau Twins, punti cardinali attorno ai quali
aggiungiamo l’ambient di Brian Eno e le sperimentazioni psych-dub del
periodo, in particolare quelle dei Main, magari passate sotto il bliss dell’E,
in un bilanciamento sonoro che, allora come oggi, rende riconoscibile e
unico un progetto intimamente laboratoriale.
All’inizio è Mark Clifford a mettere il più classico degli annunci sulle pagine del settimanale musicale NME: sta cercando qualcuno per formare
una band. O forse è Sarah a metterlo. A distanza di quasi vent’anni, è una
casualità senza troppa importanza come quella di darsi un nome che, per
necessità, dopo un concerto live, viene dato alle stampe dopo un altrettanto distratto sguardo alle tracce composte fino ad allora (‘Seefeel’ laconi31
camente nasce dalla canzone See, Feel). Quel che importa a Mark e Sarah
è sperimentare, e per farlo hanno ancora bisogno di una strumentazione
rock fatta di basso (Mark Van Hoen, sostituito poi da Daren Seymour) e batteria (Justine Fletcher) oltre che rispettivamente di chitarra e voce.
Dopo un anno di laboratorio, l’etichetta Too Pure (la stessa di PJ Harvey)
li scrittura, convinta che quel misto di shoegaze, dream e wave abbia le carte in regola per farsi carico di un nuovo suono sulla scia di Loveless ma già
con un’identità e prospettive proprie. E dietro a queste scelte non c’è l’azzardo ma un fitto sottobosco di altrettante ricerche parallele concentrate
sulle timbriche e le texture dei suono piuttosto che sulle classiche modalità
di ritmo, melodia e armonia Si va da un’ambient sempre più scura e contaminata dub (i citati Main ma anche Scorn), a retro futurismi al sapor di
krauti (Stereolab, Pram), o psych sempre più sintetica (Spectrum), in pratica, sequencer, MIDI, loop-station e strani pedali avevano invaso le stanze
di musicisti che poco tempo prima adoravano certamente il noise ma mai
si sarebbero sognati di trafficare con l’elettronica e il loop. Ovvio, c’era una
novità tecnologica fondamentale: la possibilità di prendere un suono, che
sia un frammento di chitarra, un sample o qualsiasi altra cosa, e ripeterlo
sempre identico a se stesso per un tempo indefinito, un trick che diventa
una malattia e porterà Aphex sulla via di complicatissimi poliritmi. E non
solo: il multi traccia introduce un approccio sonico a strati, strati di loop di
quei frammenti magari in un mix sonico dall’estetica circolare e chiusa.
Il campionatore, limitato spesso all’incisione di due secondi, e il multi
traccia, dapprima dominio dell’estetica taglia e cuci dell’hip hop, approdando nelle stanze di questi musicisti, diventa la base per abbattere qualsiasi
frontiera a partire però da una mentalità diversa, interessata al suono in
sé, alla texture e alla timbrica, più che al tradizionale effetto riff e frequenze medie del rock. Mark Clifford lo confessa al citato Reynolds proprio nel
famoso articolo con queste parole: “ora è possibile prendere due secondi di
chitarra e spezzettarli in 1000 parti, mandarli in loop, dilatarli per dieci minuti,
sovrapporli e via così”.
Il sound che esce da Quique, l’esordio sulla lunga distanza che esce per
la Too Pure nel 1993, prende queste idee e riesce a trasformarle in un unicum in perfetto equilibrio tra rock sperimentale, IDM, ambient e shoegaze.
La possibilità di utilizzare i loop mette il concetto di circolarità al centro
delle composizioni della band, che allunga i tempi tipici del rock, lasciando che i suoni delle chitarre si sovrappongano, si intersechino con la voce
filtrata della Peacock, ma senza che mai si abbia la sensazione di vera e
propria libertà. Nella provetta dei due secondi, tutto è perfettamente sotto controllo, alla ricerca di una immobilità ancora una volta ereditata dallo
shoegaze, per un suono che è arty per necessità.
Yin’n’Yang
Molto consistenti, anzi determinanti, i contatti con i My Bloody Valentine,
cui abbiamo già accennato per quanto riguarda un fil rouge che unisce i
padre ai molti figli. Rispetto al gruppo di Shields, però, il velo psichedelico
che si posa sulla musica dei Seefeel è meno mascolino e ha connotazioni
più femminee. Non lo diciamo solo per la presenza dietro i microfoni di
Sarah Peacock, il cui utilizzo della voce e la costruzione delle parti vocali
devono sicuramente molto a Elisabeth Fraser che con i Cocteau Twins è
uno dei cardini essenziali del cambio di decennio tra Ottanta e Novanta.
Si prenda nota della liquida Charlotte’s Mouth e delle dilatazioni da trip di
Filter Dub, in cui la voce della Peacock subisce tutti i trattamenti delle chitarra, ma soprattutto è mandata in loop e stratificata, brandello melodico
su brandello melodico.
Il risultato è una polvere angelica, simile a un coro, che altrove si adagia
quasi in filigrana sulla struttura quadrata (Plainsong, Polyfusion) messa in
piedi del resto della band. È un richiamo, ancora una volta, a quell’estasi
che evidentemente Mark Clifford e soci, come confermatoci dalla stessa
Peacock, hanno provato almeno annusando l’aria dei rave party di allora.
La stessa aria che ha mosso Manchester verso abiti più larghi e Aphex Twin,
Orb e Autechre verso un ritiro pre-sessuale magari in un’infanzia tra l’idillio
e l’incubo. Nei Seefeel tutto questo sublima in una lievitazione quasi zen.
Il paradiso dei Seefeel si adagia su un’idea ipercinetica di musica (basti
ascoltare la sezione ritmica di Industrious o della già citata Plainsong), in
un naturale contraltare all’(e)stasi dell’MDMA: un tappeto nervoso basato
sulle anfetamine. Queste ultime sono un’altra presenza chimica costante
di quegli stessi anni. Dal loro miscuglio, anche solo ideale, nasce un sound
bifronte (e per certi versi bipolare), come testimoniano anche coloro che
hanno apprezzato dal vivo i Seefeel a inizio anni Novanta. Soprattutto Seymour pare che si muovesse come una trottola, tarantolato quindici anni
dopo le crisi di Ian Curtis. Ma il monolite musicale che ne scaturiva, soprat-
32
33
tutto nelle intenzioni di Clifford, era tutto volto alla ricerca di una stasi, di
una scomparsa, di un annullamento dentro allo stesso paesaggio sonoro
creato dagli strumenti e dalle macchine. La circolarità che non faceva che
ripetere se stessa, screziata solamente da microvariazioni: è il debito che
Seefeel e altre band dell’epoca pagano al minimalismo (si ascoltino anche
i Bark Psychosis).
Oltre le chitarre, l’altra portante del suono Seefeel è il basso dub i cui
suoni rotondi e dilatati, assieme alla metronomica ritmica che rimanda direttamente al motorik di scuola kraut, portano diritti nell’inghilterra black
di Bristol ma non solo di Massive Attack, Orb e più indietro naturalmente i
PiL, senza dimenticare i producer Adrian Sherwood e Mad Professor, figure chiave dietro alle vicende di tanti eroi di questa monografia e idoli pure
di Sarah che ci racconta che, oltre ai citati noisers, dalle casse della band
vibravano un sacco di classici dub, dai citati protagonisti a padri come Lee
Perry.
Chiaramente anche il dub, come tutto nell’universo seefeeliano, viene
spogliato dal proprio contesto e ricollocato. Viene cioè sbiancato e messo al servizio di un suono che, all’epoca, sfugge alle etichette: si parla di
shoegazetronica, di ambient-noise, di indie-ambient-dub-house. Forse la
definizione più giusta, e completamente arty, l’ha data lo stesso Seymour:
“musica per giardinaggio a tarda notte”, un’idea riecheggia la Music for airports e la Music for films di Brian Eno, un’ispirazione per molte band che a
quel tempo misero in moto il post-rock reynoldsiano proprio negli anni in
cui i Massive Attack affidano proprio a Mad Professor il remix dub dell’album Protection.
E igthies
becoming
Clifford inoltre stava prendendo piede nell’economia creativa del laboratorio
e, nel contempo, la concentrazione sulle timbriche era aumentata di pari passo alla capacità di manipolare i suoni stessi. Gli altri rimangono in posizione
di silenzio assenso e il suono che ne esce, pur mantenendo intatte le parti
dream della Peacock (When Face Was Face, Ruby-Ha), è maggiormente astratto e dronato (Meol), quando non più oscuro con le ritmiche a differenziare sul
quattro quarti (Vex) e i beat a prendere altre strade (Fracture, Gatha). Rimangono gli echi angelici (Rupt a ricordarci un’altra grande band del periodo, i
Portishead), il collante dub è più soldio, ma la consistenza comincia a farsi un
manieristico affare gassoso e spettrale. E’ l’inizio della fine.
Un(a)
fine sperimentale
Il distacco dalla carne sembra completarsi con l’appendice Ch-Vox dell’anno
successivo, che si fatica a immaginare essere figlio delle stesse menti. La sezione ritmica è quasi totalmente assente in tutti e sei i brani. In questa mezz’ora
di musica pubblicata sull’etichetta dello stesso Aphex Twin, la Rephlex, c’è una
scheletrizzazione totale del suono della chitarra. Sembra scomparso il legame
ombelicale con lo shoegaze, ma nemmeno si va in direzione di ritmi sintetici, siano essi da club o IDM. Qui si aprono paesaggi sonori che ci portano
nell’ambient e nella drone-music, davvero lontani dall’idea classica di rock.
Ch-Vox si avvicina ad alcuni episodi della superband E.A.R. (Experimental
Audio Research), composta dallo stesso Kember, attorno al quale ruotano in
una formazione aperta e, appunto, sperimantale Kevin Martin, Kevin Shields
ed Eddie Prévost (batterista di formazione jazz già cofondatore degli AMM).
N ineties
In Quique si ritrovano molti elementi determinanti nella trasfigurazione
degli Ottanta nei Novanta. C’è il traghettamento dell’eredità My Bloody Valentine e Cocteau Twins verso nuovi lidi, le cui ultime propaggini giungono fino a noi sotto forma di dubstep. Pungolata su quali eredità avessero
lasciato i Seefeel, Sarah infatti fa un nome che forse lì per lì sorprende ma a
pensarci bene non stupisce troppo: è Burial i cui scenari urbani riecheggiano infatti in Signals ma c’è anche qualcos’altro che lega la dub–tronica della
band al sound del dubstep: la georeferenziazione del suono, il mettere in
secondo piano l’azione dei musicisti che spariscono dietro alla consolle di
dj o sound system o allo stesso strumento.
E’ una costante negli anni Novanta, dagli Slint ai Chemical Brothers,
all’epoca c’è una sorta di macchinizzazione della rock band, il tentativo di
una scomparsa o, all’estremo opposto, la fusione con la tecnologia stessa:
il cyberpunk (Nine Inch Nails) e la musica “automatica” dei Daft Punk che
“alle 9:09 del 9 settembre 1999” diventano robot.
La tecnologia è dunque variabile centrale in molte musiche, specie in
quella di Mark e Sarah che nel sophomore, Succour, del 1995, possono
sbizzarrirsi in uno studio di registrazione con le ultime trovate elettroniche
grazie al budget proveniente da un nuovo contratto discografico. Finita la
fase di purismo elettro, la blasonata Warp li aveva presi con sé. Il label manager Steve Beckett ricorda in una recente intervista “che furono la prima
band con le chitarre a firmare per l’etichetta”.
Certo lo furono ma è anche vero che la direzione che il suono Seefeel
stava prendendo era eminentemente elettronica e dub più che il contrario.
34
35
Non più legati alla forma canzone della tradizione rock, Seefeel, E.A.R., Main
e Sonic Boom, aprono nuove strade e nel contempo chiudono i ranghi
dietro di sé portando la musica isolazionista tutta a un punto morto. Nel
1996, ci ha raccontato Peacock nell’intervista, “ne avevamo abbastanza gli
uni degli altri” ma probabilmente erano lei, Seymour e Fletcher ad averne
abbastanza di Clifford, dato che nemmeno il tempo di annunciare lo stop
Seefeel e loro tre si erano imbarcati nel progetto Scala, addirittura riprendendo in formazione Mark Van Hoen.
Clifford, da quanto raccontato in una lunga intervista rilasciata nel 2003,
era a suo modo stanco di essere quello che tirava le fila del discorso musicale, mentre – a suo dire – gli altri tre non avevano concrete proposte da
fare al gruppo. O se ne avevano, non le esprimevano così apertamente. Di
sicuro lui aveva in mente già altri percorsi musicali, che si sono concretizzati in un percorso solista iniziato già nel 1995 con Disjecta e proseguito
anche sotto altri moniker.
Too Pure ripubblica l’esordio Quique in una edizione ampliata che arriva a
riempire due interi cd. Il primo ripercorre il programma originale del 1993,
il secondo comprende altri nove episodi tra outtakes, remix e alternate version che ampliano il discorso senza spostarne la barra. I tempi sono maturi
perché i Seefeel si ripresentino nuovamente sulla scena e l’occasione arriva
presto al party del ventennale Warp, al quale Clifford e Peacock si presentano con Shigeru Ishihara al basso (uno del giro di musicisti di Brighton, città
in cui vive Clifford) e un ex batterista dei Boredoms, Iida Kazuhisa. L’assenza
di Seymour e Fletcher viene giustificata da non precisati impegni fuori UK.
Sia come sia, Sarah Peacock ci racconta che l’operazione di reunion non è
stata pianificata a tavolino: “ci ha chiamati la Warp per il concerto e noi abbiamo un po’ esitato, poi abbiamo accettato. Io e Mark non ci vedevamo da sette
o otto anni ed è stato strano rivedersi all’intervista: tornando a casa ci siamo
accorti che avevamo ancora molti interessi musicali in comune”.
Due anni più tardi e arriviamo all’oggi con Seefeel, un album eponimo,
che nel gergo della musica ha sempre significato una palingenesi. Faults,
lo anticipa di qualche mese ponendo le basi per un inedito riavvicinamento in senso rock verso un suono libero dalla circolarità che si sposa benissimo con dieci e più anni di laptop noise (Fennesz fino a Ben Frost). L’hype,
trainato dalla Warp, cresce oltre ogni aspettativa e la timida Peacock è sorpresa.
L’aspetto più evidente dei Seefeel 2.0 è dunque l’impatto fisico dovuto
al drumming di Kazuhisa ma probabilmente anche dalla distanza dall’estasi
acida dei primi Novanta. Troviamo ritorni al passato più o meno marcati
(Faults, Making, Sway) aggiornati ai nuovi noise (“anche se non abbiamo mai
smesso di comporre materiale che poi riuscissimo a suonare anche dal vivo,
abbiamo sempre utilizzato il laptop in questa fase”, dice la Peacock), una tecnologia vissuta come fatto quotidiano e la frammentazione dello stesso
vissuta in brevi composizioni (Step Up, Gzaug, Step Down). Peacock ascolta un range di musica molto più diversificato ora, classica e jazz compresi.
Forse i frutti migliori di queste infusioni si notano nel dittico a fine scaletta:
Airless è l’appropriazione (scretching compreso) del sound di Bristol trasfigurato in un psichedelia circolare; Aug 30 è la versione 2.0 di Succour, impreziosita da un delicato equilibrio tra vuoti e pieni (in pratica una colonna
sonora per un film futuribile).
Alla fine della nostra intervista chiediamo a Sarah se i Seefeel siano qui
per rimanere. Lei ne è convinta. C’è persino del materiale inedito inciso di
recente e altro che non è confluito nell’album. Ora parte il tour e dopo My
Bloody Valentine e Primal Scream a ricordarci l’eredità dei Novanta al terzo posto mettiamo proprio loro.
Palingenesi
Tutto rimane sospeso nella bolla di metà anni Novanta fino a quando la
36
37
Recensioni
— cd&lp
highlight
24 Grana - La stessa barca (La Canzonetta,
Gennaio 2011)
Genere: rock partenopeo
Se una band decide di rivolgersi a Steve Albini in occasione del decimo album, significa che ha voglia di recuperare l’estro basale smarrito nel pelago dei tentativi.
Un bel lavacro d’autenticità, di suoni essenziali e buona la prima, di piglio brusco ma pulito modello live in
studio. Sembra proprio il caso dei 24 Grana, che dopo
escursioni più o meno felici in ambiti pop-rock e tentativi di sofisticare la calligrafia, hanno deciso di rifarsi
una verginità ruvidella, immediata, essenziale. Saggia
decisione. Questo La stessa barca è venuto fuori proprio bene. Disco che vola basso, ad altezza marciapiede, raccontando storia urbane, d’ordinaria quotidianità
partenopea e oltre.
L’estro wave che sfrigola d’allarme la chitarra, il canto
laconico, la spinta cruda della ritmica: triangolazione
agile per un’efficacia nuda che esalta pezzi forse non
trascendentali ma benedetti da una bella immediatezza come Turnamme a casa e Ombre (essenze mediterranee e indolenzimento ridanciano Wilco), stuzzicando
il nervolino del dub nelle guizzanti Ce pruvate Robé e
Salvatore, cogliendo quindi il petalo dell’urgenza con
Malavera, ispirata alla triste vicenda carceraria di Stefano Cucchi. Forse i pezzi meno riusciti sono Cenere
(un po’ troppo Steve Rogers Band) e la vagamente
stucchevole Germogli d’inverno (che ricorda a livello
omeopatico One Of Us di Joan Osborne): curioso che
si tratti di due dei tre pezzi in italiano (l’altro è la piuttosto solenne e folkeggiante Oggi rimani laggiù). Tirate le
somme, massì, è un buon disco.
(6.8/10)
Stefano Solventi
3/4HadBeenEliminated - Oblivion (Die
Schachtel, Dicembre 2010)
Genere: elettroacustica
Non esiste più il post-rock. Con gli occhi di oggi, anche i Gastr Del Sol li ascolteremmo con altre orecchie.
Non possiamo che trovarci ad affrontare Oblivion con
l’abitudine dell’elettroacustica, della sperimentazione
e lavoro certosino e meditatissimo verso cui Pilia Tricoli
38
e Rocchetti ci hanno accompagnato per mano - con la
violenza del rumore, o con una spinta fantasmatica - in
tutti questi anni. Ma cosa rimane di peculiare nella firma 3/4HadBeenEliminated, della “band” tre quarter?
L’album numero quattro della formazione, in un certo
senso, ce lo spiega.
Primo: occorre arrendersi alla elevatissima capacità di
produzione di qualità del trio. La formula è semplice.
Trovare un concept adeguato e riuscire a scavarlo dal
pieno con la padronanza dei mezzi. Sì, perché anche
l’elettroacustica è un mestiere, una pratica, eccezionalmente intelligente e sofisticata, se vogliamo, ma pur
sempre soggetta a condivisione. I ¾ sono maestri in
questo: nel rendere abbordabile quella prassi, riempirla di umanità, nella forma degli archi (vedi Oblivion
Part II) oppure - inevitabilmente - con la componente
vocale, seppure spesso strozzata, flebile come l’ultimo
respiro.
Nelle quattro parti di Oblivion, frastagliatissime nel fraseggio di atmosfere, di mondi cosmici, sono pur sempre rintracciabili le dilatazioni della forma canzone, dei
nodi lirici continuamente perturbati da trovatismi ed
elettroniche (Oblivion Part III), eppure costantemente
ripresi, come elemento centrale nell’economia ambientale dei brani. Ci sembra un tratto distintivo e un
lascito fondamentale, nel quadro in cui si muove questa musica.
Il compimento è tutto nel finale: una struttura scheletrica che elabora una melodia minima (voce e chitarra)
e la rende una macchina dal moto perenne, fino a chiudere l’album e lasciare questo segno nella memoria,
cosparso dei suoni che l’hanno preceduto.
Parlandone dal vivo, Stefano Pilia ci confessa di vedere HadBeen come una formazione fissa - dall’identità
lampante, aggiungiamo noi, e destinata a durare.
(7.3/10)
Gaspare Caliri
A Hawk And A Hacksaw - Cervantine (LM
Duplication, Febbraio 2011)
Genere: total folk
Jeremy Barnes e Heather Trost hanno perfettamente
compreso - nella loro discografia parsimoniosa e scin-
AA. VV./Planet Soap - After Silkworm (Car Crash Set, Dicembre 2010)
Genere: uonchi/steps
After Silkworm è un progetto importante e speriamo faccia anche da catalizzatore nel lungo e lento
cammino verso la definizione di una scena credibile di produttori italiani. Diciassette remix a partire dai
sette pezzi dell’EP Silkworm (7.0/10), materiali già ottimi che qui vengono completamente trasfigurati/
ricreati ed esplodono in tutte le direzioni, sancendo il riconoscimento della qualità del prodotto e l’interesse in generale per le produzioni nostrane da parte degli addetti ai lavori fuori confine. Il primo passo
per riconoscerci è essere riconosciuti dagli altri? E’ un’interpretazione possibile.
Quattordici dei diciassette remixer al servizio di Planet Soap (duo di producer dalla provincia di Monza)
sono stranieri: russi, francesi, olandesi, tedeschi, americani, giapponesi. Le
produzioni sono tutte cesellate e d’impatto - la qualità è altissima - e descrivono analiticamente quella che in sintesi possiamo definire una koiné
elettronico-produttiva che deve tanto dall’hip hop quanto alle mutazioni
della lingua madre electro, con tutte le possibili emanazioni/filiazioni.
Su una base comune allora che è quest’ibrido bipolare wonky/step (e che
ritroviamo particolarmente “puro” nell’asciuttissimo pezzo a firma di Harrison Blakoldman, il secondo della tracklist), si impone di volta in volta come
un’essenza diversa (che sia un genere, una scelta timbrica, un’atmosfera) a
determinare l’aroma, il sapore, la consistenza persino di ciascuna traccia:
spacey (diversamente declinato da UXO, Miqi O., Kay Tee, Pixelord, Demokracy), noise/effettistica industrial-postfidget (+verb, Damscary, Moa Pillar), electro-funk & dintorni (B-Ju) e ancora tech-house
(Coco Bryce, 3 Is A Crowd), electro-dancehall (Moresounds, DZA), praticamente footwork (Apes On
Tapes), mutazioni tribal (Halp, BD1982), fino al Dilla elettronico di casa Planet Soap (la conclusiva title
track). Goduria. E tutta una scena che ribolle e sta per uscire fuori dal pentolone.
(7.5/10)
Gabriele Marino
tillante e nel coraggio a cimentarsi con tradizioni sconosciute e lontane - che il segreto della musica migliore
sta nella contaminazione. Nelll’appropriarsi di qualcosa
non tuo, che hai osservato dall’esterno e hai succesivamente conosciuto; nel quale hai infine infuso la tua
esperienza e il tuo retaggio fino a un risultato che va
oltre la semplice somma delle parti. Da bravi busker che
il mondo lo girano e ti ci fanno girare, insomma, e che
ora lanciano un personale marchio (scelta “pesante”
oggi, nello specifico caricata da un ulteriore ed encomiabile scopo: collocare sotto i riflettori nomi rappresentativi di un’Europa orientale cui seguitano a ispirarsi)
e allestiscono un nuovo tassello della propria indagine.
Il quale si muove da dentro quel misto collaudato di ma-
linconia e gioia, di fisarmoniche e sarabande fiatistiche,
però ispessendo le trame sonore (magistrale l’articolata
No Rest For The Wicked), soprattutto riportando a casa
loro l’est europeo e mescolando ulteriormente le carte nel Mediterraneo della mente di The Loser e in una
Mana Thelo Enan Andra in gira sul Gange. Senza incappare mai in cali ispirativi e anzi approcciando il cantato
con atteggiamento ancor più disinvolto e accorato, addirittura indicando futuri sviluppi in una sensazionale
title-track giustappunto tra bolero e cieli di Messico e
nel respiro impalpabile di Lujtha Lassu. Bellezza messa
su nastro nel tepore di Albuquerque avvalendosi della presenza dei fratelli Stephanie e Chris Hladowski
(a voce e bouzouki: polacchi d’Inghilterra, ovviamen39
te...), come a voler porre un sigillo significativo a qualcosa di vibrante e romantico. In una parola: di vivo.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
A Small Document - The New Middle Ages
(Red House Recordings, Gennaio 2011)
Genere: psych garage
Metti un trio toscano alle prese con una magnifica ossessione. Anzi, con una ressa di ossessioni che l’impeto,
l’attitudine e - massì - una certa dose di talento riescono a fondere in una sola. E’ il consueto procedere del
rock, una strategia di sintesi più o meno cruciali, uno
smarcarsi utilizzando in modo possibilmente inedito le
tecniche dei “maestri”. Nel loro piccolo - e quanto sia effettivamente piccolo o potenzialmente grande lo dirà,
come sempre, il tempo - gli A Small Document piazzano un bel dribbling, si fanno spazio, aggrediscono lo
schema. E insaccano un buon punto.
Vista alla moviola, l’azione esala proto-grunge, garage
psych, accenni lo-fi e sprazzi wave-noise. A velocità normale è una bella botta d’acido e adrenalina. Soprattutto la prima parte di questo album d’esordio The New
Middle Ages, è roba che farà felice i neuroni affamati di vibrazioni acide. Si va da una Muddling Head che
ipotizza il lato hardcore dei Foo Fighters ad una Song
Of Robespierre che mette l’invettiva laconica e beffardella John Lydon al centro di una strategia protopunk,
passando dal caracollare Pavement della title track ad
una travolgente New Strange Red Flavour, ovvero i Pearl Jam in nevrastenia Dead Boys, per approdare alla
melassa tormentata Cobain di Shock Down.
C’è nella loro calligrafia una muscolarità losca e impetuosa, però continuamente irrorata dalla vena folle
che diresti Soft Boys via Flamin’ Groovies e da una
foga torbida Stooges, come ben dimostra Desert Road,
il pezzo migliore di un ipotetico lato B che pur difendendosi bene non ripete l’eccitante sequenza iniziale.
Basta e avanza però per un’impressione globalmente
positiva.
(7.1/10)
Stefano Solventi
AA. VV. - Bangs & works vol.1 (a Chicago
footwork compilation) (Planet Mu
Records, Dicembre 2010)
Genere: Footwork
Dopo che la Hyperdub ha lanciato la compilation, Five
years of Hyperdub, primo lucido riassunto sui linguaggi dubstep, wonky, grime, sembra sia iniziata una corsa
alla ricerca di nuovi sviluppi e orizzonti da esplorare
40
per queste sonorità, in definitiva di nuove scene. Ecco,
il materiale contenuto in questa raccolta della Planet
Mu è un tentativo di andare in tale direzione.
Le coordinate della compilation sono, come suggerisce
il titolo, essenzialmente due: Chicago, base geografica
condivisa dagli artisti in questione, e footwork, genere il cui epicentro musicale ruota attorno all’uso retrò
- leggi ‘80 - dei sample quando cioé campionare significava poter registrare frammenti miserrimi formando
loop brevissimi e frenetici, spesso più legati alla voce
che al suono, alla riduzione dei brani nelle matrici più
scheletriche, costruiti sull’aritmia di pochi elementi reiterati; ad un avvicinamento spirituale all’hip-hop versante Antipop Consortium (vedi Ima dog di dj Nate),
nonostante i bassi rimangano fedeli al dubstep-wonky.
Tra i migliori interpreti di questa compilation si segnalano allora dj Roc, dj Diamond dj Nate e dj Trouble, che riescono più di altri di marchiare il battito del disco,
ampliando le strutture musicali di samples ora industrial ora new age.
Costruita su 25 brani che difficilmente superano i tre
minuti, la compilation ha il merito di mettere a fuoco
la prospettiva su una realtà, forse ancora troppo simile
a qualcos’altro per riconoscersi in uno stile completamente autonomo, ma comunque da testimoniare. E in
tutto ciò, la Planet Mu si conferma etichetta affidabile
e di qualità.
(7.3/10)
Stefano Gaz
AA.VV. - Mellon Collie And The Infinite
Power (42, Dicembre 2010)
Genere: remake
L’idea meravigliosa è venuta in mente agli Albanopower: confezionare un album-tributo ad un albumcardine dei Novanta, Mellon Collie And The Infinite
Sadness degli allora enormi Smashing Pumpkins.
Anzi, più che un tributo un remake, nel solco di quanto
fatto dai Flaming Lips col Dark Side Of The Moon, per
intendersi. Ora, vuoi perché nel frattempo il progetto si
è allargato a virus alla cerchia dei tanti (circa cinquanta)
amici musicanti, vuoi perché l’impresa era di quelle che
senza un (mica tanto) piccolo aiuto è difficile sfangarla,
fatto sta che ne è uscito un (doppio) album corale. Che
paga pegno quindi al difetto tipico delle ammucchiate,
ovvero una giustapposizione di calligrafie non sempre
contigue, di sensibilità e frequenze incongruenti.
Tuttavia possiamo ben dirlo un lavoro riuscitissimo,
perché celebra la persistenza del “marchio” Mellon Collie nell’immaginario d’una generazione che o lo ha conosciuto in diretta o si è fatta cullare dalle onde d’urto.
Ma non si limita a questo, perché ogni contributo fornisce da par suo un angolo di visuale più o meno spostato, diverso, che mette alla prova forma e sostanza
degli originali, il loro perpetuarsi mutando, di memoria
che sfida se stessa. Folktronica oppiacea, dance-wave
sincopata, incantesimi asprigni e ghigni brumosi: lo
zibaldone hardcore-noise-dream-pop-folk di Corgan
e compagni subisce una trasfigurazione formidabile e
(in)dolente.
Delle 28 riletture potremmo segnalare la deliziosa
stralunatezza dei Music For Eleven Instruments (alle
prese con To Forgive), un waitsiano William De Marion
(Where Boys Fear To Tread), un alcolico Feldmann con
Cesare Basile e Micol Martinez (Bullet With Butterfly
Wings) ed ovviamente i “padroni di casa” Albanopower
bravi ad estrarre sogni di celluloide da Tonight, Tonight
e malie esistenziali da Bodies. E sia chiaro che non citandoli facciamo torto ad un bel po’ di gente. La Sicilia
è arguta, sensibile, viva. E generosa: il download è rigorosamente free all’indirizzo www.42records.it/albanopumpkins/.
(7.4/10)
Stefano Solventi
Ad Bourke - Mirage (Citinite, Dicembre
2010)
Genere: wonk boogiefunk
Il Dam-Funk de noantri? Beh, è questo il primo pensiero che passa lecitamente per la testa ascoltando Mirage. Pur partendo dagli stessi presupposti e con una
sensibilità affine, Adam aggiunge un tocco wonky (nel
senso del barcollamento ritmico) e un certo gusto per
strutture quasi-progressive rispetto al guru boogiefunk
di casa Stones Throw.
Sette strumentali e una Cosmic Connection (title omen)
in doppia versione, con i vocals di Amalia (e il pezzo
ne guadagna, è una strada da battere di più), in un tripudio di synth e motivetti oldie riletti con la sensibilità
del nerd Duemila. Gustosissimo, artigianale, sentito,
solo apparentemente derivativo (Dam e Ad hanno percorso la loro strada in parallelo), e però il nostro può
sicuramente variare di più e soprattutto spingere più
a fondo.
(7/10)
Gabriele Marino
Agoria - Impermanence (InFiné, Febbraio
2011)
Genere: melodic house
Un disco di elettronica pensato per essere ascoltato
dall’inizio alla fine. Un disco che Sébastien Devaud - tra
le menti della Infiné e tra gli organizzatori del festival
di Lione Nuits Sonores - ha pensato di getto, invitando degli amici a casa a registrare. Tra questi Seth Troxler, uno dei più grandi spinners del momento che in
Souless Dreamer tira fuori una voce da urlo, il mito per
l’etichetta - già esaltato nel lavoro di Francesco Tristano - Carl Craig che presta la sua anima in una bomba
come Speechless e per finire la voce splendida che non
sembra nera (ma che invece lo è) di Kid A, la scoperta
americana dell’uomo Agoria.
Un nuovo modo di ripensare la house più melodico,
che salta il passato prossimo del french touch e si ricollega di striscio a quel sentire che Air e St. Germain fra
gli altri avevano potenziato con le loro proposte qualche lustro fa. Occhio però, non c’è lounge qui. L’unica
cosa acustica che Seb tira fuori dal cilindro è il suono
del pianoforte, uno strumento che ormai connota le
solide basi della sua etichetta e un rinnovato interesse per la melodia in setting house di qualità (e quindi
anima).
La non permanenza del titolo è l’essenza delle nuove
proposte di questi ragazzi che svicolano dalla lezione
snob della capitale e si affacciano in modo personale
alle infinite stande del mondo del ritmo. Ben arrivato
Seb.
(7.25/10)
Marco Braggion
Arnaud Fleurent-Didier - La
reproduction (Sony BMG Music
Entertainment, Gennaio 2010)
Genere: pop, french
Primo lavoro uscito con Sony per il talentuoso cantautore francese, dopo l’esperienza con una label giapponese e con la francese French Touch. La reproduction è il secondo LP solista di Arnaud Fleurent-Didier,
album composto nel piccolo scantinato dell’artista, a
Place de Clichy, Parigi, è una perfetta commistione di
generi, riferimenti e sguardi, dal pop al punk passando attraverso le variazioni su Marilou tanto care a Serge Gainsbourg. Un album che nasce a partire dall’idea
della riproduzione, intesa come infinito possibile ripetere, ricreare, riprodurre, nel mondo contemporaneo:
riproduzione sessuale, riproduzione ideologica, riproduzione, tutta, in buona sostanza, meccanica, non naturale. La riproduzione di cui parla Didier è quella, anche, del ripetersi che consuma, allontana i significati, il
valore di tutte le cose, togliendo loro la magia dell’originario (Reproductions) . La copertina è una chicca: ritrae
infatti un Didier che sostituisce il nostro Nanni Moretti
in una delle migliori scene del film Bianca (1983), quella
41
il cui il protagonista si trova a osservare la riproduzione,
in ogni angolo della spiaggia, dell’immagine di coppie
in amore. Il protagonista proverà dunque a riprodurre, lui stesso, in modo meccanico, quello scambio di
effusioni, buttandosi addosso a una donna libera venendo naturalmente allontanato, brutalmente deriso e
insultato da tutti i presenti. Nell’album trovano radice e
spazio i ritratti di un giovane uomo nella Parigi di oggi,
tra una dissoluta vita amorosa e riflessioni politiche
sull’educazione ricevuta dalla famiglia, sul possibile destino che toccherà alla sinistra e alle generazioni che in
essa riporranno la propria fiducia (French culture, Mémé
68). Riflessioni amare, quelle di Didier, che vivono su
una varietà musicale eccezionale, attenta soprattutto
alle composizioni dei grandi autori di colonne sonore
(Morricone in primis) senza dimenticare mai certi barocchismi conterranei come quelli di Michel Polnareff
(noto in tutto il mondo per la sua eccezionale Love me,
please love me baluardo della chanson d’amour tutta
miele, classicità e violini) o di Pierre Vassiliu, uno di
quelli a loro volta già avanti pur senza dimenticare le
tradizioni. Moltissimi altri nomi potrebbero essere considerati ispiratori di Arnaud Fleurent-Didier, tuttavia è
soprattutto convincente la sostanziale unicità di questo cantautore che potrebbe diventare facilmente una
sorta di other side del cantautorato francese mentre
dall’altra parte Biolay, giustamente, impera. La reproduction si presenta come un concept album pop riuscitissimo che non rinuncia, nelle ossa dei propri suoni, a classicità e accurati inserti elettropop, e anche se
qualitativamente i singoli pezzi risultano a tratti meno
sorprendenti delle perfette hit contenute nel precedente Portrait d’un jeune homme en artiste, la maturità
di questo disco è eccezionale e ciò è sottolineato, non
in ultimo, da una produzione pressoché impeccabile.
(7.8/10)
Giulia Cavaliere
Asobi Seksu - Fluorescence (Polyvinyl
Records, Gennaio 2011)
Genere: Psycho pop
Ai tempi del loro secondo album, il bellissimo Citrus,
del combo newyorkese si esaltò l’eleganza e la generosità degli arrangiamenti che non si limitavano a rivestire di feedback delle melodie ad alto tasso di glucosio.
Si mise inevitabilmente l’accento sulle capacità canore
della brava Yuki Chikudate capace di prendere il gruppo per mano e portarlo a spasso in un fitto bosco di
infiorescenze rumoriste. Dopo un album interlocutorio
come Hush, il nuovo Fluorescence sposta un pò più in
alto le quotazioni artistiche della band che oggi è autri42
ce di un sound da sogno profondamente ambizioso.
Dream pop? Forse, ma solo per il modo in cui aggredisce i sensi e per le suggestioni oniriche. In un genere
che storicamente sacrifica il ruolo delle voci femminili,
riducendole a presenze diafane, l’ugola della Chikudate sarebbe quanto mai fuori posto. Gli Asobi Seksu
scelgono invece di valorizzarla allestendo un impasto
sonoro ricchissimo, fatto di lucido e solidissimo electro
pop, percussioni tronituanti e rumori digitali assortiti.
Dello shoegaze rimangono le distorsioni, calde e sempre molto fisiche. E’ un bouquet di profumi inebriante,
il loro, forse pefino stordente; un fiume in piena che talvolta rischia di perdersi in mille rivoli, ma quando trova unità grazie ad un potente tema melodico (è il caso
dell’affascinante Trails), travolge inesorabilmente.
(6.9/10)
Diego Ballani
Banjo Or Freakout - Banjo Or Freakout
(Memphis Industries, Gennaio 2011)
Genere: Elettronica, Glo
Dopo i Disco Drive e dopo Walls giunge al traguardo
dell’album anche il progetto solista di Alessio Natalizia,
alias Banjo Or Freakout. Le tante buone premesse del
musicista di Vasto trapiantato in Inghilterra hanno creato, tra mp3, EP, 7” e cassette, una certa attesa anche
tra media specializzati molto importanti quali la stessa
Pitchfork.
Rispetto a quanto sentito finora Banjo Or Freakout suona giustamente più uniforme e vanta la produzione
più importante ed equilibrata di Nicolas Verhens, già
visto con Deerhunter ed Animal Collective. Certo chi
ama la bassa fedeltà e l’attitudine home-made dietro a
simili progetti potrebbe rimanere parzialmente deluso,
ma d’altra parte fin dagli esordi Alessio ha sempre manifestato un gusto più personale ed ‘europeo’ rispetto
ai luoghi comuni del cosiddetto glo: molto meno scazzo e molta più attenzione al dettaglio, molta meno ‘freakadelia’ e molta più cura per gli arrangiamenti. Molto
meno Syd Barrett e molto più Jason Pierce, insomma.
Ora questa attitudine fin qui contenuta sfoga in un
esordio ancora perfezionabile ma già di rilievo, che esce
da una nicchia per sboccare in un’altra ben più grossa
ponendo così l’intero progetto sul medesimo gradino
degli altri sopra citati: il già ampio spettro di influenze
e richiami che caratterizzava l’opera precedente non si
è certo ristretto, eppure ora si riesce a scorgere un legame più netto tra i singoli brani laddove prima tutto
suonava ancora come un intrigante assemblaggio di
buoni spunti. Ancora più precisamente, se le coordi-
highlight
AA. VV./Xabier Iriondo/Massimo Falascone/A Spirale/Amuleto/Ossatura/Tumble Musica Improvvisa (Die Schachtel, Ottobre 2010)
Genere: impro
Più che un manifesto un vero e proprio monumento. Le dimensioni innanzitutto: 10 cd (più un dvd) per
10 progetti più o meno estemporanei che sono una vera e propria cartina al tornasole della scena improvvisativa italiana. A scorrere i nomi si ha già la dimensione del tutto: Xabier Iriondo, Francesco Dillon,
Ossatura, Andrea Belfi, Massimo Falascone, Elio Martusciello e moltissimi altri, prestano le loro musiche
in modalità rigorosamente impro alla label che, per estetica ed etica, meglio rappresenta il panorama
italiano.
L’onore dell’apertura spetta ai napoletani A Spirale con Viande, 12 pezzi untitled che si muovono tra jazz
inform(al)e e concretismi dall’animo rock. La nenia rock-autistica della quinta traccia, i contrappunti del
sax di Gabola nella nona, il free-jazz starfuckersiano della penultima non sono che esempi di un sentire
musicale libero, insieme sempre ostico e in tensione. Dietro Amp 2 troviamo Gandolfo Pagano (chitarra),
Dario Sanfilippo, Domenico Sciano, Antonio Secchia (tutti al laptop) e Andrea Valle (percussioni) quintetto che sposta l’asse verso l’impro-elettronica da laptop. Hopeful Monster consta di 5 pezzi in cui l’elettronica riduazionista si fa collage sonoro multiforme, aiutata da una notevole predisposizione al ritmo.
Fratturato e frantumato, continuamente in coazione coi live-tronics dei tre pc, trova nella lunga opener
Parent-Explains la sua migliore forma.
Cambio di atmosfere radicale con 11h15:Local Weather Forecast a nome Amuleto, ovvero Francesco Dillon e Riccardo Wanke. Ci si sposta sul versante di un minimalismo dilatato e volatile (Mind The Gap Pt.2), di
matrice droning (il crescendo di Final Del Juego) via via sempre più spettrale. La conclusiva Cani Neri è di
una evanescenza encomiabile. Su panorami decisamente più avant si muove l’accoppiata Xabier IriondoRoberto Sassi sotto le mentite spoglie di An Experiment In Movement. L’interazione tra la celebre mahai
metak autocostruita per il lungocrinito e le chitarre di Sassi crea immaginari landscapes fatti di corde in
opposizione dolce/aspro (The Earth Abstracted
) o pieno/vuoto (la prima parte di Wreckage in Gaddani),
lontano da qualsiasi cosa del genere si sia sentita negli ultimi anni.
In Territori, accreditato a Ligatura (Alessandro Giachero, piano, Maurizio Rinaldi, chitarra, Andrea La macchia, contrabbasso e Fabrizio Saiu, percussioni), ci si muove sul crinale tra contemporanea e jazz cameristico meno conforme, in cui la ricerca sul suono è funzionale alla creazione di un “estemporaneo processo
di rappresentazione di un territorio”. Impro-psicogeografia? Da parte loro, i veterani Ossatura (Elio Martusciello al computer, Fabrizio Spera alle percussioni, Luca Venitucci al piano) si fanno accompagnare dal
clarone di Gene Coleman e dal violoncello di Marina Peterson. Nata per “investigare le connessioni tra
suono elettrico e acustico”, la line-up si muove intensa nelle 4 lunghe tracce tra flusso di coscienza elettroacustico (Non Prima) e contemporanea più astratta e colta (Non Più).
Fabrizio Spera è protagonista anche in Thau, in cui condivide la scena con la cantante Sabina Meyer, coi
fiati di Hans Koch e col basso di Paed Conca. Ambito di riferimento principale è, giocoforza, quello della
sperimentazione vocale, tanta è la forza attrattiva della vocalist svizzera. L’apporto degli strumenti però
non è secondario, muovendosi agile tra lande avant-, concretismi e contratture ritmiche camusiane. In
For Tumbling, Andrea Belfi e Attila Faravelli, in arte Tumble, vanno di interazione tra computer/giradischi,
il primo, e batteria/elettronica, il secondo. Un procedere ipnotico (Trampoline) e tentacolare (Gymnastic
Apparatus) che ha nella stratificazione ritmica - afro, dub, kraut, ecc. - la sua spina dorsale e che si fa apprezzare per eclettismo e originalità.
Ancor più corposa l’esperienza Wintermute (Xabier Iriondo accanto alla batteria di Cristiano Calcagnile e
ai sax di Massimo Falascone). Episodio più latamente rock del lotto, mette in scena singulti e sbuffi tra artrock claudicante (Neuromancer) e impro-jazz deragliante (Molly, The Razorgirl), per un album corrosivo e
compatto. In Elliptical - Fotopartiture Per Tre Improvvisatori, Marco Ariano, Elio Martusciello e Gianfranco
Tedeschi aka Xubuxue interagiscono coi visuals di Pietro D’Agostino nell’accluso dvd per una perfetta
dimostrazione del legame genetico tra elettroacustica d’avanguardia e ricerca visiva concettuale.
Musica Improvvisa è un vero e proprio monumento alle musiche altre, un laboratorio in cui esperienze
ed estetiche differenti dialogano per riplasmare la musica dal di dentro. In un parola, un capolavoro.
(8/10)
Stefano Pifferi
43
nate per avvicinare la musica di Banjo erano e rimangono quelle dell’elettronica, del dream-pop e di certo
space-rock degli anni 90, opportunamente depurati da
ogni sontuosità e riletti in chiave più intimista, qui tale
caratteristica diventa spesso il trampolino per interfacciarsi con molto altro. Così, mentre 105 strizza l’occhio
a quell’altro italiano/nonitaliano di Jonathan Clancy,
Can’t Be Mad For Nothing ipotizza remix per gli stessi
Animal Collective; Move Out usa come pretesto il solito drumming di Just Like Honey per un folk languido
alla Cass McCombs; Dear Me declina le chitarre di Black
Scratches in un tunnel cosmico di rara suggestione.
(7.2/10)
Simone Madrau
Barbagallo - Quarter Century (42,
Gennaio 2011)
Genere: avant pop-rock
Tempo poche settimane ed al Quarter Century EP
segue un album intero che di quello riprende il titolo e ne completa gli intenti. Quattordici le tracce per
una scaletta che espande ulteriormente le coordinate,
stabilizzandosi in orbita ellittica sopra una Canterbury
robotica e lo-fi, spacciando patafisica e amarezze concrete, art wave e avant-jazz, folk-prog ed electro-ambient. Ai cinque pezzi già noti si aggiungono tra gli altri
episodi di ossessiva ebbrezza come il valzerino lunare
di Tx313, quella Great Sun che fa galleggiare lo spettro
di Syd Barrett in un cocktail Flaming Lips-Gastr Del
Sol, una Wake Up che battezza i Blur di spaesamento
Howe Gelb, l’estro power sclerotizzato di Town Calls,
il trip-hop accartocciato di Simon Templar e l’oppiaceo
lirismo futurista di The Crowd.
Se ti metti a contare i musicisti che hanno reso possibile l’impresa, fanno una ventina compreso il “padrone di
casa” Carlo Barbagallo. Un lavoro corale e perciò variegato, forse anche eccessivamente vario, tuttavia pervaso da una palpabile progettualità, da una sola smania
visionaria, quasi fosse la lucida frenesia espressiva di
chi non conosce altre vie d’uscita o comunque non altrettanto efficaci, gratificanti, necessarie.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Baroque - Rocq (Hertz Brigade, Gennaio
2011)
Genere: rock, glam
Una commistione sorprendente di hard rock, derivazioni dal glam dei ‘70, un certo gusto per il pop da cabaret
nonché, in modo evidente, per il prog e il beat nostrani:
questa è, in buona sostanza, la linea compositivo-deri44
vativa dei torinesi Baroque i quali, attingendo senza sosta da un universo musicale vastissimo, non mancano
comunque di una propria originalità conferita soprattutto da un’evidente bravura nel lavoro di composizione e arrangiamento. Dietro a una certa ingenuità, di cui
sono ricchi, soprattutto, i testi, questo Rocq è un lavoro
che si struttura in modo deciso, forte certamente delle
ottime capacità dei suoi autori nel lavoro sporco con la
strumentazione.
Filastrocchesco, danzereccio, istrionico e un po’ punk
nell’attitudine, ricorda Le Vibrazioni e le schiaccia, talvolta, per intuizioni melodiche non banalizzanti avvicinandosi ai migliori Decibel, quelli di Vivo da re. Capaci
di giocare con le voci e di scattare da chitarre ardite (la
festa dell’alloro) a pianoforti dandy (parlapetalo) in un
modo che di certo non dimentica i primi Queen (il camaleonte), i Baroque si dimostrano una realtà dall’insolita personalità, un progetto che senz’altro va tenuto
d’occhio.
(6.2/10)
Giulia Cavaliere
Bart Davenport - Searching For Bart
Davenport (Antenna Farms, Febbraio
2011)
Genere: Acoustic pop
Attraverso dodici riletture di brani altrui, Bart Davenport ci racconta la propria anima di cantautore soft,
innamorato tanto del sole della California quanto del
soul di Philadelphia, tanto del pop FM degli anni Settanta quanto del Brasile di Caetano Veloso. L’artista di
Oakland giunge alla quinta uscita solista, in una carriera cominciata nel 2002 e che dal 2006-2007 ha conosciuto una certa popolarità nazionale con il progetto di
una vera e propria band a nome Honeycut. Ma è con
il produttore del suo quarto album solista che si incrociano definitivamente i dati per inquadrare il personaggio. Per Palaces del 2008, infatti, siede in console quel
Kelly Stoltz che pochi mesi fa si guadagnava il plauso
della critica mondiale con il suo pop psichedelico.
Per un album di cover, qui rigorosamente eseguite solo
voce e chitarra, il vero valore aggiunto lo danno, oltre
che le capacità tecniche e interpretative, il gusto e la
classe. E Bart Davenport ne possiede quanto basta a riappropriarsi di brani molto lontani dal suo mondo di riferimento, come Better Days Ahead di Gill Scott-Heron
e Come On, Let’s Go dei Broadcast. Altre riletture sono
meno sorprendenti, come Cayman Islands dei King Of
Convinience o You Get Brighter dell’Incredible String
Band. Il ritratto delle influenze di Davenport mostra
però, se non proprio eclettismo, almeno varietà, tra la
highlight
Akron / Family - S/T II: The Cosmic Birth And Journey Of Shinju TNT (Dead Oceans,
Febbraio 2011)
Genere: folk-rock collettivo
Set ‘Em Wild, Set ‘Em Free era un disco della ricucitura, del dopo Gira, del dopo fuoriuscita di Ryan Vanderhoof. In fondo dichiarava qualche debolezza di una delle band più importanti degli ultimi dieci anni.
Gli AF non avevano mai temuto di essere semplici o complessi a seconda delle richieste del pezzo, e per
dirla tutta di come gli andasse in quel momento. In seguito al capolavoro Love Is Simple, però, hanno
avuto un po’ di timore di semplicità, come se essere eclettici fosse diventato
un dovere della family, come se tenere insieme le diverse anime del combo
fosse più difficile. Set Em Wild, Set Em Free era forse un modo di trattare
questa specie di lutto interno, per quanto la separazione da Vanderhoof ci assicurarono ai tempi - fosse avvenuta in termini sereni e consenzienti, e
infatti si sentiva, all’interno di questo eclettismo ricercato, un tono minore
nell’umore, anzitutto, una mancanza di vivacità colmata dalla complessità
dalla ricerca.
Con The Cosmic Birth And Journey Of Shinju TNT vanno diretti al presente, si presentificano cioè con un nuovo disco omonimo (dopo il primo) e con tutta la positività - e la compattezza di produzione - da trip buono di cui sono capaci. Tornano i cori, la chitarra poderosa (dall’iniziale
Silly Bears a So It Goes), la giovialità, l’euforia e la “collettività” 100% Akron/Family, su quel tema folk-rock
collettivo che tanto abbiamo battuto qui a SA. Una percentuale piena che non a caso va di pari passo con
un self-titled n° 2, l’esse-tì della maturità. Non c’è eclettismo ma un naturalissimo pescare nel variegatissimo ventaglio di possibilità che sta nelle corde Akron/Family e costruisce né più né meno che canzoni,
splendenti pezzi di melodia e lieta arguzia compositiva.
C’è poi un’altra arma, l’ironia: nel titolo, nel fatto di aver composto il vulcano di idee musicali in un vulcano
giapponese attivo (sull’isola di Hokkaido). Si prendono in giro da soli quando chiamano A AAA O A WAY un
bozzetto di coro (stereotipico) di repente trasformato in sofficissimo soul. E a scala più ampia i tre Akron
si rendono conto, da veri post-hippy, di quanto sia improbabile e improponibile essere realmente come
loro, e del resto chi del gruppo ha davvero (senza il distacco dell’ironia) fatto una scelta massimalista e
definitiva (vetero-hippy, forse) è proprio quel Ryan che ha deciso di separarsi dai compagni e di andare
a vivere in una comunità buddista. I superstiti rimangono su quella soglia che, quando ci trova a proprio
agio, diventa solare e canzoniera, senza perturbazioni e jam (i tre nel 2010 ci hanno già dato dentro in Totem 1, una sorta di replica di Meek Warrior, ma in sordina, pubblicato online qualche mese fa), e produce
dischi capaci secondo il produttore Chris Koltay di “trascendere le forze di Internet”. In grado, questo lo
possiamo dire anche noi, senza preveggenza, di dimostrare che la band è ancora nel pieno delle proprie
forze creative.
(7.4/10)
Gaspare Caliri
bossa di Maria Bethania (Veloso), il romanticismo corny
di Everyone’s In Love With You di David Byrne, il country
di Ramblin’ Gonna Be The Death of Me di Jansch o i Sixties di Wonder People dei Love. Poco meno di quaranta
minuti piacevoli. Non è questo il senso del pop?
(6.5/10)
Marco Boscolo
Ben + Vesper - HONORS (Sounds Familyre,
Febbraio 2011)
Genere: Pop oddities
Per la seconda prova sulla lunga distanza la coppia dal
New Jersey ritrova in console Sufjan Stevens, dopo
che li aveva già guidati nell’EP dello scorso anno, LuvInIdleness, ed era già apparso nell’esordio All This Could
Kill You del 2007. L’impressione, già sottolineata quattro anni fa, è di un duo ipersnob che sforna amenità
45
sotto forma di canzoncine pop che spesso prendono
direzioni impreviste (Knee-hi Wall), si accendono improvvisamente (l’iniziale Adult vAcA, Cheers Up, Cheers)
o si avvolgono su se stesse e scompaiono (Find Your
Friend, How Are You). Il fulcro del sound è l’intreccio tra le due voci, baritonale e scazzata quella di lui, più leggera e rotonda quella
di lei, sempre in precario equilibrio melodico. L’impasto
riesce talvolta in maniera quasi perfetta (Holly Home?),
assieme a una serie di piccole invenzioni sonore che
bisogna tendere l’orecchio per cogliere pienamente,
ma che rendono l’idea di chi li ha definiti “iene in stile
Disney che si ululano l’un l’altra”. Il culmine orchestrale
della titletrack è materia dall’ultimo Stevens, mentre
l’appena precedente Understruggle; Yay, Win gioca in
territori Mirah.
L’impressione è che i due sposini abbiano un sconfinata discografia di psichedelia, nuggets-delia, folk e pop
elettro-acustico e che di volta in volta decidano di scrivere nell’uno o nell’altro stile. Ne esce un pastiche che
se da un lato attesta la duttilità e le potenzialità dei Ben
+ Vesper, dall’altro non si incolla alle orecchie.
(6.5/10)
Marco Boscolo
Beppe Aliprandi Jazz Academy - Natura
morta con flauto (Ultra-Sound Records,
Dicembre 2010)
Genere: jazz
Beppe Aliprandi è un sassofonista dal percorso tutt’altro che lineare. Classe ‘39, ha professato jazz per tutti
i Sessanta e i primi Settanta prima in chiave hard bop
per poi darsi all’afro-cubana e confrontarsi con la tradizione di New Orleans. Quindi, dopo un lungo periodo
di stacco per dare sfogo alla passione per le arti figurative (vedi ad esempio l’immagine di copertina), ha
dato vita al Jazz Academy, una vera e propria “struttura
aperta”, un’accolita per musicisti con la voglia d’esplorare seguendo le mappe immaginifiche tracciate in un
passato più o meno remoto, comunque grandissimo.
Da allora Beppe è un’autorità apprezzata e riconosciuta a livello internazionale, e quest’ultima incarnazione
della Jazz Academy - un quartetto acustico composto
da vibrafono, contrabbasso e batteria oltre ai sax e al
flauto del leader - offre tutte le conferme del caso. Sostrati eterei, cangianti e inesorabili fanno da canovaccio per trame improvvise e meditabonde, come fosse
il suono dell’intelligenza al lavoro mentre abbozza atmosfere, ritratti, sensazioni, situazioni. Stilisticamente
in bilico tra post-bop e free, con qualche ammiccamento ai prodromi fusion della “via silenziosa”, è un disco
46
intenso e generoso, aperto con l’omaggio all’inesauribile Thelonious Monk (una strapazzata e irresistibile
In Walked Bud) e chiuso trasfigurando fregole latine
con Davito di Cal Tjader. Nel mezzo, sette originali che
smazzano eleganza obliqua (XYZ, Very Very Blue), verve
arguta (Limone e panna, Thelonious Hat) e rarefatta inquietudine (la title track).
(7.1/10)
Stefano Solventi
Black Eyed Peas (The) - The Beginning
(Interscope Records, Novembre 2010)
Genere: crook mesh pop
I Crookers non devono molto (moltissimo) al solo Kid
Cudi, ma anche a will.i.am, che si è innamorato del
loro suono, li ha promossi e si è fatto produrre e adesso ricambia il piacere con l’ennesimo blockbusterone
mesh pop blackeyedpeasiano mai come ora attento
ai fermenti anche di certe avanguardie dancefloor.
L’obiettivo - raggiunto - è sdoganare il suono Crookers
anche “per chi non sa”, apponendovi sopra il marchio
di immediatezza e affidabilità commerciale del gruppo
ammerigano.
Catchissima e furbissima, tanto sul versante broad che
narrow, nonostante l’abuso di autotune e qualche numero seriamente irritante (Xoxoxo), questa marmellata
pop a base di tastiere super-sature centra perfettamente l’obiettivo: divertimento, solarità, leggerezza.
Will mischia commercial hip hop di lusso (Kanye west),
electro-ragga, disco-funky (Daft Punk), ballad, filastrocchine e tormentoni (un finale quasi pooo-po-po-po-popooo-pooo), ricordi Ottanta&Novanta (New Romantics,
Flashdance, Avril Lavigne) e accelerazioni fidget (non
solo Bot & Phra ma anche Bloody Beetroots).
Sono fashion beats per le masse, ma will.i.am è tutto
fuorché uno sprovveduto, li cucina per bene, facendoli
funzionare alla grande, con tutte le strizzate d’occhio al
punto giusto.
(6/10)
Gabriele Marino
Boxer Rebellion (The) - The Cold Still
(Absentee, Febbraio 2011)
Genere: pop-rock
Strane cose accadono nell’era della Rete che tutto pervade e permette. Prendete i Boxer Rebellion, onesta band
di pop-rock scuro ed epico. Nel 2005 il loro primo disco,
Exits, funziona bene, ma non abbastanza da indurre la
Mercury a investire sul sophomore. I quattro si trovano
così a un bivio: mollare o andare avanti cercando un’altra strada. Optano per la seconda opzione, producendo
e registrando da soli, e mettendo in vendita via iTunes. Il
loro Union del 2009 è il primo disco della storia che riesce
a entrare nella Top200 di Billboard senza essere distribuito fisicamente, decretando un successo che li porta a
un cameo cinematografico in Going The Distance (Amore
a mille
miglia) con Drew Barrymore e Justin Long. L’attesa per il terzo disco, prodotto da Ethan Jones (Kings of
Leon, Ryan Adams, Ray LaMontagne), è stata piuttosto
alta, soprattutto in UK e USA. E dopo nemmeno un anno
dal precedente, eccolo questo The Cold Still, rilasciato
per la loro personale etichetta, la Absetee.
La cifra stilistica non si sposta di molto dal precedente
lavoro, mescolando sapientemente melodie e ritmi a là
Coldplay con atmosfere più scure e umbratili che furono dei primi Editors. Queste le coordinate generali, con
in più una ricerca dell’epica che funzionerà soprattutto
dal vivo, ma i Boxer Rebellion cercano di fare propri gli
Smiths mescolandoli ai Radiohead (Step Out The Car).
Mentre l’unico motivo per inserire in scaletta Both Sides Are Even è lo spot a cui faceva da colonna sonora la
scorsa stagione. Sarà un successo e accontenterà tutti
coloro che cercano una valida alternativa a Chris Martin e non tollerano più gli U2. Noi apprezziamo la cocciutaggine e l’onestà davvero indie che li ha portati alla
ribalta finora più importante della loro carriera, ma non
crediamo che lasceranno un segno duraturo.
(6.7/10)
Marco Boscolo
Caroline - Verdugo Hills (Temporary
Residence, Gennaio 2011)
Genere: indie-tronica
Sofficissime emozioni dovrebbero germogliare da Verdugo Hills, costruito con strategie che ricordano da vicino i tentativi più morbidi della Morr Music. Nella plateale ricerca delle ovvietà di certi stati d’animo sta però
il difetto principale di Caroline Lufkin (membra attuale
dei Mice Parade), e di quella voce angelica che fa presto a diventare pilota automatico.
Di buono, nel migliore dei casi (Waltz), c’è tutto ciò
che sta in mezzo tra la batteria elettronica di scuola
indie-tronica e il canto celeste e fiabesco di Caroline.
Raramente, però, i due elementi di cui sopra rinunciano al protagonismo, connotando l’impianto in modo
irrimediabile, non lasciando spazio a questo set di ballate dolci di trovare una forma propria, che pur a volte
cercano con una certa insistenza (Lullabye, Snow).
Il sophomore della Lufkin, probabilmente, sta lì a cercare un’approvazione che sa già da chi cercare, e non
vuole esporsi a un altro pubblico. Non c’è traccia della metà nipponica della giovane ugola, che da Boston
andò a Tokyo per scrivere il suo primo album. Ciononostante, chi avrà apprezzato Murmurs, opera prima
di Caroline, troverà forse il seguito coerente, ma anche
fatto con economia di idee narrative, di una storia, piena di delicatezza e di happy ending indie. I fan dei Mice
Parade, e tutti gli altri, arriveranno da un altro pianeta,
e con tutta probabilità ci torneranno.
(5/10)
Gaspare Caliri
Cave Singers (The) - No Witch (Jagjaguwar,
Febbraio 2011)
Genere: folk blues
Terzo album per la compagine Cave Singers, trio di
Seattle col pallino del folk blues rurale e la benedetta
impudenza di servirlo come il piatto del giorno. Formula che si è guadagnata considerevoli consensi coi
lavori precedenti, riproposta oggi in questo No Witch
mettendo a punto la calligrafia e testimoniando una
certa freschezza in fase di scrittura. Detto che le vibrazioni sembrano propagarsi sotterranee tra Appalachi e
Delta, i dodici pezzi sbocciano all’insegna di suggestioni che abbracciano le decadi con buona disinvoltura,
dal country asperso gospel vagamente Iron & Wine
dell’iniziale Gifts And The Raft al Mike Scott invasato
Black Keys della conclusiva No Prosecution If We Bail.
Nel mezzo, un bel po’ di umori Rolling Stones altezza
Beggars Banquet (le simpatie diaboliche di Faze Wave
e gli afrori d’hammond in Falls), estro Violent Femmes
con strattoni Fleetwood Mac (la notevole Black Leaf), il
piglio un po’ John Mellencamp e un po’ George Harrison (Clever Creatures) e certo retrogusto I Am Kloot
(Haller Lake) per non dire Gomez (la deliziosa Swim
Club). Ancora un album sostanzialmente riuscito, però
incapace - oserei dire per definizione - di scavare solchi
inauditi.
(7/10)
Stefano Solventi
Celer/Yui Onodera - Generic City (Two
Acorns, Novembre 2010)
Genere: Ambient, field recs
Il nuovo album dei Celer arriva da una neonata etichetta, la Two Acorns, curata dalla metà del duo Will Long e la cosa non ci stupisce data la prolificità della coppia.
In più, a inaugurare il catalogo troviamo un album nato
dalla collaborazione con Yui Onodera, che ha contribuito massicciamente alla cattura dei field recorder qui
presenti. L’intento di Generic City riguarda l’unione dei
frammenti sonori raccolti dai tre nelle rispettive location, Los Angeles e il Giappone, al fine di creare uno
47
streaming di natura e suoni urbani, di spazi e luoghi
che inglobano casualmente un passato, uno dei tanti (i
canti al Buddha), e lo restituiscono in una quotidianità
globale, a volte austera, spesso fascinosa.
In Generic City, il classico dronato Celer-iano incontra
vari momenti concreti, come i passi nella metropolitana, le conversazioni di adulti e bambini e una serie di
mezzi (automobili, tir, aerei, bicilclette). Filo conduttore è il flusso di coscienza, con una piccola novità, ossia
l’idea di imaginary tale onoderiana. In pratica, un progetto ampiamente riuscito: costruire una città generica - o meglio, sui generis -, non solo un’impersonale toponomastica sonora, ma un favola sopra un ambiente
familiare ma altro. L’ottimo Taylor Deupree al mastering completa un lavoro consigliato non solo ai soliti
frequentatori dell’elettroacustica ma anche a chi vuol
scivolare dall’ambient e dal post à la Dean Roberts a
queste lande senza farsi male.
(6.8/10)
Edoardo Bridda
Chain And The Gang - Music’s Not For
Everyone (K Records, Febbraio 2011)
Genere: root-rock
L’atto secondo di Ian Svenonius e dei suoi Chain And
The Gang è una marcia indietro a tutta birra. Nella ricerca del nocciolo garage del soulrock, con punto di
partenza New York, la combriccola non poteva che ritrovarsi nelle lande di una Motown svezzata e Dylaniata.
Le tipiche dinamiche nuggets sono lì vicino, ma forse
più che altro sfiorate: l’obiettivo sembra essere applicare una coolness asciuttissima propria del post-punk
più secco e deciso alla tradizione blues-rock. Come se
i Gang Of Four avessero lavorato con il blues al posto
del funk. Ian è uno che va sul sicuro (yeh-yeh è il suo
motto, come sottolineammo quando uscì Down With
Liberty... Up With Chains), e replica come innumerevoli volte si è fatto un rito scanzonato, divertito come in
un gioco di ruolo. Non a caso l’inno del disco è Detroit
Music, ossatura con riff d’attacco hendrixiano.
In copertina Svevonius compare in manette e dietro
le sbarre, ma in un completo che oltreoceano avrebbe fatto invidia a un mod. La metafora delle catene e
della schiavitù sembra raccontarci la storia di un’intensità sanguigna - quella del rock, obviously - che non ha
intenzione di uscire dal garage della Gang. Tutt’al più
concede raffinati richiami ai declamatori della New Vision (Allen Ginsberg su tutti) nella title-track.
La bravura di Ian e soci è di confezionare il revival senza
sembrare caricaturale. A queste condizioni, sappiamo
48
benissimo quanto un prodotto come questo stia in
piedi - e si venda - da solo. Ne hanno piena coscienza
anche i ragazzi dei Dub Narcotic Studios e della K Recs,
evidentemente.
(6.5/10)
Gaspare Caliri
Cheveu - 1000 (Born Bad, Dicembre 2010)
Genere: Weird Pop
Dopo l’antologia di demo e outtakes Cheveau del 2009,
secondo capitolo vero e proprio per il Capello francese.
Per l’atteso ritorno, i tre parigini smorzano la furia degli
esordi senza perdere il gusto deviato che da sempre
caratterizza le uscite d’oltralpe d’area weird-garage.
Segnato dalle sbilenche melodie di scuola Country Teasers, 1000 mette in campo una formula più ambiziosa
e una maggior dose di istrionica demenza metropolitana (Ice Ice Baby e Impossible Is Not French, praticamente
i Nirvana in versione synth-punk).
E’ un lavoro eccentrico e coloratissimo a partire dalla
copertina, una sorta di luna-park surreale in cui omaggiare/deridere i propri beniamini, siano essi esponenti
della vecchia scuola hip-hop, icone del rock da manuale scolastico o semplicemente tutti i degenerati postpunkers degli ultimi decenni. Non mancano nemmeno
le rumorose divagazioni (Sensual Drug Abuse e La Fin
Au Debut) ma è lo spirito ludico a risaltare in questo
odierno e travolgente burlesque.
(7.3/10)
highlight
Animation - Asiento (RareNoise, Gennaio 2011)
Genere: jazz / drum&bass
Ai più suonerà quantomeno blasfema l’idea di rileggere in chiave drum & bass Bitches Brew di Miles Davis.
Eppure Bob Belden e Tim Hagans sanno quel che fanno e non sono degli sprovveduti: il primo ex A&R
Blue Note e curatore dei remasters di Miles Davis per la Columbia, oltre che sassofonista e arrangiatore capace; il secondo trombettista sinuoso con tanto di nomine ai Grammy e uno
stile in bilico tra Freddie Hubbard e lo stesso Davis. Uniti dalla passione che
lega i proseliti al maestro - Hagans parla di Bitches Brew come di un disco che
gli ha letteralmente cambiato la vita -, quella che, trasposta in ambito rock,
deve aver animato un paio di anni fa i Flaming Lips nel momento di personalizzare un totem come Dark Side Of The Moon. A completare la formazione, vengono qui chiamati comprimari di lusso come DJ Logic alle basi, Guy
Licata alla batteria, Matt Garrison al basso, Scott Kinsey alle tastiere, per un
live trasmesso dalla BBC che ha tutto il sapore dell’esperimento riuscito.
Si tratta in realtà di una rilettura piuttosto fedele, nel senso che la struttura di base rimane quella dell’opera originale. A cambiare è semmai l’equilibrio tra i vari strumenti, con la tromba onnisciente del Bitches
Brew di Davis che in Asiento divide l’onere e gli onori con la parte ritmica. Quest’ultima un po’ il valore
aggiunto del disco, con l’asse Dj Logic/Garrison che impressiona per solidità matematica, presenza autoritaria e coordinamento, oltre che per il ruolo implicito di chiave di volta finalizzato all’aggiornamento
temporale del materiale. Tanto che se si eccettuano una John McLaughlin e una Miles Runs The Voodoo
Down la cui struttura fusion/funk fa un po’ da collante tra epoche e stili diversi, il resto è materiale vibrante
e tutto da scoprire. Musica che in Pharaoh’s Dance e nella title-track dà forse il meglio di sé, aggiungendo
nuove sfumature e insospettabili diktat all’impalpabile trascinante del Davis originale.
(7.3/10)
Fabrizio Zampighi
Andrea Napoli
Cristina Donà - Torno a casa a piedi (EMI,
Gennaio 2011)
Genere: canzone d’autore
Da Dove sei tu in poi è scattato qualcosa in Cristina
Donà che l’ha portata a mondare la sua musica da tutte quelle curvature avant che, in Tregua e soprattutto
Nido, avevano fatto delle sue inquietudini una questione (anche) formale prima ancora che contenutistica. Sintomo di una raggiunta maturità personale probabilmente, o forse semplice voglia di cambiare, sta di
fatto che il precedente La quinta stagione la vedeva
alle prese con una manciata di canzoni in bilico tra pop
e rock dalla geometricità cristallina e non poco razionalizzata. Come a voler incastrare quelle inquietudini,
certamente diverse ma non meno urgenti, in forme
strutturate e riconoscibili, talvolta classiche, lasciando
che fosse la sostanza di quest’ultime a penetrare piano
piano piuttosto che ad esplodere energica ed esterna
come in passato.
Torno a casa a piedi rimane su quella traiettoria, e
anzi in qualche modo la rafforza, ma allo stesso tempo
cerca di variare una tavolozza coloristica che a questo
punto rischiava di apparire stinta. Da qui il favore ad
un singolo atipico come Miracoli, pepperianamente
bandistico ad annunciare un uso ricorrente dei fiati, e
qualche altra scelta d’arrangiamento inattesa - portata dalla complicità di una figura come Saverio Lanza
(P.G.R., Biagio Antonacci, Piero Pelù), sulla carta assai distante dalla cantautrice milanese ma alla luce dei fatti
rispettoso del suo mondo com’è oggi: su tutte vedasi una Bimbo dal sonno leggero che con l’organetto di
Riccardo Tesi vira quasi al tango ipermoderno in zona
Gotan Project ma dimostra più che mai come all’origine di tali decisioni ci sia stata una particolare voglia di
libertà e alterità.
Tenuto presente questo, il sesto disco della Donà presenta però la titolare per quello che è, ovvero una delle
nostre migliori cantautrici in circolazione. Elegante ed
aerea nell’incantevole ballad d’amore Un esercito di alberi, folk senza eccedere per il levare mascherato di In
un soffio e nel retrogusto di fiati soul con vicinanza No-
rah Jones di Più forte del fuoco, chirurgica in una titletrack carveriana che racconta agglomerando dettagli
la fine di una storia d’amore fra due amanti. I tempi di
Goccia e Mangialuomo sono lontani e a qualcuno la
Donà di questo disco potrà apparire o troppo algida o
troppo lieve. Ma è lava che cova sotto il ghiaccio la sua,
un modo d’intendere la canzone che non punta al clamore ma attraverso tonalità medie prova a conficcarsi
scavando con pazienza, lentamente.
(7.2/10)
Luca Barachetti
Dargen D’Amico/Nic Sarno - Macrobiotics
- Balerasteppin (Autoprodotto, Gennaio
2011)
Genere: bastarDargen
Con in copertina le Muse di Giulio Romano, Dargen
mette su disco (registrato dal fondamentale onnipresente Marco Zangirolami, in free down ovunque sul
web) la collaborazione nata - tra il faceto e il faceto con il dj Nic Sarno (giro Crookers) per alcune serate mi49
lanesi. L’idea è quella del riciclo come unica via possibile, con un karaoke dargeniano in ottica cover/mashup,
e cioè Dargen a rappare i testi di alcuni più o meno
classici della canzone italiana su basi che in realtà sono
strumentali di vari produttori electrodancestepeccetera (una è di Rustie) opportunamente aggiustate.
Alcuni numeri sono semplicemente perfetti, per il taglio del trattamento: il funky di Impressioni di settembre
è trascinante, Adelante! Adelante! apocalittica, Vita spericolata giustamente smozzicata, Siamo Ricchi (Nannini) tamarro/Kraftwerkiana come non poteva non essere, La guerra di Piero e Albergo a ore (Paoli) quasi da
pelle d’oca. Il resto è sempre interessante (per orecchie
comunque allenate) ma non di uguale efficacia (latin
step Crookersiano per Banane e lampone, Oh angelo
mio della Bertè e Che storia è della Pausini). Gli skit hanno per sottofondo la musica di Almeno tu nell’universo
e uno in particolare presenta un botta e risposta dalla
famosa polemica TV (trasmissione di Renzo Arbore) tra
Lucio Battisti e un suo detrattore seduto tra il pubblico.
Aspettiamo altri volumi dal juke-box dargeniano, magari con i più difficili e ancora più dargeniani Battiato,
Camerini, Graziani.
(6.65/10)
Gabriele Marino
Deadpeach - 2 (Go Down, Gennaio 2011)
Genere: stoner-psych-rock
Disco di difficile interpretazione, questo 2. Il ritorno
del terzetto romagnolo mette talmente tanta carne al
fuoco che è arduo intravedere delle linee direttrici. Lo
stoner scorre sicuramente nelle vene del trio, e di quello bello possente. Diciamo di seconda generazione,
altezza Nebula per capirsi. Ad esso appartengono di
diritto numeri da circo come il panzer kyussiano virato
Fuzz Orchestra di L’Ora o quello dell’opener Cameriere,
tutto un susseguirsi di scatti in avanti e ralenti.
Poi tanta psichedelia. Di quella dura, muscolare e ipervitaminizzata, che flirta col fuzz di chitarra come nella migliore tradizione del garage-sound: ecco allora
i migliori MC5 in overdose sul palco con i Blue Cheer
(Universo) o le reminiscenze seattleiane più acide (dai
Soundgarden agli Skin Yard) di Nel Bosco. Un pizzico
di interesse in più lo fornisce la scelta del ritorno alle
vocals in italiano: dalle curiose aperture semi-prog ’70
che rendono ancor più intrigante il sound delle già citate Cameriere, Universo o di Non Sarà, alla filastrocca
post-Dadamatto di Le Scarpe Nuove offrono una cifra
personale e meno canonica nell’innesto della lingua
italiana su sonorità hard.
50
A fare veramente la differenza troviamo le due suitemonstre dell’album: Il Mattino (9 minuti) attraversa
psichedelia delicata e soffusa e pause prog con tanto
di flauto alla Ian Anderson con esplosione rock-funkettona; mentre lo strumentale conclusivo Bombay se la
gioca di drone e loop, tra mantra e raga.
Disco difficile, sfaccettato e anomalo in un panorama a
volte troppo cristallizzato. Bravi.
(7/10)
Stefano Pifferi
Decemberists (The) - The King Is Dead
(Capitol, Gennaio 2011)
Genere: songwriting
Dopo l’articolato concept british folk The Hazards Of
Love che nel 2009 aveva dato nuova linfa ai Decemberists (senza contare sempre in materia di folk opera, il
terzultimo The Crane Wife), il loro leader Colin Meloy
riparte azzerando tutto e semplificando musica e attitudine del gruppo. Il nuovo The King Is Dead (Smiths
eh?) è un album di canzoni folk rock, perlopiù acustico
e molto R.E.M.: come ospite fisso troviamo infatti Peter
Buck, che ha arrangiato anche alcune parti di chitarra e
mandolino, e sul solco dell’Americana, Gillian Welch.
Fra riferimenti UK (i già citati Smiths) ma soprattutto
USA (si vedano qua e là gli omaggi assortiti al buon
Neil Young, a Bob Dylan, a The Band e ai Byrds), Meloy ricostruisce la propria epopea rock delle radici, mostrandoci le personali preferenze e ribadendo la sfida
che quest’album ha rappresentato: dopo tanta tradizione inglese apparsa nei precedenti album, un ritorno
alle radici americane dell’autore, semplici canzoni brevi di tre minuti per sbrogliare le complesse epopee folk
del passato. “Realizzare musica semplice ha rappresentato veramente una scommessa, ci siamo trovati spesso a
dover fare esercizio di semplificazione, non è stato affatto
facile come si può pensare
”. Come si dice in questi casi?
Less is better...
(7.2/10)
Teresa Greco
Deerhoof - Deerhoof vs. Evil (Polyvinyl
Records, Gennaio 2011)
Genere: ethnoschizopop
Un paio di anni fa, avevamo lasciato i Deerhoof sulla
strada che loro stessi hanno inventato, quella che, nonostante i walzer di collaboratori, di membri, di equilibri tra gli strumenti e i generi, è a tutt’oggi il lascito (ormai passato?) del combo. Si discuteva ancora di pop vs.
non pop, strutture complesse vs. garage. Era appena
arrivato Ed Rodriguez, come seconda chitarra, e l’ab-
bandono di Chris Cohen sembrava metabolizzato.
È difficile pensare ora - nell’album numero 12, se non
13, considerando una pubblicazione online - a un brusco cambiamento, e in effetti Deerhoof vs. Evil è un disco
inequivocabilmente riconoscibile come Deerhoof-iano.
Ci sono sempre strutture che cambiano, complessità,
e quel sound da Bay Area (Behold a Marvel in the Darkness) che porta il loro marchio da ormai quindici anni,
quando Rob Fisk e Greg Saunier (quest’ultimo ancora
all’attivo nella band, e decisivo in ogni senso) misero a
punto i primi singoli.
Nel crogiolo di opposizioni, e nella lotta tra lo zoccolo e
il demone, abbiamo però un vincitore. Non è la schizofrenia, ma la melodia. Non vince ai punti, ma in quanto
punto di vista dominante - e questa è una novità non
da poco. Non si tratta di pop e non pop, né di caramelle
o carbone. Si discute di gerarchie. I Deerhoof non guardano più con le lenti di una complessità schizzata verso tutti i generi, ma sembrano oggi scrutare la diversità delle opzioni e delle strutture con il cannocchiale
della melodia (The Merry Barracks). Di conseguenza, le
canzoni vere e proprie crescono di numero - pur non
mancando le sterzate musicali - e si impongono come
momenti importanti del disco (I Did Crimes for You), finendo col deliziarci come fossero novelli brasiliani extropicalisti (Must Fight Current). Fa il gioco del branocanzone la pubblicazione, nel countdown dell’uscita
del disco, di un brano in streaming al giorno in un sito
web di nazionalità ogni volta diversa.
La conclusione è la stabilità. E di dischi così, a questo
punto, i Deerhoof potrebbero farne altri dodici.
(7/10)
Gaspare Caliri
Demdike Stare - Tryptych (Modern Love,
Gennaio 2011)
Genere: electro occulta
Voices Of Dust è il terzo album del 2010 per i superproduttivi Sean Canty e Miles Whittaker. Dopo Liberation
Through Hearing e Forest Of Evil (riproposti nel pacchetto riassuntivo Tryptych per completezza) con le voci
della polvere si conclude un anno che ha visto salire
le quotazioni della musica horror applicata all’electro
(vedi la witch house di Salem, Modern Witch, oOoOO)
e al dubstep (i Demdike, appunto).
Ad un ascolto iniziale non c’è molta distanza con l’avanguardia storica della musica elettronica (l’opener Black
Sun è un misto di Pan Sonic e di Studio di Fonologia
Musicale di Milano), ma in seguito la proposta si situa
a metà strada tra un’ammirazione delle atmosfere dub
- che gente come DJ Rupture coniuga da tempo con
l’ambient sporcata di etergoeneità etno-ambient - e la
pesantezza del doom-drone di Sunn O))) & Co. (Leptonic Matter). Il tutto mescolato alla progressività delle
colonne sonore anni Ottanta di Vangelis (Repository
Of Light) e di un sentire dub che in Pole e nelle prove
più ardite della Basic Channel trova illustri prodromi.
L’amore per il cut-up quasi selvaggio non nasce comunque dal caso. Canty è il boss della label Finders Keepers, che tra le altre cose promuove la ristampa di musica horror di colonne sonore dei film di Dario Argento.
I due Demdike sono poi da molti anni collezionisti di
dischi infatuati di mistiche alternative (vedi la citazione
al Libro tibetano dei morti nel titolo dell’EP Liberation
Through Hearing) che va di moda oggi: solo nel 2010
sono emersi infatti numerosi progetti affini, come i video dei Mater Suspiria Vision, le mutazioni post-dub di
Shackleton e le colonne sonore di Umberto e dell’Ensemble Economique. I Demdike riportano tutto a
casa, preannunciando un genere che deve ancora essere catalogato. Per questo pur non proponendo grosse novità, segnano una delle possibili vie per il futuro
di quella che per non sbagliare possiamo continuare a
definire come ‘musica elettronica’.
(7.2/10)
Marco Braggion
Deniz Kurtel - Music Watching Over Me
(Crosstown Rebels, Marzo 2011)
Genere: Deep, house
La ragazza turca, nel giro Wolf+Lamb da un po’ di anni
oramai, esce per Crosstown Rebels con il suo primo
long playing, Music Watching Over Me che suona come
un lavoro di solido revisionismo. House memorabilia,
citazionismo Kraftwerk, tocchi psych e fuori programma digi-ambient, sono tutti segni di un’esperienza
decennale a New York tra installazioni artistiche e frequentazioni del Marcy Hotel.
Nell’album troviamo tagli più canonici (Best Of) che si
mescolano ad angolazioni psych ereditate dal marchio
Wolf + Lamb, e soprattutto ottimi dosaggi chiacagodetroitiani; come a dire, i groove della Windy City e
la tecnologia meccanica della Motor City (mixati alla
grande nel supersingolo The L Word).
Nella seconda parte infine buone visioni prog cinematiche per synth Settanta e un’uscita dalla strada maestra (il ritmo garage britannico in Trust): tasselli molto
probabilmente ereditati dalla sua frequentazione come
light designer agli show brooklyniani della premiata
ditta Wolf + Lamb.
Dopo le prime prove un po’ ingessate (Whisper EP e il
singolo Yeah) la Kurtel brilla oggi di luce propria e con51
highlight
Anna Calvi - Anna Calvi (Domino, Gennaio 2011)
Genere: folk blues rock
Padre italiano e madre inglese. Più o meno venticinquenne. Piuttosto bella, ottima presenza scenica,
grande voce, profilo ammaliante. Dichiara di ispirarsi a Jimi Hendrix e Debussy, al mai troppo rimpianto
Captain Beefheart e a Maria Callas. Si è fatta largo nell’immaginario dei rockofili romantici d’Albione col
singolo Jezebel, vecchio pezzo dall’esotismo impetuoso portato al successo da Edith Piaf. Ha già avuto
modo di aprire i concerti dei Grinderman di Nick Cave e a questo punto
è impossibile non citare affinità e convergenze che la fanno sembrare un
potente succedaneo di PJ Harvey.
Di più: Anna Calvi potrebbe incarnare la Polly Jean che parecchi fan avrebbero desiderato dopo l’autodafè pseudo-blues di To Bring You My Love:
nella realtà dopo di allora la ragazza del Dorset si mise a trasfigurare il proprio idioma consegnandosi alle fregole bristoliane per poi misurarsi con
turgori mainstream. Se invece avesse dato fondo alla vena più teatrale, ai
languori mediterraneai e alla decadenza mitteleuropea, magari - chissà - ne
sarebbe uscito qualcosa di molto simile a pezzi come First We Kiss o No More Words. Del resto l’ucronia è
una pratica in uso da sempre in ambito pop-rock, dagli Echo & The Bunnymen che ipotizzano i Doors
negli Eighties agli Audio 2 che consolano gli orfani del Battisti mogolliano.
Comunque la si voglia vedere, l’ampiezza del ventaglio stilistico e l’armamentario espressivo definiscono
la Calvi come cantautrice di tutto rispetto (altrimenti, presumo, Rob Ellis non si sarebbe scomodato a
co-produrne questo omonimo esordio). Le dieci tracce in scaletta formano un rosario avvincente: Desire
sembra cuocere nello stesso calderone impeto Smiths e abbandono Scott Walker, Blackout non spiacerà
ai devoti del verbo Arcade Fire, The Devil bazzica suggestioni Nina Simone via Jeff Buckley, I’ll Be Your
Man è il pezzo che la Harvey e il Re Inchiostro si sono scordati di scrivere, Love Wont Be Leaving è la pira
tex-mex che consuma tutti gli struggimenti di cui sopra.
Sembra persino troppo bello per essere vero. Voglio dire: se fosse un fenomeno costruito a tavolino,
avrebbero fatto un fottutissimo gran lavoro. Ecco.
(7.3/10)
Stefano Solventi
ferisce quel tocco femminile leggero e anticonformista
ad una produzione usualmente machista, come in altri
lidi avevano testimoniato le creazioni di Dinky, Magda
e Anja Schneider. Denitz is playing at my house.
(7.2/10)
Edoardo Bridda, Marco Braggion
Dimlite - My Human Wears Acedia Shreds
(Now Again, Gennaio 2011)
Genere: glitch hop/wonky
Dimlite continua a bilanciare culto del timbro e motivetti (“forma-canzoncina”), wonky curatissimo (KittyCradle-Fog) e capacità di mostrare il farsi struttura del
pezzo, partendo da premesse quasi sempre scollatissime, al limite del found sound. Continua a rifinire il
proprio tocco, con un feel caldo e suonato qui come
mai vicinissimo alla fusion anni Settanta (stessa ope52
razione di Flying Lotus, ma Dimlite ci pare già molto
più a fuoco; Metal-Snake-Rider è molto Heliocentrics;
Loins super-percussivo, psichedelico, orientaleggiante). Quattro nuove perle (compreso uno squarcio di sospensione elegiaca tutto piano, tastiere e piatti sottili,
Gone-O-Tron), in attesa di un nuovo grande album.
(7/10)
Gabriele Marino
Dirtbombs (The) - Party Store (In The Red
Records, Febbraio 2011)
Genere: cover album
Se si parla di libertà creativa, beh, con Mick Collins non si
sbaglia mai. Già in Ultraglide In Black - omaggio alla sua
maniera alla black music - l’uomo dietro Gories e Blacktop aveva dimostrato di giostrare con un universo di
riferimento più ampio di quello che potesse ipotizzarsi
guardando il suo background coi paraocchi dell’integralismo. Ora Party Store fa il paio con quell’esperimento al tempo parso estemporaneo, solo che stavolta a finire sotto la lente deformante del chitarrista è il sound
techno di Detroit, la motor city americana che tanto ha
dato al garage e al punk e nel quale Collins è cresciuto.
Quasi che così facendo volesse omaggiare l’intera cultura musicale della sua città.
Ecco allora che i Dirtbombs prendono classici più o meno
noti della techno detroitiana anni ’80 e li rimodellano a
modo loro: Good Life degli Inner City (il progetto di Kevin Saunderson), la Sharevari targata A Number of Names, la Strings of Life di Derrick May o ancora la Alleys of
Your Mind dei Cybotron di Juan Atkins, insomma, i veri e
propri riempipista dell’epoca vengono completamente
rielaborati, risemantizzati, ricontestualizzati dalla band
del gigante nero in forme “rock”. Ne è perfetto esempio
la riedizione di Bug In The Bass Bin della Innerzone Orchestra di Carl Craig (presente ai synth nel rifacimento)
risolta in una megasuite mantrica di 20 minuti dall’incedere funk-motorik e dalle atmosfere algide e rumoriste.
Una operazione particolare, sentita e personale, magari fuori tempo massimo se riferita alle commistioni
p-funk o ai vari crossover techno-rock che andavano
per la maggiore verso la fine del millennio scorso, ma
fondamentale per apprezzare ancor di più uno spirito
libero come quello di Collins. Ce ne fossero di altri.
(7/10)
Stefano Pifferi
Drive By Truckers - Go-Go Boots (Pias,
Febbraio 2011)
Genere: americana
Si annotava già nella recensione del precedente The
Big To Do quanto i Drive By Tuckers abbiano la musica
“nel DNA”. Fuor di metafora, la formazione guidata da
Patterson Hood, infine stabilizzatasi a solido sestetto,
ha saputo trasfondere la passione profonda che ne guida l’agire in un lavoro a tempo pieno, faticando passo
dopo passo e approdando alla ATO dopo una dozzina
d’anni, forte di un seguito costruito battendo ogni angolo della madrepatria statunitense. Questo il punto
quando si è alle prese con l’Americana: dimostrare conoscenza della materia e abilità esecutiva necessarie a
non scadere nel mestiere, o peggio ancora cadere preda dell’oleografia; rischio che i Nostri non corrono, poiché non si entra in sala d’incisione assieme a Booker T.
e Bettye Lavette per caso, né si chiama alla consolle
l’ex-Sugar David Barbe.
Occorre stoffa per temprare una penna che oggi guadagna ulteriore rispetto in scia al nume tutelare Tom
Petty, influenza sapientemente trattenuta nei confini
dell’omaggio e qui al vertice nell’omonimo blues felpato, nell’impolverata Ray’s Automatic Weapon e in una
nuova Breakdown intitolata The Thanksgiving Filter. Altrove spetta a The Band o ai Flying Burrito Brothers
infilarsi in una scaletta compatta nonostante oltrepassi
l’ora di durata, altrimenti alle dilatazioni di Used To Be
A Cop e The Fireplace Poker sottolineare lo spirito di chi
non vuole annacquare il proprio suono per inseguire
chissà quale successo.
Caparbietà e riservatezza che basterebbero a premiarli
e lo stesso dicasi per Go-Go Boots, riassunto di carriera
robusto e romantico anche a prescindere dall’ambito
di riferimento.
(7.1/10)
Giancarlo Turra
Duran Duran - All You Need Is Now (Tape
Modern, Dicembre 2010)
Genere: synth pop
Per la loro tredicesima fatica, i Duran si affidano a Mark
Ronson. Scopo? Rifarsi il trucco sonico con il culo parato. Nel 2007, c’erano stati Timbaland e Timberlake
a tentare l’improbabile spolvero; nel 2011, nemmeno
con l’aiuto di Kelis e di Ana Matronic delle Scissor Sisters si riesce a tirar fuori qualcosa degno della loro
eredità.
Abbiamo appreso da varie interviste che il disco avrebbe dovuto essere il successore del mitico Rio, eppure
un proseguio, oltre che a portare un suono perfetto e
limato, dovrebbe almeno risplendere di luce riflessa.
Potremmo anche soprassedere sulle citazioni e sugli autoplagi, arrivando a capire come sia automatico
esaltarsi (e far esaltare) in ricordo dei vanagloriosi Ottanta; non transigiamo invece sulla patina di stantìo e
di pacchiano che mostra il suono rimodernato con i tools contemporanei: nello scimmiottamento industrial
nella strofa della title track, nella copiatura (che non
ce la fa’) dei Depeche Mode in Blame The Machines,
nella pomposità barocca della pseudoballad conclusiva Before The Rain e in molti altri punti che vi lasciamo
scoprire non c’è nemmeno il buon senso di prendersi
in giro, o la capacità di creare un oggetto da classifica
(come ad esempio riescono bene a fare Mika o la Gaga
di turno) o la cura maniacale dei giovani hypnagogici che con i suoni dei papà stanno da un po’ di tempo
sbancando anche il mainstream.
Sperando che sia stato il numero tredici a portare un
po’ di iella, aspettiamo il prossimo. Ma anche no.
(4.5/10)
Marco Braggion
53
highlight
Aucan - Black Rainbow (La Tempesta International, Febbraio 2011)
Genere: electro-rock
È una vera e propria enciclopedia delle elettroniche degli ultimi 20 anni, il sophomore del trio bresciano
formato da Dario Dassenno (batteria), Francesco D’Abbraccio (chitarra, synth, effetti) e Giovanni Ferliga
(synth, voce, chitarra e sampler). Black Rainbow non somma e basta ciò che è rintracciabile nelle influenze
musicali del progetto, ma rielabora, fonde e confonde suggestioni, atmosfere e slanci in un magma personale. Portishead, witch-house, Autechre, nurave, hauntology, Warp, industrial, Planet Mu, dubstep si sfiorano, si toccano
e copulano in un percorso che risulta alla fine riconoscibilmente personale.
Proprio come nell’immagine di copertina: una esplosione di colori diversi
che si fa paradigma del prisma sonoro tendente al nero racchiuso in Black
Rainbow.
L’apertura spetta a Blurred, una bassa battuta impreziosita dalla voce di Angela Kinczly ed è subito spiazzante. Torna a galla l’Inghilterra dei primi ’90.
Bristol per l’esattezza. Clangori industriali e voce suadente per un pezzo da brividi. Heartless - prossimo
video e singolo - si ricollega subito a DNA, l’ep lungo che è vero embrione degli sviluppi del sophomore,
col suo interplay tra synth volatili e batteria corposa calati in atmosfere da mood dimesso e notturno.
Ma la carne al fuoco sacro e rituale dell’album è molta di più: evanescenze goth-bombastic quasi witchhouse (Sound Pressure Level), idm primi ’90 in salsa impro-electro (Embarque), iridescenza tribal-ambient
(In A Land), dubstep non canonico e posseduto (Away), bassi gonfi di scorie dub e cadenza da rave postnucleare (Storm). Eccola la chiave di volta dell’intero album: l’electro del dopo-electro, il suono della cattedrale in dissoluzione, il dancehall del day after.
Black Rainbow è un disco oscuro e screziato, potente e denso, perfettamente equilibrato e magistralmente prodotto dallo stesso Ferliga (il guru della nu-electro Matt Colton provvede a masterizzare). Un disco in
grado di rivoltare l’elettro(ck) di questi anni dal di dentro e lanciare una sonda verso il domani.
(7.4/10)
Stefano Pifferi
Earth - Angels of Darkness, Demons Of
Light 1 (Southern Lord, Febbraio 2011)
Genere: psych americana
La reinvenzione dell’americana avvenuta ormai un
buon lustro fa, all’altezza di Hex; Or Printing In The
Infernal Method, fu sicuramente uno scarto non indifferente per chi aveva apprezzato l’innovativa musica (e)statica dei primi dischi targati Earth. Quel suono
eterno, denso, drogatissimo che tanti avrebbe influenzato e mosso a suonare una nuova forma di musiche
pesanti, si scindeva in uno stillicidio di psichedelia della provincia americana più southern-gothic possibile.
Da allora il percorso di Dylan Carlson & co. è rimasto
invariato e Angels of Darkness, Demons Of Light 1 ne è
l’ennesimo ideale anello.
Lievi variazioni di line-up - della partita sono anche
Lori Goldston al violoncello e Karl Blau al basso - non
incidono in maniera significativa sull’ormai acquisito
canone dei “nuovi” Earth: lunghi, ritualistici orizzonti
54
lisergici e dilatati paesaggi western da dopo-bomba
che sono una vera e propria liturgia, ipnotica e visionaria, del nuovo sentire musicale del baffuto chitarrista.
Si respira sabbia e disperazione, solitudine e tradizione
in quantità nei solchi di Angels of Darkness, quasi fosse
una versione personale del Dead Man neilyounghiano.
Stesso impatto visionario, stessa capacità evocativa,
stessa monotonia di fondo. E stessi fondali.
Ormai il percorso verso una nuova forma di psichedelia rurale è tracciato, le sperimentazioni d’inizio carriera
dissolte, perciò inutile recriminare. Non resta che questo. Prendere o lasciare.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Edipo - Hanno Ragione I Topi (Produzioni
Dada, Novembre 2010)
Genere: electro pop
Forse il cantautorato (in) italiano si sta sbattendo per
trovare una risposta significativa alla lucida e nevrastenica gravità de Le Luci Della Centrale Elettrica, quella risposta che nemmeno lo stesso Brondi è riuscito a
dare (a darsi). Tra Amari e Amor Fou passando da Non
Voglio Che Clara ed il sorprendente Dimartino, non
mancano motivi per ben sperare. Quanto a Edipo, al
secolo Fausto Zanardelli, con questo album di debutto
sembra voler reagire alla tenaglia di cupezza & intensità con un disarmo ad alzo zero, generazionale e cazzone, un po’ come il Bugo della fregola electro alle prese
con arguzie paracule Daniele Silvestri.
Hanno ragione i topi sembra il diario impressionista
dell’universitario sperso, tra illuminazioni pigre e seghe
mentali acidule, lo spasmo digitale ed il riflesso automatico indie-rock. La tentazione del demenziale dietro
l’angolo, l’insostenibile pesantezza del dover essere,
il gusto del calembour nerd. Tra canzonette poco più
che simpatiche col retrogusto amaro che non le riscatta (Appartamenti, Per fare un tavolo), spuntano ipotesi
para-psych (Un nuovo concetto di thè, Sospendimi) che
lasciano intravedere possibilità ancora da esprimere.
Attendiamo senza troppe aspettative, ma attendiamo.
(6/10)
do d’un regalo mancato a Patty Pravo con Non mi hai
fatto male e la chiusura con il godibilissimo funky-pop
spaziale di Parabole lasciano con la richiesta di un posto per loro almeno nel novero di quegli autori importanti per altri.
Ecce homo non è un capolavoro, non lo è per una
qualche prevedibilità sotterranea ma ancora presente (il lascito Matia Bazar di Con stile non li salva da un
ennesimo calco baustelliano) e per una serie di liriche
incentrate sulla mediocrità imperante dell’individuo
italiano che finiscono spesso nella didascalia - mentre gli Egokid sono grandi quando con pari vitalità e
struggimento cantano d’amore. Tuttavia siamo dinanzi
al lavoro di una band in progresso, meno bizzarra di
un tempo e più concentrata su un percorso che ha già
dato e darà ancora dei frutti. Seguiamoli. Anzi: lassù nei
palazzi, seguiteli.
(7/10)
Stefano Solventi
Dall’esordio Migrations al sophomore Humus, Errante
ha inseguito un’idea fissa: dipingersi ambient artist
facendo ambient music nell’era post-laptop. Con un
rigore e coerenza invidiabili, il musicista campano ha
perseguito questo scopo con una serietà e visione
d’insieme che l’ultimo Brian Eno non ha avuto, posizionando la propria arte lontano dai concettualismi e
dalle astrazioni, dalle tentazioni dark di moda e dai rimpasti idm di ritorno. Il segreto del nuovo Time Elapsing
Handheld non sta pertanto in un nuovo azzeramento
delle distanze tra mente e spazio, immagine e pensiero
ma nella contaminazione ampiamente assimilata nei
mezzi (parti acustiche e parti elettroniche/digitali) e
nell’organico funzionamento dell’insieme.
Lo troviamo ad osservare gli ultimi avanposti della trasfigurazione post in Leaving The Nowhere (la cui umbratilità defluisce definitivamente ogni urgenza avant
verso un’idea di classicità cercata e possibile), nei luoghi magici del west altro dei Matmos in Made To Give
(brano nato dalla collaborazione dell’ottimo Simon
Scott degli Slowdive), oppure confrontarsi con la classica musica per film di enoiana memoria nelle magiche
Counterclockwise e Dorian’s Mirror (di cui è disponibile
anche il videoclip).
La firma Karaoke Kalk mette l’ultimo sigillo al miglior
album di Errante finora, musicista coerente e decisamente maturato dagli esordi. Time Elapsing Handheld è
una soundtrack della memoria. Un adult stream of con-
Egokid - Ecce homo (Novunque, Gennaio
2011)
Genere: pop d’autore
La musica pop è un esercizio patologico, ne sanno
qualcosa gli Egokid e il loro citazionismo midollare fin
dagli esordi in inglese. Ma fortunatamente non tutte
le malattie vengono per nuocere, e a salvarli dai rischi
del precedente Minima storia curativa - prima release in italiano due anni or sono: quasi una brutta copia
dei Baustelle degli inizi, con liriche che cantavano una
gaytudine in frangenti fin troppo autoreferenziali - arrivano qui una serie di input ad hoc per canzoni scritte
come si deve e con la giusta necessità.
Al retaggio bianconiano delle iniziali L’uomo qualunque e Credo (quest’ultima in vero con un qualcosa fra
il beat italico e gli Smiths) Piergiorgio Pardo e Diego
Palazzo oppongono infatti una quaterna centrale di
quelle che ti ricordi: Come un eroe della Marvel love ballad sessantiana in traiettoria Bindi - Non Voglio Che
Clara; Ragazze+ragazzi cover omaggio ai Blur rivisitati
con déjà-vu glitterato; Non si uccidono così anche i cavalli? semioscuro anthem new-wave con addirittura
Fausto Rossi come ospite; Sirene quale nuova rincorsa con sorpasso ai Clara per un lento perfetto addosso
alla Vanoni che s’illanguidisce dolorante su fondali di
voci di un Morricone argonauta. Più in là poi l’azzar-
Luca Barachetti
Emanuele Errante - Time Elapsing
Handheld (Karaoke Kalk, Febbraio 2011)
Genere: Ambient
55
sciousness per il 2011 (Dal 7 marzo nei negozi virtuali
e non).
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Enrico Coniglio - Salicornie: Topofonie
Vol. 2 (Psychonavigation, Novembre 2010)
Genere: ambient
Se artisti come Fennesz rielaborano l’ambient in micro-porzioni di elettronica che si accavallano per generare un nuovo tessuto sonoro, musicisti come Enrico
Coniglio vanno in tutt’altra direzione, scegliendo invece la scenografia e la narrazione come linguaggio
privilegiato. Nessuna vena sperimentale o tendenza
avanguardista, insomma. Semmai lentezza e sviluppo
nell’ottica di una musica rarefatta ma profonda, capace
di giocare con le suggestioni che nascono dall’unione
di classica, jazz e looping.
In Salicornie: Topofonie vol. 2 (seconda puntata di una
serie di opere ispirate alla laguna di Venezia) si sommano chitarre minimali, pianoforti, violoncello, tromba, organi, glockenspiel, mini gong, synth e field recordings (il vociare e le campane in Angels Of San Marco,
le funi che si tirano e il legno di Fondamente Nove Incl.
130 cm s.l.m.). Per dar vita a un’opera “suonata” che ha
un sapore orchestrale tutto particolare, nel suo essere
disciplinata, corposa (settanta minuti per tredici brani)
e a conti fatti piuttosto conservatrice.
(6.5/10)
Fabrizio Zampighi
nero senza il minimo accenno di incertezza, ma anzi
con un’energia ruvida e creativa, che non si sentiva da
anni in questo tipo di sonorità. Già l’ep di debutto, su
sei brani vanta almeno due piccoli classici (Marching
Song e About This Peninsula, per non parlare della micidiale Skeleton Swoon contenuta nella compila Dance
to the radio), che da sole basterebbero a ridicolizzare
decine di band che hanno pensato bastasse copiare i
riff dei Sisters Of Mercy e il canto psicotico di Peter
Murphy, per costruirsi un’identità. Gli Esben di contro,
pur non inventando nulla, riescono a creare perfetti
congegni pop (anzi “nightmare pop” come li chiamano
loro) usando il linguaggio del gotico inglese come fosse
una grammatica.The Marching Song cos’altro è se non
la loro Spellbound, rallentata, inacidita e astutamente
inquietante nella sua fissità ritmica? E il riferimento ai
Banshees torna con insistenza nel corso del disco, non
foss’altro che per il taglio veemente e glaciale dei vocalizzi della cantante Rachel Davies, novella dominatrix
dark, che da sola fa metà disco alternando cupa crudeltà (Chorea) e malinconiche verità (Eumenides, Swans).
La produzione di Daniel Copeman completa l’opera intervallando abilmente elettronica e chitarre, riverberi
ed echi, in un modo che a tratti li porta dalle parti di
una Bjork arcigna ed austera (Light Streams, Hexagons
IV) o meglio ancora di una Bat For Lashes per adulti
(Warpath). Violet Cries è un altro esempio perfetto di
come nella pop music nulla si crea e nulla si distrugge,
ma tutto si trasforma.
(7.2/10)
Antonello Comunale
Esben & The Witch - Violet Cries (Matador,
Gennaio 2011)
Genere: nightmare pop
Vengono da Brighton e dipingono tele inquiete usando tutti i colori del buio. In un momento di evidente
ritorno per le sonorità neo-gotiche, tanto nei fenomeni
più o meno “under” come Zola Jesus e la witch house, quanto in quelli più commerciali e pop con il taglio
sempre più eighties di produzioni come Bat For Lashes
e The XX, Esben and the Witch sembrano capitare talmente alla perfezione che il sospetto di operazione costruita furbamente da qualche homo marketing viene
quasi automatico. I dubbi vengono dissipati dalla sostanza delle idee e dei suoni che i tre muovono. L’eppì
dell’anno scorso aveva spinto qualche penna lungimirante a parlare di next big thing, la firma successiva per
Matador e il conseguente tour con Zola Jesus hanno
spinto verso l’hype, in maniera tanto classica quanto
efficace.Il suono dei ragazzi di Brighton si riallaccia in
maniera devota alla più solida tradizione britannica del
56
Etnoritmo - Dall’acustico all’elettrico
(Galletti Boston, Novembre 2010)
Genere: etnofolk
La musica popolare italiana è un ambito tanto sotterraneo quanto affollato e non è un caso che un outsider
come Paolo Farina, arrivato qui al terzo disco a nome
Etnoritmo, non abbia ancora raccolto quanto meriti.
Dall’acustico all’elettrico (titolo fin troppo didascalico) raccoglie dieci canzoni firmate dallo stesso Farina,
cinque inedite in fogge semiacustiche e cinque arrangiate (anche) con strumenti elettrici ed elettronici
riprese dal precedente Tondomondo. Da grande conoscitore della tradizione musicale pugliese, e in particolare di quella che caratterizza le zone di Castellana
Grotte con relativo dialetto, Farina si tiene lontano da
ogni possibile folklorismo e multiculturalismo banalizzante, piuttosto inietta piccole dosi di modernità o di
cultura altrui in una tradizione rinnovata con rigore e
freschezza.
Così se l’iniziale Ball i ball, da un riddim di A sud a sud
di Teresa De Sio, è tradizione riscritta all’insegna della
classicità, Vijn cu mmei ospita darbouka e flauto irlandese mentre Mijnz a chiazz e Mamm ind’a cucein cercano una via fra pop acustico e cantautorato mescolando
storia locale e onesto neorealismo ad alta gradazione
emotiva. La parte elettrica invece avvicina Etnoritmo
alle coincidenze fra musica popolare antica e contemporanea dei Nidi D’Arac, seppur con una minore
spinta sul beat e un maggior uso di citazioni e campionamenti (da Eugenio Bennato, Matteo Salvatore,
Radiodervish ed Enzo Del Re: in pratica una specie
di carta d’identità musicale). A tal proposito piacciono
molto Nan c’ ste’, travolgente con la sua ritmica quasi
urban, e la conclusiva Tijmp d c’ros, crogiolo di dialetti
con ospiti Lele Battista, Canio Loguercio e Enrico Capuano a rilanciare un culto delle identità che faccia da
collante anziché no.
(7/10)
Luca Barachetti
ché continuino a prenderne spunto.
Dentro tali binari, Something Is Dirty somiglia a volte
(Tell The Bitch To Go Home) ai tanto bistrattati anni del
dopo Faust IV, certamente minori (di parecchi gradini)
ma capaci di far annidare una disumanizzazione sincera (Whet, Dampfauslass 1), meno intelligente, forse,
ma molto efficace e diretta alla corteccia dell’ascoltatore. La chiave, come anticipato, è il rumore, una saturazione noise, una predilezione verso la distorsione
forse mai così insistentemente perseguita dalla band
(in questa formazione), tanto da rendere l’album quasi muto, a forza di saturarlo. C’è spazio solo per un accenno di emotività (Herbststimmung è un crescendo
- quasi Mogwai-ano!- di chitarre distorte e meccanica
percussiva), tutto il resto è sporcizia radioattiva, come
nelle migliori famiglie che non si concedono compromessi. Se non sapessimo che per i diretti interessati la
musica non è nient’affatto una cosa seria, questa volta
ci sembrerebbe che i Faust ci credano davvero.
(7/10)
Gaspare Caliri
Faust - Something Dirty (Bureau-b,
Gennaio 2011)
Genere: krautrock
Le due facce dei Faust si contrappuntano. Dopo l’addio proclamato da Hans Joachim Irmler (Faust Is Last),
il testimone passa a Jean-Hervé Péron e Zappi W. Diermaier, di fatto i maggiori depositari (in termini quantitativi) del marchio, almeno negli ultimi anni, live compresi.
Va da sé che il suono dei Faust odierni dipenda dalle
personalità che se ne prendono carico. Something
Dirty somiglia profondamente alla mole di Zappi.
La sua batteria pachidermica, i metalli percossi, sono
un’avvisaglia che percorre il tessuto ritmico di tutto
l’album, ne detta la cifra stilistica. Parimenti, il sapere
krauto Péron-iano, fatto di synth chitarre e fiati, è uguale a se stesso eppure sempre scientifico, specie quando si sceglie l’opzione del rumore. Come da copione,
non mancano i coadiuvanti, in questo caso - come nel
2007 - James Johnston e la voce femminile di Geraldine
Swayne (in un valzer di contributors a cui dai Novanta i
due krautrockers ci hanno abituato).
I Faust sono ormai un incedere, un modo di procedere,
che potrebbe non finire mai. Una postura nel cammino
tra l’uomo e la macchina, anzi, ancora, un motore antropomeccanico propulsivo che agisce su di sé e sugli
innumerevoli altri che a quel motore si sono ispirati. I
Faust prendono parola per se stessi, dopo aver fatto da
cassa di risonanza per la storia della musica, ma non di
meno rinnovano una pratica da lasciare agli altri, per-
Fausto Balbo/Andrea Marutti Detrimental Dialogue (Boring Machines,
Novembre 2010)
Genere: electro-kosmische
Uno dei più sottovalutati dischi d’elettronica dell’anno
appena trascorso è opera di due veterani della scena
italiana e vede la luce grazie all’ennesima collaborazione tra label (Boring Machines, Fratto9 e la AFE di mr.
Marutti).
Le quattro lunghe tracce di Detrimental Dialogue sono
tutto fuorché un dialogo dannoso tra i due sperimentatori. Concepite con un lungo procedimento di registrazione a quattro mani ed elaborazioni in solitario,
sempre in modalità rigorosamente analogica, le composizioni sono caratterizzate trasversalmente da un isolazionismo di matrice kosmische limitrofo all’ambient
più scarnificata e droning, e da una taratura retro-futurista che sembra la risposta al negativo delle istanze di
tanta neo-new age sentita in giro ultimamente. Come
se l’hypnagogic più elettronico e synthetico fosse finito sul lato oscuro della luna in mano a sperimentatori
onnivori e inarrestabili. O come HAL 900 avrebbe immaginato la soundtrack per il suo viaggio di morte ai
confini dell’ignoto.
Passaggi rarefatti e diafani, diluiti e ovattati come in assenza di gravità si alternano in suite in cui ogni singolo
suono, loop o frammento sonoro è calibrato meticolosamente e mai fuori posto. Minaccioso anche nei molti
momenti di stasi, Detrimental Dialogue è la colonna
57
sonora più plausibile per l’oscurità dello spazio più
profondo e dell’assenza di vita. Da suonare a volume
altissimo per apprezzare il certosino lavoro di scultura
sonoro attuato da Marutti e Balbo.
(7.3/10)
Stefano Pifferi
Fujiya & Miyagi - Ventriloquizzing (Full
Time Hobby, Gennaio 2011)
Genere: Space pop
Dal semisconosciuto Electro Karaoke in the Negative
Style ai fasti del 2006 in piena epoca space-disco con
i singoli di successo come Collarbone (da Transparent
Things di quell’anno e nella pubblicità della Jaguar),
Oh (da Lightbulbs, traccia scelta nella serie tv di culto
Breaking Bad) e pop song felpate e deliziose come Knickerbocker e Pickpocket. La storia dell’allora duo e ora
quartetto Fujiya & Miyagi, con il presente Ventriloquizzing, sembrerebbe alle battute finali.
Passato il momento hype dovuto ai Pitchfork e agli
NME, ma anche alla stampa specializzata di mezzo
mondo, cosa ne resterà di questa Beta Band aggiornata alla space disco norvegese cresciuta a krautrock e
tastiere anni Settanta?
Sulle prime la quarta prova sembra fallire l’obbiettivo:
non solo mancano i potenziali singoli ma è anche la
leggerezza melodica che da sempre contraddistingue
il progetto di questi simpatici nerd a venir meno. I quattro, come gli Hot Chip di qualche tempo fa, guardano
giù nel dark e settano il motorik su strofe pronunciate
sottovoce tra citazioni del Barrett solista (Pills) e visioni
Blade Runner (Universe). Quando all’ascolto subentra il
lato sperimentale della faccenda emergono i dettagli
più interessanti: le sfumature testuali germogliano e
dagli scioglilingua di gelati o lesti taccheggi nascono
insoliti mondi popolati da ventriloqui che non respirano e da pupazzi oscuri che non vivono di vita propria,
che si muovono a comando.
La produzione per la prima volta è condivisa: F & M
compaiono assieme a Thom Monahan, ingegnere e
musicista che ha lavorato principalmente per Devendra
Banhart e che qui si limita sostanzialmente al ruolo di
assistente. Il lavoro di squadra è certosino e non cerca
clamori: punta alla qualità del prodotto di genere che
ha superato le mode. La lezione che va da Vangelis agli
Air più virgin suicides fa emergere giochi di sponda con
i conterranei Depeche Mode (Sixteen Shades of Black
& Blue è un synth pop ribaltato, surreale e cameristico proprio come la loro copertina retrò raffigura) e più
in generale un nuovo inizio con un batterista che apre
a scenari inediti (soffusioni pianistiche e i ritmi para58
d’n’b in Ok, i Pet Shop Boys dandy urbani degli esordi
rimpinguati in Minestrone, i Suicide teardroppiani citati
in Tinsel & Glitter).
Nessuno stravolgimento del segreto del loro successo, eppure i ragazzi si sbilanciano molto nel racconto
suonato: i nuovi F & M sono più teatrali, introspettivi,
tenebrosi ma ancora maledettamente sinuosi e felini.
Disco di transizione comunque riuscito.
(6.8/10)
Edoardo Bridda
Get Up Kids (The) - There Are Rules (Quality
Hill Records, Gennaio 2011)
Genere: Guitar pop
Il complimento più sincero che mi sento di fare ai Get
Up Kids è che non suonano affatto come li ricordavo. Il
reunion album della band che più di ogni altra ha definito i confini del genere più vituperato dell’ultimo decennio, non poteva scottarsi al principio del “rompete
le righe” che ha caratterizzato più o meno tutti i campioni dell’emocore.
Basta questo a salvare la baracca? Ovviamente no. Melodie svenevoli e dilemmi da geek sono sempre dietro
l’angolo; nel loro caso, poi, non si limitano fungere da
mere coordinate estetiche, ma costituiscono la natura
più intima di un modo (stucchevole) di intendere la
musica. In questo senso, There Are Rules le prova un
pò tutte per cercare nuove strade.
I Get Up Kids tirati a lucido funzionano quando recuperano l’urgenza di un guitar pop punkizzato, diretto e
potente, con brani che non fanno in tempo ad avvilupparsi in un melodismo di maniera. Peccato che da un
gruppo che esce da sei anni di iato, sarebbe stato lecito
aspettarsi un maggiore scarto rispetto alla sua produzione più recente.
Dal canto loro, i cinque provano a traghettare il disco
dalle parti di un pop moderno e maturo, ma è qui che
falliscono miseramente l’obbiettivo: quando seppelliscono la maggior parte dei brani fra posticce stratificazioni electro e arrangiamenti wave, o cercano soluzioni
arty per colorare i soliti turgori giovanilistici. Certamente un’occasione persa, ma d’altra parte “ci sono regole”
a cui è difficile sottrarsi.
(5/10)
Diego Ballani
Gionata - In nove mosse (Hansia Records,
Dicembre 2010)
Genere: pop d’autore
La terza prova del cantautore del Canton Ticino riassume l’andamento a dir poco altalenante dei due pre-
highlight
Destroyer - Kaputt (Merge, Gennaio 2011)
Genere: soft-rock, jazz-pop
Malinconia sciropposa, arguzia sorniona, inquietudine felpata, un vasto, agile, carezzevole disincanto. Nel
nuovo e nono album sotto l’egida Destroyer, il caro Dan Bejar costruisce la più soffice strategia destabilizzante che sia lecito attendersi. Lo fa guardando al soft-rock, al blue-eyed soul, alla disco-funk, all’acid-jazz,
ricorrendo ad astrazioni spacey e folk asprigno per addensare un impasto
gelatinoso che sa farsi umorale e a tratti amniotico. Melodie che galleggiano
con nonchalance sull’ordito agile di synth gassosi, tastierine vivaci, fiati allusivi (tromba, sax, flauto) e chitarrine ormonali. Tutto un immaginario sonoro
retrodatato, quasi fosse un gettarsi nell’abbraccio consolatorio di certi (ipotetici) Eighties, il rifugio da un presente corrotto, appassito, inaccettabile.
Bejar ha dichiarato d’essersi ispirato a nomi (e numi) quali Bryan Ferry, Ryuichi Sakamoto e Gil Evans, e ci può stare. Ma le coordinate (cui potremmo
aggiungere Jim O’Rourke, Giorgio Moroder, Ariel Pink, Brian Eno, Belle
And Sebastian, Edwin Moses...) alla fine contano meno della sintesi, che acquista senso ed efficacia proprio in quanto tale, ibrido di incantesimi vagheggiati, miraggio di valori smarriti, di attonita, vitrea, fatua
sensualità. E’ un modo decisamente morbido di rappresentare la decadenza dell’Impero, missione per la
quale la voce dal demiurgo dei New Pornographers (ben assistito dalla vocalist Sibel Thrasher) sembra
possedere il timbro e l’atteggiamento più adatti: una narratività strascicata da crooner disilluso, una resa
letargica all’indolente rassegna di visionari (e subdolamente caustici) nonsense.
La palpitazione tenue di Blue Eyes, la pulsazione danzereccia di Song For America, l’allucinazione dolceagra delle title-track, la disinvoltura pseudo-wave di Savage Night At The Opera e soprattutto il caracollare
trepido ed espanso di Suicide Demo For Kara Walker, sono forse i momenti migliori di un album che modula frequenze e vibrazioni senza allontanarsi dal solco emotivo centrale. Per la sua capacità di spacciare allarme e consolazione, di cullarti mentre t’inocula un sottile sgomento, e tenuto conto delle diverse
premesse e finalità stilistiche, mi sembra affacciarsi sugli anni Dieci come fece Yankee Hotel Foxtrot lo
scorso decennio. Ed è una sensazione che mi piace.
(7.7/10)
Stefano Solventi
decessori. Un piccolo gioiellino di italo pop l’esordio Si
può essere un’alba (tanto che allora qualche network
radiofonico s’accorse meritatamente di lui), un tonfo di
canzoni spuntate, autoreferenzialità e un filo di spocchia il successivo Daytona, a rappresentare Gionata
come autore controverso, capace a stretto giro di quasi
capolavori e sostanziali patacche.
In nove mosse, dicevamo, fa il riepilogo, anche per
quanto riguarda le influenze, vedasi quell’alternarsi
di synth-pop analogico, cicaleggi funky e amenità disco che è la cifra del titolare, ma anche perché da una
traccia all’altra si trova la stessa instabilità qualitativa
dei dischi meno riusciti di certi outsider del nostro cantautorato (Fortis, Giurato) ed è innegabile che l’indole
di Gionata, più che l’identità musicale effettiva, sia da
avvicinare a costoro.
Insomma è un saliscendi continuo. Happy boy con la
sua piacevolezza mediana a mentire su una successiva e salvifica aurea mediocritas, Le cose facili azzoppata
da un testo banale e prevedibile, Tu vali! risolta in un
godereccio disco-funky-pop nonostante un altro testo
da rifare, Di più attraversata da una bella intimità cantautorale e il synth ad albeggiare al posto del ritornello (una citazione da Impressioni di settembre?), Credo
in Disney nuovamente funky e synth-pop con testo e
melodia a dir poco stentorei. Da qui in poi è la volta
delle carte migliori, a partire da una Lola variegata su
più influenze dopo un inizio esaltante in quadratura
Battiato ottanta e volteggi d’archi e proseguendo con
una Giorno sì in ricami di acustica, sentore d’elettrica
Radius e ritornello in grazia battistiana.
Ovviamente il finale è con lo schianto di una torch song
secondo lui, titolo La mia avenue, con elegia di archi e
fiati che aggiungono (melo)dramma a (melo)dramma.
59
Che qualche testa esterna intervenga almeno per tagliare col machete certe zizzanie testuali: Gionata è
uno dei maggiori talenti sprecati degli ultimi anni, una
cometa da indirizzare affinché non si spenga.
(6.3/10)
Luca Barachetti
Giovanni Peli - Giovanni Peli EP
(Kandinsky, Dicembre 2010)
Genere: cantautorato
Poeta e librettista, il bresciano Giovanni Peli - classe
‘78 - può vantare in repertorio svariati album autoprodotti lungo i famigerati anni zero. Il presente EP omonimo rappresenta quindi una sorta di debutto ufficiale
ed è forse il pezzo migliore dei cinque usciti nella serie
Eureka2 della Kandinsky. Un pugno di tracce che alla
disinvolta pregnanza dei testi - storie minime, meditazioni, situazioni - abbina una bella sensibilità musicale
e melodie accorte.
Echi sparsi di De André, Tenco e Fossati, vaghe suggestioni Fred Neil e Tim Hardin, restando ad ambiti più
recenti potrebbe sembrare un Filippo Gatti frugale o
una versione (parecchio) pacata dei Marta Sui Tubi.
Insomma, quello di Peli è un andare oltre la semplice
narrazione in musica per abbracciare il mistero e la potenzialità della canzone.
Notevole biglietto da visita, aspettando conferme sulla
lunga distanza.
(7/10)
Stefano Solventi
Giuliano Dottori - Silenzi ep (Via Audio,
Dicembre 2010)
Genere: canzone d’autore
Tre tracce in acustico a poco più di un anno di distanza da Temporali e rivoluzioni per Giuliano Dottori.
L’esperienza del precedente disco, elegante e intenso
senza strafare, con Giovanni Ferrario alla produzione,
sembra aver giovato al chitarrista degli Amor Fou, che
conferma un tratto del tutto privo di sbavature anche
asciugando al massimo gli arrangiamenti. La title-track
e il tre quarti Cuore di bue, entrambi accorati, ricordano il Moltheni folkeggiante, ma è una scrittura sempre
più personale quella di Dottori, mentre l’indole da novantiana che era definisce contorni autonomi e fecondi. Alla prossima, con prerogative sempre migliori.
(7/10)
Luca Barachetti
60
Go! Team (The) - Rolling Blackouts
(Memphis Industries, Gennaio 2011)
Genere: Hip Hop Dance Groove
Non più hype da un bel po’ di tempo, i Go! Team si
presentano comunque alla prova del terzo disco senza
alcun sostanziale cambiamento. Le immagini evocate
dalla musica del gruppo sono le medesime di sempre:
il sole di un mattino d’estate che splende sulle strade
ancora deserte del quartiere di Harlem a New York;
campi da basket, Muhammed Alì e la musica che immagineremmo oggi se ancora potesse calcare un ring;
un melting-pot di razze con l’asfalto nel proprio DNA;
e poi un’orchestra black, ma black nel senso più puro e
tradizionale del termine, che improvvisa una specie di
parata per le vie di un qualche ghetto; percussioni, fiati
sparatissimi, funk del più acido; cori di bambini; elettronica mandata in loop; e una voce che quando non apre
verso Belle And Sebastian (Secretary Song), tropicalismi (Super Triangle) e (j-)pop (Buy Nothing Day), mette
insieme rime con l’isteria dei migliori Beastie Boys.
Questi ultimi suonano come un’influenza anche sul piano degli intenti: anche qui, infatti, l’idea è quella di seguire un percorso personale e al di fuori delle mode. Ancora
incapaci di sfornare un Ill Communication (o più verosimilmente un Hello Nasty, che dei Beastie era il disco più
meticcio) il sestetto di Brighton esce con un lavoro che
non è quindi decisivo ma godibile quanto i precedenti,
spesso leggero ma in una maniera che piace.
T.O.R.N.A.D.O., non a caso primo singolo e prima traccia dell’album, lo dimostra egregiamente: una botta
di energia necessaria per combattere l’uggia dei mesi
freddi laddove l’hip hop celestiale della splendida
Apollo Throwdown profuma già di estate. Ricordatevene quando di dischi ‘importanti’ avrete fatto il pieno e
girerete in maniche corte con un gelato in mano.
(7/10)
Simone Madrau
Gr3Ta - Gr3Ta (Bagana Records, Febbraio
2011)
Genere: elettrock, post-punk
ANdREA, polistrumentista attivo discograficamente sin
dal 2001 con gli Unwelcome, ha raggiunto una certa
fama con una seconda incarnazione discografica (Kessler) con la quale ha condiviso il successo del tormentone Teoria del Vuoto e quello di critica con Un Altro
Giorno D’Amore (prodotto da Riccardo Tesio dei Marlene Kuntz). Durati giusto il tempo di un ellepì ciascuno,
i due progetti hanno lasciato il posto a una realtà più
solida: i Gr3Ta esordiscono nel 2008 con il buon Please
Kill Me per l’americana Renaissance Rec./Koch, poi ar-
rivano diversi remix ed ora un sophomore a sancire il
valore di progetto importante nel panorama italiano (e
non solo).
Parliamo di un ibrido ruvido ed abrasivo in Gr3Ta. Pezzi
compatti. Tutti singoli potenziali. Materia pulsante che
parte dall’estetica dei primi Nine Inch Nails e percorre
la transgenetica cyberpunk dei Novanta, dalle metamorfosi (s)he di Marylin Manson agli attacchi frontali
degli Young Gods. Non solo, impressionante come
ANdREA vada a segno giocando sui groove piuttosto
che sull’effetto speciale, l’elettro la maneggia tanto
bene (gli Autechre d’annata Untitled) quanto poi fluido
risulta l’innesto di chitarre trattate, basso cavernoso,
drumming pesante o settato.
Discreta bomba questi Gr3Ta che puntano alle Pretty
Hate Machine e alla TV Sky dei citati svizzeri con i quali condividono anche un altro prefisso, la techno-rock,
label per una musica che abbraccia l’intero spettro di
certo post-industrial fino ai precursori post-punk.
La girandola di nomi e riferimenti è vorticosa e ha fatto la storia della contaminazione tra certo alt. rock con
un’altrettanto incompromissoria live-tronica. ANdREA
(voce e testi, chitarre, synth, programming, produzione)
e la sua band - Cristiano (live drums, programmazione beat), Daniele (basso e cori) e Ago (chitarre) - in
quest’omonimo album hanno i mezzi e i groove per
entrare a pieno titolo nel filone maestro della cultura
cyber e del suo ritorno anni zero, sia sotto forma revival post-punk che versante dancefloor (vedi Dj Hell,
Ny Muscle per citarne uno). Lui la chiama Ugly Pop. Noi
confermiamo la statura del progetto. E attenzione alle
voglie elettrock italiane: gli Aucan anche loro pronti
con una discreta bestia contaminata...
(7.3/10)
Edoardo Bridda
Gruff Rhys - Hotel Shampoo (Turnstile,
Febbraio 2011)
Genere: psych-pop canterbury
Uno splendido quarantenne, le sue manie, la capacità di farne manufatto curioso anzi prezioso. Gruffydd
Maredudd Bowen Rhys - Gruff per gli amici - è il leader
dei Super Furry Animals da oltre due decadi, da un
pezzo ha il vizio di collezionare le bottigliette di shampoo degli hotel, e da un lustro a questa parte si diletta
a sfornare - impegni permettendo - album solisti. Tutto ciò è il prologo e il contorno del terzo lavoro a suo
nome, Hotel Shampoo, realizzato in contemporanea
all’installazione omonima (ovvero la suddetta collezione di mini-shampoo) esposta al Chapter Arts di Cardiff.
Che uomo curioso. E che bel disco. Sobrie trovate sin-
tetiche, archi, pianoforte, tutta una fregola canterbury
in salsa chamber-pop, contorno psichedelico e sparsi
umori francesi.
S’inizia dal singolo Shark Ridden Waters, cinematico ovvero godardiano (produce Andy Votel) , un po’ quello
che Badly Drawn Boy potrebbe sfornare se recuperasse confidenza cogli sciropposi fantasmi sixties (in
questo caso, un sample da It Doesn’t Matter Anymore,
pezzo di Bacharach coverizzato dai Cyrkle nel ‘67). La
restante dozzina mette in fila una collana variegata e
flemmatica di morbide prelibatezze, dal soffice estro
Robert Wyatt (la deliziosa inquietudine di Sophie
Softly e Space Dust, quest’ultima in coppia con - chi si
rivede! - El Perro Del Mar) alle trepide suggestioni Beach Boys (l’allucinato sdilinquimento di Rubble Rubble,
lo splendido abbandono versante Kinks di Honey All
Over) passando per gli struggimenti Belle And Sebastian via Left Banke (Take A Sentence), power pop sfrigolante (i Suede patafisici di Patterns Of Power) e certo
stomp come lo rivisiterebbe Jim O’Rourke (Conservation Conversation). E che dire dello zampillio tex-mex di
Sensation In the Dark e dei languori armoniosi - il piano,
gli archi, il sax morbidone - della stupenda Vitamin K?
C’è voglia di intrattenere con gusto, di costruire gradevoli ordigni curati nell’aspetto e in profondità, bramosi
di ritagliarsi ambiti estetici fieramente desueti. Per rivendicare l’appartenenza ad un tempo, un mondo, una
dimensione dove il pop è sogno palpabile, stile di vita,
modalità emotiva. Hotel Shampoo è un piccolo capolavoro che ti riconcilia, almeno un po’, con le cose del
mondo.
(7.4/10)
Stefano Solventi
Holiday In Arabia - Holiday In Arabia EP
(Mad On The Moon, Giugno 2010)
Genere: dance / wave
In fatto di trasversalità i mantovani Holiday In Arabia non hanno nulla da imparare, come sottolinea un
primo Ep che riesce a ben conciliare in quattro branimanifesto, dance, ambient, psichedelia e new wave. I
rimandi non sono molti ma spiccano in grassetto: dai
Daft Punk chiamati a gestire le casse dritte e l’elettronica avvolgente ai Joy Division via Depeche Mode di
Dirty Pleasures, dagli ambienti dancefloor spacey ipotizzati dagli Ottanta sospesi di Budavari al post-punk
gravido e espanso della conclusiva Gravitation.
Roba che i fan dell’elettronica più di ricerca snobberanno ampiamente, visto e considerato che qui dentro,
di nuovo, non c’è nulla. Materiale che invece chi con
gli Ottanta sintetici e più di confine traffica volentieri
61
highlight
in un’accorata ballata pianistica (Never Alone).
Ne risulta un attestato di classe e godibilità somme che
le giovani generazioni dovrebbero prendere a esempio.
(7.1/10)
Hercules And Love Affair - Blue Songs (Moshi Moshi, Gennaio 2011)
Genere: house, electro
Un magma di nostalgie newyorchesi e quindi house. Il sophomore della creatura di Andrew Butler riempie il vuoto che il post-Blind aveva lasciato. Anche senza Anthony, ma con il fresco contributo di Kele
Okereke dei Bloc Party, della cantante venezuelana Aerea Negrot, del collaboratore ed ex-fan Shaun
Wright e del produttore Mark Pistel (Meat Beat Manifesto), le undici tracce
sono comunque tutti potenziali singoli: il disco risulta essere un sussidiario
del meglio che la cultura sintetica ha prodotto in questi ultimi trent’anni.
L’eredità disco (Falling), il synth pop di Jimmy Sommerville (Painted Eyes
con quell’entr’acte mitopoietico da urlo che è il verso Elegance / you were
born at night) mescolato a suggestioni discoidi con gli archi in visibilio Philly,
la deep-echo garage che trasuda dai muri dei club della grande mela (My
House, questa volta senza i Daft Punk dell’amico James Murphy), gli inevitabili Ottanta (Leonora), la puntatina bucolico-folk per il dopo party casalingo
(Boy Blue), i Kraftwerk del periodo Computer Love (Visitor), le atmosfere derivate dalla lezione di Arthur
Russell (il clarinetto cameristico di Blue Song), il basso e il bbreaking dei Novanta (Step Up) e per chiudere
la new age dei Narada e della Windham Hill Records tutta (la ballad It’s Alright).
Tecnicismi a parte, questo lavoro ha due features che lo elevano istantaneamente a rango di piccolo grande classico: si ascolta dall’inizio alla fine e soprattutto si ascolta ovunque. Al club, al bar, in macchina, in
cuffia, in corsa, in divano e pure in sauna. Praticamente fa quello che l’esordio aveva annunciato (e che
purtroppo molti emuli della DFA non sono riusciti a perseguire nell’immediato seguito): porta la cultura
da club nel mainstream pop di classe. È quindi perciò godibilissimo anche per chi non ha nulla a che fare
con i sintetizzatori o le casse dritte. In più non servono droghe per capirlo. Nel contempo ha in sè una coscienza storica invidiabile, che esalta ancora una volta l’avventura del virus dance nord-americano. Cosa
vuoi di più dalla vita?
(8/10)
Marco Braggion
potrebbe eleggere ad ascolto privilegiato. In attesa di
un disco lungo che possa confermare le prime buone
impressioni.
(6.6/10)
Fabrizio Zampighi
Jonny - Jonny (Pias, Febbraio 2011)
Genere: pop enciclopedico
Bella per certi versi la vita del musicista. Se ti annoi, puoi
telefonare a qualche amico e collega e metter su un gruppo con lui. Questa la premessa dietro ai Jonny (niente “h”,
mi raccomando), al secolo Norman Blake - cantante e leader dei favolosi Teenage Fanclub - ed Euros Childs, già
a capo di quella dolce stramberia tipicamente gallese che
furono i Gorky’s Zygotic Mynci. Sai cosa attenderti dal
loro background, considerando che entrambe le formazioni distillarono brillantemente una personalità dal passato senza arrendersi alla nostalgia. Ha pagato, in termini
di durata nel tempo, quel loro schivare le vacue baruffe
62
“brit” per concentrarsi sulle Canzoni e fabbricare uno stile
impastando Beatles e Big Star, Beach Boys e Neil Young
con sentimento e trasversalità.
Cavalli di razza che conoscono la storia e il valore della
scrittura, i due varavano il progetto nel 2006 e lo concretizzano ora - dopo l’e.p. di riscaldamento Free dello scorso novembre - in un album che diverte anche chi ascolta
e non si nasconde dietro un dito; che anzi fa della propria
franchezza forza e lo stesso valga per i citazionismi e le
deviazioni dal percorso, gli indizi di paternità e le robuste dosi d’ironia di cui è cosparso. Può così spaziare disinvolto da bubblegum che non induce carie (Candyfloss)
a glam in bassa fedeltà (Which Is Which), da un Rubber
Soul maturato sotto il sole californiano (Waiting Around
For You) a sfrenati garage-pop (Goldmine). E già che c’è,
offrire del folk-rock che batte i Coral sul loro stesso terreno (You Was Me, Circling The Sun) oppure apre squarci sui
primi 70 (Bread), ipotizzare suite degne di un Pet Sounds corretto a krautismi (l’ottima Cave Dance) e rifugiarsi
Giancarlo Turra
Joy - Joy (Le Son Du Maquis, Febbraio 2011)
Genere: chamber pop
A dispetto del nome, di gioia in questo album ce n’è
davvero poca. Il titolo si riferisce a un profumo creato
in piena depressione post-1929 da Jean Patou e per la
cui produzione sono serviti petali di gelsomino e rosa
in quantità inenarrabili: un lusso sfacciato in uno dei
periodi di più grande miseria della storia occidentale.
Ed è proprio in contrasti come questo che bisogna andare a cercare la chiave di interpretazione nella musica
di Marc Huygens (già noto con il suo progetto decennale Venus, di cui era frontman e principale autore),
Françoise Vidick (anche con i dEUS) e Anja Naucler:
brani all’incrocio tra echi Novanta à la Radiohead e Sigur Rós, e il chamber pop più raffinato e notturno.
I protagonisti del sound dei belgi sono essenzialmente
due. Da una parte l’intreccio delle voci di Huygens e
Vidick, che per timbro e tessitura sembrano sempre dipingere tutto in un bianco e nero d’epoca. L’altro è il violoncello della Naucler, capace di sottolineare in modo
perfetto le intuizioni cinematiche e cinematografiche
della scrittura. L’anima dei Joy, però, deve ancora essere messa del tutto a fuoco. A noi pare che le atmosfere
mittleuropee e cameristiche di Flag e N° 7 o l’impeto
quasi Cream di Mirage funzionino molto meglio degli
eccessi barocchi in scia Muse di Sword. Huygens, la Vidick e la Naucler non sono alle prime esperienze musicali e il tempo sarà un ingrediente fondamentale nella
crescita del progetto Joy e il definitivo affrancamento
dai Venus. Per il momento godiamoci una metà abbondante di disco che testimonia una scrittura e una sensibilità armonica superiore alla media.
(6.6/10)
Marco Boscolo
Joycut - Ghost Trees Where To Disappear
(PillowCase Records, Febbraio 2011)
Genere: Post Punk / New Wave
A volte bisogna lasciar sedimentare le cose, seminare
e aspettare i frutti, non disperdere le energie ma concentrarle sui propri obiettivi: certamente ne sono stati
capaci i JoyCut, che con questo nuovo album hanno
ottenuto il giusto riconoscimento internazionale, testimoniato dalla produzione di Jason Howes (già al lavoro con Block Party e Arctic Monkeys) che in Ghost Trees
Where To Disappear riesce a valorizzare le potenzialità
della band donandole il manto sonoro più consono,
proiettandola direttamente nel suo territorio di origine
musicale: l’Inghilterra anni ‘80.
Bastano infatti le prime note dell’opening strumentale
10 Pence per accorgersi di quali siano i loro riferimenti
e di come i JoyCut amino tingere stratificazioni soniche
di tradizione new wave con riflessi elettronici, virando spesso verso una solare melanconia pop à la Cure
(lampante in Green Garden). Quando poi, attraverso il
post rock di TTG e le cupe sonorità dissonanti di Deus,
si arriva a The Fall sorge spontaneo il paragone con gli
Arcade Fire e con tutti quegli elementi dei tardi anni
‘80 - come Echo & The Bunnymen, Psychedelic Furs e
The Wake - a cui tanta musica indipendente degli anni
zero ha fatto riferimento.
In dieci anni di carriera i JoyCut hanno imparato a rimescolare bene questi elementi, quanto basta per creare
un linguaggio sufficientemente personale e affinare
una capacità compositiva riconoscibile. Ghost Trees
Where To Disappear è il loro disco definitivo.
(7.2/10)
Alberto Lepri
Kangding Ray - Pruitt-Igoe (Raster Noton
DE, Dicembre 2010)
Genere: Minimal Techno
Dopo l’ottima prova di Autumn Fold, torna Kangding
Ray con un eppì di quattro brani dalla solida base
concettuale. Pruitt-Igoe, altro non è che il nome di un
quartiere di St. Louise, costruito e demolito nel giro
di un paio di decadi tra gli anni Cinquanta e Settanta,
un complesso (ad opera di Minoru Yamasaki, lo stesso
delle torri gemelle) mitizzato come uno dei più grandi
fallimenti dell’architettura moderna.
Per riuscire nell’impresa di condensare i venti anni di
vita della struttura in venti minuti di musica, il buon Kangding Ray si fatto aiutare dal padrone di casa Alva
Noto e da un altro noiser di lusso, Ben Frost. L’apporto
del primo si limita nel frullare gli stilemi di casa Noton,
con microsuoni stile fotocopiatrice che sembrano venir
fuori da Xerrox, e ritmiche asincrone alla Unitxt. Il secondo invece sfodera una prova più convincente, con una
traccia tra bassi distorti e minacciosi che preannunciano la caduta dell’edificio ed echi di Murcof.
In mezzo, Ray mastica suoni metallici e post-urbani in
linea con certo dubstep d’autore, e rappresenta forse il
passo oltre gli steccati dell’etichetta in un lavoro ibrido
e tutto sommato importante.
(6.8/10)
Stefano Gaz
63
L’Altra - Telepathic (Acuarela Discos,
Marzo 2011)
Genere: post-indie pop
Lungo un decennio costellato di pochi e assai buoni
dischi, L’Altra hanno tradotto in realtà un’idea post dei
primi Everything But The Girl e/o dei Go-Betweens
maturi. Nel senso che sapevano come modernizzare,
mescolandola con elettronica lieve ed echi jazz, un
pop al tempo stesso ricercato e sensuale. Qualcosa che
parlava a cuore e mente sottovoce però con invidiabile
chiarezza e raggiungeva l’apice nel secondo album del
2002, In The Afternoon. Si raccontava più che dignitoso
il successore Different Days, col quale la formazione si
raccoglieva attorno al nocciolo della cantante e tastierista Lindsay Anderson e di Joseph Costa, chitarrista
e altra voce. Situazione immutata sei anni dopo per un
ensemble che si conferma “aperto”, avvalendosi di Josh
Eustis (Telefon Tel Aviv), Josh Abrams (Bonnie Prince
Billy) e Marc Hellner (Pulseprogramming).
Dove Telepathic apporta novità è infatti in angoli ulteriormente smussati e strutture vieppiù lineari di curatissimi acquerelli indie-pop, che grazie al lieve “ammorbidimento” formale potrebbero regalare qualche
soddisfazione di natura commerciale. Ottimi i risultati dove la band integra il passato alle nuove esigenze
poggiandosi su una penna solida, come nella splendida Big Air Kiss (refrain sospeso, archi che feriscono)
e nell’eterea (This Bruise), in una cupa Boys prossima
ai Walkabouts e nel respiro neo-cameristico di Black
Wind e Dark Corners II.
Qualche sbavatura - sebbene non grave - affiora nella
seconda metà del disco, in un paio di tracce piuttosto
melense e in una title-track che soccombe alla retorica
strada facendo. Amici cari erano e lo rimangono, nonostante qualche capello grigio.
(7/10)
Giancarlo Turra
Le Corps Mince De Francoise - Love &
Nature (Heavenly, Gennaio 2011)
Genere: elettropop
Sono figlie delle Slits, le finlandesi Mia ed Emma
Kemppainen, responsabili della sigla Le Corps Mince
de Francoise. Non tanto per l’effetto musicale (che a
volte, e una volta a quanto pare, rasenta e rasentava
lo stile di Palmolive e co.), piuttosto per l’approccio disinvolto, fresco e sorridente (Cool And Bored) con cui le
due vocalist affrontano le brevi scorribande elettropop
contenute in Love & Nature.
Non ci si discosta dal genere di riferimento, nell’album
d’esordio delle due sorelle, e anzi a volte si scivola sulla
64
buccia di banana dello scimmiottamento mainstream
radiofonico involontario (Future Me). Nulla di grave, se
prendiamo Love & Nature per quello che è: un passatempo composto da caramelle di pop femminino
che ci aspettiamo così come sono, e mai pretendono
di essere più di questo. Non è certo il caso di fare un
discorso sull’onestà, ma semmai sulle aspettative, quello strano oggetto che costruisce mondi premeditati, li
sconvolgono e ci fanno dibattere e accapigliare, o semplicemente restare delusi.
Non in questo caso. L’elettropop è ormai talmente storicizzato (sembrano eoni fa che parlavamo dei Blow)
da non dover spendere neanche virgole e incisi sul genere, sulla scena, sui suoi rimandi interiori ed esteriorizzati. Le tastiere e la drum machine Eighties di Hard
Smile ci smuovono ancora qualche collegamento, così
come non potremmo mai risparmiarci di cogliere il felice sforzo costruttivo di alcuni brani (Something Golden,
We Are Cannibals).
Un disco che svolazza nella stanza il tempo dell’ascolto
e poi vola via senza rincorse.
(5.9/10)
Gaspare Caliri
Les Spritz - Payaso (Lemming Records,
Dicembre 2010)
Genere: noise-math
Parliamo di un trio con la voglia di sferzare il sordido
stato delle cose. Lo scudiscio è una stringata e spasmodica ossessione math-noise, ovvero una sarabanda strumentale blues, hardcore, funk e punk, fermo
restando l’immancabile prefisso post. Nevrosi ritmiche
ribadite da corde urticanti, spigoli, sincopi, intrecci
schizofrenici, acidità avariata e via discorrendo. I Les
Spritz dominano l’estro come ingegneri kamikaze caricati a fulmicotone, accumulano tensioni poi saettano
incendiari in un brulicare ruvido e beffardo di batteria,
basso e chitarra.
Una triangolazione che a dire il vero sembra aver esplorato da un pezzo (facciamo dagli Shellac in poi?) tutte
le possibilità e le varianti. Ciononostante i tre siciliani
la interpretano con piglio da pionieri, permettendosi
d’introdurre talora una tromba lisergica e malandrina
(vedi la notevole Glasnost), espediente che li esortiamo a perseguire più spesso e fino alle estreme conseguenze. Per pubblicare Payaso si sono mosse ben
quattro etichette: Lemmings Records, Have you said
midi?,Whosbrain Records, Musica per organi caldi. Uno
sforzo - mi sembra il caso di dire - ben giustificato.
(7/10)
Stefano Solventi
Maceo Plex - Life Index (Crosstown Rebels,
Febbraio 2011)
Genere: House
C’è un vago ritorno techy-minimal nell’ultimo disco di
Maceo Plex sulla label di Damian Lazarus. L’americano Eric Estornel, conosciuto con innumerevoli moniker
tra cui Maetrik, Eric Entity, Tali Wackas e Mariel Ito ci
riporta di nuovo sul pianeta house, aggiungendo coordinate di base funk (The Feeling) e soul che ad un primo ascolto sembrano essere in sordina. Man mano che
si approfondisce la faccenda, emerge chiaramente un
sentimento derivato dal suo lavoro più che decennale
di analisi dell’anima che l’ha portato a pubblicare singoli su Cocoon, Audiomatique, Mothership, Dumb Unit
e molte altre label.
La mossa solare che permea l’intero full length deriva
probabilmente dal suo trasloco a Valencia, in Spagna;
nel corso della tracklist si sentono infatti tutte le vibrazioni positive derivate dalla città che si affaccia sul
mediterraneo: il tributo a Stevie Wonder cantato da Peter King in Vibe Your Love, la balearica in acido di Gravy
Train, il tribalismo deep di Sleazy E, il sogno sexy e tutto
newyork di The Feelin, la compattezza mostruosa nei
bassi di Your Style (con la voce dello stesso Maceo) e
l’ottimo downtempo da decompressione di Love Your
Mama (con l’aiuto dell’amico barcellonese Fabel).
Un’altro punto a favore per la Crosstown Rebels, che
quest’anno ha già pubblicato il buon disco di Deniz
Kurtel e dovrebbe poi continuare con le bombe Art
Department e Jamie Jones. Ribelli, continuate così.
Stay cool and dance.
(7/10)
Marco Braggion
Majakovich - Man Is A Political Animal, By
Nature (Anti-dot, Gennaio 2011)
Genere: noise-rock 90s
Sulle ordinate il chitarrismo rock dei primi 90s in tutte
le sue salse; sulle ascisse l’insana capacità da meltingpot globale dei Faith No More. All’intersezione, loro, i
Majakovich: al secolo Francesco Sciamannini (voce e
chitarra), Francesco Pinzaglia (basso) e Leonardo Antonelli (batteria). Trio di belle speranze e amicizie rumorose (sono della partita a vario titolo Xabier Iriondo, Gio
Ferliga degli Aucan, Giulio Ragno Favero e molti altri)
che colpisce dritto in faccia al primo disco mettendo in
scena un intero “universo di contraddizioni”.
Gente di provincia, quella sana, dove si fa gavetta bella tosta. E quando si arriva, si è in grado di spacciare
un esordio che ricicla e condensa in un rock vibrante,
emozionale, muscolare e sempre melodico tutto ciò
che di rumoroso si è sentito nell’ultima era dorata del
rock pre-internet. Dai Fugazi della seconda fase (periodo In On The Kill Taker) della title track ai Faith No More
che aleggiano sul tutto (Leonard’s Smile Pt. 2 ha lo stesso sorriso sornione e lo stesso scazzo domenicale della
Easy faithnomoriana), passando per il panzer melvisiano virato stoner desertico dell’opener If I Could Take A
Light, il post-grunge di The Financial Cut (che spazza via
l’ammiccante strizzare d’occhio alla Foo Fighters giocando sullo stesso terreno hard-melodico), le chitarre
post-Shellac, la mathematica chicagoana e una fisicità
mai doma.
Un disco dai suoni pressochè perfetti e ideale per la carica giornaliera: adrenalinico, scanzonato, ruvido. Ottimo anche per molteplici passaggi radiofonici.
(7/10)
Stefano Pifferi
Marcus Schmickler - Palace Of Marvels
(Queered Pitch) (Editions Mego, Dicembre
2010)
Genere: musica informatica
Il compositore Schmickler, noto anche con il moniker
di Pluramon e già collaboratore al negozio ed etichetta A-Musik con l’amico Jan St. Werner dei Mouse On
Mars, esce con un nuovo full length che testimonia il
sonoro di un’installazione dello scorso anno in collaborazione con il collettivo artistico Interpallazo.
Dal punto di vista tecnico, il disco esplora il cosiddetto Shepard tone, un’illusione sonora che sale e scende continuamente di intonazione e che quindi non si
assesta su una nota identificabile, ricordando gli esperimenti di Jean-Claude Risset e l’intera produzione
di James Tenney. Il disco - da cartella stampa - vuole
‘esplorare sonicamente il palazzo delle meraviglie descritto da Leibniz come un mondo perfetto nel quale
il padrone di casa riesce a vedere e comandare in ogni
piccola parte la sua dimora’.
Seppur le premesse teoriche non manchino (basandosi
anche sugli scritti musical-politici di Attali), il disco è di
difficile assimilazione e risente di un tecnicismo troppo
freddo, anche per gli amanti della sperimentazione e
della computer music. Fuori dall’installazione il sound
perde la sua potenza e si cristallizza in uno sfoggio di
progressività (New Methodical Limits Of Ascension) e di
tecnicismi che suonano come i capolavori dei maestri
già citati (Risset Brain Hammer, Hypercubist Pareto Dist).
Solo per aficionados e nerd.
(6.2/10)
Marco Braggion
65
Maria Lapi - Ignote melodie (Effettonote,
Dicembre 2010)
Genere: jazz-funk
Maria Lapi rientra in quella categoria di virtuosi della
voce capace di spaziare tra jazz, musica d’autore, easy
listening e funk. Nulla di particolarmente originale, a
dire il vero, piuttosto un’attitudine generalizzata e talmente diffusa nel Bel Paese da poterci stilare quasi una
categoria a sé stante. Nel caso della Lapi, quando va
bene, il punto di riferimento è l’ultima Cristina Donà
(Mani, Pochi Istanti, La chiave giusta, L’inatteso), quando
va male i Dirotta su Cuba (Gravità, Ignote Melodie) e in
generale un virtuosismo un po’ fine a sé stesso.
Si tratta nel complesso di un disco d’esordio gradevole, innocente, leggero, esattamente come vorrebbe far
credere l’immagine di copertina che ritrae la nostra
Maria in atteggiamento piuttosto svagato. E che non
chiede “altro” all’ascoltatore se non di trovargli un significato che non sia il gusto per un’estetica raffinata e
tecnicamente impeccabile.
(5.2/10)
Fabrizio Zampighi
Mark Fell - UL8 (Editions Mego, Dicembre
2010)
Genere: computer music
Mark Fell ha visto e vissuto attivamente tutti i passaggi della sound art dalle microwave all’elettroacustica
odierna e alla computer music, sia come produttore
che come metà dei .snd, progetto che condivide con
Mat Steel. Epperò di uno come lui, che siamo abituati a
vedere iscritto nei cartelloni dei festival di arti elettroniche di tutta Europa, non sempre si conosce l’origine
musicale. Il quid che diede il la a una carriera, spesso
perso nell’adolescenza o giù di lì. UL8, nome di un modello di riproduttori a tre vie della Celestion, ma anche
da oggi nome del mastodonte sintetico che Mark fa
uscire per la Mégo (dopo passaggi noti presso Mille
Plateaux e Raster-Noton), sta qui a rappresentare quel
momento adamico, quando il Nostro sentiva uscire
dalle casse il synth pop di metà Ottanta e in mezzo a
chitarre e bassi focalizzava l’attenzione sulle oscillazioni delle onde prodotte dai synth.
Con quello spirito l’ora e passa di UL8 ci propone un
sound incompromissorio, un ritorno alle origini e all’essenza, computer music che rimane fedele a quel suono
in bassa risoluzione (quasi un glitch che fa da mattoncino ritmico da ripetere all’infinito) ricordando i tempi in
cui si riusciva a sintetizzare solo quello. “Le tracce”, come
dice Fell medesimo, “replicano la semplice equazione
synth mono / drum machine; sono state fatte con e per
66
le casse UL8”. Un trapano ipnotico davvero estremo,
che perfora i neuroni e non lascia via d’uscita (tranne
nell’impasto ritmico del secondo brano che compone
la parte 3 dell’opera, quasi-drill avveniristica per particelle di bit); Mark ha dalla sua una testardaggine e una
coerenza invidiabile, che avvicina la follia ritmica e si
pavoneggia dell’immunità di cui gode, trovando esempi di musica da computer da manuale, in entrambe le
accezioni dell’espressione (traccia 16, sempre all’interno della Part Three). La chiusa (Death And Love) ironizza con le tastiere di Human League e compagnia, che
duettano in lontananza con il giocattolo elettronico di
Fell in primissimo piano, quasi uno specchio che ingigantisce i pori. Duetto/duello che fa il riassunto di una
vita. Vince il computer, evidentemente.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
Mike Watt - Hyphenated-Man (Parabolica,
Marzo 2011)
Genere: indie/roots USA
Il nome Mike Watt è più di un insieme di lettere, perché Mike Watt è lo zio Mike, il veterano. Inutile dire che
i Minutemen sono uno dei pochi veri gruppi fondamentali e che Double Nickels On The Dime è uno dei pochi veri dischi definitivi. Diciamo allora che Ball-Hog Or
Tugboat? (1995, il primo disco solista) è una all star jam
indie da sogno, rappresentativa e riuscita come poche
(con singoli pezzi bellissimi), e che tutti i progetti postD.Boon dell’uomo (Dos, fIREHOSE, vari supergruppi)
sono stati sempre animati da passione e portati avanti
con intensità, bilanciando nostalgia e pruriti sperimentali.
Hyphenated-Man, pubblicato in Giappone già a ottobre 2010, è la terza rock opera firmata da Watt, molto meno narrativa delle precedenti (dedicate alla vita
marinara del padre e a momenti autobiografici messi
in parallelo con la Divina Commedia dantesca; tsk, ‘sti
americani), composta da trenta brevi sketch ispirati ai
mostriciattoli dei quadri di Hieronymus Bosch, in una
sorta di Mago di Oz miniaturizzato (e al maschile).
Scritto tutto su una vecchia Telecaster appartenuta
a D.Boon, registrato assieme ai fidi Missingmen Tom
Watson (chitarra) e Raul Morales (batteria) nello studio
newyorkese dell’ex-Pere Ubu Tony Maimone, l’album
è un concentrato di enciclopedismo indie/roots USA
nella più classica tradizione wattiana, uno zibaldone
stranoto ma ancora sorprendentemente fresco e frizzante, tra funk costipato, country modificato, hardrock,
HC melodico, slow blues e - fondamentali - residui beefheartiani (proto-post, free e psych). Lo zio Mike non si
highlight
James Blake - James Blake (Atlas, Febbraio 2011)
Genere: post-dubstep soul
Inutile stare a chiosare più di tanto sui singoli brani dell’album di debutto del ventiduenne James Blake: è
tutta la stessa morbida pasta soul-elettronica che si spande, spigolosa e avvolgente. Rispetto al già ottimo
Klavierwerke EP, il ragazzo scopre ancora di più le carte e dà nuovi indizi, mette tra parentesi gli esercizi
di stile strumentali, mette in primo piano la voce e getta sul tavolo quello
che appare adesso - in controluce - il riferimento più forte: i Super Collider.
Pur piazzandosi su un versante decisamente non-techno rispetto a Lidell &
Vogel (e quindi a un Taprikk Sweezee), con questo suo soul post-dubstep,
vagamente ectoplasmico e venato di spiritualità, James propone una nuova
ipotesi di chill out per i raver dal palato fino a cui non bastano le contaminazioni trip-hop (Mount Kimbie), wave (Darkstar, che come lui hanno riscoperto la centralità della voce) o gli scivolamenti verso la classica contemporanea (Blake himself).
Con lucide sporcature glitch, passaggi wonky miniaturizzati, invadenti crescendo di tastiere supersature,
misuratissimi tocchi di piano e falsetti in stilizzazioni autotune (finalmente non più esclusiva delle tamarrate plastic hip hop?), James costruisce un pathos trattenuto e un algido romanticismo che incornicia e
puntella con lunghe pause e lunghi silenzi: dai legnetti dubstep e dagli sdilinquimenti dell’iniziale Unluck,
fino allo sbocciare addirittura gospel del conclusivo a cappella Measurements. Passando per il cuore del
disco che è l’intensissima cover piano-voce di Limit To Your Love di Feist.
Credibile da punti di vista anche molto diversi (e altrettanto diversamente inquadrabile), legato alla base
tanto all’intimismo di Antony quanto al mood asciutto e vaporoso dei Massive Attack (filtrati da un
background di nowness black/pop che passa anche per Kanye West e Lil Wayne), James riesce a unire
appeal e ricerca, canzone e suono, tradizione e modernità, stile e anima: piacerà ai fan di Jamie e dei suoi
xx e piacerà a chi ama immergersi nell’ambient-soul di Burial; finirà in classifica e finirà anche nelle top
dei magazine più esigenti.
Splendido nuovo capitolo nella dialettica senza posa uomo-macchina, James Blake è soprattutto un
barlume di speranza tra le brume londinesi: l’illusione del calore soul. Come quel vapore grigiobianco che
si libera dal ghiaccio secco quando sublima.
(8/10)
Gabriele Marino
è ancora rincoglionito e ci tiene a far sapere che non è
soltanto il bassista degli Stooges...
(6.95/10)
Gabriele Marino
Miss Julicka - Show Money Please
(Revomuzik, Gennaio 2011)
Genere: electro wave
La proposta dei Miss Julicka tradisce evidenti infatuazioni post-wave e trip-hop, con licenze atmosferiche e congetture ritmiche tali da scomodare memorie
così diverse eppure affini quali Lamb, Subsonica, Lali
Puna, CSI e Blonde Redhead. Si tratta sostanzialmente di un duo: lui è Flavio Ferri, membro storico dei Delta
V e attualmente in bazzica anche nei Gurus On Vaca-
tion; lei è la vocalist Aigoulya Divaeva, origini tartare,
ex-ballerina del Bolshoi che dopo un curriculum vitae
trafelato è infine approdata nel nostro meraviglioso e
scellerato Paese.
Tra i due c’è ben più che un sodalizio artistico, ma è di
quest’ultimo che ci preme riferire, anche se d’interessante c’è soprattutto come le attitudini soniche di Ferri si mettano al servizio del fascino esotico e desueto
della vocalist, imbastendole scenografie come autodafé emotivi fin de siécle. Escludendo una cover dei
Plasmatics (Sometimes I) e quella BBC estrapolata dalla
soundtrack di un film russo, Show Money Please mette in fila originali tanto intensi quanto prevedibili, nei
quali la sensualità evasiva e l’ambiguo turbamento della Divaeva (sorta di nipotina inquieta di Amanda Lear)
67
trovano compimento anche grazie alla felice scelta dei
testi ridotti all’osso, poche parole reiterate a mo’ di raga
metropolitano. Qualche pezzo riesce piuttosto bene
(Brucia, A volte pensi, la title track) ma nel complesso
non si va oltre un prurito di (prematura) archeologia
sonora.
(6.2/10)
Stefano Solventi
Mogwai - Hardcore Will Never Die, But
You Will (Rock Action, Febbraio 2011)
Genere: wave rock
E’ almeno da Rock Action, il loro terzo lavoro, che i Mogwai cercano una scappatoia dall’impasse, un modo
cioè per lasciarsi alle spalle quella ingombrante calligrafia che li rese grandi, modello stilistico imprescindibile tra i molti attribuibili alla voce post-rock. Parliamo
quindi di dieci anni fa, mese più mese meno. Fu quando gli scozzesi (assieme a tutto il “movimento”) capirono l’importanza di tornare nel grembo della canzone,
recuperandone strutture e idioma senza rinnegare la
trasfigurazione della ritualità rock operata con gli stupendi CODY e Young Team. Ovviamente, fu allora che
per Stuart Braithwait e compagni iniziarono i problemi.
Non convinse del tutto Rock Action e non convinsero i
lavori successivi, sospesi tra la necessità di reinventarsi
e l’impossibilità d’essere altro da sé.
Tornano a provarci oggi con l’opera settima Hardcore
Will Never Die, But You Will, titolo che pare ispirato
all’imprecazione proferita da un teppistello ad un negoziante che si rifutava di vendergli alcolici. La chiave
stavolta è un wave pop da vorrei-ma-non-posso, tanto accattivante quanto banale (vedi gli Stereolab via
New Order di Mexican Grand Prix), che si appiattisce
tra incedere chitarroso più da motoretta che motoristico (San Pedro, George Square Thatcher Death Party),
pseudo-epiche marziali (la distorta e un po’ bolsa Rano
Pano) e tentativi atmosferici senza troppo genio (la
cremosa ma sterile Letters To The Metro, una How To Be
A Werewolf che prova a mettersi in scia Wilco).
Gli otto minuti abbondanti di You’re Lionel Richie - con
curioso, breve inserto in italiano (“...disse che l’aveva
trovato, doveva uccidere il lupo, quel lupo non morì mai.
Doveva avvolgersi nella sua pelle...”) - sono una melmosa processione all’insegna di quel formidabile passato
che li condanna ad essere una variazione un po’ disperata del proprio mito.
(5.5/10)
Stefano Solventi
Morgan Packard - Moment Again
Elsewhere (Anticipate, Ottobre 2010)
Genere: elettronica
La forza del minimalismo sta nel fatto che è una scuola, ma anzitutto una pratica, efficace, modulare e modulabile. Un modus operandi riconoscibile ma anche
annidato, e sappiamo quanto, in ogni genere. Morgan
Packard parte da questa conoscenza per ri-approcciare il suo mondo, quello dell’elettronica, delle textures di
produzione.
In Moment Again Elsewhere, il responsabile dei moniker Tundra (pianeta drum’n’bass) e Captain Campion
(con Phil Salathe) si cimenta con minimalismi (Reveal),
appunto, ma anche armoniche strutture elettroacustiche e house (Insist), con esiti alla Four Tet. Rispetto a
Kieran, Morgan è americano (viene da una zona rurale
del New England e vive a New York, sebbene abbia imparato il mestiere, pare, a Londra) e, piuttosto che dirigere gli esperimenti verso la sala da ballo, nutre i suoi
pezzi di riflessioni elettroacustiche, e lascia all’ascoltatore lo studio delle soluzioni creative, piuttosto che la
fruizione - pur intelligente - nella più sofisticata club
culture. Packard viene poi dalla dedizione conservatoriale al sax jazz, e non disdegna il pianoforte, che non
interpreta altro ruolo che se stesso, pur affiancato da
obliquità percussive di derivazione glitch (Window),
così come non rinuncia a meditazioni che rimandano a
Terry Riley (Explain).
Nulla di sorprendente (date le premesse), eppure di
Packard ricorderemo il tocco, alla costante ricerca della
grazia, e l’assenza di perturbazione e disturbo. La sofficità è una presa di posizione, se gestita con padronanza
dei mezzi che più potrebbero sconvolgerla (l’album è
stato composto interamente con Ripple, un software di
programmazione creato dallo stesso Morgan) - e all’interno di una musica che definiremmo certo più cerebrale che easy listening.
(6.7/10)
Gaspare Caliri
Mr. Milk - Mr. Milk (Casa Molloy, Novembre
2010)
Genere: folk
Folkster campano e barbuto, voce appesa a un filo,
esordio affidato a dodici brani voce e chitarra acustica.
Mr. Milk sembra una via di mezzo tra Nick Drake, Will
Oldham e Bob Corn, perso com’è in una musica fragilissima e che più introspettiva non si potrebbe. Un pianoforte in Cardinal Legs e il resto dei brani a rallentare il
battito su qualche arpeggio e una vocalità accordata su
desinenze jazz, immaginario nudo che gioca con l’inno68
cenza del bianco, tiene gli occhi chiusi per concentrarsi
sul cuore e riserva dediche ai figli che verranno. Il tutto
in un tripudio di delicatezza e sensibilità che abbandona la “cameretta” adolescenziale giusto per questioni
anagrafiche, giacché la destinazione naturale della musica sarebbe proprio quella.
Le cautele si sprecano in fase di ascolto, non fosse che
di materiale sul genere se ne trova praticamente ovunque. Eppure Mr. Milk riesce a conquistarci con un misto
di immediatezza e malinconiche melodie dal passo forbito, costringendoci a relegarlo nelle prime posizioni di
quella scena nostrana minimal-folk in cui già rientrano
artisti come Le-Li, Comaneci, Paolo Saporiti, Brown
And The Leaves e il già citato Bob Corn. Il domani è ricco di interrogativi, ma per ora c’è un disco di cui essere
ampiamente soddisfatti.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Nicolas Bernier - String Lines (Crónica
Electronica, Ottobre 2010)
Genere: elettroacustica
Dei diapason. Guide quasi morali. Le “linee” a cui fa riferimento il titolo del nuovo suggestivo lavoro di Nicolas
Bernier sono “tuning fork”, strumenti di accordatura
e curiosi spiriti di metallo che riproducono un “puro
tono”, a cui anelare. Per un anno e mezzo (settembre
2008-febbraio 2010), Nicolas ha seguito la fascinazione
di ciò che detta la regola: ha chiamato a sé due suonatori d’archi, Pierre-Yves Martel (violista) e Chris Bartos
(violinista) e insieme hanno esplorato le risorse asintotiche del tuning attorno a una determinata frequenza.
Bernier, compositore elettroacustico canadese (curiosamente omonimo di un compositore francese del Seicento), ha miscelato questi elementi riuscendo a creare
una ricerca sui timbri di grande impatto, con un’insistenza e un’intensità che ricordano le notti di Giacinto
Scelsi, più che le ricerche di Luciano Berio. Funziona
particolarmente la dinamica e il sistema di relazioni
che si creano tra layer ambiental-elettronici (sfrigolii
sofisticati fin quasi al silenzio, a volte - line (c) - formicai
percussivi) e le note acustiche (line (a)), prolungate fino
a essere un mantra dell’essenza. Ciò che sembra paradossale, ma solo in apparenza, è la possibilità di fare improvvisazione attorno al concept di String Lines. Non è
per nulla inconcepibile maturare un approccio alla nota
che per quanto si avvicini la rifugga, ne colga interstizi,
vie d’uscita, mimetizzati nella ripetizione.
L’ascoltatore vive una piccola narrazione, dalla quale è
costretto a rimanerne escluso. È imbavagliato, come in
una camicia di forza, dall’ipnosi dei forks, e gode, impo69
tente, della maestria altrui nel fare fuga e trovare escamotage per ravvivarne le potenzialità compositive.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
Ninni Morgia/William Parker - Prism
(Ultramarine, Novembre 2010)
Genere: impro
È sempre la benemerita Ultramarine a dare alle stampe
Prism, doppio vinile collaborativo che mette in campo
forze in apparenza lontane ma unite dalla indomita
sperimentazione strumentale: una leggenda del freejazz americano, William Parker, e un giovane ed eclettico chitarrista nostrano, Ninni Morgia.
Apprezzato e adorato da mostri sacri come Derek Bailey, il primo; onnivoro sperimentatore di tutto lo spettro
delle musiche chitarristiche (noise-rock, kraut, psichedelia, sperimentalismo in solo, free-jazz), il secondo, i
due trovano il loro punto di contatto ideale in passaggi
strumentali lontani da ciò che hanno prodotto in solo
finora. L’americano contrappunta col suo contrabbasso, fa da fondale, rende fluido il tutto mentre il siciliano offre forse la sua prova più ardita e avanguardistica. Prism è tutto un lavorio di chitarra e “sulla” chitarra
che genera gorgoglii alieni e rumorismi spettrali, frasi
monche e puntillismo zoppo e fuori fase, fuoriuscendo quasi trasfigurata dal suo ruolo naturale. Non ce ne
voglia Parker: il suo contributo al contrabbasso è tanto
umile quanto essenziale per diluire e insieme legare
il suono altrimenti dispersivo della chitarra di Morgia,
ma è quest’ultimo e il suo strumento il vero centro nodale dell’album. Acquietando i passaggi (Prism 7, Prism
4), inasprendoli quasi fino alla schizofrenia (Prism 3) o
alienandoli verso una sorta di parafrasi elettronica (Prism 11, Prism 15), Morgia fornisce una delle sue migliori prove, piazzandosi indubbiamente al livello di altri
grandi chitarristi avant.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
talità corale/strumentale inclusa nel pacchetto.
Viste le premesse, un’installazione multimediale di
otto speaker e altrettanti schermi, Hexadecagon,
quarto album dei ragazzi, doveva essere la loro
prova più interessante e avant. Una conversione in
formato album (e quindi stereofonica) ha poi ridimensionato l’impresa con risultati nettamente minimalisti (il caso più ecclatante: il pigiare incessante di
tasti da quaranta pianoforti in Circling) e in generale
un impasto sonico ampiamente masticato e digerito
(lo xilofono e le elettroniche in crescendo Mogwai di
Glass Jungle).
(6.4/10)
Edoardo Bridda
Ofeliadorme - All harm ends here
(Autoprodotto, Dicembre 2010)
Genere: indie rock
Primo passo sulla lunga distanza per i bolognesi Ofeliadorme dopo l’ep Sometimes it’s better to wait del
2009. Le undici tracce di All harm ends here raccontano di un combo dall’aspetto (quasi) bifronte: elettrico in odore del più canonico brit-pop radioheadiano
per le prime sei tracce, acustico o semiacustico dalla
settima in poi, uno strumentale psychfolk dal titolo
omaggio a Whitman Leaves of grass. A fare da filo rosso la voce lamentosa e allucinata, un po’ Cat Power un
po’ PJ Harvey, di Francesca Bono e l’indole smussata
negli angoli ma pronta alla deflagrazione sul ritornello
del resto della banda: agli Ofeliadorme manca la zampata che li allontani da un calligrafismo onesto ma un
filo soporifero, si veda la crescita poderosa di River che
potrebbe essere qualcosa di più di una bella crescita
poderosa e basta. Peccato, perché le liriche raccontano
con la giusta tensione delle nostre quotidiane lotte con
le paure, l’amore e i sogni dimostrando per una volta
che l’utilizzo dell’inglese (Ian) non è solo un cespuglio
dietro cui nascondersi.
(6.4/10)
Luca Barachetti
Octopus Project (The) - Hexadecagon
(Peek-A-Boo, Dicembre 2010)
Genere: Coralità pop
Semisconosciuti e mai davvero spinti criticamente, i texani The Octopus Project sono una stereotipica band
Anni Zero. Attivi dal 1999, e presenti a festival anche
importanti, sono scomparsi dentro un mulinello di
post-rockismi di stampo europeo virati all’elettronica
(tastiere e synth vari, drum machine) e layeristica sonora sulla scorta di label come Arts&Crafts e act come
Architecture in Helsinki o Mùm, campanellini e men70
One Fuck One - We’ll Be Men Once More
(Bloody Sound Fucktory, Gennaio 2011)
Genere: industrial-wave
Un incalzante beat electro di stampo ebm, una linea
di basso digitale ossessivamente industrial, una voce
decadente e anfetaminica. Si presenta in questo modo,
stabilendo da subito humus, traiettorie e finalità l’esordio di One Fuck One. Nuova propaggine delle Marche
marce, il duo vede protagonisti David Starr ai suoni e
Luca Giommi, già con Edible Woman, alla voce. Di-
highlight
Joan As Police Woman - The Deep Field (Pias, Gennaio 2011)
Genere: neo soul errebì
La neo-quarantenne Joan Wasser sforna il terzo album di inediti in cinque anni (senza contare l’interlocutorio Cover) e azzecca la formula. Rispetto ai lavori precedenti, le dieci tracce in programma - che
per gli amanti del vinile diventano dodici - correggono la rotta quel tanto che basta perché la calligrafia
esaudisca appieno le pretese espressive, sembrando quello che la poliziotta
avrebbe sempre voluto e dovuto fare. Assistita al solito dall’esperto producer
Bryce Goggin (in repertorio album di Phish, Apples In Stereo, Sebadoh e
Ramones, nonché il missaggio dell’epocale pavementiano Crooked Rain,
Crooked Rain), Joan si disimpegna agile e appassionata attravreso un soulerrebì riprocessato, ovvero smontato e rimontato secondo l’estro, la sensibilità, l’organizzazione mentale da caucasica metropolitana (newyorkese), di
buona cultura, disposizione globale e tendenza liberal.
E’ un vero e proprio luogo estetico ed emotivo in cui inquietudini e traversie
socio-esistenziali trovano epifania e redenzione. Bassi arguti e pastosi, chitarre nervosette e acidule, fiati,
archi, organo e clavinet concorrono a definire assieme al canto della Wasser - mai tanto duttile e partecipe
- un morbido rituale laico dove la sensualità primaria della black music sembra come sublimarsi, mettendosi al servizio di una “educazione sentimentale” tanto composta quanto tormentata, ad un tempo battagliera, elegante e apprensiva. Per questo durante l’ascolto capita di ripensare ad altre modalità di riappropriazione “bianca” dello stilema soul/errebì, così simili e così diverse: ad esempio ad una Cat Power senza
quella tribolata e un po’ disperata devozione (Kiss The Specifics, The Action Man), ad una Beth Gibbons più
serial televisivo che noir cinematico (Run For Love, Forever And A Year), ad una nipotina irriverente di Joni
Mitchell (The Magic), a dei Morphine meno febbricitanti che assorti (vedi la fosca Flash).
E’ un gioco che ammalia finché riesce a non sembrarti troppo cerebrale, sostenuto da un pensiero debole ma suadente/pervadente (il frutto insipido dell’era dei social network?) di cui la ex compagna di Jeff
Buckley (che magari avrebbe gradito l’appiccicosetta Chemmie) riesce a passare per la miglior interprete
possibile.
(7/10)
Stefano Solventi
menticate le chitarre che tanto contano in quella fetta d’Italia: qui il referente principale è l’area grigia, la
macchina, l’elettronica più paranoica e disturbante.
A riattivare l’eterno conflitto macchina vs umano che
caratterizza l’electro-industrial dalle sue origini è il
confronto/scontro con la voce, sì graffiante e malata, a
tratti robotica e ipnotica, ma sempre percettibilmente
“umana” di Giommi.
Il tappeto sonoro è ovviamente targato Suicide (Fuck
3-4 Turning Clocks Back è più di un omaggio), innanzitutto, ma anche Young Gods (Fuck 6 Fury rimanda
alle migliori prove di TV Sky), l’industrial-rock dei nostrani Templebeat o dei Pankow della seconda fase,
la cold-wave made in deutschland più incompromissoria, l’ebm alla Klinik (Fuck 9 Hail To) in versione heavy-screamo, non disdegnando momenti dei primigeni
Nine Inch Nails (Fuck 12 Counted Out e il suo macilen-
to procedere post-reznoriano) e facendo aleggiare su
tutto un immaginario post-apocalittico non dissimile
da quello ballardiano. Un disco anni ’80 fino al midollo:
oscuro, spiazzante, urgente.
(7/10)
Stefano Pifferi
Owls - The Night Stays (RareNoise,
Febbraio 2011)
Genere: wave
“Se Ian Curtis e i Joy Division esistessero ancora, oggi
probabilmente suonerebbero così”. A dar retta alle
press-sheet spesso si prendono topiche assurde. Stavolta, parlando degli Owls, la definizione ci sta tutta.
Quello proposto da un eterogeneo terzetto di veterani
delle scene musicali più oscure e trasversali è infatti un
suono dark-wave dal taglio apocalittico e dall’incedere
71
cadenzato, tanto raffinato nei suoni quanto esoterico e
gloomy nelle atmosfere.
Lorenzo Esposito Fornasari (voce, elettronica, già collaboratore di Bill Laswell), l’istituzione Eraldo Bernocchi (dalle asperità industrial anni ’80 coi Sigillum S alle
collaborazioni a 360° con Mick Harris, Raiz, Jah Wobble
ecc.) a chitarre, beats e elettronica e, udite, udite, mr.
Sol Invictus Tony Wakeford, il leggendario eroe del
neo-folk britannico (qui protagonista a voce e chitarra
tagliente), prendono la tradizione più gotica del neofolk british e della wave più scura e la tinteggiano di
tappeti electro e bassi cavernosi non distanti dall’uso
di Bristol.
Ne esce un disco di wave matura, algida e distante, di
una eleganza unica e non dissimile da un altro disco
del genere che tanto ci era piaciuto, il Venetian Book Of
Dead di Unfolk. Una ottima fusione tra la voce di Wakeford, baritonale e esoterica, spesso raddoppiata da
quella di Fornasari, la chitarra tagliente del menestrello
inglese e i tappeti di elettronica tendente al beat “phat”
dei compagni d’avventura. Ne escono panorami più o
meno astratti (la lenta, sinuosa title track, l’evanescente
God Is Right, il trip-hop made in 4AD di We Took This
Land) o ibridi intriganti (l’ipotesi goth-western di I Am)
che non sono che piccoli esempi di un gran bel disco
inaspettato.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Pitch - Comme Un Flux (Pocket Heaven,
Gennaio 2011)
Genere: noise-wave
Partiti a metà anni Novanta, quando lo standard era il
grunge e il rock in italiano stava per diventare maggiorenne con pietre miliari come Hai paura del buio? degli
Afterhours (a quel disco Alessandra Gismondi contribuirà collaborando alla stesura del testo di Lasciami
leccare l’adrenalina), i Pitch si sono adattati al nuovo
millennio cambiando d’abito con una certa facilità.
Smessi i panni della band rapita da una Seattle punknoise versante Hole non privo di spunti interessanti recuperate Bambina Atomica e Velluto, se li trovate - i
Nostri hanno scollinato nell’Era del Mp3 riprendendo
l’inglese del primo EP (1994) e riconvertendosi alla
wave dissonante/evocativa di scuola Blonde Redhead
con A Violent Dinner. Un disco che tre anni fa è servito
alla “vecchia” guardia (la Gismondi citata in apertura)
per mettere in ordine le idee dopo otto anni di silenzio
e ai nuovi arrivati (Luca Bandini, Christian Amatori e
Nicola Rambelli) per ridefinire i ruoli all’interno della
formazione.
72
Comme Un Flux non cambia di molto le cose. Al massimo le aggiusta e le perfeziona, confermando ispirazione, direzione e buone intuizioni. In un succedersi di atmosfere sognanti francofone (la title-track) e sensualità
(Divine), malinconie urticanti (Breakfast Star) e labirinti
wave (Dna) dal fortissimo imprinting blondrediano.
Del resto i nuovi Pitch (senza parentesi attorno alla P)
mantengono piccole fissazioni e pregi del passato: tra
le prime il bisogno di rientrare in un immaginario riconoscibile - e a suo modo istituzionale - legato a filo
doppio alle passioni di chi suona, tra i secondi la capacità di scrivere ottima musica entro i suddetti canoni.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Resurrextion - Elettro Sud (Relief
Records, Febbraio 2011)
Genere: rap
I bassi e le periferie di Napoli cercano una via di fuga
anche attraverso le vie del rap (e del rap in lingua), lo
sappiamo, dai 99 Posse fino ad AleA. Ecco allora i Resurrextion. Cantato in dialetto e feat in italiano, basi
ora nu-electro (come da titolo) ora ancorate a prestiti
HH commerciale (con tanto di autotune), alla ricerca di
una veracità da sbattere in faccia ai “finti intellettuali”
che sicuramente non apprezzeranno. Sinceri, genuini
e incazzati, i ragazzi parlano di quello che vedono per
le strade (lo sbando degli scugnizzi che per andare a
scuola devono chiedere il permesso allo spacciatore) e
in tivvù (le trimalchionate del berlusconesimo). Si vede
che l’impegno è tanto, il rappato scivola anche bene,
ma sia su questo versante che soprattutto su quello
delle basi è possibile fare molto di più, sforzandosi di
non consegnare a tutti i costi al “pubblico” un’immagine del ghetto de noantri che faccia per forza rima con
truzzo.
(5/10)
Gabriele Marino
Rhyme - Fi(r)st (Bagana Records, Febbraio
2011)
Genere: metal
I Rhyme sono un quartetto lombardo formato da Gabriele Gozzi (voce), Matteo Magni (chitarra), Riccardo
Canato (basso) e Guido Montanarini (batteria) e questo
Fi(r)st è, come da titolo, il loro esordio dopo una autoproduzione molto ben accolta nel sottobosco metal
mondiale. I quattro si muovono infatti sul versante delle musiche pesanti di matrice hard-rock e metal melodico, tutto assoli, stop-and-go, vocalizzi sopra le righe e
cori a squarciagola, non disdegnando però alcune pun-
tate più lente e oscure verso orizzonti post-grunge.
Detto della ovvia centralità della voce di Gozzi, capace di muoversi mobile e personale tra i generi citati in
precedenza, e della inappuntabile perizia tecnica dei
restanti musicisti, il nodo più dolente è la proposta in
sé. Reazionaria, iper-abusata, ancorata a stilemi ormai
triti e ritriti, ha sempre il suo fascino e il suo seguito nei
giri metal, ma rischia di disperdere energie e annoiare
chi non è uso abbeverarsi a questa cup of tea.
(6/10)
Stefano Pifferi
Sailors With Wax Wings - Sailors With
Wax Wings (Angel Oven Records, Ottobre
2010)
Genere: doom, shoegaze
Il fantasma di Stephen Crane infesta la mente del leader dei Pyramids, R.Loren che ne trae ispirazione per
creare un nuovo, allucinato progetto. E che progetto:
Ted Parsons degli Swans e degli Jesu alla batteria, Ian
Fernow alias Prurient a occuparsi del ‘noise’, la voce
dream-folk di Marissa Nadler, il malinconico violoncello di Hildur Gudnadottir, James Blackshaw al
pianoforte, le influenze shoegaze assicurate da Simon
Scott degli Slowdive, Colin Marston dei Krallice a dare
un tocco black metal, Aidan Baker dei Nadja per la
parte sperimentale e persino David Tibet... Il suono non è molto dissimile dagli Jesu (Soft Gardens
Near The Sun, Keep Your Distant Beauty) ma quando gli
ospiti prendono il loro posto (There Came A Drooping
Maid, If I should cast off this tattered coat), il mood si fa
etereo, sospeso in un limbo doom (Yes, I Have A Thousand Tongues And Nine And Ninety-Nine Lie) oppure epico (There Was One Who Sought A New Road).
Classico super gruppo i Sailors With Wax Wings, ma
con un grande pregio: ognuno ha portato una parte di
sé facendo dell’insieme qualcosa di più della somma
delle parti.
(7/10)
Gemma Ghelardi
Sakee Sed - Bacco ep (Autoprodotto,
Gennaio 2011)
Genere: folk-rock
I Sakee Sed sono un duo bergamasco animato da una
devozione storta e alcolica alla tradizione americana
nelle sue molteplici forme. L’esordio dell’anno scorso,
Alla base della Roncola, li vedeva passare con piglio
da bevuta e volontaria noncuranza dei dettagli dal folk
allo stoner, transitando inevitabilmente attraverso il
rock e il blues ma con liriche in italiano di un Caposse-
la imbottigliato o di un Celentano ritrovato alfiere del
rock’n’roll.
Questo Bacco ep ricalca in cinque tracce i passi del suo
fratello maggiore seppure con qualche contorno rifatto. Qualcosa dei Grinderman in una title-track ancora
adatta al Molleggiato e qualcosa degli Zen Circus nel
folk-punk rallentato di Oggi, mentre C’è stato un party
e la bella Tralalala rinnovano un’aurea folkeggiante in
punta di banjo che qui trova atmosfere prima da drinking song e poi da canto alla luna. Repetita Iuvant è
invece stoner fin troppo sguaiato, cui servirebbe una
produzione ad hoc. Ma è una debolezza del tutto perdonabile a degli irriverenti cantori dello sbraco come
lo sono costoro.
(6.5/10)
Luca Barachetti
Scorpion Violente - Uberschleiss (Avant!,
Novembre 2010)
Genere: dark-electro
Efficace esempio di come le nuove generazioni sappiano trarre il meglio da un background musicale ampio
e praticamente illimitato, gli Scorpion Violente. Provenienti dal sottobosco weird-wave che fa riferimento al collettivo semi-massonico Grande Triple Alliance
Internationale De L’Est (da lì fuoriuscirono AH Kraken,
Anals, Normals e Feeling Of Love), i due francesi si
muovono agilmente al confine tra electro, synth-wave
robotica e idm in versione pagana, sfiorando in alcuni
passaggi il dancefloor ebm se non addirittura p-funk.
Proprio al canone del fenomeno dancey più hype del
terzo millennio sembrano rifarsi gli SV, mettendolo
però sotto la lente di mastro Moroder, della grey area
più ossessiva e robotica - vedi alla voce Cabaret Voltaire e TG, ma non solo - e della malignità della cold-wave
synth-driven più minimale ed esoterica. La copertina
sado-pagan-satanica, dopotutto, non è casuale.
Grooves alla !!! immersi in una palude goth-wave (Ray
Ov Gold), techno-spasmi da Aphex Twin autistico cresciuto sotto i vessilli della DDR (13 Ans Presque 17), nichilismo post-Suicide virato dark-kosmische (la title
track), beat-box impazzite a suon di gas nervini e suicide commandos (Fugue De Pute Mineure) e un piccolo
capolavoro come la nenia post-tutto dal titolo Christopher Walken, fanno di Uberschleiss una delle sorprese
dell’anno in ambito weird-wave.
(7.1/10)
Stefano Pifferi
73
mezzo - vi prego di sforzarvi - tra Joanna Newsom e
Belinda Carlisle (Fyre). Carina, certo. Per la magia vera
ripassare fra un po’.
(6.3/10)
highlight
Nicolas Jaar - Space Is Only Noise (Circus Company, Gennaio 2011)
Genere: Ambient house
Nicolas Jaar è stato oggetto di potenti riflettori fin dall’inizio della sua breve e giovanissima carriera. Non
solo lui, a dire il vero. La label alla quale è affiliato, la Wolf + Lamb, ha ricevuto pari se non maggiori attenzioni corso degli ultimi due anni.
Questione di sinergie (un locale diventato culto, Marcy Hotel, padrini d’eccezione - Seth Troxler) ma anche delle giuste spezie che fanno della crew il centro nevralgico dell’house newyorchese più fresca del
momento. E dei numeri giusti a fare del boy il caso nel caso, un culto dentro
il culto fatto di età giovanissima e stile che respira le più svariate culture musicali, in particolare la musica latina (via Villalobos, primo amore giovanile), i
piani preparati di Cage e la pre-ambient di Satie.
Nel 2008, il ragazzo allora diciassettenne presenta una traccia, The Student EP,
ai rampanti dj/producer Zev Eisenberg e Gadi Mizrahi. Questi ne rimangono
affascinati. Non era dance ma neppure non-dance. Una base perfetta per
alcuni remix prontamente affidati a Seth Troxler e Kasper. Jaar sembra già il
nuovo Aphex Twin dell’house, o meglio, visto il piano e l’house che lo lega ai
producer, un cugino di Francesco Tristano; meglio ancora, l’amico americano di quel James Blake con il
quale condivide un altro aspetto fondamentale, la decolorazione dei tessuti neri, il soul e l’errebì. Nicolas è
arty tanto quanto il non molto più vecchio britannico ma il suo è un taglio post-house e pertanto nell’eppì
Time For Us del 2009 (Wolf+Lamb sempre) spuntano voci da annali house à la Dj Sprinkles e quel tocco
latino che fa tanto Ibiza quanto Santiago. In altri mix accadono invece, folgoranti innesti jazz (ama Mulatu
Astatke), sensualità tanghere, sezioni afro e un battito che si assesta al massimo sui 100 bpm.
I punti cardinali attorno al primo long playing sono tracciati. Space Is Only Noise è un prodotto ancora
più rarefatto che reinventa i Thievery Corporation ricollocandoli in una tela d’orologi molli (field recording di vita quotidiana, sample a-ritmici, ancora il piano), un terreno nu ambient decisamente maturato
rispetto agli esperimenti del ’92 al cui sci-fi si sostituisce la cultura world, e uno sguardo globale legato
comunque al celeste (Colomb). Down tempo parola chiave dunque ma senza erbe e cioccolati (Ninja
Tune), un gioco adult piuttosto, tra vocoder evoluti (ancora James Blake) e arrangiamenti senza frontiere
tra elettronico e suonato, solipsismi e chamber music (Sunflower, la eastern musica da camera di To Many
Kids Finding Rain In The Dust).
Il lato USA di quel post-dubstep britannico che da qualche tempo a questa parte vede la luce. Un lavoro
che ristabilisce il dialogo tra bianchi e neri e tecnologia a livelli creativi eccellenti.
(7.4/10)
Edoardo Bridda
Sea Of Bees - Songs for the Ravens
(Crossbill, Gennaio 2011)
Genere: folk pop
Nel bailamme contemporaneo si fa luce una sempre
più palpabile voglia di folk pop sostenuto da un’enfasi
calda, quasi che l’ascoltatore premiasse il musicista che
mette in gioco un bel po’ d’anima e core. La californiana Julie Ann - Jules per gli amici - Baenziger stacca il
ticket e sale su questo trepido torpedone, spacciandosi
come Sea Of Bees e licenziando con Songs For The
74
Ravens un debut album imperniato su un’empatia fiabesca, su germogli di teso romanticismo e tenerezza
retrofuturista.
Ballate folk che vanno a fare il bagnetto nella madreperla, tra nuances sintetiche e brezze acidule, più qualche bruma ad ispessire le scenografie emotive (Marmalade). Immaginatevi una nipotina scafata di Neko Case
invaghita degli Arcade Fire (The Gold, Sidepain), oppure una cuginetta svenevole dei Beach House (Skinnybone, Won’t Be Long) o ancora una carezzevole via di
Stefano Solventi
Seefeel - Faults (Warp Records, Settembre
2010)
Genere: electro-dub,shoegaze
Della reunion dei Seefeel già vi accennammo qualche
tempo fa. Oltre ai due leader storici Mark Clifford e
Sarah Peacock, la formazione vede l’ingresso di Shigeru Ishihara e Iida Kazuhisa, ex-batterista dei Boredoms. Proprio le ritmiche compresse e meccaniche
di quest’ultima sono la base dell’aggiornamento sonico che troviamo in questo EP uscito a settembre e anticipato dalla pubblicazione su Soundcloud della sua
traccia omonima.
In epoca post-dubstep, il mix di rock, ambient e shoegaze che caratterizzava i Seefeel si aggiorna alle novità
dei soundsystem. Faults è un’inquietante e indecifrabile
trama di voci eteree e bassi potenti, una progressione
la cui incompletezza è il principale pregio: le colpe cantano, innocenti, ma picchiano forte nella mente a colpi
di cassa. Crawded e Folds non vengono meno all’intreccio di pattern di batteria, bassi pesanti, chitarre vellutate e acide al tempo stesso, in stile Succour; Clouded è la
traccia più sperimentale e vicina a Ch-Vox, sospesa fra
atmosfere ambient e interventi noise.
L’album, intitolato semplicemente Seefeel, è previsto
per febbraio. (7.2/10)
Gemma Ghelardi
Seefeel - Seefeel (Warp Records, Febbraio
2011)
Genere: psych ambient
Nessuno potrà mai rimproverare Mark Clifford e Sarah
Peacock di non avere il dono della sintesi. Tutta la storia
dei Seefeel è la continua ricerca di leggere il presente
attraverso lenti tanto deformanti quanto rivelatrici. A
15 anni di distanza da quel discusso canto del cigno
che fu (CH-VOX) i due membri storici della band britannica, complici i sodali uomini della Warp, arrivano
a consegnare alle stampe un disco nuovo, che ha il
sapore della rivincita. Complici una “air du temps” da
fine decade e una sezione ritmica completamente rinnovata con il bassista Shigeru Ishihara e l’ex batterista
dei Boredoms, Iida Kazuhisa, questo disco omonimo
fotografa perfettamente gli anni che stiamo vivendo
meglio di qualunque articolo o trattato musicale.
Se lo storico Quique era una riuscitissima polaroid dei
primi anni ’90, con il suo geniale idioma trance che
anticipava quasi tutto quello che di li in poi si sarebbe
chiamato post-rock, il nuovo omonimo pur non avendo
la stessa carica preveggente dice chiaramente alcune
cose sugli anni presenti che val la pena di sottolineare:
1. Usciamo fuori da una decade di animalismi collettivi
dove l’elettronica e il folk spesso si sono dati l’un l’altro
un abbraccio mortale (o vitale a seconda dei punti di
vista). Non a caso un generale humus bucolico e pastorale (finanche terzomondista ) salta fuori tra le spire
astratte dei loro consueti liquidi turbinii elettro. Faults
aveva già indicato questa direzione, ma ancora meglio
fanno brani come Dead Guitars e Airless.
2. Se è vero che il dub è sempre stato una loro chiave di
volta, questo disco merita di essere considerato come
la loro massima espressione in tal senso. Complici la
pesantezza tutta analogica della sessione ritmica, brani come Rip-run e Making riescono a far dimenticare i
corridoi neurolettici di Succour finendo con l’arrivare,
in molti punti, vicinissimo a gente che pur trafficando
col dub partiva da premesse completamente diverse
come gli ultimi Gang Gang Dance.
3. Quello che ormai rimane dell’ascendenza shoegaze
è ridotto al contorto fuzz elettronico di una serie di drones mandanti in reverse e controreverse, da un mixer
mai come ora usato in maniera strumentale. Clifford
e Peacock ottengono così una serie di manipolazioni
masturbataorie (è il caso di bozzetti indefiniti come
Gzaug e Sway) dove le frequenze vengono tirate e ritirate fino allo spasimo disegnando una serie di astratti
eden dell’oltre umano - “zones without people” direbbe
qualcuno - che odorano della stessa psichedelia sintetica in voga presso i “new age punksters” di quest’ultimo
lustro.
E’questa, dopo una decennio, la storia del (non) rock
secondo i Seefeel.
(7/10)
Antonello Comunale
Shriekback - Life In The Loading Bay
(Malicious Damage, Dicembre 2010)
Genere: wave-funk
Life In The Loading Bay è il dodicesimo disco degli
Shriekback ed è anche un’opera probabilmente destinata allo zoccolo duro dei fans del gruppo. O per
lo meno a chi ne saprà apprezzare i dettagli sonori ricercatissimi, cristallizzati in un limbo temporale tutto
sommato nostalgico - gli Ottanta wave inglesi - e fissati su una mescolanza di crooning à la Nick Cave (la
Pointless River corrispettivo della caveiana Brother, My
75
Cup Is Empty o magari Nowhere Nothing Never) e funk in
stile Prince (Loving Up The Thing), singulti Julian Cope
(Now I Wanna Go Home, Running With The Mothmen)
ed elettronica algida su fondali di sintetizzatore (In The
Dreamlife Of Dogs).
I tempi del synth-pop-wave veloce dell’esordio Tench
sono ovviamente lontani e la band si rivela un’abile manipolatrice più preoccupata della sua naturale eleganza che dell’impatto ideologico che la propria musica
potrebbe avere sulle nuove leve. Come testimoniano
certe distese di pianoforti caraibici su percussioni tenebrose, le ipotesi R.E.M tra drum machine e bassi ripieni,
i paesaggi inquietanti costruiti sul groove. Impeccabile
la ricerca di nuovi dettagli da sommare al background
giovanile, sospesa tra indagine consapevole e rassicurante ritorno a casa.
(6.7/10)
Fabrizio Zampighi
Smart Cops - Per Proteggere E Servire (La
Tempesta Dischi, Febbraio 2011)
Genere: punk
Brucia più in fretta di una sigaretta l’esordio degli sbirri
con più classe del mondo. Quartetto rock per antonomasia, Nicolò Fortuni (voce, ex With Love), Marco Rapisarda (basso, ex-tutto, attualmente Crocodiles e Blank
Dogs e padre di Hell! Yes), Matteo Vallicelli (batteria)
e Edoardo Vaccari (chitarra) sono un concentrato di
energia punk sboccata e anacronistica, dritta in faccia
e nichilista, ma proprio per questo viva e genuina.
Belli, giovani e cattivi. Fasciati in uniformi all-black sparano un concentrato di punk ’77 made in NY (Ramones
e Dead Boys su tutti) con influenze garage e beat italiano dei sessanta letteralmente irresistibile. Di quello
che ti fa muovere il culo come un ossesso pure seduto
al computer e cantare a squarciagola ironici inni singa-long debosciati, pungenti, irriverenti e appiccicosissimi. Sempre irrimediabilmente contro, anthemici a
nastro e intelligentemente sempre sul crinale del doppiosenso tra il di qua e il di là della barricata: menzione
speciale per Facile Bersaglio e il suo indimenticabile ritornello, per l’outing insabbiato di Meglio Insabbiare (il
dispiacere di dire a mia madre che ero gay
ti cucio addosso la divisa prima che se ne accorga) e per il poliziotto
imbranato di La Legge Del Più Debole.
Un trittico d’apertura letteralmente da sballo - il garage-rock sguaiato e fuori luogo di Realtà Cercami,
il surf-psychobilly cavernoso di Vesciche Di Guerra, il
punk’n’roll tutto stop&go di Il Cattivo Tenente - mette
al tappeto in 5 minuti netti, ma è tutto a scorrere veloce e impazzito sulle stesse coordinate: voci incazzate,
76
insieme diafane e melodiche su un carrarmato punkgarage-rock senza freni.
Roba a originalità zero. Ma di quella che se fatta bene
come in questo caso, si torna subito ai vent’anni. Per
certe musiche, miglior pregio non può esserci.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Smith Westerns - Dye It Blonde (Fat
Possum, Gennaio 2011)
Genere: neo power pop
Tempo di sophomore per gli Smith Westerns, che in
occasione dell’omonimo esordio si spacciarono per
l’ennesima band lo-fi con parecchia voglia di guadagnarsi la cresta dell’onda. Missione quasi impossibile,
salvo tentare con un’aggiustatina di rotta. Ecco quindi i
quattro ragazzi di Chicago ripresentarsi vestiti di fiammanti abiti power-pop con sfrangiature glam e blandi
ammiccamenti al britpop (in particolare quello dei primi Oasis e degli ultimi Suede).
Carinerie e baldanza a profusione, una chitarra capace
di arguta spavalderia (vi basti quel che combina nella guizzante Weekend), romanticismo caramellato di
spersa inquietudine Sixties, arpeggi tintinnanti e retrogusto vaudeville compresi. Proposta a pronta presa
che si guadagnerà posizioni di prestigio nella classifica del cool. Quanto alla profondità dell’impatto, mi sa
che è argomento del tutto trascurabile. Dye It Blonde
sembra uno di quei dischi in grado di accompagnarti
deliziosamente per un paio di settimane. Al massimo.
Se sia tanto o poco, considerati i tempi, lo lascio alla
valutazione del lettore.
(6/10)
Chi infine ha sentito Fool Bloom, prima opera lunga licenziata sotto la sigla SC, si aspetterà qualcosa di percussivo, ma anche etero, lunare, cosmico. Di certo “underground”, all’opposto di quello che di fatto è Shore
Obsessed: disco di synth pop raffinato figlio sì di New
York, ma di quella di fine anni Settanta e inizio anni Ottanta, mutante, terzomondista e popolarmente intellettuale. Il rumore e le sfaccettature del caso scompaiono dalla penna e specialmente dagli arrangiamenti di
Shore Obsessed. Eppure, fatta eccezione per alcuni episodi evitabili (come First Time, che purtroppo, essendo
il brano iniziale, mette una disposizione d’animo non
certo incline a proseguire), plausibilmente chi è curioso di capire cosa sta succedendo vedrà stemperare il
rifiuto iniziale. Barhoocha è risalito alle origini di quel
suono “tribale” e intellettuale che ha re-invaso NY, e
quindi alle esperienze di David Byrne, Talking Heads,
il Brian Eno conseguente - e quello di Before And After
Science (Treading Water, Bad Habit).
Hisham si è ritrovato fuori dal giro, lontano anni luce
dalle atmosfere di Fool Bloom e, guardandosi allo
specchio, si è visto sereno e sostanzialmente pop,
con il rischio, non sempre evitato (Reaper), di risultare peggio degli altri emuli odierni. Chissà se tutto
ciò non comporta la ricerca di un giro più grande,
oppure semplicemente l’ennesima operazione intellettuale, basata su un ritorno al passato, passatista,
facile a dirsi, e che comunque non dichiareremmo
imprescindibile. Anche se il modo di spiazzare l’uditorio si guadagna un tentativo per scavare nell’imbarazzo iniziale.
(6.5/10)
Gaspare Caliri
Stefano Solventi
Soft Circle - Shore Obsessed (Post Present
Medium, Dicembre 2010)
Genere: synth-tribalpop
Se conoscete Hisham Bharoocha, la prima reazione
all’ascolto di Shore Obsessed sarà probabilmente il rifiuto. Un giudizio che sarà dipeso dal grado di approfondimento sul personaggio, e ad ogni modo difficilmente
evitabile. Avendolo appena sentito nominare lo assocerete probabilmente a Brooklyn, forse a Black Dice e
Lightning Bolt, band in seno alle quali è avvenuta la
formazione del Nostro. Oppure forse ricollegherete il
suo nome e il moniker Soft Circle all’ondata New Tribal
America, che affrontammo qualche anno fa - Hisham
partecipò infatti ad alcune delle vicende più significative della storia, come il 77 Boa Drum, e l’88, l’anno
dopo.
Spagetti Bolonnaise - Disco 1 (42,
Dicembre 2010)
Genere: beat avant pop
Sono un quintetto dal veronese messo insieme con
elementi di My Awesom Mixtape, Fake p, Lava Lava
Love, I Got A Violet e quant’altro. Hanno in testa un’idea
immediata e complessa (o viceversa, fate voi) che essi
stessi usano definire “ultrapop”. Come suona? Tipo uno
squillante miscuglio di errebì e beat condito di elettroniche cosmico/patafisiche al neanche troppo vago
aroma canterbury, ventaglio di codici che agli estremi
prevede estro indie-pop e sussulti sincopati para-prog.
Pur targati Vaggimal, gli Spaghetti Bolonnaise - che
come tutti sanno è un ragù ipotetico, inesistente nel
ricettario tradizionale ma onnipresente nei menù turistici all over the world - colgono l’opportunità offerta
da 42 Records e confezionano un brillante grano per
la collana 24 (un EP al mese ogni 24 del mese) in free
download.
Cucinato con voce, basso, moog, batteria, clarinetto e
sax (tenore e contralto), questo Disco 1 merita attenzione per il balzano entusiasmo, la garrula inconsuetudine, l’intelligenza ficcante. Sei tracce abitate da spiriti
mattacchioni come le fregole Hidden Cameras ingrugnite Morphine di Backscratching, i Kinks giocherelloni di Cave Canem e quelli invasati Van Der Graaf Generator (!) di Warburg, gli Style Council corroborati Belle
And Sebastian di A Large Amount of Useless Information, mentre di Dedicated to Wyatt but Wyatt Wasn’t Listening il titolo dice molto se non tutto. Ci sono idee, c’è
voglia, impudenza, dinamismo e sagacia. Una spolveratina d’intensità non guasterebbe (chiedere lumi agli
chef Mariposa), ma come antipasto direi che ci siamo.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Stateless - Matilda (Ninja Tune, Febbraio
2011)
Genere: electro, trip-hop
Il quartetto di Leeds in sophomore ripropone stilemi
che spopolavano nei Novanta infatuati di post-jungle,
trip hop ed etno- pop. Quei suoni che James Lavelle
con i suoi UNKLE ha saputo esaltare al massimo grado
(usando tra le altre anche la voce di Thom Yorke, uno
dei riferimenti del combo britannico) vengono estratti
dal cappello a quasi vent’anni di distanza. La soluzione
si impasta giustamente nelle corde dell’eclettica Ninja
Tune, ma non garantisce la sorpresa di un remake costruttivo: a tratti sembra soffrire infatti di una retrodatazione che risulta un po’ stantia.
Sebbene la vocalità sia intensa (ricalcando le soluzioni di Bono mescolate a Lanois ed Eno) e i ragazzi stiano sul pezzo, l’atmosfera di questo Matilda può andar
bene per qualche ascolto, ma alla lunga si impolverisce,
confinandosi al massimo a un buon trompe l’oreille da
sottofondo per localini trendy.
Tra gli ingredienti più intriganti restano le ballad che ricalcano Jeff Buckley (I’m On Fire), le collaborazioni con
DJ Shadow (altro patron di quei bei tempi andati), la
produzione di Damian Taylor (Björk e Prodigy), gli archi
del Balanescu String Quartet e la voce di Shara Worden
dei My Brightest Diamond. Buoni i propositi, ma c’è ancora un po’ da lavorare. Take your time, guys.
(5.9/10)
Marco Braggion
77
Streets (The) - Computers And Blues
(Atlantic Records, Febbraio 2011)
Genere: White slaker hiphop
Mike ritorna a farsi fotografare dalla palazzina - è uno
studentato a Norwich - e già la cosa ci gasa. E’ la cover
di un album dark e futuristico, ha confidato alla stampa, una svolta rispetto al buonismo soul-hop del precedente Everything Is Borrowed e, dunque, un probabile
ritorno allo skinner che avevamo amato tanti anni fa
con l’indimenticato Original Pirate Material. Campale
sul sito poi la scritta lapidaria: the final The Streets album, il lavoro definitivo: l’ultimo probabilmente sotto
questa firma. Un disco ballabile, dove ci puoi bere il the
sopra con sonorità rave e qualche smalto philly, intriso
comunque di una britannicità impossibile da grattar
via. E’ tutto vero, o quasi, quello che si ascolta in Computer
And Blues: una tracklist più upbeat, i pallosi cori tormentone soulful finalmente sotto sedativo e una rinvigorita verve a unire su basi compatte (garage, hip-hop, uk
bass tutta) le clip alt/arty, lo slack flow e gli ingredienti
dell’uomo che i fan conoscono bene e le cose che lo
hanno reso star internazionale.
Mike alza la testa ed è ancora in grado di segnare degli
high score: non spaccherà sulle basi à la Magnetic Man
di The Robots Are Taking Over, con le rime fiacche di In
The Middle o le gigionate in salsa mexi-ragga di He’s
Behind You, He’s Got Swine flu, ma funziona alla grande,
soprattutto a inizio scaletta, con numeri tra crudezza
geezer, hard step e savoir faire Bass con la B maiuscola
(I Love My Phone, Daivd Hassles, Skills On Toast).
Troviamo nell’album una potenziale summer hit a base
di soft rock e memorabilia 80s (Trust Me), un nuovo
episodio post-Kinks nella uptempo See If They Salute,
ma ciò che s’apprezza di più è il formato che alterna
cruderie e raggi di sole, lo stream urbano tornato veramente urbano (dopo le saghe personali sul successo e
le depressioni al giro dei trenta) e la parlata monotono
che ricongiunge ghetto e quadretti kenloachiani, free
form e narrativa di amori periferici. Che le ballad non
gli escano più come un tempo (A Blip On A Screen) non
è un fatto da sovradimensionare in un album così diretto e ben prodotto. Goodbye?
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Sven Kacirek - The Kenya Sessions (Ping
Pung, Febbraio 2011)
Genere: ambient-africana
Sven Kacirek è sia un seguace del ritorno al suono
suonato - almeno per quanto concerne le percussioni
78
- sia un produttore d’elettronica, che non vuole però
rinunciare alle evoluzioni ritmiche degli ultimi decenni.
La verità per lui sta in mezzo - vedi il libro a sua firma
dedicato a come suonare - con le pelli - drum’n’bass e
altri suoni computerizzati del 2000.
Troviamo un surrogato di questo approccio in The
Kenya Sessions, album frutto di un viaggio in Africa
che per il Nostro è stato folgorazione di suoni, (poli)
ritmi, e voci autoctone, nonché il risultato di una stratificazione esperienziale, o di un “ritorno” in un moto
uguale a quello dal digitale all’analogico, seppure qui
condotto dal Sud al Nord del mondo (per dirla come lo
fanno le note di copertina, “recorded in Rangala Village
and Jafferstrasse no. 10”).
La chiave dell’album è la sovrapposizione di sensibilità, che a volte produce strane alienazioni tra l’euforia
africana e l’emotività repressa delle lande europee (Paperflowers, Vuvuzela In White). È curiosa questa “restaurazione attenta” in un mondo che valuta le possibilità
delle tecnologie, come quello dell’elettroacustica. E
forse le voci keniote e somale nascondono la stranezza dell’operazione, dandoci esempi di armoniosi crash
culturali, più che programmi di ribellione alla logica
mcluhaniana.
Ad ogni modo, sembrano a volte sopravvivere a se
stessi più i primi piani “terzomondisti” (Walk To Rangala, scritta dalla Rangala Village Community), affiancati
ad autorialità miste dello stesso Kacirek con autori africani (Old Man Small Studio, composta insieme a Owino
Koyo), nell’economia del disco, piuttosto che le sofisticazioni percussive contrappuntate - ma da lontano - di
canti popolari delle comunità locali (Headphones & Headdress).
Parafrasando, è lo “stare là” che dà la tenuta a The Kenya Sessions, non il “tornare qua”.
(6.9/10)
Gaspare Caliri
Sybiann - Sybiann (Glue, Dicembre 2010)
Genere: post-punk / wave
Trentun minuti di tribalismi, droni, chitarre accuminate,
echi claustrofobici. In testa i Liars, tra i coetanei i Buzz
Aldrin e a santificare quest’orgia post-punk da disadattati Birthday Party, Joy Division e pure certi Animal
Collective vestiti a lutto (Monsoon Breath). Per il loro
esordio lavorano d’intuito i romagnoli Sybiann e fanno
bene, perché è proprio l’irruenza un po’ naïf a salvarli
dalla morte certa riservata agli epigoni troppo fedeli
della band newyorkese citata in apertura. Concentrandosi più sulle soluzioni semplici che sui massimi sistemi (l’assioma ritmico, la convergenza tra sintetizzatori e
highlight
Sic Alps - Napa Asylum (Drag City, Gennaio 2011)
Genere: lo-fi psych-rock
Uno slittamento quasi impercettibile, quello dei Sic Alps. Dal sottobosco weird di Siltbreeze, Woodsist,
Animal Disguise e molte altre label ancora, al catalogo indie ma non troppo della Drag City. Il passo c’è, lo
scarto pure, anche se non sembra così evidente.
Giunto alla fatidica prova del terzo album il trio californiano - a Matt Hartman e
Mike Donovan si aggiunge alla seconda chitarra l’ex Comets On Fire Noel Von
Harmonson - chiude definitivamente più di un cerchio. Nella propria carriera e
anche all’interno del catalogo della nuova etichetta: non solo cortocircuitando
la slackerness Pavementiana con l’atteggiamento sperimentale e irriverente
dei Royal Trux sul corpo morto della tradizione americana, ma proponendo
questa propria idea di “classicità del lo-fi” in forme meno frammentate che in
passato. Rendendosi più intelligibile e coeso, più maturo verrebbe da dire se
non fosse quasi un ossimoro; quasi che il passaggio ad una label più nota - e di conseguenza ad un pubblico più ampio - abbia spinto il terzetto di San Francisco a compattare quella frammentata, errabonda e
centrifuga energia che da sempre ne contraddistingue le uscite (U.S. Ez, su tutte) in forme brevi, apparentemente abbozzate eppure perfettamente compiute.
Liturgia rock in ogni salsa - dal blues al country, dall’hard-rock al garage-rock, al folk c’è veramente di tutto:
liofilizzato, citato, maltrattato as usual - e attitudine sixties psych sempre affrontata con passo claudicante,
andatura indolente e semi-narcolettica, atteggiamento di distacco quasi indisponente: questa è la cifra
caratteristica dei Sic Alps. Lo è da almeno un quinquennio e questo ci basterebbe. Se poi ci aggiungiamo
l’ulteriore passo in avanti nella elaborazione di una sorta di liofilizzazione delle istanze lo-fi degli anni ’00,
ecco che avremo uno dei migliori gruppi in circolazione. E non lo scopriamo oggi.
(7.3/10)
Stefano Pifferi
batteria, i crescendo improvvisi), suggerendo ambienti
inaspettati costruiti sulla chitarra elettrica (Lucid Dream), giocando con i volumi tra raga, soundscape e psichedelia (l’ottima Talkin With Nature Inside The Barrell).
Il risultato è un disco dall’andatura irregolare, sunto efficacie di suoni spigolosi e velleità chimico-espansive.
Un salto senza rete di sicurezza cui si perdonano volentieri certe interferenze legate alle passioni più umorali
della formazione (nello specifico, il fac-simile Oneida
della scapicollante Embryo) in virtù di una personalità
già formata e poco avvezza ai formalismi consolidati.
(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Take That - Progress (Polydor, Novembre
2010)
Genere: synth pop
Il ritorno di Robbie Williams nella ex-boy band più
famosa del globo ha fatto alzare la colonnina di mercurio, tanto che i concerti per il tour, prima ancora che
uscisse questo sesto lavoro, sono andati esauriti in
pochi istanti, facendo pure crashare la rete. Dal 1995
- anno in cui il non-più-ragazzo ha lasciato il gruppo nel pop internazionale ne sono successe di cose. Lady
Gaga, M.I.A., Ke$ha e tanti altri nuovi volti hanno preso
piede, cristallizzando le boys band a fenomeno di costume Novanta. Ha senso farsi troppe pippe interpretative su una nuova reunion? Non molto. Ormai siamo
abituati alle rimpatriate, siano esse nuovi inizi o mere
operazioni commerciali. Per leggere il testo’ che ci
propongono i That, è meglio ripartire da zero, senza
pregiudizi.
E da zero ripartono pure loro, affidandosi a Stuart Price,
aka l’uomo-dai-numerosi-alias-che-ha-fatto-rinasceredalle-ceneri-pure-Madonna. Jacques Lu Cont mette
pesantemente lo zampino nelle dieci tracce di questo
Progress e il suo intervento si sente tutto: vaghi ricordi à
la Bowie (Affirmation), l’onnipresente citazione di Mika
(What Do You Want From Me?), il synth rock da dancefloor delle Scissors Sisters (SOS), pomposità baroccoUK per Elton John (Eight Letters) e il singolone promozionale già visto su tutte le TV e le radio del globo (The
79
highlight
Voices Of Black - Plastic Dolls (Wolf + Lamb Music, Gennaio 2011)
Genere: Glo-House
Perfetta per fare di desiderio, cosmesi e forme plastiche un tutt’uno, l’house è stata la colonna sonora
degli stilisti da vent’anni a questa parte almeno. Storicizzandosi è diventata la soundtrack delle ritualità
del mondo della moda e di un tempo libero vissuto in sinergia ai dettami edonisti. In pratica, l’house è
perfetta per restituirti un’idea supersexy e allo stesso tempo tutta glossata,
un gioco onanista che mescolandosi a caldi groove e immagini tattili può
diventare facilmente ossessivo.
Lo sanno bene i Daft Punk e lo sanno pure i Voices Of Black (al secolo i
poco più che ventenni Babatunde Doherty e Julian Randolph) che hanno
pensato di farci un concept album, raccontandoci in 4/4 un day in the life’
di una modella. L’idea - venuta al duo mentre guardava ad audio spento uno
speciale su Ana Beatriz Barros - è stata realizzata grazie a un massiccio uso
di campionamenti “descrittivi” l’universo dentro e fuori la passerella, ma anche rubacchiando con il fare dell’hip-hopper slacking tutto un intorno di femminilità in dischi altrui (da
lì molti frammenti eclettic, tra cui anche il mito soul Sade). In questo notiamo un interessante e quanto
mai improbabile accostamento con le mosse dei glo-fiers di qualche tempo fa, dato che il loro sguardo
traguarda anche ere musicali ormai più che storicizzate (i loro eroi dichiarati sono Fela Kuti, George Clinton e J Dilla).
Plastic Dolls è uno spasso ben congegnato perfettamente nelle corde della deep house creativa dell’ormai
superhyped label Wolf+Lamb. Magari a tratti potrebbe risultare troppo fumato (All Must Conclude) nel
mescolare narrative synth, canto campionato e la psych svagata e vintage, ma è un’ottima traduzione
della felinità in un gioco intrigato e intrigante, variegato e non senza ironia. Ci troviamo ben dosate spezie
disco, frammenti soul, filtri, funk, 80s e una good vibration da House party senza tempo che si diffonde
per tutto il disco e che ci fa ricordare che le cose possono ancora girare bene nella dance.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Flood in Italia è passato pure a X-Factor). Insomma un
frullato di ricordi da visibilio barocco come solo gli inglesi sanno promettere e in più quel tocco modaiolo
da dancefloor che non guasta per la top five.
Un disco che nella stampa inglese ha sbancato, ma che
da noi - prescindendo dai fan - sarà presto destinato
all’oblìo. Ricordi Novanta senza ballads - non c’è una
nuova Back For Good per intenderci - non bastano a
far gridare al miracolo. Anzi, dato che il riciclo è stato
promosso da interviste ufficiali che predicavano un’innovativa crescita introspettiva che alla luce dei testi risulta solo paventata, il risultato è l’ennesimo affidarsi
al buono e bravo lifting del produttore di turno. L’unica curiosità rimane l’attesa per un loro live. Conoscete
qualche bagarino?
(5/10)
Marco Braggion
80
Talons’ - Songs For Boats (Own Records,
Febbraio 2011)
Genere: lo-fi folk
Già membro dei bedroomers Trouble Books e dei
post-rockers Six Parts Seven, Mike Tolan è un chitarrista di New Philadelphia, 50 miglia a sud di Akron, Ohio.
E’ però durante un soggiorno in Spagna che ha concepito questo Songs For Boats, secondo lavoro uscito
a nome Talons’ su Own Records tre anni dopo Songs
For Babes. Se quello metteva in fila pezzi ispirati ad altrettante figure femminili, questo - ma guarda un po’
- si dedica ad imbarcazioni di vario ordine e grado, altrettanti pretesti poetici ovviamente per una calligrafia
che insiste a costeggiare placide rive lo-fi folk.
Basale, etereo, indolenzito, Tolan tratteggia atmosfere
col carboncino che poi spennella di bave acquarello.
Chitarre acustiche, field recordings agresti, evanescen-
ze di tastiera ed il canto tiepido tratteggiano bozzetti
con la delicata pregnanza d’un Will Oldham letargico
o del Jason Molina dei minimi termini, talora rievocando la pregnanza impalpabile di certi Red House Painters o il gracile trasporto dei Sodastream. Tra dolce ipnosi e inevitabile tedio, le dodici tracce scorrono come
increspature dell’aria.
(6.7/10)
Stefano Solventi
Tapes N Tapes - Outside (Ibid, Gennaio 2011)
Genere: Indie-Rock
Rientro sulle scene per quei Tapes N Tapes che qualche anno fa ci avevano positivamente impressionato
con Walk It Off. Per questo nuovo Outside il quartetto
del Minnesota abbandona la XL Recordings e, come ai
tempi del primo The Loon, ripiega su un’autoproduzione. Nel frattempo però, qualcosa sembra cambiato.
Se l’iniziale Badaboom rende nuovamente lecito il paragone con l’indie-rock più sgangherato e spigoloso
dei vari Clap Your Hands Say Yeah, i brani seguenti suonano molto più nitidi rispetto al passato, come
se si fosse voluto semplificare le strutture e ripulire il
suono. Avrebbe potuto essere una scelta azzeccata se
il gruppo avesse sviluppato di pari passo un adeguato
talento per la melodia, invece la maggior parte dei brani scorre via senza alcuna sorpresa. Da un lato, assistiamo ad un’innocua contaminazione con altri generi, dal
country al rock’n’roll, dall’altro ad una caccia al ritornello accattivante che quand’anche si concretizza (One In
The World, People You Know) non porta con sè nulla che
gruppi come Vampire Weekend non abbiano sviluppato in maniera più convincente.
Nella seconda metà dell’album le cose si fanno più interessanti, soprattutto quando intervengono l’andatura languida di Hidee Ho e il crescendo rumoroso di On
And On: le due tracce su cui il gruppo dovrebbe puntare qualora volesse ritrovare la propria freschezza. Per il
resto, dei Tapes N Tapes che ricordavamo rimane giusto qualche eco sullo sfondo: qua e là un riff di chitarra
meno prevedibile o un verso urlato quando, mediamente, tutto sembra tenuto a freno. Perfino un singolo
tiratissimo come Freak Out, che dovrebbe procedere
a briglia sciolta, segue un canovaccio assolutamente
banale. C’è qualcosa di forzato in queste nuove tracce,
una sorta di snaturamento che non convince e lascia il
gruppo a metà strada tra se stesso e un profilo più alto
ma poco consono all’attitudine sviluppata fin qui.
Preso per ciò che è, Outside risulta dunque niente più di
una gradevole raccolta di canzoni; nella discografia dei
Tapes N Tapes, invece, è sì un passo avanti in termini di
accessibilità ma pure un rischioso muoversi in direzioni
meno personali, dove la forma vince sulla sostanza.
(5.9/10)
Simone Madrau
Teenage Panzerkorps - German Reggae
(Holidays Records, Gennaio 2011)
Genere: Post-punk
I punk teutonici più amati d’America tornano con un
nuovo full-length e nel farlo scelgono una delle etichette italiane più attente e attive degli ultimi tempi.
Dopo ben due LP su Siltbreeze, il combo yankee-tedesco decide di darsi una smossa per quanto possibile
all’interno dei limiti non morbidi del genere.
Non resta quindi che rivedere ritmiche e tempi, la patina di doverosa bassa-fedeltà e l’intramontabile amore
per Fall, Joy Division e compagnia d’Albione, elementi
amalgamati in chiave personale dal marchio di fabbrica dei Carristi Adolescenti: il cantato scandito in lingua
madre dal mercuriale Bunker Wolf.
E’ del resto la componente ritmica la vera novità di
German Reggae che, già dal titolo, predispone ad un
lungo auf wiedersehen ai 4/4 asettici ed immutabili
degli album precedenti. La scena si riempie di sincopi
sconnesse (Our Health), tribalismi percussivi tanto indiavolati quanto inusitati (Metal Seeds, Human Animal
Burial), incursioni marziali dal retrogusto industriale
(Kampflust) e jam narcotiche con il fantasma di Mark E.
Smith a scrutare dall’ombra (Machine Racists).
Un modo indubbiamente interessante di rinfrescare
una proposta già notevolmente efficace ma che, protratta oltremodo, avrebbe cominciato a mostrare i primi segni di cedimento. Pericolo scampato con maestria
ed astuzia.
(7.2/10)
Andrea Napoli
Tiny Tide - Febrero (Kingem, Febbraio
2011)
Genere: lo-fi pop-rock
A poche settimane da MoonTalking, è già tempo di
un nuovo album per Tiny Tide, la creatura “indie pop
arcade rock” del cesenate Mark Zonda. Lo ha intitolato
Febrero - febbraio in spagnolo - perché a suo dire è il
mese in cui accadono gli eventi cruciali della sua vita.
Particolare non da poco, perché sottolinea in qualche
modo l’intimismo disarmante, il mettersi in gioco senza rete di protezione, la deliziosa vulnerabilità emotiva
che già abbiamo avuto modo di apprezzare nei precedenti lavori. Zonda è un entusiasta, innamorato della
musica indipendente e di tutte le sue premesse, che si
81
chiamino David Bowie o Left Banke, Primal Scream
o Ash, Beatles o Elliott Smith.
Malgrado uno sforzo maggiore in fase di produzione tanto che si è spinto a coinvolgere band come gli svedesi Stars in Coma, i britannici Brigadier e lo statunitense Anthony Rochester - la dimensione lo-fi è il timbro
predominante, come una patina sulla pelle del suono
e una cartilagine che frastorna le strutture. Quattordici
le tracce all’insegna di un power-pop intorpidito psych con una vena wave che pulsa a intermittenza, ora
arty, ora sbrigliata e ora tesa. Un carosello attraverso
tormenti dolciastri ed enfatico sdilinquimento (Kitty Jesus, quella Mask Me Mask Me Mask Me che sembra Jens
Lekman alle prese col repertorio Smiths), tra strali
glam e hardcore-pop (Silver Star, Ginger Genie), trepidazioni brumose (A Song For EMI) e sussulti melliflui (il
batticuore Badfinger di Scrambled Eggs, una February
che sa scozzare Steve Wynn e Scott Walker).
Se è piacevole gia di per sé questo senso di frugale
devozione, di entusiastico sbattimento, occorre aggiungere che Zonda sa tirare fuori dal cilindro pezzi
di tutto rispetto. Roba tipo una Tiny Trains o quella Valentine Disco Night (i Roxy Music ipnotizzati da Robyn
Hitchcock?) che con adeguata produzione - fatemelo
dire, anche se può suonare antipatico - t’immagini a
lambire le playlist che contano. Restiamo in attesa di
sviluppi.
(7.1/10)
un denominatore melodico arrangiativo che rimane
sostanzialmente inalterato dall’inizio alla fine. Nell’era
della Rete, lo sappiamo, l’operazione è funzionale, ma
da un punto di vista prospettico, potrebbe risultare carente. Come primo step non pretendiamo di più.
(6.4/10)
Stefano Solventi
Fabrizio Zampighi
Treefight For Sunlight - A Collection of
Vibrations For Your Skull (Bella Union,
Febbraio 2011)
Genere: chamber pop
Ci piacciono le operazioni di depistaggio geografico,
qui ben rappresentate da un quartetto pop tutto sole
californiano che però ci arriva dalla Danimarca. Mathias
Sørensen, Morten Winther Nielsen, Christian Rohde
Lindinger e Niels Kirk sono i loro nomi e si sente fin dalle note dell’iniziale Dream Before Sleep che il nume tutelare è uno e uno soltanto: Brian Wilson. La mezz’ora
di quest’esordio per l’etichetta di Simone Raymonde è
tutta intrecci di armonie, falsetti e chitarre jangle che
oltre ad aver mandato a memoria la lezione del surf dei
Beach Boys ma attualizzata agli MGMT (seppure in
versione meno trippy).
Funziona lo zucchero che si scioglie al sole del singolo Facing The Sun (che nel ritornello si accende come
i migliori Belle & Sebastian) o l’affondo della marcietta Hidden Cameras di What Became of You and I,
il problema semmai è l’appiattimento della tracklist su
82
Marco Boscolo
Tupolev - Towers Of Sparks (Valeot,
Febbraio 2011)
Genere: jazz / post-rock
Austriaci, provenienti da altre esperienze musicali e
collaborazioni d’avanguardia (Port-Royal, Slon, Protestant Work Ethic, Werner Kitzmüller Trio, Primordial
Undermind), i Tupolev arrivano con Towers Of Sparks
al secondo disco lungo della loro carriera, dopo il Memory Of Björn Bolssen di due anni fa. Tutto resta confinato a un jazz ibrido pianoforte, violoncello, batteria,
elettronica che flirta con la classica e con i classici (Keith Jarrett in testa), si concede qualche parentesi free e
ricorda in qualche maniera il post-rock. Una parentela
quest’ultima più umorale che definitiva, rintracciabile
nella tendenza della musica a creare spaccati capaci
di giocare con l’intensità, la topografia e l’architettura,
senza mai scadere in eccessi cerebrali.
Il risultato è un disco complesso, angolare e tutto da
decifrare.
(6.7/10)
Twilight Singers - Dynamite Steps (Sub
Pop, Febbraio 2011)
Genere: rock noir
Ritorno a casa per Greg Dulli? Meglio, un ritorno fiero
e cocciuto a se stesso, passando dai vari stadi attraversati sul vascello Twilight Singers, per appordare alla
chiave rock sovraccarica, dannatamente ed eccessivamente noir, perpetrata coi gloriosi Afghan Whigs. Ebbene, questo Dynamite Steps - sesto album targato
TS un lustro dopo il più che discreto Powder Burns
- suona come se fosse stato realizzato subito dopo il
canto del cigno dei Whigs (1965, uscito nel ‘98), tanto
appare come un tentativo di ripartire da quell’impetuoso impasse mettendo a punto il tasso psichedelico, irrobustendo la fibra folk ed azzardando organiche
suggestioni electro.
Se non suona come la rianimazione forzata di un cadavere è perché Dulli artisticamente ha già oltrepassato
la zona morta, è uno splendido zombie a sangue caldo
da indicare come esempio alle nuove generazioni. La
sua è una calligrafia inconfondibile, un conflitto che
cammina: cuore soul, estro rock e malanimo incurabile
pasturato a cinema e letteratura noir. Tutto già ampiamete ed esaustivamente rappresentato, eviscerato nei
sei album con la compagine di Cincinnati. Le variazioni
sul tema successive - Gutter Twins compresi - hanno
impietosamente rimarcato questo dato di fatto. Allora, queste undici tracce? Hanno un senso perché sembrano accettare quel decesso, provando a coniugare il
verbo al presente perché si trattava comunque di una
proposta fottutamente buona.
In un certo senso, Dulli fa le prove di persistenza. E mette
a segno degli ottimi colpi, come il glam-psych avariato
di On The Corner, la psicotica mistura electro-shoegaze
di The Beginning Of The End, l’ordigno soffice della titile track (coi ghiribizzi blaxploitation genialmente fuori
contesto) e una Waves che ghigna tra noise e digitale
come un Iggy Pop preso in ostaggio dai Primal Scream. Il resto è perlopiù una rivisitazione di luoghi comuni
dulliani, passione bieca e trasporto sanguigno, quei crescendo di prammatica che esalano struggimento malefico e ambigua perdizione. Rare le sorprese (il sentore
John Lennon tra spunti Tom Petty e Soundgarden di
She Was Stolen, la febbre desertica di Never Seen No Devil)
e molta programmatica prevedibilità, cui non sfuggono i
duetti col sodale Mark Lanegan (la fosca processione di
Be Invited, ospite anche la chitarra - non particolarmente
incisiva - di Nick McCabe) e con Ani Di Franco nella tutto sommato riuscita Blackbird And The Fox.
Apoteosi di mestiere indomito, quindi, con cui presumo dovremo fare i conti per un bel pezzo ancora.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Vinicius Cantuária/Bill Frisell - Lágrimas
Mexicanas (Naive, Gennaio 2011)
Genere: bossa / jazz
Folgorato sulla via del jazz in giovanissima età da Wes
Montgomery, Bill Frisell è un artista in perenne movimento. Un moto continuo, il suo, che l’ha portato ad indagare generi diversissimi tra loro alla ricerca di un filo
conduttore che potesse unire sperimentazione, musica
contemporanea e linguaggi consolidati. A questo tende una discografia infinita e ibrida che va dal blues al
country, dalle colonne sonore alla world music, costante tentativo - in gran parte riuscito - di reinterpretare
la chitarra in bilico tra complessità e immediatezza,
grazie all’ausilio di musicisti sempre diversi (tra i tanti,
Arto Lindsay, Elvin Jones, Ry Cooder).
In Lagrimas Mexicanas il Nostro torna a collaborare
con il bravo Vinicius Cantuária, vecchia conoscenza dei tempi di The Intercontinentals (ma non solo),
lasciandogli idealmente carta bianca. Il che, nel caso
di Frisell, significa retrocedere ad accompagnatore di
lusso per il Sud America malinconico e romantico del
collega, auto-privandosi del ruolo di innovatore che da
sempre gli è familiare. Ne vien fuori un disco elegantissimo, preso in ostaggio dai ritmi latini, nobilitato da
un dialogo costante tra le sei corde dei due artisti ma
a suo modo anche standardizzato, capace di lasciare
al Frisell che tutti conosciamo solo qualche parentesi
isolata (la parte centrale di Mi Declaraciòn, il divertissement di Cafezinho e il post-rock di El Camino).
Si centra l’obiettivo del “bello” a tutte le latitudini, insomma, ma si nega nel contempo il piacere della scoperta che da che mondo è mondo accompagna l’ascolto di un disco del musicista americano. Ammesso che
questo lo sia.
(6.5/10)
Fabrizio Zampighi
VipCancro - Tropico (Lisca Records,
Ottobre 2010)
Genere: impro spettrale
Spettralismo ed evanescenza impro-rumorista sono le
coordinate che caratterizzano Tropico, album che segna il ritorno dei VipCancro. Il quartetto toscano si era
già fatta notare con le autoproduzioni d’esordio (XaX,
vinile del 2008, e il cd-r omonimo dello stesso anno)
e con alcune comparsate nei territori di confine tra
avanguardia artistica e musica (le performance videomusicale in omaggio a Luigi Nono, su tutte). Ora la questione sembra aver preso una piega più radicale.
Filippo Ciavoli Cortelli (percussioni e nastri), Andrea
Borghi (basso), Nicola Quiriconi (voce) e Alberto Picchi
(elettronica) piegano la strumentazione quasi convenzionalmente rock ad una missione: fondere in un linguaggio personale l’astrattismo e la radicalità di una
proposta proveniente da un ambito tradizionalmente
ambient noise-industriale. E nel marasma semi-magmatico che ne esce, ciò che sarebbe in apparenza riconoscibile viene travisato se non trasfigurato in qualcosa
di altro: l’isolazionismo, la kosmische, l’industrial italica
d’inizi ’80, l’elettronica colta e di ricerca si frantumano
in forme astrali e spettrali, impalpabili o granulose, allucinate e lacerate dal di dentro.
Qualche concettualità di troppo, ovvia quando si calcano simili terreni, e una certa omogeneità di fondo non
rovinano un album denso e incompromissorio, che segna lo spessore della “scena” dell’improvvisata italiana
anche sul versante più oscuro.
(6.9/10)
Stefano Pifferi
83
White Lies - Ritual (Fiction, Gennaio 2011)
Genere: Wave pop
Brutta cosa realizzare un disco di successo e disporre di poche idee su come dargli un seguito. Si finisce
con diluire le intuizioni valide dell’album precedente,
esasperarne gli elementi vincenti e gettarsi in qualche
maldestro tentativo di imboccare nuove strade.
Il caso dei White Lies è quasi da manuale. Sul nuovo
Ritual riproducono pedissequamente la formula vincente di To Lose My Life, quella che traduce definitivamente il new wave revival in ambito mainstream,
ma lo fanno con una freschezza infinitamente minore
rispetto all’esordio.
In passato, se ne poteva apprezzare la potenza delle
melodie, i richiami, seppur ingenui, a Psychedelic Furs
e Depeche Mode, la voce elegante ed austera di Harry McVeigh; tutti aspetti che sul nuovo Ritual vengono
amplificati dalla cassa di risonanza di una produzione
fin troppo solenne, curata da Alan Moulder.
Volendo spendersi a trovare elementi di novità, vale la
pena citare il tiro elettro-funk di alcuni frammenti, Holy
Ghost su tutti, che avvicina di un altro passetto il sound
del gruppo a quello dei Depeche Mode.
Peccato che il resto della tracklist sia composto da quelle che sembrano outtakes di To Lose My Life cui sia
stata data frettolosamente la veste dell’album, al fine
di capitalizzare l’improvviso successo. I dubbi sul reale
valore dei tre restano ancora tutti da sciogliere.
(5.5/10)
bisogna avere la forza di trasfigurare la tradizione in un
linguaggio proprio, magari andando a sporcare il proprio sound e la propria scrittura con influenze nuove
come seppero fare i grandi padri del pop come i Beatles, i Kinks, i Beach Boys, giusto per citarne qualcuno.
Non che i Zoey Van Goey non possano farlo nel loro futuro, ma al momento pur risultando piacevoli, suonano
comunque qualcosa che abbiamo già sentito altrove,
senza che il loro tocco riesca a rendere indimenticabili
le canzoni.
(6.5/10)
Marco Boscolo
Diego Ballani
Zoey Van Goey - Propeller Versus Wings
(Chemikal Underground Records,
Febbraio 2011)
Genere: folk pop
La band irlandese-canadese-inglese di cui si era già
parlato in occasione di The Cage Is Ulocked, l’esordio del 2009, torna sul luogo del delitto tirando fuori
undici caramelle chamber-folk-pop fumettoso e divertente per continuare a raccontarci delle loro magagne
sentimental-amicali, in pieno stile da cameretta. Le coordinate sono le stesse di allora, pop scanzonato tanto
debitore alla tradizione british (i calchi Field Music di
The Cake and Eating It, Escape Maps e You Told The Drunks I Knew Karate), quanto al folk irlandese (Little Islands,
Where It Lands, Extremities).
Il problema per gruppi come i Zoey Van Goey non è
tanto il saper intrattenere l’ascoltatore, ché le melodie
qui presentate sono appiccicose quanto basta fin dal
primo ascolto, ma la loro durata nel tempo. Non è sufficiente evocare per scrivere una grande canzone pop,
84
utti i
t
è
o
t
n
tame
L’appun
orni su
i
g
i
i
t
t
u
et
lm
igita
d
l
i
n
o
c
si
me
m ndimenti
o
c
.
e
r
a
o
ascolt
, approf
re oni, contest
i
t
n
e
s
.
nsi
www
rti, rece
once
News, c
tis
ra
tutto g
click
n
u
i
d
a
at
e a port
df
in p
e
n
i
z
a
g
a
anche su
Gimme Some
Inches #13
Vinili grandi e piccoli nel consueto appuntamento con Gimme
Some Inches. Questo mese girano Teenage Panzerkorps, Antimagic, Soviet Soviet, Frank (Just Frank) and many more...
Ben tre coppie di nuovissime uscite
per questa nuova puntata di Gimme
Some Inches. Cominciamo con una
delle nostre frequentazioni preferite di quest’ultimo periodo, ovvero
la temibile nidiata a nome Teenage
Panzerkorps che, non paga di aver
appena licenziato l’ottimo German
Reggae, rilancia con due EP che vedranno presumibilmente la luce nei
giorni in cui leggerete queste righe.
Il primo esce a nome Der TPK sotto
il vessillo della svedese Release The
Bats che prosegue nella nuova collana di 7 pollici tirati in sole cento
copie e venduti esclusivamente via
mail order. Dopo il primo split Lust
For Youth/Blessure Grave e il recente The Tower di Burial Hex, ecco
ora il terzo anello dall’evocativo titolo Thee Incantations Of Bunker
Wolf (quest’ultimo cantante degli
stessi Teenage Panzerkrops, per chi
non lo sapesse). Due brani e due
skit nel tipico quanto irresistibile
stile dei terroristi germanici, in cui
86
spicca una hit punk-wave come
V3. In tempi più rosei per il mercato discografico un brano come
questo avrebbe spopolato tra tutti
gli affiliati delle cultura dark e non
solo, ma il momento è quello che
è, per cui i fedelissimi dei TPK dovranno correre sul sito della label
di Goteborg per accaparrarsi una
delle copie prima che, in men che
non si dica, vada sold out come è
successo ai predecessori. Fortuna
che il secondogenito dei teutonici
non esce in tiratura così ristretta.
Parliamo di Pink Flowers, nuovo EP
questa volta targato Horrid Red, il
side project con cui hanno già dato
alle stampe lo splendido 12” Empty
Lungs (per Holidays). Per il ritorno
gli Horrid Red si affidano alla statunitense Soft Abuse che rilascia ben
tre versioni: la prima su vinile corto
con i tre brani migliori, le altre due
rispettivamente su cassetta e in
digitale con quattro brani aggiuntivi di cui due strumentali firmati
da Clay Ruby alias Burial Hex. Una
conferma impeccabile.
La seconda coppia di uscite introduce una nuova band, i newyorkesi Dream Affair che forse qualcuno ha già avuto modo di notare
grazie alla maxi-compilation The
Guide to Grave Wave in cui partecipavano con Silent Story, brano
che apre anche il primo mCD All I
Want. Autoprodotto in un centinaio di esemplari, il mini in questione
butta sul piatto (o sarebbe meglio
dire fuori dalle casse) cinque brani
dalla caratura puramente dark-wave, frutto della palese devozione
per il sound più tetro degli Eighties di scuola Bauhaus, Joy Division
e compagnia caliginosa. Insieme
alla sopracitata opener, Until The
Fall e No Use Hiding dicono di un
suono nero come da tradizione inglese, scandito da drum machine
metronomiche, chitarre pungenti
come spilli e dalla voce color pece
di Hayden Payne, main man del
gruppo. Andato a ruba a stretto
giro di posta tra gli amanti del genere, il gruppo di Brooklyn rilancia
ora con 405, 7” edito da Five Three
Dial Tone. Due nuovi brani a riba-
dire quanto testé detto: atmosfere
tanto lugubri quanto meccaniche,
fredde quanto ammalianti, che non
ci fanno stupire di come la band
spesso alberghi presso le sulfuree
serate della Wierd Records proprio
in quel di NY.
Per l’ultima doppietta scomodiamo niente meno che Amanda
Brown e la sua nuovissima label
100% Silk di cui avevano già accennato in sede di recensione. Per
i meno attenti va detto che la nuova etichetta della ragazzaccia californiana produrrà esclusivamente
12” a 45 giri (il caro vecchio feticcio
da DJ), guarda caso, di elettronica
deviata. E inizia col botto Amanda:
ben due vinili in un colpo, rispettivamente per Ital e Deeep. I primi
con Ital’s Theme si cimentano in
una sorta di minimal disco synthetica e robotica, condita dagli
immancabili suoni vintage da videogame d’antan. I secondi sfornano
invece Muddy Tracks, un’electro
più rarefatta, obliqua e traballante, ammorbidita da ipnotiche voci
femminili che imbastiscono oniriche visioni notturne. Entrambe le
edizioni hanno una tiratura di 350
copie e vantano una veste grafica
comune dai soffusi toni pastello, a
metà tra Belle époque e stile trash
made in LA. Tenete d’occhio questa nuova realtà perché, ne siamo
certi, regalerà perle che altrimenti
sarebbero destinate a restare solo
su Internet.
Rimaniamo negli States, ma
cambiano costa. I nostri protetti
Antimagic (gente del giro These
Are Powers) tornano con un 7” e
una cassettina live. Se Live Trash è
giusto la fotografia delle potenzialità dissonanti del duo in sede live,
confezionata in splendida cassetta
verde acido, il 7” Shake Shake Shake
su Temple South ci mostra cosa Ted
McGrath e Marcia Cahill potranno
fare col sophomore Heat Waves,
previsto per i primi mesi del 2011.
La title track è uno scheletrico funk
bianco, ossessivo e fantasmatico,
sensuale e groovey as fuck! Inner
Most Secret Shogun Heart è un continuo stop’n’go sfasato e spigoloso
che fa venire in mente una versione proto-punk spastica dei Velvet.
Nella versione digitale già disponibile è presente una versione lunga
della title track. Consigliato.
Tornando a casa nostra invece,
è obbligatorio segnalare lo split 12”
tra una nostra vecchia conoscenza,
i francesi Frank (Just Frank) e gli
italiani Soviet Soviet. Benedice il
tutto la Mannequin, label italiana
che, nata come distro del sottobosco neo-wave, si sta facendo un
nome in campo synth/cold/dark,
insomma qualsiasi prefisso preferiate al genere wave, con ristampe
mirate e nuove proposte. Il lato A,
appannaggio del duo autore di The
Brutal Wave, si muove tra synthpop vintage e electro-wave spesso tirata e robotica (Do The Soviet,
Valerie) ma sempre melodicamente
british. Rispondono dall’altro lato i
Soviet Soviet e il panorama si tinge
di post-punk abrasivo, riverberato
e epico. Un frullatore fuori dal tempo tra epilettica furia iconoclasta e
energico nichilismo chitarra, basso
e batteria. Tutto, rigorosamente, in
b/n. Brava Mannequin.
Stefano Pifferi, Andrea Napoli
87
Re-Boot
#12
Un mese di ascolti
emergenti italiani
Ecco a voi una bella misticanza di metà inverno. Dal folk-blues
al dream-pop passando per psichedelia jazzata e disco-funk. Di
tutto. Da tutto lo Stivale. Ed oltre.
Il Quintetto Zizkov opera nel bresciano ed esordisce con un ep omonimo (Kandinsky/Bandsyndicate,
6.9/10) nel quale tenta un ibrido
azzardo tra jazz, latin e surf, l’aria
un po’ così da soundtrack poliziesca, il film proiettato ora in un club
ovviamente fumoso e un po’ rancido (See... La police!) oppure nella
balera dei sogni perduti (Acapulco).
Due chitarre, il basso, saxofoni e
batteria. Tra Calibro 35, Morphine
e Calexico, sintonizzando frequenze più opache che ruspanti, battagliere senza clamore aggratis. Non
so se è una strategia commercialmente vincente, però se la cavano
assai.
Quartetto romano di rock riflessivo/combattivo, gli Hyaena Reading. Questo In Movimento (autoproduzione, 6.7/10), ep d’esordio
disponibile in free download sul
sito di Sub Terra label, ricorda le
modalità narrative di Massimo Volume e Offlaga Disco Pax però ri88
condotte sui sentieri d’un folk-blues
tra il basale e l’industriale (Acciaio),
strattonato punk-wave (Al calore
dell’alba) e in qualche modo balcanico (In movimento). Non un rifarsi
supino ai modelli citati insomma,
anzi uno smarcarsi programmatico
che in qualche modo significa superamento e individuazione d’un
percorso proprio. Interessanti e forse anche qualcosa di più.
Mirabile l’opera di sintesi dei cosentini Multicolor, capaci di conciliare in First Spaceship On Venus
(autoproduzione, 7.0/10) un immaginario grafico che sa di sci-fi anni
sessanta e certa psichedelia contaminata. Sei tracce in bilico tra jazz
e Grateful Dead, Flaming Lips e
Pink Floyd, con un cantato Big Star
e qualche accenno al post-rock che
impressionano per omogeneità e
qualità nella scrittura. Tanto da far
convivere senza alcun problema
stimoli all’apparenza inconciliabili,
come il crooning sudamericano di
Venus e le narcosi di scuola Alice in
Chains di Upset, il folk crimsoniano
di Reflex e i Black Rebel Motorcycle Club traviati dall’indie americano anni Novanta di Netherworld.
Per un disco d’esordio multicolor,
come da ragione sociale.
Naturale prosieguo del precedente La piccola enciclopedia del
bosco Vol.1, il qui presente Vol.2
(autoproduzione, 6.5/10) vorrebbe ribadire le buone potenzialità
de Le Fragole, pop-rock melodico di quartiere da Borgo Panigale
(BO). A certificare lo spessore della
band, un campionario di stili che
va dall’easy listening anni Sessanta
(Indeciso) al brit-pop (La mia via),
da Ivan Graziani (E il sole splende
anche per me) ai Belle & Sebastian
(Superman), da Luca Carboni (Ragazzi di sobborgo) a Tricarico (Domenica). Proposta di confine tra indie-rock e pop a larga diffusione, la
musica dei Le Fragole ha la mirabile
capacità di unire ingenuità e buona creatività, riuscendo a ritagliarsi
una piccola porzione di universo a
propria immagine e somiglianza.
Il nome a suggerire una fragilità
resistente, sulla scorta di canzoni
come ricami acustici nel vento di
una landa desolata. L’ex Venere di
Vetro Roberto Lucido alias Flowers
of Hiroshima imbastisce canzoni
auspicando dei Kings Of Convenience onirici o un Jeff Buckley
in ossessione dream-pop. Delicati e penetranti (Passing Clouds) o
affetti da un’ipnosi leggera prima
di un’esplosione trattenuta (Dust)
i quattro brani dell’omonimo ep
d’esordio (Revolutionary Boy Records, 6.7/10) non cercano nient’altro che qualche tocco di glockenspiel ad accompagnare la chitarra,
mentre la voce lavora su delay in
espansione nel vuoto. L’impronta di FoH è già distinguibile, serve
però uno scatto di scrittura.
“Sono
uno abitudinario” cantavano gli Elio
qualche anno fa con spirito da fenomenologi nell’elencare le intime
manie di ciascuno di noi.
I bergamaschi Venua declinano
il medesimo intento rivolgendolo
però ad una socialità sempre più
afflitta da nevrosi e insicurezze radicali ne Gli abitudinari (Libellula,
7.0/10). Con Marco Fasolo (Jennifer
Gentle) e Paolo Pischedda (Marta sui Tubi) ai comandi, azzardano una decina di episodi in mood
analogico, fra chitarre surf, richiami
funk, vitamine beat e un’attitudine
alle smussature pop cui fanno da
rinforzo una serie di chitarre secche
e citazioniste come si conviene. Gli
apici sono una Buon compleanno
con le sue vertebre funk-dance e
una title-track in fuga psych, ma
tutto il disco è piacevole per carburata leggerezza e critica pungente
senza moralismi.
Freschi, sbarazzini e ironici, i baresi (da Monopoli) Io ho sempre
voglia con l’omonimo (autoprodotto, 7.1/10) si cimentano nei territori assai scivolosi del pop-rock,
con una piuttosto buona verve
di testi in italiano. Musiche e testi
sono composti da Vittorio Nacci,
studi da Mogol, mentre parte della
band ha una formazione classica.
Si indovinano ispirazioni variegate, che vanno dal cantautorato
italiano classico, a partire da Lucio
Battisti, Rino Gaetano, fino a Max
Gazzè e alle evidenti ascendenze
beatlesiane e brit pop; il tutto con
un disincanto e una freschezza che
fanno di questo loro primo album
un prodotto godibile e consistente.
Se sapranno capitalizzare questo
potenziale il seguito sarà senz’altro
da non perdere.
Ed eccoci infine ai Synsoma dalla Svizzera italiana e trapiantati a
Losanna. Stomach (6.8/10) è il loro
secondo opus dopo un primo EP
pubblicato nel 2007. Si muovono
su territori indie rock con influenze
che vanno dallo stoner alla psichedelica ’70 di matrice Pink Floyd e
King Crimson, fino alla musica
italiana di Marlene Kunz e Afterhours, con cantato tra inglese
e italiano. Qua e là ascendenze Radiohead e voglia di suite mischata
alla forma canzone.
Stefano Solventi, Teresa Greco,
Fabrizio Zampighi, Luca Barachetti
89
Lonely
China Day
China underground#3
L’indie-sperimentale pechinese
dei Lonely China Day
Immagine-intervista di Deng Pei, leader di uno dei progetti artistici più solidi della realtà indipendente cinese, sospeso tra musica, sperimentazione sonora e video-arte
“Al di sopra del cielo terso di nubi
può estendersi la corte celeste. Il
fragore del tuono mi scuote riportandomi alla vita. Nei sogni quieti,
c’è sempre una tua traccia. In alto tra
le nuvole, nella bruma. Terra d’ombra, è il colore della mia devozione.
Sono devoto a ciò che chiamiamo
Amore. In un istante cambia fino a
perdere forma. Come acqua calda,
come cubo di ghiaccio.”
Thou, dall’album Sorrow, 2006
“Sono a pezzi, lascio lo spirito del
mio corpo a un sonno tranquillo. Ma
la mia condotta si incarna in un demone lussurioso pronto a macchiarti. Come un verme repellente risalgo
strisciante i tuoi gemiti. Contorcersi
privo di vergogna. Ho oltrepassato
i tuoi rami più alti, come un capro
espiatorio o un criminale pieno di
rimpianti. Terrorizzato, dalla fine
all’inizio. Sei un fiore di pruno rosso, un fiore rosso dimenticato dalle nuove generazioni. Io, l’ipocrita,
90
non merito le tue attese per me, il
logorio del tuo sguardo puro come
pozza d’acqua. ”
Red Blossom of Plum and Me, dall’album Sorrow, 2006
“La libertà di oggi, guardala diventare un cagnolino domestico alla
moda. Tenuta al guinzaglio per le
strade da un governatore ignorante.
E la rabbia di oggi, diventare il pretesto per un massacro. Urlata come
insulto da masse innocenti in tutto
il loro odio.”
Rage and Freedom, dall’album Sorrow, 2006
Deng Pei, compositore, voce e
musicista dei Lonely China Day.
Si muove senza eccessivo clamore
nella scena musicale cinese, su una
strada tutta sua e verso un ideale
creativo fatto di personalità e visione. Ha qualcosa da dire, ma senza
declamare e urlare. Solo con lo spessore di quel tipo di arte che è suono
e voce senza peso, volta all’equilibrio di un percorso estetico-intellettuale. Senza clichè o stereotipi, e per
questo unica ed irripetibile. L’amalgama musicale dei Lonely China
Day nasconde un’attitudine a tratti
perfezionista, apparentemente cervellotica, ma che nel suo talento sa
vestirsi di forme diverse, come traspare dai live della band, quando il
colto indie rock registrato in studio
si completa nelle immagini video di
sfondo, o viene destrutturalizzato in
sperimentazioni elettroniche più o
meno ardite.
Formatisi nel 1996, con incessanti tournées in patria ed un terzo
album uscito alla fine del 2010 per
consacrarne l’approdo a sonorità
elettroniche, i Lonely China Day
sono solo una delle realtà della
musica alternativa cinese, un oceano in grado di benedire e disfare
promesse con incredibile facilità. In
patria non godono di fama esclusiva e non riempiono stadi come
Xie Tianxiao, ma all’estero hanno
ottenuto riscontri importanti, con
pubblicazioni e tour negli U.S., date
in Canada e in Inghilterra, interviste,
91
apprezzamenti e accostamenti musicali tanto illustri (Sigur Ros) quanto fuori luogo.
È una sfida al futuro, da parte di
chi si sente in grado di reinterpretare per conto proprio la tradizione
con spirito contemporaneo. Ben pochi artisti potrebbero ritenere con
la stessa convinzione di Deng Pei
che “musicalmente non c’è nessuna persona che ci può influenzare.”
Un’avanguardia, isolata dall’abbondanza di imitazioni effimere e messa ai margini da un mercato musicale alternativo, quello cinese, troppo
giovane per essere percepibile ai
più: “Un mercato musicale maturo
necessita del sostegno di un’industria musicale matura. Quello che
oggi manca in Cina è proprio questo tramite. Poi bisogna considerare
che oggi in Cina non c’è un pubblico
indie. Per creare una scena musicale
il semplice apporto dei musicisti è
pienamente insufficiente, la quantità di persone che ci ascoltano è
una delle componenti che determi92
na il grado di sviluppo della musica
alternativa. Inoltre l’assalto che subiamo da internet fa sì che un vero
artista musicale indie sia sempre più
svalutato. Nei prossimi anni potrai
assistere a un nuovo fenomeno: lo
sviluppo di un falso mercato musicale indipendente bilanciato da
una diminuzione della musica con
un’essenza vera, un processo che
comunque renderà ancor più preziosi alcuni prodotti.”
Deng Pei canta il coraggio ed il
tormento, con una voce che, a seconda dei versi intonati, scandisce
rabbia sociale, sofferenza intima e
fulgida violenza. Sfrutta con sensibilità cantautoriale le potenzialità che
la lingua cinese offre, ricorrendo
ad efficaci richiami fonici e giochi
di assonanze che creano immagini
nuove e “neologismi” sulla base di
parole esistenti. Scorrendo i versi di
un pezzo qualsiasi dei Lonely China Day è difficile non pensare di
trovarsi di fronte a una tecnica e ad
ispirazioni poetiche: “In realtà non
faccio alcuna distinzione tra testi
musicali e poesia, neppure all’interno del processo creativo ho mai
pensato se stessi scrivendo testi o
liriche. Se guardo un testo separatamente dalla musica naturalmente si
tratta di poesia. La letteratura classica cinese presta attenzione alla
metrica, alle figure retoriche e alle
rime; l’uso della lingua cinese ha i
suoi vantaggi, ed io credo nella sua
natura diretta e concisa, nella sua
chiarezza di significato.”
L’incisiva espressività dei testi
si mescola ad una natura musicale
composita ed eterogenea, per una
struttura sospesa tra forme rock familiari e un’anima fortemente cinese, a volte ostile per chi è culturalmente distante. Il tessuto musicale
si dilata nel tempo ed è modificato
con suoni campionati, ma non c’è
mai un tradimento della melodia,
sotto la guida di una voce che si
fa strumento dissonante o di note
chitarristiche votate ad echi algidi
e rarefatti. La ricercatezza di musica
e versi emerge in un unicuum fatto
di suono e pensiero, senza cause ed
effetti: “Se nel processo compositivo
la parte melodica avesse la priorità,
probabilmente ne deriverebbe un
testo troppo rigido; ma anche partendo dalla scrittura delle parole si
andrebbe a scapito della musicalità.
La mia abitudine è quella di comporre testi e musica come fossero
le diverse dimensioni di un corpo
unico.”
Quando parla di musica Deng
Pei non esita, la musica sembra confondersi con la proiezione della sua
stessa anima, la spiega come una realtà da inseguire ed esprimere attraverso le proprie capacità. Racconta
di un talento e di propensioni innate, di una vocazione manifestatasi
dall’infanzia. E per descrivermi lo
stato d’animo che il nome del gruppo vuole evocare si sofferma sulla
solitudine: “un continuo approccio
alla vita e all’atto creativo”, una condizione riflessiva da cui non si separa
mai completamente e che è un momento essenziale della composizione musicale. Ma i Lonely China Day
non inseguono un’idea che si esaurisce in sé stessa o nel suo semplice
compimento, scrivono e si esibiscono per qualcuno, senza interrogarsi troppo su quello che rappresentano per chi ascolta: “Che il nostro
pubblico sia animato da un amore
persistente o da una distanza che ci
respinge, noi speriamo comunque
di esserci per l’esistenza di quelle
persone sensibili che ancora sanno
essere colpite dalla sofferenza.”
La comunicazione va ben al di là
del piano emotivo, buona parte dei
testi hanno un contenuto sociale e
lo stesso Deng Pei non si tirerebbe
indietro “se potessi semplicemente influenzare una persona.” Non si
fermano neanche all’estero, dove
si sono esibiti anche recentemente
(Londra) e dove si recano ogni volta che se ne presenta l’opportunità, per “continuare ad apprendere
e fare esperienza”. Alla domanda
sull’immagine che gli arriva dell’Occidente Deng Pei risponde in modo
molto diretto: “Ammiro la libertà e la
fede che riempie la gente nell’Occidente sviluppato. L’alto grado di sviluppo fa sì che la gente in Occidente
sia meno complessa negli ideali, ma
proprio per questa spontaneità gli
occidentali sono ancor più propensi
a commettere degli errori per sentito dire e questo è un lato che non
mi piace. Secondo me, in Cina, non
c’è alcuna incomprensione dell’Occidente, quando guardiamo dei film
occidentali ci sono forse cose che
non capiamo? Le differenze nella
comprensione sono solo delle scuse che denotano un diverso accento
che l’Occidente e l’Oriente pongono
sulla realtà ognuno secondo la propria coscienza, niente di più.”
E quando parla di Cina non lo fa
con un criticismo scontato o di su-
perficie, né si lamenta per l’assenza
di diritti umani o democrazia. Nelle
sue interviste Deng Pei trova sempre modo di esprimere l’amore per
il suo paese, ed è proprio questo
profondo legame che lo spinge al
cupo e allusivo decadentismo di
denuncia nei suoi pezzi: “Un mio
punto fermo è che attraverso la musica dei Lonely China Day spero di
saper trasmettere al nostro pubblico un grande amore per la Cina e
anche sfidarla. Conoscere la gloria
che questo paese ha sperimentato in passato e riuscire a sfidarlo
per l’arretratezza contemporanea.”
Quello stesso amore e odio che lui
prova nel vivere il proprio paese: “Il
posto di Lonely China Day nella
Cina contemporanea è quello di chi
ama la sua patria perché ne è parte,
e la odia semplicemente perché ne
è parte.”
Mauro Crocenzi
Album:
Lù (“Record”, 2002)
Jìmò Xià Rì (“Lonely China Day”, 2005), Ep
Āishāng (“Sorrow”, 2006)
Zhège yì tónghuà mínzú (“This Readily assimilative People”, 2010)
Links:
Sito Web (cinese-inglese): http://www.lonelychinaday.com/
Pagina MySpace: http://www.myspace.com/lonelychinaday
Pagina su DouBan (cinese): http://www.douban.com/artist/lonelychinaday/
93
Rearview Mirror
—speciale
Primal Scream
Vent'anni dopo la rivoluzione
A vent’anni dalla pubblicazione, Screamedelica verrà rimasterizzato e portato in tour: la storia dei Primal Scream doverosamente riscoperta e contestualizzata
94
Testo: Edoardo Bridda
Giancarlo Turra
Pop S ongs ’91
S creaming S onic Flowers
Il tempo che passa fa un effetto strano: venti anni sono
trascorsi da un 1991 che pare oggi sempre più cruciale.
Dodici mesi di autentici ribaltoni che all’epoca lasciarono sconcertati e anche dubbiosi, che ebbero ricadute
- alcune drammatiche: si pensi al “dopo Nevermind” da valutare nei mesi e lustri a venire. Gli anni del post
col trattino in divenire, del crossover totale, della tecnologia e del dopo-modernismo spinto, come pure
dell’affacciarsi di una nuova generazione danzereccia
e dell’accelerare - e differenziarsi - della già sostenuta
produzione discografica degli Ottanta, iniziano lì. Segnando un caso unico di decade dove l’inizio detta artisticamente il passo e le vie future sono indicate con
chiarezza poi ineguagliata.
Dalla nebulosa psichedelia minimale di Loveless al
mischione funk-punk Blood Sugar Sex Magic, passando per i panorami oltre il rock (Spiderland e Laughing
Stock) sta lo spirito di un’epoca che è anche la nostra.
E, va da sé, anche nei due Capolavori che contribuirono
ad abbattere il muro tra pista da ballo e “purismo” rock,
e tra quest’ultimo e il techno-pop “di razza”. Mondi che
avevano preso ad annusarsi dal mainstream (Beastie
Boys, gli Run DMC e Aerosmith di Walk This Way),
all’undeground (i successi commerciali di Inner City,
M/A/R/R/S e S’Express), in epoche in cui gli steccati
tra generi erano netti e allorché l’hip-hop ancora non
era stato soppesato a dovere nella sua rivoluzionaria
portata.
La quale ebbe invece una gittata lunghissima, che
investì collettivi che avrebbero continuato la tradizione
del sound-system (Massive Attack) in più ampi contesti e inventandosi una narcosi dance che prese il nome
di trip-hop e travolse anche Screamadelica. All’uscita,
come tanti dischi figli del suo tempo però troppo sporti in avanti, fece scalpore col suo lavare nelle luci stroboscopiche la psichedelia dei Love e le visioni fanciullesche di Brian Wilson. Sembrò - a chi seppe coglierla
- una faccenda a metà tra bestemmia e benedizione; di
quelle vincenti, nondimeno, e da molti e tra loro differenti punti di vista.
Cristallina oggi la parabola di Gillespie e compagnia,
in perenne bilico tra omaggio amanuense e cannibalizzazione di (sotto)generi che la rivoluzione dell’Ecstasy
portò con sé. Un gioco di squadra, rammentiamolo, di
musicisti e produttori, fonici e tecnici, mezzi (studi di
registrazione veri) e fini comuni, in questo senso nel
solco della tradizione del pop/rock classico. Un concetto che negli “anni zero” sembra avere perso un bel po’
del suo valore. Robert Bernard Gillespie nasce a Glasgow nel 1962 e
alla Kings Park Secondary School, come in un bel manuale di romantica epica rock, allaccia amicizie che gli
cambiano la vita. Frequenta vari tipacci poco raccomandabili, fuma erba e crea qualche casino, ma nel mucchio selvaggio - oltre a Jim “Navajo” Beattie che è al
tempo amico e rivale - conosce un certo Alan McGee,
figura destinata a cambiare tante vicende compresa la
sua. Alan è il fondatore dell’etichetta Creation, talentscout d’eccezione e in quei giorni primo manager dei
Jesus & Mary Chain, per i quali il ragazzo innamorato
dei Velvet Underground finirà per suonare la batteria
in piedi, proprio come Maureen Tucker.
E’ un periodo storico particolarmente propizio per
l’ennesima rinascita del rock. Sotto il rapido successo
della Catena di Gesù & Maria - odiati e amati per il mix
di canzoncine sixties sotto massicci feedback chitarristici - la new wave subisce il colpo decisivo e lascia
il passo al ritorno dei favolosi Sessanta che Gillespie,
mentre lavora anche come roadie negli Altered Image, sta pensando di omaggiare con un progetto parallelo all’attività con i fratelli Reid.
Nel 1985, nell’anno di Psychocandy, la band prende
il nome di Primal Scream (ciao Lennon!), con Bobby e
Beattie a rappresentare le uniche certezze in una situazione un (bel) po’ precaria. Entro breve porteranno a
casa due 7”, l’abortito The Orchard e il discreto All Fall
Down, conditi da fumose prospettive psych mentre
fuori dalla finestra, da una sponda all’altra dell’Atlantico, i capelli iniziano ad allungarsi e l’abbigliamento si
regola di conseguenza.
Gli Ottanta stereotipati del synth-pop da classifica rappresentano soltanto una faccia del prisma musicale dell’epoca: infatti R.E.M e Smiths, guardando
alla decade “fab” per eccellenza come alla wavedelia
“made in Liverpool” di Teardrop Explodes ed Echo &
The Bunnymen, tirano la volata al movimento Paisley
Underground e alla generazione “C86”, battezzata
dall’omonima cassetta allegata al New Musical Express
che chiarisce gli intenti della neonata scena albionica.
In quell’anno, a Nord nascono i Vaselines che tanto
influenzeranno Cobain, mentre i Primals ingranano col
fondamentale 45 giri Velocity Girl/Crystal Crescent.
Compressa in meno di due minuti, Velocity Girl ricolloca i Byrds al di là del Vallo di Adriano come dei Jesus
sotto Ecstasy. E la forza del brano si misura in quel che
saprà fare, cioè cambiare la storia degli Stone Roses
la cui splendida Made Of Stone sarà omaggio e metà
reinvenzione. Ad ascoltare bene, inoltre, il Roger McGuinn chiamato in causa per l’arpeggiare delle sei cor95
de si segnala come modello popolare in Scozia sin dai
capostipiti Orange Juice.
Tutto resta “in famiglia”. I singoli escono per la Creation di McGee, nel frattempo assurta al rango di “cult
label” di fascino. Costui finanzia il debutto dell’amico
tramite la Elevation, sussidiaria scaturita da un accordo con la WEA ed ecco nell’87 Sonic Flower Groove,
album di gentilezze Byrds, Love e Beach Boys in una
dolce guida pratica di arpeggi e melodie ariose, Gillespie innamorato a intonare classici - magari “minori” ma
nemmeno troppo - come Gentle Tuesday e Sonic Sister
Love, come l’epica Love You e We Go Down Slowly Rising.
Il disco non può che raccontarsi come figlio di un’epoca
tornata ad imporsi per il respiro arioso e un’icona out
come Mayo Thompson in consolle, ma più che altro
per l’insuccesso commerciale che causa la rottura definitiva tra Gillespie e Beattie, facendo prendere all’instabile formazione una piega assai diversa.
Primal Scream, due anni dopo, è il “gemello cattivo”
che trasloca i ‘60 da Woodstock ad Altamont e i calchi
vanno di conseguenza: gli idolatrati Stooges (il riff di
Gimme Gimme Teenage Head riprende T.V. Eye; Duffy si
rifà a Scott Thurston in Ivy Ivy Ivy) accanto ai i Rolling
Stones eroinomani dei Settanta, più alcuni dei rispettivi derivati migliori come New York Dolls (Sweet Pretty
Thing) e Ramones (Lone Star Girl), laddove She Power
96
insegna qualcosa ai primi Oasis, guarda caso scoperti
proprio da Alan McGee.
Il merito della svolta va accreditato anche al tastierista dei Felt, Martin Duffy, che ha sostituito Beattie andatosene a formare gli effimeri Spirea X. Senza il loro
McGuinn la banda è libera di prendere una piega stonesiana, di lasciare nastri in reverse (Kill The King) per una
saga di ballate alla Jagger (Jesus Can’t Save Me) senza
però sfondare commercialmente nemmeno a questo
giro. Oakenfold, Johnny Walker e Danny Rampling torna
cambiata dai soggiorni a Ibiza. A Manchester, invece,
Tony Wilson - già guru della Factory e uomo chiave
dietro a Joy Division… - decide di trasformare il locale
Haçienda, da lui direttamente finanziato con le vendite
discografiche dei New Order, in un club che segua le
più fresche tendenze dance mondiali. Manchester sta per diventare Mad, ma il variegato
mix di suoni che si respira in quel periodo, dalla pesa
acid house fino ai truzzi ritmi hip, l’EBM fino all’hi-NRG
e all’house cantata (che in Italia personalizzeremo in
versione spaghetti), si diffonde uno spirito vacanziero e
“svaccato” che lascerà un segno trasversale in tutti i Novanta. Haçienda diventa presto leggenda, con lo stesso
Alan McGee che ci passa le notti, convertito come gli
altri alla potenza rivoluzionaria della droga che annulla
le differenze di classe.
La storia è cambiata per sempre, ma per cambiare
quella dei fricchettoni Primal Scream occorrono una sinergia e delle casualità ben precise. Accade che la Creation, nel 1989, invii a un tale Andrew Weatherall una
copia di Primal Scream. Andrew è un ex roadie dei Clash
che scrive per “Boys Own Magazine” e tiene dj set al londinese Astoria; soprattutto mastica dozzine di dischi, in
particolarmente ama P.I.L., A Certain Ratio e ovviamente il dub. Rimane particolarmente colpito da I’m Losing
More Than I’ll Ever Have, e con il collega Paul Oakenfold
in studio con gli Happy Mondays, valuta l’idea di un lp
che sia ibrido di rock con dell’altro. Parte dall’idea di
remixare il brano di cui sopra e incassa un rifiuto. Poi
Robbie ci ripensa e con Weatherall nasce un’amicizia e
una collaborazione destinata a durare. Da I’m Losing More… nasce dunque Loaded, addizionata del parlato di Peter Fonda dal film I Selvaggi e
stirata tramite un sensuale groove che funge da ponte
tra gli Stones più negri e un’anticamera del down tempo. Insomma una Sympathy For The Devil aggiornata
e buona per il salotto e per l’after-party, avanguardia
pop che impasta pigri languori hip-hop, flemma dub
e dolcetti Soul II Soul proiettando dentro le mille evoluzioni future prossime. Per il relativo 33 giri, le session
vedono presenti Andrew e il navigato Jimmy Miller,
produttore “vintage” che lega come un cordone ombelicale agli Stones venerati nell’innodia rock stemperata in coro gospel dell’iniziale Movin’ On Up. Sin lì tutto
ok, sicché la svolta sta strategicamente nel brano numero due: la cover dei 13th Floor Elevator Slip Inside
This House si immerge nei suoni da club della Second
Summer Of Love, aprendosi sull’universo recentemente scoperchiato da Alex Paterson e Youthcon gli archivi
di Impossible Oddities. Breakbeat e voci in loop, tablas
e funkettone sintetico. In cima Gillespie, scazzato ma
sexy come manco Shaun Ryder.
L’essenza di queste quattro facciate di vinile sta qui:
in un pacifico caleidoscopio di classicismo psych-rock
e della revisione “in dub” che ne danno gli Orb e uno
I Was B lind , N ow I Can S ee
Nel mentre i ragazzi si riempiono di acidi e nichilismo,
rischiando di diventare l’ennesimo fenomeno per futuri
“Nuggets”, un altro hippismo prende rapidamente piede nel Regno Unito. Cosa figuriamoci non vista di buon
occhio a casa Gillespie, ma il mondo mica lo può fermare. Salirci sopra e cavalcarlo, però, sì. Da Ibiza a Londra si celebra quella che prenderà il nome di “Second
Summer Of Love” e tra i giovanissimi il tempo libero significa Acid House (sub-genere dell’House chicagoana
a base di Roland ipnotiche e ripetitive) e MDMA (leggasi: ecstasy). Inoltre, sotto l’onda d’urto dei free party
(leggasi: rave), che alimentano un sottobosco di feste
in luoghi fuori dagli schemi e dalle città, si abbatte su
Albione un’incontrollabile euforia. Gente come Paul
97
Creation che raccoglie il seminato portando a casa il
Mercury Music Prize.
B ad Trips
Sentenziato il presente e prospettato il futuro, qualcosa si intoppa. Gli anni seguenti il trionfo sono segnati
da eccessi di droghe e un ennesimo cambiamento, stavolta in peggio. C’è voglia di America e di rock-blues,
per niente cosmico e parecchio terreno e terrigno, sul
sentiero competente dei coevi Black Crowes. InGive
Out But Don’t Give Updel 1994, l’ispirazione arranca
nonostante il germe sonoro fosse presente nel DNA
della gang. Dalle sessioni a Londra si cerca ispirazione in Alabama col produttore George Drakoulias (lui
dietro i fratelli Robinson…) e i Memphis Horns, con
una confermata Denise Johnson e George Clinton. Il
disco vive nondimeno di episodi imbarazzanti (Funky
Jam: Clinton sfiatato alla voce) e pochi apici (il singolo
Rocks, da premiata ditta Jagger/Richards annata ’72;
Free, lento con la Johnson in grazia) offuscati da fiacchi stereotipi. Segue una tournée di spalla ai Depeche
Mode nelle arene e si sfiora il tracollo accanto a uno
sballatissimo Dave Gaham, tra squallidi litigi nei camerini sulla droga da - ahem - farsi e abbondanti tensioni.
Si paventa uno scioglimento e preoccupa non poco il
Bobby smagrito e pallido di allora. A posteriori, l’unica
Jah Wobble convocati per l’occasione. A ben vedere,
soltanto Don’t Fight It, Feel It si allontana verso la dance
più purista in una chiave hip-house, laddove il cuore
del lavoro indica un audace centro di gravità epocale, molto di più che Pills ‘n’ Thrills And Bellyachesdegli
Happy Mondays e del 12” Fools GolddiStone Roses,
pregevolissimi momenti “indie” che non irrompono nel
mainstream al pari di Screamadelica. Il quale è una sorta di Sgt. Pepper’s e cioè pop contaminato dai fermenti
più vividi dei suoi giorni: parlano chiaro una produzione inappuntabile che è - Giamaica, Chicago e Detroit
insegnano - strumento come gli altri; poi, un porsi che
fagocita slabbrature “commerciali” come spesso accadrà nella carriera della band (Higher Than The Sun
- sono qui gli Orb - è incanto pop da prefissare synth
o dream; Jagger affiora sublime/mieloso nella ballata
Damaged).
I veri momenti “sperimentali” e l’immersione con le
mode acide, i ragazzacci le approfondiranno dieci anni
più tardi in Exterminatorma ne pongono qui le fondamenta. In un “masterpiece” che, come tale, si assapora
anche per dettagli nascosti come le voci dei predicatori - in scia a Eno e Byrne, altri immensi sperimentatori - raccolte da Come Together, oppure la meraviglia
98
gioia di questa nefasta annata è la versione che Rod
Stewart darà di Rocks, segno che ci si deve ripulire e
alla svelta.
Una scossa la fornisce Gary ‘Mani’ Mounfield, che
sale a bordo dopo lo scioglimento degli Stone Roses.
Via Drakoulias e dentro Brendan Lynch e ancora Weatherall, in parole povere motori nuovamente a tutta.
Vanishing Point esce tre anni dopo come colonna sonora immaginaria dell’omonimo cult movie del 1971,
da sempre uno dei preferiti della band. Bobby la spiega così: “La musica del film è hippy e perché non incidere
qualcosa che rifletta il mood del film? Amiamo l’aria di
paranoia e gli speed-freak. Quel film è un classico underground zeppo di claustrofobia, il nostro un road-album
anarco-sindacalista e speedfreak.”Attenzione però,
niente passatismo: la claustrofobia è quella attuale che
respira affannoso il Tricky di Pre-Millenium Tension,
che scorgi dietro all’America urbana in trasferta desertica del Beck di Odelay, entrambi messaggi recepiti
in Kowalski, traccia più influenzata dal lungometraggio ed episodio che della raccolta misura idealmente
il peso specifico. Non uno Screamadelica parte seconda, semmai un animale che cavalca fiero e ricco d’idee
i Novanta preconizzati dai suoi artefici e si colloca nel
mezzo delle correnti. Giocando di carezza e schiaffo in
attacchi frontali dub e bozzetti strumentali come Train-
di ritualità orientalistica, Kraftwerk subacquei e umori
free-jazz I’m Coming Down.
Tutto quadra e fa brodo, come chiarirà nell’autunno
2010 Weatherall in un programma per la BBC 6 Music,
illustrando gli ascolti che influenzarono lui e Gillespie
nella costruzione dell’album. Andy programmerà per
l’occasione due ore che accavallano Bill Laswell, P.I.L.,
Prince Far I e Jah Wobble; Gillespie, da par suo, offre
kraut e manciate corpose di soul-funk anni ‘70). Il collante? La qualità di quanto proposto, ma pure Isaac
Hayes, Curtis Mayfield e Dennis Wilson. Di fatto, pare
di rivivere il patchwork di copertina pepperiano in versione multietnica, e al pari del sergente il riscontro di
critica e pubblico è finalmente unanime. I pochi che remano contro puntano sulla preponderanza dei produttori, critica insensata che si tira la zappa sui piedi dimenticando George Martin e Phil Spector, accantonando o non conoscendo Lee “Scratch”
Perry e il taglia e cuci di Teo Macero su Bitches Brew.
Idiozia cancellata da una pietra miliare istantanea, replicata qualche mese dopo l’uscita dal Dixie-Narco
EP, ottimo corollario da avere e non solo per la sentita
cover di Carry Me Home (un Dennis Wilson ripescato
in tempi non sospetti). Della manna beneficia anche
99
spotting, riassunto dell’asse con Weatherall, qui ben
più che coautore. Finirà nella soundtrack dell’omonima
pellicola legittimando l’empatia con lo scrittore Irvine
Welsh, iniziata l’anno prima con il singolo The Big Man
And The Scream Team Meet The Barmy Army Uptown e
raddoppiata con lo script per il video di Kowalski, diretto da Douglas Hart e la presenza di Kate Moss.
Uscito in piena estate, Vanishing Pointha il sole in
fronte. L’escamotage della colonna sonora e del dub
“terapeutico” in chiave bristoliana funziona. I Nostri ci
hanno giocato sopra e assieme, evitando abili di confrontarsi apertamente col mito e appropriandosi del
rock meticcio che impazza nelle chart, dai Chemical
Brothers di Dig Your Own Hole ai Beastie Boys passando per i nomi di cui sopra. Ciliegine sulla torta:
l’omaggio ai Motorhead - hippie cattivi e gonfi di speed per eccellenza - nella traccia omonima, trasfigurata in anfetaminico elettro-rock; Medication, che pare
riprendersi il dovuto dalla Jon Spencer Blues Explosion, che similmente aveva mietuto consensi pasticciando il rock’n’roll in qualcosa di nuovo.
I Was L ost , N ow I’m Found
Tanti, s’è detto, i paralleli con i fondamentali Massive
Attack ed ecco l’ennesimo. Come questi affidarono a
Mad Professor la revisione dub di Protection, Primal
Scream vanno alla fonte e chiedono ad Adrian Sherwood di rifare il trucco a Vanishing Point. Il Maestro ne
ricava il pregiato Echo Dek e - in un sapiente bilanciarsi
tra “bianco” e nero” - l’e.p. If They Move, Kill ‘Em vede
il Bloody Valentine Kevin Shields a remixare la traccia
omonima. Shields sarà figura chiave nell’economia di
un gruppo che necessita di “mentori” forti per sottrarsi
ai peggiori clichè del rock n’roll, cioè droghe che non
aiutano la creatività e vita inutilmente spericolata. Faccende che influiscono sull’attesissimo tour di Vanishing
Point, prima ritardato e poi latore di una drum machine
al posto del batterista. L’arrivo di Darrin Mooney aggiusta una formazione che cominciava ancora a scricchiolare, ma quel che conta è il ruolo splendidamente
inafferrabile di Kevin Shields, colui che aveva domato il
noise e ne aveva fatto polvere per gli angeli. Anticipato dal fortunato tormentone Swastika Eyes, la reazione
si getta senza rete in un grigio rigore urbano sull’asse
Detroit/Berlino. Va al fondo delle influenze kraut sin lì
accennate via percussioni alla Can e una spinta motorik
figlia dei Neu!
Exterminatoraffonda le mani in verbi fino ad allora
solo accarezzati e, fedele al nome che porta, “stermina”
l’epopea anni ’90 delineata dalla band. Un gesto da autentici Geni, in sostanza, che nello specifico si affidano
all’estetica techno e a un efficace plotone di produttori
(vecchi e nuovi: Brendan Lynch, Adrian Sherwood, Jagz
Kooner, David Holmes, Hugo Nicolson), benché siano
soprattutto Chemical Brothers e Kevin Shields a imprimere la direzione al lavoro più “politico” dei Primals.
Bellissimo, nel suo mescolare il “dopo Screamadelica“
ad alcuni eccellenti genitori di quest’ultimo e a ciò che
è stato nel frattempo. Sporco come la Motor City dei
Settanta e degli Ottanta, con la zampa dei primi evidente in Swastika Eyes e il piacere del sangue alle orecchie nel rumore brusco di Accelerator, suona come se
Madchester avesse adottato le abrasioni techno invece
della house. Ospita un Weatherall divino nella gemma
degna dei futuri Two Lone Swordsmen di From The
Double Gone Chapel Blood Money (visioni post-punk,
incursioni jazzy, taglio psych); stupisce con il Miles
Davis elettrico smontato dentro la spiraliforme MBV
Arkestra(If They Move Kill’Em); manda al tappeto con
Beastie Boys e Scorn sposati per Insect Royalty. La critica si esalta compatta e nel seguente tour appare un
pezzo carico di significati: Bomb The Pentagon attacca
l’Amerika che non piace e di lì a poco diverrà profezia,
non di quelle buone però. Ritoccato, non smarrisce
forza e anzi ne infonde nell’urgente Evil Heat, che nel
2002 riassume senza banalità né calligrafismi i punti
cardinali del gruppo, coinvolgendo come d’abitudine
amici antichi (Jim Reid) e conoscenze fashion (Kate
Moss nella celestiale, codeinica rilettura di Some Velvet
Morning). Un calderone da cui emergono la Germania
che sappiamo (Autobahn 66 e Hit Of Morning Sun s’inchinano a Kraftwerk e La Düsseldorf: la seconda dispiega comunque una melodia da California ’67 che si
fa India…); il punk e il suo dopo che esisteva già prima
(Skull X; una Rise che guarda a Neu! 75 e all’Immagine
Pubblica); blues del dopobomba (The Lord Is My Shotgun: Robert Plant all’armonica, il silicio e desolazione
industriale attorno a lui redenti a fine corsa dall’autoesplicativa elegia Space Blues #2); eccellenti perversioni
della pista da ballo (la laida Miss Lucifer, i clangori adeguatamente stordenti su cui poggia Detroit). Hai detto
niente, fratello.
B eautiful S creams
Facciamo un po’ di conti: quindici anni e sette album,
dal jingle-jangle al motorik tra trionfi divini e umani
imbarazzi. Se non c’è più niente da chiedere poco ci
manca, e infatti da qui in poi i Primal Scream si mantengono grazie al mestiere e va benissimo così. Status
e anagrafe non permettono miracoli (ma chissà…) e la
parola d’ordine si chiama classicismo. Di grana fine nel
2006in Riot City Blues, un Give Out But Don’t Give Up
dal passo e l’estro ben superiori e saggi d’enciclope100
dismo Rock trainati dall’anthem Country Girl. Si oscilla tra boogie ‘n roll trascinante oppure bucolico (Nitty
Gritty, We’re Gonna Boogie) e cartoline a Gram Parsons
(Hell’s Coming Down) o da Let It Bleed Sometimes I Feel
So Lonely), tra memorie New York Dolls (Suicide Sally &
Johnny Guitar, giustappunto Dolls) e perfino sciamanesimo Doors (Little Death). Un divertissementdi lusso
che diverte anche chi ascolta, fatto da chi se lo può
permettere e così sia, che già che c’è mostra la materia
grezza dei Nostri, depurata da contaminazioni a nuda
essenza rock. Ci sta eccome, così come si chiude un occhio a Mani dopo essere stato beccato ubriaco alla guida poco prima dell’esibizione al Leeds Music Festival,
tramutata da Kevin Shields in un “set nostalgia” rimasto
privo di replica.
In quello stesso periodo filtrano anche indiscrezioni
sulla nuova fatica, annunciata in abiti pop/krautrock.
In verità, di teutonico in Beautiful Future del 2008 c’è
poco e di pop viceversa eccome, ammiccante e impastato di tarda new-wave. Quanto di più potabile offerto
sinora, si veda la cassa dritta di Uptown, i Black Rebel
Motorcycle Club che si mescolano ai Bloc Party - Josh
Homme alla chitarra! - di Necro Hex Blues, una I Love To
Hurt cantata con Lovefoxx dei CSS. Cast e riferimenti
non di prim’ordine, ne converrete, cosicché il risultato
è spento e ruffiano, abissi la Zombie Man che neanche i
più triti Aerosmith e una Beautiful Summer da scarichi
Depeche Mode. Assumono perciò un valore di riflessione i ventiquattro mesi posteriori, intessuti di dichiarazioni di circostanza e silenzio, dal peso della scadenza
che sta per approssimarsi. Facile che sia così: lo riprova
che, gli “anni dieci” alle porte, Gillespie si apra alla Grandezza irripetibile che fu e ne celebri il ventennale.
Ad alcune date dal vivo già effettuate, seguirà nel
marzo venturo l’esecuzione di Screamadelica. In contemporanea, una sua lussuosa edizione - quattro CD,
vinile e DVD - approderà nei negozi rispolverando
l’e.p. Dixie Narco e i restanti remix pubblicati a loro
tempo. Addetto al remaster, ma pensa, Kevin Shields,
che come ha dichiarato Bobby recentemente “Farebbe
inorridire qualsiasi tecnico di studio, ma è talmente bravo con volumi e frequenze che abbiamo subito pensato
a lui.” Chiusura di cerchio, non a caso: dopo la reunion
dei My Bloody Valentine, si tratta di una delle più attese
tournée degli ultimi anni, passati via a riportare in vita il
passato più che a vivere il presente. C’è e ci sarà sempre
un prima e un dopoil 1991. Assai probabilmente, l’ultimo tra gli spartiacque del rock come lo conoscevamo.
101
CAMPI MAGNETICI #1
classic album rev
Scisma
Captain Beefheart
Rosemary Plexiglas (Catapulta/Emi, novembre 1997)
Trout Mask Replica (Straight, giugno 1969)
Si avviavano a spegnersi non senza clamori gli ultimi
anni del secolo, anzi, del millennio. Potrei dire che si avvertiva un senso di raccolto, di percorsi che tiravano le
fila e convergevano in un punto impreciso ma decisivo.
Era appunto una sensazione, magari personale, forse
diffusa, probabilmente indotta. In ogni caso, val bene
prenderla come “aperitivo emotivo” a Rosemary Plexiglas, l’album che fece conoscere gli Scisma al più o
meno vasto pubblico indie rock dello Stivale. C’era stato
un cd autoprodotto, Bombardando Cortina, nel 1995,
e prima ancora addirittura una audiocassetta,Pezzetti
di carta, a punteggiare quattro anni di gestazione che
guadagnarono al sestetto le attenzioni della EMI. Un
sestetto, già: attorno al compositore, cantante e chitarrista Paolo Benvegnù, agivano il chitarrista Diego
De Marco, la bassista Giorgia Poli, la tastierista Michela
Manfroi, il batterista Danilo Gallo più Antonella Ianniello al synth, presto sotituita dalla cantante e chitarrista
Sara Mazo. Proprio la voce di quest’ultima - da fanciullina delicata e posseduta - costituirà una stimolante alternativa
a quella di Benvegnù, rivelando nei duetti una complementarità insospettabile. Rosemary Plexiglas fu prodotto da Manuel Agnelli, per la prima volta al banco
di regia fuori dal contesto Afterhours (in procinto di
fare il botto con Hai paura del buio?). Insomma, non
nacque dal nulla, questo disco. Le premesse lavoravano perché fosse un album importante. A modo suo,
lo fu. Ascoltarlo in quei giorni significava accogliere
finalmente la possibilità di un rock italiano aperto al
mondo e gravido di conseguenze, inseminato e fertile.
Un frutto deliziosamente avariato del grunge, aperto
a brusche cupezze noise-shoegaze, capace di liberare
vibrazioni neo-psych e brume trip-hop, di meditare
scenografie arty e margini emotivi jazz. Se le forme guardavano con decisione al rock indipendente anglosassone (più USA che Albione), la specificità italiana o - meglio - europea sbocciava nell’estro
poetico di Benvegnù, nella sua languida, equivoca,
102
obliqua profondità. Che le quattordici tracce provvedevano a scandagliare con diversi modi e mood. Con
tale forza, variegata attitudine e una cura dei dettagli
ai limiti del maniacale, da scomodare un referente impegnativo come Mellon Collie And The Infinite Sadness, il (doppio) disco che concretizzò la formidabile
schizofrenia poetico/estetica di Billy Corgan. Pezzi
come Centro, L’equilibrio, Loop 43 e la title track celebrano l’incontro tra attitudine melodica, fregola visionaria e piglio elettrico. Le chitarre intrecciano riff tosti e
spirali brumose, il piano è un costante contrappunto
meditabondo, effetti sintetici e rumoristici abitano gli
spazi definendoli come altrove stranamente familiare. I
testi giocano tra enigmi e suggestioni, sono fotogrammi e micro-sequenze, squarci d’illuminazione tra tentativi d’introspezione indomiti (84), appassionati (Golf) e
disperati (Svecchiamento). Oppure sordidamente beffardi (Videoginnastica). O, ancora, capaci di esplorare
languori sospesi (L’autostrada). I segnali che venivano da questo disco e dal successivo – ahimé - canto del cigno Armstrong, sono
rimasti, in un certo senso, lettera morta. Le generazioni indie successive hanno concentrato le coordinate
sul patrimonio pur considerevole lasciato in eredità
da CSI, Marlene Kuntz, Massimo Volume e – appunto – Afterhours, di fatto scordando la lezione degli
Scisma, il loro groviglio di diramazioni poeticamente
incalcolabili, ineffabilmente italiane. E’ un rammarico
non da poco. Stefano Solventi
Per una volta, le mitologie, le classifiche, le pose alternative sono tutte concordi e soprattutto dicono la verità. Don Van Vliet era uno dei pochi veri grandi, forse
l’artista più importante e influente del rock assieme ai
Velvet Underground. Come per i Velvet cioè, pochi
hanno ascoltato i suoi dischi, ma quelli che l’hanno fatto hanno raccolto i giusti bad seeds e li hanno piantati
nel proprio orto. Alla feconda banana warholiana sta
insomma, su un piano certamente più carbonaro, la testa di trota immortalata da Cal Schenkel.
A parlare di Captain Beefheart si rischia di spellarsi
la lingua, troppe le cose da dire, su di lui e su quello
che, per una volta a ragione, è il disco a cui viene assimilato e a cui viene ridotto, un disco così potente da
scardinare i soliti meccanismi della bignamizzazione,
risplendendo di una oscura luce propria, bastando da
solo, un disco che come le vere opere d’arte ha il pregio
di essere denso e contorto eppure capace di regalare a
chi vi si perde dentro la più grande delle soddisfazioni:
la goduria dell’ascolto. Beefheart era un vero eccentrico e un genio vero, un diamante grezzo, suonava sax
e clarino senza saper leggere la musica, componeva a
impronta e sempre sotto assistenza (ma con i suoi discepoli era un esigentissimo direttore d’orchestra e un
vero padre-padrone), e da non-musicista ispirato quale
era ha creato qualcosa che prima di lui semplicemente
non esisteva, un’idea nuova di rock, più che cubista come spesso si è detto - surrealista, quindi collagistico,
animato da cozzature arbitrarie e sempre sorprendenti.
Il picco selvaggio di quest’arte si trova condensato
in quest’opera giustamente monumentalizzata, un centauro di blues pauperistico, free jazz che era già punk
e mozziconi di classica contemporanea, un’opera ispida, scontrosa, elegantemente arruffata, registrata in un
clima tra la frenesia creativa e lo scoramento esistenziale, in mezzo a mille litigi, da un Capitano frustrato
e paranoico e da uno Zappa letteralmente sull’orlo di
una crisi di nervi in una villa dove la Magic Band stava
accampata come una comune. In mezzo e sopra a tutto
questo, il ruggito catramoso del nostro, il suo marchio
di fabbrica, figlio legittimo dei latrati di Howlin’ Wolf.
Non è un caso che i grandi vecchi - i più grandi - del
rock scritto e spiegato, Lester Bangs e John Peel, la
pensassero allo stesso modo: dietro la maschera della trota c’è uno scrigno prezioso, da cui hanno attinto
a piene mani tutti i musicisti più interessanti del rock
alternativo degli ultimi trent’anni. Elenchiamo? Nick
Cave, PJ Harvey, Pere Ubu, Devo, molta new wave e
tutta la no wave, Genesis P. Orridge e le sue creature industriali, John Lydon e i PiL, Minutemen e tutto il
jazzcore, tutto il post-rock versante -core e math-, Old
Time Relijun e tutto il rock tribale ed esoterico. E ovviamente Tom Waits.
La vita e l’arte del Capitano ci raccontano di un tempo finito per sempre, quello dei primi pionieri, armati di pala ed elmetto, tempo avvolto dalle nebbie del
mito: il nostro big bang in quegli infiniti pomeriggi
dell’adolescenza passati ad ascoltare blues e doo-wop
a due passi dal deserto del Mojave, in compagnia di un
ancora non baffuto Frank Zappa. Vero scapestrato e
vero naif, il Capitano ha poi nel tempo disperso il proprio genio, ritrovandolo giusto prima di chiudere una
volta e per sempre il proprio rapporto con le sette note.
Quando infatti, dopo il riflusso e la crisi dei Settanta, ottimi frutti stavano spuntando dai suoi semi e una schiera di alt-boys cresciuti con il suo mito stava emergendo
dalle cantine, quando insomma Beef stava per essere
riscoperto e messo sotto i riflettori come lo Spotlight
Kid di un suo titolo (lui eterno rinfrangente refrattario
Mirror Man), l’uomo si è ritirato a vita privata, tipo Salinger del rock, tornando alla passione da cui, surrealista
fin dentro il midollo, era partito: la pittura.
Il Capitano è tornato Don Van Vliet, ha visto crescere
le piante nate dai suoi semi, e non ha messo lingua.
Gabriele Marino, Stefano Solventi
103
www.sentireascoltare.com