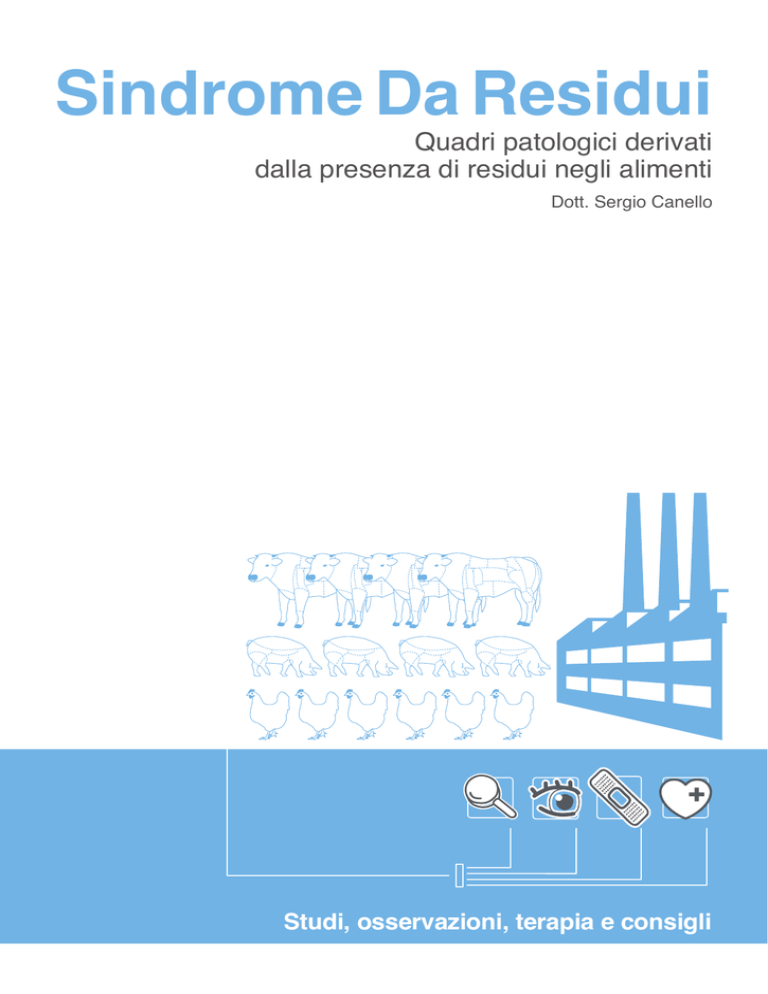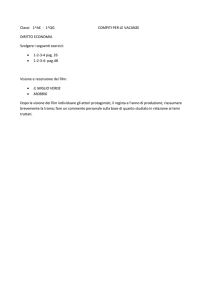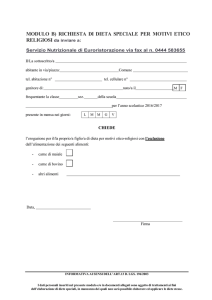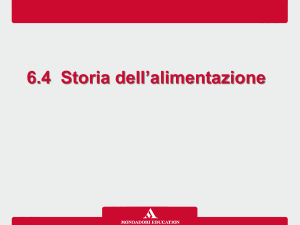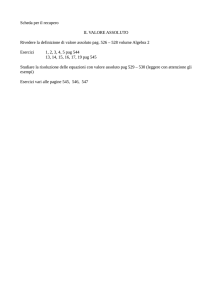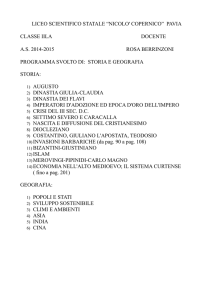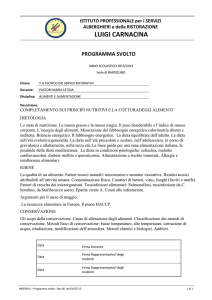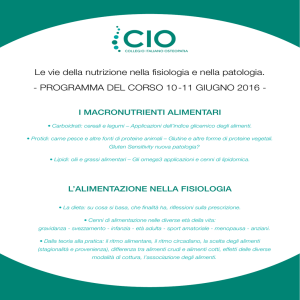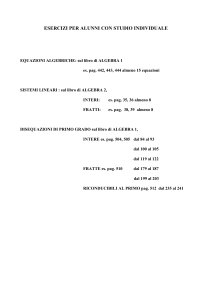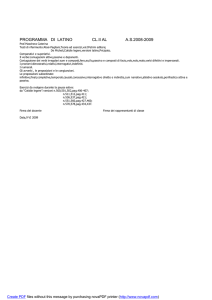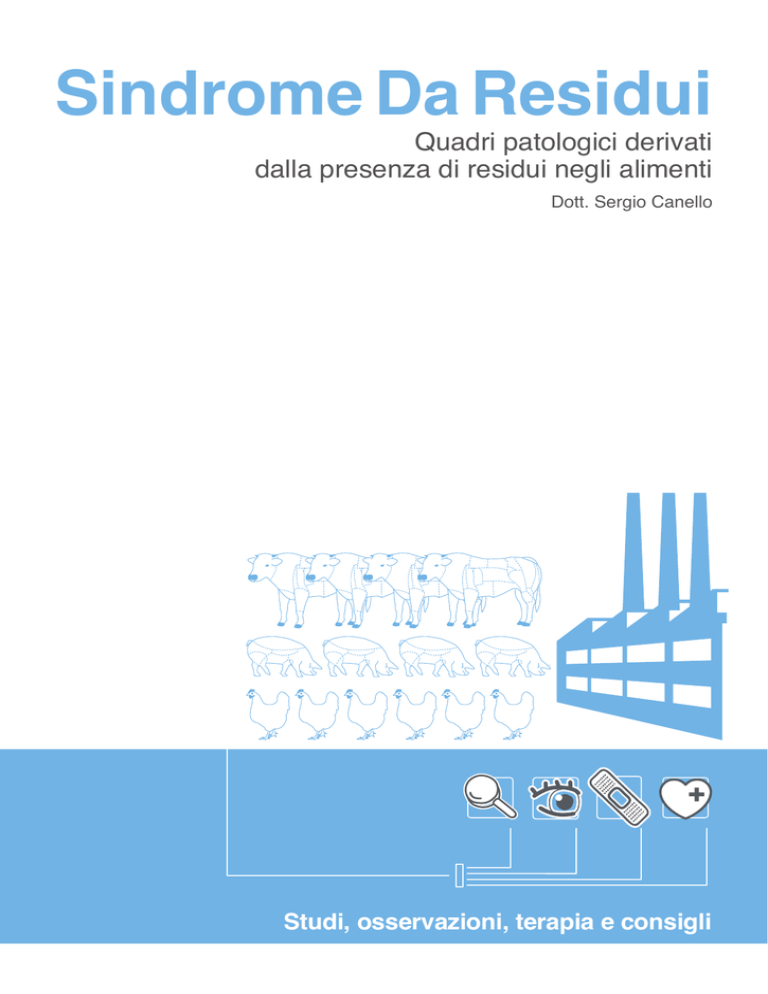
Sindrome Da Residui
Quadri patologici derivati
dalla presenza di residui negli alimenti
Dott. Sergio Canello
Studi, osservazioni, terapia e consigli
Sindrome da Residui
Dott. Sergio Canello
L’ Autore riconosce nei residui presenti
nelle carni derivanti da allevamento
intensivo la causa di un rilevante
numero di quadri patologici presenti nel
cane e nel gatto
Parole chiave:
Cane
Causa prima
Causa scatenante
Prurito
DAP Dermatite Allergica da Pulci
Dermatite
Eczema padiglione auricolare
Epifora
Vomito
Diarrea
Residui
S. R. A.Sindrome da residui negli alimenti
Fattore RFattore residuale
Alimenti provenienti da animali allevati in modo industriale
Sindrome da Residui
Introduzione
Negli ultimi 20 anni abbiamo riscontrato
nel cane e nel gatto un aumento della
patologia cutanea e gastroenterica, caratterizzate l’una da forte prurito e lesioni da grattamento, l’altra principalmente
da episodi frequenti di vomito e diarrea
non rispondenti a terapia. Questo fenomeno ci ha indotto a porre particolare
attenzione alle anamnesi dei casi trattati,
nell’intento di identificare le cause primarie dei fenomeni citati. Detta ricerca ha
permesso di evidenziare inizialmente
come causa scatenante delle sintomatologie suddette, l’assunzione di alcuni
alimenti di origine animale e più precisamente, in ordine decrescente di incidenza, le carni di pollo, tacchino, suino e
bovino, nonché di tutti i cibi confezionati
che, in misura più o meno rilevante, ne
contengano. In un secondo momento
è emerso con estrema chiarezza come
tali cibi fungano da semplici vettori di un
“fattore sconosciuto” che sembra costituire la vera “causa prima” delle patologie
manifestate. L’esistenza di un “fattore
sconosciuto” giustifica appieno perché
anche le fonti proteiche di origine aviaria,
universalmente accettate come ipo-allergeniche e molto apprezzate dal punto di
vista dietetico, giochino un ruolo addirit-
tura fondamentale nelle patologie citate.
Numerosissime esperienze hanno messo in luce le strette analogie di tali fenomeni con le intolleranze alimentari e
con l’atopia e con la DAPP (dermatite
allergica da morso di pulce): molti alimenti verosimilmente privi del “fattore
sconosciuto” o la sensibilizzazione al
morso della pulce possono provocare
sintomi molto frequentemente sovrapponibili a quelli quivi descritti, riconducibili
al capitolo delle reazioni avverse al cibo.
Il pur ampio capitolo delle intolleranze
alimentari vere e proprie non giustifica
infatti assolutamente l’impressionante
casistica emersa, essendo la letteratura pressoché concorde nell’imputare a
fenomeni di intolleranza alimentare non
più del 10% delle dermatiti pruriginose
e dei fenomeni gastroenterici (1). Il fatto
che la somministrazione sperimentale,
ai soggetti con sintomatologia in atto, di
carni fresche della medesima natura di
quelle abitualmente loro somministrate,
ma provenienti da animali allevati senza
terapie farmacologiche e trattamenti chimici, e alimentati con cibi privi di additivi,
abbia provocato, nella grande maggioranza dei casi, la scomparsa delle manifestazioni patologiche, fornisce un’ulte-
riore conferma che i fenomeni riscontrati
non si possano ascrivere tra le intolleranze alimentari classicamente intese. Una
verifica aggiuntiva si è avuta somministrando a soggetti con sintomatologia in
atto, per periodi anche superiori ai due
anni, carne di cervo: i sintomi sono completamente regrediti e non si sono manifestati fenomeni riferibili ad una progressiva sensibilizzazione a questo alimento.
Si é così ipotizzato che il “fattore sconosciuto” sia costituito da una o più sostanze estranee alla composizione naturale
degli alimenti, spostando l’attenzione
sulle reazioni avverse dovute alla presenza nei cibi di molecole farmacologicamente attive.
La ricerca da noi effettuata ha voluto
verificare, dapprima con un periodo preliminare di osservazione, e successivamente attraverso un periodo sperimentale basato su una dieta di eliminazione,
le relazioni esistenti tra le manifestazioni
cliniche citate ed una dieta a base di carni, fresche e/o confezionate, provenienti
da animali allevati con metodo intensivo.
Padova, Gennaio 1995
Studio preliminare
In seguito all’osservazione clinica di una possibile correlazione tra diverse forme di dermatite pruriginosa, eczema
o sintomatologie gastroenteriche e l’alimentazione, sono stati esaminati, nell’arco di 5 anni, tra il 1976 ed il 1980, le
diete di oltre 500 cani affetti da tale problema (Tabella 1). Data la netta prevalenza di carni da allevamento intensivo,
fresche o contenute in alimenti preconfezionati, è stata sperimentata una dieta che ne prevedesse la privazione
totale.
Sorprendentemente, oltre all’elevata percentuale di remissione, parziale o totale, della sintomatologia, si è notata la
contemporanea regressione di molti quadri patologici che non erano stati messi in relazione con la sintomatologia
in esame.
Si trattava di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
eczema del padiglione auricolare, complicato o meno da otite purulenta;
forme eczematose umide al collo, dorso, groppa e faccia laterale della coscia;
granulomi da leccamento alla cute del carpo o del tarso;
lambimento ossessivo della faccia volare del carpo;
dermatosi dello scroto;
congiuntivite e/o cheratite, mono o bilaterale;
iniezione sclerale costante;
lacrimazione costante;
ostruzione del dotto naso-lacrimale;
episodi ripetuti di vomito;
addome acuto con stato paretico degli arti posteriori;
gastroenterite emorragica;
diarrea cronica;
fermentazione intestinale abnorme e flatulenza;
replezione periodica delle sacche anali;
ascessi e fistolizzazioni delle ghiandole perineali;
episodi convulsivi a frequenza variabile;
piodermite interdigitale e mentoniera.
(La descrizione particolareggiata dei fenomeni elencati è riportata nel prosieguo della trattazione).
Tabella 1
Consumo di carni di origine industriale, fresche e/o confezionate, nei 507 cani, affetti da dermatite pruriginosa e/o disturbi
gastroenterici, sottoposti a indagine conoscitiva preliminare.
Diretto (1)
N. soggetti
Indiretto (2)
N. soggetti
Misto (3)
N. soggetti
Totale
29
17
25
71
Consumo
frequente
156
103
114
373
Consumo
quotidiano
41
15
7
63
226
135
146
507
Consumo
saltuario
Totale
;
(1) Consumo di carne, ossa e frattaglie freschi
(2) Consumo di alimenti preconfezionati che, in percentuale variabile, contenessero carni, frattaglie od ossa;
(3) Consumo misto di alimenti confezionati e carni fresche.
In base ai risultati dello studio preliminare, che confermava una relazione fra determinate patologie e l’alimentazione,
sono stati presi in esame, nell’arco di tempo compreso fra il 1980 ed il 1993, un totale di 1312 cani che presentavano
uno o più quadri patologici precedentemente descritti.
Per ogni singolo caso sono state raccolte informazioni su età, tipo di vita, caratteristiche ed abitudini alimentari,
presenza di ecto o endoparassiti ed eventuali altre patologie concomitanti. Escluse, attraverso esami di laboratorio,
le più probabili cause concomitanti (DAPP, micosi, scabbia, allergie da contatto, infestazioni intestinali, filariasi ed
altro), i soggetti sono stati sottoposti ad una dieta da privazione.
Sindrome da Residui
Schema di intervento
Tutti i soggetti selezionati sono stati alimentati per un periodo minimo di 15 giorni con una dieta di eliminazione composta
esclusivamente da riso, olio vegetale, verdure e pesce di mare (merluzzo e nasello).
Al 7o e 14o giorno dall’inizio della dieta veniva effettuata la visita di controllo: quando la sintomatologia permaneva
invariata, la dieta veniva sospesa e si ricercavano altre cause, mentre in caso di attenuazione dei sintomi la dieta
veniva continuata per altri 14 giorni, verificandone i risultati finali (Grafico 2).
Remissione complessiva dei sintomi (n. 9.170)
persistenza
Velocità di guarigione nei casi di remissione totale (n. 4.487)
remissione totale
patologia presente
remissione totale
remissione parziale
Nel grafico a torta gli esiti finali dei 9.170 sintomi analizzati. Solo il 22% dei sintomi persiste. Il grafico ad istogrammi si riferisce ai casi di remissione
totale ed evidenzia la velocità di guarigione: dopo 1 settimana più della metà dei sintomi sono regrediti completamente e dopo 14 gg più di 3/4 dei
sintomi sono scomparsi.
Remissione complessiva dei sintomi (n. 9.170)
Nel grafico sono riportati per ogni sintomo il numero di casi presi in considerazione (tra parentesi) e l’INDICE DI REMISSIONE.
L’indice di remissione è calcolato sulla base degli esiti raggiunti nel campione esaminato. Il suo valore è compreso tra 0 (persistenza
del sintomo in tutti i casi studiati) e 1(remissione totale nel più breve tempo possibile di tutti i casi studiati). L’indice sintetizza in un
punteggio finale il numero di casi di remissione totale, la velocità con la quale si è raggiunta la guarigione, i casi di miglioramento e i casi di
persistenza. tenedo conto delle peculiarità del sintomo preso in esame di volta in volta. Tutti i casi superiori allo 0,5 sono da considerarsi
Padova, Gennaio 1995
Prova di reintroduzione
In 850 soggetti in cui era stata osservata la scomparsa totale della sintomatologia in seguito alla variazione della
dieta sono stati, come controprova, reintrodotti, uno alla volta ed intervallati di 15 giorni, i diversi alimenti eliminati,
prestando particolare attenzione a tutti quelli di origine carnea e verificando tempi e modi della eventuale ricomparsa
dei sintomi (Tabella 3).
Tabella 3
Ricomparsa delle patologie alla reintroduzione della dieta originaria - valori cumulati
(campione: n.850 soggetti su cui era stata osservata la scomparsa totale della sintomatologia)
Risultati
Lo studio preliminare, la dieta di eliminazione e le prove di reintroduzione hanno evidenziato una relazione diretta fra
determinate patologie e la presenza, nella dieta, di carni da allevamento intensivo.
L’osservazione che una dieta basata su carni di animali di allevamenti “biologici” non determina la comparsa di
patologie analoghe lascia supporre che la causa di tali fenomeni sia da imputare a sostanze estranee alla composizione
naturale delle carni.
Nel prosieguo della trattazione chiameremo queste sostanze estranee “Fattore R” (Fattore residuale).
Descrizione analitica dei quadri patologici osservati
I quadri patologici che descriviamo hanno manifestato, negli anni, una costante tendenza all’aggravamento e
all’interessamento di un sempre maggior numero di soggetti.
Fino a qualche anno fa risultavano infatti colpiti esclusivamente animali adulti e la patologia aveva una evoluzione
piuttosto lenta. Ultimamente, invece, si è assistito:
1°- al coinvolgimento anche dei cuccioli;
2°- ad un sempre minore tempo di latenza tra l’assunzione degli alimenti incriminati e la comparsa del prurito e delle
lesioni da autograttamento e/o del vomito e diarrea;
3°- alla comparsa di un tale corteo di sintomi da poter parlare di una vera e propria sindrome che chiameremo
“Sindrome da residui negli alimenti” (S.R.A.)
Sindrome da Residui
Sindrome da residui negli alimenti (S.R.A.)
Per “sindrome da residui negli alimenti” (S.R.A.) intenderemo il corteo di sintomi che si sviluppa in un soggetto
sensibile in seguito all’assunzione di cibi contenenti molecole farmacologicamente attive; tali sintomi si manifestano
principalmente a carico dell’apparato cutaneo, di quello gastroenterico e dell’occhio.
L’interessamento di organi diversi avviene solo in situazioni meno frequenti, che verranno in seguito descritte.
I sintomi possono apparire singolarmente o associati tra loro nelle combinazioni più svariate.
La sindrome nel gatto sarà descritta in un lavoro successivo in quanto tale animale presenta un quadro sintomatico
alquanto diverso e sovrapponibile solo in parte a quello del cane.
Descrizione della S.R.A. nel cane
La S.R.A. presenta una fase
prodromica, una fase acuta e una fase cronica.
Fase prodromica nel cane
Il soggetto colpito presenta dapprima una fase di “sensibilizzazione”, cui unico sintomo è un prurito sine materia,
localizzato inizialmente in regioni ben definite e delimitate (groppa e lati del collo), ma che tende ad estendersi al
padiglione auricolare, alle ascelle e alla parte ventrale dell’addome. Altrettanto frequente è la comparsa, fin dalle
prime fasi, di una forte epifora, mono o bilaterale, desquamazione cutanea, forfora e congestione congiuntivale. Nei
cuccioli la sensibilizzazione può instaurarsi anche in tempi brevissimi (anche a soli due o tre giorni dallo svezzamento
è comune imbattersi in soggetti che presentano già un notevole prurito sine materia, soprattutto sul collo). Sono
comunque colpiti soggetti di tutte le età e non è infrequente osservare soggetti anziani od addirittura vecchi che si
sensibilizzano improvvisamente.
Forma acuta nel cane
Nei soggetti precedentemente sensibilizzatisi la sintomatologia si manifesta molto rapidamente: i tempi di latenza
variano infatti da pochi minuti ad un massimo di 12 ore. Tale quadro presenta quindi strette analogie con fenomeni
squisitamente allergici.
I soggetti possono presentare, dopo un tempo medio di latenza di un’ora dall’assunzione dell’alimento, insorgenza
improvvisa di:
• forte prurito ed arrossamento dei padiglioni auricolari;
• forte prurito ed irritazione nella zona dorso-lombare e solo prurito nella zona del collo*;
• una forma eczematosa umida, identica all’hot spot e solitamente ben delimitata e localizzata al collo, al dorso,
alla groppa o alla faccia esterna della coscia; tale lesione, caratterizzata da prurito intensissimo e conseguenti
lesioni da autograttamento, dapprima caratteristica del periodo estivo, è ormai riscontrabile sempre più
frequentemente in tutte le stagioni. In alcune razze (barboncino, cocker) tale forma si manifesta anche nella
regione della guancia;
• grave congiuntivite monolaterale, frequentemente anche con interessamento della cornea, che può ulcerare o
perfino lacerarsi in seguito ad autograttamento, con conseguente svuotamento della camera anteriore *;
• congiuntivite e lacrimazione bilaterale con fotofobia come sintomo peculiare: tale forma colpisce quasi
esclusivamente i cani di piccola taglia;
• seria dermatite scrotale ben localizzata ad evoluzione benigna; è presente una forte dolorabilità, il cane tende a
lambire con estrema precauzione la parte e presenta evidenti difficoltà a sdraiarsi *;
• addome acuto con paresi degli arti posteriori, borborigmi e flatulenze, ad evoluzione benigna, con risoluzione in
un massimo di 2 o 3 giorni.
• episodi ripetuti di vomito;
• gastroenterite emorragica caratterizzata da presenza di sangue rosso vivo soprattutto nelle feci, febbre assente o
di modica entità (39-39.5°C) e buono stato generale, senza abbattimento particolare del sensorio;
Padova, Gennaio 1995
• episodi convulsivi.*
Gli animali, in assenza di ulteriori assunzioni di cibo, manifestano la sintomatologia per circa 4-5 giorni, mentre i
soggetti particolarmente sensibili anche per 25-30 giorni.
* Nei casi contrassegnati da asterisco è frequente la cronicizzazione dei fenomeni descritti.
La forma cronica della S.R.A. si può suddividere schematicamente in:
A) Forma cronica
B) Forma cronica evolutiva
Forma cronica nel cane
Nella forma cronica molti dei sintomi già descritti nella forma acuta tendono a persistere nel tempo senza rilevanti
variazioni di intensità.
Cute e annessi:
• opacità e aridità del mantello (a);
• prurito sine materia nelle regioni del collo;
• prurito sine materia alla faccia volare del piede, in particolare l’anteriore (tale localizzazione è più frequente nel
barboncino e nelle razze nane);
• prurito ed eritema a uno o a entrambi i padiglioni auricolari; (la patologia al padiglione ed al canale auricolare, che
si presenta con calore, rossore, ispessimento, seborrea, desquamazione e forte prurito è da noi osservata con
sempre maggior frequenza ed è talmente caratteristica da assumere, insieme al prurito al collo ed alla groppa,
carattere patognomonico della S.R.A.)*;
• prurito ed eritema alla regione ascellare;
• prurito ed eritema alla regione ventrale dell’addome con comparsa di papule e/o pustole;
• prurito alla regione dorso-lombare accompagnato da desquamazione, alopecia e lesioni da autograttamento;
• cute maleodorante;
• piodermite interdigitale e alle callosità cutanee con possibile interessamento della regione del mento.
Alla stessa eziologia sono da imputare la maggior parte dei piccoli granulomi da leccamento (6, 7, 8, 9, 14),
classificati anche come “dermatosi psicogena”(13), solitamente localizzati sulla parte distale della faccia anteriore di
un arto, che non tendono alla guarigione spontanea;
Apparato gastroenterico:
• frequenti episodi di vomito a digiuno e desiderio abnorme di assumere erba (b);
• frequenti episodi di diarrea, solitamente di consistenza poltacea;
• tendenza a un’imponente fermentazione intestinale e flatulenza;
• diarrea cronica afebbrile;
Occhio:
• epifora pressoché costante, con modico interessamento congiuntivale (c);
Sacche anali:
• tendenza periodica alla loro replezione con contenuto nettamente più denso e colloso della norma, tanto da
impedirne ciclicamente lo svuotamento spontaneo, con la conseguente formazione di ascessi ricorrenti che
fistolizzano;
Sistema nervoso:
• comparsa di attacchi epilettiformi che possono assumere frequenza variabile;
Stato emotivo:
• atteggiamento depresso e stanco con scarsa propensione alla socializzazione e al gioco.
L’intensità sia del prurito che degli altri sintomi, con aggravamenti orari frequentemente molto precisi, e la loro
permanenza nel tempo sono ovviamente legate alla presenza negli alimenti del “fattore R” ed addirittura, data
l’estrema brevità del tempo di latenza, all’orario dei pasti.
(a) Nei soggetti in fase cronica il pelo tende a mantenersi lucido per un tempo molto breve dopo il lavaggio; l’animale
in buona salute riacquista invece rapidamente e senza bisogno di alcun trattamento un mantello morbido e lucido
anche dopo essersi abbondantemente infangato.
(b) Aumenta costantemente il numero dei soggetti che cercano quasi quotidianamente erba da “brucare”: il fenomeno,
proprio in ragione della sua frequenza, tende sempre più ad essere considerato fisiologico anche da molti colleghi,
mentre in realtà un soggetto in piena salute ricerca erba molto di rado.
Sindrome da Residui
(c) Parimenti al desiderio di erba, la costante secrezione oculare di moltissimi soggetti viene spesso considerata un
fenomeno parafisiologico: la sua scomparsa in molti soggetti in seguito alla variazione della dieta indica invece
come tale secrezione rappresenti anch’essa un vero e proprio “canale di scarico” dell’organismo. Anche nelle razze
brachicefale, sia canine che feline, nonostante le evidenti implicazioni anatomo-funzionali, le secrezioni oculari
sono estremamente influenzate dalla dieta.
Forma cronica evolutiva nel cane
Nella forma cronica evolutiva si evidenziano:
Cute e annessi:
• progressivo peggioramento dello stato del mantello con pelo opaco, secco e forforoso, estensione delle lesioni a
tutto il dorso, all’addome e agli arti con alopecia diffusa, prurito pressoché costante, anche se meno intenso delle
fasi acute e comparsa di eczemi crostosi umidi, ipercheratosi, lichenificazione, grave seborrea e piodermite;
• cattivo odore caratteristico;
• dermatosi dello scroto (6, 7, 8, 9) con progressiva ipercheratosi, lichenificazione, colorazione rosso mattone; la
notevole dolorabilità della prima fase tende a diminuire fino a quasi annullarsi;
• otite cronica con ipercheratosi del padiglione e del condotto; nelle fasi più avanzate l’otite diventa purulenta e
pressoché resistente a qualsiasi terapia;
Occhio:
• congiuntivite cronica purulenta e possibile blefarite concomitante.
Si può notare come i vari quadri della sindrome siano tutti ben conosciuti ed accuratamente descritti singolarmente
(Dermatite pruriginosa (13 pag.115); dermatite allergica da punture di pulci (2, 3, 4, 5 pag. 116; 10 pag.466; 13
pag.118-2146); otite eczematosa; dermatite atopica (6, 7, 8, 9 pag.118; 10 pag.470; 13 pag.2141); granuloma da
leccamento (6, 7, 8, 9, pag.120; 13 pag.118); dermatite allergica facciale (10 pag.456); dermatite piotraumatica (hot
spot) (15); dermatosi dello scroto (2, 3, 4, 5, pag.362); allergie alimentari (13 pag.2140; 14 pag.205); gengivite (14
pag.216; 10 pag.901); gastroenterite emorragica (13 pag.1319); diarrea cronica (13 pag.1320); epilessia idiopatica
(13 pag.89), senza tuttavia che ne sia mai stata riconosciuta un’eziologia comune.
Da evidenziare, inoltre, come il concetto di sindrome scaturisca dall’osservazione della sintomatologia cutanea
accompagnata da prurito indotta da determinati alimenti: infatti in gran parte gli altri quadri sintomatici descritti
sono stati ricondotti alla medesima eziologia solo grazie all’osservazione della loro sistematica scomparsa durante
l’assunzione della dieta prescritta per le dermatiti suddette. Altri aspetti della S.R.A. sono stati scoperti sospettando,
per estensione, un’eziologia analoga di patologie non direttamente associabili alla alimentazione (ad esempio, alcuni
tipi di fenomeni convulsivi).
Eziopatogenesi
Si è dimostrato come l’eziopatogenesi della S.R.A. sia alimentare, dal momento che un’adeguata variazione della
dieta può indurre, senza l’ausilio di alcuna altra terapia, la remissione definitiva della sintomatologia.
Come segnalato nell’introduzione, è verosimile che gli alimenti fungano da semplici vettori di un fattore sconosciuto,
vera causa primaria della S.R.A.
Questo fattore sconosciuto è stato con ragionevole probabilità identificato, attraverso alcune semplici osservazioni,
nella presenza di sostanze farmacologicamente attive in quegli alimenti di origine animale che provengono da
allevamenti intensivi.
Alimenti analoghi, se derivanti da animali allevati ruralmente in modo tradizionale “biologico” non provocano infatti la
S.R.A. nei medesimi soggetti.
Un’ulteriore conferma, come già accennato nella parte introduttiva, è data dalla remissione della sintomatologia nei
cani alimentati con carne di cervo, alimento completamente naturale e privo di additivi chimici.
La riconosciuta ipoallergicità della carne di montone, che dà un analogo risultato, si dovrebbe anch’essa alla assenza
di residui, probabilmente perché ancora non risulta economicamente interessante trattare farmacologicamente questi
animali.
Solamente con rigorose ricerche si potrà evidenziare la sostanza che si comporti da vero e proprio “minimo comune
denominatore”; è ipotizzabile chiamare in causa auxinici e antibiotici a motivo della loro presenza costante in quasi
tutti i mangimi utilizzati in zootecnia.
Il candidato più probabile potrebbe essere la ossitetraciclina o qualche suo metabolita; questo antibiotico è stato
infatti somministrato generosamente da oltre vent’anni sia come auxinico che nella profilassi e nella terapia di tutti
gli animali da allevamento.
Padova, Gennaio 1995
E’ molto probabile che il quantitativo di “Fattore R” nelle carni sia influenzato dal rispetto o meno dei tempi di
sospensione dei vari farmaci prima della macellazione; ecco, forse, la spiegazione dell’estrema variabilità di
frequenza e gravità della sindrome in Paesi differenti e perfino in regioni diverse della stessa Nazione. Non è poi da
sottovalutare il diffuso impiego delle carcasse di animali trattati fino all’ultimo con antibiotici ed auxinici per ricavarne
farine di carne, pratica che contribuisce a determinare un progressivo aumento della quantità residuale.
E’ probabile comunque che la sindrome, riferendosi a fenomeni di reazione avversa al cibo, si sviluppi anche in
presenza di quantitativi di “Fattore R” apparentemente insignificanti.
In base alle nostre conoscenze attuali gli alimenti che possono contenere il “Fattore R” sono:
• tutte le carni di animali che non vengano allevati con alimenti naturali;
• tutti gli alimenti che in qualche modo contengano tessuti di tali animali (tabella 4).
Tabella 4
Presenza del “Fattore R” nei diversi alimenti
Assente
Agnello
Dubbia
Variabile
Bassa
Media
Elevata
X
Cavallo
X
Coniglio
X
Maiale
X
X
Manzo
Montone
X
Pollo
X
Tacchino
X
Vitello
X
Estratto di carne (dado)
Cereali
X
X
Pane
X
Cereali Soffiati
X
Latte
X
Uova
X
Burro
X
Formaggi
X
Pesce di mare
X
Pesce allevato
Verdura
Elevatissima
X
X
Frutta
X
Grassi Vegetali
X
* La presenza del “Fattore R” nelle carni equine oscilla tra l’assente e l’elevato a seconda della provenienza dell’animale: il
semplice e seppur breve “finissaggio” cui vengono di norma sottoposti tali animali al loro arrivo in Italia, sembra compromettere
la “purezza” delle carni. Anche le carni dei cavalli sportivi macellati a fine carriera o per patologie che ne impediscano l’impiego
risentono della medesima problematica.
Presenza del fattore “R” nei diversi tessuti
Il proseguire delle ricerche ha permesso di stilare, in base alla risposta dell’organismo, una graduatoria del grado di
fissazione dei residui nei diversi tessuti.
E’ stato infatti clinicamente verificato che il tessuto adiposo e quello osseo agiscono da veri e propri depositi di
“Fattore R”: la conseguenza di ciò è che gli alimenti che contengono in maggiore misura tali tessuti risultano essere
quelli che scatenano con maggiore frequenza una sintomatologia imponente.
I tessuti che dimostrano clinicamente minor accumulo di “Fattore R” sono i visceri, in particolare modo polmone e
milza (tabella 5).
La comparsa della sindrome in animali che non vengono apparentemente nutriti con carne o suoi derivati potrebbe
Sindrome da Residui
essere spiegata dal quasi ubiquitario impiego di farine d’osso e/o di grassi animali (burro e strutto) negli alimenti
preconfezionati. I grassi sono ad esempio aggiunti per aumentare l’appetibilità di alimenti non particolarmente graditi
(fioccati, verdure liofilizzate, sfarinati etc.).
E’ comunque possibile che vi sia la corresponsabilità di altre sostanze o altri metaboliti nella comparsa della S.R.A.
Tabella 5
Presenza di “Fattore R” nei diversi tessuti
Bassa
Media
Elevata
Grasso
Elevatissima
X
Muscolo
X
Osso
X
Pelle
X
Visceri
X
Tempo di permanenza del “Fattore R” nell’organismo
Numerose osservazioni cliniche hanno permesso di accertare il tempo di permanenza del “Fattore R” nell’organismo:
la singola assunzione di un alimento contenente tale fattore scatena nel soggetto sensibile reazioni che permangono
per un tempo variabile fra i 4-5 e i 25 giorni, in relazione verosimilmente più alla sensibilità individuale che al
quantitativo di “Fattore R” presente nell’alimento.
Fattori che influenzano la comparsa della S.R.A.
Nei numerosi casi clinici da noi seguiti nel corso degli ultimi 15 anni non sono state rilevate differenze significative
riguardo al sesso ed alla taglia, mentre si è notata una maggiore predisposizione all’insorgenza delle lesioni nei
soggetti sedentari, in quelli a pelo lungo e in quelli che vivono in casa.
La comparsa della S.R.A. è comunque strettamente legata ai seguenti altri fattori:
• presenza effettiva di residui: ovviamente non tutti gli alimenti responsabili contengono sistematicamente
residui;
• sensibilità individuale: soggetti diversi che si cibano con medesimi alimenti possono sviluppare o meno la
S.R.A. a seconda del proprio grado di sensibilità. In ogni caso, nella grande maggioranza dei soggetti la
sintomatologia si manifesta più o meno marcata a carico di almeno uno degli organi bersaglio;
• residenza: i soggetti che vivono in zone poco servite dalla distribuzione industriale risultano meno interessati
dalla sindrome;
• ambiente: i soggetti che vivono all’aria aperta risultano meno interessati dalla S.R.A.;
• attività fisica: i soggetti da lavoro risultano nettamente meno colpiti dalla sindrome;
• stagione: la stagione estiva influenza nettamente l’intensità della S.R.A. amplificando tutta la sintomatologia
presente. La motivazione di ciò è, con ogni probabilità, da ricercare nei fenomeni allergici stagionali di altro
tipo: la sensibilizzazione nei confronti di un qualsiasi allergene sembra contribuire alla accentuazione del livello
di ipersensibilità generale del soggetto;
• parassiti: gli ectoparassiti, in particolare le pulci, influenzano solo parzialmente il quadro **;
La quantità di alimento non è significativa: la sindrome si sviluppa anche in seguito all’assunzione di
modestissime quantità di alimento.
** Un dato significativo emerso dalle nostre ricerche è il ridimensionamento del ruolo della pulce nella patologia
cutanea a eziologia allergica. Numerosi casi clinici, documentati anche in video, hanno permesso di evidenziare con
chiarezza come la grande maggioranza delle dermatiti che vengono comunemente attribuite ad “allergia alle pulci”
sia invece da attribuire alla S.R.A. Eliminando infatti la causa primaria con una semplice variazione della dieta si può
osservare la scomparsa non solo degli effetti patologici derivati dalla presenza del parassita, ma frequentemente
addirittura la scomparsa delle pulci o per lo meno un notevole ridimensionamento dell’infestazione.
Padova, Gennaio 1995
Tale fatto dimostra con chiarezza come il parassita tenda semplicemente ad approfittare di un terreno particolarmente
favorevole al suo insediamento e come l’allergia alla pulce sia molto spesso da considerare secondaria o
semplicemente sovrapposta alla S.R.A. E’ d’altronde ormai universalmente accettato che la soglia di reattività a
fenomeni del tipo finora descritto sia spesso correlata all’associazione di due o più concause: in molti soggetti
possono essere contemporaneamente presenti ipersensibilità di origine diversa (pulci, pollini, polveri ed altro) che
singolarmente potrebbero non essere in grado di scatenare reazioni significative.
Un’ulteriore prova del ruolo secondario della pulce nelle dermatiti con prurito è rappresentata dalla constatazione
che, pur eliminando i parassiti con antiparassitari, si verificano recidive pressoché sistematiche della patologia
cutanea in tempi più o meno brevi. Gli antiparassitari potrebbero quindi avere un meccanismo d’azione di tipo
immunosoppressivo, effetto collaterale peraltro già dimostrato per diverse molecole (levamisolo, ivermectina,
triclorfon).
Non bisogna poi dimenticare l’azione topica di alcune sostanze antiparassitarie (triclorfon), che molte volte possono
spiegare i successi, seppur effimeri, ottenuti nelle dermatiti.
Un regime dietetico costantemente privo degli alimenti “a rischio” assicura nella maggior parte degli animali l’assenza
di recidive, ad esclusione dei casi largamente inveterati, nei quali si può talora verificare, dopo il pressoché costante
miglioramento invernale, un parziale, seppur attenuato, ritorno dei sintomi nella prima estate successiva. Un buon
numero di soggetti portatori di quadri sintomatologici anche impressionanti e cronicizzati da anni raggiunge la
completa guarigione in 20-60 giorni.
Prognosi
La prognosi della S.R.A. è fortemente condizionata da 4 fattori fondamentali:
1°- eliminazione contemporanea e totale dalla dieta di tutti gli alimenti possibili veicoli del “Fattore R”: sono sufficienti,
nei soggetti sensibili, quantità veramente insignificanti di cibi a rischio (il classico “bocconcino”) per alimentare la
sindrome o per reinnescarla in pochissime ore. E’ quindi necessario un coinvolgimento totale di tutte le persone
che si occupano in qualsiasi misura dell’alimentazione del cane.
2°- superamento delle difficoltà psicologiche, spesso veramente impressionanti, dei proprietari nell’eliminare o
perlomeno nel sostituire qualitativamente i rituali alimentari consolidati nel tempo (il biscotto, il bocconcino);
3°- grado di cronicità della sindrome: i tempi di guarigione sono proporzionali al tipo e al grado di cronicità dei sintomi.
Nella forma cronica semplice la guarigione avviene quasi costantemente entro i 5-30 giorni (fa eccezione il
“granuloma da leccamento o psicogeno”, che necessita anche di alcuni mesi per regredire completamente); nella
forma cronica evolutiva è necessario, a causa delle lesioni cutanee, un lasso di tempo più lungo, 20-60 giorni,
per vedere scomparire l’ipercheratosi, la lichenificazione e la pachidermia. La nostra casistica comprende molti
soggetti che, nel lasso di tempo descritto, sono pervenuti alla completa guarigione di forme croniche evolutive
presenti anche da 8 o 10 anni.
4°- sufficiente capacità del veterinario di convincere il proprietario a porre in atto il modello dietetico necessario: tale
capacità è strettamente correlata alla convinzione del terapeuta medesimo dell’efficacia dello schema proposto e
presume un vero e proprio modello di comportamento.
Modello di comportamento del veterinario nei confronti dei proprietari di animali soggetti
alla S.R.A.
Lo studio clinico della patologia in questione ha evidenziato la necessità di un modello di comportamento ben definito
nei confronti dei proprietari di animali affetti dalla S.R.A.: dipendendo infatti il successo della terapia interamente dalla
dieta e dovendosi il nostro apporto limitare necessariamente a puri e semplici schemi alimentari, dovremo essere
assolutamente convincenti e preparati a prevenire e/o controbattere tutte le possibili obiezioni, perplessità e dubbi
che fatalmente assaliranno il proprietario nel momento in cui rivoluzioneremo, oltre alla dieta del suo cane, anche
molte sue convinzioni.
I dubbi più frequenti che possono venire al proprietario riguardano:
•
come un carnivoro possa avere problemi assumendo carne o ossi (sottolineare la presenza di residui);
•
come il modello alimentare classico possa improvvisamente dimostrarsi non più valido e soddisfacente
(evidenziare come siano cambiate le tecniche di allevamento degli animali);
Sindrome da Residui
•
come dei cibi anche di prima qualità che compaiono sulla nostra tavola senza causarci problemi, possano
scatenare le reazioni descritte nei nostri animali (per tale legittimo dubbio basta accettare l’evidenza di una
diversa sensibilità del cane rispetto alla nostra. Consideriamo poi l’aumento delle intolleranze alimentari anche
nella specie umana...);
•
l’effettiva possibilità che tali reazioni siano scatenate anche da bocconcini pressoché insignificanti (ricordare ad
esempio come le crisi d’asma vengano scatenate anche dall’invisibile polline);
•
la manifestazione della sindrome apparentemente solo in un cane del medesimo proprietario o di un allevatore
quando l’alimentazione è invece comune (la reattività dipende sempre dalla sensibilità individuale; inoltre, a
un’osservazione accurata, sono pochi i cani che non presentino alcun sintomo, anche lieve o saltuario, della
sindrome).
Terapia
Unica terapia della S.R.A. è l’eliminazione definitiva dalla dieta di tutti gli alimenti che potrebbero contenere il “Fattore
R” anche in minima percentuale.
Il modello dietetico che fornisce i risultati migliori si basa sull’impiego temporaneo di un unico alimento sicuramente privo
del “Fattore R”; sebbene non tecnicamente indispensabile, l’esperienza ha dimostrato che solo la monoalimentazione,
protratta per un periodo di 15-20 giorni, garantisce sufficientemente il rispetto della prescrizione.
E’ importantissimo per il successo di tale modello ribadire più volte e con il necessario vigore che è indispensabile
eliminare totalmente qualsiasi altro cibo, compresi gli ossi, il pane e i vari fuori pasto.
L’alimento rivelatosi il migliore in assoluto sia per il periodo di prova che per la successiva dieta di mantenimento
è il pesce di mare: nessun soggetto ha presentato sintomi della S.R.A. assumendolo costantemente anche per
lunghissimi periodi.
Altri alimenti dimostratisi costantemente privi di “Fattore R” sono:
• la pasta (esclusa quella all’uovo);
• tutte le verdure fresche, congelate e surgelate;
• tutta la frutta;
• le carni di animali rigorosamente selvatici;
• le carni ovine (casistica meno numerosa delle precedenti e quindi non totalmente affidabile);
• i grassi vegetali;
Per ulteriori chiarimenti si veda la tabella 4.
Per la presenza di “Fattore R” nei diversi tessuti si veda tabella 5.
L’eliminazione definitiva e totale di qualsiasi alimento “a rischio” permette un miglioramento dei sintomi (soprattutto
il prurito) tanto rapido da superare completamente il comprensibile scetticismo iniziale del proprietario. Un’ottima
possibile controprova di quanto asserito è costituita dall’immediato ritorno dei sintomi in seguito a un pur minimo
“sgarro” della dieta.
Il periodo iniziale di monoalimentazione apporta, come abbiamo detto, notevoli benefici in pochi giorni: l’eventuale
assenza di netti miglioramenti dopo un periodo di due settimane di dieta sicuramente seguita* depone con alta
probabilità a favore di eziologie diverse. Osservazioni recenti, tuttavia, hanno evidenziato un determinato numero di
soggetti che hanno reagito positivamente alla dieta in tempi più prolungati.
Nel primo caso dopo una decina di giorni si possono reinserire in tempi brevi gli alimenti “sicuri”.
A remissione totale della sintomatologia o perlomeno quando il miglioramento raggiunto perduri da un sufficiente
lasso di tempo si consiglierà di reintrodurre, uno alla volta, gli alimenti a basso grado di rischio, tenendo presente
che l’eventuale reazione compare nella grande maggioranza dei casi entro le 12 ore e solo più raramente dopo le
24 ore dall’assunzione.
Gli alimenti dimostratisi “patogeni” non andranno mai più somministrati.
Le recidive estive si osservano quasi esclusivamente nei soggetti che non mantengono la dieta prescritta anche
nel periodo invernale, nel quale si osserva comunque la regressione spontanea, parziale o totale, della patologia
cutanea e del prurito; è verosimile ipotizzare che tale miglioramenti siano correlati alla scomparsa stagionale degli
Padova, Gennaio 1995
allergeni che nelle stagioni primaverile/estiva contribuiscono a determinare la comparsa della patologia in esame.
L’animale che non mantiene la dieta firma delle vere e proprie “cambiali” che pagherà puntualmente nel periodo
caldo successivo.
Ribadiamo quindi che per assistere ad una remissione definitiva dei sintomi della S.R.A. bisogna seguire
costantemente la dieta adeguata.
Negli animali alimentati rigorosamente con cibi privi di “Fattore R” si assiste spesso ad un progressivo, seppur
temporaneo, aumento della sensibilità ai cibi a rischio, per cui gli “sgarri” eventuali provocano spesso l’insorgenza di
sintomi più imponenti rispetto al passato.
Nei primissimi giorni di monoalimentazione, anche per l’eliminazione della carne, è molto facile che il cane attui
un totale “sciopero della fame”, fatto che suscita comprensibilmente ansia nella maggior parte dei proprietari,
frequentemente convinti che poche ore di digiuno siano sufficienti a far crollare un cane a terra stecchito; oltretutto
l’animale è un vero maestro nel suscitare sensi di colpa nel proprietario, rendendo estremamente arduo arrivare alla
collaborazione completa della famiglia. Ben gestito dal veterinario, l’episodio potrà tradursi invece in un ulteriore
strumento di convinzione: il semplice digiuno infatti porta di norma già in un paio di giorni ad apprezzabili miglioramenti
del quadro (talvolta si può assistere ad un iniziale peggioramento iniziale).
Nella prima fase è poi di estrema importanza sottolineare come, perdurando l’effetto di ogni minimo “strappo” alla
dieta un tempo medio di 4-5 giorni, siano sufficienti due “bocconcini” alla settimana per vanificare in buona parte la
prova. Teniamo ben presente che il primo periodo di monoalimentazione è fondamentale per convincere il proprietario
di un animale con S.R.A. dell’eziologia alimentare dei problemi suddetti.
La conoscenza sempre più ampia di tutti i fenomeni connessi alla S.R.A. ci ha permesso di ridurre progressivamente
gli insuccessi: la maggior parte dei fallimenti attuali nasce proprio dalla incapacità di convincere il padrone a seguire
alla lettera i primi 10-15 giorni di dieta. La percentuale di successo nei casi seguiti per un tempo minimo di 6-7
settimane è oggettivamente alta.
La monoalimentazione è stata inoltre quella tecnica che ci ha permesso di risolvere molti casi che, pur presentando
sintomi sicuramente riconducibili alla S.R.A., non rispondevano ad una dieta semplicemente priva di carne
di allevamento intensivo e suoi derivati. Si é così evidenziato come molti tipi di pane e cereali soffiati possano,
probabilmente a causa dell’aggiunta, ormai molto diffusa, di grassi (strutto o burro), scatenare una sintomatologia
perfettamente sovrapponibile alla sindrome **.
La conferma si è poi avuta dalla rilevazione che un crescente numero di soggetti, durante la progressiva reimmissione
di tali alimenti susseguente alla prima fase monoalimentare, ha evidenziato un subitaneo ritorno soprattutto del
prurito. Il sintomo è nuovamente scomparso rapidamente eliminando l’alimento introdotto.
* Un attento interrogatorio porta molto spesso ad accertare l’inosservanza parziale o totale, anche involontaria, della
dieta.
** L’osservazione che i soggetti reattivi manifestano reazioni diverse dopo l’assunzione di uno stesso alimento a
seconda della sua provenienza fa propendere verso la spiegazione data nell’articolo piuttosto che verso una
semplice intolleranza alimentare.
Sintesi delle principali cause di insuccesso
1° Errata diagnosi: la notevole diffusione della sindrome indurrebbe facilmente a sospettarne l’esistenza anche in
presenza di molti quadri patologici simili, ma di diversa eziologia.La percentuale di successo della dieta descritta
in presenza di prurito è talmente elevata da giustificare comunque un tentativo sistematico in tal senso.
2° Atteggiamento scettico del veterinario: un approccio poco convinto e pieno di riserve sullo schema proposto,
motivato in buona parte da quel bagaglio personale di conoscenze e dal retaggio di convinzioni tradizionali, può
lasciare spazio a tentativi di applicazione non sufficientemente rigorosi e quindi fallimentari, autoalimentando così
i dubbi e consolidando rapidamente la errata convinzione che l’intera trattazione non sia valida.
3° Insufficiente capacità di coinvolgimento del proprietario da parte del veterinario.
Sindrome da Residui
4° Dieta applicata solo parzialmente: molte volte il proprietario non considera “a rischio” determinati alimenti, in
particolare:
•
molti tipi di croccantini del gatto;
•
le feci dei gatti che si cibano di croccantini (non sono pochi i cani che le considerano una vera “leccornia” e le
deiezioni mantengono in buona parte inalterato il “Fattore R”);
•
lo spuntino al mattino;
•
l’osso (anche spolpato); il “Fattore R” non si degrada nel tempo, per cui è comune osservare cani che, dopo
aver ingerito ossi sotterrati molto tempo addietro, accusano immediatamente sintomi della sindrome;
•
il dado (scatena soprattutto il prurito);
•
il prosciutto e gli insaccati;
•
il bocconcino di pane;
•
alimenti “recuperati” durante la passeggiata.
Bibliografia
1° Moraillon, Legeay, Fourrier, Lapeire: Dizionario pratico di terapia canina, Masson editore - Milano, 1988, pag.
12-15; pag. 40, pag. 98, pag. 116-127; pag. 132-135; pag. 257-260; pag. 296-298; pag. 315-321; pag. 338; pag.
427-430; pag. 361, 362
2° Kirk, R. W.: Terapia Veterinaria attuale, Piccin Editore, Padova, 1984 - pag. 456/460; pag. 466/470, pag. 470-474,
pag. 474-479, pag. 482-487, pag. 580-581
3° Ettinger: Trattato di Medicina Interna Veterinaria, volume 1° pag. 89; pag. 115-118; volume 2 pag. 1319-1320; pag.
2140-2146
4° Catcott: Trattato di medicina interna del cane, Edizioni Medico-Scientifiche Torino, 1976; volume 1°, pag. 388-394;
volume 2 pag. 710-711; pag. 747/773; pag. 788/792; pag. 1078-1084; pag. 1111-1124
5° E.A Chandler., J.M Evans., W.B Singleton., F.G. Startup., Sutton J.B., Tavernor, W.D.: Diagnostica e terapia delle
malattie del cane, Marrapese Editore, 1981, pag. 39-45, pag. 77-78, pag. 235-236, pag. 240-242, pag. 250-255.
6 ° G.H. Muller, R.W. Kirk, D.W. Scott: Dermatologia Veterinaria dei piccoli animali, Edizioni UTET (1994), pagg. 310319, 323-326, 331-335, 551-555.
7° T. Willemse : Dermatologia clinica del cane e del gatto, Editore Masson (1992), pagg. 44-48, 50-57.
I Professionisti del Benessere™