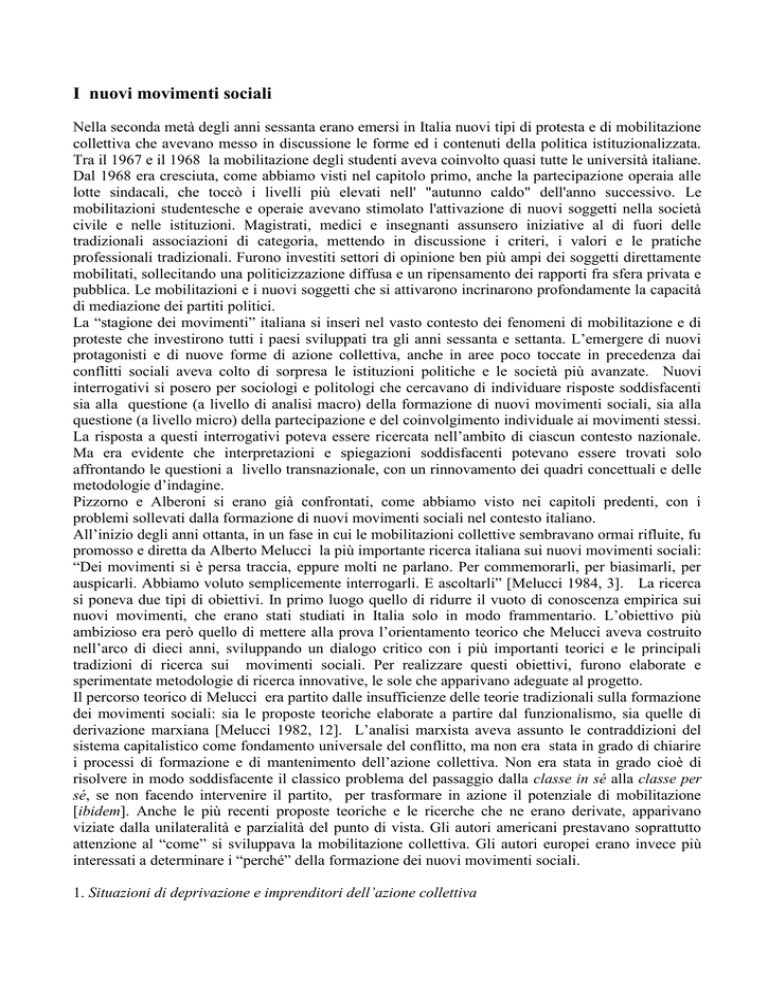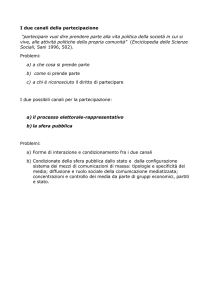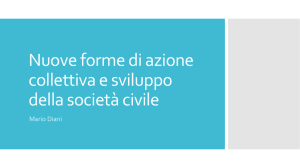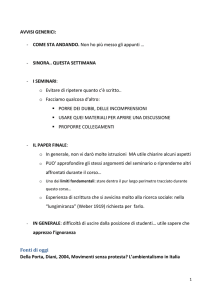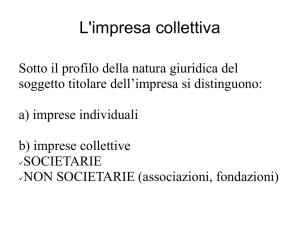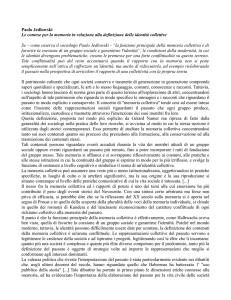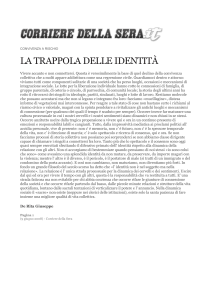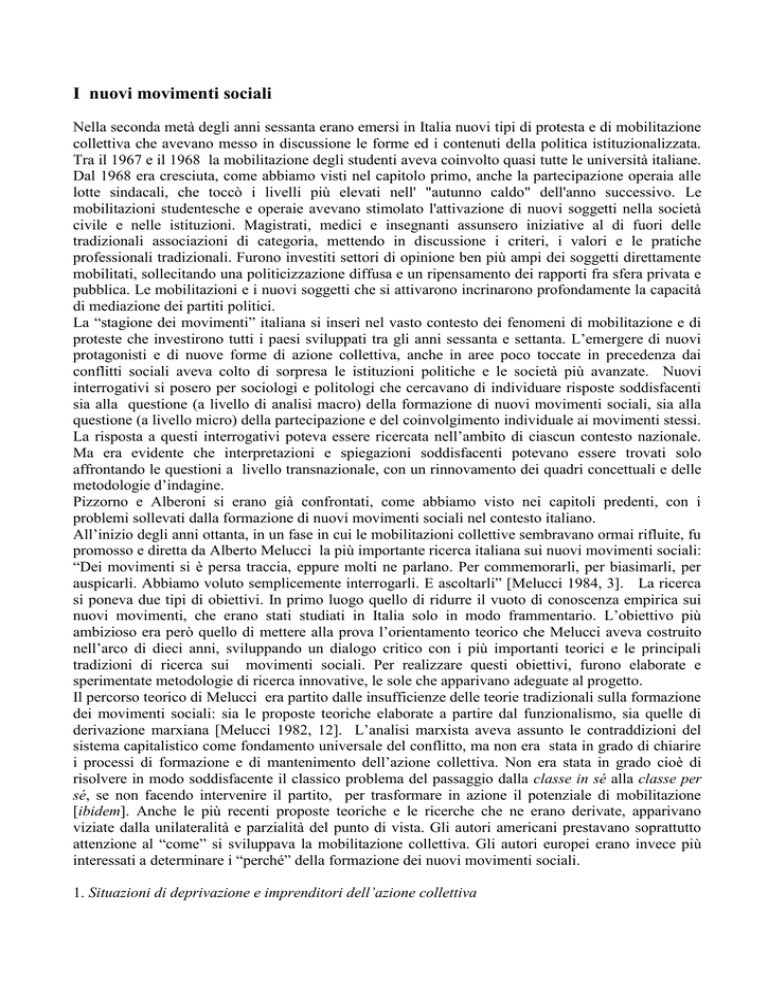
I nuovi movimenti sociali
Nella seconda metà degli anni sessanta erano emersi in Italia nuovi tipi di protesta e di mobilitazione
collettiva che avevano messo in discussione le forme ed i contenuti della politica istituzionalizzata.
Tra il 1967 e il 1968 la mobilitazione degli studenti aveva coinvolto quasi tutte le università italiane.
Dal 1968 era cresciuta, come abbiamo visti nel capitolo primo, anche la partecipazione operaia alle
lotte sindacali, che toccò i livelli più elevati nell' "autunno caldo" dell'anno successivo. Le
mobilitazioni studentesche e operaie avevano stimolato l'attivazione di nuovi soggetti nella società
civile e nelle istituzioni. Magistrati, medici e insegnanti assunsero iniziative al di fuori delle
tradizionali associazioni di categoria, mettendo in discussione i criteri, i valori e le pratiche
professionali tradizionali. Furono investiti settori di opinione ben più ampi dei soggetti direttamente
mobilitati, sollecitando una politicizzazione diffusa e un ripensamento dei rapporti fra sfera privata e
pubblica. Le mobilitazioni e i nuovi soggetti che si attivarono incrinarono profondamente la capacità
di mediazione dei partiti politici.
La “stagione dei movimenti” italiana si inserì nel vasto contesto dei fenomeni di mobilitazione e di
proteste che investirono tutti i paesi sviluppati tra gli anni sessanta e settanta. L’emergere di nuovi
protagonisti e di nuove forme di azione collettiva, anche in aree poco toccate in precedenza dai
conflitti sociali aveva colto di sorpresa le istituzioni politiche e le società più avanzate. Nuovi
interrogativi si posero per sociologi e politologi che cercavano di individuare risposte soddisfacenti
sia alla questione (a livello di analisi macro) della formazione di nuovi movimenti sociali, sia alla
questione (a livello micro) della partecipazione e del coinvolgimento individuale ai movimenti stessi.
La risposta a questi interrogativi poteva essere ricercata nell’ambito di ciascun contesto nazionale.
Ma era evidente che interpretazioni e spiegazioni soddisfacenti potevano essere trovati solo
affrontando le questioni a livello transnazionale, con un rinnovamento dei quadri concettuali e delle
metodologie d’indagine.
Pizzorno e Alberoni si erano già confrontati, come abbiamo visto nei capitoli predenti, con i
problemi sollevati dalla formazione di nuovi movimenti sociali nel contesto italiano.
All’inizio degli anni ottanta, in un fase in cui le mobilitazioni collettive sembravano ormai rifluite, fu
promosso e diretta da Alberto Melucci la più importante ricerca italiana sui nuovi movimenti sociali:
“Dei movimenti si è persa traccia, eppure molti ne parlano. Per commemorarli, per biasimarli, per
auspicarli. Abbiamo voluto semplicemente interrogarli. E ascoltarli” [Melucci 1984, 3]. La ricerca
si poneva due tipi di obiettivi. In primo luogo quello di ridurre il vuoto di conoscenza empirica sui
nuovi movimenti, che erano stati studiati in Italia solo in modo frammentario. L’obiettivo più
ambizioso era però quello di mettere alla prova l’orientamento teorico che Melucci aveva costruito
nell’arco di dieci anni, sviluppando un dialogo critico con i più importanti teorici e le principali
tradizioni di ricerca sui movimenti sociali. Per realizzare questi obiettivi, furono elaborate e
sperimentate metodologie di ricerca innovative, le sole che apparivano adeguate al progetto.
Il percorso teorico di Melucci era partito dalle insufficienze delle teorie tradizionali sulla formazione
dei movimenti sociali: sia le proposte teoriche elaborate a partire dal funzionalismo, sia quelle di
derivazione marxiana [Melucci 1982, 12]. L’analisi marxista aveva assunto le contraddizioni del
sistema capitalistico come fondamento universale del conflitto, ma non era stata in grado di chiarire
i processi di formazione e di mantenimento dell’azione collettiva. Non era stata in grado cioè di
risolvere in modo soddisfacente il classico problema del passaggio dalla classe in sé alla classe per
sé, se non facendo intervenire il partito, per trasformare in azione il potenziale di mobilitazione
[ibidem]. Anche le più recenti proposte teoriche e le ricerche che ne erano derivate, apparivano
viziate dalla unilateralità e parzialità del punto di vista. Gli autori americani prestavano soprattutto
attenzione al “come” si sviluppava la mobilitazione collettiva. Gli autori europei erano invece più
interessati a determinare i “perché” della formazione dei nuovi movimenti sociali.
1. Situazioni di deprivazione e imprenditori dell’azione collettiva
Le ricerche americane sui movimenti sociali erano state per molti anni inquadrate nella teoria del
collective behavior (Smelser 1963). I movimenti collettivi erano considerati fondamentalmente
come risposte irrazionali a situazioni di crisi da parte di settori della società che stavano
sperimentando particolari situazioni di deprivazione e di tensione. Nello schema teorico elaborato da
Smelser a partire dalla prospettiva parsonsiana, l'azione collettiva non istituzionale era concepita
come una risposta a qualche fattore di disturbo (strain) in una delle componenti dell'azione sociale
(valori, norme, mobilitazione delle motivazioni, risorse). Il comportamento collettivo tendeva a
ristrutturare la componente disturbata, attraverso una credenza generalizzata che mobilitava gli attori
in forme di azione non istituzionalizzate. L’elaborazione di credenze condivise assumeva un ruolo
centrale nella teoria di Smelser. Esse permettevano fra l'altro di discriminare i vari tipi di
comportamento collettivo: una credenza isterica era alla base del panico, una credenza orientata
alla norma era presente nei movimenti riformistici e una credenza orientata ai valori si manifestava
nelle rivoluzioni. In questa prospettiva, l’azione collettiva rappresentava soprattutto uno dei
meccanismi di ristrutturazione del campo sociale: ma non veniva offerta nessuna base per la
comprensione dei contenuti del conflitto, e del carattere antagonista delle lotte rispetto alla logica del
sistema [Melucci 1982, 13].
Nella mobilitazione collettiva si possono distinguere due componenti fondamentali, che
rappresentate rispettivamente dalla domanda latente (la base potenziale dei movimenti) da un lato, e
dall’offerta di possibilità di azione collettiva (le organizzazioni e i leader potenziali) dall'altro. Alla
prima componente aveva dedicato particolare attenzione la teorie della deprivazione relativa
(Crawford e Naditch 1970; Gurr 1970), alla seconda quella nota come resource mobilisation theory.
La teoria della deprivazione relativa era soprattutto orientata a cogliere la formazione della domanda
di movimento, facendo riferimento alle situazioni di malcontento e quindi alle rivendicazioni diffuse
in particolari settori della società. Ma non era in grado di spiegare l’impegno degli attori individuali
nell’azione collettiva, superando il paradosso del free rider messo in luce da Olson.
Per questa ragione si era diffuso negli studi americani sui movimenti sociali l’approccio teorico del
resource mobilisation theory, elaborato a partire dalla teoria della scelta razionale. In questa
prospettiva la formazione e lo sviluppo dei movimenti vengono spiegati non tanto rivolgendo
l'attenzione alle situazioni di deprivazione, tensione e scontento sociale - supposte sempre presenti
in una data società [Oberschall 1973] - quanto prendendo in considerazione la disponibilità delle
risorse riguardanti le opportunità politiche utilizzabili per le campagne e le mobilitazioni su
particolari tematiche La domanda è rappresentata dai settori di opinione pubblica favorevoli agli
obiettivi che caratterizzano il movimento. Le base del movimento si trova nell’ "insieme di opinioni
e credenze in una popolazione che rappresentano preferenze orientate al cambiamento di qualche
elemento della struttura sociale e/o della distribuzione delle ricompense in una società " [Mc Carthy
e Zald 1977, 1217-1218]. Questa componente viene in generale assunta dalla resource mobilisation
theory come data, così come le preferenze dei consumatori nella teoria economica neoclassica. Dal
lato dell’offerta di possibilità per l’azione collettiva, si prendono in considerazione le organizzazioni
preesistenti e i loro leader professionalizzati (gli imprenditori del movimento). L'azione di questi
attori segue una logica di agire strategico, tendente a massimizzare la raccolta delle risorse di tutti i
tipi utilizzabili nell'iniziativa dell'organizzazione. Nelle formulazioni più radicali della resource
mobilisation theory, viene sostanzialmente negata la influenza di nuove situazioni di deprivazione
nella genesi dei movimenti sociali, e si ritiene plausibile che "scontento e lamentele possono anche
essere definite, create e manipolate dagli imprenditori di 'issues' e dalle organizzazioni" [ibidem] .
Il nocciolo teorico della resource mobilisation theory può essere sintetizzato nell'assunto che lo
scontento è al più un fattore secondario che favorisce l'emergere della protesta, mentre la formazione
e la crescita dei movimenti può essere spiegata sulla base dei cambiamenti nelle disponibilità di
risorse e nelle opportunità di successo per l'azione collettiva [Jenkins 1983]. Le risorse utilizzabili
sono di verso tipo: da quelle tangibili (denaro e vari tipi di dotazioni di mezzi materiali), alla
disponibilità di militanza, alle preesistenti reti organizzative, alla disponibilità di professionisti ed
esperti. Se migliorano le risorse disponibili, i costi della mobilitazione diminuiscono e le probabilità
di successo aumentano. Particolarmente importanti fra le risorse sono le organizzazioni e i network
di relazioni interpersonali preesitenti: questi infatti non solo aumentano le probabilità di
coinvolgimento dei singoli nelle campagne e nelle mobilitazioni, ma rendono possibile il cosiddetto
“reclutamento in blocco” [Oberschall 1973].
Il movimento sociale per la resource mobilisation theory si configura così come la risultante
dell’interazione fra i portatori di domande latenti e di offerte esplicite di azione collettiva. La
assunzione delle preferenze e degli interessi come dati preesistenti evidenzia la parzialità della
resource mobilisation theory. Questa limitazione del campo di indagine è però funzionale alla
maggiore attenzione alle complesse e diversificate relazioni che si attivano fra gli imprenditori dei
movimenti, le organizzazioni, gli aderenti e i settori di opinione pubblica favorevoli ai movimenti.
In termini generali, gli approcci del collective behavior e quelli derivato dalla resource mobilisation
theory fanno riferimento implicitamente a due opposte concezioni della società. Il primo
presuppone un sistema sociale e politico in equilibrio che, una volta disturbato, genera
temporaneamente un’azione collettiva di tipo non-istituzionale, tendenzialmente irrazionale,
destinata ad essere riassorbita in un funzionamento ritornato alla normalità. Il secondo approccio fa
riferimento ad una società come sede di innumerevoli conflitti latenti: una opportuna combinazione
di risorse disponibili, opportunità politiche e iniziativa imprenditoriale di leader e organizzazioni
può promuovere l'azione collettiva. La resource mobilisation theory fu elaborata in una particolare
fase dei movimenti sociali negli Stati Uniti, mentre esisteva una relativa stabilità delle situazioni di
disagio sociale e si erano formate potenti lobby di interesse pubblico, in grado di promuovere
iniziative e campagne di protesta gestite da piccoli gruppi di professionisti dei movimenti, con il
supporto finanziario di ampi settori di simpatizzanti (la cosiddetta conscience constuency). E’
plausibile che questo ceto di imprenditori di movimento abbia selezionato temi e obiettivi per
l'azione collettiva prevalentemente in riferimento al tipo e alla quantità delle risorse che essi
permettevano di mobilitare [Mc Carthy e Zald 1973].
Nella formulazione del suo progetto di ricerca, Melucci riprese il contributo fondamentale della
resource mobilisation theory, che aveva considerato l’azione collettiva come “la capacità di un
attore di mobilitare risorse all’interno di un sistema di scambi (vincoli/opportunità, interno/esterno,
ecc.) con un calcolo mutevole e (più o meno) adattabile di costi e benefici” [Melucci 1984, 17]. In
questa prospettiva teorica era possibile spiegare come si forma e come si mantiene nel tempo
l’attore collettivo. Ma esistevano limiti insuperabili dalla teoria resource mobilisation. Non era
possibile infatti cogliere il senso dell’azione collettiva all’interno del sistema sociale. E la stessa
definizione del concetto di movimento sociale restava incerta e convenzionale, e arrivava a
comprendere ogni azione e ogni protesta rivolta contro qualche tipo di autorità costituita.
2. Nuovi movimenti sociali?
Gli autori europei che avevano studiato i nuovi movimenti sociali negli anni settanta tendevano a
spiegare la formazione di nuovi attori collettivi non tanto sulla base delle risorse disponibili e delle
opportunità politiche per l'azione, quanto a partire dalle trasformazioni che avevano investito l'intero
sistema sociale. Era soprattutto il riferimento ai problemi sistemici che determinava il senso
dell'azione collettiva.
La formazione di nuovi attori e nuove forme di azione collettiva estranee alla tradizione del
movimento operaio furono ricondotte ai mutamenti indotti dal capitalismo post-industriale. Se
restava importante la lezione di Marx per l’interpretazione del conflitto sociale, era messa in
discussione la centralità del conflitto capitale/lavoro. Il ruolo di lavoratore non era più il punto
focale ed esclusivo dell'esperienza di deprivazione , che investiva in generale i ruoli di cittadino, di
consumatore e di tutti coloro che dipendono dalle decisioni dell'amministrazione pubblica
[Habermas 1981]. Se nel secondo dopoguerra, fino agli anni sessanta, i conflitti sociali e politici
erano stati centrati sui problemi della crescita, della distribuzione delle risorse economiche e della
sicurezza in politica interna e internazionale, l'azione dei nuovi movimenti si sviluppò soprattutto su
alcune questioni emergenti nelle società altamente industrializzate: l'inquinamento ambientale,
l’impiego dell'energia nucleare, l'uguaglianza delle donne, i diritti umani, la pace, gli aiuti per il
terzo mondo [Baker, Dalton e Hildebrandt 1981, 141]. Furono di regola considerati nuovi movimenti
sociali i movimenti ecologisti, femministi, pacifisti e autonomisti [Cohen 1987, 28]. Questi
movimenti coinvolgevano soprattutto alcuni settori della società: parte delle nuove classi medie, ma
anche soggetti al di fuori del mercato del lavoro (studenti, casalinghe di classe media, disoccupati.)
e, localmente, elementi delle classi medie tradizionali. L'azione collettiva non era orientata a favorire
gli interessi di una classe sociale: gli obiettivi erano o di tipo universalistico (per l'ambientalismo, il
pacifismo, i movimenti per i diritti umani) oppure molto puntuali e spesso circoscritti in ambiti
locali. Le nuove mobilitazioni non ricevevano impulso dai partiti esistenti, poco orientati e preparati
ad affrontare le nuove tematiche. Soggetti dell'iniziativa erano spesso gruppi ad hoc ed
organizzazioni poco formalizzate, che praticavano prevalentemente forme di azione politica nonistituzionali.
Il teorico più importante dei nuovi movimenti sociali era stato Alain Touraine, che aveva influenzato
profondamente la formazione di Alberto Melucci. Touraine aveva elabora una teoria generale dei
movimenti sociali, considerati non come tema particolare, ma come la questione centrale per
l’analisi sociologica. Il concetto di movimento sociale comprendeva tre elementi fondamentali: a) la
definizione di una identità; b) la identificazione di un avversario (principio di opposizione); c) la
coscienza di investire una posta in gioco (principio di totalità) (“definisco il movimento sociale come
la combinazione di un principio di identità, di un principio di opposizione, e di un principio di
totalità, come attore di un campo di azione storica” [Touraine 1973, 413]). In ogni epoca il
movimento sociale è un’azione collettiva orientata non tanto a intervenire sull’organizzazione sociale
o nell’ambito della partecipazione a un sistema di decisioni politiche, ma sul "sistema di storicità",
definito come "l'insieme di modelli culturali - cognitivi, economici, etici - posta in palio del conflitto
sociale centrale" proprio della società in ogni epoca storica. [Touraine 1984, 83]. Nelle società
postindustriali, gli attori del conflitto centrale non sono più le classi legate alla produzione
industriale, ma gruppi sociali con interessi e orientamenti opposti sull’uso e sulla destinazione delle
risorse cognitive e simboliche: “il campo principale dei rapporti e dei conflitti di classe è la cultura”
[Touraine 1973, 224].
Melucci riprese e sviluppò le idee dei teorici dei nuovi movimenti sociali, e in particolare la lezione
di Touraine. Per Melucci un movimento sociale poteva essere definito come “una forma di azione
collettiva basata su una solidarietà, che esprime un conflitto, attraverso la rottura dei limiti di
compatibilità del sistema di riferimento dell’azione” [Melucci 1984, 423]. La definizione fa così
riferimento a tre distinte dimensioni analitiche. Il conflitto è inteso come “opposizione di due attori
per l’appropriazione di risorse che entrambi valorizzano” [Melucci 1982, 15]. La solidarietà
consente all’attore di condividere una identità collettiva, di riconoscere e di essere riconosciuto come
parte di una unità sociale. I limiti di un sistema indicano la gamma di variazioni tollerabili all’interno
della sua struttura. Le tre dimensioni analitiche permettono di distinguere i movimenti sociali da altre
forma di azione collettiva, come una semplice azione conflittuale, la solidarietà volontaria, la
devianza, l’innovazione o l’antagonismo atomizzato, le condotte di aggregato come le mode o il
panico [Alberoni 1981, 31]. E’ d’altra parte possibile distinguere diversi tipi di movimenti sociale, a
seconda del sistema di riferimento dell’azione. Se i conflitti mettono in discussione i limiti di
compatibilità relativi all’organizzazione sociale, al sistema politico, al modo di produzione e ai
modelli culturali che lo governano, si potrà parlare rispettivamente di movimenti rivendicativi di
movimenti politici e di movimenti antagonisti [Melucci 1982, 28-29].
I movimenti sociali concreti e le diverse manifestazioni di protesta contengono spesso una
combinazione dei diversi significati analitici, che devono essere messi in luce dal ricercatore, per
andare al di là sia delle autorappresentazioni fornite da leader e partecipanti all’azione collettiva, sia
delle sua stigmatizzazione proposta dalle autorità e dalle agenzie di controllo sociale.
I nuovi conflitti antagonisti si fondano sulle nuove contraddizioni emergenti nelle società
postindustriali, società ad alta differenziazione che producono e distribuiscono risorse crescenti per
l’individuazione, l’autorealizzazione, la creazione autonoma di identità individuali. Queste risorse
rendono gli individui affidabili ed efficienti nei sistemi complessi ad alta intensità di informazione.
D’altra parte, i sistemi complessi estendono il loro controllo sulle stesse risorse, con un intervento
crescente sugli apparati simbolici, le relazioni sociali, le identità e i bisogni individuali. Le nuove
forma di azione collettiva rivelano la formazione di un campo di conflitti specifico delle società
industriali avanzate : "i conflitti sociali si spostano dal tradizionale sistema economico al livello
culturale : essi interessano l'identità personale, il tempo e lo spazio della vita quotidiana, la
motivazione e i modelli culturali dell'azione individuale" [Melucci 1985, 140].
3. Nuovi metodi di ricerca sull’azione collettiva
La teoria sui movimenti sociali e la riflessione sulle trasformazione dei conflitti nella società
postindustriale, furono impiegate da Melucci per definire una metodologia appropriata per la ricerca
empirica. Il concetto di movimento fu utilizzato come griglia analitica per lo studio dei fenomeni
empirici comunemente designati come movimenti sociali.
Nella ricerca milanese i referenti empirici furono denominati “aree di movimento”, aree di relazioni
e di azione collettiva caratterizzate da alcuni tratti: a) l’esistenza di una relativa stabilità delle forme
di aggregazione; b) l’esistenza di un reticolo di relazione fra i gruppi; c) la definizione di sé come
parte dei un movimento.
L’indagine ricostruì accuratamente le forma di mobilitazione, le dinamiche organizzative, i
meccanismi decisionali, la formazione dei leader, il ruolo e i contenuti dell’ideologia. Per studiare i
processi attraverso cui gli attori collettivi si formavano, agivano sull’ambiente esterno e si
mantenevano nel tempo potevano essere utilizzati molti degli schemi concettuali e dei risultati delle
ricerche promosse dagli autori che si ispiravano alla resource mobilisation theory. Un altro punto
riferimento fondamentale per la ricerca furono le teorie di Pizzorno sulla formazione e il
mantenimento delle identità collettive e sullo scambio politico. Per Melucci era necessario andare
oltre queste proposte perché: “nei fenomeni contemporanei di azione collettiva non tutto si riduce
allo scambio e non tutto è calcolabile. Ci sono dimensioni delle condotte che sfuggono a questa
interpretazione, che non hanno come referente un mercato politico, e che solo un’ipotesi in termini
di conflitto antagonista può aiutare a spiegare” [ibidem, 20].
Il risultato più ambizioso della ricerca riguardava perciò la individuazione dei possibili legami tra la
dinamica del sistema sociale, le motivazioni individuali e l’azione collettiva: “si trattava di stabilire
il rapporto tra determinanti macro-sociologiche a livello di sistema globale, nazionale e dell’area
empirica considerata, e il funzionamento di specifici sistemi d’azione” [ibidem]. Fu perciò progettata
una complessa strategia di ricerca in funzione di questo obiettivo. Touraine aveva proposto e
sperimentato una originale metodologia di indagine definita intervention sociologique, come pratica
di ricerca adeguata all’oggetto-movimento. Veniva costruito un gruppo sperimentale formato da
militanti dei diversi settori di un movimento, che veniva osservato nel suo confronto con gli
avversari e gli altri attori sociali e infine indotto dal ricercatore all’interpretazione generale delle
interazioni. L’analisi era centrata sul sistema di relazioni tra gli attori, che rivelava il significato
generale dell’azione, e poteva generare il riconoscimento (o meno) della sua natura di movimento
sociale [Touraine 1978; 1980]. Melucci riconobbe il valore della metodologia dell’intervention
sociologique, ma ne mise in evidenza due limiti fondamentali: a) l’orientamento di tipo missionario e
pedagogico assegnato al ricercatore; b) la mancanza di strumenti di controllo della relazione
ricercatore/gruppo.
La ricerca sulle aree di movimento progettata da Melucci tentò di superare questi limiti integrando le
metodologie e le esperienze maturate in diversi campi disciplinari (antropologia, psicologia,
psicoanalisi, sociologia, studi organizzativi). In una prima fase si realizzò una mappatura generale
delle aree utilizzando svariate tecniche di indagine (osservazione partecipante, interviste in
profondità a militanti e testimoni privilegiati, analisi di documenti). Fu poi individuato un gruppo
“naturale” in posizione centrale per ogni area, e venne negoziato un contratto per lo svolgimento del
lavoro sperimentale, sulla base dell’interesse dei partecipanti a utilizzare la ricerca come occasione
per una riflessione su di sé e la propria azione. Nella fase di laboratorio, ogni gruppo fu invitato a
partecipare a una serie incontri durante i quali si svolgevano giochi di simulazione, registrati da una
telecamera. Il gruppo era sottoposto a stimoli di diverso tipo e sollecitato a dare un definizione di sé,
a confrontarsi con le definizioni provenienti dall’esterno, a rapportarsi a situazioni immaginate. Il
carattere riflessivo dell’intero processo veniva favorito dall’uso del materiale registrato come
stimolo, dalla restituzione verbale del conduttore e dalle discussioni finali sull’esperienza. Nella
conduzione dei gruppi, Melucci utilizzò la personale formazione in psicologia clinica, conclusa con
un dottorato all’università di Parigi.
La situazione sperimentale produceva un rottura esplicita rispetto alla situazione naturale, ne alterava
in buona parte i contenuti e le forme tipiche, ma gli stimoli proposti potevano fare emergere le
logiche d’azione sottostanti. Vennero d’altra parte sottoposto ad analisi, come problema della ricerca,
lo stesso rapporto fra il ricercatore e gli altri partecipanti alle sedute.
Mentre la strategia di ricerca di Touraine ricercava la verifica della proprie ipotesi sul conflitto
centrale di sistema nella “conversione” dei partecipanti all’esperienza dell’intervention sociologique,
il progetto di ricerca di Melucci seguiva un percorso molto diverso. Le azioni sociali erano innanzi
tutto spiegate sulla base dei principi del calcolo delle utilità e della teoria dello scambio. I contenuti
antagonisti, che si sottraevano alla logica del mercato, potevano essere individuati nelle dimensioni
delle condotte che non erano spiegabili con la logica utilitaristica. La ricerca di significati antagonisti
dell’azione collettiva poteva trovare una giustificazione solo dopo che altre spiegazioni, basate sul
calcolo delle utilità e sullo scambio, si fossero mostrate insufficienti.
4. Aree di movimento e forme di azione
I primi problemi affrontati dalla ricerca furono la scelta della quattro aree di movimento per
l’indagine empirica e, all’interno di ogni area, l’individuazione dei gruppi naturali da coinvolgere nel
lavoro di laboratorio.
A Milano i movimenti giovanili e la mobilitazione operaia avevano conosciuto alcuni dei momenti di
massima espressione tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni settanta. In questo
periodo la città aveva conosciuto la più alta percentuale di eventi di protesta [Tarrow 1986, 93]. La
ricerca sulle aree di movimento milanesi diretta da Alberto Melucci fu realizzata in una fase in cui il
ciclo di mobilitazione collettiva appariva ormai al termine. Le tracce di questa esperienza erano
ancora forti nella memoria degli attori individuali, nella fisionomia organizzativa e nella cultura dei
gruppi organizzati, nella opinione pubblica e nel costume della città. Gli effetti del ciclo di
mobilitazione precedente si mescolavano d’altra parte ai segni di una nuova cultura, fondata sulla
valorizzazione dell’individualismo, dell’immagine di sé, dell’edonismo e del consumismo, che trovò
il suo luogo di massima visibilità proprio nella metropoli lombarda ("Milano da bere").
Per l’indagine empirica furono scelte le aree che facevano riferimento rispettivamente ai movimenti
giovanili, al movimento delle donne, al movimento ecologista e ai gruppi impegnati in nuove forme
di ricerca spirituale. Le quattro aree avevano relazioni molto diverse con le mobilitazioni degli anni
settanta.
Nell’area dei movimenti giovanili erano più evidenti le tracce e le forme organizzative ereditate dalle
esperienze precedenti. Nella seconda metà degli anni settanta le speranze, le esigenze e le delusioni
di vasti strati giovanili avevano cercato nei centri sociali autogestiti i luoghi in cui esprimersi.
Nuovi centri si formarono a Milano e nell'hinterland. Gruppi giovanili di diversa provenienza si
insediarono in edifici a volte occupati, a volte concessi dagli enti locali. Nel 1977 esistevano 35
centri milanesi che svolgevano molteplici attività: alle iniziative specificamente politiche, si
mescolavano quelle culturali e ricreative. Si creavano però soprattutto luoghi per l'incontro dei
giovani, in una fase in cui la mobilitazione collettiva era calante. Negli anni successivi il numero dei
centri attivi si era ridotto: all’inizio degli anni ottanta restavano una decina di centri attivi [Lodi e
Grazioli 1984]. L’area delle aggregazioni giovanili comprendeva però anche altre presenze: da una
lato, le organizzazioni giovanili dei partiti tradizionali e della nuova sinistra, dall’altro i gruppi legati
ai diversi filoni della musica rock e alle diverse espressioni delle mode giovanili [ibidem, 71-76].
Nell’area si manifestavano importanti differenziazioni. In primo luogo, era diverso il peso relativo
dell’impegno politico rispetto a quello delle attività culturali, intese come proposta di servizi e di
iniziative. In secondo luogo, erano diversi i rapporti con le istituzioni politiche: dalla collaborazione,
al conflitto fino all’assenza di ogni relazione. Alcuni gruppi avevano instaurato un rapporto stabile
con le istituzioni, e potevano contare su diversi tipi di risorse per svolgere attività socio-culturali,
gestite da operatori sempre più professionalizzati. Altri gruppi mostravano invece la permanenza
delle idee e dei linguaggi ereditati dalle precedenti fasi di mobilitazione, e mantenevano un rapporto
conflittuale con le istituzioni. Alcune aggregazioni giovanili apparivano d’altra parte del tutto
estranee e indifferenti rispetto alla politica. Esistevano poi alcuni centri sociali in cui l’impegno
politico coesisteva con una ricca attività culturale. Entro questo segmento dell’area fu scelto il
gruppo naturale per il lavoro di laboratorio: la Commissione Cultura del Leoncavallo, che gestiva il
rapporti fra il centro e gli utenti degli spazi e delle iniziative culturali [ibidem, 78].
Anche la ricerca sull’area del movimento delle donne si svolse in un periodo percepito come fase di
stasi, riflusso e dispersione delle esperienze del femminismo. Nell’area, coesistevano le componenti
emerse nelle fasi precedenti: il femminismo delle élites intellettuali, il separatismo, il femminismo
politico, il femminismo del quotidiano [Bianchi e Mormino 1984, 131]. La struttura dell’area
appariva così complessa e frammentata. Incerta era anche la autorappresentazione di sé come
movimento, e la stessa denominazione (“movimento femminista” o “movimento delle donne”?). Le
ricercatrici potevano tentare una descrizione dell’area solo in base alle tematiche prevalenti nei
gruppi (salute e sessualità, lavoro e specificità femminile, intellettualità femminile, case occupate e
attività di quartiere, cooperative, pacifismo). Le caratteristiche fondamentali di ogni esperienza
potevano essere colte analizzando l’intreccio fra individuale e collettivo, e le forme di
ricomposizione fra progetto interno ed esterno. In tutti i gruppi emergeva un elevato investimento
affettivo: si poteva rilevare “il tentativo di ricomporre affettivamente la totalità dell’esperienza con la
parzialità dell’esperienza di gruppo” [ibidem, 141]. Sempre presente era poi il progetto di
costruzione di una identità collettiva e individuale “come diritto … e come spazio ‘altro’ rispetto ai
processi associativi presenti nella società, al fine di riprendere le fila della propria biografia
individuale frammentata” [ibidem]. L’esperienza nei gruppi presentava d’altra parte una continua
tensione fra la sue dimensione interna e quella esterna. In alcune situazioni prevalevano in modo
quasi esclusivo gli aspetti relazionali e affettivi, e la pratica era soprattutto l’autocoscienza. In altri
assumevano un peso maggiore le competenze tecniche e professionali, e l’azione era più orientata
alla produzione di beni e prodotti specifici. Rispetto all’ambiente esterno, emergevano due diverse
modalità di relazioni. La prima modalità era individuale, di ogni singola donna arricchita e rafforzata
dall’esperienza del gruppo. La seconda, coinvolgeva l’intero gruppo in un rapporto con le
dimensioni pubbliche e collettive dell’ambiente esterno. Per il lavoro di laboratorio, le ricercatrici
scelsero un gruppo (Collettivo Donne del Ticinese) riconosciuto come punto di riferimento
dall'intero movimento. La fisionomia del gruppo rivelava d'altra parte la sua posizione di centralità
rispetto alle diverse esperienze e ai diversi orientamenti del femminismo milanese.
Se i movimenti giovanili e il movimento femminista attraversavano all'inizio degli anni ottanta una
fase di latenza e di relativo riflusso rispetto agli anni settanta, il movimento ecologista in Italia era
ancora in formazione. Nell'area ecologista erano confluite tre componenti: a) l'associazionismo
protezionistico e naturista tradizionale (Italia Nostra, WWF, Pro Natura ecc.); b) i gruppi di militanti
legati a partiti di sinistra o al partito radicale; c) le aggregazione di base autogestite [Barone 1984,
183]. Mentre la mobilitazione sul tema del nucleare attraversava una fase di relativa stasi, si
costituivano nuovi gruppi informali e nuove associazioni ecologiste. Nel 1979 era stata fondata la
Lega per l'Ambiente, che era destinata a prendere sempre più le distanze dall'Arci, l’associazione
ricreativa promossa e tradizionalmente orientata dai partiti di sinistra.
L'area ecologista milanese comprendeva aggregazioni territoriali poco formalizzate, gruppi
autogestiti per la promozione di nuove forme di alimentazione di coltivazione naturale, alcuni gruppi
professionali impegnati nelle campagne per la tutele dell'ambiente. Tutti i gruppi dell'area erano
formati in prevalenza da persone altamente scolarizzate, di età compresa fra 25 e i 35 anni, che
avevano conosciuto precedenti esperienze associative o di militanza politica nella nuova sinistra o
nella FGCI. In riferimento agli orientamenti, potevano essere distinti due settori. Il primo (ecologia
politica) impegnato in azioni per influenzare i processi decisionali delle istituzioni politiche. Il
secondo (ecologia sociale) più interessato alla trasformazione dei modelli culturali che regolano i
rapporti fra l'uomo e l'ambiente [ibidem, 188]. Il lavoro sperimentale di laboratorio fu perciò svolto
con un gruppo del primo settore (il collettivo di redazione della rivista La Nuova Ecologia), e uno del
secondo (Ecologia 15, gruppo di lavoro sui problemi dell'ambiente della zona 15).
L’indagine sull’area della “nuova coscienza” studiò gli orientamenti e le logiche d’azione di un
insieme di gruppi che con difficoltà potevano essere ricondotti al concetto di movimento sociale.
L’area si era formata a Milano negli anni ottanta, per la diffusione di esperienze e forma di
aggregazione ispirate dalla controcultura americana e dalle tradizioni religiose orientali. La crisi dei
movimenti e delle formazioni della nuova sinistra avevano favorito l’avvicinamento di molte
persone a percorsi di ricerca interiore. L’esperienza aveva attratto anche persone di diversa
provenienza sociale e culturale. Si era così formata un’area relativamente estesa in cui convivevano
“misticismo ed integrismo comunitario, pratiche terapeutiche ed esperienze settarie, spinte verso la
liberazione dalla repressione e fenomeni di rigido moralismo, casi di fuga dalla società e
testimonianza di impegno civile” [Diani 1984, 226]. L’elemento che accomunava queste disparate
attività era l’esigenza di accrescere la consapevolezza individuale e di ritrovare un nuovo equilibrio
fra corpo e mente. La mancanza di orientamenti definiti e condivisi al di là della singola esperienza,
rendeva difficile la individuazione di un gruppo “naturale” per il lavoro di laboratorio che potesse
rappresentare l’intera area. Fu scelto un centro buddista (Ghe Pel Ling) per il carattere
prevalentemente volontario della partecipazione, la solidarietà fra i membri e un’attività che non si
limitava alla pratica spirituale ma comprendeva anche proposte culturali e prestazioni di servizi
rivolte all’ambiente esterno [ibidem, 230]
5. Nuove forme di azione, di organizzazione e di leadership
La ricerca sulle aree di movimento milanesi mise in luce profonde trasformazioni nelle forme di
azione collettiva, di organizzazione e di leadership. La mobilitazione emerse alla fine degli anni
sessanta avevano espresso figure di leader forti e visibili, in grado di assicurare la centralizzazione,
coerenza rispetto agli obiettivi strategici e una relativa continuità nel tempo ai movimenti. I
movimenti della prima metà degli anni settanta e le organizzazioni della nuova sinistra richiedevano
una militanza personale orientata a un progetto di trasformazione politica e sociale di lungo periodo.
Tra la seconda metà degli anni settanta e gli anni ottanta erano cambiati gli orientamenti ideologici e
il modo di rappresentare la propria azione, con la caduta di interesse per le utopie e i progetti globale.
L’attenzione era rivolta soprattutto a obiettivi puntuali e contingenti. Le forme organizzative erano
perciò mobili e flessibili, e potevano crescere e disperdersi rapidamente. Le aree mantenevano nel
complesso una struttura organizzativa segmentata e reticolare, con una leaderhip diffusa. Sembrava
così riprodursi, con una accentuata dispersione delle componenti, la tipica forma organizzativa delle
aree di movimento americane [Gerlach e Hine 1970]. Questa forma organizzativa era la più
funzionale per un movimento che alternava a fasi di mobilitazione relativamente brevi, periodi di
latenza sempre più estesi. Mantenere canali di comunicazione, reti informali di piccoli gruppi, luoghi
privilegiati di aggregazione, rendeva possibile una rapida riattivazione della mobilitazione di fronte a
particolari congiunture.
Le aree di movimento milanesi presentavano naturalmente dei tratti peculiari diversificati, in parte
dipendenti dalle fasi attraversate. I gruppi giovanili milanesi erano impegnati dalla seconda metà
degli anni settanta a fare convergere i fini collettivi perseguiti con i bisogni individuali. La ricerca
confermava l’importanza crescente degli incentivi selettivi di carattere solidaristico ed affettivo.
Venne rovesciato il tradizionale rapporto fra mezzi e fini di un movimento “il senso di appartenenza,
la solidarietà, la comunicazione, non costituiscono più semplici risorse a disposizione del gruppo per
facilitare l’azione ma divengono un fine in sé, da conseguire nell’immediato” [Lodi e Grazioli 1984,
110]. Restava però diffusa la definizione del proprio impegno come politico, e la rivendicazione di
un’identità di attori conflittuali rispetto alla società e alle istituzioni. I leader centrali e riconosciuti
che avevano guidato le mobilitazioni nel sessantotto erano stati sostituiti da reti di opinion-leader:
militanti con accessi privilegiati all’informazione, in grado di fornire orientamenti e indicazioni
operative, e promuovere rapidamente nuove campagne di mobilitazione. Nelle fasi di latenza,
emergevano con più frequenza nuove professionalità da alcune componenti dei movimenti giovanile,
che cercavano di coniugare l’impegno con la autovalorizzazione personale, occupando spazi
trascurati dal mercato. E d’altra parte, mostravano talvolta maggiore vitalità proprio i gruppi che
avevano scelto di professionalizzare i propri interventi.
L’area del movimento delle donne milanese appariva impegnato soprattutto nel lavoro di
autoriflessione ed elaborazione di nuovi orientamenti per l'azione. Il movimento era nato fra donne
ad alta scolarità, impegnate in un processo di ridefinizione e ricostruzione della identità, sottoposte
alle richieste contraddittorie, innovative e tradizionali, loro rivolte dalla società. L'area vedeva la
presenza di tre generazioni di donne che avevano interpretato in modo diverso il femminismo: le
"storiche", le "reduci dai gruppi della nuova sinistra" e le "giovani". All'inizio degli anni ottanta, più
che alla protesta e alla contrattazione con il mercato politico, l'attenzione dei gruppi era rivolta alle
molteplici dimensioni della vita sociale: la cultura, le competenze professionalità, l’imprenditorialità
e le esperienze di autogestione. Emergeva così un forma di antagonismo di carattere culturale che si
esprimeva nell'esperienza quotidiana delle donne: "il lavoro di produzione e riproduzione che
coinvolge le donne non é solo funzionale al sistema: nella loro azione le donne elaborano anche
strategie per la sopravvivenza, la resistenza e il cambiamento" [Bianchi e Mormino 1984, 167]. Il
movimento delle donne milanesi presentava diverse specificità rispetto ad altre situazioni e si
caratterizzava per lo spazio e la tolleranza concessi alle idee e alle iniziative più diversificate. Un
maggior interesse per le relazioni con le istituzioni consentiva d'altra parte al movimento delle donne
di investire un'area sociale molto più larga degli originari gruppi dell'élite femminista. All'interno dei
sindacati, dei partiti, di diverse associazioni e istituzioni si erano così aggregati gruppi di donne che
ne utilizzavano gli spazi per ritrovarsi su propri obiettivi e progetti. Il messaggio femminista aveva
così raggiunto anche le operaie e le donne di livello colturale meno elevato. Nell'area di movimento
milanese d'altra parte apparivano minoritari e poco rilevanti il separatismo e la componete
omosessuale del femminismo.
L’area ecologista milanese era ancora in formazione e conosceva una tendenziale polarizzazione fra
due orientamenti principali, corrispondevano a diverse generazione di militanti. Il primo era espresso
soprattutto dagli attivisti con precedenti esperienze nei movimenti degli anni settanta e nella nuova
sinistra. Combinando una cultura antagonista a competenze e professionalità specifiche, gli
ecologisti di questo settore mettevano in discussione e contrastavano dall’esterno le decisioni delle
istituzioni politiche. Il secondo orientamento emergeva nella generazione più giovane di attivisti,
assumeva l’impegno ecologista in termini più pragmatici, in vista di obiettivi puntuali e limitati, e
appariva più disponibile ad essere coinvolto direttamente dalle istituzioni. Questi attivisti
assumevano “all’interno dell’istituzione un ruolo modernizzatore, mentre la loro azione si traduce,
verso l’esterno, in interventi di supplenza istituzionale o di imprenditorialità alternativa “ [Barone
1984, 220]. Nell’area ecologista milanese mancava d’altra parte un leadership centrale in grado di
unificare i diversi orientamenti. Esistevano invece momenti di coordinamento informale, gestite da
diverse agenzie e da opinion-leader in grado di fornire informazioni e indicazioni per l’azione.
Nell’area della nuova coscienza mancavano progetti condivisi, non esistevano canali di collegamento
e di scambio, e ogni gruppo procedeva senza contatti con gli altri. I contenuti conflittuali dell’azione
erano rilevabili solo a livello simbolico, per le sfide sui processi di definizione dell’identità, i
significati dell’azione, i valori e i modelli di comportamento. Questi orientamenti alternativi si
esprimevano sul terreno dei simboli e degli stili di vita, ma non originavano mai conflitto sociali. In
diversi casi non si manifestava neppure antagonismo sul piano simbolico, e si rivitalizzavano
semplicemente alcune pratiche religiose nel rispetto della morale tradizionale: “la forte presenza di
orientamenti integralisti favorisce la progressiva neutralizzazione dell’antagonismo simbolico”
[Diani 1984, 226].
La ricerca sulle quattro aree di movimento milanesi mise in evidenza importanti cambiamenti del
profilo sociale e delle motivazioni degli attivisti. In una fase di relativa stagnazione dei movimenti,
partecipavano alle attività e alle iniziative promosse dai gruppi soprattutto i soggetti che potevano
essere considerati centrali per alcuni aspetti (livello di istruzione, residenza e accesso ai circuiti
dell’informazione) e invece marginali per altri (per la posizione nel mercato del lavoro, il
riconoscimento sociale e il ruolo nella politica istituzionale) [Grazioli e Lodi 1984, 309]. Si poteva
così riproporre il modello della incongruenza di status come possibile spiegazione della
partecipazione [Pizzorno 1966b].
Altri fattori che facilitavano la partecipazione: non solo l’appartenenza a reti di relazioni e le
esperienze organizzative precedenti, ma anche i rapporti parentali e le relazioni amicali. Le
trasformazioni della militanza osservate mostravano in generale uno sforzo per fare convergere
l’impegno e la gratificazione personale, l’autorealizzazione e la partecipazione. Si cercava così di
ottenere, nello stesso tempo, “la valorizzazione delle risorse espressive e la loro utilizzazione in
termini di azione collettiva” [Grazioli e Lodi 1984, 311]. L’osservazione delle aree rivelava però
oscillazioni marcate fra esperienze in cui prevalenza del narcisismo individuale e di gruppo, ed
esperienze in cui era più accentuato il senso di appartenenza al movimento e si ridimensionavano le
differenze individuali. La poca visibilità dell’avversario spingeva d’altra parte molte esperienze al
ripiegamento nella solidarietà del piccolo gruppo. La chiusura settaria era però di regola evitata per
la molteplicità delle appartenenze, e il carattere parziale e limitato nel tempo che caratterizzava la
partecipazione individuale.
Negli anni ottanta le quattro aree di movimento milanesi apparivano prive di leader riconosciuti e
visibili, di gerarchie definite e di strutture formalizzate. Non erano però venute meno le asimmetrie
nei rapporti interni ai gruppi e fra i gruppi, anche se le pratiche di autoriflessione avevano cercato di
rendere più trasparenti e negoziabili i rapporti di potere. Le asimmetrie nelle posizioni dei
partecipanti ai gruppi trovavano spesso fondamento nella maggiore disponibilità all'impegno, nelle
competenze professionali, nella conformità rispetto alle regole informali e alle aspettative collettive.
Lo stesso ruolo di critica e di smascheramento dei rapporti e delle posizioni di potere all’interno dei
gruppi poteva diventare la base per nuove leadership [Diani e Donati 1984, 330]. D’altra parte le
asimmetrie nelle relazioni di potere tendevano ad essere dissimulate, soprattutto nei gruppi in cui era
molto forte la componete solidaristica e affettiva. “Negli attuali nuclei di movimento, l’esigenza di
garantire la sopravvivenza dell’organizzazione attraverso funzioni produttrici di asimmetria si
affianca alla impossibilità di esplicitare, formalizzandola, tale asimmetria, pena ancora una volta la
rottura della solidarietà e della relazione” [ibidem, 344].
Anche nelle quattro aree di movimento non esisteva una leadership centralizzata investita di poteri di
decisione e di rappresentanza. Nelle fasi di latenza erano sufficienti le iniziative e le attività di
servizio di alcuni gruppi ed agenzie per mantenere i contatti e tenere vivo il senso di identità. Le fasi
di mobilitazione erano di regola gestite da comitati di coordinamento a livello nazionale o locale,
composti da una pluralità di gruppi e di organizzazioni che operavano per raccogliere e attivare le
risorse necessarie per l’azione collettiva. I comitati non mantenevano una continuità nel tempo, e più
che funzioni di decisione o di rappresentare del movimento, si limitavano a lanciare proposte per la
mobilitazione e temi per il dibattito. Anche le organizzazioni politiche che mettevano a disposizione
importanti risorse umane e organizzative per la mobilitazione, evitavano di fare apparire il loro ruolo
come centrale [ibidem, 339].
Si creavano cosi forme temporanee di leadership di area,
spersonalizzate e funzionali alla mobilitazione, entro le quali assumevano talvolta un ruolo
importante anche i militanti, le agenzie e gli organismi più professionalizzati.
I mutamenti delle forme organizzative e le pratiche via via diffusa nelle diverse aree di movimento
erano coerenti con il ripensamento dei fini e del senso dell'azione: "il rifiuto di riconoscere e
proclamare dei leader, ed il passaggio dalle organizzazioni formali ai gruppi informali è un processo
che va di pari passo con il tentativo di rifondare l'identità collettiva e di sostituire uno scambio di
lungo periodo scarsamente controllabile con uno scambio di natura immediata e di alta
controllabilità" [ibidem, 326].
6. Le aree di movimento fra latenza e visibilità
La ricerca diretta da Melucci sollecitò un ripensamento dello stesso concetto di movimento, di fatto
sostituito da quello di area di movimento. Il concetto di area di movimento fu introdotto nel disegno
di ricerca come campo per l’indagine empirica e si rivelò un modello molto utile per descrivere la
struttura organizzativa che caratterizzava i movimenti negli anni ottanta. Nelle aree coesistevano
diversi modelli di comportamento, che erano il risultato delle esperienze storiche passate e delle
differenziazioni delle modalità di approccio di una stessa tematica. L’area era la sede della
formazione di un’identità collettiva e la garanzia della sua continuità e coerenza nel tempo. “Gli
individui e i gruppi trovano nell’area un riferimento per ricomporre identità divise fra molte
appartenenze, tra ruoli e tempi diversi dell’esperienza sociale” [Melucci 1984, 436]. Per descrivere i
fenomeni empirici studiati Melucci propose di sostituire la stessa denominazione di movimenti con
quello di aree o netwoks di movimento: “una rete di gruppi che condividono una identità collettiva e
una cultura a orientamento conflittuale” [Melucci 1986, 25]. Erano parte costitutiva dell’area non
solo insiemi di organizzazioni formali e informali, ma anche le relazioni informali che legano
individui e gruppi fra loro e con un’area più vasta di possibili partecipanti. Questa forma
organizzativa da una parte richiedeva il coinvolgimento personale e la solidarietà affettiva come
condizione per la partecipazione; dall’altra permetteva l’appartenenza simultanea a diversi gruppi e
un impegno che può essere a tempo parziale o a termine.
Alberoni aveva delineato un modello idealtipico dell’esperienza dei movimento, lungo un percorso
che partiva dallo stato nascente per approdare all’istituzionalizzazione [1981]. Melucci elaborò, a
partire dalla ricerca milanese, un modello più complesso e flessibile, che prevedeva un alternarsi di
diverse modalità di funzionamento delle aree di movimento. Nell’esperienza dei movimenti (o
meglio, delle aree o reti di movimenti) si possono riconoscere due fasi fondamentali: la latenza e la
visibilità. Nella fase di latenza gli individui e i gruppi sperimentano nuovi modelli culturali,
elaborano nuovi significati e nuovi codici comunicativi che spesso si oppongono alle pressioni
sociali dominanti: “La latenza è una sorta di laboratorio sommerso dell’antagonismo e
dell’innovazione” [Melucci 1984, 445]. I gruppi che formano l’area di movimento emergono e
acquistano visibilità quando si confrontano apertamente con l’autorità politica per contestarne le
decisioni. La mobilitazione opera in questo caso come un media: “indica al resto della società il
legame tra il problema specifico e la logica dominate del sistema;… annuncia che sono possibili
modelli culturali alternativi” [ibidem]. Esiste d’altra parte un complementarietà fra le due fasi dei
movimenti. La latenza crea e permette la sperimentazione di nuovi codici culturali, e fornisce alla
mobilitazione le risorse di solidarietà e i riferimenti culturali. La mobilitazione rafforza l’area di
movimento, favorendo la creazione di nuovi gruppi, il reclutamento di nuovi militanti e il
rafforzamento della solidarietà.
Anche dopo la fine di un ciclo di protesta, le aree di movimento possono mantenersi a lungo, in
presenza di un sistema politico non rigido né repressivo, se esistono organizzazioni di movimento e
agenzie di area in grado di garantire la comunicazione interna nelle fasi di latenza e la promozione
della mobilitazione nelle fasi di visibilità, fornendo le risorse organizzative per le campagne politiche
senza negare l’autonomia delle reti informali.
Il concetto di area di movimento sviluppato nella ricerca diretta da Melucci ha contribuito a un
ripensamento dello stesso concetto di movimento sociale nella ricerca internazionale. Questo attore
collettivo viene individuato sulla base di quatto caratteristiche fondamentali: a) una rete di relazioni
prevalentemente informali; b) un insieme di credenze condivise e una specifica solidarietà; c)
l’impegno in conflitti politici e/o culturali; d) l’uso frequente di azioni di protesta [Della Porta e
Diani 1997, 28-30].
7. I movimenti fra antagonismo,, innovazione culturale e modernizzazione.
Melucci aveva da tempo rifiutato la proposta di Pizzorno di considerare i movimenti sociali come
una forma di partecipazione politica [Melucci 1977]. Se nella società industriali i conflitti tendevano
a ricomporsi intorno alla frattura capitale/lavoro e al confronto con lo stato nelle lotte per la
cittadinanza, nelle società postindustriali l’azione nelle aree di movimento si separava da altre forme
di partecipazione, e in particolare perdeva la sua focalizzazione sul sistema politico. Melucci criticò
perciò gli studi sui movimenti sociali che si concentravano esclusivamente sui loro rapporti con il
sistema politico, ignorando la società civile: “i confronto col sistema politico e con lo stato è sempre
una parte, più o meno importante dell’azione collettiva, ma è solo una parte […] Il fuoco sul sistema
politico coglie esclusivamente la dimensione dello scambio. ” [Melucci 1984, 420]. I nuovi
movimenti andavano al di là della sfera politica, diventavano “post-politici” ed investivano l’intero
sistema sociale soprattutto sul terreno dei codici simbolici.
La ricerca sulle aree di movimento milanesi si era interrogata lungamente sulla esistenza di aspetti
conflittuali di natura antagonista. A conclusione del lavoro, questo tipo di contenuti furono
individuati sia negli orientamenti all’azione che caratterizzavano l’identità collettiva di ogni area, sia
nelle forme e nella strutturazione dell’azione collettiva.
Nella società ad alta densità di informazione, l’antagonismo non si manifestava solo nella resistenza,
ma anche capacità di rovesciare i codici dominati. Nell’area dei gruppi giovanili e dei centri sociali
si era affermata una concezione della gioventù che alla definizione biologica aveva sostituito quella
culturale, fondata sul diritto alla variabilità e alla reversibilità delle scelte: “I giovani a partire dalla
condizione di sospensione sociale, dal limbo simbolico che la società assegna loro, oppongono a
questa logica l’appello a una variabilità che si manifesta come assenza di progetto, come esperienza
del presente, come diritto di appartenere per scelta e non per collocazione” [ibidem, 437].
Nell’area dei gruppi femministi, le lotte contro la discriminazione e per l’uguaglianza dei diritti, si
erano intrecciate con quelle per il diritto alla differenza. Questo aspetto faceva emergere il contenuto
antagonista del conflitto “In società che sviluppano forti pressioni per la conformità, l’appello alla
differenza ha un significato dirompente sulla logica dominante” [ibidem, 438]. D’altra parte la
cultura femminista era entrata dagli anni ottanta nei mercati della politica, della cultura e dei
consumi, e aveva contribuito a rinnovarli. Il successo aveva provocato trasformazioni nell’area di
movimento, professionalizzando alcuni gruppi e disperdendo alcune esperienze. Restava però un
nucleo antagonista del movimento, reperibile soprattutto nella forme di comunicazione autoriflessiva
del piccolo gruppo, che mantiene vivo un rapporto continuo fra l’azione e la riflessione sui suoi
significati cognitivi e affettivi. Questa modalità di comunicazione si opponeva alle logiche del
sistema sociale che accettavano solo o l’identificazione e l’integrazione con i codici dominati, o la
separatezza e la esclusione. La ricerca milanese aveva mostrato che nel movimento si impegnavano
soprattutto donne con istruzione superiore, in particolare se impegnate nel sistema di welfare. L’area
di movimento sembrava così configurarsi come una sorta di enclave, a cui la società affidava il
compito di sperimentare l’innovazione. Il movimento poteva assumere la funzione di un gruppo di
pressione, contribuendo alla modernizzazione della società con la diffusione dei contenuti politici e
culturali dal femminismo, mentre restavano attivi piccoli gruppi fondamentalisti non
istituzionalizzati [ibidem, 440]. L’appello simbolico al valore della differenza apriva d’altra parte
spazi per tutti, al di là dello specifico della condizione femminile.
L’area ecologista aveva assunto dalle origine un funzione di gruppo di pressione istituzionale, e la
sua azione appariva condizionata dalla presenza di nuove élite in formazione. Ma i suoi contenuti
culturali mettevano in discussione il paradigma industrialista e valorizzavano la “natura” come ciò
che sfugge al dominio della tecnologia e alle esigenze del mercato. I gruppi della “nuova coscienza”
segnalavano e sperimentavano percorsi di ricerca spirituale, mettendo in luce “orientamenti che
hanno una forza straordinaria di rovesciamento simbolico” [ibidem, 441].
I contenuti antagonisti dei nuovi movimenti si esprimevano però anche nelle forme secondo cui si
organizza la pratica: le modalità di costruzione delle mobilitazioni da una parte, le strutture
organizzative e la leadership nelle aree di movimento dell’altra. Le nuove forme organizzative non
erano solo strumentali in vista degli obiettivi specifici: “La forma del movimento è un messaggio,
una sfida simbolica alla cultura dominante” [Melucci 1986, 27]. Le mobilitazioni diventavano
sempre più a tempo, reversibili e costruite in modo da rispondere anche ai bisogni individuali che
non separano più il tempo dell’impegno dal tempo libero. Nelle reti organizzative di movimento,
l’azione collettiva era tendenzialmente sempre negoziata e autoriflessiva, per rendere espliciti e
mantenere sotto controllo i rapporti di potere.
La visibilità delle relazioni di potere e la loro esposizione alla contrattazione interpersonale
assumevano il carattere di un codice di tipo antagonista rispetto a quelli prevalenti nella società,
relativamente indipendente dai contenuti proposti da ciascuna area di movimento. Per Melucci se i
contenuti assumevano un peso predominante nell’azione, si apriva la strada all’istituzionalizzazione
dei movimenti: “la ricerca spirituale diventa una chiesa, la cultura giovanile una moda che i mercato
integra e rapidamente consuma, i temi del femminismo un rinnovamento del costume e della moda”
[Melucci 1984, 443]. L’istituzionalizzazione di alcune aree di movimento spostava l’antagonismo
altrove, ad altri temi ed altri attori. La conclusione a cui approdò la ricerca fu che “L’antagonismo
dei movimenti ha carattere eminentemente comunicativo. Essi offrono al resto della società altri
codici simbolici che rovesciano la logica di quelli dominanti” [ibidem, 443-444]. I movimenti
funzionavano perciò principalmente come nuovi media, che postavano alla luce ciò che di regola il
sistema non diceva [Sassoon 1984]. Le mobilitazioni degli anni ottanta facevano emergere uno
spazio pubblico intermedio fra le istituzioni politiche e la società civile, in cui potevano esistere ed
esprimersi aree di movimento che, senza istituzionalizzarsi né trasformarsi in partito, chiedevano alla
società di “ascoltare il loro messaggio e di tradurre le loro domande in decisioni politiche, mentre i
movimenti mantengono la loro autonomia” [Melucci 1986, 29-30]. La distinzione fra azione
espressiva e azione strumentale sembrava così scomparire, perché i risultati dell’azione e la
sperimentazione di nuovi codici comunicativi tendevano a coincidere. Essi annunciavano che il
possibile poteva essere già reale e praticato, esasperando paradossalmente o capovolgendo i codici
dominanti, separando i contenuti dai codici abituali secondo cui erano rappresentati. Ma nel
complesso, la ricerca confermò soprattutto i tratti ambivalenti dei movimenti degli anni ottanta. Essi
finirono per essere soprattutto agenti di innovazione culturale e di modernizzazione, diffondendo
culture e stili di vita alternativi che erano spesso assorbiti dai circuiti del mercato o dalle istituzioni.
La cultura, le forme organizzative e le logiche d’azione delle aree di movimento milanesi degli anni
ottanta hanno d’altra parte anticipato molti aspetti del nuovo “movimenti dei movimenti” che, dopo
la contestazione della riunione del WTO a Seattle nel 1999, si è sviluppato in molti paese gestendo
le proteste contro la mondializzazione neoliberista e le sue istituzioni [Ceri 2001].