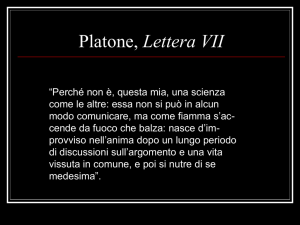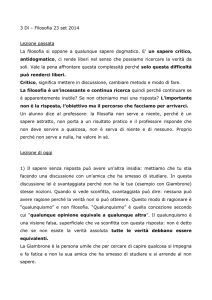Pragmatismo
Nella filosofia classica, l'efficacia pratica è considerata come un tratto specifico
dell'epistéme, peraltro subordinato al ruolo essenzialmente teoretico di quest'ultima. Con il
tramonto del tentativo filosofico di fissare verità definitive, quella valenza pratica del sapere è
conservata, ed anzi si propone addirittura come l'unica, concreta ragion d'essere del sapere
medesimo.
Ancor di più: le strutture conoscitive tendono ad essere viste sempre più come
strumenti di tipo particolare (funzionali all'organizzazione ed alla coordinazione di altri
interventi pratici). Questo processo, per converso, porta la scienza sperimentale (vista come
l'ambito in cui si mettono a punto gli strumenti tecnici per intervenire sul reale) a costituirsi
come la via maestra della conoscenza, soppiantando la vecchia cultura filosofica.
Se è vero (come pensa ad esempio Nietzsche) che la filosofia ha inteso essere il
rimedio contro l'imprevedibilità minacciosa ed angosciosa del mondo, il ruolo oggi assunto
dalla scienza è sempre più quello del rimedio efficace, che cioè, a differenza di quanto è
accaduto per la filosofia, “mantiene” quanto promette, sia pure promettendo qualcosa di
meno, e cioè rinunciando ad essere un rimedio assoluto. (E anzi, è proprio perché opera tale
rinuncia, perché evita di affrontare i problemi ultimi, di cercare una verità definitiva,
incontrovertibile, che la scienza può aver successo là dove la filosofia ha fallito).
Già Hume, Mill, Spencer, e da una diversa prospettiva Marx, hanno prospettato il
ruolo essenzialmente economico del sapere, dell'intelligenza vista come strumento di
sopravvivenza per l'uomo in quanto organismo fisico (e quindi la subordinazione del
momento teoretico a quello pratico). Su questa strada si sono poi variamente mossi pensatori,
spesso anche su posizioni assai lontane tra di loro, come Mach, Nietzsche, Poincaré, Bergson,
Weber.
In particolare le tesi di quest'ultimo possono essere viste come uno dei momenti in cui
il sapere scientifico prende più lucidamente coscienza del proprio ruolo fondamentale nella
civiltà contemporanea e futura, ed insieme dei propri invalicabili limiti. Fallito il tentativo
filosofico di dare un senso definitivo alla realtà, non resta infatti, per Weber, che lo scontro
pratico tra interessi e valori diversi, scontro che la scienza può bensì far risolvere a favore di
una delle parti in lotta, ma senza poter dare garanzie sulla “giustizia” o sulla “verità” dell'esito
così conseguito.
Il “disincanto” di Weber in relazione alla civiltà della tecnica è conseguenza del
tramonto della verità, che caratterizza la cultura di questa civiltà: la consapevolezza di tale
tramonto è presente, ma con sbocchi alquanto più ottimistici, negli esponenti del
pragmatismo, cioè di quella corrente che rappresenta il maggior contributo americano alla
storia della filosofia contemporanea, le cui posizioni appaiono particolarmente vicine anche a
quelle del neopositivismo europeo.
Charles Peirce (n. 1839) è il primo pensatore ad usare il termine “pragmatismo”
per definire la propria filosofia, intendendo indicare con esso un atteggiamento volto
all'unificazione di teoria e pratica, con sostituzione dell'interesse positivistico per le
conoscenze con quello per le operazioni. Ogni significato (e la conoscenza si articola appunto
in significati determinati e distinti) è sempre relativo ad un agire: se due conoscenze “diverse”
hanno la stessa conseguenza pratica esse sono da considerarsi, in realtà, come identiche.
Se ci atteniamo a questo criterio, secondo Peirce è possibile eliminare dalla filosofia
tutti i falsi problemi (cioè le questioni “prive di senso”, in quanto non corrispondenti ad
alcuna possibile operazione): ciò porterà alla costituzione di un linguaggio rigoroso, capace di
esprimere tutto ciò che ha significato (cioè tutto ciò che esiste)1.
D'altra parte, dato che i possibili risvolti pratici di una struttura teorica (o anche
operativa) non sono mai delimitabili in via definitiva, ogni significato appare sempre aperto a
re-interpretazioni, cioè a nuove assunzioni ed utilizzazioni, da parte dell'uomo, in vista di
nuovi sbocchi pragmatici.
E' evidente, date queste premesse, che la verifica di una certa ipotesi potrà consistere
solo nel successo pratico delle previsioni su di essa costruite; ma proprio per questo nessuna
“verifica” potrà mai essere assunta come accertamento di una verità oggettiva, inconfutabile,
ma soltanto come convalida dell'ipotesi in senso probabilistico: a differenza della vecchia
metafisica, il pensiero scientifico è ben consapevole della propria provvisorietà, fallibilità,
dunque di continuo disponibile a rivedere e riformulare le proprie tesi2.
Se in Peirce lo sbocco pratico resta il criterio unico della “verità” di una qualunque
costruzione teorica, per William James (n. 1842) esso coincide addirittura con la verità
stessa: l'essenza di quest'ultima si riduce al funzionamento di una certa teoria. Ogni teoria è
fede, e la verità di una fede è data anzitutto da suo essere seguita, dal suo successo pratico tra
gli uomini. O, in altre parole, la verità coincide con la volontà di credere, non è qualcosa da
scoprire, ma piuttosto da costruire (secondo un'ottica che, nel pensiero europeo, è portata
avanti con particolare energia da Nietzsche)3.
James perviene così ad un “empirismo radicale”, per cui viene negata addirittura
l'esistenza di fatti oggettivi: ogni asserzione su dati di fatto è un'ipotesi. Questi dati sono bensì
la base concreta di ogni conoscenza, ma non hanno mai contorni completamente determinati,
definitivi: l'esperienza vissuta viene sempre ridefinita attraverso interpretazioni, ed il sapere
non è altro che elaborazione, costruzione provvisoria a sua volta re-interpretabile4.
1
Una impostazione analoga sarà successivamente adottata dagli esponenti dell'empirismo logico vedi anche la nota successiva.
2
Si ha qui a che fare con una concezione della “verità” abbastanza affine a quella successivamente
adottata dal pensiero ermeneutico (ad es. da Gadamer), per cui la verità stessa non è più pensata
come piano stabile, terreno definitivo del senso delle cose, ma come apertura di orizzonti di significato
soggetti a continua ristrutturazione. Molto vicine alla filosofia ermeneutica sono, del resto, sia
l'importanza centrale che Peirce, come si è visto, assegna al linguaggio, sia, soprattutto,
l'individuazione di ogni atto di conoscenza come atto interpretativo. Del resto è proprio l'instabilità di
ogni significato, la sua reinterpretabilità da parte dell'uomo, che porta a vedere nel linguaggio non più
la semplice rappresentazione - per segni - di significati oggettivi, definitivi, ma la stessa scena in cui si
giocano le sorti di ciascun significato, il luogo (sociale, pubblico) ove è possibile verificare in concreto
la validità, l'incidenza intersoggettiva di una teoria (cfr. anche il “fisicalismo” di Neurath o Popper).
3
Nietzsche, peraltro, ritiene che tutte le forme di fede sinora elaborate dalla cultura occidentale
abbiano portato più danni che vantaggi alla libertà umana: su questo punto James sembra alquanto
più ottimista (e in questo senso più vicino alle tesi di Bergson), ravvisando ad esempio in certe forme
religiose, elementi “pragmaticamente favorevoli” allo sviluppo dell'energia vitale insita nell'uomo.
4
Si noti come l'empirismo di Hume cogliesse bensì il carattere di credenze di tutte le teorie
scientifiche, ma conservasse un valore di verità assoluta ai dati dell'esperienza (matters of fact): è a
partire dalla seconda metà dell'Ottocento che anche la struttura di tali dati viene individuata come
risultato di credenze, interpretazioni non-necessitanti.
2
Lo stesso credere in qualcosa può essere condizione essenziale del suo avverarsi: sia
l'atteggiamento di credere nelle proprie forze che quello di non crederci possono risultare veri,
alla prova dei fatti, ma la configurazione che si produce nel primo caso è per noi più
favorevole, per cui è verso tale fede che conviene rivolgersi. Non si dovrebbe mai chiedere:
“Come stanno in effetti le cose?”, ma piuttosto: “Che cosa si ottiene credendo in queste
cose?”. Il che, se preso alla lettera, dovrebbe portarci ad assumere come vera qualsiasi dottrina
filosofica o metafisica che presentasse conseguenze utili (e viceversa a scartare ogni dottrina
che non abbia utilità pratica), secondo un'ottica (la fede come scommessa favorevole) che
ricorda in qualche modo Pascal, e che sembra avere molto in comune anche con il “mito”
sorelliano della rivoluzione.
Le interpretazioni attraverso cui l'uomo costruisce la “realtà” del mondo, non possono
in alcun modo venir organizzate in una unità assoluta (cioè in un sistema onnicomprensivo
che bloccherebbe la fluidità del loro sviluppo): l'universo è in realtà un “multiverso” di realtà
(= punti di vista) indipendenti e contrastanti tra di loro.
Come non c'è un punto di vista definitivo sul movimento frammentato, imprevedibile,
del reale, così non c'è una natura stabile, prefissata, dell'uomo: la mente umana non è
organizzata per schemi logici necessari, ma è strumento dinamico, in continuo adattamento
rispetto all'ambiente. James è qui abbastanza vicino alle tesi dell'empiriocriticismo, per cui gli
atti di pensiero sarebbero essenzialmente funzioni biologiche dell'organismo vivente, inteso
poi come espressione, momento particolare di un flusso vitale fondamentalmente irrazionale.
(E sarebbe lecito chiedere a James se quest'ultima tesi sia espressione di una verità
indiscutibile o, a sua volta, frutto di una fede “più conveniente” di altre).
Anche John Dewey (n. 1859) concepisce le forme conoscitive come strumenti che
l'essere umano adotta nel suo processo di adattamento all'ambiente. Tuttavia “uomo” e
“ambiente” sono da lui intesi come momenti interni al flusso dell'esperienza, per cui lo stesso
concetto di “adattamento” non va visto tanto come azione reciproca tra un mondo soggettivo
ed un mondo oggettivo precostituiti, ma come articolazione dinamica di tale flusso (che
costituisce la dimensione originaria del reale) in quei due aspetti complementari.
Dewey condivide l'assunto di James (ma poi anche di Nietzsche, di Bergson) per cui
noi non abbiamo a che fare anzitutto con dei dati (come credeva l'empirismo classico), bensì
con interpretazioni: qualsiasi contenuto della nostra esperienza e conoscenza ci giunge infatti
sempre filtrato da precedenti indagini ed operazioni, il cui insieme costituisce appunto la
realtà storica, culturale, di ciò che noi chiamiamo un “oggetto”5. I “fatti” con cui ci misuriamo
sono in realtà sempre delle ipotesi (certamente confermate da una lunga serie di esperienze,
ma pur sempre superabili, falsificabili).
Anche tutte le strutture “polarizzate” del nostro mondo (la sfera psichica in quanto
opposta alla sfera fisica, la soggettività come opposta all'oggettività) non vanno quindi pensate
come realtà sostanziali, ma come costruzioni interpretative attraverso cui l'esperienza, cioè
l'apparire stesso del mondo, si sviluppa.
5
Ad esempio: quando usiamo una macchina da scrivere, il nostro rapporto, apparentemente
immediato, con questo oggetto è in realtà mediato da tutta una serie di nozioni e capacità operative,
precedentemente acquisite, che ci consentono appunto di utilizzarlo efficacemente come strumento.
Husserl, che è bensì consapevole del contenuto “culturale” (e quindi interpretativo) dei contenuti
dell'esperienza, si propone tuttavia di portarsi oltre tale livello, attingendo (v. riduzione fenomenologica)
l'aspetto eidetico dei fenomeni anche attraverso la valenza “culturale” implicita nell'uso pratico degli
oggetti.
3
E altrettanto dicasi delle leggi del pensiero logico, che non sono affatto strutture
eterne, immutabili, ma rappresentano a loro volta produzioni storiche interne a quello
sviluppo, funzioni particolarmente efficaci di adattamento (inteso nel senso visto all'inizio).
Ogni indagine sul mondo appare, di conseguenza, come espressione di un'attività volta
a “stabilizzare” il flusso dell'esperienza, organizzandolo, a fini operativi, secondo schemi
relativamente fissi; attività che non si limita dunque a conoscere gli oggetti, ma è l'operazione
tramite cui viene costituito il senso che gli oggetti hanno per noi. Ed è ancora un'indagine a
determinare la struttura dei criteri conoscitivi, cioè a definire i problemi e la prospettiva della
loro soluzione. In quanto “indagine dell'indagine”, la filosofia occupa un posto del tutto
speciale nell'organizzazione dell'attività umana.
Allo stesso tempo, comunque, viene a cadere ogni differenza qualitativa tra giudizi
scientifici, o filosofici, e convinzioni proprie del “senso comune”, trattandosi in ogni caso di
forme conoscitive, interpretative, aventi tutte il medesimo carattere di strumenti organizzativi
(cioè costitutivi) del rapporto tra l'uomo e la realtà. Va anche aggiunto che l'ambito in cui tali
strumenti operano non è (come spesso sembra intendere James) la sfera individuale, e in
definitiva biologica, bensì soprattutto la collettività sociale (il “noi” precede sempre l'“io”, e
ne costituisce la dimensione concreta).
Per questo lato il pensiero di Dewey, assai più di quanto accadeva per quello di James,
presenta qualche aspetto di consonanza con il marxismo, o addirittura con l'idealismo (ai quali
lo collegano anche la tesi dell'organicità del reale, o della complementarità “dialettica” di
soggetto ed oggetto).
D'altra parte la visione radicalmente empiristica di Dewey (non esiste altra realtà che
l'esperienza, ossia il movimento libero da schemi, problematico e spesso indefinito, del
divenire) fa del suo pensiero una punta avanzata della nuova organizzazione che va
assumendo il sapere scientifico; nella quale certi schemi teorici strutturalmente affini a quelli
di precedenti sistemi filosofici, vengono riproposti come progetti operativi provvisori, e
sempre assunti in funzione di ipotesi.
4