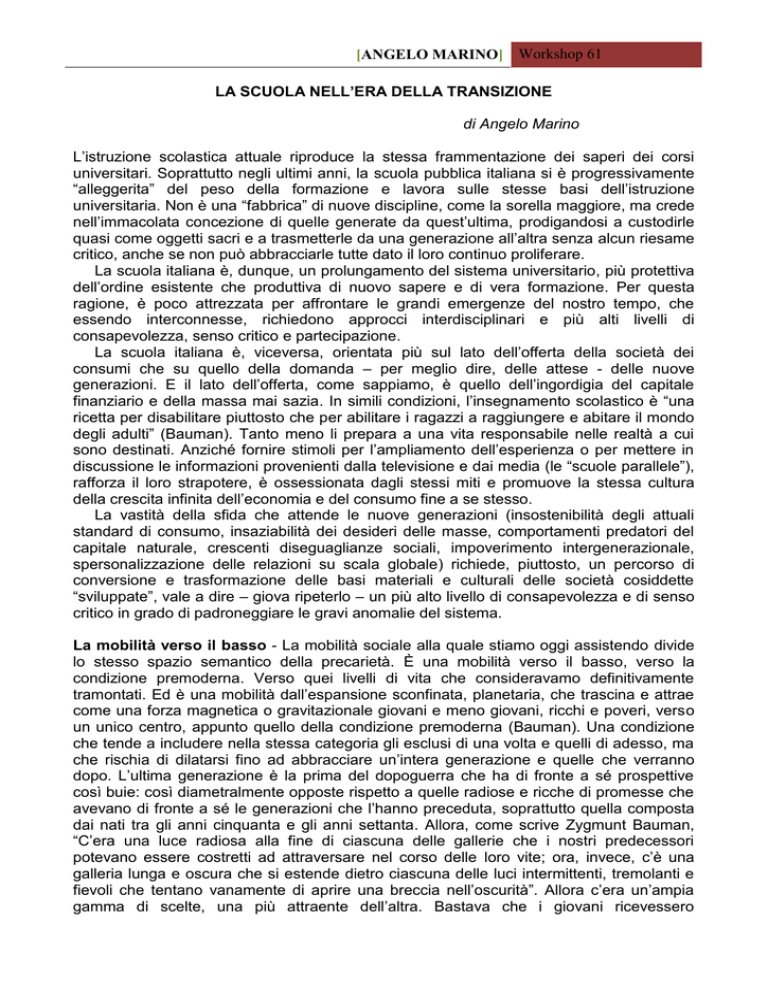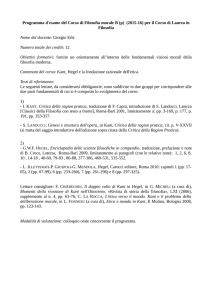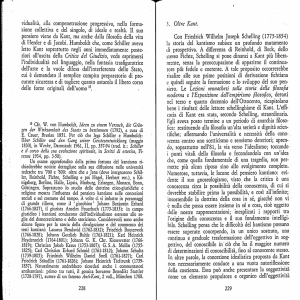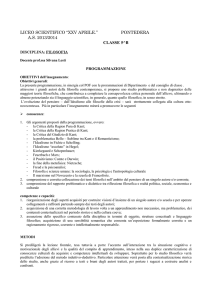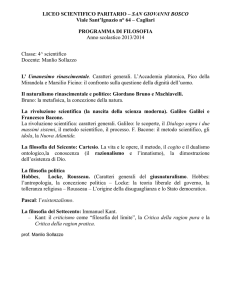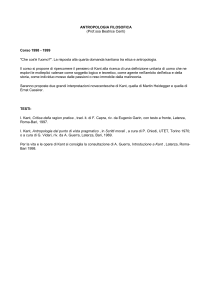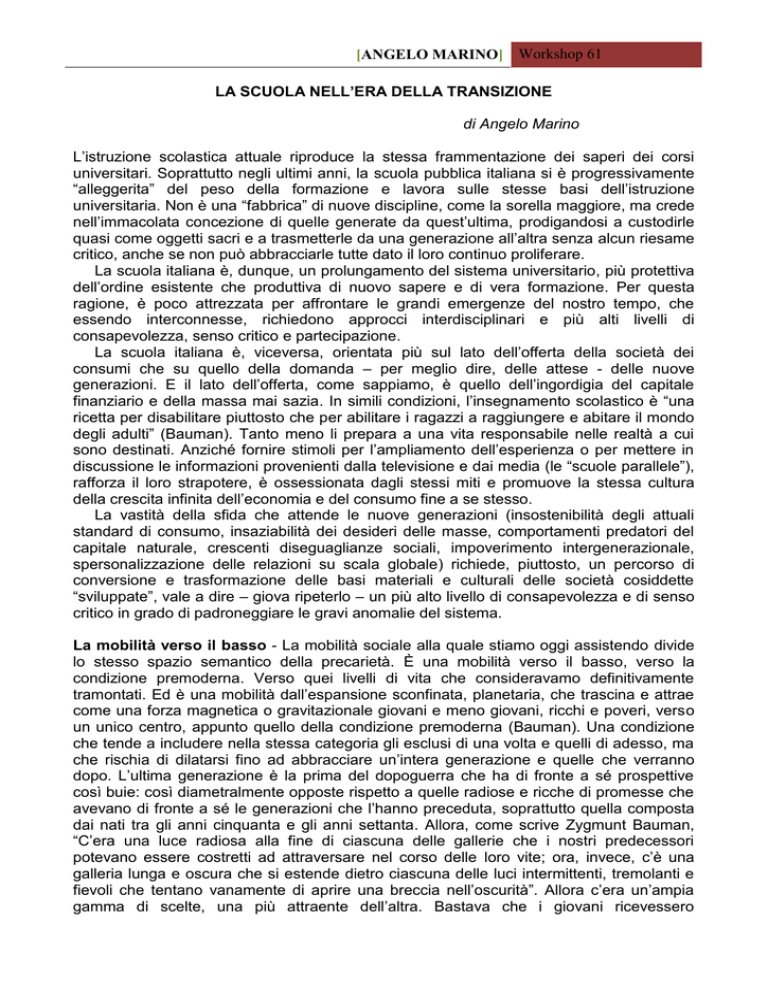
[ANGELO MARINO] Workshop 61
LA SCUOLA NELL’ERA DELLA TRANSIZIONE
di Angelo Marino
L’istruzione scolastica attuale riproduce la stessa frammentazione dei saperi dei corsi
universitari. Soprattutto negli ultimi anni, la scuola pubblica italiana si è progressivamente
“alleggerita” del peso della formazione e lavora sulle stesse basi dell’istruzione
universitaria. Non è una “fabbrica” di nuove discipline, come la sorella maggiore, ma crede
nell’immacolata concezione di quelle generate da quest’ultima, prodigandosi a custodirle
quasi come oggetti sacri e a trasmetterle da una generazione all’altra senza alcun riesame
critico, anche se non può abbracciarle tutte dato il loro continuo proliferare.
La scuola italiana è, dunque, un prolungamento del sistema universitario, più protettiva
dell’ordine esistente che produttiva di nuovo sapere e di vera formazione. Per questa
ragione, è poco attrezzata per affrontare le grandi emergenze del nostro tempo, che
essendo interconnesse, richiedono approcci interdisciplinari e più alti livelli di
consapevolezza, senso critico e partecipazione.
La scuola italiana è, viceversa, orientata più sul lato dell’offerta della società dei
consumi che su quello della domanda – per meglio dire, delle attese - delle nuove
generazioni. E il lato dell’offerta, come sappiamo, è quello dell’ingordigia del capitale
finanziario e della massa mai sazia. In simili condizioni, l’insegnamento scolastico è “una
ricetta per disabilitare piuttosto che per abilitare i ragazzi a raggiungere e abitare il mondo
degli adulti” (Bauman). Tanto meno li prepara a una vita responsabile nelle realtà a cui
sono destinati. Anziché fornire stimoli per l’ampliamento dell’esperienza o per mettere in
discussione le informazioni provenienti dalla televisione e dai media (le “scuole parallele”),
rafforza il loro strapotere, è ossessionata dagli stessi miti e promuove la stessa cultura
della crescita infinita dell’economia e del consumo fine a se stesso.
La vastità della sfida che attende le nuove generazioni (insostenibilità degli attuali
standard di consumo, insaziabilità dei desideri delle masse, comportamenti predatori del
capitale naturale, crescenti diseguaglianze sociali, impoverimento intergenerazionale,
spersonalizzazione delle relazioni su scala globale) richiede, piuttosto, un percorso di
conversione e trasformazione delle basi materiali e culturali delle società cosiddette
“sviluppate”, vale a dire – giova ripeterlo – un più alto livello di consapevolezza e di senso
critico in grado di padroneggiare le gravi anomalie del sistema.
La mobilità verso il basso - La mobilità sociale alla quale stiamo oggi assistendo divide
lo stesso spazio semantico della precarietà. È una mobilità verso il basso, verso la
condizione premoderna. Verso quei livelli di vita che consideravamo definitivamente
tramontati. Ed è una mobilità dall’espansione sconfinata, planetaria, che trascina e attrae
come una forza magnetica o gravitazionale giovani e meno giovani, ricchi e poveri, verso
un unico centro, appunto quello della condizione premoderna (Bauman). Una condizione
che tende a includere nella stessa categoria gli esclusi di una volta e quelli di adesso, ma
che rischia di dilatarsi fino ad abbracciare un’intera generazione e quelle che verranno
dopo. L’ultima generazione è la prima del dopoguerra che ha di fronte a sé prospettive
così buie: così diametralmente opposte rispetto a quelle radiose e ricche di promesse che
avevano di fronte a sé le generazioni che l’hanno preceduta, soprattutto quella composta
dai nati tra gli anni cinquanta e gli anni settanta. Allora, come scrive Zygmunt Bauman,
“C’era una luce radiosa alla fine di ciascuna delle gallerie che i nostri predecessori
potevano essere costretti ad attraversare nel corso delle loro vite; ora, invece, c’è una
galleria lunga e oscura che si estende dietro ciascuna delle luci intermittenti, tremolanti e
fievoli che tentano vanamente di aprire una breccia nell’oscurità”. Allora c’era un’ampia
gamma di scelte, una più attraente dell’altra. Bastava che i giovani ricevessero
[ANGELO MARINO] Workshop 61
un’istruzione adeguata, una qualsiasi laurea o diploma che li ponesse in una determinata
area professionale, per ottenere remunerazioni, successi e avanzamenti di carriera ancora
più alti dei loro genitori. La prospettiva di un mondo in espansione non è più nelle nostre
previsioni - perché non può esserlo nei fatti - né del futuro prossimo né del futuro remoto
(Bauman).
I ragazzi della generazione che adesso accede o spera di accedere al mondo del
lavoro sono stati istruiti o indottrinati dalla scuola - oltre che allevati e abituati dai loro
contesti familiari e sociali - a credere di poter ripetere la stessa storia dei loro genitori:
gratificazioni, successi e traguardi crescenti sulla falsariga della storia precedente.
L’istruzione scolastica e universitaria hanno fatto poco o nulla per prospettare loro un
quadro radicalmente cambiato rispetto a prima. “Non c’è stato nulla, osserva Bauman, che
abbia potuto prepararli all’arrivo del nuovo mondo duro, freddo e inospitale in cui i voti
hanno perso il loro valore, i meriti guadagnati si sono svalutati, le porte hanno finito di
schiudersi e si sono subito richiuse ed essi si sono trovati a vivere in un mondo di lavori
volatili e disoccupazione ostinata, di fugacità di prospettive e durevolezza di sconfitte, di
un nuovo mondo di progetti nati morti, di speranze frustrate e opportunità che brillano per
la loro assenza” (Bauman).
La scuola estraniata dai processi partecipativi e deliberativi - Già i dati osservabili due
decenni fa lasciavano prevedere questi esiti: davano il quadro di una società degradata,
offrivano “un campionario di segni più o meno chiari in cui il senso del nostro vivere
[andava] disfacendosi sotto gli assalti di forze sfuggite di mano alla cultura” (E. Turri). E
sono proprio le “forze sfuggite di mano alla cultura” che hanno prodotto la crisi attuale.
Alla caleidoscopica crescita delle specializzazioni accademiche ha continuato a fare da
reciproco l’incapacità della scuola di offrire formazione e di riconnettere i saperi
frammentati.
Se il difetto della “cultura togata” è quello di “generare” nuove discipline
(molto spesso per ragioni che non hanno niente a che fare con alcuna necessità
oggettiva), le inadempienze della scuola non sono meno gravi: infatti, oltre a legittimare e
perpetuare la frammentazione dei saperi, pone ad essi, da sempre, le stesse domande per
avere, sempre, le stesse risposte (dal canto loro i vari saperi articolati nelle varie discipline
curricolari non possono che dare le stesse risposte… se vengono loro rivolte le stesse
domande).
Questo circolo vizioso fra domande – sempre le stesse – e risposte – sempre uguali –
si giustificava nelle società relativamente statiche della pre-modernità, non più nella
società mondializzata della modernità e della post-modernità.
Porre nuove domande alle stesse fonti - La scuola come primo attore della
trasformazione – il luogo in cui si incrociano le generazioni e si elaborano i saperi – ha un
ruolo insostituibile da svolgere. Tanto più di fronte ai problemi posti dalla crisi attuale, la
cui gravità richiede, per farvi fronte, un grado di consapevolezza pari all’altezza delle sfide
che essa pone. L’imperativo di uscire dalla crisi, senza ripetere gli errori che l’hanno
generata, è lo stesso imperativo che ha la scuola di scegliere fra risposte vecchie,
frammentate e sempre uguali e risposte nuove, adeguate e dirompenti; fra risposte
“dormitive”, per usare un’espressione di Gregory Bateson – quelle che ha sempre dato – e
risposte all’altezza delle sfide attuali. Il solo modo di “aprire una breccia nell’oscurità” – e di
fare uscire la scuola dal ruolo subalterno alla politica, all’economia, all’informazione
massmediatica – è oggi quello di porre nuove domande alle stesse fonti, vale a dire alle
varie discipline curricolari. E, se le fonti non sono culturalmente attrezzate per rispondere
alle domande degli utenti della scuola, non sono le domande che devono cambiare, ma le
fonti. Detto altrimenti, non è chiudendosi negli “schematismi disciplinari”, come li chiamava
Lucio Gambi – o nelle “paratie” dei vari specialismi, come le chiamava Marc Bloch – che si
[ANGELO MARINO] Workshop 61
risolvono i problemi. Ma svecchiando e ammodernando quell’immenso “campo a riposo”
(l’espressione è ancora di Gambi) che è il sapere compartimentato, segmentato e
sedimentato nelle specializzazioni accademiche e nella programmazione scolastica.
L’immenso lavoro che attende la scuola - Quale immenso lavoro resta da fare per
capovolgere questa prospettiva (il sapere che nasce dai problemi, anziché i problemi dal
sapere), possiamo solo immaginarlo. È stato Carlo Cattaneo – è qui il caso di ricordarlo –
a sostenere per primo che la scienza è “utilità sociale” e che il sapere “non è strutturabile a
mo’ di trattazione sistematica o istituzionale, ma consiste solo in problemi: e l’unica
ragione del lavoro culturale sono i problemi che investono di volta in volta le diverse aree
della scienza”. Ma, aggiungeva Cattaneo, “quando una di queste aree vuole elevarsi a
istituzione, diventa una astrazione”. Nessuna di esse è scienza “se non aiuta a risolvere
dei problemi singoli o integrati fra loro”. E dunque la scienza non ha valore “quando
seziona o divide i problemi in tronchi, con diverse designazioni, e va sostituendo ad una
visione genetica o funzionale – cioè storica – della realtà, una panoramica invece
orizzontale”.
Spetta alla scuola investire “le diverse aree della scienza” di “utilità sociale”. Tradotto in
pratica didattica, questo vuol dire che gli insegnanti di ogni ordine e grado sono chiamati a
coordinare i loro sforzi in progetti formativi condivisi. Detto in termini ancora più chiari, è
giunto il momento di passare in rassegna, una dopo l’altra, tutte le discipline degli indirizzi
scolastici attualmente in vigore “con diverse designazioni” (italiano, storia, geografia,
economia, filosofia, chimica, fisica, biologia, diritto, arte, ecc.) e verificare se ciascuna di
esse “diventa un’astrazione”, perché “divide i problemi in tronchi”, oppure svolge – da sola
o integrandosi con le altre – una ”utilità sociale”.
Non è questa, ovviamente, la sede per svolgere, anche in modo sommario, un lavoro di
revisione critica dei contenuti delle varie discipline scolastiche per accertare il loro grado di
“utilità sociale”. Possiamo, tuttavia, tentare di suggerire il metodo comune al quale
attenersi, prendendone a casaccio una – la filosofia – a mo’ di esempio di disciplina
scolastica che, invece di “risolvere problemi”, dà “risposte dormitive”.
Le “risposte dormitive” della filosofia – Può sembrare paradossale, ma fra le discipline
scolastiche più inclini o corrive a dare risposte o “spiegazioni dormitive” – per riprendere
l’efficace formula di Bateson – è proprio la filosofia.
Per i motivi cui si è accennato sopra, riteniamo che sia giunto il momento di puntare su
questa disciplina riflettori più potenti, ed a più ampio spettro visivo, rispetto a quelli
normalmente adoperati dai compilatori di antologie e manuali scolastici.
Non essendo neanche questa la sede per una rassegna, sia pur parziale, del lungo
elenco di filosofi presenti nei manuali in uso nelle scuole, ci soffermiamo brevemente su
uno dei più celebrati: Immanuel Kant. Secondo Alexandre Kojéve, la filosofia moderna e
contemporanea, inaugurata da Bacone, Cartesio e Kant, altro non è che “un brusio simile
a quello prodotto dalle api nell’espletazione del loro ciclico lavoro stagionale”. Ma questa
filosofia ha fatto qualcosa di più: ha contribuito ad aprire una faglia gigantesca tra mondo
umano e mondo della natura, non meno di quanto hanno fatto la corporazione degli
scienziati, quella dei policymaker e quella degli economisti.
Kant è, secondo noi, tra i filosofi che hanno inaugurato la modernità quello che ha
contribuito, forse più dello stesso Cartesio, ad aprire o ad allargare questa faglia. Va detto
anzitutto che il filosofo tedesco, separando l’attività del pensiero nelle tre Critiche, è in un
certo senso l’antesignano della modernità come “età delle separazioni”: la separazione tra
sfera pubblica e sfera privata, tra attività produttiva e famiglia (Max Weber, com’è noto,
vide nella rottura dei legami familiari e affettivi l’atto costitutivo dell’economia moderna), tra
intenzione morale e ricadute effettive, tra lavoro e merce, ecc.
[ANGELO MARINO] Workshop 61
La tesi a sostegno della estraneità di Kant alla Rivoluzione industriale – e dunque a
giustificazione del fatto che egli non ne avverta la portata rivoluzionaria nei suoi scritti – è
che la Germania, come l’Italia, la Francia, la Scozia ecc., erano relegate ai margini del
nuovo ordine che si stava costruendo. L’epicentro della Rivoluzione industriale era la Gran
Bretagna. Ma questo non impediva a nessuno degli intellettuali più riflessivi - anche se
lontani dal centro (e Kant lo era) - di prevedere gli esiti a breve e a lungo termine della
“grande trasformazione”. Come fa osservare Bauman, “Vivere ai confini del centro della
civiltà significa stare abbastanza vicini da vedere le cose chiaramente, ma abbastanza
distanti da ‘oggettificarle’ e dunque fondere e condensare le percezioni in concetti”. Era
evidente che la dislocazione del lavoro dalla campagna alla città e l'apparizione della
fabbrica al centro del lavoro stesso – era quello che stava avvenendo con quella
rivoluzione – avrebbe modificato i rapporti fra gli attori produttivi, dato luogo alla nascita di
nuove classi sociali, a una profonda modificazione del concetto di tempo, ecc. Negli scritti
di Kant non si fa cenno a tutto questo. Manca la riflessione sulla totalità dei mutamenti in
atto: a cominciare da quella della “essenza umana” per effetto della separazione del lavoro
dalla sua fonte “naturale”, la terra, del lavoro tradotto negli opifici e “fatto a pezzi” nelle
catene di montaggio. Una trasformazione, questa, che investiva non solo i prestatori
d’opera, ma gli stessi datori di lavoro, ossia la società intera.
L’emancipazione della filosofia kantiana dagli “appigli celesti” della tradizione
metafisico-escatologica, le servì solo a ritagliarsi uno spazio neutro, una sorta di zona
franca escludente la totalità della visione, e a prendere le distanze dalla dialettica storica
che implicava l’analisi del presente e il presentimento del futuro.
Pur essendo pressoché coevo di Sadi-Nicolas Carnot (Kant: 1724-1804; Carnot: 17961832), autore di fondamentali studi sulla termodinamica, il filosofo di Königsberg non
avvertì che “les temps des craquements [scricchiolii]” erano arrivati anche per la
Germania. Se non altro perché le “macchine termiche” per alimentarsi avevano – come
hanno – bisogno di un flusso costante di energia fossile, e a fornirla erano allora
soprattutto i bacini carboniferi della Saar e della Ruhr. In una sua Memoria del 1824,
Carnot studiò per la prima volta l’economia delle macchine termiche – la scienza del fuoco
“tradotta e domata in officina” – facendo notare fra l’altro che, quando queste macchine
bruciano un pezzo di carbone o di legno, introducono nell’ambiente un processo entropico
irreversibile. Oggi sappiamo che l’energia passa nel ciclo produttivo una sola volta, o
perché si dilegua nei sistemi contigui (in natura non esistono sistemi chiusi) o perché si
degrada. Sappiamo anche – dagli studi più recenti condotti sulla falsariga di Carnot,
Clausius, ecc. – che il fuoco è una forza mobile, diffusiva e devastante, che tende a
dissolversi in direzioni diverse da quella gravitazionale, ma non prima di avere trasformato
in maniera irreversibile i corpi attraversati (ignis omnia mutat). Ma sappiamo altresì – e la
Memoria di Carnot lo spiega a chiare lettere – che ogni prelievo di materia ed energia è
“un fenomeno volumetrico sotterraneo”, che introduce processi lineari, unidirezionali e
irreversibili che nessuna scienza che si occupi del futuro può ignorare.
Gli scritti di Kant, lo ripetiamo, si collocano in un arco cronologico nel quale la
Germania rimase relativamente immune dall’impatto della Prima rivoluzione industriale
(1760-1830). Ma non al punto che non fosse possibile percepirne o intuirne – quanto
meno ai più riflessivi fra i testimoni dell’epoca – la portata rivoluzionaria su tutti i fronti della
vita organizzata precedenti.
Ora, è singolare che Kant, nonostante sia vissuto nel pieno di questa rivoluzione, non
abbia rivolto a questo evento epocale nella storia dell’umanità l’attenzione che meritava.
Risulta strano che per lui il tempo si fosse fermato alla geometria euclidea, sui cui
postulati, non dimentichiamolo, si fondava il giudizio sintetico a priori, e alla fisica
newtoniana, sui cui presupposti elaborava la teoria (gnoseologica) dell’io “legislatore
dell’universo”; che non abbia previsto ciò che era largamente prevedibile, e cioè che il
[ANGELO MARINO] Workshop 61
soggetto umano da lì in avanti non si sarebbe più limitato a contemplare l’universo – che
gli ruotava intorno “con tutto l’esercito degli astri” e delle cose inanimate – ma che lo
avrebbe dominato e trasformato, divenendo egli stesso il più potente agente geologico.
È altrettanto singolare che Kant non abbia previsto – nonostante la mole imponente di
studi in atto sulle strutture fisiche e termodinamiche dell’universo – gli effetti distruttivi
dell’azione umana sui processi naturali; il suo potenziale disgregativo degli ecosistemi; il
carattere irreversibile di questi processi; che non abbia avuto il lampo di intuizione
profetica di un Carnot di quali congegni sarebbero scattati in avanti nel futuro per effetto di
quella rivoluzione.
Ci sono malattie, aveva scritto Machiavelli più di due secoli prima, che “all’inizio del loro
manifestarsi sono facili a curare e difficili a conoscere, ma nel progresso del tempo, non
avendole in principio conosciute né medicate, diventano facili a conoscere e difficili da
curare”.
In un celebre passo della Critica della Ragion Pura, così Kant sintetizzava il suo
pensiero a proposito del dover essere naturale: “Nella natura, l’intelletto può conoscere
solo ciò che è, è stato o sarà. È impossibile che qualcosa debba essere altrimenti da ciò
che è stata di fatto nelle sue relazioni temporali: il dover essere, quando si guarda al corso
della natura, non ha il minimo significato. Non possiamo chiedere che cosa deve accadere
nella natura, come non possiamo cercare quali proprietà deve avere il circolo; ma soltanto
che cosa accade in quella, o quali proprietà questo possiede. Il dover essere esprime
soltanto un’azione possibile, il cui principio non è altro che un semplice concetto; mentre di
un’azione naturale il principio non può essere altro che un fenomeno”.
Nella citata Memoria del 1824, Riflessioni sulla potenza motrice del fuoco, Sadi-Nicolas
Carnot, formalizzando l’atto di nascita della termodinamica, mostrava cosa può accadere
“al corso della natura” con l’intervento dell’uomo, e dunque – restando nell’ambito
fenomenico – come fosse tutt’altro che “impossibile, come riteneva Kant, che qualcosa
debba essere altrimenti da ciò che è stata di fatto nelle sue relazioni temporali”. Oggi
sappiamo, viceversa, che l’attività economica innesca processi fluidodinamici a livello
molecolare – e dunque invisibile – che, oltre a produrre alta entropia, accelerano la
sequenza temporale degli eventi. Questo processo modifica la stessa visione circolare,
pendolare, ripetitiva della fisica classica “narrata” dalle sole forze fisiche (le traiettorie, la
posizione, le masse, ecc.), sulla quale il filosofo di Königsberg fondava quasi interamente
il suo sistema.
Due ere di transizione a confronto - Se è vero – com’è vero – che Kant modifica il
quadro concettuale della filosofia occidentale, è anche vero che le intuizioni di un Carnot,
di un Clausius, di un Boltzmann, ecc. modificano il quadro epistemologico dell’intera
costellazione delle scienze della terra, e dunque della stessa filosofia come “pensiero della
totalità”. Ciò che viene alla luce dai loro studi è che l’universo non è solo un plenum
uniforme di corpi macroscopici – un “unicum assoluto”, come Newton aveva creduto e
Kant continuava a credere – ma un macrosistema che si evolve in maniera irreversibile
sotto l’azione di forze latenti (termodinamiche, geochimiche e biofisiologiche) fino ad allora
mai indagate dalla cosiddetta “scienza normale”.
Un lavoro teorico e sperimentale altrettanto importante veniva svolto intorno a quegli
anni in altri campi del sapere e delle scienze applicate: elettricità, magnetismo terrestre,
scienze matematiche e geometriche (la scoperta delle geometrie non-euclidee).
Lavorando in modo sistemico – sovente cooperativo – nell’interfaccia delle problematiche
emerse di volta in volta, questi studiosi hanno mostrato l’”altra faccia” dell’universo e
aperto orizzonti inediti alla ricerca. Con le loro scoperte le nuove frontiere dell’umanità
erano decisamente segnate. Questi studiosi applicavano per la prima volta la teoria dei
[ANGELO MARINO] Workshop 61
sistemi, rivolgendo l’attenzione all’insieme e rompendo le croste delle specializzazioni.
Vivevano, come noi adesso, un’era di transizione di cui erano pienamente consapevoli.
Se Kant avesse avuto sentore dei “contenuti in mutamento” della scienza del suo
tempo e guardato la terra da una prospettiva meno distante, avremmo forse un filosofo in
meno o, in alternativa, una filosofia meno astratta e più in sintonia con i tempi, piuttosto
che una filosofia chiusa nei suoi recinti concettuali che guarda la terra “come una sfera
silenziosamente immersa in una sua pacifica, ‘oziosa’ dimensione temporale, ferma e
come sospesa nel lento pulsare geologico” (Turri).
Riassumendo. L’accusa di essere un pensiero ripiegato su se stesso e centrato sui
propri obiettivi specifici, non è un’accusa da rivolgere soltanto alla filosofia. Le scienze
umane e naturali, che costituiscono l’intelaiatura dei programmi scolastici, offrono un vasto
campionario di “spiegazioni dormitive” alle domande che esulano dai loro recinti d’indagine
settoriale. Ripetono verità diventate vuote e trite.
La frenetica attività di estrazione ed emissione cui abbiamo sottoposto gli ecosistemi
terrestri, a partire dalla “prima era di transizione” – la Rivoluzione industriale, appunto –
non ha cambiato la sostanza fisica del mondo. In natura, infatti, nulla si crea a nulla si
distrugge (prima legge della termodinamica). Ad essere cambiato nella nostra biosfera è
“l’insieme delle funzioni che si oppongono alla morte” (Bichat); è "il grumo denso di
disordine" che vi abbiamo introdotto dislocandolo dalla logica del profitto ai nostri ambienti
di vita. Come scriveva il grande economista e filosofo rumeno Georgescu-Roegen, “Il
destino ultimo dell’universo non è la morte per calore, come si credeva un tempo, ma una
condizione ancora più tremenda: il caos”.
Certo è che, se poniamo interrogazioni sulle origini della crisi attuale (riscaldamento
climatico, desertificazioni, inquinamento, impoverimento delle risorse energetiche,
spersonalizzazione delle relazioni globali, ecc.), la filosofia di Kant resta muta. Queste
domande dobbiamo rivolgerle – certi di avere una risposta – ai resoconti dei suoi
contemporanei (o giù di lì) assai meno famosi di lui: Fourier, Carnot, Clausius, lord Kelvin,
Helmholtz, Boltzmann.