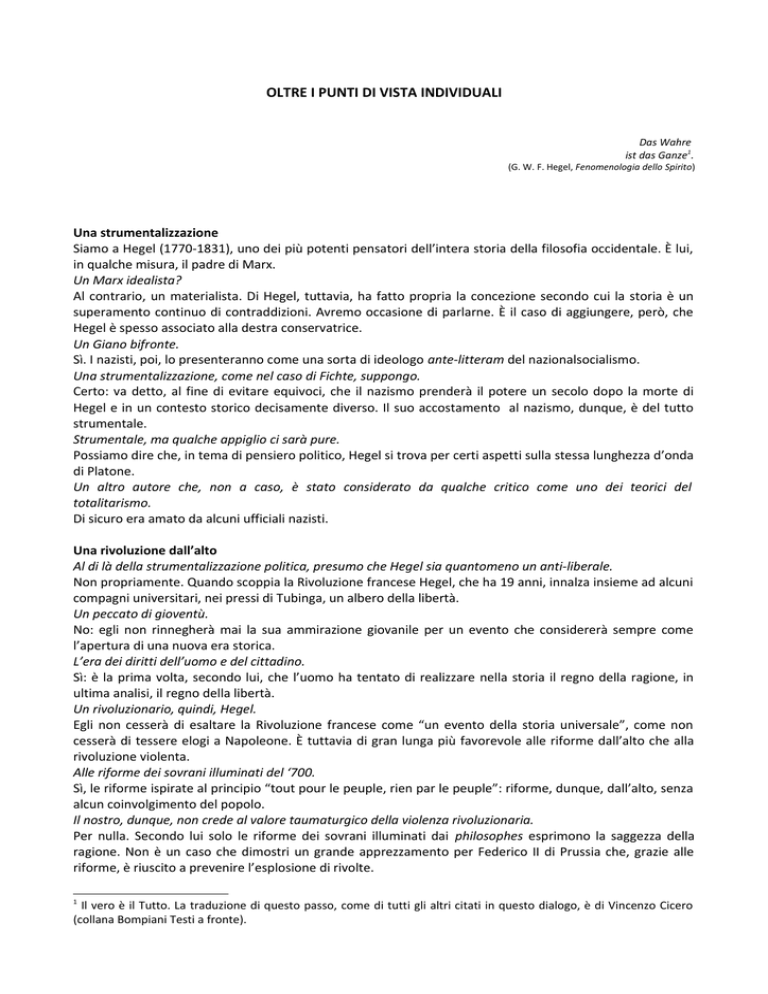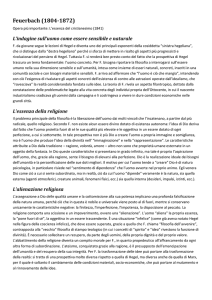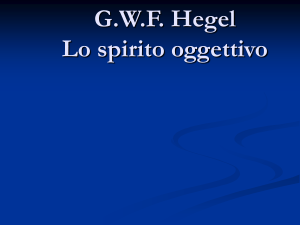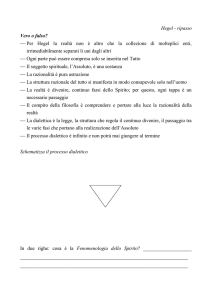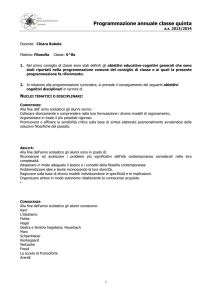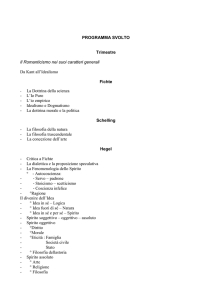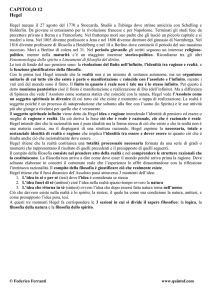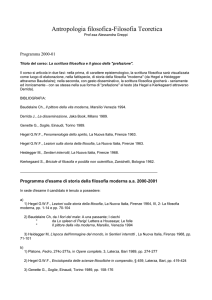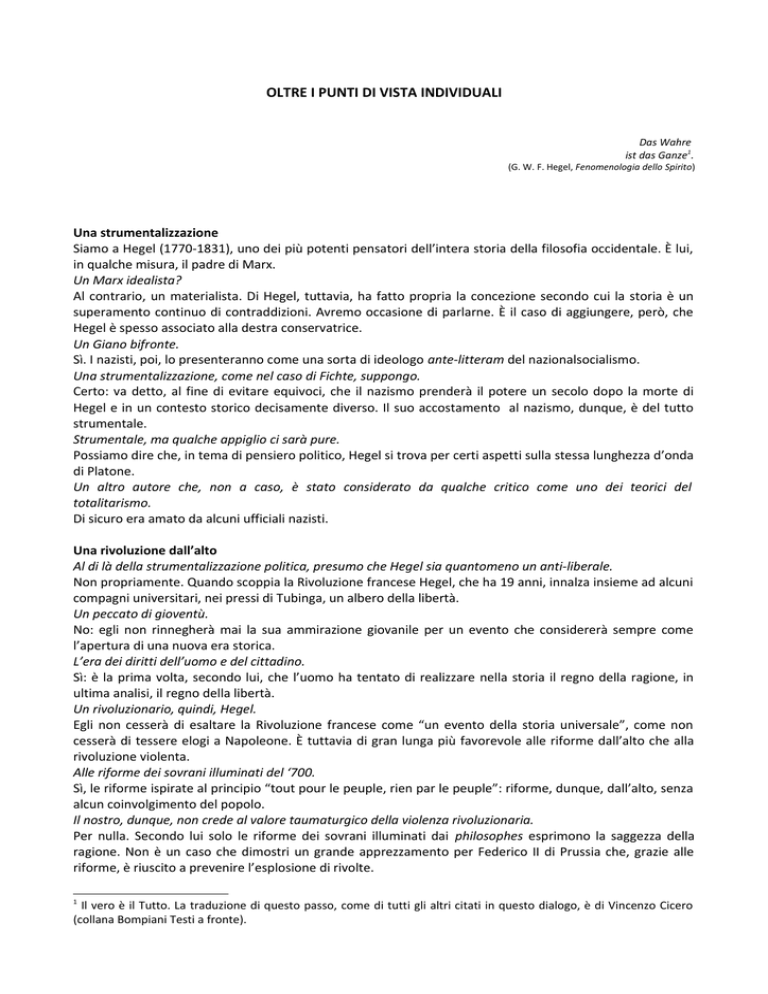
OLTRE I PUNTI DI VISTA INDIVIDUALI
Das Wahre
ist das Ganze1.
(G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito)
Una strumentalizzazione
Siamo a Hegel (1770-1831), uno dei più potenti pensatori dell’intera storia della filosofia occidentale. È lui,
in qualche misura, il padre di Marx.
Un Marx idealista?
Al contrario, un materialista. Di Hegel, tuttavia, ha fatto propria la concezione secondo cui la storia è un
superamento continuo di contraddizioni. Avremo occasione di parlarne. È il caso di aggiungere, però, che
Hegel è spesso associato alla destra conservatrice.
Un Giano bifronte.
Sì. I nazisti, poi, lo presenteranno come una sorta di ideologo ante-litteram del nazionalsocialismo.
Una strumentalizzazione, come nel caso di Fichte, suppongo.
Certo: va detto, al fine di evitare equivoci, che il nazismo prenderà il potere un secolo dopo la morte di
Hegel e in un contesto storico decisamente diverso. Il suo accostamento al nazismo, dunque, è del tutto
strumentale.
Strumentale, ma qualche appiglio ci sarà pure.
Possiamo dire che, in tema di pensiero politico, Hegel si trova per certi aspetti sulla stessa lunghezza d’onda
di Platone.
Un altro autore che, non a caso, è stato considerato da qualche critico come uno dei teorici del
totalitarismo.
Di sicuro era amato da alcuni ufficiali nazisti.
Una rivoluzione dall’alto
Al di là della strumentalizzazione politica, presumo che Hegel sia quantomeno un anti-liberale.
Non propriamente. Quando scoppia la Rivoluzione francese Hegel, che ha 19 anni, innalza insieme ad alcuni
compagni universitari, nei pressi di Tubinga, un albero della libertà.
Un peccato di gioventù.
No: egli non rinnegherà mai la sua ammirazione giovanile per un evento che considererà sempre come
l’apertura di una nuova era storica.
L’era dei diritti dell’uomo e del cittadino.
Sì: è la prima volta, secondo lui, che l’uomo ha tentato di realizzare nella storia il regno della ragione, in
ultima analisi, il regno della libertà.
Un rivoluzionario, quindi, Hegel.
Egli non cesserà di esaltare la Rivoluzione francese come “un evento della storia universale”, come non
cesserà di tessere elogi a Napoleone. È tuttavia di gran lunga più favorevole alle riforme dall’alto che alla
rivoluzione violenta.
Alle riforme dei sovrani illuminati del ‘700.
Sì, le riforme ispirate al principio “tout pour le peuple, rien par le peuple”: riforme, dunque, dall’alto, senza
alcun coinvolgimento del popolo.
Il nostro, dunque, non crede al valore taumaturgico della violenza rivoluzionaria.
Per nulla. Secondo lui solo le riforme dei sovrani illuminati dai philosophes esprimono la saggezza della
ragione. Non è un caso che dimostri un grande apprezzamento per Federico II di Prussia che, grazie alle
riforme, è riuscito a prevenire l’esplosione di rivolte.
1
Il vero è il Tutto. La traduzione di questo passo, come di tutti gli altri citati in questo dialogo, è di Vincenzo Cicero
(collana Bompiani Testi a fronte).
Dà, dunque, una valenza negativa alla rivolta.
Sì, nelle rivolte vede solo anarchia, irrazionalità. Egli non ha dubbi che la vera rivoluzione si realizzi tramite
le leggi, la razionalità delle istituzioni, non nelle sommosse: queste, anzi, scoppiano proprio quando i
governi non sono rivoluzionari.
La Rivoluzione francese, però, ha saputo codificare in principi legislativi alcuni fondamentali valori razionali.
Sì, perché la Rivoluzione francese aveva alle spalle i lumi della ragione dell’Illuminismo. Possiamo dire che
con tale rivoluzione la ragione è andata al potere.
È andata al potere contro un monarca che non sapeva o non voleva attuare le riforme tese a sopprimere
privilegi e ingiustizie.
Certamente. In Francia è scoppiata la rivoluzione perché Luigi XVI rimaneva sostanzialmente sordo alle
istanze “razionali” avanzate dai philosophes.
Hegel, quindi, riconosce, anche se in casi estremi, la funzione positiva della violenza rivoluzionaria.
È vero. In questo è in sintonia col machiavellismo: il fine giustifica i mezzi. Non per nulla sottolinea non solo
la grandezza di un contemporaneo quale Napoleone, ma anche di grandi personaggi storici come
Alessandro Magno, Giulio Cesare e, in Inghilterra, Cromwell.
Il prezzo da pagare
Giustifica quindi anche le guerre.
Certo, se queste sono finalizzate a diffondere nel mondo valori e istituzioni razionali.
Alla stregua di chi nel nostro tempo punta a esportare la democrazia con la forza.
Hegel sa bene quanta sofferenza - in termini di morti e feriti – genera una guerra, ma è convinto che tutto
questo sia il prezzo da pagare se si vuole far avanzare nel mondo il regno della ragione (o, ancor prima,
realizzare l’unità di una nazione contro i particolarismi locali).
Quindi anche la morte di milioni di innocenti.
Senza dubbio. Condannare le guerre per il dolore che provocano, secondo lui, è tipico dei moralisti che non
sanno guardare ai “risultati”: sono questi che conferiscono un valore positivo ai “mezzi”. È in questa ottica
che Hegel parla di “Astuzia della Ragione”, della Ragione cioè che è tanto astuta da utilizzare la sete di
gloria e di dominio di alcune personalità storiche (da Alessandro Magno a Napoleone) come uno strumento
per diffondere nel mondo la razionalità. Una Provvidenza a fin di bene: è grazie a Giulio Cesare che si sono
diffusi valori e istituzioni romane di gran lunga più razionali dei costumi dei barbari.
È un Hegel che mi sconcerta.
È un pensatore che cerca di dare un “senso” alla storia.
Sulla scia di S. Agostino.
Sì, anche per S. Agostino la tragedia vissuta dall’impero romano con il saccheggio di Roma del 410 ad opera
dei Goti di Alarico, vista alla luce dei “risultati” che ci saranno, assume un valore positivo.
La preziosa eredità del cristianesimo
S. Agostino, però, ha un punto di vista opposto a quello di Hegel: è il cristianesimo, secondo lui, che
rappresenta i valori più alti rispetto a quelli dell’impero romano.
Sicuramente, ma è lo stesso Hegel che esalta i valori cristiani: i valori razionali espressi dai “Diritti dell’uomo
e del cittadino” della Rivoluzione francese contro i privilegi di casta, infatti, altro non sono che un’eredità
cristiana.
Ma il cristianesimo è una religione, una “fede” che, in quanto tale, non ha l’evidenza della ragione.
È vero, ma il messaggio di Gesù Cristo è rivoluzionario. È il cristianesimo che esalta la dignità infinita di ogni
singolo uomo: “l’individuo in quanto tale ha un valore infinito” (das Individuum als solches einen
unendlichen Wert hat). Un valore che viene rafforzato dalla lettura luterana (pensiamo al primato della
coscienza) e dallo stesso Kant che vede nell’uomo, in ogni singolo uomo, un “fine”.
Il liberalismo, quindi, è erede del cristianesimo.
Sì, quel liberalismo di cui si appropriano alcuni degli esponenti di primo piano dell’Illuminismo francese e
che confluisce nella celebre Dichiarazione del 1789.
Siamo in presenza di diritti individuali che Hegel considera conquiste definitive.
Certo. Hegel prende tuttavia le distanze dall’impostazione di Locke: secondo lui non si tratta di diritti
“naturali” in quanto nello stato di natura non ci sono diritti.
Perché l’uomo – rubo la formula di Hobbes - è un lupo per l’altro uomo.
Sì, se si intende lo stato di natura lo stato in cui non c’è ancora una società organizzata, siamo in presenza
del regno della violenza, della sopraffazione.
Uno stato da cui è necessario uscire costruendo lo Stato con le sue leggi e con i suoi organi di prevenzione e
di repressione dei reati.
Sicuramente: è appunto lo Stato che stabilisce ciò che è “giusto” e ciò che è “ingiusto”, ciò che è permesso
fare e ciò che invece è reato.
Non esiste, dunque, un diritto “naturale”, ma solo un “diritto positivo”.
È così: il diritto è tale in quanto viene convenzionalmente stabilito dallo Stato, proprio in sintonia con
Hobbes.
Ma in questo modo crolla il giusnaturalismo con conseguenze disastrose: non si può più giudicare “ingiusta”
una legge perché viola il diritto naturale.
Senza dubbio. Hegel di fatto rovescia la logica del giusnaturalismo secondo cui una legge non è tale se non
è giusta, se cioè non è conforme al diritto naturale: una legge è giusta proprio perché è una legge.
Ma in questo modo giustifica anche le leggi più aberranti.
Il principio hegeliano secondo cui “ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale ( was vernünftig
ist, das ist wirklich; was wirklich ist, das ist vernünftig)” sembra confermare la tua interpretazione, ma Hegel
non arriva a tanto: secondo lui una legge può avere dei contenuti irrazionali, ma finché è legge, deve essere
rispettata.
Una convinzione anche di Spinoza.
Sì, ma Hegel sottolinea il fatto che in qualsiasi legge c’è, comunque, più ragione di quanto ve ne sia nel
punto di vista soggettivo di chi assume il ruolo di critico della legge.
Spinoza, al contrario, invita il critico a darsi da fare perché convinca gli organi competenti a modificare o ad
annullare la legge oggetto di critica.
Spinoza è un liberale ed esalta la libertà di pensiero, inclusa la libertà di critica. Hegel, invece, è
preoccupato per i possibili effetti negativi di tale libertà.
La patria dei privilegi spacciati per diritti
Vedo una grande incoerenza: Hegel da un lato esalta i diritti individuali sanciti dalla Rivoluzione francese,
considerandoli una grande eredità del cristianesimo, dall’altra ha paura delle conseguenze.
Hegel non nasconde la sua diffidenza nei confronti del liberalismo inglese. Quello che ha di fronte - è il suo
punto di vista - è solo un’esplosione di individualità, di privilegi piccoli o grandi. Lo stesso parlamento
inglese, secondo lui, altro non è che la cassa di risonanza di tanti interessi di parte. L’Inghilterra - egli non ha
dubbi - non è la patria dei diritti, ma dei privilegi spacciati per diritti (anche il privilegio dei proprietari di
cacciare via dalle loro terre decine di contadini). Hegel, facendo riferimento alle leggi inglesi, arriva a
parlare di un “mucchio di letame di diritti privati”. Ecco perché le leggi inglesi non hanno nulla della
razionalità che caratterizza, ad esempio, il Codice Federiciano del 1794, il capolavoro giuridico di Federico II
di Prussia.
Hegel non è contro il liberalismo, ma è convinto che si debba andare oltre. Ecco perché smonta la
concezione contrattualistica dello Stato tipica della tradizione liberale.
Perché storicamente gli Stati non sono sorti in seguito a contratti sociali.
Non è tanto questa la ragione: secondo Hegel è la stessa idea di contratto sociale che va respinta perché è
uno strumento del tutto inadeguato a fondare lo Stato. Se questo, infatti, avesse come fondamento un
contratto, sarebbe in balia di una miriade di volontà individuali, come il parlamento inglese è in balia di
interessi di parte, interessi che variano tra l’altro a seconda delle maggioranze politiche e in balia della
stessa arte oratoria dei parlamentari. Le leggi dello Stato non possono essere il risultato di una sorta di
assalto alla diligenza, ma devono ispirarsi a principi razionali.
Devono cadere, allora, dall’alto.
Già, proprio perché devono esprimere l’interesse generale e non la sommatoria degli interessi particolari, le
leggi devono essere dettate dalla saggezza.
Torniamo a Platone, allo Stato retto dai sapienti.
I philosophes dell’Illuminismo: sono loro che “illuminano” con i lumi della ragione i sovrani.
La libertà autentica
Hegel critica gli effetti negativi del liberalismo inglese, ma poi non costruisce un modello alternativo.
Non è proprio così. Egli è dell’avviso che i diritti individuali vadano “conservati”, ma nello stesso tempo
“superati”.
Ma andare oltre il liberalismo è altamente rischioso: il pericolo è quello di scivolare nel totalitarismo.
Il nostro non intende per nulla giungere a tale approdo. Egli infatti ritiene compatibili sia le istanze
dell’individuo che quelle della collettività, sia i diritti individuali che l’interesse generale dello Stato.
Ma questa è già la funzione dello Stato liberale.
No: Hegel punta ad andare oltre lo Stato liberale. Secondo lui, contrariamente a quanto sostengono il
giusnaturalismo e il liberalismo, l’individuo non esiste prima dello Stato: è il tutto – nel linguaggio hegeliano
– che viene prima delle parti.
L’individuo, dunque, è subordinato alla “volontà generale” dello Stato.
Sì, in questo è perfettamente in sintonia con Rousseau: è nella conformità alla “volontà generale” che
l’individuo acquista l’autentica libertà.
La libertà dall’egoismo, dagli interessi di parte, di cui parla anche Fichte.
Senza dubbio. Finché l’individuo insegue i suoi interessi egoistici, il suo utile privato, non riesce a sollevarsi
al punto di vista dell’interesse generale: di conseguenza non è davvero libero, ma schiavo.
Un fascino irresistibile
Ma di questo passo Hegel arriva a giustificare qualsiasi forma di totalitarismo: l’individuo, proprio per il
valore infinito che lo stesso Hegel gli riconosce, viene sempre prima dello Stato.
Sì, ma il punto di vista della totalità prevale su quello della singola parte. Hegel, fin da studente, è
affascinato dalla pόlis greca, una comunità in cui l’individuo è strettamente fuso con la collettività, in cui la
stessa religione non è privata, ma pubblica.
Un modello di comunità in cui l’individuo non ha alcun diritto: il “caso Socrate” docet.
La pόlis greca, è vero, non riconosce i diritti individuali che sono una conquista prima cristiana, poi del
liberalismo, dell’Illuminismo e, infine, di Kant: la pόlis rappresenta l’unità di “individuo” e “comunità”, di
“parte” e di “tutto”, mentre l’esplosione dei diritti individuali si traduce in una “scissione” che, secondo
Hegel, va superata.
Tornando al modello della pόlis greca.
No, non si tratta di tornare tout court indietro, ma di andare avanti costruendo uno Stato in cui i diritti
individuali non sono annullati, ma salvaguardati. È questo il concetto hegeliano di “Aufhebung” che indica
sia l’atto del “superare” che quello del “conservare”.
Continuo a pensare che questa sintesi sia già operata dallo Stato liberale o da quello che oggi è lo Stato
liberal-democratico.
Non è così perché nello Stato liberale e, ancora di più in quello liberal-democratico il cui potere viene dal
basso, le leggi sono il risultato della sommatoria di interessi particolari.
La celebre “volonté de tous” di Rousseau.
Sì, “volonté de tous” che è altra cosa rispetto alla “volonté générale” di Rousseau.
Ma la distinzione è solo teorica: una legge è sempre espressione di una maggioranza che giunge a una
mediazione di interessi particolari delle sue componenti.
Ma tu ragioni dal punto di vista dello Stato liberale e di uno Stato liberal-democratico che hanno come
perno il parlamento. Ora un organo come questo non può che essere la cassa di risonanza degli interessi di
parte degli elettori. È proprio quello che Hegel rifiuta: lo Stato, perché sia davvero uno Stato e non
semplicemente l’espressione della società civile, deve essere superiore agli interessi di individui o di ceti
sociali.
Questo è ciò che realizza la mediazione politica quando questa vola alto.
Può volare alto, ma una mediazione è pur sempre un compromesso di interessi o, comunque, di punti di
vista individuali o corporativi. Ecco perché Hegel è convinto che solo un monarca, che non deve rispondere
a nessuno perché non è stato eletto da nessuno, può rappresentare l’interesse generale, quella che
Rousseau chiama “volonté générale”.
Ma non è affatto scontato che un monarca sia illuminato: la storia è ricca di esempi di sovrani tutt’altro che
saggi e tutt’altro che al di sopra delle parti.
È vero. Hegel lo sa bene. Il suo modello, infatti, non è la monarchia assoluta, ma la monarchia costituzionale
con tanto di distinzione dei poteri: governativo, legislativo e del sovrano.
Ma allora ricadiamo nella tanto disprezzata tradizione inglese.
I poteri sono sì distinti, ma l’unità dello Stato è garantita dal sovrano.
Lo spirito di un popolo
Ma questo vale anche per la Gran Bretagna.
No, Hegel è molto distante dal modello inglese. In primo luogo perché lo Stato, secondo lui, non si fonda su
una costituzione che è il risultato di un “contratto” tra individui. Hegel, come abbiamo già visto, rifiuta la
concezione contrattualistica dello Stato tipica della tradizione liberale, concezione che applica in modo
indebito a ciò che è pubblico categorie del diritto privato (tra l’altro, un contratto privato può essere come
può non essere stipulato). Lo Stato, di conseguenza, non risponde né a individui, né a punti di vista
particolari. Il nostro è dell’avviso che lo Stato non sia che l’incarnazione dello spirito di un popolo.
Un concetto - il popolo - particolarmente sottolineato da Rousseau e da Fichte.
Sì, un concetto che diventa un Leitmotiv del Romanticismo. Ogni popolo ha un suo spirito, una sua anima
fatta di tradizioni, di lingua, di religione, di istituzioni… È qui che troviamo la vera “morale” di un popolo.
Morale nel senso che riflette i “costumi” di un popolo.
Sì. È ciò che Hegel chiama col nome di “Sittlichkeit” (eticità), termine che deriva da “Sitte” che significa
“costume”.
Siamo lontani dal concetto kantiano di morale.
È vero: qui non siamo in presenza di una morale “soggettiva” (che Hegel chiama “moralità”), ma
“oggettiva”, una morale che diventa costume, tradizione, istituzioni e valori che vengono trasmessi alle
generazioni successive. La costituzione di uno Stato, dunque, non è il frutto di un “contratto” che è
accaduto storicamente in un determinato momento storico, ma il risultato della vita di un popolo.
Vita intesa come patrimonio spirituale di un popolo.
È proprio così: ecco perché Hegel parla di “spirito” di un popolo. Non siamo in presenza di norme astratte
come l’imperativo categorico di Kant, ma di valori storicamente incarnati in istituzioni… È ciò che Hegel
definisce “Spirito oggettivo”, Spirito cioè che si è concretamente realizzato.
Spirito che plasma la vita degli individui.
Sì, non sono quindi gli “individui” che danno forma allo Stato, ma è lo Stato, incarnazione dello spirito di un
popolo, che forma gli individui. Ecco, allora, la centralità del “tutto” rispetto alla “parte”, del “popolo”
rispetto all’“individuo”. Siamo davvero agli antipodi di uno Stato liberale.
Ma siamo anche di fronte a una retromarcia di Hegel: egli in questo sacralizza lo status quo, la tradizione,
giusto in sintonia con lo spirito della Restaurazione.
In sintonia con lo stesso Fichte: vedi i suoi celebri “Discorsi alla nazione tedesca”.
Fichte, però, invita ad agire, a trascendere sempre lo status quo, in altre parole, è proiettato verso il futuro,
mentre Hegel non fa che rimanere nel solco della tradizione perché è in questa lo spirito di un popolo.
È indubbio che tutto questo possa dare l’immagine di un ideologo della Restaurazione. Si tratta, però, di
un’immagine che fraintende il pensiero politico complessivo di Hegel. Questi non rinnega per nulla - lo
stiamo rimarcando da un po’ - la tradizione cristiano-liberale che esalta i diritti individuali. Non rinnega
quindi il grande lascito della Rivoluzione francese. Ecco perché è fuorviante dipingerlo come un pensatore
reazionario. Anche Fichte enfatizza la grande tradizione del popolo tedesco, ma non per questo è nostalgico
di un passato fatto di privilegi, di ingiustizie e di gerarchie sociali. Al contrario.
Non riesco, però, a vedere come riesca Hegel a sintetizzare due aspetti così diversi.
Hai parlato di sintesi. E infatti lo Stato hegeliano è una grande sintesi, la più alta.
Una sintesi di che cosa?
Di “famiglia” e di “società civile”. Lo Stato (sintesi) è una sorta di ritorno all’“unità” della famiglia (tesi),
conservando tuttavia i valori della “scissione” (l’antitesi).
L’esplosione degli interessi privati
I diritti individuali.
Sì, ma non solo. La famiglia – non c’è dubbio – incarna l’unità, addirittura la fusione, una fusione che nel
matrimonio fa dei due coniugi una vera e propria unità. Una unità che si esprime non soltanto tramite il
rapporto sessuale, ma anche e soprattutto attraverso il sentimento dell’amore, un sentimento che permea
tutto, il rapporto tra i coniugi e quello tra genitori e figli.
Naturalmente, nella famiglia non esistono rivendicazioni individuali.
Diciamo che le esigenze individuali sono subordinate a quelle della famiglia: sono l’amore e la fiducia che
fanno da collante tra i componenti.
I figli, una volta cresciuti, però, se ne vanno per loro conto e la famiglia si spezza.
È così: i figli formano a loro volta altre famiglie, ognuna delle quali, naturalmente, ha a cuore i propri
interessi. Inizia così la “scissione” dell’unità che si esprime, in prima istanza, nella sfera economica.
Una sfera in cui ognuno punta al suo utile: sia chi produce sia chi consuma, sia chi vende sia chi compra.
Infatti: è proprio nei rapporti economici che si ha la massima esplosione degli interessi privati. Qui l’amore
che unisce non c’è, ma c’è solo ciò che divide. C’è però da aggiungere che il lavoro ha un carattere sociale e,
di conseguenza, mette tra loro in contatto gli individui. Hegel, poi, fa propria l’idea del padre dell’economia
classica, Adam Smith: ognuno, è vero, nella sfera economica pensa al proprio tornaconto, ma il risultato
complessivo è di fatto un utile generale.
Ma lo scontro tra interessi genera conflitti, non vantaggi reciproci.
Pensa alla divisione del lavoro: ognuno lavora per il suo interesse, ma di fatto il suo lavoro ha come risultato
il soddisfacimento dei bisogni degli altri. La divisione del lavoro, in altre parole, divide, frantuma, ma nello
stesso tempo crea interdipendenza.
Stiamo parlando della “società civile”.
Sì, quella che Hegel chiama “bürgerliche Gesellschaft” che rappresenta l’antitesi della famiglia, la sfera cioè
della frantumazione, della dispersione, della contrapposizione di interessi privati, ma anche
dell’interdipendenza che scaturisce proprio dalla divisione del lavoro: nel momento in cui ci si specializza
nel lavoro, ognuno ha bisogno degli altri. Ma la società civile non si riduce a quello che Hegel definisce
“sistema dei bisogni”, ma coinvolge anche l’amministrazione della giustizia e quella che il nostro chiama
“Polizia” (Polizei), vale a dire l’insieme degli interventi a favore di chi, nella lotta economica, soccombe.
Ma questo rientra nella sfera di competenza dello Stato.
Dello Stato liberale, ma non dello Stato come lo concepisce Hegel, un’entità che è di gran lunga superiore
alla “Stato di diritto” della tradizione liberale. I giudici risolvono le controversie tra individui facendo
riferimento alle leggi che esprimono di per sé l’interesse generale. Sono queste leggi, infatti, che sanciscono
i diritti universali conquistati dalla Rivoluzione francese.
Nell’amministrazione della giustizia, quindi, si va oltre gli interessi privati.
Senz’altro.
Nella società civile Hegel include anche le “corporazioni”.
Che rappresentano, naturalmente, interessi corporativi.
Hegel vede in essi una valenza positiva: le corporazioni sono associazioni di mestiere che, in quanto tali,
esprimono una mediazione di interessi dei singoli componenti e all’interno delle quali concreta è la
solidarietà reciproca nei momenti di difficoltà.
Sono le corporazioni che, in nuce, rivelano quella mediazione tra “particolare” e “universale” che ha la sua
espressione più elevata nello Stato. Lo Stato recupera lo spirito unitario della famiglia (è di fatto una
famiglia in grande), e nello stesso tempo non rinnega, ma anzi porta a un livello superiore, la pluralità degli
interessi privati che emerge nella società civile. Lo Stato, in quanto risultato dello spirito di un popolo,
recupera tutto e fa di tanti individui una unità, un’unità che in qualche misura è già in parte preparata
dall’amministrazione della giustizia e dalle corporazioni. Ecco perché Hegel sottolinea con forza il ruolo
unificante del monarca.
La “volontà divina” che si manifesta nello Stato
Di un monarca di tipo costituzionale.
Sì, ma nell’ottica di Hegel, il potere legislativo non è tout court espresso dal parlamento concepito alla
maniera inglese, in quanto cioè espressione degli interessi di tanti individui. Il nostro prevede due Camere
che non esprimono individui, ma ceti sociali, organismi cioè in cui la mediazione tra interessi individuali e
un interesse più generale è già avvenuta: una Camera alta costituita dal ceto dei nobili e la Camera bassa
formata dai rappresentanti delle corporazioni. Tali Camere, poi, non detengono tout court il potere
legislativo, ma semplicemente “concorrono” col monarca alla formazione delle leggi. E c’è di più: Hegel
sottolinea come le classi sociali presenti nelle due Camere tendono a far prevalere gli interessi privati su
quelli generali. Le vede quindi con una certa diffidenza.
A maggior ragione, dunque, non vede di buon occhio la democrazia di Rousseau.
Certamente. Secondo Hegel il popolo non sa quello che vuole (der nicht weiß was er will), mentre i membri
del governo conoscono molto meglio i bisogni del popolo stesso. Egli parla della moltitudine come “una
massa amorfa” (eine formlose Masse) il cui agire è “irrazionale” (vernunftlos).
Il monarca, dunque, si avvale di ministri.
Indubbiamente: in una monarchia costituzionale il governo è un organo di primo piano.
Ma anch’esso concorre alle decisioni del monarca.
Sì, l’ultima decisione spetta a lui: in definitiva, però, il ruolo del sovrano si riduce a dire di “sì” ( der “Ja”) o di
mettere il punto sulla “i” (das Punkt auf I).
È il caso di precisare che il potere esecutivo include il potere giudiziario che opera nella sfera della società
civile.
Non siamo, quindi, alla tripartizione dei poteri come è stata teorizzata da Montesquieu.
È vero. Hegel, in questo, è in sintonia con Locke. Va sottolineato, poi, che i poteri dello Stato, pur distinti,
non sono per nulla divisi come nella tradizione liberale, così come va sottolineato che il fine dello Stato non
è la tutela dei diritti dei singoli cittadini (incluso il diritto di proprietà): questo è un compito della società
civile.
E quale sarebbe, allora, il compito dello Stato?
Lo Stato non ha come scopo quello della sicurezza dei cittadini. Non è, in altre parole, in funzione dei
cittadini, ma viceversa. I cittadini, infatti, sono tali e si realizzano come tali “in quanto” componenti dello
Stato.
Stiamo scivolando ancora nel totalitarismo.
È un’interpretazione che è stata data, tanto più che si ha l’impressione che Hegel faccia dello Stato una
sorta di idolo.
Come Hobbes.
Con Hobbes, come abbiamo visto, condivide non poche idee, inclusa l’idea di uno Stato forte. Hegel giunge
a tal punto da affermare che “lo Stato è volontà divina” (der Staat ist göttlicher Wille) e che “è il cammino
di Dio nel mondo a far sì che lo Stato sia” (es ist der Gang Gottes in der Welt daß der Staat ist).
Ma questo è mostruoso.
È mostruoso se leggiamo lo Stato hegeliano con l’ottica liberale che è un’ottica che ha come fulcro i diritti
dei singoli cittadini. Non dimentichiamo che secondo Hegel lo Stato è l’espressione più alta dello “spirito” di
un popolo e che incarna non la moralità astratta di Kant (Moralität), ma il bene concreto, possiamo dire lo
spirito fatto… carne, fatto cioè istituzioni, tradizioni… È nello Stato che l’individuo sa che cosa è bene fare,
conosce i suoi “doveri”. È nello Stato che si concretizzano i valori spirituali e, quindi, i diritti e i doveri. Non
siamo in presenza di norme kantiane del tutto formali, prive nel modo più assoluto di contenuti: le norme
qui hanno dei contenuti ben precisi che sono l’oggetto delle leggi, delle tradizioni… Ecco perché Hegel parla
dello Stato come l’espressione più elevata dell’“eticità”.
La civetta di Minerva
È questo l’errore di Hegel: la pienezza dei valori è un ideale a cui tendere all’infinito (lo Streben di Fichte),
non uno Stato che esiste, uno Stato che oggettivamente è sempre imperfetto.
Hegel prende le distanze dall’idea di costruire “uno Stato così come esso dev’essere” (einen Staat, wie er
sein soll). Non si tratta di inventare a tavolino un modello razionale di Stato (come ha iniziato a fare
Platone), ma, al contrario, di individuare la razionalità che si è realizzata nello Stato esistente. Ecco che egli
va alla ricerca dello “spirito” di un popolo. Del resto è questo lo stesso compito della filosofia: essa altro
non è che “il proprio tempo colto in pensieri” (ihre Zeit in Gedanken erfaßt). Anzi, è necessario che il
proprio tempo sia compiuto perché in esso si possa vedere interamente dispiegata la razionalità. Non è un
caso che, secondo il nostro, la filosofia è come “la civetta di Minerva” (die Eule der Minerva) che “inizia il
suo volo soltanto sul far del crepuscolo” (beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug).
È più che giustificata, allora, l’interpretazione di Hegel come l’ideologo della Restaurazione.
L’abbiamo già chiarito: Hegel non nega la presenza nelle leggi di aspetti irrazionali (ad esempio, l’istituto del
maggiorascato nello Stato prussiano) e invita a distinguere in esse ciò che è “sostanziale” da ciò che è
semplicemente “accidentale”. Non fa quindi dello Stato prussiano (di cui pure è un ammiratore) il migliore
degli Stati possibili.
Una cosa è certa: Hegel è lontano dall’idea di Fichte secondo cui il fine dello Stato è quello di estinguersi. Gli
individui, infatti, sono davvero “liberi” soltanto nello Stato.
Sono “liberi” in quanto “sottomessi” allo Stato: un vero e proprio paradosso.
Secondo Hegel la libertà esaltata dai liberali è “astratta” in quanto “separa” l’individuo dalla comunità:
soltanto la libertà nello Stato è una libertà “concreta”. Hegel la chiama libertà “sostanziale”: nella famiglia
l’individuo in quanto tale non esiste; nella società civile si impone come tale e si contrappone agli altri, in
particolare nella sfera economica; nello Stato l’individuo realizza al massimo la sua libertà perché è in
sintonia con lo “spirito” del popolo.
Un po’ come la libertà teorizzata da Rousseau.
Sì. La libertà sostanziale assume una valenza etica: l’individuo nello Stato, nella sua adesione alla “volonté
générale”, si libera dal suo egoismo, dal suo attaccamento all’utile personale e corporativo. Ecco perché
siamo in presenza non di una sudditanza, ma di una libertà reale.
Ma qui ci troviamo di fronte a una totale sottomissione dell’individuo a quella sorta di Moloch che è lo
Stato.
Solo nello Stato l’individuo può elevarsi all’altezza dello spirito universale. Il compito dello Stato, infatti, è di
fare la storia.
Un Hegel proiettato nel futuro come Fichte: questa è una sorpresa.
Una Ragione astuta
Hegel legge la storia come la storia della Ragione.
Una storia guidata da grandi condottieri.
Sì. Hegel li chiama uomini “cosmico-storici”: sono loro che con le guerre, con le conquiste, diventano
inconsapevoli strumenti dell’Astuzia della Ragione.
Ne abbiamo già parlato.
Sì. Ecco perché dobbiamo aspettare che un’epoca sia chiusa per poterla giudicare: è solo alla fine che noi
possiamo coglierne i risultati. Mentre una guerra è in corso noi tendiamo a vedere solo le distruzioni, le
vittime innocenti… e solo alla fine noi riusciamo a comprendere come, attraverso tanto dolore, si è
dispiegata la razionalità.
Vuoi dire la civiltà.
Sì, norme istituzioni più civili, cioè più razionali. È quanto hanno esportato i Romani: il loro “diritto” è
ancora oggi ammirato e oggetto di studio nelle università. Così il codice napoleonico che si è diffuso
laddove sono arrivate le armate di Napoleone: si tratta, senza dubbio, di norme di gran lunga più razionali
di quelle in vigore in precedenza.
Ma qui cadiamo nell’idea secondo cui esistono norme razionali che vanno esportate, in quanto tali e quindi
in quanto universali, con la forza.
Non si tratta di “cadere”in una trappola: è questo che ci rivela la storia come si è concretamente sviluppata.
Non esistono dei giudici che risolvono controversie internazionali. Le guerre, al di là delle condanne
moralistiche, hanno un’importante funzione nella storia. Così scrive Hegel: “come il movimento dei venti
preserva il mare dalla putredine cui sarebbe ridotto da una bonaccia duratura, così la guerra preserva i
popoli dalla putredine cui sarebbero ridotti da una pace duratura o addirittura perpetua” ( oder gar ein
ewiger Friede).
Un cinico, questo Hegel.
Egli si sente lontano dall’utopia della “pace perpetua” di Kant. E si sente lontano perché è nella storia che
vede il ruolo decisivo delle guerre per far avanzare lo spirito nel mondo. Non è un caso che si passi dal
mondo orientale dove libero è “uno” solo (il monarca) al mondo greco-romano in cui liberi sono “alcuni”
(pensiamo, ad esempio, all’esclusione delle donne e degli schiavi) per giungere al mondo cristianogermanico in cui liberi sono “tutti”.
Sulla carta, però.
Tutti liberi in quanto, grazie alla tradizione cristiano-liberale che arriva fino a Kant, la libertà è riconosciuta
ad ogni uomo “in quanto uomo”. Hegel insiste sulla missione culturale del popolo tedesco.
Anche lui su posizioni nazionalistiche.
Così lo si è letto, come così si è letto Fichte. Ambedue, tuttavia, sottolineano il primato spirituale del popolo
tedesco, primato che raggiunge la sua massima manifestazione nell’idealismo.
Una tesi pericolosa.
Certamente, ma è un fatto che la cultura tedesca del tempo (inclusa la filosofia idealistica che ne è in gran
parte l’ispiratrice) si impone con forza in pressoché tutta l’Europa. Una cultura che, secondo Hegel,
rappresenta un colpo d’ala rispetto a quella liberal-illuministica.
Nella storia, quindi, ci sarebbe un fine.
Sì. È la cosiddetta concezione “teleologica” di Hegel (concezione “finalistica”): nella storia popoli e individui
realizzano, senza saperlo, un disegno provvidenziale.
Mi pare una lettura cristiana in chiave laica.
È vero: in Hegel la provvidenza non è quella cristiana, ma la Ragione che si dispiega nella storia. Ecco, allora,
dove si eleva il singolo individuo: ben oltre il proprio “particulare”, ben oltre gli stessi confini nazionali.
L’individuo collabora a realizzare la storia dello Spirito nel mondo.
Superamento di contraddizioni
Già, lo “Spirito”. È giunto il momento di inquadrare il pensiero politico di Hegel all’interno della sua più
ampia visione del mondo o, come la chiamano i tedeschi, Weltanschauung.
L’idealismo.
Sì: proprio perché la cosa in sé (Ding an sich) è contraddittoria, non vi è nulla al di fuori del pensiero, nulla
al di fuori dello spirito. Lo spirito, quindi, è tutto. In ultima analisi, tutto è razionale: lo stesso Stato
(abbiamo visto), la stessa storia. Perfino la stessa natura – l’ha sottolineato con forza un altro grande
idealista, Schelling – è permeata di spiritualità.
In sintonia con Kant.
Sì, ma Schelling va oltre Kant: la spiritualità è l’anima della natura. Ne è l’anima – è il concetto romantico di
natura – nel senso che la natura palpita di vita, di energia.
È l’attività, infatti, che caratterizza lo spirito.
Infatti. È questo il Leitmotiv di tutta la filosofia moderna: la materia è soggetta al determinismo, è quindi
passiva, mentre lo spirito è libero e dunque attivo.
Una distinzione chiara già in Cartesio.
Certo. Lo spirito è attivo anche nella concezione di Locke: è l’intelletto che elabora le idee semplici e
costruisce le idee complesse.
Come le stesse idee di sostanza e di causalità.
Sì. Kant, poi, coglie nello spirito un dinamismo ancora maggiore: è la mente che, nel processo conoscitivo,
organizza i dati sensibili, fondando in tal modo la scienza.
E Fichte va ancora più in là: lo spirito è infinita attività liberatrice.
Un perenne superamento di limiti. Ed Hegel è in sintonia con Fichte: anche secondo lui l’attività dello spirito
si esprime in un processo di superamento.
L’Aufhebung di cui abbiamo già parlato.
Sì. Non siamo, però, in presenza di “limiti”, ma di “contraddizioni”. Il pensiero, in altre parole, è un processo
di superamento di contraddizioni.
Mi pare paradossale: se non vi è nulla al di fuori del pensiero e se il pensiero coincide con la razionalità, la
contraddizione sarebbe il prodotto della razionalità!
Tieni presente che il pensiero, secondo Hegel, si articola in funzioni diverse: un conto è l’“intelletto”
(Verstand) e un conto la “ragione” (Vernunft).
Una distinzione già kantiana.
Sì, ma Hegel ne rovescia il significato. Secondo Kant è l’intelletto che svolge una funzione positiva in
quanto, con le sue categorie, dà fondamento alla scienza, mentre la ragione, con la sua pretesa di andare
oltre l’orizzonte dell’esperienza, approda a un non-sapere che è la metafisica. Secondo Hegel, invece, la
funzione dell’intelletto è quella di separare ciò che è intrinsecamente unito (è per questo che egli lo chiama
“intelletto astratto”, intelletto cioè che “separa”). Si tratta di una funzione negativa, ma necessaria: se non
ci fosse la separazione, non ci sarebbe la contraddizione e se non vi fosse la contraddizione, non ci sarebbe
il motore del superamento.
Ma perché mai la separazione dovrebbe comportare contraddizione?
Proviamo a pensare alla “parte”. Se pensiamo alla parte separata dal tutto, pensiamo a una parte che… non
è una parte: che parte sarebbe se non fosse posta in relazione – in quanto opposta – al tutto? È questa la
contraddizione: se separiamo la parte dal tutto, ciò che pensiamo come “parte” è “non parte”.
Separare, quindi, significa contraddirsi, cadere in contraddizione. È questa contraddizione la molla che
spinge la “ragione” a superarla. La contraddizione, dunque, costituisce lo stimolo necessario del progresso.
Una contraddizione logica il motore del progresso? Mi sembra un’idea campata per aria.
Secondo Hegel la contraddizione logica è ben incarnata. Pensa all’esplosione dei diritti individuali e delle
libertà teorizzate dalla tradizione cristiano-liberale, allo scontro tra interessi privati nella sfera economica.
È ciò che abbiamo definito il regno della “scissione”
Appunto, il regno della “separazione”, vale a dire il prodotto dell’“intelletto astratto”: è l’intelletto astratto
che separa l’individuo dalla comunità a cui è intrinsecamente legato.
Ma tutto questo è da considerare una conquista della civiltà.
Lo pensa anche Hegel che - come abbiamo più volte rilevato - non ha mai rinnegato le grandi acquisizioni
della Rivoluzione francese. Ma l’individualità contrapposta alla collettività genera solo danni, disgregazione,
disordine, a partire dagli egoismi di carattere economico. Da qui la necessità di andare oltre le conquiste
cristiano-liberali, oltre la contraddizione che comporta la separazione tra individuo e collettività, tra singolo
cittadino e popolo (Volk).
La necessità di giungere alla “libertà sostanziale” di Hegel.
Sia chiaro: non si tratta di giustificare la Restaurazione che si poneva l’obiettivo di riportare l’ordine dove
c’era il caos. Si tratta di aprire una nuova epoca storica che conservi le conquiste ottenute a partire da
Lutero, ma nello stesso tempo, le elevi a un livello superiore, al livello dello spirito del popolo. Come vedi,
non siamo in presenza di una semplice contraddizione mentale: qui stiamo parlando di processi storici, di
processi che durano nel tempo.
Ma si tratta comunque, di una contraddizione logica: separare l’“individuo” dalla “comunità” è lo stesso che
separare la “parte” dal “tutto”.
Infatti. Ed è come separare il “mezzo” dal “fine”.
Come nel caso della guerra.
È così, secondo Hegel: non si può separare il “mezzo” (la guerra) dal “fine” (i risultati in termini di civiltà
diffusa nel mondo).
Un’operazione moralistica che Hegel condanna.
Già, un’operazione dell’intelletto astratto: ecco perché solo quando si ha presente il “tutto” (quando
un’epoca si è conclusa) è possibile cogliere la funzione razionale della “parte” (la guerra) e la funzione
razionale di quella “parte” che è rappresentata dalle ambizioni dei singoli uomini “cosmico-storici”.
Il vero è il Tutto
Ecco quindi la funzione stessa della filosofia che è come la civetta che spicca il volo al tramonto del sole.
Infatti: è solo il tutto che rivela la razionalità. È quanto sottolinea Hegel nella Fenomenologia dello Spirito: il
vero è il tutto.
È solo Dio, dunque, la verità.
Sì: è la stessa ragione (Vernunft) che ci conduce al punto di vista di Dio, il punto di vista dell’Intero.
Come nella concezione agostiniana.
Certo: è solo dall’altezza della provvidenza divina che si possono cogliere i nessi tra i singoli eventi (anche la
sofferenza degli innocenti) e il loro fine.
Solo la “sintesi” è la verità. La sintesi, però, non è un dato immediato, ma il “risultato” di un processo. La
verità, di conseguenza, non è un punto di partenza, ma di arrivo.
La sintesi, dunque, per essere realizzata, ha bisogno della “scissione”.
Infatti. È il processo che Hegel chiama “dialettico”: si parte dalla “tesi” (in questo caso la famiglia), si passa
dalla “società civile” (antitesi) per giungere allo “Stato” (appunto, la sintesi).
Si parte cioè da una unità per arrivare a una unità superiore.
È così: l’unità tra “individuo” e “ comunità” che si concretizza nello Stato, come abbiamo visto, non è un
semplice ritorno all’unità originaria della famiglia.
Abbiamo sempre a che vedere col concetto di “Aufhebung”: si supera, sì, il punto di vista dell’individuo, ma
anche lo si conserva.
È il caso di aggiungere che il processo dialettico non è esclusivo di Hegel perché è già presente in Rousseau:
lo stato dell’armonia originaria, lo stato della decadenza che fa entrare nella storia il regno dell’egoismo per
giungere alla democrazia diretta che rappresenta (pensiamo alla volonté générale) una nuova e superiore
armonia.
Un processo triadico, quello di Rousseau, che ricalca l’analogo processo presente nella visione cristiana
della storia: l’armonia del paradiso terrestre (armonia tra uomini e uomini e natura), il peccato che separa
l’uomo da Dio e dalla natura, e la Redenzione di Cristo che riconcilia l’uomo con Dio.
Una infelicità strutturale
Ho la sensazione che la religione continui a svolgere la sua influenza anche in pensatori del tutto “laici”.
Infatti. Hegel giunge ad affermare che “la religione è la verità per tutti gli uomini” (die Religion ist die
Wahrheit für alle menschen). Non dobbiamo poi dimenticare che la tematica religiosa è stata uno dei primi
amori di Hegel. Lo si coglie nelle sue riflessioni giovanili in cui è già chiaro il suo interesse a ricomporre le
scissioni. Come la scissione tra l’uomo e Dio nella religione ebraica.
Nel senso che gli ebrei continuano ad attendere un Messia che non viene mai.
Sì, ma anche nel senso che il Dio del Vecchio Testamento è un Dio terribile, un Dio lontanissimo dall’uomo.
Da qui, secondo Hegel, l’infelicità di fondo del popolo ebraico, un’infelicità che, al contrario, nel
cristianesimo non c’è.
Nella religione cristiana, infatti, Dio si è fatto uomo.
Non solo: l’amore, l’oggetto del messaggio radicale di Gesù Cristo, unisce l’uomo e Dio e gli uomini tra loro.
È un messaggio di unione, di conciliazione.
Lo stesso cristianesimo, però, subisce a sua volta una involuzione.
Una… scissione.
Sì, da messaggio squisitamente morale, da religione in cui lo “spirito” ha il primato sulla “lettera”, il
cristianesimo diventa istituzione, gerarchia, dogmi.
Si sclerotizza come l’ebraismo.
È così. In esso lo spirito si trasforma in rigidi precetti. Da religione “soggettiva”, in altre parole, diventa
“oggettiva”, istituzionalizzata, dogmatica.
Una religione senz’anima. Una religione che di fatto muore.
Il nostro - l’abbiamo visto - è affascinato dalla Volksreligion (religione popolare) della pόlis greca, un tipo di
religione in cui “soggettività” e “oggettività”, “privato” e “pubblico” si fondono in una unità organica.
Un Dio che non è, ma diventa
Ricomporre ciò che è separato, arrivare a una sintesi “concreta”: è questo il cavallo di battaglia di Hegel che
ritroviamo in tutte le sue grandi opere, dalla Fenomenologia dello Spirito all’Enciclopedia delle scienze
filosofiche ai Lineamenti di filosofia del diritto. È in tale logica che il nostro critica Fichte: in lui vede un
cattivo infinito.
Lo Streben fichtiano, la tensione all’infinito, l’infinito superamento di limiti.
Già, una tensione che denota, come nell’ebraismo, una strutturale infelicità: un compito all’infinito
dell’uomo di diventare Dio senza mai diventarlo.
In Hegel, invece, lo Spirito diventa Dio.
È proprio così: lo Spirito diventa consapevole di essere l’infinito, di essere quindi Dio.
Accade con l’idealismo.
Sì, una volta caduto il concetto di “cosa in sé” in quanto contraddittorio, il pensiero sa di essere l’Intero.
Ma anche Fichte ha questa consapevolezza.
Sì, ma Fichte conserva un’opposizione tra Io e non-Io, tra l’Io come attività e il Non-Io come limite da
superare all’infinito. In Fichte, dunque, il limite è semplicemente spostato all’interno del pensiero.
Il servo che diventa padrone
Ma il limite è presente anche in Hegel: la contraddizione, frutto della separazione prodotta dall’intelletto
astratto.
Sì, ma è appunto la contraddizione che spinge ad andare oltre, a ricomporre ciò che è stato separato. È
nella storia che si coglie questa dialettica tra momenti dominati dall’“intelletto astratto” e momenti
dominati dalla “ragione”. Pensiamo al rapporto tra servo (der Knecht) e signore (der Herr) tipico dell’epoca
antica, rapporto che si instaura nel momento in cui, nella lotta tra individui, chi con coraggio rischia la vita
diventa “signore” e chi si arrende per paura di perdere la vita diventa “servo”. È in questo rapporto di
signoria sul servo che il signore diventa autocosciente. Ma poi è il servo che si trova a vivere una potente
presa di consapevolezza: egli è, sì, servo, ma, grazie al lavoro, grazie cioè al suo “oggettivarsi” (al suo
realizzare qualcosa di oggettivo), prende coscienza che il signore dipende da lui e che quindi in realtà è il
signore il suo servo.
C’è un rovesciamento di ruoli.
Sì: il servo diventa padrone e il padrone servo.
Il padrone, però, rimane sempre padrone e tratta sempre il servo come un servo.
Certo, il processo dialettico che avviene grazie al lavoro rimane all’interno della coscienza.
Hegel, dunque, valorizza molto il lavoro.
È su questa strada che Marx giungerà a teorizzare il lavoro come la natura stessa dell’uomo: è grazie al
lavoro, al processo cioè di oggettivazione di se stesso, che l’uomo si realizza come uomo.
Si realizza perché, nella trasformazione della natura, proietta le sue capacità razionali.
È così. Ed è nella razionalità proiettata nell’oggetto che coglie se stesso. Il servo, poi, nel lavoro coglie, lui
servo, la sua “libertà”, la sua autonomia dal signore. Si tratta, naturalmente, di una libertà puramente
interiore. È quella teorizzata nell’antichità dallo stoicismo: si può essere liberi anche in catene perché ciò
che conta è l’autocontrollo, la libertà appunto interiore. Con lo stoicismo, di fatto, si nega il mondo esterno
e ci si raccoglie in quello interiore. Una negazione che è chiarissima nello scetticismo che dimostra la
sfiducia nella possibilità umana di conoscere la realtà, di raggiungere quindi la verità.
Ma anche lo scettico vive nel mondo e quindi lo considera reale.
Sì. Ecco la contraddizione in cui si trova: da un lato nega il mondo (la sua accessibilità) sul piano conoscitivo,
dall’altro lo utilizza sul piano pratico.
La scissione è ancora più evidente nella cosiddetta “coscienza infelice” (unglückliche Bewusstsein) che
caratterizza la coscienza religiosa.
Parliamo di religione ebraica.
Di sicuro nell’ebraismo troviamo la massima scissione tra la nullità dell’uomo e l’onnipotenza di Dio.
Lo stesso rapporto che c’è tra il servo e il signore.
In qualche misura, sì: l’uomo è totalmente in balia di un Signore che è padrone della vita e della morte.
Una scissione che il cristianesimo annulla.
Non del tutto in quanto Cristo è vissuto “lontano nel tempo e nello spazio” per cui è percepito dai posteri
come remoto e perché, in quanto risorto, appartiene al mondo dell’aldilà.
Nel cristianesimo la scissione tocca il suo apice nell’ascetismo quando l’uomo giunge a umiliare la propria
carne. La coscienza infelice, tuttavia, è solo un momento (anche se durato a lungo) destinato ad essere
superato.
Il senso della storia
La felicità, quindi, è il destino della coscienza.
Sì, lo Spirito sarà felice quando, dopo una serie di lacerazioni e ricomposizioni, saprà di essere Dio.
Dio, dunque, non esiste da sempre, come nella versione religiosa, ma diviene tale nel tempo.
Infatti: Dio diventa cosciente di essere Dio solo con l’idealismo hegeliano, un idealismo che va oltre quello
di Fichte e quello di Schelling. L’idealismo di quest’ultimo, secondo Hegel, parla sì di un Dio come la
Totalità, ma tale Totalità non è concepita come il risultato di un processo storico, in quanto oggetto
dell’intuizione artistica. Si tratta di un Dio che è sintesi indifferenziata di spirito e natura, di soggetto e
oggetto, di conscio e di inconscio, di libertà e necessità.
Dio, dunque, sarebbe accessibile non ai sacerdoti, non ai filosofi, ma solo agli artisti perché è la stessa arte
che implica un ibrido di consapevolezza e di ispirazione inconscia.
Sì. Secondo Hegel, invece, l’arte ha sì un importante ruolo conoscitivo (ne riparleremo), ma è solo con la
filosofia che possiamo accedere a Dio. C’è poi un altro motivo che spinge Hegel a tenersi alla larga da
Schelling: l’Assoluto concepito da questi è una sorta di “notte in cui tutte le vacche sono nere”.
Vuol dire che in Dio non vi sarebbero distinzioni in quanto tutto in esso è indifferenziato.
È così. Il risultato, invece, del processo dialettico dello Spirito, essendo la sintesi finale, non può che
“conservare” tutto (sia tesi che antitesi).
L’unità degli opposti di Eraclito.
Siamo, pur in contesi diversi, sulla stessa lunghezza d’onda.
L’Intero, dunque, è concepito da Hegel come l’Infinito “concreto”, non astratto, l’Infinito che contiene tutte
le differenze.
Non si tratta, tanto per dare un’idea, di una sorta di essere parmenideo.
Un essere tanto indeterminato da non contenere alcuna differenza.
Tanto indeterminato – sottolinea Hegel – da coincidere col suo opposto: il nulla. Il Dio di Hegel, invece, è sì
Essere (anche il pensiero in divenire “è”), ma un Essere “concreto”, ricco cioè di tutte le cosiddette
“determinazioni”.
Di tutte le cose.
Esatto.
Siamo di fronte a una forma di panteismo.
Certo: non vi è nulla al di fuori del pensiero, nulla al di fuori dello spirito, nulla in ultima analisi al di fuori di
Dio. Ed è proprio dall’altezza del “Tutto” che si possono cogliere le “parti” non come separate, ma come
parti appunto del Tutto. Ed è da questo punto di vista che si coglie la funzione positiva (quindi necessaria)
della scissione, come è da questo punto di vista che si coglie il senso della storia.
Il senso provvidenziale della storia.
Sì, anche il senso ultimo di quegli eventi orrendi che sono le guerre. È da questa altezza che si percepisce
come tutta la storia ha come unico fine il diventare Dio di Dio, il suo prendere coscienza di essere l’Intero.
Un’Epifania in chiave laica
Mi pare, Il punto di vista di Hegel, una pretesa assurda: come è pensabile che l’uomo, un ente finito, possa
abbracciare l’Infinito e cogliere il Tutto come lo coglie Dio?
Non è l’individuo Hegel che prende coscienza di essere Dio: il nostro non fa altro che leggere la storia che gli
appare come una manifestazione di Dio, ovvero una teofania.
Una sorta di Epifania in chiave laica.
Sì.
Mi pare un peccato di hýbris: la pretesa di leggere la storia della filosofia e la stessa storia come un
processo che conduce alla… “indiazione di Dio”.
È vero, ma per capire tale approccio dobbiamo tenere presente che questo è il punto di vista dell’idealismo:
se Dio è l’Infinito, l’Intero, la Totalità, l’orizzonte del pensiero altro non è che l’orizzonte di Dio. Un
orizzonte - l’abbiamo detto più volte – che non è il frutto di un’intuizione di un singolo uomo (vuoi un
sacerdote, un artista o un filosofo), ma il risultato di un processo storico.
Presuppone quindi Kant: è da qui, dall’affermazione della cosa in sé come inconoscibile che scatta il
superamento tra pensiero e mondo.
Sì, come presuppone un po’ tutto il pensiero moderno, a partire da Cartesio, che rivela una profonda
lacerazione tra il pensare e l’essere, tra il pensare e le cose.
Un punto di vista presente anche nell’empirismo: ciò che il pensiero percepisce non sono le cose, ma le
“idee”, vale a dire le immagini, le rappresentazioni.
Una lacerazione che viene ulteriormente esasperata in Kant che sostiene (l’abbiamo appena detto) non
solo l’esistenza della cosa in sé (come concetto-limite), ma anche la sua inconoscibilità.
Una lacerazione che viene superata dall’idealismo, ma qui vedo l’antitesi e vedo la sintesi, ma non la tesi.
Effettivamente, come abbiamo detto e ridetto, la sintesi è un ritorno alla tesi, conservando però la stessa
antitesi come superata. E la tesi è, in ultima analisi, la concezione parmenidea (e per lo più la filosofia
antica) secondo cui pensare è pensare l’essere.
Lo spirito, dunque, torna all’aurora del filosofare.
Vi ritorna, ma senza l’ingenuità di Parmenide: è proprio grazie alla lacerazione operata dalla filosofia
moderna tra pensare ed essere che il pensiero prende consapevolezza della contraddittorietà di tale
lacerazione. La sintesi, di conseguenza, registra un notevole passo in avanti della coscienza rispetto alla tesi.
Nella sintesi, quindi, ogni forma di scetticismo viene debellata.
Infatti: proprio perché è contraddittoria la “cosa in sé”, quello che il pensiero coglie non è l’immagine di una
cosa sconosciuta, ma lo stesso essere, la stessa… cosa. La sintesi, cioè, fonda ciò che in un primo momento
non ha alcun fondamento.
Ancora di più appare chiara la funzione positiva della scissione.
Una funzione essenziale: senza scissione non c’è contraddizione (lo stiamo ripetendo a iosa) e senza
contraddizione non vi è superamento.
Nella sintesi, quindi, sono presenti sia la tesi che l’antitesi, viste però come dei momenti che vengono
superati nella loro separazione.
Ricordiamoci: la parte è tale solo in relazione al Tutto. Di conseguenza, si può cogliere il senso della parte
solo all’interno del Tutto.
Solo Dio, dunque, può illuminare la singola parte nella sua relazione col Tutto.
Nella relazione con la sintesi e, in ultima analisi, con quella sintesi che è la Totalità, cioè con Dio.
Una manifestazione dello spirito
Anche l’arte, dunque, viene colta nella sua relazione con l’Intero.
Sì, l’arte, anzi, è già una manifestazione dello Spirito (perfino un semplice manufatto rivela più spiritualità
che la stessa natura).
Non è, di conseguenza, opera di un singolo artista.
Diciamo che il singolo artista è uno strumento attraverso il quale si esprime lo spirito di un popolo.
Ci stiamo ricollegando, quindi, al pensiero politico di Hegel.
Sì, a quello che abbiamo chiamato “Spirito oggettivo”, lo Spirito cioè che ha impregnato di spiritualità
costumi, istituzioni, la stessa arte. Nell’arte la spiritualità (il messaggio) prende una forma sensibile. È
l’estetica che, riflettendo sulle opere d’arte, ne coglie i contenuti spirituali.
Contenuti spirituali che non è sempre agevole decifrare.
Hegel vede nella storia tre diversi livelli di arte, simbolica, classica e romantica: l’arte simbolica in cui la
forma sensibile prevale sui contenuti, l’arte classica in cui forma e contenuti sono in perfetto equilibrio
(pensa, ad esempio, alle statue di Fidia) e l’arte romantica in cui il contenuto spirituale è tanto ricco che
non riesce a trovare una forma sensibile adeguata.
Qui non vedo alcuna sintesi. Anzi, semmai questa si trova nell’arte classica.
È vero. Non tutte le triadi hegeliane ci appaiono coerenti. In questo caso lo squilibrio tipico dell’arte
romantica sta a indicare che l’arte è destinata a morire, a dissolversi per dare spazio ad altre forme di
conoscenza.
Il cristianesimo al vertice delle religioni
Un’altra manifestazione dello Spirito è la religione.
Ma la religione si basa sulla fede, non sulla ragione.
Senz’altro, ma la religione è comunque una modalità di conoscenza di Dio che viene colto non dentro una
forma sensibile (come nell’arte), ma nell’interiorità dell’uomo.
Nella rappresentazione religiosa di Dio.
Già, nelle rappresentazioni che appartengono all’immaginario dell’uomo. Anche la religione, secondo il
nostro, registra nella storia tre momenti: il momento in cui Dio viene colto nella natura (pensiamo al
feticismo), il momento in cui viene percepito come Persona (quindi come spiritualità) e il momento in cui
Dio è colto come sintesi di finito e infinito, di spirito e natura.
E il cristianesimo?
Il cristianesimo si trova all’apice del terzo momento: la figura di Gesù Cristo, figlio di Dio, rappresenta
proprio l’unità di finito e infinito; la stessa Trinità altro non è che un’immagine che esprime il processo
triadico dello Spirito.
Il livello più alto della conoscenza di Dio, quindi, non può che essere rappresentato dalla filosofia.
Infatti. Se nell’arte lo Spirito (Dio) si manifesta mediante la “forma sensibile”, se nella religione si esprime
tramite “immagini”, nella filosofia viene colta mediante i “concetti”. E la storia della filosofia altro non è che
la storia dello Spirito che, mediante continue scissioni e ricomposizioni, diventa consapevole di essere
l’Intero.
L’alienazione
Nella storia della filosofia, quindi, ogni filosofia esprime solo un momento della Verità.
È così: non esistono filosofie erronee, o meglio, ogni filosofia è vera per ciò che dice ed è errata per ciò che
nega.
Perché solo l’Intero è la verità.
Appunto. Nella storia della filosofia, infatti, ogni filosofia è funzionale rispetto a quella successiva.
La storia della filosofia, dunque, è in ultima analisi la stessa filosofia che si sviluppa superando i momenti
precedenti.
Sì, è la stessa filosofia perché il soggetto è unico, cioè lo Spirito: è esso che man mano supera tutte le sue
contraddizioni (frutto delle scissioni) e prende consapevolezza di non avere nulla al di fuori di sé, né la
natura, né la storia, né un Dio trascendente.
La filosofia, dunque, è assimilata a un organismo vivente in cui ogni “parte” (ogni singola filosofia) è
strettamente in relazione con le altre.
Sì, in sintonia del resto con lo stesso Platone che vede le Idee non isolate, ma tra loro in relazione.
Qualcosa però non mi torna: come si concilia con tale impostazione la tesi hegeliana secondo cui la filosofia
è il proprio tempo colto nei pensieri?
Ogni filosofia è organicamente legata al suo tempo, ne è anzi una riflessione tesa a coglierne la razionalità
(è impensabile che un filosofo possa andare oltre il suo tempo). Ogni filosofia, però, è solo un momento di
un’evoluzione.
Un’evoluzione che ha come motore la contraddizione.
Infatti. Lo Spirito, prima di riconoscersi come Dio, ha bisogno di perdersi, di diventare altro da sé, di
cogliersi “finito” quando invece è “infinito”. Ma solo perdendosi, “alienandosi”, diventando, appunto, “altro
da sé”, che lo Spirito si rende conto della contraddittorietà di tale scissione: da qui la consapevolezza di
essere l’Infinito, cioè Dio.
“Figlio del suo tempo”
Un pensatore forte, questo Hegel, ma del tutto inattuale.
Di sicuro, per usare le sue parole, ciascuno di noi è “figlio del suo tempo” ( Sohn seiner Zeit), un tempo oltre
il quale nessuno può “saltare”. È un fatto, comunque, che la sua influenza in Europa è stata notevole e ben
al di là della sua epoca. Nel Novecento abbiamo avuto anche un idealismo tutto italiano con due filosofi di
alta statura quali Benedetto Croce e Giovanni Gentile.
L’ideologo, quest’ultimo, del fascismo.
Sì, è stato lui che ha teorizzato lo “Stato etico” in chiave fascista.
Uno Stato totalitario.
È vero, ma un conto è Giovanni Gentile che è vissuto in una temperie politica completamente diversa e un
conto Hegel. Il filosofo tedesco, come abbiamo già anticipato, ha ispirato sia pensatori di destra che di
sinistra.
Abbiamo fatto riferimento a Marx.
Anche secondo Marx la storia è un processo di superamento di contraddizioni.
Non certamente di carattere logico.
Secondo Marx il motore della storia è la lotta di classe. Anche sulla concezione del lavoro Hegel ha
influenzato Marx: è grazie a questo che l’uomo proietta in un oggetto la sua personalità, la sua intelligenza,
la sua fantasia, realizzando così pienamente se stesso.
Al di là dell’influenza che ha avuto, è un dato di fatto che Hegel ha posto esigenze ancora attuali. L’esigenza,
ad esempio, di una politica che vada oltre gli interessi privati.
Ma Hegel ha accentuato talmente tale istanza da fare dello Stato una vera e propria divinità a cui il singolo
è totalmente subordinato. Ci vuole, di sicuro, una mediazione tra le esigenze individuali o di gruppo e quelle
collettive, ma questo è già il ruolo che svolge uno Stato liberal-democratico, uno modello di Stato che Hegel
nega.
Influenzato in questo dal modello inglese. Non c’è dubbio che egli fosse ossessionato dall’esigenza di
andare oltre gli interessi particolari di cui il parlamento inglese era oggettivamente la cassa di risonanza.
Interessi particolari (vedi la ricerca esasperata del profitto, l’accumulo di enormi ricchezze in mano a poche
persone) che erano alla base della miseria della classe dei lavoratori.
Un Hegel attento alle esigenze del proletariato: un’altra sorpresa!
Egli non solo stigmatizzava la miseria, ma anche l’eccessiva parcellizzazione del lavoro che rendeva il lavoro
stesso ottuso.
Denunciava, ma poi non concedeva al popolo alcuna possibilità di incidere a livello politico.
Infatti, secondo lui il popolo era una semplice moltitudine che operava in modo irrazionale. Ecco l’idea che
le leggi dovessero essere pensate ed elaborate da una colta e preparata burocrazia (ministri e alti
funzionari, tutti di nomina regia), burocrazia in grado di conoscere i bisogni della gente meglio della gente
stessa.
Un’idea, questa, anacronistica.
Forse non del tutto: non è un caso che nell’Unione europea, laddove i problemi sono particolarmente
complessi, a governare sono di fatto i cosiddetti eurocrati che non hanno avuto alcuna investitura dal
popolo.
Ma questa è la morte della democrazia.
La democrazia si dispiega massimamente a livello di governo di piccole comunità dove i problemi sono
relativamente semplici. Più invece questi diventano complessi, diventa fondamentale selezionare delle
persone competenti.
Già, ma tocca ai partiti, in un sistema democratico, candidare tali persone.
È vero, ma è anche vero che non è automatico che i competenti abbiano tanto carisma da conquistare il
consenso degli elettori. C’è sempre il rischio che a vincere siano i demagoghi di turno.
Sono problemi già sollevati nella Grecia classica da Socrate e, soprattutto, da Platone. La politica è
sicuramente un’arte nobilissima, ma anche molto difficile, tanto più in un regime democratico.
Ciò che conta è non farsi incantare da modelli totalizzanti: vedi lo stesso modello di Platone.
Ma anche il modello “etico” di Hegel. La politica è una costruzione tutta umana, frutto di pazienti
mediazioni di numerosi punti di vista. Non abbiamo bisogno di scomodare Dio o lo Spirito o l’Astuzia della
Ragione. Non abbiamo bisogno di guru che pretendono di ergersi al punto di vista dell’Intero e di leggere il
senso e il fine della storia.
Già. È il caso di precisare, in conclusione, che noi qui ci siamo soffermati con una certa ampiezza solo sul
pensiero politico. L’abbiamo fatto perché non solo si tratta di una tematica che in qualche misura solleva
problemi ancora attuali, ma anche perché è la più accessibile.
Vuol dire che il resto è ostico.
Siamo lontani dalla prosa di Locke, di Hume e di Voltaire. I capolavori di Hegel sono opere scritte con un
linguaggio iper-specialistico, un linguaggio che disorienta gli stessi studiosi: vi è chi ritiene che non ci sia
nessuno capace di spiegare letteralmente una sola pagina dei suoi libri.
Un altro Eraclito.
Un Eraclito all’ennesima potenza. È per questo che non ci siamo addentrati nello specifico del suo
linguaggio e neppure nella complessità delle sue triadi logiche.
Siamo lontani dallo stesso Fichte.
Anche Fichte, è vero, ricorre a un linguaggio tecnico quando si rivolge a degli specialisti. Nei Discorsi alla
nazione tedesca, però, non solo è chiaro, ma trasmette emozioni, passioni.
Passioni che il freddo Hegel non trasmette.
Ciò che trasmette è l’invito a non condannare la storia, ma a cercarne le “ragioni” e, soprattutto, la
passione per la Verità.
Una Verità (l’Intero) che, tuttavia, non è accessibile ai mortali.