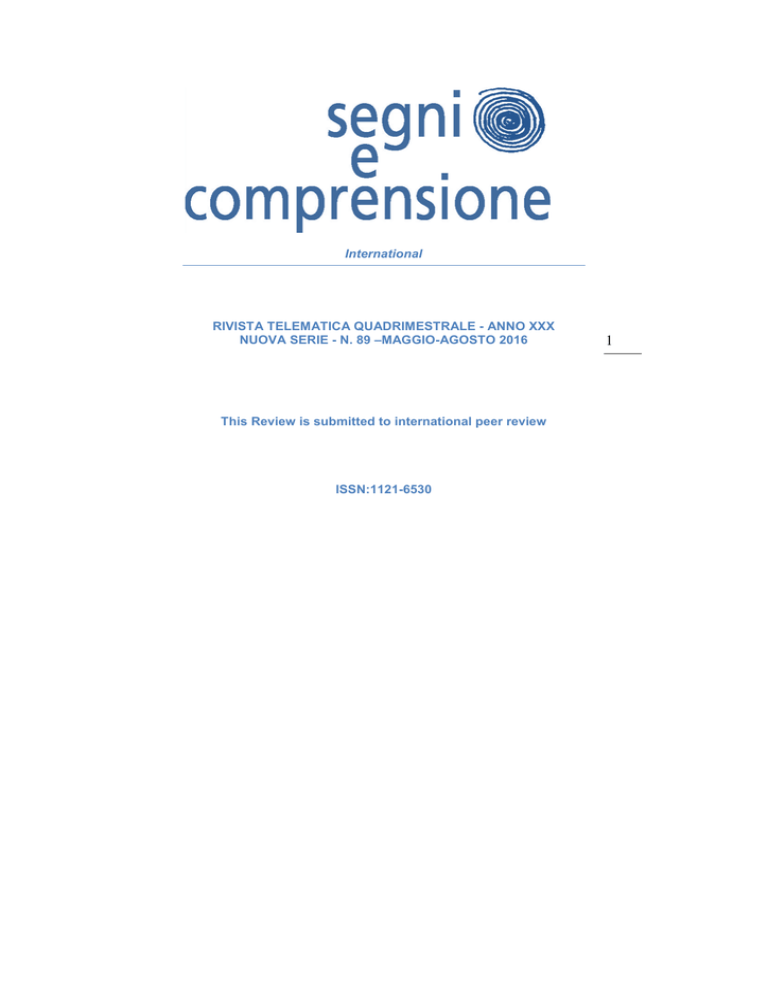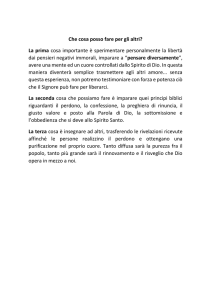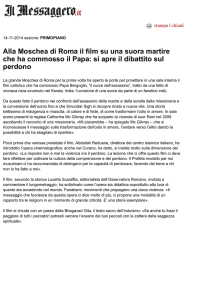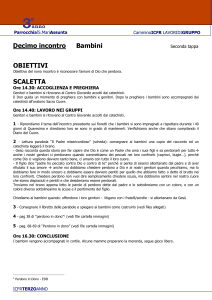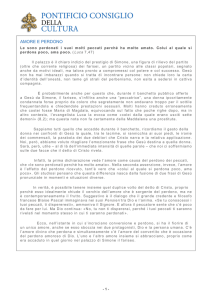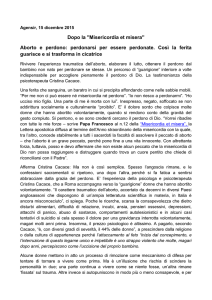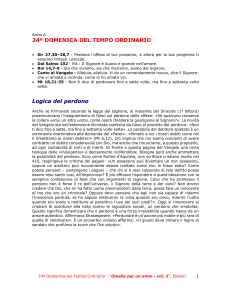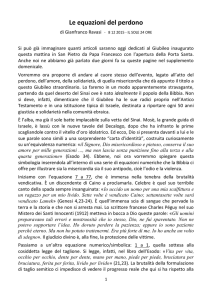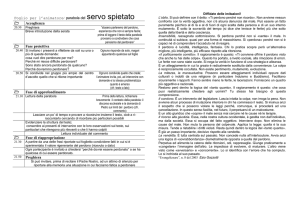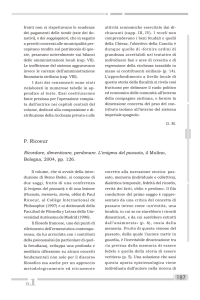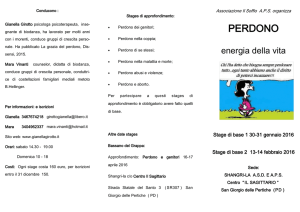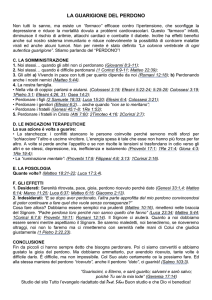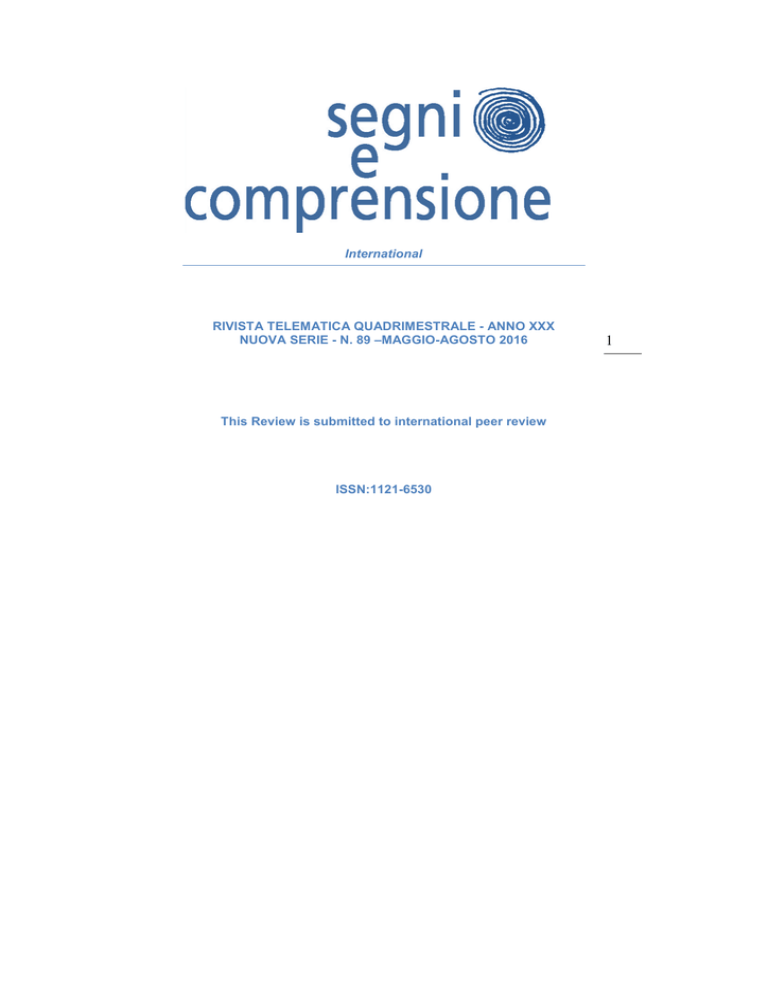
International
RIVISTA TELEMATICA QUADRIMESTRALE - ANNO XXX
NUOVA SERIE - N. 89 –MAGGIO-AGOSTO 2016
This Review is submitted to international peer review
ISSN:1121-6530
1
Direzione
Giovanni Invitto (Direttore, [email protected])
Daniela De Leo (Co-direttore - [email protected])
Comitato di Redazione
Angela Ales Bello - Università Lateranense; Angelo Bruno Università del Salento; Pio Colonnello - Università della Calabria,
Daniela De Leo - Università del Salento; Antonio Delogu -Università
di Sassari; Marisa Forcina - Università del Salento; Elena Laurenzi, Università del Salento; Aniello Montano -Università di Salerno; Paola
Ricci Sindoni - Università di Messina.
Comitato scientifico
Nicola Antonetti - Università di Parma; Gabriella Armenise –
Università del Salento; Jean-Robert Armogathe -École Normale
Supérieure de Paris; Renaud Barbaras - Paris I Sorbonne; Francesca
,Brezzi -Università di Roma 3; Bruno Callieri Università di Roma 1;
Mauro Carbone - Université Jean Moulin Lyon 3; Gennaro Carilllo Università di Napoli; Giovanni Cera - Università di Bari; Claudio
Ciancio - Università del Piemonte Orientale; Dino Cofrancesco ,Università di Genova; Françoise Collin fondatrice di “Les Cahiers
du Grif”; Umberto Curi - Università di Padova; Roger Dadoun Université de Paris VII-Jussieu; Ennio De Bellis - Università del
Salento; Franco Ferrarotti - Università di Roma 1; Renate HolubUniversity of California – Berkeley; Roberto Maragliano - Università
Roma Tre; William McBride - Purdue University West Lafayette,
Indiana; Augusto Ponzio - Università di Bari; Pierre Taminiaux Georgetown University; Christiane Veauvy - Cnrs; Sergio Vuskovic
Royo -Universidad de Valparaiso; Chiara Zamboni - Università di
Verona.
Staff di redazione
Daniela De Leo (responsabile); Siegrid Agostini, Lucia De Pascalis;
Maria Teresa Giampaolo.
2
Sede
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento
di Studi Umanistici, Università del Salento – Via M. Stampacchia –
73100 Lecce.
Periodico iscritto al n. 389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale
di Lecce.
Segni e comprensione International
Pubblicazione promossa nel 1987 dal Dipartimento di Filosofia e
Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce, oggi Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università del Salento, con la collaborazione
del “Centro Italiano di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma,
diretto da Angela Ales Bello.
La versione elettronica della rivista Segni e Comprensione è
disponibile ai seguenti indirizzi:
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/segnicompr
http: //www.segniecomprensione.it
http://dipfil.unisalento.it/
http://www.mannieditori.it/rivista/segni-e-comprensione (1987-2009)”
NOTE PER GLI AUTORI
I testi vanno inviati alla Direzione, indirizzati alla seguente e-mail:
[email protected]
e
per
conoscenza
a
[email protected]
I testi, in forma anonima, verranno esaminati da due referees, esterni
al Comitato Direttivo e competenti nelle diverse tematiche trattate dai
contributi. Questi forniranno al Comitato Direttivo gli elementi
necessari per valutare la correttezza e l’utilità, segnalando la
necessità di modifiche o integrazioni per migliorarne le caratteristiche
o evidenziando gli aspetti che, se non correttamente modificati, ne
potrebbero impedire la pubblicazione.
3
News di Redazione
L'Anvur ha classificato la Rivista Segni e Comprensioni come Rivista
Scientifica nell'Area 11
4
INDICE
Editoriale
PERCHE’ PERDONARE
Daniela De Leo
7
Saggi
“CHIEDERE PERDONO”
IL PRIMO DOVERE DEL MEDICO
Luisella Battaglia
13
COLPA, PENTIMENTO, PERDONO
UNA INTRODUZIONE ETICO - RELIGIOSA
Paola Ricci Sindoni
36
Note
PERDONO DI SÉ E PERDONO IN SÉ
NELL’ULTIMO DOSTOEVSKIJ
Federica Bergamino
53
“IL Y A LE PARDON”. PICCOLA FENOMENOLOGIA
DEL PERDONO, A PARTIRE DA PAUL RICOEUR
Annalisa Caputo
75
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA
Juan Carlos García Jarama
111
PERDONO E RICONCILIAZIONE: SONO ANCORA CONSIDERATI
NECESSARI NEL MONDO CONTEMPORANEO?
Augusta Fiore
130
5
LUIGI STURZO E “LA MISERICORDIA”,
TEMA DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DI PAPA FRANCESCO
Salvatore Latora
152
LA MISERICORDIA COME ‘PRINCIPIO PEDAGOGICO’.
LA POIESI DI UNA NUOVA FORMA COMUNICATIVA
Gaspare Pitarresi
157
PAROLA, RESPONSABILITÀ, PERDONO: UNA PREMESSA
FILOSOFICA
Romano Romani
177
Resoconti
RÉFLEXIONS SU MARCEL CONCHE
Santo Arcoleo
180
UNA LINEA INTENSIVA. RIFLESSIONI SU DELEUZE E FOUCAULT
A PARTIRE DA L’ORDINE DISCONTINUO DI DEBORAH DE ROSA
Claudio D’Aurizio
215
UNA FILOSOFIA “MILITANTE”. TRACCE DI LETTURA SU
LA LOTTA PER LA SCIENZA DI GIUSEPPE SEMERARI
Rossana de Gennaro
231
6
Daniela De Leo
Nel discorso filosofico internazionale contemporaneo,
anche prima dell’avvento di Papa Francesco, che ha dato
a questo tema, soprattutto con l’indizione del Giubileo
della Misericordia, un impulso formidabile, il tema del
perdono ha sempre avuto una rilevanza fondamentale.
Ecco perché con questo numero monografico sul
Perdono i saggi ospitati nella nostra Rivista si prefiggono
come scopo quello di contribuire a tale dibattito.
L’intento è di “attrezzare” il lettore perché possa
rintracciare le potenzialità e le possibilità di rielaborazione
semantica che lo stesso termine “perdono” dischuide.
Punto di partenza la Lettera Apostolica redatta a
conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia:
“E tutti uscirono di scena. Soli restarono Lui e lei; restò il
Creatore e la creatura. Restò la Miseria e la Misericordia,
lei consapevole del suo reato e Lui che ne rimetteva il
peccato” queste parole del commento di Sant’Agostino al
Vangelo di Giovanni, rappresentano l’icona di quanto
celebrato nell’Anno Santo.
Perché partire da quell’episodio per spiegare il senso del
perdono, e soprattutto perché il perdono può trovare un
senso in questo incontro tra l’adultera e il Signore?
EDITORIALE
L’APERTURA DEL PERDONO
7
Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, adultera e,
secondo la Legge, giudicata passibile di lapidazione; Lui,
che con la sua predicazione e il dono totale di sé, che lo
porterà alla croce, ha riportato la legge mosaica al suo
genuino intento originario. Al centro non c’è la legge e la
giustizia legale, ma l’amore di Dio, che sa leggere nel
cuore di ogni persona, per comprenderne il desiderio più
nascosto, e che deve avere il primato su tutto. In questo
racconto evangelico, tuttavia, non si incontrano il peccato
e il giudizio in astratto, ma una peccatrice e il Salvatore.
Gesù ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel
suo cuore: vi ha trovato il desiderio di essere capita,
perdonata e liberata. La miseria del peccato è stata
rivestita dalla misericordia dell’amore. Nessun giudizio da
parte di Gesù che non fosse segnato dalla pietà e dalla
compassione per la condizione della peccatrice. A chi
voleva giudicarla e condannarla a morte, Gesù risponde
con un lungo silenzio, che vuole lasciar emergere la voce
di Dio nelle coscienze, sia della donna sia dei suoi
accusatori, i quali lasciano cadere le pietre dalle mani e
se ne vanno ad uno ad uno (cfr. Gv 8,9). E dopo quel
silenzio, Gesù dice: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata? Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non
peccare più» (vv. 10-11). In questo modo la aiuta a
guardare al futuro con speranza e ad essere pronta a
rimettere in moto la sua vita; d’ora in avanti, se lo vorrà,
potrà “camminare nella carità” (cfr. Ef. 5,2). Una volta che
si è rivestiti della misericordia, anche se permane la
condizione di debolezza per il peccato, essa è sovrastata
dall’amore che permette di guardare oltre e vivere
diversamente. Il perdono diventa sigillo tra i due
8
protagonisti, si proietta nel futuro di un progetto di vita
diverso, ma ha anche una potenzialità celata: perdonare
per riconoscersi misericordiosi. Perdere la dimensione
storico-oggettiva del giudicare per assumere quella
storico-attuativa del mettersi in ascolto prima in se stessi
e poi degli altri. “Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e
ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di
cattiveria! Siate invece benevoli misericordiosi gli uni
verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi
ha perdonati in Cristo” (Ef 4:31-32).
La dimensione del perdono prende forma: è uno spazio in
cui c’è un incontro profondo tra i due protagonisti, una
intesa in cui ci si sente accolti, accettati, non un semplice
“far finta” che ciò non sia mai accaduto, ma riconoscere
che ciò che è accaduto deve essere distinto. Il perdono
occupa uno spazio, ma anche un tempo. Non è però il
tempo del presente, dell’ora in cui si riconosce l’errore e si
dona il perdono, ma il tempo del futuro. Sì, il perdono è da
collocarsi nel futuro. L’atto del perdonare proietta
entrambi i protagonisti – la peccatrice e il Salvatore - in
una dimensione futura. Ciò che è ora stato perdonato è
diviso da ciò che è stato ed è direzionato nel futuro, in un
vivere diversamente da prima. L’essenza del perdono
consiste nel restituire la capacità di agire a colui che
rischierebbe di restare inchiodato all’azione compiuta, se
non gli si offrisse la possibilità di diventare qualcosa di
diverso da ciò che ha fatto. Nel perdono c’è l’irriducibilità
di ognuno ai suoi fallimenti. Perdonare infatti non vuol dire
solo ricostruire una relazione interrotta in seguito a
un’offesa: si tratta di riaprire per l’altro le relazioni di vita.
9
“Il perdono instaura un’era novella, istituisce nuovi
rapporti, inaugura una vita nova. La notte della colpa, nel
graziato, presagisce una nuovissima aurora; l’inverno del
rancore in colui che grazia, annuncia una nuovissima
primavera”1.
Per conoscere il perdono occorre, dunque, sperimentarlo.
Il provare misericordia, cioè quel sentimento di pietà e di
comprensione, spinge al perdono. La misericordia spinge
verso il perdono e predispone, prepara, fa comprendere
ed amare colui che perdoneremo, libera dall’odio e dal
rancore.
Il perdono inizia da se stessi per potere essere donato,
questo il fondamento del termine, di cui il rimando
etimologico chiarisce il senso. Perdono dal latino
medievale perdonare, comp. di pĕr rafforzativo e donāre.
Questo rafforzativo ci fa comprendere che il termine
perdono non rimanda ad un semplice condonare –
rimettere i peccati, ma ad un processo di “sentire se
stessi”, come attanti del donare incondizionatamente. Il
perdono infatti non è un semplice “fare pace”, un “non
rispondere alle offese”, ma è un atto volontario
incondizionato e gratuito: “Padre perdona loro perché non
sanno quello che fanno” (Lc 23:33).
Perdonare fino a “settanta volte sette” (Mt 18:21-22)
risulta così educativo per un formarsi etico.
Il perdono si applica a ciò che deve essere perdonato,
non scusato, si può dunque occupare solo di ciò che va
oltre la semplice scusa, perché non si cura di giustificarsi
dato che non può fornire ragioni a suo favore. Esso
1
V. Jankélévitch, Le pardon, Aubier - Montaigne, Paris 1967, trad. it di L. Aurigemma,
Il perdono, I.P.L., Milano 1968, p. 215
10
perdona a chiunque, all’uomo in quanto uomo non
secondo le sue particolari determinazioni. Il perdono,
come l’amore, “perdona qualunque cosa indistintamente,
così come perdona a chiunque; perdona tutto a tutti e non
si attarda a far distinzioni fra le colpe gravi e le colpe
leggere”2 .
Si è capaci di perdonare, se si è stati perdonati, cioè si è
in grado di comprendere cosa sia il perdono solo nella
misura in cui abbiamo una certa esperienza del perdono,
ricevuto ed esercitato nella realtà quotidiana. Perdonare
non è un semplice saldare un debito, ma ricostruire sulle
rovine di una richiesta. Infatti il perdono si costruisce sul
dialogo tra colui che chiede il perdono e colui che
risponde a tale richiesta. Dunque il perdono aiuta a
ricostruire, in quanto aiuta colui al quale si perdona a
comprendere se stesso, ad accettarsi, a rinunciare alle
proprie
rivendicazioni
relative
all’esaltazione
e
all’umiliazione. Ma tale cammino, lo scandire di tali tappe,
è un perdere qualcosa, è un cambiare. Un guardare con
occhi diversi l’oggettività dell’accaduto, non orientarsi
verso la colpa, ma scorgere l’altro come altro da se,
entrare nel conflitto delle interpretazioni, per riemergere
con una ermeneutica della compassione: dare alla
peccatrice la possibilità di entrare nella dimensione
dell’essere salvata.
È questa l’apertura che la riflessione diversificata e
articolata nel presente volume offre al lettore: perdonare è
un per -donare, cioè sperimentare il donare se stessi
quale modello per interrogare gli eventi.
2
Ivi., p. 141
11
Si perdona l’offesa non nel momento in cui viene
impressa sulla propria carne la cicatrice dell’offesa
ricevuta e grava come un peso, ma quando si avverte la
leggerezza del proprio essere, è questo il vivere
diversamente da prima, quell’essere misericordiati che
crea il circolo salvifico del perdono, misericordiati per
misericordiare.
12
SAGGI
“CHIEDERE PERDONO”
IL PRIMO DOVERE DEL MEDICO
Luisella Battaglia
“Il medico incline alla saggezza
è simile a un dio”.
Ippocrate
13
In una delle scene più intense ed enigmatiche de Il posto
delle fragole (1957), il capolavoro di Ingmar Bergman, il
protagonista Isak Borg, un grande medico a fine carriera,
sogna di rifare l’esame di stato per l’abilitazione alla
professione. Gli viene chiesto qual è il primo dovere del
medico ma lui non sa rispondere. Eppure, insistono i
commissari, è semplice: “il primo dovere del medico è
chiedere perdono”.
Mi sono da sempre interrogata su questa risposta
ricchissima di suggestioni di cui coglievo, insieme, il
mistero e la profondità. Che cosa intendeva dire
Bergman? E a quali riflessioni può introdurci oggi questa
risposta che, al di là della vicenda umana del
protagonista, apre a interrogativi sulla natura stessa della
professione medica? Certo, il tema del perdono è
profondamente intrecciato alla storia personale di Isak
Borg, ma quel “dovere” assume una risonanza speciale
per il suo essere medico e anticipa profeticamente molte
delle questioni che agitano il dibattito contemporaneo. La
nascita della bioetica negli anni settanta ha posto, infatti,
al centro della discussione il grande tema della crisi della
medicina occidentale del nostro secolo, una medicina che
punta sempre più sulla tecnologia, sulla perfezione della
diagnosi e sempre meno sul rapporto tra medico e
paziente. Tale crisi sembra attribuibile in parte ai medici,
sempre più burocratizzati, e in parte alle esigenze di
un’organizzazione che spinge ad aumentare la loro
produttività, in nome dell’economia e dell’efficienza.
Siamo in presenza di un sistema che non attribuisce più
una valenza positiva al tempo trascorso con il paziente,
tempo che, al contrario, viene associato al concetto di
perdita invece di essere considerato un investimento e
valutato come una parte importante della stessa terapia.
Per studiare questo fenomeno può essere utile partire da
una sia pur sommaria riflessione sulla natura stessa della
medicina, una riflessione, appunto, a cui il film ci invita,
ricordandoci che, prima di essere un sapere, la medicina
è innanzitutto un rapporto che si instaura tra due persone:
colui che cura e colui che è curato. Originariamente la
medicina è dunque un dialogo, una reciprocità che non
può stabilirsi che nel colloquio singolare della relazione
tra due soggetti. Il medico e filosofo Georges Canguilhem
sottolinea lungamente nelle sue opere il significato e
l’importanza di tale singolarità.
14
Il colloquio è singolare – scrive – proprio perché
individualizzato, tale da ricominciare ogni volta e quindi
non classificabile in quanto relazione tra due individui
assolutamente unici1.
È proprio sul finire degli anni 50 che comincia a profilarsi
una crisi della medicina che si manifesta soprattutto nei
suoi modi d’essere relazionali con la società, la cultura, le
istituzioni, i pazienti. Un film come Il posto delle fragole lo
testimonia esemplarmente mostrando come il medico
debba ormai fare i conti con un approccio riduzionistico
che lo induce a vedere nel paziente non tanto una
persona nella sua integralità, quanto piuttosto una somma
di parti o di organi. Da qui il pericolo di un progressivo
impoverimento della relazione terapeutica che rischia di
approdare – come ha osservato Giorgio Cosmacini - ad
una sorta di “nichilismo curativo”, caratterizzato
dall’assenza di ascolto e di dialogo e da una generale
carenza del ‘prendersi cura’2. Emblematica è la figura del
protagonista, un medico di chiara fama e illustre
ricercatore che appare tuttavia incapace di esercitare
l’ippocratica ars curandi e, soprattutto, è dimentico
dell’importanza del com-patire, del sentire come propria la
sofferenza dell’altro.
Ripercorriamo brevemente la trama del film. In una sorta
di presentazione, Isak Borg spiega le ragioni del suo
progressivo isolamento dalla vita sociale attraverso una
constatazione assai amara: “i nostri rapporti con il
prossimo si limitano, per la maggior parte, al pettegolezzo
1
G.Canguilhem, Il normale e il patologico, Einaudi, Torino 1998.
G.Cosmacini, La qualità del tuo medico. Per una filosofia della medicina, Laterza,
Roma-Bari1995.
2
15
e a una sterile critica del suo comportamento. Le mie
giornate trascorrono in solitudine e senza troppe
emozioni. Ho dedicato la mia esistenza al lavoro e di ciò
non mi rammarico affatto. Incominciai per guadagnarmi il
pane quotidiano e finii con una profonda, deferente
passione per la scienza”. Dopo aver descritto la sua
famiglia - la madre vecchissima chiusa nei suoi ricordi, la
moglie non amata e non rimpianta, morta da diversi anni,
il figlio medico freddo e distante, la giovane nuora che
soffre di un rapporto tormentato col marito - sente il
bisogno di fornire un’ulteriore informazione: “dovrei
aggiungere che sono un vecchio cocciuto e pedante.
Questo fatto rende sovente la vita difficile sia a me che
alle persone che mi stanno vicine. Mi chiamo Isak Borg e
ho 78 anni. Domani nella cattedrale di Lund si celebrerà il
mio giubileo professionale”. Siamo dinanzi al lucido
autoritratto di un professionista stimato che tuttavia, dietro
la facciata di bonarietà, di modi gentili e formalmente
corretti, si rivelerà gelido, egoista, sordo ai bisogni e ai
sentimenti degli altri, oppresso da pensieri angosciosi e
oscuri presagi. Anche la mattina della partenza per Lund,
Borg è scosso da un sogno inquietante. Si trova in una
città sconosciuta dove gli orologi pubblici sono privi di
lancette e avvengono episodi spaventosi: un uomo senza
volto si accascia improvvisamente a terra, un carro
funebre si schianta contro un lampione facendo cadere
una bara da cui esce una mano che lo afferra, la mano di
un morto in cui riconosce sé stesso. L’incubo evoca
chiaramente un presagio di morte, quella morte non solo
fisica ma soprattutto interiore da cui Borg è terrorizzato. Il
viaggio in macchina da Stoccolma a Lund in compagnia
16
della nuora, attraverso deviazioni non previste del
percorso verso quei luoghi della giovinezza di cui il “posto
delle fragole” è il magico simbolo, sarà l’occasione di
rivivere ricordi penosi e memorie dolorose che daranno,
tuttavia, origine ad un radicale ripensamento della propria
esistenza. Cammino, dunque, di conversione e di
cambiamento, tragitto a ritroso nel tempo ma, insieme,
viaggio all’interno di sé stesso per ritrovare antiche radici,
scoprire insanabili contraddizioni, confessare tragici errori.
Particolarmente significativa, come si è detto, è la
sequenza dell’esame, il momento rituale che – come
sottolinea James Hillman - mette alla prova non solo le
nostre capacità e le nostre conoscenze ma anche la
nostra vocazione. “Il mio daimon vuole davvero la strada
che ho scelto? La mia anima è davvero coinvolta?”3. Se il
riuscire bene in un esame può rappresentare una
conferma, una bocciatura può essere il modo in cui il
daimon ci fa sapere che abbiamo preso la direzione
sbagliata. È appunto ciò che si chiede angosciosamente
Isak Borg, dal momento che l’esame sembra rivelare in
modo clamoroso la sua incompetenza. Batteriologo di
fama, non risulta in grado di riconoscere i batteri al
microscopio, dichiara morta una persona che invece è
viva, e, infine, non sa rispondere alla domanda cruciale
relativa al suo dovere professionale di medico. Il giudizio
finale non solo sarà negativo ma verrà gravato da accuse
di indifferenza, di incomprensione e di insensibilità che
comporteranno un verdetto inappellabile: la condanna alla
solitudine. Attraverso un continuo gioco di rimandi, per cui
3
J. Hillman, Il codice dell’anima, Adelphi, Milano 1997, p.138.
17
l’esame di stato si trasforma in un vero e proprio giudizio
che provocherà, a sua volta, un ineludibile esame di
coscienza, il “chiedere perdono” riguarderà ormai non
soltanto la sua vita professionale ma coinvolgerà la sua
intera esistenza. A proposito dei suoi sogni angosciosi,
Isak confesserà infatti: “è come se cercassi di dire
qualcosa a me stesso, qualcosa che non voglio udire
quando sono sveglio. Quel ‘qualcosa’ è che sono morto,
pur essendo vivo”. La confessione allude chiaramente alla
morte dei sentimenti, alla freddezza glaciale che ha
improntato i suoi rapporti con gli altri e che ha anche
comportato l’oblio del nucleo etico e della dimensione
antropologica della sua professione.
Viene in tal modo prefigurata nel film una situazione che
stiamo oggi vivendo. La medicina scientifica ha compiuto
straordinari progressi: tecniche sempre più sofisticate
consentono al malato di vedersi in tre dimensioni, il
medico lo può curare a distanza grazie alla telemedicina,
il chirurgo può operare senza toccare direttamente il
malato. Progressi innegabili che celano tuttavia un
pericolo, quello di vedere l’individuo oltrepassato dal
sovra-individuale, ignorato nella sua singolarità dalle
esigenze classificatorie. Che resta allora della relazione
originaria, di quel colloquio descritto fin dall’antichità da
Ippocrate e dai suoi discepoli dell’isola di Kos? Il malato è
solo un “caso”? Sarà curato secondo le norme ottenute
attraverso la somma di casi comparabili? Le conferenze
di consenso rappresentano, lo sappiamo, un tentativo di
universalizzazione delle conoscenze mediche al fine di
una cura sempre più efficace. Un’impresa di grande
rilievo ma – e qui si ripropone la domanda – quanto
18
compatibile
con quell’ideale
medico ippocratico
dell’accompagnamento individuale e individuato di ogni
malato, con la relazione definita come colloquio
singolare? È sempre Canguilhem a ricordarci che la
definizione della malattia richiede, come punto di
partenza, la nozione di essere individuale. Si tratta di
un’affermazione ancora valida? Qual è il posto del malato
nella malattia, in una medicina sempre più spinta verso
l’universalizzazione e chiamata a divenire una scienza
dell’oggetto umano?
La medicina della persona
Ritorniamo a Isak Borg. Quali sono i peccati che deve
farsi perdonare? Si tratta solo degli errori inevitabili
commessi nel corso della sua carriera? A questo
riguardo, occorre sottolineare che Borg è stato, almeno
all’inizio della professione, un medico molto apprezzato
dai suoi pazienti, come dimostra una scena significativa
del film in cui una coppia di benzinai rifiuta recisamente di
essere pagata per il rifornimento della benzina in nome
della perenne gratitudine (“noi non dimentichiamo!”) che
nutrono per quello che fu il loro medico condotto. Ed ecco
il primo momento di rammarico del protagonista: aver
abbandonato la professione per dedicarsi alla ricerca:
“Non avrei dovuto allontanarmi da qui”. Non è casuale, a
ben vedere, la scelta della sua specializzazione - la
batteriologia –, una scelta che sottolinea ulteriormente il
suo distacco, il guardare la realtà attraverso uno
strumento, il microscopio, che ha accentuato il suo
19
‘sguardo clinico’, non certo empatico, contribuendo a
rafforzare il suo isolamento dagli altri. A lui, in quanto
specialista, non sembra interessare, dal punto di vista
professionale, la persona intera in cui si imbatte e tanto
meno il suo vissuto, cioè il modo in cui vive il suo rapporto
col mondo e la malattia. Il suo interesse di “medico
nell’età della tecnica” – per riprendere il titolo di un
celebre libro di Karl Jaspers – si focalizza ormai solo sulla
specifica parte malata del corpo. Per questo, dinanzi alla
parcellizzazione specialistica delle competenze sanitarie,
il malato “si vede di fronte a medici nessuno dei quali è il
suo medico”4. Ma perché si afferma quello ‘sguardo’ che
avrà tanta importanza nella storia della medicina?
In Nascita della clinica Michel Foucault tratteggia
magistralmente il cammino compiuto dalla medicina
moderna, dalla metà del XVIII secolo, concentrandosi sul
momento – la rivoluzione francese – in cui essa si
distacca dalla metafisica: si sviluppa lo “sguardo clinico” e
l’ospedale, inteso come ““cittadella fortificata della
salute”“, consente di collocare il fatto patologico in una
serie, permettendone la classificazione5. Lo sguardo
clinico perfetto, che appare come lo sforzo della
razionalizzazione di un’intuizione, corrisponde per
Foucault al sogno di una struttura aritmetica del
linguaggio medico legato al mito di un sapere oggettivo
che vuole liberarsi da una soggettività – quella appunto
del colloquio singolare tra due esseri umani – ritenuta
nociva alla conoscenza. Si intende, pertanto, studiare
direttamente quel corpo umano che diviene a tutti gli
4
5
K. Jaspers, Il medico nell’età della tecnica, Cortina, Milano 1991, p. 51.
M. Foucault, La nascita della clinica, Einaudi, Torino 1969.
20
effetti l’oggetto del sapere medico. In tal modo viene
messo in evidenza quello che può considerarsi lo statuto
epistemologico della medicina moderna: l’affermazione di
una verità come adeguazione (vedere/sapere) che
costituirà il fondamento del cosiddetto “paradigma
biologico”. Con esso ci si propone di costituire un sapere
oggettivo del corpo nel quadro di una medicina intesa
come scienza esatta: una visione ancora pesantemente
positivistica, secondo la quale non vi sarebbe sapere
medico senza l’oggettivazione della malattia e del malato.
Ciò che conta è la precisione matematica dei dati di
laboratorio, piuttosto che l’intuizione e l’interpretazione dei
segni clinici, perché intuizione e interpretazione
appartengono al campo delle informazioni che vengono
ritenute aleatorie e inattendibili. Il rischio, tuttavia, è di
“sradicare” il soggetto, di non rendersi conto delle
difficoltà della clinica, della diagnostica e della presa in
carico terapeutica, in nome di una medicina troppo
sbilanciata sul versante delle scienze naturali, incapace di
integrare il sapere che deriva dalle discipline umanistiche.
È questo fondamentalmente il modello cui si ispira Isak
Borg che agisce come puro tecnico, senza rischiare alcun
coinvolgimento emotivo, rifugiandosi nel laboratorio dove
spirito e corpo possono essere separati con rassicurante
nettezza. Il suo è un blocco affettivo, una patologia dei
sentimenti e della comunicazione.
Al di là degli errori di distorsione prodotti dallo ‘sguardo
clinico’, potremmo forse suggerire che la richiesta di
perdono implichi anche l’ammissione di non sapere, e
quindi la confessione socratica della propria ignoranza? In
un testo dedicato specificamente all’importanza della
21
formazione etica in medicina, cioè Manuale di etica per il
giovane medico, vengono sintetizzate efficacemente le
domande che un medico dovrebbe porsi per entrare nel
territorio dell’etica: “Sto facendo la cosa giusta? Mi sono
comportato onestamente? Ho calpestato un diritto? Sto
difendendo un mio interesse? Ho procurato una
sofferenza ingiustificata? Cosa significa rispettare
l’autonomia del paziente? Quanta parte di verità dovrei
rivelare?” Secondo il manuale ci sono una serie di peccati
per cui il medico dovrebbe chiedere perdono. Innanzitutto
“per la presunzione comune a molti di noi medici, forse
alla maggior parte, di credere di poter davvero esaudire la
domanda di ascolto e di attenzione insita in ogni relazione
di cura. O, ancora, per la trascuratezza e la superficialità
con
cui
abbiamo
soppesato
un’espressione
insopportabile, ascoltato una frase spiazzante, liquidato
un caso sconveniente. O, infine, per il torto di non aver
mostrato lo sguardo inconfondibile di chi è pronto a
vegliare su chi soffre come se fosse un figlio proprio.
Insomma, per aver dimenticato la nostra umanità”6.
Il guaritore ferito
Giungiamo qui al punto veramente essenziale: per poter
curare le altrui ferite occorrerebbe ammettere la propria
vulnerabilità. Affiora inevitabilmente, nell’ethos che
dovrebbe informare il comportamento del medico,
l’immagine classica del ‘guaritore ferito’ rappresentato, nel
6
U. Veronesi, G. Macellari, Manuale di etica per il giovane medico, F. Angeli, Milano
2016, p. 284.
22
racconto di Apollodoro, dal centauro Chirone. Il quale – si
ricorderà - insegna l’arte medica ad Asclepio dopo essere
stato ferito da una freccia che gli procura una piaga
inguaribile, ciò che gli consentirà di sviluppare una
profonda sensibilità e una totale disponibilità a sentire
come proprio l’altrui dolore. Ecco l’importanza del compatire, della condivisione della sofferenza7. Ne deriva – lo
rileva Gadamer - una configurazione dell’arte medica
come intreccio tra competenza tecnica e disponibilità
umana, tra sapienza scientifica e saggezza personale8.
La relazione tra medico e paziente, di conseguenza,
riesce a realizzarsi pienamente quando il medico assume
su di sé il limite esistenziale implicito nell’offesa
invalidante della malattia.
Il dovere del medico di chiedere perdono sembrerebbe,
pertanto, riguardare la sua incapacità di accettare e
sentire come propria la sofferenza dell’altro. Potremmo
aggiungere, seguendo ancora James Hillman, che la cura
della malattia è dentro la malattia stessa la quale
dovrebbe essere integrata nella vita, indagata
problematicamente nei suoi aspetti, al di fuori soprattutto
degli schemi causalistici che pretendono di dar conto di
come certi eventi avvengano senza indagarne il perché9.
Saranno allora le trame perdute, gli orditi complessi che
appartengono all’esistenza quotidiana – e complicazioni
sentimentali, i drammi individuali, i conflitti interpersonali,
le aspettative e le delusioni – che abbiamo “perduto”,
perché appunto le abbiamo smarrite lungo il cammino
7
A. Montano, Il guaritore ferito, Bibliopolis, Napoli 2004.
H. G. Gadamer, Dove si nasconde la salute, Cortina, Milano 1994, p. 79.
9
J. Hillman, Trame perdute, Cortina, Milano 2001.
8
23
delle spiegazioni deterministiche e delle strategie di
sicurezza e di benessere, a ritrovare la loro centralità.
L’invito di Hillman è di contrastare quella spinta verso la
normalizzazione che ci rassicura per la sua uniformità,
che ci fa capire perché siamo malati, perché lo siamo
delle stesse malattie e che ci cura con gli stessi farmaci:
occorre invece recuperare la diversità, la differenziazione,
la molteplicità, riconoscendo che la malattia è una
presenza costante e corposa della nostra vita, un segnale
della sua precarietà, nella estrema varietà delle sue
componenti affettive, emozionali e culturali. Esiste, in altri
termini, un “lato d’ombra” anche nelle malattie del corpo
che ne rappresenta la componente psicologica,
inafferrabile e che appartiene al paziente in modo così
peculiare da poter affermare che “la malattia è il paziente
stesso”. Ancora una volta, anziché attenersi ai modelli
generali di riferimento per conoscere la malattia, è
necessario individuare gli scarti che sempre esistono tra i
modelli e il singolo malato.
La ricostruzione etimologica di alcuni termini chiave si
rivela, in questo quadro, particolarmente utile. Hillman ci
ricorda, ad esempio, che medicus richiama il verbo latino
mederi che significa “prendersi cura” e che la parola
greca therapeia ha anch’essa tale significato: “la sua
radice Dher vuol dire portare, sostenere [...]. Il terapeuta è
uno che porta e presta attenzione nello stesso modo di un
servitore”10. Per questo, il medico che passeggia “lungo le
sale bianche dell’ospedale, con graziose nozioni della
sofferenza, della causalità, della malattia e della morte”
10
Id. Il suicidio e l’anima, Astrolabio, Roma 1999, pp.90-91.
24
dovrebbe ritrovare la strada verso la visione più antica e
integrata della sua vocazione, specie in quelle situazioni
difficili della medicina moderna che “mostrano come
l’aspetto umano sia caduto nell’ombra”. È la stessa
predilezione per la patologia scientifica ad allontanarlo
dalla comprensione della sofferenza in favore della
spiegazione della malattia: la sua attenzione è spostata
dal soggetto all’oggetto, da colui che è disturbato al
disturbo e alla sua causa. Ma soprattutto diventa
immemore della sua stessa vulnerabilità. “I medici” rileva
Hillman “sono notoriamente cattivi pazienti forse perché
hanno perduto la capacità di essere feriti11.
In conclusione: Isak Borg dovrebbe chiedere perdono per
non aver riconosciuto la propria vulnerabilità, per non aver
saputo essere un “guaritore ferito”? Mi sembra un’ipotesi
degna di interesse che potrebbe essere suffragata dalla
definizione della medicina proposta da Paul Ricoeur ne Il
giudizio medico come “una delle pratiche fondate su una
relazione sociale che ha nella sofferenza la motivazione
fondamentale e nella speranza, per l’ammalato, di essere
aiutato e guarito, il suo telos”.12 Si sottolinea, in tal modo,
la struttura relazionale dell’atto terapeutico il cui nucleo
etico è costituito dal patto di fiducia che impegna quel
paziente e quel medico e che conclude un percorso
segnato all’inizio da una notevole asimmetria: da un lato
colui che sa e sa fare, dall’altro colui che soffre.
11
12
Ivi, p.103.
P. Ricoeur, Il giudizio medico, Morcelliana, Brescia 2006, p.31.
25
La lezione di Ricoeur. Il ‘patto di cura’
L’istituzione di un patto di cura può considerarsi come un
vero e proprio cammino che prevede una serie di passi da
parte di entrambi i partner per colmare il fossato iniziale.
Innanzitutto il paziente “porta al linguaggio” la sua
sofferenza, la descrive, ne narra la storia; avanza la sua
richiesta di salute e promette di osservare il protocollo del
trattamento proposto. A sua volta, il medico compie l’altra
metà del cammino, attraverso l’accettazione del malato, la
formulazione di una diagnosi, la prescrizione di una
terapia, e quindi la promessa di seguire il paziente. Un
impegno, come si vede, che vincola entrambe le parti e
che fa sì che il patto di cura divenga una sorta di alleanza
contro il nemico comune: la malattia. Ma come comunica
il medico e come dovrebbe comunicare? Isak Borg agisce
da puro tecnico, senza rischiare alcun coinvolgimento
emotivo e senza aver vissuto i sentimenti da cui la tecnica
prescinde: dolore, impotenza, paura, disperazione.
Eppure occorre trovare le parole perché l’alleanza
terapeutica possa effettivamente realizzarsi.
Con la crisi del modello positivistico è emersa la necessità
di ripensare lo stesso vocabolario medico relativo alla
malattia. Sentiamo ormai di avere un vocabolario
colpevolmente povero per “dire” la sofferenza umana: per
questo dovremmo moltiplicare le nostre parole, elaborare
concetti per nominare in modo più attendibile l’universo
così multiforme, variegato, plurimo del disturbo, della
sofferenza, della dissonanza. L’interpretazione del
termine malattia, così come ci è fornita dalla scienza
medica, non ci soddisfa più giacché la malattia, nella
coscienza collettiva, ormai non è solo un problema
26
biochimico, genetico o disfunzionale ma è un concetto
che si allarga fino a includere disagio, dolore, malessere.
Ne discende una diversa visione della malattia come
esperienza di un soggetto in una data situazione e un
richiamo alla dimensione soggettiva della sofferenza: si
può certo partire dal dolore in generale, elaborando
categorie utili a fissarne e a precisarne la fenomenologia
ma il rischio è di dimenticare l’individuo che soffre. Da qui
una crescente attenzione per le modalità personali,
esistenziali, profonde con cui il singolo vive e si
rappresenta la sua malattia. Grazie alla medicina
antropologica si è fatta strada la consapevolezza
dell’insufficienza di un approccio meramente quantitativo
alla sofferenza: ciò ha significato il recupero dello spazio
della soggettività e il riconoscimento delle dissonanze
inevitabili tra le categorie generali dei manuali e i vissuti
concreti dei sofferenti. Ma pare soprattutto importante
considerare con la massima attenzione tutte quelle auto
rappresentazioni cariche di significati simbolici secondo
cui il soggetto vive il suo dolore. In tal modo si assiste a
quello che potremmo chiamare il passaggio della
medicina dalla misurazione alla narrazione13. Ricoeur –
che ha posto con forza l’accento sul racconto,
incardinandolo nella condizione umana – sottolinea a
ragione il profondo significato del “portare al linguaggio” la
sofferenza da parte del paziente, come di un momento
fondativo del patto di cura, cogliendone la duplice valenza
etica e epistemologica. Il dolore che il paziente narra non
coincide infatti esattamente con il male che il medico
13
B. Good, Narrare la malattia, Ed. di Comunità, Torino 1999. S. Spinsanti, La
medicina vestita di narrazione, Il Pensiero Scientifico edizioni, Roma 2016.
27
cerca. Accanto al semplice recupero espressivo della
sofferenza, che rappresenta un primo elemento di
elaborazione, esiste infatti un secondo livello nel corso del
quale la malattia è ricostruita nella sua genesi e inserita in
un contesto individuale che può favorire sia l’anamnesi
esistenziale e relazionale del vissuto del paziente, sia la
costruzione condivisa con il medico del significato del
vissuto della malattia. In tal modo il rapporto viene a
configurarsi come un’autentica relazione ermeneutica.
Ricoeur non si nasconde tuttavia la fragilità di un patto
insidiato fin dall’inizio dal sospetto, il contrario quindi di
quella fiducia che è minacciata, dal lato del paziente, dalla
diffidenza nei confronti del potere medico e dei suoi
possibili abusi e, dal lato del medico, dall’intrusione sia
delle scienze biomediche, tendenti all’oggettivazione del
corpo umano, sia dalla prospettiva della sanità pubblica,
che verte sull’aspetto non più individuale ma collettivo del
fenomeno generale della salute.
Ancora una volta, Isak Borg sembra testimoniare col suo
comportamento questa oggettiva difficoltà, laddove la
forte connotazione etica del patto di cura intende appunto
contrastarla con il suo riferirsi alla aristotelica phronesis,
alla saggezza pratica, che, sul piano medico, si traduce
per Ricoeur in tre fondamentali precetti. Vale la pena, ai
fini del nostro discorso su “il primo dovere del medico”,
seguirne analiticamente il percorso. Innanzitutto, il
riconoscimento del carattere singolare della persona del
paziente e quindi della situazione di cura: dietro ogni
malattia c’è la presenza di un soggetto che struttura la
sua sofferenza, facendone un elemento della sua
biografia. Solo rispettando questa indicazione si può
28
umanizzare la scienza medica e recuperare il rapporto del
medico con un soggetto che è l’uomo nella sua totalità. In
secondo luogo, l’indivisibilità della persona, da cui
discende il dovere di considerare non una molteplicità di
organi e di funzioni ma il malato nella sua integralità,
evitando ogni frammentazione e sfasatura tra dimensione
biologica, psicologica e sociale. Infine, la stima di sé, e
quindi il riconoscimento del proprio valore da parte del
paziente stesso, di grande importanza poiché la
situazione di cura, specie nell’ospedalizzazione, induce la
regressione a comportamenti di dipendenza umilianti per
la dignità della persona. È questo, occorre aggiungere, un
rischio cui si è particolarmente esposti specie quando si
entra nella fase dei trattamenti invasivi o nelle situazioni
che si possono definire terminali. In tali casi, tende infatti
insidiosamente a ristabilirsi quella condizione di
ineguaglianza da cui la costituzione del “patto di cura”
presumeva di allontanarsi: occorre pertanto ritornare
all’esigenza di base del patto che prevedeva il
coinvolgimento e la corresponsabilità di entrambi i partner
chiamati a una vera e propria alleanza.
Le virtù del medico e la ‘buona cura’
La classica virtù della prudenza, chiamata da Ricoeur
“saggezza
pratica”,
richiede
che
si
precisino
esplicitamente gli elementi più determinanti di ogni
situazione particolare per contestualizzare nel modo
migliore la decisione che verrà presa e le sue
29
giustificazioni etiche. L’esercizio della prudenza cerca
infatti di assumere la doppia complessità della medicina,
divisa tra istanze generalizzanti e situazioni singolari, dal
momento che il passaggio dal tradizionale rapporto a due
poli – paziente/medico – a un modello ramificato e
composito
rischia
di
trasformare
la
relazione
interpersonale in relazione depersonalizzata, soprattutto
se accompagnata a forme crescenti di burocratizzazione
della figura del medico. Di conseguenza, l’autonomia,
lungi dal ridursi alla sola accezione negativa della “non
interferenza”, dovrebbe essere intesa positivamente sia
come fonte del dovere del medico di informare il paziente
e verificare, in un vero e proprio processo di
comunicazione, l’effettiva comprensione dell’informazione
data; sia come capacità dello stesso medico di ascolto e
comprensione delle richieste del paziente, capacità
necessaria per individuare le scelte terapeutiche più
opportune e rispettose della persona nella sua interezza.
Se l’informazione è lo strumento che consente di
eliminare o, quanto meno, di attenuare l’asimmetria
conoscitiva caratteristica del rapporto medico-paziente, il
momento fondamentale di tale rapporto è tuttavia la
comunicazione reale e non fittizia, sostanziale e non
formale, che sola può consentire lo scambio di opinioni,
ansie, dubbi. Nessuna scelta risulta facile e il medico oggi
– in quanto destinatario di un fondamentale dovere di
garanzia nei confronti del paziente – dovrebbe diventare
sempre più consapevole che alleanza terapeutica
significa condividere le gioie e le sofferenze che fanno
parte dell’evoluzione della malattia. Decisivo è dunque il
momento dell’ascolto in cui il medico è impegnato a
30
recepire i bisogni, le aspirazioni e i valori della persona
che ha di fronte al fine di umanizzare il trattamento
sanitario e individuare la soluzione ottimale per quel
soggetto.Sembra riaffiorare qui il tema classico –
delineato da Seneca – della philíaiatriké, da intendersi
come relazione in cui la reciprocità diviene reciproco
riconoscimento di cui entrambe le parti beneficiano.
Ritorniamo qui al punto essenziale del patto di cura che
vede il ‘consenso informato’ come fase finale di un
processo nato da un rapporto di comunicazione empatica
tra medico e paziente e richiama la capacità del primo di
comprendere i tempi di cui il malato ha bisogno per
assimilare la diagnosi e, soprattutto, di individuarne i
meccanismi personali di difesa e di adattamento al fine di
intenderne la reale volontà. Il ‘chiedere perdono ‘come
primo dovere del medico coinvolge manifestamente livelli
ulteriori e più complessi di responsabilità che rinviano al
profondo significato del patto di cura.
Parlare di relazione di fiducia significa affrontare un tema
assai rilevante per la riflessione bioetica: quello
dell’educazione del medico e degli operatori sanitari. Non
ci si può illudere infatti che sia sufficiente definire alcune
regole di comportamento o fissare alcuni obblighi cui
ottemperare, giacché si tratta anche di acquisire capacità
e pratiche di condotta in certo modo esemplari. Educare,
dunque, a sviluppare una disponibilità all’ascolto, a
ricercare la migliore comprensione dell’altro: ecco
riemergere la virtù umanistica del prendersi cura. Questo
progetto si fonda su una concezione della bioetica come
pedagogia “allargata” e, quindi, come formazione
31
permanente di professionisti della salute, responsabili e
consapevoli dei propri compiti ma anche dei propri limiti.
Si chiarisce, dunque, come nel concetto di umanizzazione
della medicina vi sia la volontà di contrastare talune
derive della cosiddetta medicina tecnologica che hanno
portato, coi progressi tecnico-scientifici, a una crescente
professionalizzazione, ma hanno altresì condotto a una
progressiva perdita d’importanza, nella prassi medica,
delle virtù altruistiche.
La salute e la ‘buona vita’
Ancora una volta, Il posto delle fragole mi sembra ne offra
una significativa testimonianza, in particolare mostrando
come, nel comportamento pur formalmente ineccepibile
del protagonista, attitudini virtuose quali l’ospitalità, la
filantropia, la simpatia, che per secoli avevano modellato
l’atteggiamento terapeutico, tendano man mano a
scomparire dalla sfera morale della cura della salute. Da
qui l’invito di Ricoeur di ritrovare il segreto di una buona
cura, alla luce del fatto che l’idea stessa di salute è
andata evolvendosi, riproponendo il significato aristotelico
della buona vita. Il bene possibile, in una rinnovata
concezione del benessere, è infatti tutto ciò che, a partire
dalle capacità e dalle opportunità materialmente offerte, è
in grado di situare la salute all’interno di un progetto di
autorealizzazione della persona. Quello che è in gioco è,
dunque, il concetto stesso di salute, non separabile per la
32
sua intrinseca complessità dai nostri pensieri più profondi
sui rapporti tra la vita e la morte, la nascita e la
sofferenza, il sé e l’altro. È a questo livello che Ricoeur
ritiene possibile inscrivere l’idea di salute nel quadro di
una riflessione sulla buona vita. La salute è la modalità
propria del vivere bene nei limiti che la sofferenza
assegna alla riflessione morale [...]. Il desiderio di salute è
la figura che, sotto il giogo della sofferenza, riveste
l’auspicio di vivere bene”14.
Riprendendo temi sviluppati in Sé come un altro, Ricoeur
individua nell’etica, distinta dalla morale, la dimensione
della vita pratica cui è propria la tensione verso
l’autorealizzazione presente in ogni essere umano.15
Mentre la morale rappresenta il momento deontologico
della norma, l’etica si caratterizza in senso teleologico per
la presenza del telos della buona vita: “un orizzonte
popolato dai nostri progetti di vita, le nostre anticipazioni
della felicità, le nostre utopie, in breve tutte le figure mobili
di ciò che consideriamo segni di una vita compiuta”.16
La deontologia è certo essenziale nel suo riferirsi a valori
e a norme di carattere formale che mirano a temperare
l’inevitabile relazionalità asimmetrica tra medico e
paziente ma – come ci mostra il film – l’esercizio della
professione medica esige un livello di consapevolezza e
di responsabilità non del tutto realizzato né realizzabile
dal solo codice comportamentale.
14
P. Ricoeur, Il giudizio medico, op.cit., p.53. Su una medicina come arte della cura cfr.
M. Gensabella-Furnari, a cura di Il paziente, il medico e l’arte della cura, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2005.
15
P. Ricoeur, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993.
16
Id., Etica e morale, Antologia a cura di D. Iervolino, Morcelliana, Brescia 2007, p. 34.
33
Se la richiesta del perdono è il primo dovere del medico,
per Isak Borg si tratterrà indubbiamente di un perdono
difficile che riguarderà inscindibilmente anche la sua vita
personale. È Ricoeur, ancora una volta, a chiarire che
‘difficile’ è quel perdono che, se deve contribuire alla
guarigione della memoria ferita, dovrà prendere sul serio
il tragico dell’azione, puntare alla radice degli atti e
affrontare il rischio del rifiuto17.
Per ottenerlo, dagli altri e da sé stesso, Borg dovrà
dunque risalire alla fonte dei conflitti e dei torti che hanno
caratterizzato drammaticamente la sua vita di medico e di
uomo, generando la sua insensibilità e la sua misantropia.
Solo così, al termine del cammino, dopo aver avvertito il
vuoto della sua esistenza, potrà ritrovare sé stesso e quel
che resta della sua umanità instaurando una relazione
d’affetto sincero col figlio e colla nuora e avviando un
rapporto di autentica simpatia con i giovani compagni di
viaggio. È qui, secondo Ricoeur, che il perdono confina
con l’oblio attivo, non con l’oblio dei fatti, ma del loro
senso per il presente e il futuro,
Nel sogno catartico che conclude il film, in opposizione
all’incubo iniziale, un paesaggio di straordinaria bellezza,
immerso nella quiete e animato dalla presenza dei
genitori che, giovani anch’essi, salutano Isak bambino, il
protagonista ritrova l’incanto di quel ‘posto delle fragole’
che evoca nostalgicamente la stagione della felicità. I
pensieri angosciosi si sono placati ed è possibile ormai,
grazie al perdono che, anche semanticamente, è dono di
17
Id. Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, Il Mulino, Bologna
2004, pp.116-117.
34
riconciliazione, fare pace col proprio destino e prendere
serenamente congedo dalla vita.
35
COLPA, PENTIMENTO, PERDONO
UNA INTRODUZIONE ETICO - RELIGIOSA
Paola Ricci Sindoni
Non ho perdonato nessuno dei colpevoli,
né sono disposto
ora o in avvenire a perdonare alcuno,
a meno che non abbia dimostrato [6]
di essere diventato consapevole
delle colpe e degli errori del fascismo
nostrano e straniero
e deciso a condannarli, a sradicarli
dalla sua coscienza e da quella degli altri.
Primo Levi
36
“Il perdono è forte come il male, ma il male è forte come il
perdono”1. Questa lapidaria affermazione di Jankèlèvitch
– affermazione dal sapore biblico che rievoca il versetto 6
del capitolo 8 del Cantico del Cantici: Forte come la morte
è l’amore- venne pronunciata all’indomani delle
polemiche, intorno agli anni Settanta del secolo scorso,
relative alla temuta prescrizione dei crimini nazisti. Segno
che tale asserzione, ponendo sorprendentemente sullo
stesso piano male e perdono, non fa che spalancare
l’abisso tra l’assoluto della legge della misericordia e
l’assoluto della libertà malvagia. Ed ancora: tra l’inaudita
potenza del perdono e le profonde lacerazioni inflitte dal
1
V. Jankélévitch, Perdonare?, La Giuntina, Firenze 1987, p.10.
male, indicando – se ce ne fosse ancora bisogno- che
oblio e indifferenza, amnesia morale e perdonismo di
bassa lega, che continuano a circolare anche negli
ambienti intellettualmente impegnati, non possono più
consegnare il perdono in pasto alla dialettica, utilizzata
come anestesia metafisica, volta a guarire magicamente
squarci di male troppo grandi2.
Per questo occorre penetrare con realismo e con urgenza
dentro il mistero della malvagità umana, perché dentro le
mostruose “orge dell’odio” (P. Claudel) si annida il segreto
di un possibile riscatto, sempre ambiguo e doloroso,
quando non ci si accontenti di soluzioni facili e
compensatorie, sia sul piano giuridico che su quello
morale3. I “professori del perdono”, come li chiama
Jankèlèvitch4, hanno facile gioco e come in una
drammatica partita a scacchi spingono le loro pedine
argomentative verso la scontata vittoria. Anche alcune
frange della teologia, dovendosi muovere con disagio
dentro temi tanto inusuali, come quello del “peccato della
Chiesa” o del perdono come imperativo teologico5,
sembrano nascondersi all’interno di un sottile gioco ad
incastro, il cui esito finale sembra doversi aprire ad un
ulteriore approfondimento circa il pentimento (più che il
perdono) o al massimo alludere ad un perdonare “lieve”,
che con insostenibile leggerezza sia capace di attenuare
le contraddizioni, di disattivare le tensioni storiche, di
2
Ivi, pp.43 e sgg.
Cfr. al riguardo M. G. Carnevale, Il perdono come problema filosofico in “Revista
Direitos Humanos e Democracia, 1/2013, pp. 147-169.
4
V. Jankélévitch, Perdonare?,cit., p. 43-44.
5
Si noti in tal senso che neppure nel Nuovo Dizionario di Teologia, a cura di G.
Barbaglio e S. Dianich, S. Paolo, Milano 1991, compare la voce: Perdono.
3
37
pretendere la neutralizzazione delle dinamiche del male;
insomma una vera panacea da distribuire al bisogno
dentro tutte le tragedie del dolore umano.
Ben venga, al riguardo, la domanda lancinante, che si
esprime nella doppia interrogazione – quale pentimento?
E per quale perdono?- che sembra includere a sua volta
la temibile questione: per quale male? C’è forse un
peccato così grande, come quello rivolto da Giuseppe alla
moglie di Putifar: “Come posso io fare un male così
grande e peccare contro Dio?” ( Gn 39,9)? C’è dunque un
male grande per il quale la richiesta del perdono, che è la
grande dismisura, non riesca ad essere coperta da alcuna
misura di pentimento?
Questa ed altre domande sembrano dover intrecciare tre
paradigmi – colpa, pentimento, perdono - che non
possono essere semplicemente posti in una immediata
consequenzialità sincronica, né tantomeno innestati
dentro un movimento logico-dialettico, che li veda come
posizione della tesi (colpa), dell’antitesi (il pentimento) ed
infine della sintesi (il perdono), quanto ripensati nella loro
tragica paradossalità, nella loro costitutiva incompiutezza.
Sia che il perdono e il male si esprimano, come vuole
Jankèlèvitch, nella loro forza egualitaria che non ammette
né vincitori né vinti, come nella notte della lotta di
Giacobbe con l’Angelo ( Gn 32, 23-32), sia che si pensi,
come nel messaggio evangelico, che questa irriducibile
tensione contenga una inesauribile carica di senso, non
c’è logos conciliativo che tenga, non c’è alcuna promessa
di soluzione indolore, non c’è spazio allo sterile gioco dei
38
concetti, alla mania ossessiva della rimozione e della
dimenticanza6.
“Perché caricarsi del passato, se dobbiamo guardare il
futuro?”, si domandava non senza ironia von Balthasar7 e
tale interrogativo ha continuato a circolare con cinico
realismo in ambito cattolico, ad esempio durante la
preparazione del Giubileo del Duemila ed ancora oggi
nell’Anno della Misericordia promulgato da Papa
Bergoglio. Quasi fosse possibile resecare la memoria
della storia più o meno recente, ancora troppo invasiva,
rinverdendo la distinzione comoda tra giudizio storico e
giudizio teologico, creando in tal modo il vuoto di un
presente che non tollera più la sua insostenibile usura, di
un presente senza radici, come nota Hannah Arendt,
esposto ai venti del momento e impotente ad esprimere
orientamento e senso8.
Vale la pena in tal senso entrare nel vivo della questione
della colpa, del male commesso, e solo dopo aver tentato
di scoperchiarne le sue dinamiche contorte, sarà possibile
ripensare alla disciplina, che è insieme personale e
comunitaria, del pentimento, per volgerci, infine, sulla
paradossale fenomenologia del perdono.
6
Sul tema importanti osservazioni in P. RICOEUR, La memoria, la storia,
l’oblio,Cortina, Milano 2003.
7
H. U. Von Balthasar, Verbum caro, Morcelliana, Brescia 1975, p.25.
8
H. Arendt, La vita della mente, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 83-98.
39
La colpa, evento teologico
La colpa – basti pensare alla riflessione di Jaspers su
questo tema9- va considerata come una componente
delle situazioni-limite, volte a ricondurre la realtà e
l’esperienza umana dentro uno specifico evento morale.
Segno della contraddizione immanente alla libertà, la
colpa diventa la cifra della non corrispondenza tra la
dignità umana, espressa nel valore, nella legge giuridica,
nella norma morale, e la sua libera attuazione. La colpa,
insomma, è la libera degradazione della libertà umana, è
la dignità che si dimette da se stessa. Ma, inversamente
questa contraddizione può essere risolta allo stesso modo
in cui è sorta: la libertà che si contraddice è anche la
libertà che, in una prospettiva religiosa, viene illuminata
dalla grazia, la sola in grado di sciogliere la
contraddizione.
L’uomo che si degrada è anche l’uomo che si riabilita; il
male che l’uomo commette è anche il male che può
riparare; egli infatti è capace del bene e del male, e poi
ancora del male e del bene10. In tal modo, però, la realtà
della colpa viene compresa dentro un cerchio concluso
sul piano umano, diventa cioè un circuito morale chiuso,
quasi privato e al cui interno Dio diventa il supremo valore
e il garante dell’ordine della razionalità e della libertà, e
non più il Dio della rivelazione e della salvezza.
Così impostata all’interno dell’orizzonte della moralità, la
colpa – o il peccato, come lo si caratterizza nella
dimensione religiosa - si legittima nella sua autonomia, si
9
K. Jaspers, Filosofia 2. Chiarificazione dell’esistenza, Mursia, Milano 1978, pp. 220222.
10
R. Blomme, L’uomo peccatore, EDB, Bologna 1971, pp. 16-28.
40
garantisce e si definisce sul piano della coscienza morale
e della dignità della persona umana, ed anche l’intervento
della “grazia”, orientata sacramentalmente, assume il
compito di risanare e di cancellare la trasgressione libera
della legge divina11. Divenuta un capitolo della teologia
morale, la colpa viene in questo contesto indagata nel suo
aspetto formale e in quello materiale, al fine di definirne la
natura.
Vale la pena comunque allargarne la prospettiva,
cogliendo il peccato non soltanto come colpa morale, ma
soprattutto come un “evento teologico”, come una realtà
di fede. Si commette peccato nella fede e dalla fede,
quando fede significhi –in una prospettiva di filosofia della
religione – indagine e riflessione sulla rivelazione e sul
suo progetto di salvezza. Ciò significa che la colpa stessa
è oggetto di rivelazione; è Dio insomma che ci rivela la
nostra peccabilità e l’attualità delle nostre colpe, è sempre
lui a rivelarne il contenuto, la struttura, la vicenda; è
sempre lui ad illuminare il peccatore nel suo “essere –
dentro – il male”12. È questa stessa rivelazione, che è
anche promessa di salvezza, ad indicare al peccatore che
il giudizio emesso sulla colpa esige superamento,
pentimento, remissione, e dunque “grazia” del perdono.
Tutto questo non è mera constatazione dottrinale o una
specie di teoria morale; è azione salvifica di Dio, dono e
comunicazione di grazia, riconoscimento, da parte
dell’uomo, della possibilità di un superamento; è insomma
11
Cfr le acute pagine di S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, in Opere, La Nova
Italia, Firenze 1972.
12
A. Molinaro, voce: Peccato,in Nuovo Dizionario di Teologia, cit., pp. 1107-1119.
41
la vittoria della grazia sul peccato: “Il principe di questo
mondo è già stato giudicato” (Gv 16,11).
La colpa, perciò, appartiene alla realtà della salvezza, più
che al solo ordine della morale; indica infatti che le
lacerazioni, che essa compie, non sono originarie, né
definitive, ma solo intermedie e provvisorie nel giudizio di
Dio, che ad un tempo condanna e perdona ( 1Gv 2,2),
condensando la pienezza della rivelazione in Gesù
Cristo13. Si legge in 2Cor 5,21: “Vi supplichiamo in nome
di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non
aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in
nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo
di lui giustizia di Dio”. Come dire che Dio, divenendo altro
da sé nel Figlio, divenuto parte finita del Padre, ha voluto
indicare, dentro il dramma della lacerazione del male a
cui si consegna, la sua risposta definitiva al peccato.
Sin dall’origine, esso si qualifica come tragica esperienza
della lontananza e dell’abbandono di Dio, ma anche si
comprende in quanto pienamente assunto da Gesù
Cristo, da lui giudicato e fatto oggetto di redenzione per
tutta l’umanità attraverso il suo sacrificio vicario e la
richiesta universale di perdono di fronte al Padre. Se il
peccato, colto esclusivamente come colpa morale, viene
ricondotto al circuito norma – libertà - grazia, solo quando
è riconosciuto come evento teologico, rivelativo e
redentivo, può aprirsi ad una dimensione universale e
riconoscersi anche come un “fatto” che riguarda e
appartiene a tutta la Chiesa.
13
Ivi, p.1114.
42
Nasce da questa consapevolezza quel “soprassalto
profetico”14 di Giovanni Paolo II, quando nel novembre
1994 ebbe a sostenere nella lettera apostolica Tertio
Millennio Adveniente che “è giusto che [_] la Chiesa si
faccia carico con più viva consapevolezza del peccato dei
suoi figli nel ricordo di tutte quelle circostanze in cui,
nell’arco della storia, essi si sono allontanati dallo spirito
di Cristo e del suo Vangelo, offrendo al mondo, anziché la
testimonianza di una vita ispirata ai valori della fede, lo
spettacolo di modi di pensare e di agire che erano vere
forme di antitestimonianza e di scandalo”(n.33). Questo
paragrafo innovativo così continua: “ La Chiesa, pur
essendo santa per la sua incorporazione a Cristo, non si
stanca di fare penitenza: essa riconosce sempre come
propri, davanti a Dio e davanti agli uomini, i figli peccatori”
(ivi). Già qualche mese prima, nel giugno, il Pontefice
aveva in modo più esplicito sostenuto, di fronte alla
sorpresa e alla perplessità di molti cardinali riuniti in
Concistoro, che “la Chiesa è certamente santa, come
professiamo nel Credo, essa però è anche peccatrice”; ha
dunque il compito di riconoscere gli errori commessi nella
storia “da uomini suoi e in nome suo”, così da dover
attivare una conversione radicale quale unica condizione
dell’unione con Dio “sia delle singole persone come
anche delle comunità umane e di tutta la Chiesa”15.
Pur esistendo, al riguardo, una ricca tradizione, anche
solo guardando al Novecento, rivolta ad approfondire sia
l’aspetto sociale del peccato, sia la questione relativa al
14
L’espressione è di G. Alberigo, Chiesa santa e peccatrice. Conversione della Chiesa,
Bose, Magnago 1997, p.74.
15
Ivi ,p. 71-78.
43
peccato come colpa nella Chiesa o della Chiesa, il
problema rimane ancora aperto e nella ricerca teologica
esposto ad una serie di interpretazioni diversificate16,
quasi che parlare di una Chiesa peccatrice ponesse
questioni teologiche irrisolvibili. L’idea prevalente, come
sostiene Hans Küng, è quella secondo cui nel corso della
storia i peccati, più che inerire costitutivamente alla
Chiesa, siano piuttosto da riferire ad alcuni suoi figli17. Di
conseguenza sono state viste come necessarie, specie
come cammino di preparazione e di purificazione del
Giubileo del duemila ed anche quello recente sulla
misericordia, le rivisitazioni storico – critiche degli eventi
che hanno coinvolto alcuni rappresentanti della Chiesa,
insistendo comunque che solo quest’ultimi sono
direttamente responsabili delle loro colpe.
Opporre resistenza a questa pratica di riconoscimento
della colpa comunitaria significa ricadere ancora nella
concezione morale del peccato, che ha certamente una
dimensione individuale, ma che va colto, come spesso
ripete Papa Bergoglio, nella sua valenza rivelativa, quale
realtà ecclesiale che esige anche un pentimento
comunitario, diffusivo, quello pensato e testimoniato da
intere generazioni, quelle narrate dalla Sacra Scrittura, da
Genesi sino all’ Apocalisse. Con questo spirito si è di
recente celebrato il Giubileo della Misericordia e fra le
molte iniziative messe in atto, spicca quella voluta dal
Pontefice nel suo viaggio in Svezia, il 31 ottobre 2016,
specificatamente rivolto –in occasione dei 500 anni della
16
Cfr. G. Wainwright, Confessione delle colpe e riconciliazione delle Chiese, in
“Concilium” 23/1987, pp. 333-345.
17
H. Küng, Riforma della Chiesa e unità dei cristiani, Borla, Torino 1965.
44
riforma di Lutero – a superare la colpa della separazione,
fonte di sofferenze e di incomprensioni, attraverso una
preghiera corale comune capace di guarire le ferite della
storia e della memoria ecclesiale.
Nell’intervista rilasciata il 28 ottobre 2016 al gesuita
svedese Ulf Jonsson e pubblicata su “Civiltà Cattolica”
papa Francesco ribadiva le ragioni di un necessario
passaggio dal conflitto alla riconciliazione18 anche tramite
quella che ha chiamato “grazia della vergogna”, scaturita
dal riconoscimento del proprio peccato individuale e
comunitario e ispirata dai versetti presenti in Ezechiele: “
Tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti
vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca,
quando ti avrò perdonato quello che hai fatto” (Ez 16,6263).
45
Il pentimento, evento personale e sociale
“Signore onnipotente – si legge nel libro di Abacuc – Dio
di Israele, un’anima angosciata, uno spirito tormentato
grida verso di te. Ascolta Signore, abbi pietà, perché
abbiamo peccato contro di te” (Abc 3,1-2). Il pentimento,
questo grido di dolore lanciato verso Dio, lacera molte
pagine della Sacra Scrittura, spezzando in due l’essere
della creatura, convocata dal suo Signore a riconoscere
con sofferenza e amore la propria colpa. Anche il
18
Cfr. Documento interconfessionale fra cattolici e luterani: Dal conflitto alla
www.vatican.va/.../rc_pc_chrstuni_doc_2013_dal-conflitto-allacomunione
in
comunione_it.html
pentimento, al pari del peccato, diventa così fonte di
rivelazione di Dio, lento all’ira e grande nella misericordia;
attraverso il riconoscimento della propria malattia il
credente e con esso tutta la comunità prende atto che la
causa vera del proprio male è l’aver smarrito la fiducia
nell’Altissimo. E’ dunque “cosa cattiva e amara aver
abbandonato il Signore” (Ger 2,19). Solo mediante questa
diagnosi precisa sul proprio male, sulla profonda e
sofferta consapevolezza delle cause della propria
malattia, ci potrà essere per il credente e la sua comunità
un principio di guarigione.
Certo Israele, si legge sempre nel libro di Geremia, è un
malato grave; la sua infedeltà ha radici così profonde da
sembrare inguaribile: “Da sempre tu hai infranto il tuo
giogo” ( Ger 2,20); “il mio popolo mi ha dimenticato da
giorni innumerevoli” (Ger 2,32). Ciò nonostante, evento
inaudito scaturito dalla misericordia di Dio, è ancora
possibile rileggere con uno sguardo nuovo il proprio
passato, non per cancellarlo, ma per vederlo rivisitato dal
perdono dell’Altissimo: “ Se vuoi, Israele, tu potrai tornare
a me. Se rigetterai i tuoi abomini non dovrai più vagare
lontano da me” (Ger 4,1). Se vuoi, Israele, se cioè
l’intenzionalità del pentimento, ben più radicale del
semplice rincrescimento o del momentaneo rimorso, sarà
condotta sino in fondo, verso l’impietosa lettura della
propria colpa. Il pentimento assume in tal senso la forma
di una forza storica, di una potente interruzione del
negativo, di una contestazione rigorosa del diritto del
male ad intervenire dentro le vicende umane, della rottura
46
delle connessioni del peccato ed infine della inaudita
posizione di un nuovo inizio19.
Il pentimento, questo ponte lanciato dall’uomo verso Dio,
volto a collegare il pilastro della volontà cattiva con quello
della richiesta di perdono, gioca un ruolo centrale anche
nel giudaismo postbiblico. Per i rabbini dell’epoca
talmudica il pentimento è una realtà che l’Eterno ha
creato prima della creazione del mondo, avendo Egli
previsto che il mondo senza pentimento non avrebbe
potuto sussistere ( b.Pesahim 54a). “È meglio un’ora di
pentimento e di buone azioni in questo mondo, che tutta
la vita del Mondo Avvenire”, si legge in Pirqè Avot,4,22;
questo perché nell’ebraismo da sempre il peccato, di cui
ci si deve pentire, è peccato contro Dio, costituendo la
rottura con il suo volontà espressa nella Torah20. Come
dire che senza la consapevolezza della densità rivelativa
del male, non può esserci autentico riscatto, dunque, non
esistono ulteriori possibilità di recupero di un nuovo inizio.
In tale prospettiva solo il pentimento diviene la condizione
necessaria di quel percorso inaudito che è la
“conversione”,
che
non
significa
un
generico
cambiamento di rotta, ma un differente riorientamento
verso il centro della propria relazione con Dio, dunque
una sorta di “ritorno a casa”, come rivela il termine
ebraico teshuvah, da Rosenzweig definito come ritorno
continuo alla fonte originaria dell’essere21.
19
M. Buber, La fede dei profeti, Morcelliana, Genova 1983, pp.98-125.
M. L. Solomon, La teshuvah. Une perspective juive, in “Sidic” XXIX/1, 1996, pp. 2-6.
21
F. Rosenzweig, La Stella della redenzione, Marietti, Casale Monferrato 1985, pp.
99-118.
20
47
Anche l’insegnamento del rabbi Gesù, ebreo di Nazareth,
si muove su questa scia: “ Io sono venuto per chiamare i
peccatori alla conversione” (Lc 5,32); ed ancora nel
vangelo di Marco: “Il tempo è compiuto, il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc, 1,15).
L’urgenza del pentimento e della conversione non
possiede certamente una connotazione moralistica, né un
generico appello al ricentramento della fede personale,
ma –per così dire- una esigenza messianica, quella di
vivere la fedeltà a Dio senza comodi differimenti, ma con
l’audacia di chi sa guardare il proprio passato, non solo
quello personale, da una differente visuale, così che
divenga possibile, anzi necessario, riorientare il proprio
tempo verso il futuro.
Ridurre la dinamica del pentimento cristiano alla sola
ottica individuale è misconoscere la densità dirompente
della conversione, il cui percorso consiste nel tener unite
insieme sia l’aspetto spirituale, che esige una
trasformazione interiore, sia quello etico, volto a mettere
in atto azioni concrete verso il prossimo per il
ristabilimento della giustizia offesa, sia quello sociale,
capace di innervare di tensioni profetiche la complessità
dei rapporti economici, politici e culturali in cui si è
immersi22. Soprattutto da Giovanni Paolo II sino a papa
Bergoglio il pentimento, frutto della conversione, punta in
primo luogo a riconoscerne l’impatto sociale, che attivi
una responsabilità collettiva nei confronti della
purificazione della memoria storica e sia capace di
22
L. Thorson, Dimension communitaire de la repetance dans les liturgies juve et
chretienne, in “ Sidic” XXIX/1, 1996, pp. 11-14.
48
riorientare il presente verso una visione complessiva della
vita sociale, retta da giustizia, misericordia e da perdono.
Il perdono, evento profetico
Come il pentimento, anche il perdono esige un nuovo
cominciamento, una rotazione del passato verso il futuro
mediante una radicale rottura della catena dei risentimenti
e dei rimorsi, delle vendette e delle ritorsioni. Se compiuto
come necessaria propedeutica al riscatto del male
sembra riaprire il campo delle possibilità sinora chiuse e
prevedere la ricreazione di un nuovo evento che prima
non c’era. Al pari del Creatore, anche chi perdona
disinnesca un’azione compiuta nel male, riapre le porte
del futuro a chi non ne aveva più, rompe con la feroce
concatenazione della storia che però continua a
riproporre la ingiusta divisione tra vittime e carnefici.
L’ambiguità del perdono, anzi la sua insostenibilità di
fronte al crimine “metafisico” di Auschwitz continua a
tormentare la coscienza morale dei sopravvissuti, come
molte pagine sofferte dei filosofi ebrei contemporanei
continuano ad indicarci23. E’ indubbio che all’interno della
pratica del perdono vada distinto chi chiede il perdono e
chi lo offre, chi immagina implicitamente di cancellare la
sua colpa e chi dona il proprio perdono a quanti non lo
chiedono nemmeno. Come scioglierne il paradosso se da
un lato “certi” crimini appaiono imprescrittibili, dunque
indimenticabili, mentre dall’altro qualunque azione
23
Cfr. E. Fackenheim, La presenza di Dio nella storia, Queriniana, Brescia 1077.
49
malvagia sembra esigere la difficile disciplina della
liberazione dal male, che solo un altro che perdona può
attivare?
Si può rispondere con Elie Wiesel, dicendo che c’è
perdono e perdono e se ad Auschwitz il perdono è morto,
ciò non significa che ogni ebreo credente, la sera di Yom
Kippur, non sia obbligato a perdonare gli altri, all’ amico
come ad ogni altro uomo, nella misura però che il suo atto
cattivo non abbia sopraffatto nel profondo la dignità della
persona24. Soltanto in questa circostanza devo
perdonarlo solo se è lui a chiedere perdono, riattivando
un circuito relazionale all’interno del quale la dismisura
del perdono è calibrata sulla dismisura del pentimento. Il
perdono insomma non ha il potere di annullare il passato
con le sue pratiche violente e con la necessaria richiesta
di memoria verso le vittime, ma solo di attivare un nuovo
difficile inizio senza il quale la vita personale e sociale
risulterebbe inattuabile. E’ quanto ha cercato di dire Primo
Levi, nell’Appendice di Se questo è un uomo:
“Non ho perdonato nessuno dei colpevoli, né sono disposto ora e in
avvenire a perdonare alcuno, a meno che non abbia dimostrato (con i
fatti, non con parole, e non troppo tardi) di essere diventato
consapevole delle colpe e degli errori del fascismo nostrano e
straniero, e deciso a condannarli, a sradicarli dalla sua coscienza e
da quella degli altri. In questo caso sì, io non cristiano sono disposto
a seguire il precetto ebraico e cristiano di perdonare il mio nemico,
25
ma un nemico che si ravvede ha cessato di essere un nemico” .
24
E. Wiesel, Il male e l’esilio, a cura di M. De Saint Cheron, Baldini & Castoldi, Milano
2001, pp. 98-99.
25
P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1984, p.223.
50
La rivelazione cristiana pretende comunque un altro
difficile passo, quello che misura la pratica del perdono
sotto l’ineliminabile segno della croce26. Va infatti
ricordato come la richiesta del perdono sia uscita dal
grido del Crocefisso: “ Padre perdona loro perché non
sanno quello che fanno”(Lc 23-24)27. La richiesta di
perdono e la pratica del perdonare, le due facce di questa
rischiosa e complessa dinamica interpersonale, sembrano
così rimesse nelle mani di Dio, che certo non annulla né il
peso della responsabilità del male né l’esigenza
paradossale di dare il perdono.
“Perdonatevi scambievolmente: come vi ha perdonato il
Signore, così fate voi”, si legge nella lettera paolina ai
Colossesi (Col 3,13), che sembra direttamente richiamarsi
a quell’esigente attitudine ebraica della “imitazione di
Dio”: “Come l’Onnipotente è chiamato pietoso e
misericordioso, siate voi pure pietosi e misericordiosi, e
donate liberamente a tutti. Come il santo, benedetto Egli
sia, è chiamato giusto, siate pure voi giusti; come Egli è
chiamato pio, siate voi pure pii” (Sifrè Deut 49;85a).
L’imitazione di Dio è dunque la prova che si può e si deve
perdonare perché si è stati da sempre perdonati con
quella grazia fondativa, scaturita –nella prospettiva
cristiana- dall’evento della croce. Quest’ultima non
annulla il peccato e la morte, ma li riconverte in una
nuova energia, così che il percorso del credente, qualche
volta difficile e oscuro dentro il passato della colpa, può
essere ancora riorientato verso nuovi inizi. La memoria
26
H. U. Von Balthasar, Il tutto nel frammento, Jaca Book, Milano 1990, pp. 215-287.
Si noti la rilettura di questo versetto evangelico fatta da Jankèlèvich: “Padre non
perdonare loro, perché sanno quello che fanno” ( op. cit., p.33).
27
51
degli eventi trascorsi non è certo cancellata o lasciata
irresponsabilmente alle spalle, ma recuperata nella sua
densità rivelativa, la cui forza può provocare un differente
e credibile orientamento storico, sia personale che
sociale.
“Non pensate di non poter essere perdonati”, ha precisato
papa Bergoglio nel discorso tenuto ai carcerati il 6
novembre 201628, alla fine del Giubileo della Misericordia,
quasi a dire che il grido di Crocefisso “ Padre perdona
loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23-24)”, può
anche essere ridetto così: “Padre perdona loro e aiutali a
saper perdonare, perché da soli non ne sono capaci.
Mancano di tutto; consegna loro il segreto della tua
misericordia perché il dramma della salvezza non sia
stato consumato invano”.
52
28
Discorso
di
Papa
Francesco
6
https://it.zenit.org/articles/category/papa-francesco/
novembre
2016
in:
NOTE
PERDONO DI SÉ E PERDONO IN SÉ NELL’ULTIMO
DOSTOEVSKIJ
Federica Bergamino
Introduzione
È bene che l’essere ci sia? Questa è la domanda
metafisica della post-modernità nella lettura del filosofo
francese Remi Brague (2012). La bontà dell’essere
stesso e quindi la sua generazione oggi sono poste
fortemente in discussione. In una società che per tanti
versi sembra indifferente alla vita in quanto tale, non a
quella mia in particolare, ma alla vita in sé stessa che
viene facilmente negata laddove mette a rischio il
benessere della mia vita particolare (ivi, p.58),
reintrodurre il tema del perdono significa affermare la
bontà dell’essere nonostante tutto. Vivere il perdono
implica infatti sostenere la bontà dell’essere nonostante la
sua finitezza e le sofferenze che comporta, è dire: è bene
che tu ed io ci siamo nonostante i nostri limiti e il male che
possiamo causare con essi. Perdonare è invero un modo
di generare: consiste nel ridare all’altro la sua dignità di
persona e smettere di cosificarlo identificandolo con
l’offesa che ci ha inferto (Bergamino, 2015); significa
permettergli di vivere dentro e fuori di noi come un essere
53
umano che commette errori ma che non si riduce ad
essi1.
Se questo è vero, se perdonare consiste in una sorta di
generazione, in che senso allora si può parlare di perdono
di sé? Come può uno generare se stesso?
Questo è quanto andremo a esplorare nel presente testo.
La scelta metodologica è di affrontare la questione in
modo descrittivo osservando il fenomeno del perdono
all'interno di una narrazione letteraria. Detta scelta deriva
dalla consapevolezza che il processo di perdono si
sottrae ai sillogismi così come non è deducibile dalla
struttura dell’essere umano. Esistono invero persone che
non hanno mai perdonato e osservando le quali si
potrebbe dedurre che esso è impossibile per l’uomo,
almeno il perdono di certi atti2, ma vi è pure chi ha
perdonato atrocità e offese aberranti, come ne
testimoniano libri in cui si avvicendano storie di perdono
difficili da immaginare se non fossero realmente avvenute
(Eileen Borris-Dunchustang, 2010). Le narrazioni
pertanto, anche letterarie in quanto esprimono
l’esperienza dell’autore, costituiscono l’ambito privilegiato
di osservazione di tale realtà perché forniscono la materia
prima essenziale senza la quale diventa meramente
ipotetico qualunque ragionamento.
1 Come attestano i più recenti studi di psicologia cognitiva le persone e quindi le
relazioni esistono all'interno di noi. (Cfr. Michael Tomasello, 1999 e Giovanni Liotti,
2005).
2
Questo sostiene Hannah Arendt rispetto ai crimini dell’olocausto (Hannah Arendt,
1958). Per una discussione di questa e altre posizioni filosofiche sul tema del perdono
si rimanda ad Antonio Malo, 2013.
54
Cenni sulla dinamica del perdono
Quando ci si accosta a storie di perdono, si entra sempre
immediatamente nella questione della violenza subita o
effettuata. E la violenza, come ha ben sottolineato René
Girard, è un meccanismo mimetico perverso, risultato
malato della struttura imitativa dello stesso desiderio
umano. La rivalità, spiega Girard (2006, pp.170-176)3,
affonda le sue radici nel fatto che l’uomo desidera ciò che
un altro desidera. E poiché l’oggetto del desiderio non
può essere di entrambi, inizia la lotta da cui nasce l'offesa
e che provoca la cosiddetta spirale della violenza. Se
l’uomo, infatti, continua ad attingere dal rivale il suo
desiderio, l'offesa genera altra offesa, la violenza altra
violenza. Solo il perdono può spezzare la spirale mimetica
(Girard, 2001, p.153)4. E ciò avviene quando chi è colpito
ottiene da un altro l'aiuto per perdonare. Riassumiamo qui
le principali costanti antropologiche rilevate nei casi in cui
il perdono si realizza:
a) la vittima che perdona trova un aiuto a farlo in qualcun
altro che introduce in lei un nuovo pensiero o una nuova
prospettiva dalla quale leggere la realtà dell’altra persona.
b) Rivaluta quindi il proprio comportamento di
distanziamento e di odio nei confronti dell’offensore e c)
formula un nuovo giudizio sulla situazione con la
conseguente decisione di perdonare. Questo percorso, a
volte molto lento nel tempo, permette poi alla vittima di
percepire la fragilità e debolezza del suo offensore e
3
Qui Girard offre una spiegazione del desiderio mimetico a partire dal testo di
Dostoevskij l’Eterno marito (1870).
4
Per lo sviluppo del tema del perdono in Girard come completamento del desiderio
mimetico sano si veda Federica Bergamino, 2013.
55
giungere a d) empatizzare con lui (a motivo della fragilità
percepita) e quindi a mettersi al suo posto. È a questo
punto che accade una sorta di rigenerazione: e) la vittima
smette di identificare l’offensore con l’offesa, lo riaccetta
come essere umano pari a sé, e in questo modo scioglie il
conflitto interiore generando l'altro nella sua dignità di
persona e una nuova relazione con lui. Tale relazione è
innanzitutto interiore, l'offensore vive all'interno della
vittima con l'offesa che le ha arrecato, e quando questa
ha trasformato i suoi sentimenti da odio a benevolenza
ricostituisce la relazione con lui internamente; in secondo
luogo la relazione è potenzialmente atta a mutare anche
esteriormente, sempre che non costituisca un pericolo per
la vittima e se l’offensore accoglie il perdono (Bergamino,
2015). Di fatto si osservano casi di offensori perdonati che
non accolgono il perdono. Non è sufficiente quindi che la
vittima perdoni l’offensore perché questi perdoni se
stesso; il perdono di sé richiede una indagine differente.
Bisogna entrare nella prospettiva del colpevole.
Il perdono di Zosima
Un autore paradigmatico per addentrarsi nella psicologia
del colpevole è Fëdor Dostoevskij. Nella sua opera
tuttavia non è facile rinvenire un personaggio che riveli un
vero e proprio processo di perdono. Solo nell’ultimo
romanzo, I fratelli Karamazov, troviamo cristallizzata tale
esperienza. Qui egli narra di due storie significativamente
collegate che, per la diversità dei personaggi, possono
aiutare nell’indagine che ci interessa.
In punto di morte lo starec Zosima, figura di alta statura
56
morale, padre della crescita umana e spirituale di
Alekseij, il figlio minore dei Karamazov, racconta ai
confratelli alcuni momenti significativi della sua vita.
Quando il monaco era ancora un giovane ufficiale, il suo
carattere irruente e spavaldo lo condusse a sfidare a
duello una persona con la quale cercava da tempo
l’occasione di rivalsa. Ciò che faceva bruciare il giovane
era di non aver saputo che la donna da lui prescelta fosse
già fidanzata con un altro proprio quando lui si illudeva di
conquistarla, per trovarla poi felicemente sposata al
ritorno da un suo viaggio di alcuni mesi. Ritenendo un
affronto questo essere lasciato all’oscuro della situazione,
alla prima occasione favorevole si vendica e sfida a duello
l’ignaro rivale. La sera, alla vigilia del duello, tornato a
casa arrabbiato e sconvolto, si imbatte nel suo attendente
e sfoga il malanimo prendendolo a schiaffi in modo
brutale. Sulle prime la violenza gratuita del gesto sembra
non intaccarlo, ma la mattina successiva, nell’aprire la
finestra, la bellezza della natura mattutina lo mette a
contatto con il suo stato interiore:
“Che significa?" pensai, "Ho nell'anima un senso di infamia e di viltà?
Non sarà perché mi accingo a versare sangue? No, non credo sia per
quello. Non sarà perché ho paura della morte, ho forse paura di
essere ucciso? No, nient'affatto, neppure lontanamente..." Ad un
tratto indovinai di che si trattava: i colpi inflitti ad Afanasij! Mi ritornò
alla mente la scena della sera prima e fu come se la rivivessi in quel
momento: egli era di fronte a me ed io lo colpivo dritto in faccia
mentre lui teneva le braccia giù, a testa alta, con gli occhi sbarrati,
come sull'attenti, trasaliva ad ogni colpo, ma non osava nemmeno
alzare le braccia per proteggersi: ecco fino a che punto si era ridotto
un uomo, un uomo che picchia un suo simile! Che crimine! Fu come
se un ago appuntito mi trafiggesse da parte a parte l'anima. Rimasi
57
come stordito, mentre quel sole splendeva, le foglioline luccicanti
gioivano, e quegli uccellini, gli uccellini di Dio inneggiavano al
Signore... Mi coprii il volto con entrambe le mani, crollai sul letto e
scoppiai in un pianto dirotto. E allora mi ricordai di mio fratello Markel
e di quello che diceva ai servi mentre si trovava in punto di morte:
"Miei cari, miei amati, perché mi servite, perché mi amate, mi merito
forse io che voi mi serviate?" "E io me lo merito?", quella domanda mi
balenò in mente. "E, difatti, che cosa mi rende meritevole che un altro
uomo, un uomo come me, fatto a immagine e somiglianza di Dio, mi
serva?" Era la prima volta nella vita che quella domanda si insinuava
nel mio cervello”. Le parole del fratello Markel continuano a
risuonargli dentro: “"Mamma, gocciolina del mio sangue, in verità
ciascuno è colpevole davanti a tutti per tutti, solo che gli uomini non
lo sanno, ma se lo sapessero oggi stesso sarebbe il paradiso!"
"Signore, può essere falso anche questo?" mi domandavo
piangendo. "In verità io potrei essere più colpevole di tutti e il
peggiore degli uomini del mondo!" E tutto d'un tratto la verità mi si
rivelò in piena luce: che cosa mi accingevo a fare? Mi accingevo ad
uccidere un uomo buono, intelligente, nobile, completamente
innocente nei miei confronti e, privando per sempre sua moglie della
felicità, avrei fatto soffrire e ucciso anche lei (Dostoevskij, 2014,
pp.395-396).
Quando il compagno lo viene a chiamare per andare ad
affrontare il duello, una determinazione è entrata nel suo
cuore, e prima di avviarsi obbedisce all’intimazione
interiore:
salii di corsa da solo nel mio appartamento, dritto nello stanzino di
Afanasij: "Afanasij", gli dissi, "ieri ti ho colpito due volte sulla faccia,
perdonami". Egli trasalì, come spaventato, mentre io mi resi conto
che era ancora poco, troppo poco, e così all'improvviso, come mi
trovavo, con tanto di alta uniforme, caddi ai suoi piedi e mi prostrai
fino a terra davanti a lui: "Perdonami!" gli dissi. Egli rimase sbigottito:
"Vostra eccellenza, signore, padrone, ma che cosa... mi merito io
forse..." e scoppiò a piangere anche lui come avevo fatto io prima, si
58
coprì il viso con entrambe le mani e si girò verso la finestra, scosso
dai singhiozzi; io invece raggiunsi di corsa il mio compagno e saltai in
carrozza. "Hai mai visto un vincitore?" gli domandai. "Eccolo qui
davanti a te!" Ero così esultante che non feci che ridere e parlare per
tutto il tragitto (ivi, p. 396).
Giunto sul posto del duello, il primo colpo spettava al
rivale:
Il suo colpo mi sfiorò appena la guancia e sibilò oltre il mio orecchio.
"Grazie a Dio", gridai, "non avete ucciso un essere umano", poi
afferrai la mia pistola, mi voltai e la scaraventai in alto, nel bosco.
"Quello è il tuo posto", gridai. Mi rivolsi poi al mio avversario: "Egregio
signore, perdonate uno stupido giovane come me, che vi ha offeso
solo per colpa sua e adesso vi ha costretto a sparargli contro. Sono
dieci volte peggiore di voi, anche di più, forse. Riferite questo alla
persona che vi è cara più di tutti al mondo" (ivi, p.397).
Tutti restano sbigottiti, alcuni lo tacciano di disonore al
reggimento; lo stesso avversario si sente preso in giro.
Ma questo è il momento che segna la conversione
dell’ufficiale: darà le dimissioni perché ha deciso di
cambiare vita, entrerà in monastero. Quegli errori che lo
hanno portato a essere in punto di morte,
paradossalmente lo hanno posto davanti alla vita in un
modo rinnovato per riscoprirne tutto il valore.
Senza entrare nei molti commenti che si potrebbero
apportare al testo, ciò che qui interessa sottolineare è
soprattutto il modo in cui Zosima è riuscito a rendersi
conto della sua colpa e ri-orientare il suo comportamento.
Il giovane è vicino alla morte, il suo livello di attenzione
alla vita è quindi particolarmente elevato. Non stupisce
pertanto che la contemplazione della bontà della natura
59
mattutina abbia un impatto sulla sua sensibilità e lo porti a
percepire il contrasto con il suo stato interiore. Ciò che
piuttosto può sorprendere è il passo successivo, ossia
come dal suo stato d’animo passi al riconoscimento del
male inferto (Afanasij non ha reagito mimeticamente ai
suoi colpi) e ritrovi dentro di sé la memoria del fratello con
i valori familiari in cui è cresciuto: la pari dignità fra gli
uomini, e uno sguardo comprensivo verso la colpa; tutti
siamo colpevoli verso tutti, dice Markel. Zosima è come
risvegliato all'esistenza, appena scopre un altro modo di
concepire la vita e il rapporto con gli altri, lo abbraccia. È
la sua conversione.
Michail, il visitatore misterioso
Nonostante l'immediato sconcerto generale, l’autenticità
del gesto del giovane Zosima verrà riconosciuta e
l’ufficiale diventerà una sorte di eroe del piccolo mondo
che lo circonda. È in questo frangente che appare il
secondo personaggio che ci interessa, Michail, il visitatore
misterioso. Questi, un signore di mezza età che da tempo
frequentava i salotti dove l’ufficiale raccontava la sua
storia di perdono e conversione, una sera si presenta a
casa sua. L’interesse del visitatore era tutto nel gesto
dell’ufficiale:
Descrivetemi, se non vi disturba questa mia curiosità, forse, così
inopportuna, che cosa avete provato nel momento in cui, durante il
duello, vi siete deciso a chiedere perdono: siete in grado di
ricordarlo? Non crediate che la mia sia una domanda frivola; al
contrario, ponendovi tale domanda perseguo un mio fine segreto che
vi rivelerò forse in seguito, se Dio ci concederà di avvicinarci ancora
60
di più". [...] "Voi mi domandate che cosa ho sentito nel momento in
cui ho chiesto perdono al mio avversario", gli risposi, "ma è meglio
che vi racconti tutto dall'inizio, cosa che non ho ancora fatto con
nessuno prima di ora" e gli raccontai tutto ciò che era avvenuto con
Afanasij e di come mi fossi prostrato ai suoi piedi. "Da questo potete
rendervi conto da solo", conclusi, "che al momento del duello tutto mi
è stato più facile giacché il processo aveva già avuto inizio a casa, e,
una volta imboccata quella strada, non mi è stato difficile proseguire,
anzi, per me è stato fonte di gioia e serenità" (ivi, p.401).
Da quella sera il visitatore divenne un assiduo
frequentatore della casa dell’ufficiale, voleva sapere di lui
e della sua vita, ma non parlava mai di sé. L’ufficiale
prese a volergli molto bene, lo considerava un uomo
giusto e trascorrevano molte piacevoli serate insieme
condividendo idee e sentimenti. Finché a un certo punto il
visitatore si confida.
"Che cosa avete?" gli domandai. "Vi sentite male?" Si era appena
lamentato di avere mal di testa. "Io... sapete... io... ho ucciso una
persona". Lo disse con il sorriso sulle labbra, ma pallido come un
lenzuolo. "Perché sorride?" Questa domanda penetrò nel mio cuore
prima che riuscissi a pensare a qualcos'altro. Impallidii anch'io. "Che
cosa state dicendo?" "Vedete", rispose con un pallido sorriso, "quanto
mi è costato caro dire la prima parola. Ma adesso l'ho detta e mi
sembra di aver fatto il primo passo. Proseguirò" (ivi, p.404).
Dapprima l’ufficiale faticava a crederci, Michail dovette
raccontargli la storia più volte, ma alla fine tutto era
chiaro. Molti anni addietro questa persona aveva ucciso
per passione la donna di cui era innamorato poiché aveva
rifiutato il suo amore a causa di un altro uomo. Dopo
l’omicidio era poi riuscito abilmente a nascondere le prove
e a fare ricadere l’accusa su un servo (morto poco dopo
61
per malattia), cosicché nessuno aveva mai lontanamente
sospettato di lui. Il fatto sulle prime non gli provocò alcun
rimorso tranne il dolore per aver ucciso la persona amata,
tuttavia poiché gli era intollerabile che lei potesse essere
di un altro, riteneva di non avere altra soluzione. Per
diversi anni la sua determinazione nel lavoro e nelle
opere di beneficienza gli fece quasi dimenticare il
passato, ma a poco a poco iniziò a penetrare in lui
l’angoscia per ciò che aveva fatto. In seguito si innamorò
di una ragazza bella e intelligente e si sposò presto
pensando che il matrimonio avrebbe alleviato il suo dolore
e solitudine. Avvenne invece il contrario:
Sin dal primo mese un pensiero incessante cominciò a turbarlo:
"Ecco, mia moglie mi ama, ma mi amerebbe ancora se sapesse?"
Quando ella fu incinta e ne dette notizia al marito, egli ne rimase
subito turbato: "Do la vita quando io stesso l'ho tolta?" Arrivarono i
figli: "Come oso amarli, istruirli, educarli, come farò a parlar loro della
virtù, quando io stesso ho versato sangue umano?" Intanto quegli
stupendi bambini crescevano, gli veniva voglia di accarezzarli: "Non
riesco a guardare i loro visetti innocenti, luminosi; non ne sono
degno". [_] Cominciò ad avere incubi spaventosi. Ma era un uomo
dal cuore forte e sopportò a lungo questo tormento: "Espierò tutto con
questo mio tormento segreto". Ma anche quella speranza si rivelò
infondata: più andava avanti e più intensa si faceva la sofferenza. In
società avevano preso a stimarlo per via della sua attività benefica,
sebbene temessero il suo carattere severo e cupo, ma quanto più lo
stimavano tanto più quella stima gli diveniva insopportabile. Mi
confessò che aveva persino pensato al suicidio. Ma cominciò ad
essere perseguitato da un altro pensiero, un pensiero che sulle prime
gli era sembrato impossibile e pazzesco, ma che, alla fine, aveva
così attecchito nel suo cuore che non riusciva più a sradicarlo. Ecco
in che cosa consisteva: alzarsi, farsi avanti tra la gente e confessare
davanti a tutti di aver ammazzato una persona. Erano tre anni che
questo sogno lo accompagnava, gli si affacciava alla mente in forme
62
diverse. Alla fine si convinse con tutto il cuore che se avesse
confessato il suo crimine, avrebbe guarito la sua anima e avrebbe
ottenuto la pace per sempre. Ma questa idea gli riempiva il cuore di
orrore: come l'avrebbe messa in atto? E poi, all'improvviso, era
avvenuto l'episodio del mio duello. "Guardando voi, mi sono deciso".
Io lo guardai. "È mai possibile", esclamai battendo le mani, "che un
episodio insignificante come il mio abbia potuto generare in voi una
simile risoluzione?" "La mia risoluzione è nata tre anni fa", mi replicò.
"Il vostro episodio mi ha dato soltanto la spinta necessaria.
Guardando voi, ho biasimato me stesso e vi ho invidiato", mi disse
persino con durezza (ivi, p.407-408).
Al contempo c’è in lui una grande paura, soprattutto per
ciò che sarebbe accaduto ai figli e alla moglie, e poi per la
separazione da loro. E chiede consiglio nuovamente
all’amico, il quale lo incoraggia ad obbedire alla voce della
coscienza che lo perseguita:
63
"E allora?" mi domandò guardandomi. "Andate", gli dissi,
"proclamatelo al mondo. Tutto passa, solo la verità rimane. I figli
capiranno, quando saranno grandi, quanta magnanimità si
racchiudeva nella vostra grande decisione" (ivi, pp.408-409).
Nonostante quel giorno si fosse congedato come avendo
preso una decisione, per diverse settimane nulla accadde
se non un tornare e ritornare sui pensieri che lo
affliggevano; sembrava che si stesse preparando senza
però decidersi.
"Lo so che sarà il paradiso per me, nel momento stesso in cui lo
dichiarerò. Per quattordici anni ho vissuto all'inferno. Voglio soffrire.
Accetterò la sofferenza e comincerò a vivere. Si può attraversare il
mondo facendo del male, ma indietro non si torna. Adesso non ho il
coraggio di amare non solo il mio prossimo ma neppure i miei figli.
Dio mio, i miei figli forse capiranno quanto mi è costata la sofferenza
e non mi giudicheranno! Dio non è nella forza, ma nella verità!" [_]
"Ho appena lasciato mia moglie" continuò lui. "Sapete che cosa è una
moglie? I bambini mentre me ne andavo gridavano: 'Addio, papà,
tornate presto a leggerci Il giornaletto dei bimbi'. No, non potete
capirlo! La disgrazia di un altro, non riesci a capirla". Gli occhi gli
brillavano e le labbra gli fremevano. All'improvviso sferrò un pugno
sul tavolo, tanto che tutti gli oggetti che vi erano sopra sobbalzarono era la prima volta che faceva un gesto del genere, era una persona
così pacata. "Ma sono tenuto a farlo?" gridò. "Sono obbligato a farlo?
Nessuno è stato condannato, nessuno è ai lavori forzati al posto mio,
quel servo è morto di malattia. E per il sangue versato sono stato
punito con i tormenti. E poi non mi crederanno, non crederanno
nemmeno a una delle mie prove. Devo dunque dichiararlo, devo
forse? Sono disposto a patire i tormenti per tutta la vita per il sangue
versato, a patto di non colpire mia moglie e i miei figli. Sarebbe giusto
rovinarli insieme a me? Non stiamo commettendo un errore? Qual è
la verità in questo caso? E la gente riconoscerà la verità, la
apprezzerà, la rispetterà?" (ivi, pp.409-410).
64
Altri giorni passarono con quell’angoscia quando
finalmente la dichiarazione avvenne nella festa del suo
compleanno alla presenza dei molti invitati della città. Nel
bel mezzo del festeggiamento Michail si alzò in piedi e
iniziò a leggere la sua confessione mostrando le prove di
ciò che aveva commesso. In realtà nessuno gli credette,
eppure la dichiarazione pubblica, l’accettazione delle
conseguenze delle sue azioni, gli ottenne la
riconciliazione interiore con gli altri e con Dio. Confidò poi
al suo amico:
Non appena ho compiuto quello che dovevo, ho sentito subito il
paradiso nel mio cuore. Adesso ho il coraggio di amare i miei figli e di
baciarli. Non mi credono e nessuno mi ha creduto, né mia moglie, né
i miei giudici: non ci crederanno mai neanche i miei figli. Scorgo in
questo la misericordia divina nei confronti dei miei figli. Quando sarò
morto, anche il mio nome rimarrà senza macchia per loro. Adesso
sento l'avvicinarsi di Dio, il mio cuore gioisce come se fossi in
paradiso... ho compiuto il mio dovere..." (ivi, p.413).
La situazione esistenziale e interiore di Michail è
completamente diversa da quella di Zosima. Qui abbiamo
una persona che ha celato il male commesso e oppone
resistenza a svelarlo. Nel suo caso accade letteralmente
quello che si potrebbe chiamare il lavorìo interiore della
colpa.
La colpa, quella qualità che alberga al centro della
persona attraverso i suoi atti cattivi, non consiste
semplicemente in un fatto che rimane tra gli altri nella
memoria, ma, se non la si smaschera, cresce
nascostamente negli atti e nelle azioni che determinano lo
sviluppo della persona e la consapevolezza che ha di sé
(Max Scheler, 2014, p.58). A motivo di ciò, quando si
commette un male e si ritorna poi su di esso, la difficoltà
non sta tanto nell’ammettere l’azione compiuta e il suo
disvalore, bensì nell’ammettere “che quell’azione l’ha
compiuta quella parte dell’Io nella totalità della nostra
persona da cui sorsero le radici dell’azione e l’atto di
volontà” (ivi, p.37 ); non si dice invero: ““Ah, che ho fatto!”,
ma più radicalmente: “Che uomo sono!”, oppure: “Che
uomo devo essere, se ho potuto fare una cosa simile”“
(ibidem). È tutto l’io che viene coinvolto, e quanto più la
colpa è stata nascosta nel tempo tanto più è parte del
soggetto e difficile da sradicare. La persona è convinta
ormai di essere cattiva perché la colpa ha pervaso ogni
azione e l’intero modo di percepirsi. Il problema principale
di Michail, infatti, è che non riesce più a guardare a sé
come a un essere amabile e degno di amore; per questo
65
arriva a pensare addirittura al suicidio5. Lo stesso amore
degli altri gli diviene insopportabile. Tale amore, ha invero
il potere di risvegliare in lui il dolore per la colpa, e a
causa di questa viene messa in discussione la possibilità
dell'amore stesso. Si chiede infatti: mi amerebbero se
sapessero ciò che ho fatto? Loro mi amano perché non
sanno chi sono, e quindi in realtà non amano me. Michail
è costantemente diviso dal desiderio di essere
amato/amabile e la convinzione che per lui ormai sia
impossibile.
È mentre vive questo conflitto interiore che la figura del
giovane ufficiale diventa chiave nella sua storia. Zosima
ha avuto la forza di ammettere la sua colpa, di affrontare
lo scherno dei compagni e le conseguenze delle sue
azioni. Michail lo vuole imitare e ne diventa amico;
l'esempio e la fiducia di Zosima sono essenziali per il
percorso di Michail verso la liberazione dalla colpa e il
perdono.
Colpa e pentimento
Quando si affronta il tema del perdono nella prospettiva
del colpevole, due sono gli aspetti centrali che entrano in
gioco: il rapporto del soggetto con la colpa e il
pentimento.
Per fare chiarezza occorre distinguere tra ciò che è la
colpa, ossia quella qualità che agisce nell'anima legata
all'azione cattiva effettuata, e il senso di colpa, vale a dire
5
Qui si rivela il significato ontologico e fondante dell’amore, nella linea delle
affermazioni di Buber (Martin Buber 2004, pp.69-71) e Pieper (Josef Pieper, 1974,
pp.97-98).
66
il rapporto che il soggetto stabilisce con essa. La
psicologia contemporanea (Francesco Mancini, 2008) ha
messo in luce l'esistenza di due tipi di sensi di colpa che
generano due reazioni emotive differenti: il senso di colpa
deontologico e il senso di colpa altruistico. Il senso di
colpa cosiddetto deontologico nasce dalla trasgressione
dei comandamenti dell’autorità morale, i quali sono
progressivamente interiorizzati nel corso dello sviluppo
del bambino, fino a costituire una delle strutture
fondamentali della psiche. Il senso di colpa è
l’espressione di un conflitto tra norme morali interiorizzate
e le azioni o disposizioni all’azione dell’individuo (ivi,
pp.123-124). Ora, una delle norme morali interne al
soggetto umano, è il rispetto dell’altro e il dovere di
difendere tale diritto. Le omissioni in questo senso
possono provocare forti sensi di colpa; non tanto a motivo
dell’affetto verso una persona concreta, ma a motivo della
norma trasgredita, della consapevolezza che si doveva
agire diversamente. È la propria dignità morale che c’è in
gioco qui. E ciò che si prova di fronte a una omissione in
questo senso è un profondo disgusto morale nei confronti
di se stessi e un forte desiderio di punizione (ivi, p.133). Il
senso di colpa altruistico invece è generato dal rapporto
affettivo che si ha con una certa persona. Si è ferita
questa persona e la reazione immediata sarà cercare di
riparare in qualche modo, restaurare il danno inferto
laddove è possibile. Talvolta anche tale senso di colpa si
accompagna a disgusto morale, secondo le modalità in
cui è avvenuta la ferita, ma nella maggior parte dei casi
ciò che prevale in questo tipo di senso di colpa è il
67
desiderio di riparazione; ciò che muove è l’amore dell’altro
più che la vergogna di sé.
Nel caso di Zosima, sembra prevalere questo secondo
senso di colpa, non tanto per il particolare affetto che lui
avesse verso il suo attendente o il duellante, quanto per
la nuova prospettiva esistenziale che gli si apre nella
memoria del fratello: improvvisamente lui sembra rendersi
conto di chi è un essere umano e cosa vuol dire ferirlo.
Da lì nasce il suo dolore, e non per aver trasgredito una
norma del suo codice morale. La sua attenzione non è su
se stesso né sul disprezzo di sé per il male effettuato,
bensì sull'altro; egli vuole riparare e per questo si inchina
davanti ad Afanasij e chiede perdono all'avversario nel
duello.
Le relazioni familiari e i valori in cui è cresciuto Zosima
hanno anche reso più immediato il riconoscimento del
male commesso così che la colpa non ha potuto agire
nascostamente in lui. Non che egli non si sentisse
colpevole, anzi, la convinzione emersa dalle parole del
fratello è che tutti siamo colpevoli di tutto. Ma la colpa nel
suo caso non è un ostacolo per sentirsi amato o per
amare, anzi, diventa generatrice di riparazione e di nuovi
legami. Egli, nella relazione interiorizzata del fratello,
porta già in sé la liberazione del perdono.
Nel caso di Michail invece, come si è visto, la colpa è
diventata parte di sé nel tempo, e pertanto il processo di
pentimento e riconoscimento del male davanti agli altri è
stato più lento e difficile. Il senso di colpa in lui è del primo
tipo; egli si disprezza profondamente, non si ritiene più
degno nemmeno di vivere o di dare la vita. Il suo dolore è
per essere colpevole di aver trasgredito i suoi codici
68
morali. Tutta la sua preoccupazione sta nell'essere
riconosciuto ancora degno di essere amato e di poter
amare.
Ciò che è interessante notare a questo punto è come il
processo di pentimento che ha il suo culmine nella
dichiarazione di colpevolezza pubblica, per entrambi i
personaggi richieda l'intervento di una mediazione
relazionale. Per Zosima è la memoria del fratello, la
relazione interiorizzata che ha con lui che lo aiuta a
scoprire l'entità del male commesso e il bisogno di
riparare, per Michail sarà lo stesso Zosima. Questi è
mediatore del desiderio dell'altro in due modi: da una
parte è il modello che Michail ammira e invidia, colui che
è riuscito ad affrontare il suo demone; dall'altra, è colui
che può comprenderlo senza giudicarlo – ha avuto la sua
stessa fragilità – e rende così più facile la confidenza;
l’apertura con Zosima costituisce la breccia per
confessare il suo crimine a tutti. La mediazione si rivela
quindi essenziale per evitare l'insano mimetismo che la
colpa può provocare nel soggetto nei confronti di sé
stesso: l'Io che continua ad agire deterministicamente
nella linea del male imitando continuamente il gesto
cattivo e identificandosi con esso. L'effetto trasformante
che le azioni umane hanno sul soggetto che le compie fa
sì che l'offensore, compiendo il male, privi innanzitutto se
stesso di bene, e per tornare buono, necessita di un
terzo, un'altra sorgente di bontà.
La narrazione ha altresì evidenziato la natura relazionale
del pentimento: esso non è ritenuto compiuto finché la
colpa resta nascosta agli altri. L'atto di pentirsi nella sua
radicalità consiste nel ritornare della persona su se
69
stessa, su quella parte dell'Io che ha agito male,
accettarla come tale e agire su di essa (Max Scheler,
p.44). Ma senza la dichiarazione di colpevolezza, il
pentimento e con esso la successiva liberazione della
colpa e quindi il perdono, non si realizzano. Nella
dichiarazione di colpevolezza diventa, infatti, reale
l’assunzione di responsabilità del colpevole, ed è qui che
la persona manifesta la verità del suo pentimento, nella
misura in cui è disposta a subire le conseguenze del suo
agire e a cambiare. Detta dichiarazione è al contempo un
atto di coraggio e di abbandono: il coraggio di decidere di
mettere a nudo la propria fragilità in modo che gli altri ne
possano disporre. Tale coraggio in qualche modo dà al
soggetto la consapevolezza di essere ancora capace di
bontà, equivale a una sorta di gesto riparatore nel quale
l'offensore ridona a se stesso una dignità. Tuttavia la
forza di tale gesto nei due casi è attinta dalla fiducia nel
paradiso. Per entrambi il gesto di abbandono è in
definitiva un rimettersi nelle mani del Padre; Dio non è
nella forza ma nella verità, diceva Michail. Si può quindi
affermare che il processo di pentimento inizia, avviene e
termina in relazione e con il supporto degli altri.
Ultimo elemento narrativo da rilevare qui è che in
entrambi i casi presi in esame non viene data una
punizione ai colpevoli e quindi si evidenzia come la
liberazione del perdono non derivi dalla sofferenza
dell’espiazione, bensì consista in una sorta di dono legato
al pentimento dichiarato.
70
Conclusioni
Possiamo quindi offrire una risposta alla domanda sottesa
a questa trattazione. In tutta la narrazione si rivela la
dimensione intrinsecamente relazionale del processo e
dell’esito finale di liberazione dal dolore della colpa e di
ricostituzione in dignità del soggetto che ha commesso il
male. Così come nei casi di perdono dell’altro, si osserva
qui che, per attivare il processo di perdono di sé che
passa attraverso il riconoscimento della colpa e il
pentimento, è necessario l’intervento di un terzo che
costituisca un’altra fonte di essere e di amore. Esiste però
una differenza tra i due casi: in Zosima la mediazione
relazionale è interna al soggetto, il fratello è dentro di sé
con la prospettiva nuova di cui è portatore. Qui sembra
che il soggetto abbia una fonte interna di perdono; di fatto
la gioia propria della liberazione dal dolore della colpa in
lui avviene già prima della dichiarazione di colpevolezza,
quando riscopre attraverso il fratello chi è l'essere umano
e quindi chi è egli stesso e a cosa è chiamato. Non ha
bisogno della conferma degli altri fuori di sé per sentirsi
buono e capace di bene; il perdono lo ha in sé attraverso
le relazioni familiari interiorizzate. Nel caso di Michail
invece la colpa lavora internamente ed egli tende a
identificarsi con il male commesso, a cosificarsi. È
necessario per lui interiorizzare lo sguardo empatico di
Zosima che, amandolo pur nella sua fragilità, gli ridoni la
possibilità di percepirsi come buono nonostante i suoi
errori.
Dalla narrazione e dai ragionamenti emersi si ritiene
quindi che, se con l’espressione perdono di sé intendiamo
71
che il colpevole dà il perdono a se stesso, ciò non
accade. Nel rapporto dell’offensore con la sua colpa egli
non ottiene da sé la liberazione dalla colpa, ossia non
ridona a sé la dignità di essere umano amabile e capace
di bontà. Ciò non significa che la libertà del soggetto non
abbia un ruolo decisivo nella dinamica; tale ruolo, per
nulla banale, consiste essenzialmente nell’accogliere
l’amore dell’altro, accettare il bisogno che sente di esso,
chiedere aiuto e così poter affrontare la propria fragilità6.
Ma è solo attraverso l’interiorizzazione di un altro che
conferma il soggetto con il suo amore che questi può
tornare a vivere libero dalla prigionia della colpa e a
riconsiderarsi buono.
72
Riferimenti bibliografici
Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press,
Chicago 1958.
6
La psicologia contemporanea sta sviluppando diversi studi sul tema del perdono di sé
in quanto costituisce un elemento essenziale nella psicoterapia. Nella prospettiva
antropologica qui delineata si mette a fuoco l’elemento relazionale che non è sempre
esplicito nelle trattazioni di carattere psicologico (Nicola Petrocchi, Barbara Barcaccia e
Alessandro Couyoumdjian, 2013).
Nicola Petrocchi, Barbara Barcaccia, Alessandro Couyoumdjian, Il
perdono di sé: analisi del costrutto e possibili applicazioni cliniche, in
Barbara Barcaccia, Francesco Mancini (a cura di), Teoria e clinica del
perdono, Raffaello Cortina 2013, pp.185-227.
Federica Bergamino, La trasformazione affettiva: narrazione e
antropologia del perdono, in Federica Bergamino (a cura di), Liberare
la storia, FrancoAngeli, Roma 2015, pp.15-35.
Id., La res svelata dalla letteratura, in Federica Bergamino (a cura di)
Alice dietro lo specchio. Letteratura e conoscenza della realtà,
Edizioni Sabinae, Roma 2013, pp.121-158.
Eileen Borris-Dunchustang, Perdonare, Elliot Edizioni, Roma, 2010.
Remi Brague, Les ancres dans le ciel. Infrastructure mètaphisique,
Editions du Seuil, Paris 2011, Ancore nel cielo. L’infrastruttura
metafisica, trad. di Mario Porro, Vita e Pensiero, Milano 2012.
Martin Buber, Ich und du, Insel, Lipsia 1923, Io e tu, in Il Principio
dialogico e altri saggi, trad. di Anna Maria Pastore, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 1993.
Fëdor Dostoevskij, Brat’ja Karamazovy, “Il messaggero russo”,
Mosca 1879-1881, I fratelli Karamazov, 1993, trad. di Agostino Villa,
Einaudi Tascabili, 2014.
René Girard, La voix meconnue du réel, Grasset & Fasquelle, Paris
2002, La voce inascoltata della realtà, trad. di Giuseppe Fornari
Adelphi, Milano 2006.
Id., Je vois Satan tomber comme l’eclair, Grasset & Fasquelle, Paris,
Vedo Satana cadere come la folgore, trad. di Giuseppe Fornari,
Adelphi, Milano 2001.
Giovanni Liotti, La dimensione interpersonale della coscienza,
Carocci, Roma 2005.
Antonio Malo, Dono, colpa, perdono, in Barbara Barcaccia,
Francesco Mancini (a cura di), Teoria e clinica del perdono, Raffaello
Cortina 2013, pp.1-15.
Francesco Mancini, I sensi di colpa altruistico e deontologico,
“Cognitivismo clinico” 2008 (5-2), pp. 123-144.
Josef Pieper, Über die Liebe, Kösel Verlag, München 1972,
Sull’amore, trad. di Gianni Poletti, Morcelliana, Brescia 1974.
73
Max Scheler, Vom Ewigen im Menschen: Reue und Wiedergeburt,
Bouvier, Bonn 1917, Il pentimento, trad. di Nicola Zippel,
Castelvecchi, Roma, 2014.
Michail Tomasello, The Cultural Origins of Human Cognition, Harvard
University Press, Harvard, 1993.
74
“IL Y A LE PARDON”. PICCOLA FENOMENOLOGIA DEL
PERDONO, A PARTIRE DA PAUL RICOEUR
Annalisa Caputo
Non è facile parlare ‘filosoficamente’ del perdono,
facendosi largo tra gli (inevitabili) pregiudizi che lo
colgono, per certi versi anche giustamente, come un tema
forse più religioso-confessionale che critico-teorico.
Non è facile parlare ‘fenomenologicamente’ del perdono,
cercando di evitare tanto un’esaltazione fine a se stessa
(sempre a rischio, sul crinale del moralismo e del
formalismo legalista) quanto una negazione a priori della
possibilità del perdonare (in quanto magari legata solo a
falsa coscienza o a forme di risentimento).
E forse anche per questo Paul Ricoeur – che abbiamo
scelto come compagno di strada in questo cammino –
parla da subito di “perdono difficile”1. E l’aggettivo
possiamo
spostarlo
sulla
questione
del
perdono.Interrogarsi sul perdono è difficile. E questa
difficoltà è da assumere e non da scansare: pena la
caduta nella retorica o nell’ideologia.
Alcune presupposizioni ermeneutiche, allora, vanno date.
Crediamo che del perdono si possa parlare
filosoficamente. Crediamo che se ne possa parlare ‘sine
ira necstudio’. Crediamo che esista una possibilità
1
P. Ricoeur, Il perdono difficile, Epilogo, in Id., La memoria, la storia, l’oblio, tr. it. di D.
Iannotta, Cortina, Milano, 2003, pp. 649-717.
75
alternativa sia alla sua difesa tout court sia all’esserne
inevitabilmente contrari.
Il perdono “c’è, es gibt, thereis”, “il y a” – fa notare
Ricoeur2. È un dato fenomenologico. Prima di poter (o
dover) dire se è giusto o ingiusto, se serve o non serve,
chi lo deve a chi, e come e perché, prima di tutto questo
c’è un ‘prima’. In questo “c’è”, in questo “il y a” (in questa
illeità) si articola, allora, il nostro percorso. Che di questo
dato vuol provare a tracciare un’ideale fenomenologia.
Non ‘ripeteremo’ l’articolazione argomentativa proposta
da Ricoeur nei testi in cui tratta del tema, ovvero La
memoria, la storia e l’oblio e Ricordare, dimenticare,
perdonare3. Li useremo, invece, come ‘fondo’ testuale a
cui attingere per tracciare il percorso. Nella
consapevolezza che “partiamo da Ricoeur” e non da noi.
Ma vogliamo comunque provare a pensare e descrivere a
partire da noi.
E allora iniziamo4.
C’è il perdono facile
Sotto questo titolo possiamo mettere tutte le esperienze
retoriche del perdono. Con ‘retoriche’ intendiamo, in
2
Ivi, p. 662.
P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, tr. it. di N.
Salomon, Mulino, Bologna, 2004.
4
Scandiremo il discorso in tre passaggi: perdono facile, perdono impossibile, perdono
difficile, seguendo idealmente l’affermazione che Ricoeur pone all’inizio dell’Epilogo già
citato su Il perdono difficile: “perdono difficile: né facile, né impossibile”, La memoria, la
storia, l’oblio,cit, p. 649.
3
76
questo contesto, le esperienze che si fermano al livello
verbale, ma che non rendono la parola ‘atto’.
Le ragioni per cui si innesca quel meccanismo che
Ricoeur chiama il “perdono facile”5 possono essere
innumerevoli. Qui le due matrici ‘classiche’ della ‘parola’
sul perdono (quella religioso-morale e quella psicanalitica)
si incontrano: si perdona perché si deve perdonare. C’è
un’istanza superiore che lo chiede: se sia Dio o il Super-Io
(e dunque se di conseguenza sia un bene o una male)è
relativo dal punto di vista dell’analisi del ‘soggetto’ del
perdono. Il perdono è richiesta eteronoma. Si impone.
C’è_ nel senso che si è sempre fatto così. E in fondo lo
sai anche tu che, se non lo fai, sei cattivo. In fondo.
Perché nella immemoriale memoria (della tua infanzia
personale e dell’infanzia dell’umano) tutto questo è
iscritto, come su tavole di pietra. E allora lo fai.
‘Ti perdono’ è espressione dovuta. Se sei uno
‘scrupoloso’ puoi persino riuscire a perderti nel ‘conto’
delle “settanta volte sette”. E puoi anche riuscire ad
apparire sul teleschermo in TV, dopo che ti hanno
ammazzato il figlio e dire che hai perdonato gli assassini.
Poi però resti solo con te stesso. E arriva inevitabilmente
il momento in cui ti chiedi: ho perdonato veramente? E lo
meritava? E me lo ha almeno chiesto? E che senso ha
tutto questo?
E se l’offeso, l’offesa sono io: può realmente la vittima
perdonare il carnefice (im/penitente, im/punito)?
Basterebbe la lunga litania dei femminicidi quasi
5
Id., Ricordare, dimenticare, perdonare, cit., pp. 110 sgg.
77
quotidiani per rispondere: ovviamente no. Più che facile,
un perdono di questo tipo è stupido, ottuso.
Ricoeur dice: è una fuga. Il perdono facile, superficiale,
impensato, acritico, è sempre una forma di fuga e
rimozione. Da cosa? Da se stessi innanzitutto, da quanto
accaduto. E dunque dal proprio passato6.
Il perdono ha un rapporto particolare con ciò-che-è-stato
e con il suo ricordo. Perdono e memoria: questo è il
problema.
Il perdono facile si illude di sganciarsi dalla memoria in
nome di qualche Immemorabile che chiede la
cancellazione della colpa (e/o del peccato).
Apparentemente facile. In realtà impossibile. Perché il
passato non si cancella. Jankélévitch lo dice in termini
forti e poetici nel suo L’irréversible et la nostalgie:
l’irrevocabile è che l’essere-stato non può essere disfatto7. È il peso del ‘Fu’, dell’Es warnietzscheano. Ma noi,
questo peso dell’irreversibile, non siamo capaci di
sopportarlo. E allora lo nascondiamo a noi stessi,
illudendoci di averlo appunto ri-verso nel perdono,
alleggerito
(nell’alleggerimento
della
coscienza):
insostenibile pesantezza della colpa, necessaria
leggerezza del perdono: facile: facile illudersi quando
l’impossibile si impone. Ma questo non è perdono se non
nella ‘parola’: il resto è rimozione.
E quante forme sottili può assumere questo perdono
facile (o di fuga). La litania di “il y a” con cui Ricoeur inizia
6
In questo senso, il perdono facile porta il Sé nella chiusura della malinconia. Su
questo ci siamo soffermati a lungo nel nostro Io e tu. Una dialettica fragile e spezzata.
Percorsi con Paul Ricoeur, Stilo, Bari, 2009, pp, 146-158.
7
Il testo è citato da Ricoeur in una nota de La memoria, la storia_, cit., pp. 689-90.
78
i capoversi del passaggio in cui elenca una serie di
possibili aspetti di questo (illusorio) perdono ci riporta alla
cornice della nostra fenomenologia. Che in questo caso
pare quasi una poesia.
C’è innanzitutto il perdono di autocompiacimento, che non fa altro
che prolungare idealizzandolo, l’oblio di fuga: che vorrebbe fare
economia del lavoro della memoria.
C’è il perdono di benevolenza, che vorrebbe fare economia della
giustizia e cospira con la ricerca d’impunità. [_]
C’è il perdono più sottile, quello d’indulgenza, dalla cui parte sta
un ramo della tradizione teologica, secondo la quale il perdono
significa assoluzione, [_] come se sulla tabella degli acquisti la
colonna del debito fosse cancellata, [_] il che va nella stessa
8
direzione dell’oblio peggiore
C’è il perdono di autocompiacimento
Cioè oblio di fuga idealizzato. “Strategia di evitamento,
motivata da una volontà oscura di non informarsi, non
indagare [_], non voler sapere”9. Quel che è stato è
stato. Inutile anche parlarne. Perché cercare di capirne_
ragioni, cause, errori? Tutti possono sbagliare. Tutti
meritano di essere perdonati. Ma il migliore è sempre
quello pronto a perdonare per primo e sempre. Nietzsche
la indicherebbe come sottile forma di alterigia e
superiorità. Il perdono del com-piacente (a cui piace
perdonare, sempre, per primo) è l’assoluzione farisaica
che il ‘piacente’ dà a se stesso. E certo conviene sempre
perdonare la pagliuzza dell’altro in anticipo, se questo può
evitare che l’altro noti la trave che sto ben nascondendo.
8
9
Id., Ricordare, dimenticare_, cit., pp. 112-13
Ivi, p. 106.
79
Forse innanzitutto davanti a me stesso, a me stessa. Il
perdono di autocompiacimento non ‘scioglie’ le colpe.
Semplicemente – come se fossero massi casualmente
caduti sul percorso – le evita e prosegue. Non ‘sente’ il
male compiuto o subìto (o, meglio, si sforza in tutti i modi
di non sentirlo). E quindi non ‘sente’ nemmeno realmente
il perdono. Tutto resta in superficie. Parafrasando
Nietzsche: noi abbiamo scoperto il perdono, la felicità –
dicono i piccoli uomini (del perdono autocompiacente); e
ammiccano10. Lustrini di bravura e bontà. Tutta
apparenza imbiancata e ammiccante. A nascondere tutto
quello che è diventato piccolo.
Il perdono facile di autocompiacimento è un perdono
piccolo, meschino. Non solo perché è di facciata, ma
perché è di maschera. Maschera di paura. Paura di
affrontare la realtà, la vita, il male (subìto e/o commesso).
Perché è molto più difficile chiedere: ma perché mi hai
fatto questo? Che cosa è successo? (e affrontare il rischio
del silenzio, dell’incomprensione, dell’attestazione di un
fallimento, di un’impossibilità o incapacità); mentre è più
facile dire: non è successo nulla, ti perdono.
Lo scavo nella memoria pesa. Il lavoro sull’accaduto
pesa. Pensare all’essente-stato pesa. Saltellano leggeri,
invece, i piccoli uomini che sanno mediocremente
accontentarsi delle convenzioni, dell’apparire, delle
parole.
10
Stiamo chiaramente parafrasando la Prefazione di Così parlò Zarathustra, tr. it. a
cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1991, p. 11. Nel testo nietzscheano i
piccoli uomini si illudono di aver inventato la felicità (mentre in realtà nella loro
semplificazione della vita hanno semplicemente rinunciato a cercarla, perché conquista
faticosa).
80
C’è il perdono di benevolenza:
E questo è il perdono ‘amico’ dell’impunità. Possiamo
forse inserire in questo campo anche le non sempre
chiare forme di amnistia, quando si “invita a fare come se
l’evento non avesse avuto luogo. (_) Come se si potesse
cancellare la macchia di sangue sulla mano di Lady
Macbeth!”11. Come se il perdono potesse scavalcare la
giustizia. Anche in questo caso sarebbe troppo facile. Non
solo per il perdonato/reo, ma anche per il
perdonante/benevolo.
A livello sociale questo è evidente: le conseguenze di un
male commesso o subìto non si chiudono nella relazione
duale vittima/colpevole; e necessitano di una ‘terzietà’
giudicante, di giudizi, sanzioni e possibilmente
riabilitazioni12. Paradossalmente questo sarebbe vero
anche quando ci illudessimo di poter gestire in due la
cosa, eliminando il livello ‘esterno’ dell’economia della
giustizia. Perché la prima giustizia è sempre nei confronti
di noi stessi. Lo accennavamo prima. Se io sono vittima di
un tuo atto di violenza, io non posso perdonarti con un
perdono di benevolenza, illudendomi di fare bene a me (e
a te) facendoti scavalcare il peso di un giudizio: e quanto
più grave è la violenza (la pena che tu mi hai inflitto) tanto
11
Id., Sanzione, riabilitazione, perdono, in Id., Il giusto,tr. it. di D. Iannotta, Sei, Torino,
1998, p. 178. Ancora, sulla critica ad un’amnistia usata in maniera indiscriminata, cfr.
Id., Ricordare, dimenticare6, cit., pp. 111 sgg.
12
Su questo è da leggere tutto il saggio sopra citato: Sanzione, riabilitazione, perdono.
Sul tema cfr. M. van derBrempt, Lecture de ‘Sanction, rèhabilitation, pardon’ de Paul
Ricoeur; J. Fierens, Sanctionou pardon au Ruanda. A propos de ‘Sanction,
rèhabilitation, pardon’de Paul Ricoeur, in F. X. Druet, E. Ganty (a cura di),
Rendrejusticeaudroit. En lisant ‘Le Juste’ de P. Ricoeur, Pres. Univ. De Namur,
1999,rispettivamente pp. 251-268, 269-282. Ma anche O. Aime, Dei delitti, della pena,
del perdono, in M. Piras (a curadi), Saggezza e riconoscimento. Il pensiero eticopolitico dell’ultimo Ricoeur,Meltemi, Roma, 2007, pp. 165-188.
81
più giusta sarà la pena che dovrai vivere se sarà grande.
Il perdono (autentico) non scavalca la giustizia. Mai.
Piuttosto la attraversa e la supera13. Altrimenti è un (falso)
perdono che in realtà non vuole-bene (bene-volenza) e
non fa bene né a chi a vissuto né a chi a commesso il
male. Perché il male va sempre innanzitutto riconosciuto.
E non rimosso.
Poi c’è perdono d’indulgenza
E questa sarebbe la remissione come cancellazione della
colpa. Pia strategia a cui certe teologie e certe gerarchie
religiose hanno in vari modi e tempi fatto ricorso14. Qui il
discorso di Ricoeur è ancora più sottile di quanto non sia
quello degli indulgenti. Lo sintetizziamo solo perché
abbiamo scelto di non approfondire il ramo teologico del
perdono. Il nucleo filosofico della questione è in ogni caso
chiaro: c’è differenza tra colpa (o peccato) e debito.
Pensare in termini di ‘debito’ (e dunque di credito) ci porta
in una logica dello scambio e della retribuzione.
Doppiamente paradossale. Primo perché ci rende
eternamente debitori (anche quando i debiti ci vengono
ufficialmente cancellati); infatti la nostra fallibilità e
colpevolezza non sono mai cancellabili. Secondo perché
se su un piatto della bilancia mettiamo noi stessi (con i
nostri tanti debiti e pochi crediti) e sull’altro piatto della
bilancia mettiamo il Divino Sempre Giusto, diventa
evidente la sproporzione della nostra incancellabile
13
In questo senso Ricoeur si rifiuta di inserire il perdono nella logica del politico, o della
giustizia; e, come vedremo, lo iscrive in quegli atti di gratuità assoluta che sono sovraetici.
14
Cfr. Id., Ricordare, dimenticare_, cit., p. 112.
82
miseria. In questa logica, ogni cancellazione è una presa
in giro, una magia, una superstizione, che non merita
nemmeno il nome di religione15. “Perdonare non significa
semplicemente saldare, sopprimere un debito, ma
ricostruire una memoria. E ci si scontra con qualcosa di
irreparabile, di inestricabile, e anche, eventualmente di
imperdonabile”16.
Sembra che allora abbiano ragione i maestri del sospetto.
Sembra, cioè, che, se un perdono si dà, si dà solo nella
figura dell’impossibile.
C’è il perdono impossibile
Il y a. Conosciamo bene le sue forme. Tutte le volte in cui
(non è che non vogliamo, ma_) proprio non possiamo
perdonare. E sentiamo che è giusto così. Che ci sono
delle cose imperdonabili. Che si passerebbe dalla parte
dei carnefici giustificandoli. Che si deve avere il coraggio
di dire che la Shoà è imperdonabile. Che i crimini contro
l’umanità sono imperdonabili. Che quello che succede
oggi in Siria (e in miriadi di altre parti del mondo,
silenziosamente soffocate nella loro dignità di mondo
‘umano’) è imperdonabile17.
15
Su questo cfr. Id., Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia, tr. it. di I. Bertoletti, ,
Morcelliana, Brescia, 1993.
16
Id., La logica di Gesù, tr. it. a cura di E. Bianchi, Qiqajon, Magnano (BI), 2009, p.
149.
17
Qui Ricoeur segue l’argomentazione di J. Nabert, Saggio sul male (1955), tr. it. di F.
Rossi, La Garangola, Padova, 1974, analizzato alle pp. 656 sgg. de La memoria, la
storia e l’oblio.
83
E, però, se questo è vero, è necessario essere ancora più
radicali:
Il termine [imperdonabile] non si applica soltanto ai crimini che, a
ragione dell’immensa disgrazia da cui le vittime sono schiacciate,
ricadono sotto la denominazione dell’ingiustificabile [_]. Esso non
si applica nemmeno soltanto agli attori che hanno segnatamente
perpetrato questi crimini. Si applica anche al legame più intimo
che unisce l’agente all’azione. [_] L’azione umana è per sempre
consegnata all’esperienza della colpa. Anche se la colpevolezza
non è originaria, essa è per sempre radicale. Proprio questa
aderenza della colpevolezza alla condizione umana, sembra
renderla non soltanto imperdonabile di fatto, ma imperdonabile di
diritto_ Strappare la colpevolezza all’esistenza equivarrebbe, così
18
sembra, a distruggere quest’ultima da cima a fondo .
Primo dramma del perdono impossibile: io sono
imperdonabile perché irrimediabilmente colpevole.
Si tratta di un dramma dal duplice palcoscenico:
ontologico (se non addirittura mitico) e ontico-personale.
Palcoscenico più piccolo: ‘io’ sono imperdonabile perché
sono fallibile e di fatto fallisco. E questo mio errore
(piccola colpa o grande crimine che sia) non è qualcosa
che ‘ho’, è qualcosa che ‘sono’. Io ‘sono’ i miei atti. Ogni
atto è tale perché ascritto ad un soggetto19. E ogni
soggetto è tale perché compie atti di cui è responsabile in
prima persona. L’atto ‘fatto’ è irrevocabile. E se l’atto è
colpevole, la sua colpevolezza (la mia colpevolezza) è
irrevocabile. Nessuno può far sì che quanto fatto non sia.
18
P. Ricoeur, La memoria, la storia_, cit., p. 660.
Cfr. su questo Id., La persona, tr. it. di I. Bertoletti, Morcelliana, Brescia 1997, pp. 58
sgg.
19
84
Nessuno può far sì che non sia ‘io’ quella persona che ha
ferito, umiliato, deluso, tradito20. E se anche un altro mi
dicesse che non è così o che mi perdona, non
cambierebbe questo ‘fatto’.
Palcoscenico più grande, quello dei grandi miti, delle
grande religioni o semplicemente delle filosofie
esistenzialistiche ed ontologico-storiche: da quando “c’è”
l’uomo “c’è” la colpa. Non esiste essere umano innocente.
Sì, possiamo anche arrivare a credere o pensare che
questo sia ‘accaduto’, in una contingenza e non sia
‘originario’. E si potrebbe anche arrivare a distinguere un
tempo trans-storico diverso da quello storico21 in cui le
cose sarebbero potute andare diversamente e
potrebberotornare ad essere diverse (nel Mito adamitico
questo è evidente: è il ‘prima’ del peccato, il ‘prima’
dell’Eden). Ma,ammesso pure tutto questo, resterebbeil
fatto che “il male è già sempre l’empiria”22: è già sempre
radicale e radicato nell’essere dell’uomo.
A che, allora, il perdono?
O, forse, ha ragione Derrida, è posta male proprio la
domanda? Se mai un perdono si dà, se mai è possibile, è
possibile solo senza a-che, senza finalità. Forse il
perdono va iscritto esattamente a livello dell’impossibile23.
Ma non rischia anche questa di essere solo messa in
scena e retorica e letteraria? Se poi colleghiamo questa
impossibilità del perdono a quanto detto a proposito del
20
Stiamo seguendo Id., La memoria, la storia_, cit., pp. 660-661, in cui Ricoeur
riassume le tesi di N. Hartmann.
21
Cfr. ivi, pp. 659 sgg; più diffusamente Id., Finitudine e colpa,tr. it. di M. Girardet, , Il
Mulino, Bologna, 1970, pp. 517 sgg.
22
Id., La memoria, la storia_, cit., p. 659.
23
Ivi, pp. 663 sgg., in cui Ricoeur si confronta con le tesi di Derrida sul perdono.
85
legame tra l’agente e le proprie azioni, l’impasse diventa
due volte evidente. Ammesso e non concesso che sia
possibile “separare il colpevole dal suo atto, altrimenti
detto perdonare il colpevole pur condannando la sua
azione, significherebbe perdonare a un soggetto diverso
da quello che ha commesso l’atto”24.
E qui forse più che Derrida è Nietzsche ad aver posto
l’obiezione più efficace: che poi è la stessa obiezione (non
a caso) che viene fatta nei confronti dello statuto della
promessa25. In che senso? Perdono e promessa si
radicano su un’illusione metafisica, su un’antropologia
sostanzialistica (falsa dal punto di vista ontologico ancor
prima che morale): l’illusione che io sia ‘sempre’ lo stesso,
la stessa.
Io non posso prometterti oggi che domani (e magari per
sempre) ti sarò fedele, perché domani sarò diverso,
diversa. E lo sarò ancor di più nel corso degli anni. Chi
promette ora non è lo stesso che manterrà (o non
manterrà) la promessa domani. E dato che, come
sapevano gli Antichi, non solo non ci si può bagnare due
volte nello ‘stesso’ fiume, ma nemmeno una volta (perché
non esiste ‘uno stesso’ fiume, ma solo il fiume del divenire
continuo), lo statuto della promessa è fallace e vano; così
come lo statuto della soggettività sostanziale26.
È chiaro che il perdono è impossibile, in questa logica.
Per un motivo diverso (eppure forse ancor più evidente)
rispetto a quello tracciato nel primo Primo dramma.
24
È sempre Ricoeur che riferisce e segue l’argomentazione critica, pungente che
Derrida svolge nei confronti della possibilità del perdono (ivi, p. 697).
Cfr. ivi, pp. 691 sgg., in cui appunto Ricoeur mette in parallelo il tema del perdono e
quello della promessa. Il confronto con Nietzsche è alle pp. 692 sgg.
26
Sulla questione della promessa cfr. Id., La persona, cit., p. 56.
25
86
Secondo dramma (tragico-dionisiaco) del perdono
impossibile:
io
sono
imperdonabile
perché
irrimediabilmente innocente.
Se il primo dramma ci portava a dire che io sono
imperdonabile, perché irrimediabilmente colpevole,
questo secondo dramma, al contrario, sottolinea
l’irrimediabilità della nostra innocenza. E da qui lo
sciogliersi del bisogno di perdono.
Quello che ho fatto non mi appartiene (già) più. La colpa
inchioda l’agente ad un passato che ‘resta’ solo se io
voglio che sia. Viceversa ogni istante è nuovo inizio.
“Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un
giuoco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, un
sacro dire di sì”27.Se è vero che – per dirla ancora con
Nietzsche –lo spirito deve diventare bambino, il primo
risultato di questo divenire è la liberazione dai sensi di
colpa, dai pesi dei rimorsi. Il che non significa (sarebbe
scorretto nei confronti di Nietzsche) che ogni azione si
equivale, e che non esistano discrimini e possibilità di
scelta; né tanto meno che ogni istinto liberamente sfogato
è sempre meglio della falsa coscienza del risentimento.
Significa, invece, che nessuno può essere inchiodato alle
proprie azioni, né tanto meno al proprio passato, perché
nessuno è inchiodato a se stesso.
Un’incrinatura, però, sembra insinuarsi nella figura del
perdono impossibile. Un’incrinatura che scopriamo solo
dopo aver attraversato i suoi due drammi e averli messi in
27
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., p. 25.
87
uno di fronte all’altro. Che cosa li accomuna nella loro
‘impossibilità’? L’irrimediabilmente. L’idea che nulla è
ri/mediabile. Che io non posso realmente mediarmi
‘altrimenti’, in maniera diversa. In una parola: nello
scenario della colpevolezza assoluta come in quello
dell’innocenza assoluta manca l’ipotesi del cambiamento.
Nel primo caso perché il peso del passato mi schiaccia;
nel secondo caso perché la leggerezza dell’attimo, nel
suo inevitabile continuo mutare mi schiaccia (e non a
caso l’eterno ritorno attimale del tempo è il peso più
grande anche per Nietzsche).
E allora è all’antropologia che si deve tornare, per
ripensare “altrimenti” anche un possibile posto
dell’esperienza del perdono.
Rivelativa la ‘spia’ che Ricoeur pone in una nota, dopo
aver citato Derrida e la sua idea per cui se il colpevole è
“già un altro [_] non si perdona più al colpevole in quanto
tale”. Ricoeur commenta e ribalta la questione. Il
colpevole non è già un altro; è “lo stesso, ma
potenzialmente altro”28. Come a dire: io sono
‘potenzialmente’ altro proprio perché sono me ‘stesso’,
me stessa. Se si perde la ‘stessità’, si perde il divenire. Io
non sono sempre, totalmente, necessariamente, in ogni
istante altro a me stesso. Sono Sé come un altro29. C’è
un’ipseità che si mantiene, che si può mantenere
‘nonostante’ il passare del tempo. E questa ipseità sono
io e la mia storia di vita. Quello che vivo, esperisco,
scelgo, lo riconosco come ‘mio’ perché c’è questa stessità
in cui ciò che vivo si incatena. Il perdono (così come la
28
29
P. Ricoeur, La memoria, la storia_, cit., p. 697.
Id., Sé come un altro, tr. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano, 1993.
88
promessa) sono alcune ‘possibilità’ estreme ‘tra’ le
esperienze. Ma se si portasse la logica decostruttiva fino
alle sue ultime conseguenze (se io non fossi anche ‘uno’,
ma solo ‘nessuno’ e ‘centomila’), allora ‘per me’ non solo
il perdono sarebbe impossibile, ma tutto sarebbe
impossibile.
Anche la gioia sarebbe impossibile, perché non esiste ‘la’
gioia, esisto io che gioisco, e io che ricordo che ieri ho
gioito e che aspetto domani di gioire ancora, sebbene
sappia perfettamente che questa gioia non è ‘uguale’ a
quella di ieri e non sarà ‘uguale’ a quella di oggi. E anche
la saggezza sarebbe impossibile, perché non esiste ‘la’
saggezza o ‘la’ verità, ma il ‘mio’ desiderio di cercare di
capire, e, sbagliando, cercare di nuovo, correggere,
correggermi, scoprire (e se io non esisto, chi cerca, chi
desidera?). Alloraanche ‘la’ follia sarebbe impossibile,
perché non esiste ‘il folleggiare’, ma esisto io con le mie
piccole e grandi follie, insensate o forse anche più
sensate di tutte le mie ragionevolezze messe insieme:
quelle follie tutte e solo ‘mie’. E l’amore? Anche l’amore
sarebbe impossibile, perché – senza identità, continuità,
fedeltà e novità, passione e creazione, errore e
scommessa, senza dono e rischio, senza tutto questo che
‘io’ (e ogni ‘io’) sente e soffre per un ‘tu’ – l’amore non
esisterebbe. E però_ - scrive Ricoeur - “c’è (il y a) il
perdono, come c’è la gioia, come c’è la saggezza, la
follia, l’amore. L’amore precisamente. Il perdono
appartiene alla stessa famiglia”30.
30
Id., La memoria, la storia6, cit., p. 662.
89
C’è. Il y a. Possiamo provare a negare tutto questo. Ma
sul palcoscenico di ogni ‘io’ (dai tempi immemorabili in cui
sul grande palcoscenico e-viene la storia), ogni volta che
il dramma si ripete e la domanda dell’impossibile si riapre,
insieme a questo impossibile ‘accade’ un c’è. Ac-cade. Da
un’altezza, come ogni illeità (ci ha insegnato Levinas)31.
“La grande poesia sapienziale, nel medesimo soffio,
celebra l’amore e la gioia. C’è il perdono, dice la voce”32.
Non sono ‘io’ che decido del perdono; esso si dà. O,
meglio, prima ancora che io possa decidere del perdono,
se sia giusto o no, possibile o impossibile, facile o difficile,
da donare in questa contingenza o rifiutare, se ne valga la
pena o no_, prima ancora di tutto questo, il perdono il y
a, mi precede. Come una riserva che la storia dell’umano
che mi ha preceduto (e mi attraversa) mi ha consegnato e
mi consegna.
“È una voce silenziosa ma non muta. Silenziosa, perché
non è un clamore al pari di quella degli infuriati, non muta,
perché non priva di parola”33. Prima di essere “di
qualcuno”, è un “dono”. Dono che posso rifiutare, certo.
Come ogni dono. Ma che non posso negare che si sia
dato e si dia: come possibilità. E come auspicio. La forma
poetica dell’inno, per questo, resta la più appropriata per
31
Ricoeur segue l’argomentazione di Levinas su questo tema in ivi, pp. 661 sgg. Su
questo cfr. M. Agìs
Villaverde, Le problème de la faute et duperdonchez Paul Ricoeur, in J.Porée, G.
Vincent (a cura di), Répliquerau mal: Symbole et justicedansl’oeuvre de Paul Ricoeur,
Pr. Univ. Rennes, Rennes, 2006, pp. 115 sgg.L’Autore rilegge la filosofia di Ricoeur tra
i due poli della confessionedella colpa e dell’inno al perdono. E citando questo passo
particolare de La memoria, la storia, l’oblio, commenta: “l’illéité (l’esserci, il darsi, l’il y
a) è qui quella di una proclamazione che ha un’origine inassegnabile”; c’è ed è
singolare e indefinibile_ come l’amore.
32
P. Ricoeur, La memoria, la storia_, cit., p. 650.
33
Ivi, pp. 661-662.
90
indicarlo: se anche avessi tutto, ma non avessi questo
dono, non sono nulla34.
È la sfida dell’umano al (proprio) nulla. La sfida della gioia
al dolore, la sfida della saggezza alla malafede, la sfida
della follia alla rigidità, la sfida dell’amore e della
promessa al tempo e all’infedeltà, la sfida del perdono alla
colpa e al peso dell’irredimibile. Una sfida che accade nel
tempo, in ogni attimo, in ogni singolo, e che però “se si
enuncia al presente, ciò dipende dal fatto che il suo
tempo è quello della permanenza, della durata più
inglobante, [_] che ‘non avrà mai fine’ [_], perché ‘essa
rimane’. E rimane in maniera più eccellente delle altre
grandezze, [_] perché è l’Altezza stessa”35.
In questo senso paradossalmente è vero: si può
perdonare solo l’imperdonabile, cioè tutto. Perché
viceversa nulla sarebbe perdonabile “Il perdono si rivolge
all’imperdonabile, oppure non è. Esso è non-condizionale,
senza eccezione e senza restrizioni”. Nasce da “una
sproporzione: la sproporzione tra la profondità della colpa
e l’altezza del perdono”36.
Ecco allora l’alternativa al perdono facile e a quello
impossibile: il perdono come possibilità6 difficile,
sproporzionata, folle, eccezionale: eppure assolutamente
necessaria. Come necessaria per l’umano è ogni
resistenza al nulla.
34
Ivi, p. 662, in cui Ricoeur richiama (secolarizzandolo) L’inno alla carità di Paolo di
Tarso. Su questo cfr.
L. Altieri,Le pardon difficile ou: la poétique de la
volontéréconciliée,in Breitling, Orth(a cura di), Erinnerungsarbeit. Zu Paul
RicoeursPhilosophie, cit., pp. 237-248.
35
P. Ricoeur, La memoria, la storia_, cit., pp. 662-63.
36
Ivi, p. 663. La colpa da Ricoeur non viene, dunque, negata, ma resa ‘possibile’ e
liberata dunque dalla necessità che la rendeva irredimibile. Cfr. su questo Ivi, pp. 652
sgg., in cui Ricoeur segue le argomentazioni di K. Jaspers sul tema della colpa.
91
In cosa consiste il perdono difficile e in come, in che
maniera, si pone (si può porre) come alternativa a quello
facile e quello impossibile?
C’è il perdono difficile
Si dà, se si dà, quando si dà, solo dopo attraversato tutte
le aporie delle false facilità e delle pesanti impossibilità.
Si dà nel tempo, nel tempo della lentezza, dell’attesa37.
Nel tempo discontinuo delle cadute e delle risalite, dei
rifiuti e delle riprese, delle sconfitte e degli abbandoni.
Si dà in maniera riflessiva, in prima persona, mettendo al
centro il sé, mettendo al centro me. ‘Perdono’ prima di
essere un sostantivo, in questa logica è il verbo alla prima
persona. Io perdono. Perché nessuno può perdonare al
posto mio, se non simbolicamente. Il perdono è ‘atto’
verbale, dice Ricoeur38. Non si dice ‘io perdono’, si fa ‘io
perdono’ (dicendolo).
Ma c’è una ragione ancor più profonda che collega il
perdono all’io e al primo strato della costituzione della
persona: la cura di sé, la stima di sé, la relazione con se
stessi39. Il primo vero perdono ‘io’ lo do sempre a ‘me’. La
prima persona non è solo il soggetto del perdono ma
anche l’oggetto. Perdonare è sempre innanzitutto
perdonar-si. Perdonare il passato, le ferite, ciò che non è
più o non sarà mai; che non si è e non si potrà mai
37
P. Ricoeur, nel dibattito seguito alla relazionetenuta al Colloque international
d'Amiens del 1997 sultitolo: La Justice, vertu et institution (relazioneedita in AA. VV., a
cura di J. Barash e M. Delbraccio, La sagesse pratique. Autor de l’œuvre de P.
Ricoeur, CNDP, Paris-Amiens, 1998, p. 21), dice che perdono significa “dare tempo al
tempo – cioè esercitare una grande pazienza”.
38
Id., La memoria, la storia_, cit., pp. 678; 688.
39
Cfr. ancora Id., La persona, cit., pp. 39 sgg.
92
essere; gli sguardi che non sono stati di riconoscimento
ma di violenza, le relazioni e le occasioni che non sono
state di liberazione ma di oppressione, o di perdita.
Perdonare se stessi. Altrimenti è facile: solo perdono
facile, che non innesca nulla e nasconde tutto.
Per comprendere quest’intuizione ricoeuriana è
necessario tornare a collegare il perdono alla memoria, e
al suo contrario, cioè all’oblio.
Questo lo capiamo facilmente se pensiamo ad un torto
subito, ad una violenza ricevuta, ad un tradimento, un
abbandono.
Generalmente le nostre reazioni oscillano tra due estremi
(e tutte le sfumature che sono nel mezzo; spesso anche
contradditoriamente legate tra loro).
Estremi che possiamo stigmatizzare in un classico
dilemma: dimenticare o ricordare?
Apparentemente si tratta di due atteggiamenti opposti; ma
in realtà spesso si tratta di un’unica postura e uno stesso
rischio40.
Ricordare, per certi versi, soprattutto all’inizio, è
inevitabile. Il pensiero è sempre lì.
Come quando si subisce un lutto.
C’è una mancanza; e il pensiero ne è inevitabilmente
attratto.
Difficile dimenticare!Dimenticar-si!
Eppure non tutte le dimenticanze sono errori.
40
O. Abel, L’indépassabledissensus, in O. Abel, E. Castelli-Gattinaraet al.(a cura di), La
justemémoire. Lectures autor de Paul Ricoeur, «Labor etfides», 2006, pp. 20-48, parla
della difficoltà del perdono (e dell’oblio)come della difficoltà di non cedere ad una
duplice tentazione: da un lato “la vertigine dell’entropia, l’abitudine che relativizza tutto
per cui tutto ritorna all’indifferenza” e dall’altro la negentropia, per la quale la
memoriavorrebbe tenere e riprendere tutto (p. 46).
93
Alle volte errore è la troppa memoria.
Troppo attaccamento al dolore del proprio passato41.
Ci aiuta la plastica immagine di Baudelaire:
“Ho più ricordi che se avessi mille anni” _“Un grosso mobile a
cassetti, zeppo di conti, / versi, biglietti d’amore, processi, romanze /
e pesanti ciocche di capelli avvolte in quietanze, / nasconde meno
segreti del mio triste cervello. / È una piramide, un sepolcro immenso
/ con più morti della fossa comune. / Sono un cimitero aborrito / dalla
luna, / dove, come rimorsi, lunghi vermi si trascinano / e infieriscono
42
sui miei morti più cari” .
Un cimitero di rimorsi.
Una piramide che mummifica insuccessi e delusioni.
Un mobile zeppo di ricordi caotici, che pesano e
feriscono.
Senza ordine né senso.
Da cui pare impossibile liberarsi.
41
Sarebbe interessante rileggere in quest’ottica Sé come un altro, che come ha detto a
più riprese lo stesso Ricoeur, trova il suo motto esplicativo nel passo di G. Bernanos
(Diario di un curato di campagna), che dice: “odiarsi è più facile di quanto di creda. La
grazia consiste nel dimenticarsi. Ma se in noi fosse morto ogni orgoglio, la grazia delle
grazie sarebbe amare umilmente se stessi, allo stesso modo di qualunque altro
membro sofferente di Gesù Cristo” (cfr. Sé come un altro, cit., nota n. 43, pp. 100-101).
42
La poesia è citata da Ricoeur in La memoria, la storia_, cit., p. 111.
94
Ci prova, abbiamo detto all’inizio, il perdono facile, che
Ricoeur collega all’oblio passivo43.Ci prova il (falso)
perdono del supereroe-superman che, per smettere di
piangersi addosso, per darsi la forza di andare avanti,
indossa la corazza del ce-la-posso-fare. Ma resta appunto
un oblio/perdono apparente, superficiale, ‘esterno’. Che si
illude di schiacciare con una ‘pietra’ il passato, ma in
realtà sta innescando solo una rimozione. Di facciata.
Non è possibile perdonare realmente dimenticando ciò
che è stato, cioè non pensandolo, non significandolo,
schiacciandolo nell’abisso di ciò che non deve più risalire
alla memoria. Perché l’esperienza (non solo psicanalitica)
insegna che, ciò che si rimuove, più potentemente resta
come ferita nell’intimo. Il sangue che si copre con la
corazza non cicatrizza, incancrenisce. Ciò che in
superficie si crede di poter perdonare dimenticando, più
ferocemente torna a galla, all’improvviso, mascherato
sotto altre forme di dolore, impotenza, incapacità. “La
coazione a ripetere è caratterizzata dalla tendenza a
mettere in atto un ‘sostituto’ del ricordo. [_] ‘Riproduce
43
Il discorso è in realtà più vasto perché Ricoeur distingue innanzitutto un oblio
profondo, che divide in oblio per cancellazione delle tracce (tracce cerebrali e
psichiche) e oblio di riserva, reversibile, che è quello a cui attingiamo per ‘recuperare’ i
nostri ricordi. Sia la memoria che l’oblio si prestano ad usi e abusi (oblio e memoria
impediti o manipolati o comandati), ma anche a ‘felici’ ritrovamenti o ‘felici’
dimenticanze. Poi individua quello che chiama un oblio inesorabile: “che non si limita a
impedire (o amputare) il richiamo dei ricordi, ma si adopera anche nel cancellare la
traccia di ciò che si è imparato, vissuto: erode l’inscrizione stessa del ricordo, se la
prende con [_] le tracce. [_] Effetto malefico del Tempo, potere devastante. [_]
Entropia universale: [_] una marcia verso la rovina di ogni conquista, di ogni
acquisizione” (Id., Ricordare, dimenticare6, cit., pp. 99-100). E questo non dipende da
noi. Non è in nostro potere la lotta contro questo tipo di oblio. Perché si staglia “su uno
sfondo di inesorabile disfatta, come una battaglia di ripiegamento” (ivi, p. 100). Da
questi distingue poi l’oblio passivo (di cui stiamo qui trattando) e quello attivo, di cui
parleremo tra poco.
95
quegli elementi [dimenticati] non sotto forma di ricordi, ma
sotto forma di azioni; li ripete, ovviamente senza
rendersene conto’”44.
Ecco che un ‘errato’ (eccessivo) ricordare e un errato
(illusorio) dimenticare/rimuovere si tengono per mano. In
un caso come nell’altro qual è l’atteggiamento di fondo? È
il pensiero che il male subìto, se è passato, se è ormai
dato, è incancellabile. Inutile cercarvi un senso. Così è. È
stato e sarà.
Sì, la giustizia (se non la vendetta) potrà fare il suo corso:
ma nulla mi restituirà la mia vita di prima (prima
dell’offesa, della ferita, del lutto). E, allora, questo male
insensato, non affrontato, non rielaborato, scende, e ci
schiaccia, rendendoci un po’ per volta incapaci di
rispondere di noi stessi. Non c’è un ‘perché’. C’è solo un
‘che’: il dato di fatto del non-senso. Da qui l’inevitabile
coazione a ripeter(si).
Qui paradossalmente l’avvitamento del colpevole su
stesso è lo stesso avvitamento della vittima su se stessa.
Perché entrambi restano inchiodati al proprio passato
(quello che ha portato il primo a diventare colpevole e il
secondo a diventare vittima). Nessun ‘io ti perdono’ fatto
dall’esterno potrà liberare il colpevole dai propri sensi di
colpa, se ‘io’ non perdono me stesso (colpevole).
Nessuna vendetta o giustizia fatta dall’esterno potrà mai
liberare la vittima dal peso di ciò che è stato e di ciò che
ha perduto, se ‘io’ (vittima) non perdono/accetto quello
che mi è successo.
44
Ivi, p. 73.
96
Qui, però, si gioca, si può giocare l’alternativa del
‘perdono difficile’, che si collega ad un’altra forma di
dimenticanza: quella che Ricoeur chiama ‘oblio attivo’. Il
perdono difficile (che è il ‘vero’ perdono), infatti, fa notare
Ricoeur è esattamente
il contrario dell’oblio passivo, tanto nella sua forma traumatica quanto
in quella astuta dell’oblio di fuga. Sotto questo aspetto esso richiede
un sovrappiù di ‘lavoro di memoria’. (_) È una sorta di oblio attivo,
che però non verte sugli avvenimenti in se stessi, la cui traccia al
contrario deve essere accuratamente protetta, bensì sulla colpa, il cui
peso paralizza la memoria e, per estensione, la capacità di proiettarsi
in modo creativo nel futuro. L’oggetto di oblio non è l’avvenimento
45
passato, (_) ma il suo senso e il suo posto .
“Io ti perdono”, qui, non significa: non ricorderò più di ciò
che è stato. Ma, al contrario, proprio perché lo ricordo e
perché non posso dimenticarlo, proprio perché il peso di
questo dolore è troppo grande per non incidere sulla mia
storia e sul senso della mia esistenza, proprio per questo
capisco che devo ‘significarlo’ in qualche maniera. E
decido di significarlo con il perdono.
Ricoeur fa qui l’esempio delle relazioni tra Stati46. Le
memorie dei popoli sono ‘ferite’, perché ogni comunità
nasce da una violenza fondatrice, da una guerra, da
vincitori e vinti. Cicatrici mai cancellate alimentano lo
spirito di vendetta, e lo spirito di vendetta moltiplica le
ferite storiche. I totalitarismi hanno rimosso queste
cicatrici e perciò hanno rimosso anche la memoria: hanno
45
Ivi, p. 100.
Ivi, pp. 84 sgg.; ma cfr. al riguardo anche il saggio ricoeuriano L’identità fragile.
Rispetto dell’altro e identità culturale, op. cit., pp. 38-48.
46
97
creato false memorie e false identità. Ma anche il
contrario della rimozione, il ricordo fine a se stesso non
aiuta la storia. Perché ogni Stato ha i propri ricordi e la
propria identità e – nel nome di questa – è pronto a
scatenare nuovi conflitti e ridestare l’odio sopito.
Ecco, allora, l’oblio attivo e liberatore: il perdono ‘difficile’,
non fatto sugli eventi, ma sulla colpa, il cui peso pietrifica
il presente schiacciandolo sul passato e privandolo della
capacità di progettare il futuro47.
“Io ti perdono”, in questo caso, significa: so che mi hai
ferito, ma guardo avanti e non indietro, perché solo così
possiamo cominciare una storia diversa, che non si limita
a rivangare le cicatrici del passato. E che questo perdono
dia all’io e al tu la possibilità di creare una nuova storia
‘insieme’ (o che ognuno semplicemente continui la sua
nuova vita), questo viene dopo. Prima viene la possibilità
di dare a se stessi un ‘nuovo’48. Crederci. Liberarsi.
Il perdono difficile “non cancella un debito su una tabella
contabile”, ma “scioglie dei nodi” e proprio per questo
consente di rompere con la logica della vendetta49.
“Obliando non i fatti ma il loro senso” per il presente e il
47
Id., La memoria, la storia6, cit., pp. 647 sgg.; e Id., Ricordare, dimenticare,
perdonare, op. cit., pp. 92 sgg. Può essere interessante segnalare, per inciso,
quest’‘unità’ del percorso di Ricoeur, che ritorna – al termine della sua riflessione
filosofica – nuovamente sul tema della colpa (dal quale era partito in Finitudine e
colpa), ma lo affronta e lo ‘risolve’ eticamente, contrapponendogli il suo ‘altro’
dialettico, appunto il tema del perdono. “Dalla colpa al perdono” potrebbe essere un
titolo per una ricostruzione del pensiero di Ricoeur.
48
Questa idea della possibilità di un ‘nuovo inizio ’Ricoeur la riprende anche dalla
Arendt. Sul tema del perdono, in un confronto tra i due autori, cfr. J. Greisch, Paul
Ricoeur. L’itinérancedusens, Millon, Grenoble, 2001, pp.332sgg.
49
P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare6, cit., p. 117. Cfr. anche La traduzione. Una
sfida etica,Morcelliana, Brescia 2001, p. 103: “il perdono dice al colpevole: vali più dei
tuoi atti. [_] V’è più senso di quanto tu non creda in ciò che professi; e il sovrappiù di
senso è detto altrove che in te, da altri da te”.
98
futuro, aiuta ad accettare i “debiti che sono rimasti non
pagati”, aiuta ad accettare il fatto di rimanere “debitori
insolventi”, ad accettare che ci sia una perdita50.
L’oblio liberatore fa sulla colpa il lavoro del lutto e fa
emergere dalla malinconia del ‘sarà-sempre-così’. Se i
fatti sono incancellabili, il loro senso non è fissato una
volta per tutte, ma dipende dal senso che la volontà vorrà
e saprà dargli51.
“Il passato può venir appesantito o alleggerito a seconda
che l’accusa imprigioni il colpevole nel sentimento
doloroso dell’irreversibile, o che il perdono apra la
prospettiva della liberazione”52.
Alla stessa maniera, specularmente, potremmo dire: il
passato può venir appesantito o alleggerito a secondache
io-vittima
mi
chiuda
nel
sentimento
doloroso
dell’irreversibile, o che il perdono di ciò che è stato apra
innanzitutto a me la prospettiva della liberazione.
Se mai potrò arrivare un giorno a pensare di voler (più
che dover) perdonare chi mi ha offeso o ferito, questo
sarà non tanto (non solo e soprattutto non primariamente)
per la ‘sua’ liberazione, ma per la mia. Il che ovviamente
mai dovrà escludere (ma sempre implicare) il percorso
della giustizia. Giustizia esterna nel caso si tratti di offese
perseguibili penalmente; ma in ogni caso e prima di tutto
giustizia nei ‘miei’ confronti. Mai si può perdonare l’atto,
infatti; ma (se mai) sempre e solo l’attore. Mai si può
perdonare il male; ma (se mai) chi l’ha commesso. Anche
50
P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare6, cit., p. 118.
Su questo tema cfr. A. Breitling, S. Orth(a cura di), Erinnerungsarbeit.Zu Paul
RicoeursPhilosophie von Gedächtnis, Geschichte und Vergessen,BerlinVerlag Arno
Spitz, Berlin, 2004.
52
P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare6, cit., p. 141.
51
99
l’eventuale gesto (nobile) del perdono, non ha il potere né
il dovere di alleggerir il male; al contrario ha il dovere di
dichiarare e ricordare sempre l’ingiustizia (subìta); di dire
(a se stessi innanzitutto) ‘questo è (stato) male’ e non è
accettabile che si ripeta. Il perdono non fa sconti. A
nessuno. Libera, se mai: più di quanto la mera giustizia
riesca mai da sola a fare. Il perdono chiede un di più; non
un di meno. Solo se si è attraversata la
richiesta/accettazione di giustizia si può iniziare a provare
ad attraversare anche l’odissea del perdono.
Ma il problema resta. Se sono chiuso, chiusa nel cerchio
malinconico e ferito della mia memoria/identità?
Schiacciato dal mio passato (di carnefice o di vittima che
sia)? Come passare dall’oblio passivo a quello attivo, dal
perdono facile a quello difficile, dalla prigionia alla
liberazione?
La risposta di Ricoeur, cresciuto nell’ermeneutica del
racconto, prima ancora che in quella del riconoscimento
è: “lasciarsi raccontare altrimenti; lasciarsi raccontare
dagli altri”53. Accettare la sfida di non ‘dirsi’ da soli il
proprio passato e la propria identità, perché, finché sarà
così, la frustrazione non potrà che rimanere nel proprio
specchio di dolore. Accettare la sfida di ascoltarsi
raccontare dagli altri, che - dall’esterno - possono vedere
diversamente da noi la nostra identità e leggere
diversamente da noi il nostro passato.
Forse per qualcuno non sono solo la vittima. Forse per
qualcuno non sono solo il carnefice. Forse qualcuno è
capace veramente di pensare che io “valgo più dei miei
53
Ivi, pp. 43 sgg; ma cfr. anche La traduzione, cit., pp. 82 sgg.; La memoria, la storia,
cit., pp. 636 sgg.
100
atti”: di quelli colpevolmente agìti e di quelli tragicamente
subìti.
Imparare a raccontarsi altrimenti, ascoltando il racconto
degli altri e considerando il racconto degli altri
fondamentale, almeno quanto quello che noi facciamo di
noi stessi.
Nessuno popolo è da solo il centro della storia. Nessun
individuo è da solo il centro della propria storia. Lo
scambio dei racconti è la via che può consentire il
recupero di una diversa memoria, di una diversa identità e
quindi di un diverso futuro.
C’è da chiedersi, però: quando ci troviamo davanti ad
un’auto-chiusura? È realmente possibile perdonare se
stessi, il proprio passato, le proprie incapacità?
Da soli no, non possiamo perdonarci. “Il perdono non può
rimanere chiuso entro un rapporto narcisistico tra sé e sé,
poiché presuppone la mediazione di un’altra coscienza,
quella della vittima”54.
Ma se la vittima e il carnefice sono la stessa persona? Se
sono io (incapace di perdonare, perdonarmi, andare
avanti) che ho ferito e sto ferendo me stesso? Se sono io
che devo perdonare me stesso?
Anche in questo caso, anzi a maggior ragione in questo
caso – ci sembra di poter dire – è necessario un ‘terzo’
che faccia da mediatore tra i due, tra l’io offeso e l’io
offensore. Anche qui ci sono ‘due’ che si scontrano: il
passato da perdonare, il presente che non vuole
perdonare. Anche qui c’è una vittima (l’io presente, ferito
per colpa delle scelte dell’io del passato) e un carnefice
54
P. Ricoeur, Ricordare, dimenticare6, cit., p. 100; cfr. anche Id., La memoria, la
storia, cit., pp. 678 sgg.
101
(l’io del passato che ha ‘generato’, nella sua chiusura e
nel suo blocco le chiusure dell’io del presente). L’io del
presente può liberarsi solo con l’oblio attivo che dice al se
stesso che è stato: io ti perdono. L’io del presente può
cominciare una nuova storia solo se dice alla storia che è
stata: non eri l’unica possibilità, non sei l’unica possibilità.
L’io del presente può uscire dalla coazione a ripetere solo
se torna a recuperare le possibilità che nel passato non si
sono realizzate, ma che sono ancora lì, pronte per essere
riprese e risignificate.
Nella storia dei popoli, questo è l’affascinante compito che
tocca – in maniera diversa – allo storico e agli “educatori
pubblici”55. Nella storia delle singole persone questo è
l’affascinante compito che tocca all’amore.
L’amico, l’amante, colui il quale riconosce e ama, svolge
nell’incontro con l’altro il ruolo che dovrebbe avere,
nell’intuizione freudiana ripresa da Ricoeur, il terapeuta
nei confronti del paziente: sanare le ferite del passato,
risvegliare il senso del presente, riaprire la progettualità
del futuro56.
Al di là delle indicazioni cliniche, Freud formula due proposte
terapeutiche che sono per noi della più grande importanza [_], la
55
“Gli uomini del passato, immaginati nel loro presente vissuto, hanno progettato un
certo avvenire, ma la loro azione ha avuto conseguenze non volute, che hanno fatto
fallire i loro progetti e deluso le loro speranze più care: [_] un cimitero di promesse
non mantenute. Non è più compito dello storico di professione, ma lo è di coloro che
possiamo chiamare educatori pubblici – di cui dovrebbero far parte anche i politici –
quello di risvegliare e rianimare queste promesse non mantenute”: Id., Ricordare,
dimenticare6, cit., p. 43.
56
Id., Il perdono può guarire?, tr. it. di I. Bertoletti, in “Hermeneutica”, 1998, pp. 157163. Ricoeur, parlando del perdono come atto contrario all’oblio di fuga, conclude_
che “perciò può guarire”, ma, per guarire, serve mediazione dell’altro. In questo senso,
“non è un lavoro ma un dono”.
102
prima delle quali riguarda l’analista, la seconda l’analizzando. Al
primo è consigliata grande pazienza verso le ripetizioni che
sopravvengono sotto la copertura del transfert. [_] Al paziente è
chiesto di cessare di lamentarsi o di nascondersi il proprio vero stato:
‘egli – scrive Freud - deve trovare ora il coraggio di rivolgere la sua
attenzione alle manifestazioni della sua malattia. La malattia stessa
deve cessare di essere per lui qualcosa di esecrabile e diventare
piuttosto un degno avversario, una parte del suo essere che si fonda
sopra buoni motivi, e da cui dovranno essere tratti elementi preziosi
per la sua vita ulteriore. Altrimenti non c’è nessuna riconciliazione del
57
malato con il rimosso’ .
Il secondo è il compito che abbiamo come identità ferite,
come pazienti, come vittime di noi stessi e di ciò che non
amiamo di noi e del nostro passato: il compito del
coraggio della verità, del riconoscimento dei nostri limiti. Il
primo è il compito che abbiamo come poeti dell’alterità: il
compito dell’attenzione alle ferite dell’altro, della cura,
dell’accoglienza e soprattutto della pazienza, dell’attesa,
della non invadenza58.
Il lavoro dell’incontro con l’altro si gioca tra questi due
compiti “la pazienza verso la ripetizione e [_] il coraggio
nel riconoscersi, [_] alla ricerca di un rapporto veridico
con il proprio passato”59.
57
Id., Ricordare, dimenticare6, cit., p. 74.
Già in Filosofia della volontà I, Il volontario e l’involontario, Ricoeur scriveva: “Vi sono
certi incontri che non soltanto mi apportano ragioni di vivere che posso valutare,
approvare, ma che veramente operano nel cuore del volere come una conversione,
che la portata di una vera nascita spirituale. Questi incontri sono creatori di libertà; essi
sono liberatori. Tali possono essere l’amicizia o l’amore di coppia. [_] L’azione in
qualche modo ‘seminale’ che questi esercitano nel cuore stesso nel volere appartiene
già all’ordine della ‘poetica’ della volontà” (Filosofia della volontà I, Il volontario e
l’involontario, tr. it. di M. Bonato, Marietti, Genova 1990, p. 129).
59
Id., Ricordare, dimenticare6, cit., pp. 74-75.
58
103
In questo senso, nessuno può perdonarsi da solo, perché
nessuno può guarirsi da solo, perché nessuno può essere
veramente se stesso.
Se al termine del lunga odissea del perdono difficile sono
in grado di perdonare un altro è perché prima sono stato
(stata) in grado di perdonare me stesso (me stessa). Ma
se nella svolta decisiva del ritorno al sé (verso Itaca) sono
stato in grado di perdonare me stesso, me stessa è
perché mi sono lasciato, lasciata curare da uno sguardo
paziente d’amore.
Se, al contrario, chiuso nel cerchio dell’(auto)accusa non
arrivo a perdonare la mia caduta nella colpevolezza (o
nella malinconia), e non consento agli altri di curarmi e
aiutarmi a perdonare questa caduta, questa ferita, sempre
più inevitabilmente il cerchio dei sensi di colpa o del
bisogno di vendetta si chiuderà intorno a me, fino al punto
in cui arriverò a credere che il perdono è impossibile.
L’esperienza insegna che colpevoli o incapaci di perdono
non si nasce. Si diventa. E che, quindi, liberi si può
sempre tornare ad essere. Nel coraggio dell’affidamento
ad uno sguardo che dice: tu. Tu come sei nella tua
originaria vocazione alla ri/creazione; tu come puoi
tornare a diventare; non tu come credi di essere e di
dover necessariamente rimanere.
L’incontro con qualcuno capace di risvegliare in noi la
nostra bellezza primordiale è nuova creazione che dice:
‘sia’60. Se questo qualcuno è poi un tu che mi ha
perdonato (nonostante le mie colpe dei suoi confronti), se
60
Cfr. Id., La memoria, la storia6, cit., p. 186: “I miei più vicini sono coloro che
approvano che io esista e dei quali io approvo l’esistenza nella reciprocità e nella parità
della stima”.
104
la parola creatrice che mi viene rivolta è ‘io ti perdono’ (e
questo è realmente un atto linguistico, un perdono difficile
e non un dire retorico di facciata), allora questa parola è
veramente un ‘raccontare altrimenti’. È un raccontare che
non narra ciò che è stato e che non poteva non essere,
ma ciò che poteva darsi diversamente e che ancora ‘può’
darsi. Il perdono canta il possibile. E per questo, nel
deserto del nichilismo e dei sensi di colpa, schiude nuovi
sentieri, traccia parole nuove.
Ecco, allora, la proposta paradossale di Ricoeur, oltre le
superficialità e le maschere del perdono facile; oltre le
negazioni decostruttive del perdono impossibile: il rischio
di un fragile perdono, difficile ma possibile.
A chi ritiene che il perdono non esista, l’esperienza
risponde semplicemente: Il y a le pardon. Si dà. Accade.
Lo vedi. Possibile. In te. Attorno a te. Magari quando
meno te l’aspetti. Dopo tempo. È stato il tempo. È stato lo
sguardo di un altro nel tempo. E sei stato anche tu61.
Il y a. C’è. C’era già. C’è sempre stato, come possibilità.
Ad aspettarti. Ad aspettare che tu lo accogliessi, lo
riconoscessi e lo rilanciassi.
E la memoria si perde nell’immemoriale. A quella prima
volta che io sono stato perdonato, perdonata. Da
qualcuno. E forse non ricordo nemmeno da chi (forse da
mia madre, da mio padre, da un’amica, un amico_). E
forse non ricordo nemmeno perché.
E la memoria si perde nell’immemorabile. A quella prima
volta che ho sperimentato il perdono e tra le labbra quella
61
Cfr. Id., Responsabilité et fragilité (in «AutresTemps», 1992,36, pp. 7-21, la cui
conclusione è: “c’è un tempo per l’imperdonabile e untempo per il perdono. Il perdono
esige ‘lunga’ pazienza”.
105
parola ha acquistato per me un senso. Perduto poi nelle
ferite della mia storia. E reso illogico, assurdo o forse solo
maschera di una falsa coscienza. Ma non così all’origine
dell’esperienza. E forse non così alla fine, se lo voglio
(perché lo posso).
Il y a il perdono: che mi precede, da sempre. Posso
perdonare (e perdono) perché sono (già) stato perdonato.
Almeno una volta. Tanto tempo fa.
Capiamo, allora, perché la logica del per-dono per
Ricoeur è comprensibile solo nella logica (autentica) del
dono.
La generosità del dono suscita non una restituzione che, in senso
proprio, annullerebbe il primo dono, ma qualcosa come la risposta ad
un’offerta. Al limite, occorre considerare il primo dono quale modello
del secondo dono e pensare il secondo dono come una sorta di, se
62
così si può dire, ‘secondo primo dono’ .
Vale per il perdono autentico quello che vale per il dono
autentico (e l’amore autentico).
È un ‘rischio’63. Si assume il rischio di essere rifiutato, di
non essere riconosciuto, di non essere accettato,
apprezzato. Si consegna alla possibilità della
misconoscenza
e
dell’ingratitudine,
della
non
62
Id., Percorsi del riconoscimento, tr. it. di F. Polidori,Cortina, Milano, 2005, p. 270.
“Questi comportamenti riconducono il primo dono al centro del quadro, e questo
perché il primo dono diventa il modello del secondo dono” (ivi, p. 259).
63
Cfr. Ivi, p. 271 in generale sul tema del rischio del dono. Invece più in particolare sul
rischio del perdono, cfr. Id., Ricordare, dimenticare_, cit., p. 111: “L’autore dei torti può
soltanto chiedere il perdono; ancora, deve affrontare il rischio del rifiuto. In questa
misura il perdono deve anzitutto essersi scontrato con l’imperdonabile. Questa
possibilità ci deve perciò mettere in guardia contro la facilità del perdono: se esso deve
contribuire alla guarigione della memoria ferita, è necessario che sia passato
attraverso la critica dell’oblio facile”
106
reciprocità64. Il colpevole che chiede perdono può non
essere perdonato dalla vittima. La vittima che accetta di
iniziare un difficile percorso di perdono di sé (e dell’altro)
può non riuscire ad arrivare al termine del percorso.
Ma proprio per questo, l’odissea del perdono difficile
(come quella del dono e dell’amore difficile) è anche e
sempre un’attesa. Un’attesa che resta sempre aperta alla
possibilità “di una sorpresa”.
La sorpresa di un “ti perdono” che risponda alla mia
richiesta di perdono; la sorpresa di un sentirsi perdonati
che risponda alla mia attesa di riconciliazione con me
stessa, con me stesso.
Per questo, ogni perdono autentico ha un carattere
“festivo”. Di sospensione della ferialità. Di eccezionalità.
“Il festivo che può abitare i rituali dell’arte di amare, nelle
sue forme erotiche, amicali e societarie, [_] così come i
gesti di perdono”65: è poesia, non prosa quotidiana, dice
Ricoeur66.
Per questo, ogni autentico perdono donato e ricevuto si
iscrive nel registro della gratuità. Gratuità che evoca
64
Così come per l’amore, anche per il perdono l’ideale di Ricoeur è quello di un mutuo
riconoscimento. Cfr. ivi, p. 117, dove si parla di ‘mutuo perdono’, riconciliazione come
‘riconoscersi reciproco’.
65
Id., Percorsi del riconoscimento, cit., p. 273: “c’è qualcosa di festivo nelle pratiche di
dono così comein quelle della solennità del gesto di perdono o della domanda di
perdono,[_] come il gesto del cancelliere Brandt che a Varsavia si inginocchiaai piedi
del monumento alla memoria delle vittime della Shoah. Gesti come questi non possono
costituire un’istituzione, ma, portando in lucei limiti della giustizia dell’equivalenza e
aprendo uno spazio di speranzanell’orizzonte della politica e del diritto sul piano
postnazionale e internazionale,questi gesti producono un’onda di irradiazione che, in
manierasegreta e obliqua, contribuisce all’avanzare della storia verso gli stati di pace”.
66
Sul tema della poesia e delle arti in Ricoeur, rimandiamo al numero monografico (a
cura di A. Caputo) della rivista on-line “Logoi.ph”, I, 2, 2015: Paul Ricoeur e la sinfonia
delle arti.
107
gratitudine. E gratitudine che chiama nuova gratuità.
Reconnaissance (riconoscenza – riconoscimento)67.
Il riconoscimento desta riconoscenza. Il sentirsi perdonati
e riconciliati innanzitutto con se stessi genera perdono e
riconciliazione. E solo perché, come dicevamo prima, il y
a il perdono, solo perché abbiamo (già) fatto
un’esperienza di perdono, solo perché qualcuno ‘prima’ ci
ha perdonati_, solo ‘dopo’ anche noi diventiamo capaci –
a nostra volta – di perdono.
C’è, allora, un colpo di scena! Un risvolto paradossale
della logica del perdono (del tutto simmetrico al
paradosso della logica dell’amore): che non va dal
perdono che do a quello che ricevo, ma da quello che ho
ricevuto a quello che posso dare. Non dalla gratuità alla
gratitudine, ma dalla gratitudine alla gratuità.
Perché si tratta di un’osservazione importante, di un colpo
di scena? Perché, se viene prima la gratitudine – se prima
devo poter dire ‘grazie’ a te (_che mi hai perdonato), e
solo dopo posso a mia volta donare e perdonare – allora
questo significa che io non posso mai essere la ‘prima’, il
primo a perdonare.
Significa che io sono sempre
‘secondo’, ‘seconda’. C’è sempre un perdono che mi
precede, che mi ha riempito e preceduto.
Il y a il perdono. Nessuno è un primo perdonante
assoluto. Ogni desiderio di perdono è sempre risposta,
sempre un “secondo primo perdono” – possiamo dire
67
Cfr. a riguardo A. Martinengo, Ermeneutica del soggetto ed esperienza del perdono
nel pensiero diRicoeur, in M. Piras (a cura di), Saggezza e riconoscimento, cit., pp.
189-208; e D. Iannotta, Verità, perdono, riconciliazione: PaulRicoeur, in «Esodo»,
2005, 4.
108
parafrasando l’espressione di Ricoeur “secondo primo
dono”.
Nasce, allora, inevitabilmente una domanda, che in
termini tecnici si direbbe ‘metafisica’. Qual è l’Origine del
perdono? Come è possibile che nasca (o che si sia nato,
originariamente) il perdonare, se è vero che siamo
sempre secondi? Qui si apre l’enigma del perdono (che
coincide con l’enigma dell’origine del dono e quindi
dell’amore). E su questa soglia si biforcano nuovamente
la filosofia e la religione.
Se per la coscienza credente il Primo perdonante
coincide con il Primo donatore (e Creatore e Padre), per
la fenomenologia antropologica l’il y a resta, come
enigma, in sospeso.
Forse il filosofo in quanto filosofo– scrive Ricoeur –, deve
confessare che egli non sa e non può dire se questo Altro, è un
altro che io possa guadare in faccia , o i miei antenati, [_] o Dio –
Dio vivente, Dio assente – o un posto vuoto. Su questa aporia
68
dell’Altro si arresta il discorso filosofico .
All’origine c’è un Perdonate primo che possiamo
chiamare ‘Dio’? È il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, il
Dio di Gesù Cristo? La filosofia si ferma su questa
domanda-soglia. Una certezza solamente ci consegna, ed
è quella dell’il y a che abbiamo ripercorso in queste
pagine: bisogna sentirsi perdonati, per poter imparare a
perdonare. Siamo secondi. Il perdono ci precede. Oltre
questo dato, si apre l’enigma dell’Origine, enigma che è
quello stesso della vita, della nascita e della morte.
68
È il noto finale di P. Ricoeur, Sé come un altro, Jaca Book, Milano, 1993, p. 473.
109
Certo, se c’è (il y a) il perdono, ‘esso rimane’, come vien detto
dell’amore nell’Inno che ne celebra la grandezza; se esso è l’altezza
stessa, allora non permette né prima né poi, mentre la risposta del
pentimento arriva nel tempo, che essa sia improvvisa, come in certe
conversioni spettacolari, o progressiva, alla prova di un’intera vita. Il
paradosso è, precisamente, quello del rapporto circolare fra ciò che
69
‘rimane’ per sempre e ciò che accade di volta in volta .
110
69
Id., La memoria, la storia_, cit., p. 698.
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA
Juan Carlos García Jarama
Me piden una pequeña contribución acerca del Perdón y
he aquí que la presento con gusto pues, además de
cumplir con tal solicitud, respondo también a un deseo
interno del corazón. Sí, en efecto, “todos tenemos
necesidad de contemplar el misterio de la misericordia”,
como señala el Papa en la Bula de convocación de este
gran Jubileo, que está para concluir. La sencilla reflexión
que ofrezco presenta el itinerario por el que la meditación
humana ha ido discurriendo, hasta alcanzar el sentido
definitivo de este atributo esencial en el que se revela, de
manera sublime, el rostro mismo de Dios.
El esfuerzo fatigoso del entendimiento filosófico con sus
limitados, pero meritorios logros, se ha encontrado con la
rica aportación de una divina revelación, gratuitamente
concedida; merced a ésta, aquél encuentra un resultado
humanamente insospechado. En efecto, la misericordia y
la compasión no siempre han sido comprendidas como
cualidades nobles y dignas del humano adulto, menos
como atributos propios de un ser trascendente y divino.
Basta recordar algunas culturas de la antigüedad e
incluso de la modernidad, para las cuales semejante
modo de comportarse es equivalente a debilidad y
flaqueza, siendo su paradigma la virilidad y la fortaleza.
111
De la omnipotencia a la misericordia
- “Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de
saber”, dice Aristóteles al inicio de su Metafísica. Su
entendimiento no queda detenido ante la seducción que
le provocan las cosas sensibles en su manifestación;
antes bien, en ellas encuentra siempre un reclamo para ir
más adentro, al margen de su utilidad inmediata, y
alcanzar su sentido más profundo. También al “filósofo”
que todos llevamos dentro le importa saber lo que las
cosas son, le inquieta saber qué es en realidad el mundo
que le cobija y, por encima de todo, le preocupa saber
quién es el y quiénes son aquellos con los que convive.
No obstante, dentro de su inutilidad, una cierta dimensión
práctica de este conocimiento le orienta también a saber
a qué atenerse, a cómo comportarse, a preguntarse si
vale la pena hacer esto o dejarlo pasar. Todo hombre,
antes o después, a medida que va madurando, busca
saber si tiene o no sentido cuanto hace, cuanto sufre o
cuanto goza, cuanto ha vivido y cuanto proyecta vivir. En
el fondo de la cuestión se esconde lo más propio y
especifico del ser humano, pues el hombre es el único
animal capaz de cuestionar su propia realidad y la de
todo aquello que le circunda; el único que recoge en la
memoria o que anticipa, en la esperanza, lo porvenir. Es
el único que busca, sin descanso, la felicidad.
Es en virtud de esta inclinación natural, precisamente,
como el ser humano pasa del interrogante sobre el
mundo a la pregunta acerca de sí mismo, y de ésta a la
cuestión de la trascendencia después. Gracias a sus
facultades naturales, el hombre es capaz de atisbar la
112
realidad de Dios, como un ser superior y omnipotente, al
que atribuir el origen de cuanto existe y en el que pensar,
también, como meta del devenir de la historia. La
dimensión espiritual de la persona posibilita que, cuando
ésta se sumerge en su propia intimidad, reconozca –o
pueda reconocer, al menos- la huella de Otro mayor,
anterior y necesario, que justifica y fundamenta la
existencia contingente de que ella misma goza. El libro
abierto del cosmos, gran muestrario de la intervención del
Creador, así como el laberinto interno de la personalidad,
constituyen vericuetos recorridos por el hombre, a lo largo
de la historia del pensamiento, para descubrir a Dios.
De la mano de la existencia divina, el entendimiento
humano también puede descubrir algunos de sus
atributos metafísicos, algunas de las cualidades,
íntimamente conectadas con aquella forma de ser. No
podemos tener, no tenemos de hecho, noticia alguna de
la existencia de cualquier cosa sin tener, por lo mismo,
alguna noción acerca de su esencia, por vaga e
imprecisa que ella sea. También sucede así con Dios.
Cuando nuestra inteligencia pasa del conocimiento de las
cosas contingentes a la causa de las mismas, de alguna
manera puede sospechar, en esta última, su razón de
ultimidad, de Causa absolutamente necesaria e
incausada, de perfección absoluta. Si lo que contempla
en el mundo es una cualidad imperfecta, una belleza
siempre incompleta, la bondad envuelta en fragilidad o
una verdad fácilmente amenazada, no le será difícil
postular al menos la existencia de una Perfección en
grado pleno, fuente y origen de aquellos otros modos
limitados. Cuando lo que despierta su curiosidad es, en
113
cambio, la armonía natural y el ordenamiento tan
maravilloso del universo en que vivimos, no tendrá
demasiado inconveniente en proponer al Artífice de
semejante diseño inteligente y no absolutamente
absurdo. Y si lo que sorprende al pensador es la
presencia de una ley moral universal e incuestionada en
su interior, sanción incondicionada y retribución sin
excepción, tal vez pueda sospechar la intervención, en
todo ello, de un Legislador divino.
Así, por distintos caminos de aproximación, es como
numerosos pensadores de la antigüedad, y también en
nuestros días, se han acercado al Absoluto: un Dios
inmutable y eterno, infinito y poderoso, necesario y
trascendente, ser por sí, absolutamente independiente,
origen y meta final de cuanto existe. Por muchas que
sean las teorías que intentan dar razón del rasgo
distintivo y específico del ser divino, que aquello que le
resulta más característico, en el fondo se mueven todas
ellas en el orden de un nivel metafísico, trascendente o
sobrenatural. Si se trata de la omnipotencia, esta lo
separa de la debilidad; si la principal cualidad
considerada es la eternidad, esta lo coloca al margen de
nuestra historia; si el distintivo de Dios es su santidad, no
puede Dios tener comercio alguno con la criatura
empecatada; si Él es el ser por sí, no resulta fácil
comprender una amable relación con cuanto encuentra
su radical explicación fuera de sí.
Ante una realidad así, cabe preguntarse si el ser humano
significa algo. Si el eterno es impasible, si el origen es
inmutable, si Dios es trascendente, se abre una brecha
que separa, irremediablemente, el dominio de ambos
114
mundos. El hombre tiene el peligro de quedar aislado,
desorientado y olvidado, debatido en una huérfana
existencia, indiferente para Aquél. No es de extrañar,
entonces, que de este planteamiento se siga, con
frecuencia, una especie de agnosticismo teórico que
distancia al ser divino, hasta el punto de caer en un
silencio práctico ante Dios. Pero puede suceder, por el
contrario, que ávido de protección y abrigo, el hombre
acerque tanto el eterno cielo a la pobre tierra que termine
por concebir un Dios semejante y próximo, mas revestido,
esta vez, de todos los defectos que encontramos en el
propio ser humano. Agnosticismo y antropomorfismo,
esas son las dos opciones de esta angosta encrucijada.
No parece, pues, posible concebir la esencia metafísica
de Dios sin padecer, en su trascendente lejanía, el
desconcierto de una vida solitaria o el consuelo
insatisfactorio de una proyección a la medida de la
deficiencia personal.
1.2.- Ha sido gracias a la auto-revelación del Dios de los
judíos, a lo largo de los siglos, como ha podido un pueblo,
elegido de entre todos, descubrir algunas otras
cualidades que se esconden en el corazón invisible de
Dios. A la razón le ha superado la fe; al esfuerzo humano
le ha coronado la gracia divina; lo que empezó el hombre,
Dios mismo lo ha llevado adelante.
La religión natural, como apertura y búsqueda infatigable
de un sentido definitivo para el hombre, ha pasado a ser
la relación personal y amorosa con Aquél que, además
de ser origen, guía y meta del universo, manifiesta
caracteres personales, esto es, se revela como Padre
que conoce y que ama, que llama y que salva. De este
115
modo, irrumpe una concepción religiosa absolutamente
original: la lejanía de Dios se convierte en presencia
cercana, su trascendencia en curación inmanente, la
eternidad divina entra en la historia y se hace éxodo
temporal, su inmutabilidad asume el arrepentimiento y el
cambio que hace pasar del enojo de los celos a la ternura
paciente, de la pasión encendida al cuidado providente.
La relación con este Dios, al que se pide y del que se
espera, ya no es un mero o ilusorio sentimiento que
vincula criatura y creador, el mundo de lo profano con el
ámbito de lo sagrado impersonal y, generalmente,
prohibido. La dependencia ahora incorpora la adhesión
en libertad, la conciencia y el amor. Una nueva e
inesperada visión religiosa se establece y, con ello, una
nueva manera de entender la acción de Dios y la
respuesta humana. Si Dios habla, el hombre debe
escuchar, y si Dios actúa, el hombre ha de obedecer.
Dios no es un insensible maquinista que ha dado cuerda
al mundo y, en él, al hombre que lo habita. Revestido de
entrañas propias de una madre puede, incluso cuando
ésta se olvidara del fruto de su vientre, colmar en el
corazón del hijo toda clase de impensable abandono. La
misericordia divina, a favor de los hombres, no conoce
obstáculo alguno ni limitación a su fidelidad. La debilidad
y la pobreza de su criatura, lejos de impedir su
intervención benéfica, la provocan y aceleran.
De La Misericordia Al Perdón
- Como venimos diciendo, en la revelación bíblica nos
encontramos no sólo con un Dios que manifiesta su
116
poder en todo lo que hace, de manera justa y soberana,
sino que además hayamos la acción de un Dios que se
vuelve e interviene a favor de su pueblo, anticipo de la
humanidad entera. Ser personal, el Eterno busca y llama,
conoce y rescata. No es una realidad lejana a quien la
vida del hombre resultara indiferente, antes bien, el
comportamiento del hombre le grada u ofende, le
complace o enoja. La experiencia progresiva de Israel va
descubriendo las entrañas de un ser divino que, además
de inefable y celeste, se revela también compasivo y
misericordioso. El que ha creado, el que ha elegido, no
permanece impasible ante la respuesta humana, ante su
pobreza y necesidad, más aun, ante su pecado e
infidelidad.
El mensaje bíblico de la misericordia no es una cuestión
meramente espiritual, sino que conlleva unas necesarias
implicaciones concretas de tipo moral y social. El Dios
misericordioso que salva no es un Dios de muertos, ni
goza destruyendo la vida, sino que es un Dios de vivos,
que ama y restablece la vida por él creada. Por eso,
quien recibe y goza de su misericordia no puede sino
devenir portador y testigo del mismo compromiso a favor
de la vida (de todas las vidas).
La misericordia significa que el propio corazón de quien la
experimenta se vuelve hacia la pobreza de los
miserables. En la Biblia no hay pobreza ni miseria mayor
que la del corazón, es decir, la del sufrimiento moral y,
sobre todo, la del pecado. La misericordia divina, por la
que Dios se inclina para atender las heridas de la
existencia humana, lejos de consistir en una muestra de
fragilidad lo es de soberana fortaleza. En efecto, Dios
117
muestra su poder cuando perdona, cuando vacía su
intimidad para arropar al miserable, al pecador.
Aparentemente resulta difícil conciliar la misericordia con
la justicia divina y, sin embargo, no hay más justicia, no
hay más santidad, que aquella que disfruta
compartiéndose en favor de los más desvalidos. Si la
misericordia “se ríe del juicio” no es porque lo contradiga,
sino porque lo trasciende.
En su especial predilección por los más pobres, por los
más débiles, la justicia inflexible de Dios se transforma en
experiencia de ternura y compasión. En realidad no se
contradicen, pues la misericordia es el verdadero nombre
de la justicia divina. Una justicia que crea y que salva,
una justicia que acompaña fielmente y que se comunica
gratuitamente. Dios justo lo es porque no se contradice,
porque obra conforme a su propio ser, porque actúa y
habla como es. La justicia de Dios hace que su
comportamiento sea conforme a su ser; pero su ser es
amor, bondad y ternura: santidad. Por eso, la justicia de
Dios es obrar santamente, más aun, obrar santificando
cuanto juzga, cuanto hace justo (justi-fica) y bueno, como
es Él. ¿Vamos a tener nosotros envidia de Dios, porque
él sea bueno?
Dios, tres veces santo, santifica en virtud de la alianza
que establece con los hombres y a la que estos pueden
responder creyendo. Pero entonces la fe no es una
cuestión puramente teórica, no es simplemente
considerar que debe existir Dios, o que lo que ha
revelado debe ser verdad. La fe, en el contexto de la
alianza misericordiosa, es algo más: una respuesta total,
118
una adhesión en libertad que provoca la donación del
hombre al mensaje divino y a su portador.
Si los profetas pregonan la misericordia de Dios, son los
Salmos, experiencia poética de oración, donde se
encierran las expresiones más bellas al respecto. En ella
encuentra consuelo y esperanza el pecador; ella es una
tabla de salvación para el pueblo también cuando debe
asumir las consecuencias de su infidelidad. Lejos queda
el dios impersonal del budismo o incluso la no violencia
del hinduismo, las reglas del comportamiento ético o
incluso el Dios del islam. El Dios de Israel ha mirado y ha
visto la aflicción de su pueblo, y ha reaccionado. Pero no
es otro, diverso de aquel Omnipotente para los filósofos
antiguos. En un sentido hondo y real no podemos
mantener la disyuntiva pascaliana; en todo caso, será
obligatorio repensar el modo profundo de conciliar la
imagen filosófica de Dios y su comprensión bíblica. El
único Dios soberano, conmoviéndose, actúa, libera y
salva. La misericordia y el perdón adquieren, a la luz de
la revelación, una nueva dimensión: el auténtico nombre
de Dios es Amor. Así, la potencia absoluta de Dios se
muestra, precisamente, en que puede vencerse a sí
mismo, puede hacerse donación a favor de los más
desprotegidos e incluso de los pecadores.
Bajo los efectos del marxismo y de otras ideologías
semejantes se oyen, todavía hoy, voces a favor de la
justicia social y en contra de la caridad, como si aquella
fuera contraria a la misericordia cristiana. Según aquellas,
no se trata de amar ni perdonar, de hacer limosna ni dar
por caridad, cuando en realidad lo que se debe hacer es
implantar la justicia social. No están lejos, quienes así
119
piensan, de aquella ética kantiana que se funda en la
obligación de un deber, puramente racional, al margen de
cualquier otro tipo de sentimientos morales. Pero si hay
algo debido a todo hombre, en su humana
menesterosidad, eso es precisamente el respeto, el
afecto e, incluso, el perdón.
En este sentido conviene recordar lo que apuntaba
Benedicto XVI en su encíclica Deus caritas est: que no
hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo
el servicio del amor. Desentenderse del amor significa, en
el fondo, desentenderse del mismo hombre, pues de
entre todas sus necesidades, no es la menor la del amor.
Si es verdad, también antropológica, que "no sólo de pan
vive el hombre", esto implica que junto a sus necesidades
materiales hemos de atender a las no menos importantes
necesidades anímicas, culturales y, sobre todo,
espirituales.
La misericordia de Dios
Se ha encontrado, a lo largo de los siglos, con la
ingratitud humana como respuesta. El pueblo elegido,
objeto de las confidencias eternas de Dios y de su plan
de salvación, ha olvidado una y mil veces las acciones de
su Señor. El reproche de los profetas, primero, y su
invitación, después, se dirigen a recordar las maravillas
de su Salvador. El pueblo olvida, pero Dios se acuerda.
Por eso la salvación consiste en hacer memoria, en
actualizar la obra de Dios, viva en el corazón. Re-cordar
(lo mismo que su contrario olvidar) ya no es una cuestión
puramente intelectual o de la mente, sino algo que tiene
que ver, más bien, con el corazón, con ese núcleo interior
120
de la persona donde se revuelven y saborean, donde se
disfrutan y experimentan los beneficios de Dios.
Así pues, podemos decir que también el olvido afecta no
a la facultad cognitiva sino a lo profundo del corazón.
Olvidar es no tener en cuenta, es caer en la ingratitud y
comportarse de espaldas al don recibido, es cometer una
grave infidelidad. De este modo, la gravedad del pecado
pasa de pura trasgresión de un precepto legal o formal a
una ofensa personal. El pecado se reviste también de
connotaciones personales. Por eso, en adelante, la
suprema manifestación que puede hacer Dios de su
soberana
omnipotencia,
será
precisamente
la
misericordia para con el hombre pecador. Para el hombre
de todos los tiempos, su poder se muestra en una
exhibición de fuerza sin medida, incluso de venganza, o
de ajuste de cuentas sin piedad. Ante el rechazo humano,
en cambio, la fuerza de Dios se hace misericordia y
perdón.
Porque Dios es ya en sí mismo amor eterno, es decir,
donación recíproca e inmanente en virtud de su autocomunicación, puede salir y expresarse fuera de sí,
misericordiosamente, sin perder ni ganar absolutamente
nada de su realidad más íntima. Ciertamente la santidad
de Dios se manifiesta, de manera excepcional, en el
perdón del pecador. Totalmente otro, Dios es por su
misericordia amigo y confidente, compañero y esposo,
padre y pastor. Al hacerse cargo del pecado humano
Dios se vacía, dándose, movido por su misericordioso
amor. De este modo cumple su poder la cima más
insospechada de fuerza: la de hacerse debilidad para
fortalecer al débil por naturaleza.
121
Poco a poco se irá alejando la idea de un Dios violento y
castigador, y se irá sustituyendo por la de quien no se
complace en la muerte del pecador sino en su propio
arrepentimiento y conversión. Dios no aguarda, para
sorprender a traición, al hombre en su falibilidad y
condenarlo; ante la ausencia de una respuesta fecunda,
el divino viñador sabrá siempre dar una segunda
oportunidad, no tanto porque el hombre se haga digno de
ella, cuanto por Su misma paciencia y santidad.
En la experiencia de la misericordia divina, el hombre
descubre no sólo la fuente de su permanente consuelo,
sino incluso el auténtico límite a la existencia y la fuerza
del mal en el mundo. No sólo las catástrofes naturales,
sino también las violentas reacciones de los pueblos, o
los sufrimientos no buscados de los inocentes, han sido
desde antiguo un gran motivo de escándalo y de
confusión. Cuando el rostro de la misericordia divina se
muestra, ofrece al interrogante humano no poca
consolación. La suerte del Dios de Israel parece, en
adelante, irse aparejando a la de su pueblo. En esta
eterna misericordia tiene su origen tanto la creación como
la salvación del mundo entero.
Aun cuando el lenguaje bíblico encierre expresiones que
nos lleven a pensar en la ira o la venganza de Dios, en el
fondo tendremos que pensar que, tras ellas, lo que
realmente se esconde es el fuego de su pasión por aquel
al que ama, con el deseo de su definitiva salvación; la
urgencia y gravedad de quien se toma en serio la suerte
final, abocada a la muerte o a la vida eternas. El temor
pasa por la conciencia de una posibilidad concreta, de
nuestra parte (la del rechazo), abrazada a la tranquilidad
122
de una nueva oferta, por la suya (la del perdón). “Quién
puede perdonar sino Dios”, le dijeron aquellos
interlocutores a Jesús. En efecto, la ofensa del pecado es
contra Dios y sólo él la puede perdonar. Por eso quien lo
hace, ha de hacerlo en nombre suyo, como quien ha
recibido algo nuevo que le es donado y que supera la
misma disposición mundana; y si el Cristo se arroga
semejante derecho es porque, en el fondo, lo que
proclama es, sencillamente, su divinidad.
Del perdón a la compasión
Esta misericordia de Dios, si bien acerca el reino de su
celeste trascendencia, de su alteridad absoluta y de su
inefabilidad, no lo convierte en una especie de
arbitrariedad a merced del creyente. Una familiaridad tal
que olvidara la sublime santidad de Dios, reduciendo el
trato a una inconsciente camaradería, significaría no
haber entendido nada de su soberana majestad; por el
contrario, acercarse a la presencia de Dios, víctimas del
miedo y del pavor, implicaría no haber comprendido nada
de su amor. Dispuesto a dejarse conmover por el
hombre, su creatura, la misericordia de Dios es otro modo
de contemplar su esencial santidad, diversa ciertamente
de toda bondad humana y superior a cualquier afecto que
nos rodea.
El perdón de Dios es su amor continuamente ofrecido.
Esta es la prueba mayor de su amor, que consiste en que
nos ama no porque seamos justos –amables- sino,
precisamente, por haber dejado de serlo. Médico de
nuestras almas, se complace en venir a rescatarlas;
123
pastor de nuestras vidas, toma todo empeño en
devolvernos a su redil. Pero no lo lleva a cabo en la
distancia apática de quien no quiere sufrir contagio
alguno. En su caso, la misericordia omnipotente se
convierte en paradoxal proximidad (“projimidad”).
La compasión no es sólo el modo como Dios se opone y
se resiste al mal sino, ante todo, el modo como lo asume
y lo comparte en primera persona. En unas ocasiones,
para eliminarlo, en otras –si así se puede decir- para
darlo significación. Por avanzada que se encuentre, en
nuestros días, la técnica, y por desarrollados que vivan
los países de la tierra, en el corazón del hombre laten
interrogantes que aquella no puede disipar. El sufrimiento
y la angustia, que anidan en lo profundo del ser humano y
que lo incomodan hasta la desesperanza, muchas veces,
ponen de manifiesto cuán necesario le resulta al hombre,
en dichas circunstancias, la certeza de un Sentido en el
que encontrar consuelo. Ponerse en el lugar de otro, así
como el deseo de que los demás lo hagan en el nuestro,
responde a un sentimiento siempre presente. Tal vez se
habla más hoy de la empatía, para subrayar la dimensión
psicológica de lo que, en otros tiempos ha sido una
cuestión religiosa o moral. Pero el hecho, en el fondo, es
el mismo. Para que las relaciones intersubjetivas sean
buenas y felices, estas deben edificarse sobre el sólido
cimiento de la compasión.
Dado que el hombre es un ser esencialmente dialogal,
que se desarrolla y crece en la comunicación, la
compasión viene a ser una forma de salir de aquel
aislamiento frustrante que amenaza al ser humano con
impedirlo madurar. El amor compasivo tiene un lugar
124
fundamental en las relaciones humanas de convivencia.
Lejos de lo que otras creencias religiosas o filosóficas
puedan pensar, la compasión no muestra la debilidad de
quien la cultiva sino su más profunda fortaleza, pues
implica una actitud que brota del fondo del corazón, del
centro de la propia personalidad y mira a compartir lo que
en el otro también es nuclear. No es mero
sentimentalismo, ni lástima que emana de la
contemplación superficial del dolor ajeno. Cuando es
sincera abarca mucho más.
La cuestión, ahora, es saber si el Dios omnipotente,
experimenta también la compasión. Verdaderamente el
Dios judeo-cristiano es un Dios que se conmueve, que
acompaña y hace suyo el dolor de su pueblo. Si este es
consecuencia del pecado, ofrece su perdón; si lo es de
una desgracia natural, su providencia será capaz de
iluminar un sentido superior y hacer de la calamidad una
ocasión para madurar en la libertad; cuando el
sufrimiento es consecuencia de la infidelidad, la invitación
a la obediencia puede, en adelante, ahorrar si no el dolor,
sí vivirlo inútilmente.
La teología tradicional, más edificada sobre las nociones
metafísicas de Dios, tal vez encuentra alguna dificultad
para conciliar la trascendencia de Dios con su simpatía
por el hombre pecador. No se trata de negar, en nombre
de una ingenua novedad, aquella omnipotencia a favor de
esta debilidad. Tampoco la Escritura es ajena a la
cercanía de Dios, en virtud de la cual, libremente se deja
"afectar" por la respuesta humana.
Esta inclinación de Dios a favor del hombre miserable
encuentra, llegada la plenitud de los tiempos, su máxima
125
expresión: en efecto, Cristo es la misericordia de Dios
encarnada. En Jesús, Dios mismo se hace todo corazón
para los enfermos: Él es el perdón –es decir, el don
rematadamente perfecto- de Dios, ofrecido al pecador, de
quien no quiere la muerte sino su propia conversión; Él
no sólo anuncia un mensaje de compasión sino que es,
en persona, la divina compasión. Su amor solícito y
preferido, en bien de los más pobres, constituye no sólo
el núcleo del evangelio sino, por ende, del gusto de Dios.
Si Cristo es la imagen visible del Dios invisible, icono
carne del Dios todo espíritu, su modo humano de ser
misericordioso revela, a los ojos de los hombres, la
intimidad misma de Dios. Este amor sin medida, este
perdón –que no pide ni espera nada a cambio- pone de
manifiesto la esencia misteriosa de Dios. Sin contradecir
aquellos atributos, a los que la metafísica nos acerca, la
revelación evangélica nos ofrece una nueva dimensión,
su verdadera significación. Dios es amor, y en su amor
misericordioso queda desbordada toda medida humana
de la mera justicia. Lejos de reducirse al mero dar a cada
uno lo suyo, a un tratar a cada uno como se merece, la
misericordia de Dios se dará a sí mismo en bien de
quienes ama, incluso cuando el pecado introduce la
ofensa y, con ella, el derecho a ser repulsado o excluido
del hogar de Dios.
De este modo aparece la misericordia de Dios y su
perdón como la realización suprema del ideal de justicia
anhelado por el hombre, pues en ella, también el hombre
desfigurado recupera la dignidad perdida. Así podemos
afirmar que la ternura de Dios y su compasión, lejos de
126
humillar y avergonzar al pecador, lo levanta y dignifica.
En Cristo, Dios ya no acusa, sólo salva. Y si sus palabras
sobre el juicio final desconciertan a veces, no es la suya
una intención de venganza sino de encendido amor, la
urgente invitación para aceptar la nueva oportunidad que
brota de su corazón.
En el acontecimiento de Cristo crucificado el sufrimiento
del hombre se une para siempre al sufrimiento misterioso
de Dios. Dios mismo sufre con el hombre y por el
hombre. Si, esta es la muestra mayor de amor a los
suyos que estaban en el mundo. No hay muestra de
acercamiento mayor ni de compasión que la sustitución.
La asunción vicaria del dolor ajeno, haciéndolo propio,
con tal de evitar a quien se ama su lamento, su
confusión. Esto es lo que hace un amigo de verdad, lo
que vive un amante cuando arde, por su amada, en el
fuego del amor. Pues también conmovido por la
separación del hombre, su criatura, Dios mismo hace de
su divino Hijo la víctima de reparación, a fin de evitarle a
aquel su merecida condenación. En Cristo, Dios no nos
ama en la distancia, ni tampoco en la oferta de palabras
tiernas, pero tanto como inútiles; en Cristo, Dios se hace
pecado para reconciliar al pecador. En Él se hace
ofrenda, a fin de satisfacer la expiación.
Dada la intrínseca implicación de todo hombre en la
miseria del pecado no es posible que del género humano
herido brote una pretendida reconciliación. No, el hombre
no puede salir, por sí mismo, de su situación frustrante de
separación pero sí puede, en cambio, ser sacado; sí
puede ser reconciliado por quien ha sido ofendido y ahora
ofrece, gratuitamente, la mano de su perdón. Dios no
127
quiere la muerte del pecador y, sin embargo, todo hombre
está abocado inevitablemente a ella; por ello Cristo
asume, en primera persona, la condena a muerte para
hacer de ella el pago en recompensa que devuelva al
hombre su anhelada libertad.
En la cruz el mundo es juzgado como reo y absuelto,
pues el Crucificado, exaltado como juez poderoso, ha
suplicado misericordia al Padre y ha obtenido el perdón
de la redención. Si la ofrenda vicaria de Cristo sustituye el
pago –imposible de satisfacer por el propio pecador- no
reemplaza, en cambio, la personal adhesión que,
responsablemente, tendrá que presentar en adelante a fin
de hacerse acreedor de la gracia recibida. La sangre de
Cristo nos justifica, nos hace justos ante Dios en su
misma justicia; lo cual no obsta para que, merced a
nuestra
propia
responsabilidad,
nos
hagamos
merecedores de ella.
No hay motivo mayor para la esperanza humana que la
de saberse gratuitamente salvado. Incluso en tiempos
como el nuestro, en los que no faltan ecos de aquella voz
profética que anunciara la muerte de Dios, y con él la de
los valores cristianos, el anuncio renovado de la verdad
evangélica de la salvación ofrece a todo ser humano un
motivo para seguir esperando en Dios. No hay motivo
para el miedo o la desesperación. La misericordia
crucificada es más fuerte, en su debilidad, que el peso
mismo de la ley, que la carga del pecado o que la
esclavitud de nuestras pasiones. Si el hombre no puede
vivir sino a la búsqueda de un sentido pleno, he aquí que
lo puede hallar definitivamente.
128
La radical novedad de la Buena Nueva hace del hombre
hijo de Dios. Compasión mayor no cabe, en la que
participamos del mismo ser, pues se nos da a recibir,
como propia, la misma naturaleza de Dios. Dios, en
Cristo traspasado, se vacía para colmar de este modo
nuestro deseo interior, ese que desemboca tantas veces
en el sinsentido y la angustia, en la amargura, el odio o el
rencor. Y esta es, precisamente, la nueva luz que orienta
toda la doctrina social de la Iglesia; ella -signo
esperanzador- no existe sino para acercar a todo hombre
la misericordia de Dios.
129
PERDONO E RICONCILIAZIONE:
SONO ANCORA CONSIDERATI
NECESSARI NEL MONDO CONTEMPORANEO?
Augusta Fiore
Racconta un midrash che Dio, prima di creare Adamo,
volle consultare gli angeli. Si crearono due diverse fazioni:
alcuni erano favorevoli alla creazione dell’uomo mentre
altri vi si opponevano. La Bontà affermava: “Che sia
creato perché farà opere di bene!”. La Rettitudine
protestava:”Non deve essere creato perché sarà pieno di
falsità!”. La pace: “Non lo creare perché sarà sempre in
lotta!”. La Torah affermava:
”Peccherà senza dubbio”. Ma Dio decise di creare l’uomo
e le sue parole furono:”Sono buono, sopporto a lungo e
sono pronto a creare l’uomo nonostante le vostre
obiezioni”1.
Ancora, raccontano i saggi, Dio, prima di creare questo
mondo meraviglioso, come un bravo architetto fece dei
disegni. Vedendo che la libertà dell’uomo, così grandiosa,
poteva creare degli squilibri, creò prima un’altra cosa: la
teshuvah, la conversione, la possibilità del ritorno al piano
di Dio.
1
Comunità ebraica di Roma 25/9/2013 in Blog/News, Parashà di Berishit: il Midrash
sulla creazione dell’uomo.
130
Questi due racconti mettono in evidenza, pur nella loro
semplicità, due punti essenziali: la prevista debolezza
della condizione umana e la disponibilità infinita di Dio ad
accogliere l’uomo e a perdonarlo.
Ci sembra opportuno, infatti, iniziando a parlare di
perdono, mettere in evidenza questi presupposti
essenziali che si attribuiscono sia all’uomo che a Dio.
Vogliamo sottolineare, infatti, che il perdono, la possibilità
di ottenere misericordia, dipendono dalla natura o
sostanza di Dio; l’uomo, di conseguenza, assumendo un
atteggiamento di pentimento, si giova
di questa
disponibilità di Dio. Il Perdono è un dono di Dio che può
essere colto dall’uomo che, consapevole dei propri errori,
sceglie di compiere un radicale cambiamento. La
Misericordia è una qualità di Dio che, secondo un piano
provvidenziale, viene manifestata all’uomo che è
predisposto ad accoglierla; egli comprende e desidera
per sé e per il mondo circostante questo bene, in maniera
profonda ed esistenziale, esprimendo poi gratitudine per i
benefici che un tale dono arreca.
Mettere Dio al primo posto, così come la tradizione
ebraica e cristiana ci insegnano, significa spesso, nel
mondo contemporaneo, evidenziare una verità obsoleta:
l’uomo cartesiano, nell’età moderna era considerato il
centro speculativo della realtà; nell’epoca contemporanea
per molti filosofi, Heidegger in particolare, l’uomo è
considerato un ente che viene progettato “ad essere
gettato” nel mondo secondo una continuità di necessità e
possibilità. “Dio è morto” dice Nietzsche e Sartre afferma
che “l’altro” è un nemico.
131
Il post-moderno rivendica, infine, la necessità di dare un
“altro inizio” al percorso filosofico in cui Dio, in definitiva,
non c’è e non esiste nemmeno il senso del sacro: gli enti
hanno perso il loro significato sostanziale. L’occidente,
come già diceva Heidegger, è ormai la terra dell’occaso e
del tramonto dell’essere e Vattimo aggiunge che il
tramonto definitivo avviene perché all’essere forte della
tradizione e della metafisica è subentrato un essere
“debole” che non è fondante, che non unifica, che non
possiede alcun fine nételos ed è soltanto accadimento.
Afferma ancora il filosofo che, finché si parla di Dio,
diventa necessario essere atei e, più precisamente, che
rappresentando la tradizione ebraico-cristiana insieme al
pensiero greco “punti fondanti”, di riferimento culturale,
essi offrono, proprio perché tali, all’uomo postmoderno la
possibilità di non pensare più e di non cercare il senso
dell’essere perché da forte il pensiero è diventato debole
e così chiudere, definitivamente, con la religione2.
In questo orizzonte culturale e filosofico, il Giubileo
annuncia il perdono, la riconciliazione e la rigenerazione,
come un tentativo di ridare un senso, un significato
profondo alla realtà che ci circonda. È necessario, infatti,
dare all’uomo una speranza che lo riconduca a
considerare il metafisico e a riscoprire il significato ontico
della realtà. Realtà che la tradizione religiosa ci aiuta a
comprendere come espressione di un piano di salvezza
voluto da Dio, nella Sua infinita misericordia, per l’uomo.
La tradizione ebraica e poi quella cristiana ci propongono
un itinerario, un percorso, un cammino di riscoperta di Dio
2
N. Abbagnano, Storia della filosofia,Gruppo editoriale l’Espresso, Roma 1996.
132
e dell’uomo, non teorico e astratto ma sperimentato
attraverso la storia concreta di tutti i giorni, gli
avvenimenti, le celebrazioni e le liturgie. In tal modo tutta
la realtà acquista un significato profondo che viene
vissuto esistenzialmente nel profondo di ogni uomo che
sente la speranza di nascere secondo una nuova vita che
è quella che il Signore dona attraverso il perdono.
Particolarmente significativa per la tradizione ebraica è la
festa dello Yom Kippur o giorno dell’Espiazione; è una
delle feste più importanti per il mondo ebraico fin dai
tempi più antichi. In questo giorno il popolo può ricevere
la misericordia di Dio, il perdono, per questo fa penitenza
e compie dei riti. Dio offre all’uomo la possibilità della
teshuvà, della conversione, del ritorno a Lui;ma è
soprattutto Dio che, donandogli il perdono, ritorna a lui,
facendolo partecipe della Sua natura.
È Dio stesso, infatti, che dona la conversione all’uomo,di
essere con Lui in comunione. Misericordia in ebraico si
dice rahamim che più esattamente significa “viscere di
misericordia” del nostro Dio. È questa, infatti, una parola
legata ad un’altra parola ebraica che è rechem che vuol
dire utero. Il significato di queste parole vuole indicare la
”maternità” di Dio che è capace di rigenerarci, come
attraverso un utero, a vivere un nuova vita di grazia.
Per i cristiani, Gesù Cristo manifesta quello che è già
compreso in Dio: rivela, rende evidente e concretizza,
con la Sua morte e Resurrezione, quelle viscere di
misericordia che sono destinate all’uomo.
Legato a quello della misericordia è il significato ebraico
del termine “peccato”: esso significa, letteralmente, “fallire
il bersaglio”. Sta ad indicare precisamente quell’azione
133
per cui, tirando con l’arco, il tiratore sbaglia il bersaglio. Il
peccato ha questo significato esistenziale: è il tentativo di
cercare la felicità ma di sbagliare la mira, fallire nello
scopo. È la situazione dell’uomo che cerca la felicità, la
pienezza, il raggiungimento del proprio essere in tante
cose ma, sbagliando il bersaglio, fallisce. L’accostamento
dei significati delle due parole, in realtà delle due
situazioni esistenziali è fondamentale per comprendere la
portata, nel mondo contemporaneo, dell’annuncio del
perdono che la Chiesa ha compiuto in occasione del
Giubileo.
La tradizione ebraica ci aiuta a penetrare e a valutare
meglio il suo valore. Infatti il giorno dello Yom Kippur,
dell’espiazione, può essere considerato per gli ebrei come
la risposta a questo fallimento dell’uomo, al peccato.
Vengono perdonati, condonati, cancellati i fallimenti, gli
errori, le colpe. Tale azione necessita di una preparazione
di quaranta giorni. Il suono dello shofar, di un corno,
indica che è iniziato questo periodo: ricorda l’ariete che
YHWH volle al posto di Isacco sul Monte Moriah, per il
sacrificio. Attualizzando, è la voce di Dio che chiama al
pentimento affinché la Sua misericordia sia resa evidente:
come provvede all’ariete che viene ucciso al posto del
figlio di Abramo così provvede a cancellare ogni colpa,
ogni errore3.
Per i cristiani anche questa festività fornisce l’opportunità
di fare riferimento alla figura del Cristo, vero ariete e
nuovo Isacco. Lo shofar, il suono della misericordia di
3
J. Maier e P. Shafer (a cura di), Piccola enciclopedia dell’ebraismo, trad. di D. Leoni,
Marietti, Casale Monferrato 1985. PETUCHOWSKI J.J, Le feste ebraiche. Le tradizioni
ebraiche, Dehoniane, Napoli 1987.
134
Dio, del perdono dei fallimenti dell’uomo, suona, fa sentire
la sua voce ogni volta che l’uomo lo sente risuonare nella
sua coscienza e così ritorna a Lui. La Scrittura dice che
Cristo si è fatto peccato per i peccatori e, facendo
riferimento alla festa dello Yom Kippur che prevedeva
l’adempimento di molti riti fra cui quello dell’entrata del
Sommo Sacerdote nel luogo del Sancta Sanctorum, dice
che è Cristo il Sommo Sacerdote che è entrato,
definitamente, nel luogo sacro, alla presenza di Dio. In
definitiva, per il cristiano ogni giorno è Yom Kippur; ogni
giorno, infatti, può giovarsi della misericordia di Dio
attraverso il sacramento della penitenza, convertirsi ed
iniziare una nuova vita.
Come già si è affermato, la possibilità che Dio usi
misericordia è prevista dall’eternità perché questa fa
parte della natura stessa di Dio. Questo concetto appare
particolarmente sentito dal filosofo ebreo Gershom
Scholem. Studioso di mistica ebraica, approfondì questo
argomento considerandolo il nucleo, il punto più profondo
e centrale dell’ebraismo. L’esegesi, compiuta dal filosofo,
sul libro di Giona, libro della Sacra Scrittura che viene
letto nel giorno dello Yom Kippur, mette in evidenza il
significato peculiare della profezia che contiene e
preannuncia la giustizia di Dio che è misericordia4.
È interessante notare, dice lo studioso, che il libro di
Giona è collocato nella Bibbia a metà dei libri profetici
minori, pur non contenendo alcuna profezia. Conoscendo
il contenuto del libro, sarebbe stato più logico inserirlo fra i
libri agiografi, come ad esempio, il libro di Ester e Rut.
4
G.SCHOLEM, Giona e la giustizia, Morcelliana, Brescia 2016.
135
Ma, in realtà, il libro contiene la chiave per la
comprensione del fenomeno del profetismo e ha, per
questo motivo, uno scopo didattico, pedagogico. Viene
descritta, infatti, l’educazione e la preparazione che deve
essere compiuta dal profeta per poter svolgere la
missione che Dio gli ha affidato: annunciare la
misericordia e il perdono. È questo il motivo, sostiene
Scholem, per cui il testo occupa una posizione centrale
fra i libri profetici e, aggiunge, il suo contenuto è
fondamentale, decisivo, valido per tutti i profeti e
costituisce anche una lettura fondamentale per la
celebrazione dello Yom Kippur. Questo è l’elemento
centrale della istruzione e formazione del profetismo; nel
caso di Giona, in particolare, Dio non eseguirà il giudizio
di distruzione annunciato ai Niniviti perché concede loro la
possibilità di convertirsi, di ritornare a Lui. Non tutti gli
abitanti di Ninive però accetteranno questa possibilità di
conversione; questo è un motivo per Giona di grande
sofferenza, perché con questo rifiuto verrà segnata la loro
sorte. Durante il combattimento interiore, il protagonista
vede inutile la sua missione di richiedere il pentimento agli
abitanti della città perché comprende che la misericordia
di Dio è già prevista e anticipata rispetto alla loro
conversione e questo perché la misericordia è compresa
nella Sua natura.
Scholem chiarisce anche il significato del concetto di
giustizia secondo la tradizione: essa è allontanamento,
differimento del giudizio di Dio e quindi della punizione. La
legge evidenzia i limiti previsti della norma ma, ritornando
l’uomo a Dio, attraverso il pentimento, induce Dio a
protrarre l’esecuzione del giudizio e della pena in caso di
136
colpevolezza. In definitiva Giona, ma anche tutti i profeti,
annunciano la giustizia il cui significato proprio è
misericordia
perché
significando
questa
parola
allontanamento all’infinito del giudizio compiuto attraverso
il confronto con la legge, in realtà significa non solo poter
godere del perdono di Dio ma anche ottenere una
vicinanza e un incontro con Lui, in definitiva, un’intimità
interiore.
La differenza sussistente tra giustizia, giudizio e amore,
più tardi con il Cristianesimo, è fondamentale. Giustizia è
infatti allontanamento infinito della pena, giudizio,
confronto con la legge; amore, nel caso del Cristianesimo,
annullamento, cancellazione definitiva del giudizio e della
colpa. In sintesi si può dire che giustizia e diritto si
completano e trovano una coincidenza nella sospensione
della pena; amore e diritto, invece, si escludono
reciprocamente. Il perdono nel caso del cristianesimo, è
definitivo e per sempre anche se si rinnova
opportunamente con l’accusa dei peccati e il pentimento.
Sarebbe un errore, quindi, pensare, secondo Scholem,
che il centro del libro di Giona sia la conversione di Ninive
o solamente la dimostrazione dell’effetto positivo,
convincente, della sua parola profetica che prevede
punizioni, disastri e castighi; l’elemento centrale è da
individuare nel continuo differimento del giudizio divino
che realizza e concretizza l’essenza di Dio che è
misericordia. In questo senso è anche comprensibile, nel
libro, l’invito del re della città che all’arrivo di Giona, invita
i niniviti al pentimento dei propri peccati: infatti senza il
pentimento non ci può essere il perdono. Si comprende
anche, in questo modo, la motivazione per cui questo
137
libro viene letto durante la liturgia dello Yom Kippur, del
giorno dedicato alla riconciliazione fra Dio e l’uomo.
La giustizia, secondo la tradizione ebraica, non può
essere anticipata e resa definitiva come nel Cristianesimo
che prevede, accompagna e porta a compimento
l’esercizio del perdono. Per l’Ebraismo infatti la giustizia o
misericordia non è una azione valida, come per il
Cristianesimo, una volta per tutte: per gli ebrei, di fronte
alla colpa, c’è il differimento della punizione, della colpa
fino al Giudizio finale. Diversamente, con la morte in
croce, Gesù Cristo, come già abbiamo accennato in San
Paolo, ottiene per noi, il perdono in assoluto e per
sempre.
In questo consiste anche la differenza nell’interpretazione
del libro di Giona di San Girolamo5 che vede nella
conversione dei Niniviti cioè dei pagani, in generale, la
condanna del popolo eletto, la sua esclusione, definitiva,
dalla storia della salvezza, perché non è disponibile a
convertirsi riconoscendo in Gesù Cristo il Figlio di Dio.
Questo mancato riconoscimento segnerà la linea di
separazione e di distinzione tra il popolo eletto egli altri
popoli: non lasciare la legge, non passare dal giudizio
all’amore comporta questa condanna.
In ogni caso, il perdono anche se con le distinzioni
evidenziate, viene annunciato a tutti perché
è nella
natura di Dio. Altrettanto essenziale è la conversione, il
riconoscimento dei propri peccati, la consapevolezza di
“aver sbagliato il bersaglio” per ottenere la felicità. Per
“ritornare a Dio” è, infatti, necessaria la conversione, il
5
San Girolamo, Commento al libro di Giona, Città nuova editrice, Roma 1992.
138
pentimento; per ottenere questi, è necessaria la
preghiera, l’invocazione del perdono come ci insegna il
Padre Nostro. Questa preghiera è meritevole anche se
pronunciata per mezzo della giustizia di pochi, come
leggiamo nel libro del Genesi (cap. 18): Abramo prega per
Sodoma e Gomorra e dice che “se solo ci fossero almeno
dieci giusti” questa città non sarebbe distrutta.
Lo Shabbat o l’esultanza della Eucaristia è il
riconoscimento della potenza di Dio per la storia di
salvezza compiuta nella nostra vita: Dio è Rahamim,
speranza perché perdono, misericordia e quindi
rigenerazione.
°°°
Interessante è approfondire il senso del perdono che
finora abbiamo analizzato attraverso le tradizioni
interiorizzandone i contenuti per mezzo della fede e
servirci ora della ragione e della ricerca filosofica; in
questo modo, sebbene secondo un livello diverso,
otteniamo anche la dimostrazione dell’esistenza di Dio e
del Suo rapporto con l’ uomo.
La lettera enciclica Fides et ratio di Giovanni Paolo II
esplicita l’importanza della relazione esistente fra le due
forme di conoscenza. Bellissima è l’immagine usata
nell’incipit dell’enciclica: “La fede e la ragione sono come
due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la
contemplazione della Verità”6. Attraverso l’indagine
razionale e la riflessione filosofica, dunque, sulla
dimensione religiosa del fenomeno specifico, possiamo
anche conoscere l’antropologia dell’essere umano, della
6
Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Fides et ratio, Paoline, Roma 1998.
139
realtà in cui vive e, soprattutto, la natura divina che è
nella creazione.
Il momento iniziale della nostra conoscenza è
l’autoriflessione che si realizza attraverso la coscienza:
tramite essa prendiamo atto della realtà che ci circonda e
possiamo esaminare le dimensioni, le strutture che sono
proprie del corpo, dell’anima e dello spirito di ogni essere
umano. Tali strutture, sono indicate, individuate e
considerate fondanti sia dalla tradizione filosofica che da
quella religiosa perché attraverso esse i fenomeni
“parlano”,esplicitano i contenuti e mostrano il loro
significato più profondo. È possibile, di conseguenza,
studiare le incidenze che essi hanno soggettivamente
come esperienza interna ad ogni individuo ed
oggettivamente come possibilità conoscitiva della realtà.
In particolare, il fenomeno religioso mostra, più
specificatamente, per la peculiarità del suo contenuto, il
senso profondo della realtà, il nucleo di ogni oggettività
che è l’Assoluto, l’Infinito, Dio7.
Il metodo fenomenologico, a cui facciamo ora riferimento,
considera il soggetto protagonista di ogni processo
conoscitivo. La sua struttura è composta da tre
dimensioni: corpo, anima o psiche, spirito,strettamente
connesse fra di loro dalla coscienza. I fenomeni sono
“vissuti”, costituiscono un insieme di esperienze che
compongono il momento conoscitivo e che provengono
dalla realtà delle le cose con cui il soggetto si rapporta
proprio secondo queste tre dimensioni. “Riducendo”,
sospendendo, eliminando ogni giudizio pre-concettuale, si
7
A.Ales Bello, Husserl. Sul problema di Dio, Studium, Roma 1985; Id., La teologia in un
inedito husserliano, “Aquinas”, XXV, 2, Roma 1982, pp. 349-356.
140
giunge all’epochè, all’assenza di ogni giudizio; su questa
assenza è possibile costruire la conoscenza del senso
delle cose, secondo una direzione trascendentale che va
oltre la realtà concreta. Nell’uomo, in questo modo,
attraverso la coscienza vien riconosciuta l’esistenza di un
fondo ontologico che, oltrepassando i confini della
concretezza fisica, giunge ad affermare l’esistenza di una
realtà, appunto, ontologica. La coscienza, come abbiamo
già affermato, coglie e prende atto, attraverso l’ attività
intenzionale, di questo trascendimento8.
Il filosofo Husserl ritiene che il metodo fenomenologico, in
questo modo, non solo può conoscere la realtà oggettiva,
esterna all’uomo e la realtà soggettiva che è interna al
suo essere, ma coglie anche il presupposto conoscitivo di
questo atto, anteriore a tutti gli altri atti che
successivamente vengono registrati dalla coscienza.
Questo presupposto si chiama “sintesi passiva”, latente
nella coscienza, determinante e di riferimento per l’intero
percorso conoscitivo. Stabiliamo, infatti, in questo modo,
rapporti di continuità e discontinuità, di omogeneità ed
eterogeneità con le cose e fra le cose che sono
precedenti alla percezione stessa, operazioni che
vengono compiute a livello passivo, che, come si è già
detto, sono preesistenti. Queste operazioni sono di due
tipi: di carattere logico e di carattere trascendentale e
costituiscono un fondo, un punto di partenza, da cui
attingere elementi per realizzare la conoscenza delle cose
e della realtà metafisica ed ontologica. Possiamo
8
A. Ales Bello, Introduzione alla fenomenologia, Aracne, Roma 2009; E. HUSSERL,
Ricerche logiche, Il Saggiatore, Milano 2001; E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia
pura e per una filosofia contemporanea, Biblioteca Einaudi, Torino 2002.
141
affermare che costituisce un principio, un “qualcosa” che
è nella coscienza dell’uomo, preesistente ad ogni
elaborazione conoscitiva, una via atea di dimostrazione
della esistenza di Dio.
Il “vissuto” che, secondo la filosofa Edith Stein, discepola
di Husserl, è determinante in questo percorso è quello
dell’empatia che evidenzia la presenza di una struttura
comune in tutti gli esseri umani che rende possibile fra
loro un rapporto spirituale, intersoggettivo9.
Tra gli atti spirituali che sono intellettuali, razionali,
morali, legati alla volontà, ci sono anche atti religiosi.
Questi, essendo “vissuti”, si muovono in un fluire continuo
e rimandano costantemente la coscienza all’intuizione di
un Principio Assoluto, indiscutibile, illimitato. Di
conseguenza a questo atto, si acquista anche la
consapevolezza chel’essere umano, non è assoluto e non
è illimitato. Ci sono, dunque, dei flussi di coscienza che
indicano questa realtà, che ci indicano che esiste“.
Qualcosa” che ci trascende ma che è già in noi,
consentendoci di avvertire questa distinzione10.
Sulla base di questi studi, la Stein analizzò anche
l’esperienza del fenomeno mistico. Ella compì questo
percorso che la portava alla “Verità” secondo una linea
logica-razionale ma concluse che la vera conoscenza è
vivere nella fede questo percorso, all’interno del proprio
animo, assaporando un “affidamento” a Dio11. Ella
9
E. Stein, Empatia, prefazione A. Ales Bello, Studium, Roma 2012.
Id., Essere finito ed Essere eterno, prefazione A.Ales Bello, traduzione L. Vigone,
Città Nuova, Roma 1999.
11
Id., Natura, persona mistica, a cura di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 2002.
10
142
afferma che la “Verità” è Dio che si rivela attraverso la
scientia crucis, attraverso Gesù Cristo.
Questa esperienza interiore si concretizza nella vita reale
della filosofa che muore ad Auschwitz in un campo di
concentramento. La spogliazione di sé che comporta
vivere la scientia crucis porterà la filosofa a vivere,
innocente fra gli innocenti, l’esperienza della sofferenza
suprema della persecuzione e della morte insieme al suo
popolo12. Questa morte è però un annuncio di speranza,
di resurrezione: il destino degli ebrei, ma possiamo
aggiungere di tutta l’umanità, non è quello di finire nel
nulla, nell’assurdo ma di godere della definitiva alleanza
che Dio fece con Mosè sul Sinai: la vita eterna, la Sua
santità che è perdono, misericordia, grazia.
Questa consapevolezza è presente in Sant’Agostino, in
Sant’Anselmo.
Il fenomeno religioso, infatti, è, innanzitutto, un’esperienza
dell’essere umano dell’esistenza di “Qualcosa” o di
“Qualcuno” superiore a lui che è presente in noi e in tutti
gli altri uomini. Si può dire che è in noi la traccia
dell’Illimitato, dell’Assoluto, di Dio, nucleo, centro di tutte
le esperienze religiose13.
Come abbiamo già affermato, due sono le vie della
conoscenza di Dio: la via oggettiva e la via soggettiva
che può essere filosofica e religiosa. In ogni caso
l’elemento fondamentale di ambedue è l’esperienza
secondo cui è possibile armonizzare la dualità del
percorso di conoscenza e affermare, come dice Edith
12
Id.,Vado per il mio popolo, a cura di A. Ales Bello, Castelvecchi, Roma 2012.
Id., Husserl. Pensare Dio. Credere in Dio, in Tracce del sacro nella cultura
contemporanea, n. 32, collana diretta da G. Penzo, Messaggero, Padova 2005.
13
143
Stein, che il compito della filosofia “è mettere armonia tra
ciò che essa ha elaborato con i suoi propri mezzi e ciò
che viene offerto dalla fede e dalla teologia”14.
Procedendo in un analisi del pensiero di alcuni filosofi
certamente personale, ma opportuna per evidenziare la
presenza di Dio nella esperienza propria di ogni individuo,
è interessante accennare anche alla filosofia di Bergson.
Egli afferma che l’intuizione è un mezzo di conoscenza
che precede ogni atto analitico compiuta dalla ragione e
fornisce, anticipatamente rispetto a questa, attraverso,
una visione d’insieme dell’oggetto, l’essenza profonda
della realtà. La ragione e l’intelligenza non sono dunque
l’unico strumento di conoscenza; l’intuizione coglie in
modo più completo e totalizzante l’essenza della realtà in
tutte le sue dimensioni chiamata dal filosofo “slancio
vitale”.Questo slancio è lo slancio creatore di Dio stesso
che esprime anche un amore totale e assoluto per le sue
creature. La conoscenza di Dio diventa, quindi, anche in
questo caso, esperienza profonda di Dio15.
In modo più specifico, mi è sembrato opportuno il
riferimento al pensiero di questi filosofi a proposito del
tema del perdono di cui, nella realtà della vita
contemporanea, avvertiamo la necessità, essenziale, per
percorrere una autentica via di conversione e per riparare
ad una visione deterministica del mondo che non
comprende e non vuole accettare la presenza di Dio e
che nega ogni approccio metafisico ed ontologico della
realtà. L’esperienza di fede che accompagna questa
14
E. Stein, Essere finito e essere eterno, cit., p.60.
H. Bergson, Introduzione alla metafisica, a cura di R. Ronchi, traduzione D. Giordano,
Orthotes, Napoli-Salerno 2012.
15
144
visione filosofica diventa una forma di conoscenza
intuitiva, non razionale, dell’esistenza di Dio. È
necessario, in questo modo, vivere un rapporto intimo con
Dio che inizia con il perdono di Dio e il pentimento da
parte dell’uomo. Particolarmente interessante ed utile per
la nostra riflessione, è il saggio di Max Scheler, “Il
pentimento”16. Lo studio si svolge secondo il
procedimento fenomenologico ed indaga i moti interiori
dell’anima. Il pentimento è per l’appunto considerato un
fenomeno, un moto interiore che viene analizzato come
tutti i fenomeni, secondo cause ed effetti; viene
individuata la ragione profonda del suo essere, la
centralità, il nucleo, che è il rinnovamento interiore della
persona. L’analisi delle caratteriste proprie dell’essere
umano e degli atti specifici del fenomeno del pentimento,
ci riporta a quella visione iniziale del perdono descritta
precedentemente. Nei moti di coscienza, afferma il
filosofo, l’occhio spirituale della fede percepisce la
presenza di un giudice invisibile ed eterno. Questi moti si
presentano come fenomeni oggettivi in cui appare
evidente la loro relazione di senso con la presenza di Dio.
Nel vissuto di questi fenomeni,si percepisce “Qualcosa”
che trascende ciò che è dato materialmente, ma che
comunque viene percepito insieme ad esso; infatti, dalla
unità della coscienza viene percepito un insieme di atti
che portano al pentimento e al rinnovamento interiore. Tra
questi moti è certamente compresa una attività
giudicatrice riferita ad episodi vissuti nel passato che però
acquista, sotto l’aspetto morale, la forma di una
16
M.Scheler, Il pentimento, Castelvecchi, Roma 2016.
145
autoguarigione, l’unica via da percorrere per riacquistare
le forze spirituali perdute. Sotto l’aspetto religioso, il
pentimento ha un significato ancora superiore: è l’atto
naturale che Dio concede all’anima perché essa possa
ritornare a Lui quando sene allontana. Continua il filosofo:
il pentimento uccide “il nervo vitale della colpa” che
spesso viene eliminata dalla coscienza dell’uomo perché
non gradita ma che produce impedimento e schiavitù. In
questo modo, invece, la persona, riacquista la libertà, può
vivere una rinascita spirituale, una vita nuova. La vera
mancanza di libertà di un individuo, sta proprio nel non
voler riconoscere la colpa personale dei propri errori
ma,in tal modo, impedisce all’anima di esprimere la
propria vitalità che si manifesta anche nel riconoscere la
colpa, nel cercare di essere veritieri con se stessi.
Si può affermare che è essenziale per l’uomo la
disposizione al pentimento e quindi all’umiltà che si
oppone alla naturale superbia umana che frena ogni
slancio e dinamismo interiore. La grazia, dal punto di vista
religioso, cancella la colpa dopo un completo pentimento
e assume il carattere di una vera conversione, di un
cambiamento di mentalità, di una trasformazione della
coscienza.
Molto interessante è anche ciò che dice Scheler circa il
pentimento collettivo per colpe accumulatasi nel tempo.
La storia spesso registra eventi drammatici e la cultura
afferma a volte teorie aberranti, evidenziando il
comportamento umano che spesso travalica i limiti
imposti dall’ etica: esistono, infatti, colpe che, in questo
senso, possono essere ritenute collettive.
146
Universale, possiamo dire, deve essere anche il rimedio:
il Giubileo che interpreta questa necessità e proclama
l’anno del perdono. Esistono esempi vari nella storia in cui
la Chiesa, vigile come solo una madre può essere,
avverte il bisogno di una rigenerazione dell’intera umanità
e proclama la misericordia di Dio.
In conclusione, attraverso l’ analisi condotta dallo Scheler
sul moto della coscienza, si evidenzia un ordine naturale
della nostra anima che si mostra attraverso il fenomeno
del pentimento e acquista via via un significato sempre
più profondo, mettendosi in connessione con il mondo
metafisico- religioso. Viene a caratterizzarsi con maggiore
chiarezza il senso del male, della colpa, definito dalla
religione “peccato” che si confronta attraverso la legge e
la dottrina e, nello stesso tempo, è esaltato il senso di
rinnovamento interiore che viene dal pentimento e dalla
remissione dei peccati.
Scheler afferma anche che se non ci fosse altro nel
mondo che attesti l’esistenza di Dio, il pentimento e il
conseguente senso del perdono, ne sono una prova.
L’insieme del percorso che abbiamo appena abbozzato,
è infatti una manifestazione di questa Presenza: l’accusa,
la confessione della colpa,il pentimento, la liberazione
dalla colpa sono momenti di un processo esistenziale che
portano a Dio, infinita misericordia .
°°°
Veramente provvidenziale, alla luce della riflessioni che
sono state fin qui condotte, la proclamazione del Giubileo
per i nostri tempi! Esso è frutto della consapevolezza
delle problematiche che “la città dolente”, come definisce
147
Dante l’inferno, ma possiamo dire l’umanità intera a causa
di perverse politiche, si trova a vivere. Sono
problematiche diverse che interessano tutti gli aspetti
della nostra società e che rispondono certamente ad una
visione della vita in cui Dio è stato allontanato dalla
concretezza delle scelte della vitaquotidiana. Le
conseguenze di questo allontanamento sono facilmente
individuabili anche ad un sguardo superficiale. Il
disorientamento culturale e morale è evidente; spesso si
seguono filosofie che producono incertezze, specie nei
giovani; si afferma la libertà che è autodeterminazione e
spesso licenza; l’intelligenza dell’uomo che vuole
sostituirsi a Dio, l’esercizio della propria volontà che
diventa arbitrio. Il Giubileo provvede e, come nella
tradizione ebraica, suona lo shofar e richiama il popolo
con la voce di Dio; è necessario un rinnovamento, una
rigenerazione, un cambiamento che solo il “perdono” di
Dio può dare. Le parole di Paolo agli Efesini (4, 1-24)
giungono opportune:”Dovete rinnovarvi nello spirito della
vostra mente e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo
Dio nella giustizia e nella santità vera”.
Il Giubileo diventa un messaggio, un annuncio di
conversione che la Chiesa ha previsto da secoli per
amore dei suoi figli e che oggi si rinnova perché
necessario agli occhi attenti e vigili della Chiesa. Si
compie, anche oggi, la lotta che nell’Apocalisse viene
descritta fra il drago e la donna. (cfr. 12,4): il drago si
posò davanti alla donna che stava per partorire in modo
da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Questa
è l’immagine della Chiesa che lotta per i suoi figli contro la
schiavitù del peccato.
148
È necessario ed opportuno, quindi, il Giubileo; la Chiesa,
nell’ esprimere la carità di cui è generatrice, ha visto
questa necessità e desidera essere fucina di
rinnovamento, madre di una nuova vita interiore,
portavoce del messaggio del perdono. Comprendere la
profondità di questo messaggio significa anche che tutti
possono divenire annunciatori della buona notizia che
Gesù Cristo è venuto a darci, vera scientia crucis: la
morte di Gesù Cristo, vissuta nelle sofferenze, nei
drammi della umanità, è chiamata alla resurrezione, alla
speranza, a vivere una vita nuova nello Spirito.
Per concludere, è possibile attualizzare il contenuto di
queste riflessioni facendo riferimento ad una festa ebraica
che è chiamata Khanukà o festa della dedicazione, della
ricostruzione del tempio di Gerusalemme. Questa festa è
descritta e narrata nel libro dell’Antico Testamento dei
Maccabei. Si racconta che il re Epifane IV,discendente di
Alessandro Magno, nel 167 a. C., conquista
Gerusalemme e profana il tempio, ruba tutti gli arredi
liturgici e compie un gesto terribile: porta via il candelabro,
la Menorah, il candelabro prezioso che illuminava in modo
perpetuo il tempio, simbolo della shekinà, della presenza
di Dio.
Attualizzando la storia si può dire che anche nei nostri
giorni, nel tempio del Signore che non è solo la
costruzione del tempio ma ogni cristiano, attraverso
filosofie e ideologie, può insinuarsi il culto pagano di
mettere un idolo al posto di Dio e così credere ad altri dei.
Tuttavia come la famiglia dei Maccabei insorge e così il
tempio viene riconquistato e ricostruito, ognuno di noi è
chiamato ad assumere questo ruolo e consentire che Dio,
149
vera luce, vinca l’oscurità del paganesimo di ogni tempo.
Il Talmud racconta che il miracolo del tempio non è
ancora completo perché nonostante la ricostruzione, la
luce nel tempio non poteva essere ancora accesa perché
nel tempio non c’era l’olio sacro che serviva appunto per
l’accensione del candelabro. In questa situazione fu
trovato miracolosamente un vasetto d’olio che era
sufficiente per illuminare il tempio appena per un giorno.
Fu acceso e si vide, invece, che quest’olio durò otto
giorni. Per questo motivo, la festa viene celebrata per otto
giorni. Giuseppe Flavio, storico contemporaneo a Gesù,
parlando di questa festa dice: “Dal giorno dei Maccabei
fino ad oggi, noi celebriamo questa festa e la chiamiamo
festa della luce”17. La liturgia della festa, infatti, celebra la
luce di Dio che nei tempi di crisi, di fallimento, brilla e
illumina l’uomo.
In ultimo, semplice ma significativo è il contenuto di un
midrash che dice che la festa di Khanukà risale ad
Adamoperché questo, dopo il peccato compiuto con Eva,
vide che i giorni si accorciavano e diveniva buio presto; si
spaventò moltissimo e pensando che non ci sarebbe stato
più il sole, fece una preghiera e disse:”Signore, abbi pietà
di me, è vero ho peccato e per questo sono venute le
tenebre, il caos”. Da quel momento i giorni si allungarono
ed Adamo fu consolato.
Anche per noi cristiani la Croce di Cristo, nei momenti di
maggiore crisi e di oscurità, è divenuta gloriosa. La
sofferenza, il non senso della vita riacquista un significato
perché solo in questo modo si sperimenta la presenza di
17
G. Flavio, Antichità giudaiche, XII, UTET, Torino 2013.
150
Dio. È questo un annuncio di speranza per tutti gli uomini
che a volte vedono che nella loro vita e nel mondo
circostante è entrata l’oscurità del peccato. Proprio in
questi momenti, la luce del Messia trionfa sulle tenebre.
Per questo motivo si può dire che non solo Gesù Cristo è
il nuovo tempio ma anche tutti i cristiani riconciliati per
Suo merito, attraverso il Battesimo e la Penitenza, segni
sacramentali che sanciscono una nuova natura e il
pentimento dei propri peccati, segnano il ritorno di Dio
all’uomo e di questo a Dio attraverso un percorso di
chiarificazione e di identificazione. Possono essere loro
stessi questa Menorah, luce e speranza per il mondo.
151
LUIGI STURZO E “LA MISERICORDIA”,
TEMA DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DI PAPA
FRANCESCO
Salvatore Latora
Perché questo titolo che indica una viva coincidenza con
il tema del Giubileo?
Senza ricorrere a schemi di preveggenza, temi come
questo scorrono nel fiume storico del cristianesimo e
riaffiorano di tanto in tanto in base alle esigenze del
tempo.
È certo però che le parole di Luigi Sturzo, che riporteremo
dalla sua opera: Problemi spirituali del nostro tempo,
Zanichelli Bologna 1961, ci stupiscono per la profondità e
una certa coincidenza con il tema del Giubileo,dovute alla
genialità del suo Autore.
Diciamo in premessa, che nei momenti di crisi come
quella attuale due punti luce o modelli di comportamento
potremo tenere presenti: la fervida attività e le opere di
Papa Francesco che, in modo innovativo, vuol fare
scoprire a tutti il valore liberante del cristianesimo; e la
personalità del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che ha respirato fin dalla sua famiglia d’origine
i principi sturziani.
Sottolineamo inoltre che c’è affinità tra papa Francesco,
papa delle periferie e Luigi Sturzo che, con la sua azione
152
politica, ha voluto dar voce a quei ceti che non l’avevano
avuto durante il Risorgimento, che è stato frutto di una
élite; il nostro papa vuole una chiesa di popolo; Sturzo ha
voluto una politica di popolo.
Luigi Sturzo, a giudizio di molti storici, è una delle voci più
creative del pensiero politico moderno, ma viene
conosciuto generalmente come il fondatore del PPI, nato
il 18 gennaio 1919 (il fatto nuovo della politica italiana,
come hanno compreso Gobetti, Gramsci e Chabod! che
ebbe 100 deputati tra cui anche il padre del pontefice
Paolo VI), mentre le opere più importanti dal punto di vista
storico- dottrinale e filosofico- sociale sono state scritte
durante i 22 anni di esilio in Inghilterra e in America, fino
al ritorno in Italia nel 19461.Nei brani tratti dall’opera che
abbiamo citato, Sturzo esordisce con la V Beatitudine,
che come sappiamo sono 8. Esse sono veramente un
cantico che assume in sé l’insegnamento evangelico e
non vanno confusi come spesso accade, precisa Sturzo,
con i cosiddetti consigli evangelici di povertà, castità ed
ubbidienza, che sono le basi dei voti pronunciati dagli
appartenenti alle comunità religiose. Esse sono invece
otto itinerari di perfezione per la vera felicità che, insieme
con l’inno alla carità (Paolo, Corinzi 12,31 ss.) andrebbero
insegnate in tutte le scuole!
1
Alcuni degli studi che Luigi Sturzo scrisse all’estero e che hanno un valore
prospettico di attualità: La vera vita. Sociologia del soprannaturale; Chiesa e Stato,2
Voll.; La sociologia storicistica:La società Sua natura e leggi; del metodo sociologico.
Studi e polemiche; Sintesi sociali. L’Organizzazione di classe e le Unioni professionaliPolitica e Morale- Coscienza e Politica- Problemi spirituale del nostro tempo- La
comunità internazionale e il Diritto di Guerra. Corrispondenza con il fratello , Mons.
Mario (5 Voll.).
153
“Beati i misericordiosi, perché essi troveranno
misericordia. La giustizia non basta; è necessaria anche
la misericordia nelle nostre relazioni con gli altri, proprio
come noi domandiamo sempre misericordia a Dio per i
nostri peccati ripetendo nel Pater Noster: “Rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
Come si potrebbe vivere nel mondo sotto il rigore della
giustizia se non esistessero anche la misericordia, la
compassione, la pietà, la clemenza – tutto quello che dà
la testimonianza di un’anima disposta a comprendere e
ad aiutare gli altri, dimenticando le loro offese?”(op. cit.,
p.105).
In un altro brano Sturzo ricorda che nei rapporti con Dio
solo il presente è in nostro potere!
“Nei rapporti con Dio non possiamo far altro che lasciare il
nostro passato alla sua misericordia; il nostro futuro alla
sua provvidenza, mentre il presente è nostro perché si
redima un passato di colpe e perché si ottenga un futuro
di grazie. Il presente solo è l’ora nostra; l’ora dei nostri
pensieri e delle nostre azioni; l’ora del bene e del
male”(Ivi p.183).
E allora viene da chiedersi che cos’è il presente?
“ È l’attimo che passa e che è nostro e del quale e nel
quale possiamo fare tutto il bene o tutto il male che noi
vogliamo. Questo presente è in noi stessi; è il nostro
essere: pensiero, volontà, azione. Questo momento
presente, che dura per noi tutta la vita e per l’umanità i
secoli e i millenni, è registrato da un organo simbolico e
vivente, il cuore”(Ivi p. 225).
Il cuore in senso biblico racchiude la pienezza della vita
spirituale, cioè l’energia di tutte le forze dell’anima e del
154
corpo (Mat 25, 31 ss.) o in senso pascaliano: le coeur a
ses raisons, que la raison ne connait point.
“ “Dov’è il vostro tesoro lì sarà il vostro cuore”. Il resto è
fuori della nostra cerchia di azione, il resto non esiste. Il
cuore è dentro di noi, esso vive del nostro presente col
palpito che ama, teme, spera, gioisce, dolora. Perché
sciupare questo tesoro nella vita materiale che è solo un
mezzo e non cercarlo nella vita dello spirito che è di per
sé una gioia, un godimento, una perennità felice, anche in
mezzo ai dolori e alle afflizioni del nostro pellegrinaggio
verso il cielo?”(Ivi pp. 225, 226).
Misericordia ,da miserere e cor cordis= sentimento di
compassione e pietà, grazia e perdono. È la prima
invocazione nella Divina Commedia:miserere di me gridai
a lui, (Inferno, c.I, 65); Sturzo richiama le 7 opere di
misericordia corporale e le 7 opere di misericordia
spirituale.
“Non disse il Maestro che al giudizio finale darà il premio
a chi avrà fatto il bene ai fratelli, ai più bisognosi e
derelitti; a chi aveva fame o sete, al carcerato,
all’ammalato, al nudo ecc. come se fosse fatto a Lui
stesso?”(Ibid.)
Il campo specifico di Luigi Sturzo è stato quello sociopolitico, mentre il fratello vescovo, oltre alle tante opere di
teologia, di pedagogia, di pastorale, di poesia è stato il
fondatore di una Rivista di autoformazione e il creatore di
una nuova filosofia, il Neo -Sitetismo.
La forma più alta di carità, ha proclamato Paolo VI, è la
politica e a questa si è dedicato con grande impegno per
tutta la vita Luigi Sturzo.
155
“La società si trasforma solo con le virtù, cardinali, sul
piano umano speculativo: prudenza, giustizia, fortezza e
temperanza, e sul piano divino con le virtù teologali:fede ,
speranza e carità _ Se è naturale pensare alla società in
termini di timore: - che sarà di noi, famiglia o classe? Di
noi città o nazione? Di noi occidente o oriente? Di noi
società o chiesa? È più utile e doveroso dire, continua
Sturzo: che debbo io fare oggi per la famiglia, per la
classe, per la città, per il paese, per la cultura, per la
scuola, per la chiesa? Qual è il mio dovere? Che cosa mi
dice il cuore? Che cosa mi insegna Gesù? L’oggi è vita, è
lavoro, è combattimento, è sacrificio: coraggio piccolo
gregge, a voi è dato il regno, perché ogni buona azione,
ogni atto di dovere, ogni buona parola è il tesoro con il
quale si compra il regno dei cieli”(Ivi , pag. 226)
A questo punto bisogna leggere e meditare: l’Appello a
tutti gli uomini liberi e forti; il Programma del Partito
Popolare Italiano, e l’individuazione contro Le tre
malebestie: statalismo, partitocrazia, sperpero del denaro
pubblico!
156
LA MISERICORDIA COME ‘PRINCIPIO
PEDAGOGICO’.
LA POIESI DI UNA NUOVA FORMA COMUNICATIVA
Gaspare Pitarresi
“La Misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concreta
con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una
madre che si commuovono fino dal profondo delle viscere per il
proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore “viscerale”.
Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale,
1
fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono” .
Papa Francesco
157
Introduzione
Posto che la “misericordia umana” è la “forma concreta
della misericordia di Dio nel mondo”2 e non costituisce
quindi un’idea astratta, l’obiettivo che ci poniamo con il
presente contributo è quello di captare l’inaugurazione di
una nuova forma di “comunicazione” a partire dalla
Misericordia.
1
Francesco, Misericordiae Vultus. Bolla di indizione del Giubileo straordinario della
Misericordia, 11 Aprile 2015, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, pp.
183-184.
2
Cfr. M. Naro, Teologia della misericordia, teologia dalla misericordia, in: G. Alcamo
(cur.), Con il cuore di Padre. Rivelazione di Dio e stile pastorale per la Chiesa, Paoline,
Milano 2016, p. 85.
Oggi l’idea di Misericordia, la cui immediata traduzione
può essere quella di compassione3 (cum patior), in recenti
studi di psicologia e pedagogia è sovente espressa
tramite il termine empatia o enteropatia4. Il fenomeno
dell’empatia è stato definito come:
Atto intenzionale ed esperienziale eterocentrato, che consente cioè il
riconoscimento dell'alterità personale, in una più ampia epistemologia
dei vissuti coscienziali concepita quale analitica fenomenologica della
persona umana. Di tale riconoscimento si può parlare soprattutto a
proposito dell'appartenenza alla medesima specie umana che
sperimentano ogni giorno persone di etnie e culture molto diverse o
distinte tra loro in base a età, sesso, linguaggio, classe sociale. Si
danno diversi casi di entropatia, dal suo più semplice, immediato
aspetto di percezione o intuizione dell'altra esistenza alle forme di
3
Già nel Vecchio Testamento Dio sceglie la modalità di “entrare nella cultura di un
popolo” per costituire un’alleanza. Il vocabolario veterotestamentario dispone di ampia
teoria di lemmi atti a significare la misericordia di Dio: il termine ebraico rahamim, che
deriva da rehem, ovvero grembo materno, le “viscere materne”; oiktirmós indica la
compassione, la commozione e la disponibilità ad aiutare; éleos che sta ad indicare il
sentimento di commozione; il rapporto tra misericordia e giustizia, invece, è espresso
dal termine è hesedh, che può rendersi con amicizia, favore immediato, grazia. Il
termine biblico che ci fa cogliere a pieno l’idea di Misericordia è lebh, cuore. Uno dei
volti del Dio vetero-testamentario - mutuando le parole del profeta Osea 11, 8 - è
quello di un Dio che si muove a compassione, che si commuove. Nessuna traduzione
sarebbe in grado di restituirci la ricchezza di senso dell’amore smisurato e
appassionato di Dio per la sua creatura. La stessa compassione emerge in Esodo 3,7,
ove si dice che Dio “scende”, mosso a compassione, in ascolto del grido di sofferenza
del suo popolo. Una ‘compassione’ che sarà promessa poi in Esodo 6,7 sì da
instaurare un’amicizia misericordiosa duratura. La Misericordia, dunque, manifesta la
realtà intima di Dio: «l’essere di Dio è esistenza per il suo popolo e con il suo popolo»
(W. Kasper). È nel volto di Gesù che la Misericordia spiega e dispiega l’essere di Dioper-l’altro, nel “qui e adesso” della storia.
4
Si tratta di un “atto” importantissimo evidenziato dalla lezione della fenomenologia, da
Husserl prima e Stein dopo: “Fra i nostri diversi vissuti, ce n’è uno che definiamo
Einfühlung, e la sua peculiarità è farci sentire immediatamente che stiamo in contatto
con un altro essere umano, di modo tale che possiamo dire “noi”. [_] Entropatia vuol
dire che sento l’esistenza di un altro essere umano, come me: è, pertanto, una
sensazione immediata di somiglianza”. A. Ales Bello, Introduzione alla fenomenologia,
Aracne, Roma 2009, pp. 44-45.
158
rispetto che generano comprensione e presentano motivi di
reciprocità e di associazione, fino all'atto di immedesimazione nel
5
sentire dell'altro.
Trascendendo il piano dell’analisi fenomenologica degli
atti di empatia, la riflessione proposta di seguito vuole
invitarci ad un confronto diretto con un’esperienza di vita
concreta. Muovendo da questa considerazione, “la virtù
dell’empatia diviene allora un modo d’essere, un
caratteristico stile esistenziale e un’esperienza di valore
che può investire ogni incontro, realizzarsi con ogni
interlocutore; per tale ragione, essa promuove un’azione
trasformante per quanti prendono parte al processo e alla
sua dinamica propria”6.
La Misericordia, del resto, colta nel suo aspetto
etimologico, biblico e pastorale, non è che dimostrazione
di un movimento di “decentramento” verso l’altro, atto che
implica comunque una revisione del paradigma educativo
tout court e al contempo predilige nel dialogo la scelta
etica (responsabilità-per-l’altro), per inaugurare, tramite
gesti concreti e visibili, una profonda e proficua “cultura
del contatto”.
5
G. Morselli, “Mettere al mondo”. Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in linea],
anno 17 (2015) [inserito il 30 dicembre 2015], disponibile su World Wide Web:
http://mondodomani.org/dialegesthai/>, [108 KB], ISSN 1128 -- 5478.
6
A. Bellingreri, Il metodo educativo “centrato sull’empatia” in “Studium Educationis”,
2/2013, p. 14.
159
L’urgenza di misericordia
L’atteggiamento di ostilità oggi molto frequente nei
confronti dell’altro in quanto diverso, verso i migranti in
primiis, affonda le sue radici più recenti nell’ideologia
nazista, la quale invogliava al disprezzo dell’uomo. La
lezione che le nostre società occidentali hanno raccolto
dalle pagine di storia del XX secolo può riassumersi nel
tentativo-bisogno di prevaricazione sull’altro e sulla sua
cultura, sì da elevare “un atteggiamento dei forti”, al fine
di esprimere se stessi. La conseguenza immediata è
l’incapacità di abitare il limite, tant’è che:
Quando l’uomo dimentica di abitare il limite, non è più capace di
prossimità e pretende di abitare nella totalità. Ma il pensiero di totalità
non riconosce più alcuna esteriorità, differenza e diventa
totalitarismo, nazismo e olocausto. Educare dopo i fallimenti del XX
secolo significa allora accettare di abitare il limite, condizione per
7
rispondere sinceramente “eccomi” al volto che mi fa visita .
Eppure, “un punto resta comunque assodato: di fronte
allo straniero, cede ogni possibile linguaggio dell’unicità”8.
Lo “straniero” ci inquieta perché rivela la nostra stessa
estraneità, la non coincidenza interna a noi stessi, poiché
l’identità non è un dato da cui si possa partire, quanto
piuttosto il risultato di un cammino attraverso il quale si
giunge a riconoscere la propria identità soltanto attraverso
la relazione con l’altro uomo9.
La presenza dell’altro, dello “straniero” ci costringe a
ridestare una capacità e una necessità ormai sopita, anzi
7
S. Curci, Pedagogia del volto. Educare dopo Lévinas, editrice Missionaria Italiana,
Bologna 2002, p.109.
8
U. Curi, Straniero, Raffaello Cortina, Milano 2011, p. 13.
9
Cfr. M. Ghilardi, Filosofia dell’interculturalità, Morcelliana, Brescia 2012, p. 131.
160
repressa in noi, ossia quella di comunicare. Il sorgere di
questo bisogno fa paura, rende nudi, depaupera
l’individualità di ciascuno di noi. Di fronte a
quest’atteggiamento è significativa la trasmutazione di
senso dei termini “compassione” e “misericordia”, i quali
appaiono sempre più desueti, privi di consistenza o intesi
come stati d’animo dal sapore esclusivamente
sentimentalista. Gli studi più recenti nel settore delle
scienze umane si sono sforzati di plasmare un nuovo
paradigma di Vita nella forma della compassione come
“capacità di comprensione”, giacché “l’empatia è atto
originario in primo luogo perché è atto di costituzione
dell’altro da me come soggetto che ha parte al mio stesso
mondo; ma soprattutto perché la costituzione dell’altro io
è la condizione di possibilità per la costituzione del proprio
io”10.
Il teologo Walter Kasper in Misericordia. Concetto
fondamentale del Vangelo – chiave di vita cristiana opera che sembra aver sollecitato il pontificato di papa
Francesco11 -, con grande lucidità e arguzia sottolinea
l’urgenza della promozione del concetto di humanitas
attraverso “relazioni empatiche”. In uno dei passaggi
introduttivi, il teologo afferma che:
Entrare nel mondo dei sentimenti, dei pensieri e della vita di un’altra
cultura e di un altro popolo è inoltre un presupposto fondamentale per
un incontro interculturale, per stabilire un clima di pace e di
10
A. Bellingreri, Il superficiale, il profondo. Saggi di antropologia pedagogica, Vita e
Pensiero, Milano 2006, p. 31.
Mi si permetta questa allusione, dal momento che lo stesso Pontefice, durante il suo
primo Angelus a Piazza San Pietro (17 marzo 2013) esordì di essersi preparato al
conclave leggendo questo libro del cardinale Kasper.
11
161
collaborazione tra religioni e culture e per praticare una politica e una
diplomazia che mirano alla pace [_] Non dobbiamo intendere il
termine compassione solo nel senso di un comportamento
compassionevole, ma in esso devono echeggiare anche il termine
passione e un comportamento appassionato di fronte alle ingiustizie
colossali che esistono nel nostro mondo, così come deve echeggiare
12
l’invocazione della giustizia .
Il secolo in cui viviamo ci obbliga a una serie di
considerazioni sulla Misericordia. Il monito è immediato:
“In effetti, - continua il cardinal Kasper - dovremmo tacere
su Dio, se non sapessimo annunciare di nuovo agli
uomini immersi in tanta miseria fisica e spirituale, il
messaggio della sua misericordia. Dopo tutte le
esperienze del XX secolo e dopo quelle dell’appena
iniziato XXI secolo la questione della misericordia di Dio e
degli uomini misericordiosi è oggi più urgente che mai”13.
Imparare a guardarsi dal di fuori
Antonio Bellingreri14, da molto tempo versato nello studio
dell’empatia quale virtù pedagogica, sostiene che “è
possibile leggere la storia dell’educazione e della
pedagogia sub specie emphatheias”15. In verità,
percorrendo le analisi di Edith Stein, filosofa formatasi alla
12
W. Kasper, Misericordia. Concetto fondamentale del Vangelo – chiave di vita
cristiana, Queriniana, Brescia 2013, p. 33.
Ivi, p. 14.
14
Il professore Antonio Bellingreri, ordinario di Pedagogia Generale presso l’Università
degli Studi di Palermo, ha tentato di rintracciare nel cammino biografico e teoretico di
Edith Stein “una via pedagogica per la conoscenza della persona”. Oltre al già citato Il
superficiale, il profondo. Saggi di antropologia pedagogica, si rimanda anche al suo
Per una pedagogia dell’empatia, Vita e Pensiero, Milano 2005.
15
A. Bellingreri, Il superficiale, il profondo, p. 48.
13
162
scuola del padre della Fenomenologia Edmund Husserl, è
possibile “interpretare la relazione educativa come
relazione empatica e di riconoscimento reciproco, nella
quale ciascuno, in virtù dello sguardo dell’altro è aiutato
nella costituzione del proprio sé autentico”16.
Con il termine empatia intendiamo dunque un ‘modo di
sentire’ che facilmente è riconoscibile in ogni azione
educativa, con un rimando immediato alle relazioni di
prossimità.
L’empatia, ovvero l’atto di entrare in rapporto con l’altro,
delinea un modello di reciprocità nella relazione, giacché:
“il passaggio dall’ottica dell’identità a quello della
differenza [_] implica una fase iniziale di decostruzione
per accedere a nuovi modelli e a nuovi percorsi che per
comodità
possiamo
racchiudere
nella
formula:
educare/educarsi a partire dall’altro. “A partire dall’altro” è
un’espressione e una disposizione che nell’apparente e
tranquilla ovvietà è invece indice di un “decentramento”,
di uno spostamento della soggettività. Occorre spostare il
punto d’osservazione, imparare a guardarsi dal di fuori”17.
Il processo pedagogico che si vuol mettere in evidenza
muove da un concetto di identità pensata come
dimensione “corale”, aperta e sempre rivolta all’ascolto, al
rispetto dell’alterità, del riconoscimento, al valore della
differenza, alla disponibilità al dialogo e al confronto. Tutte
queste categorie, come le tessere di un mosaico, recano
un prezioso contributo all’opera di umanizzazione della
16
Cfr. Ivi, pp. 19-20.
E. Baccarini, La persona e i suoi volti. Etica e antropologia, Anicia, Roma 1996, p.
151.
17
163
vita ed escludono ipso facto ogni schema chiuso e antidialogico.
Attraverso l’idea di Persona come centro di relazioni, si è
portati a un orientamento in interiore, all’incontro-scontro
con un cum che rafforza l’ego in nome di una coralità che
conduce all’abbattimento dei confini tra l’io e l’altro, per
una vera e propria costituzione dell’essere umano come
“con-essere-nel-mondo” o – detto in termini capitiniani “compresenza”18.
Detto altrimenti: “prendendo le distanze da se stesso,
aprendosi al tu dell’altro, ognuno trova un sé più vero ed è
questa accoglienza dell’altro, questo abbandonarsi e
aprirsi al dono rappresentato dalla presenza dell’altro che
fa sorgere in lui una nuova speranza, una nuova
possibilità di creare un maggiore accordo, una vera unità
con tutti gli esseri”19.
La scoperta dell’io come coralità ha delle ricadute sul
piano pratico. Infatti, le principali potenzialità dell’essere
umano si manifestano nell’attitudine a comunicare, a
entrare in rapporti simbolici con l’altro20; questo porta
l’educatore a raccogliere le molteplici domande
provenienti dal vissuto dell’educando, come l’unica
“Domanda” e prostrarsi in ascolto della sua esperienza
vissuta.
È questo l’approccio da usare per l’intero percorso
paideutico, coscienti del fatto che “La domanda - scrive la
psicoanalista François Dolto - non è, infatti, che la punta
18
Cfr. A. Capitini, La compresenza dei morti e dei viventi, Il Saggiatore, Milano 1966.
L. Romano, La pedagogia di Aldo Capitini e la democrazia. Orizzonti di formazione
per l’uomo nuovo, Franco Angeli, Milano 2014, pp. 41-42.
20
Cfr. G. Chiosso, Il Novecento pedagogico, La Scuola, Milano 2012, p. 273.
19
164
di un iceberg fatto di emozioni, affetti, attese che
all’educatore spetta non spegnere, prendendo soltanto in
considerazione la parola, ma da ravvivare e arricchire in
modo da rendere ciascuno padrone della propria
esperienza”21.
Il valore dell’empatia nella rel-azione educativa
Un’educazione empatica istituisce tutta una serie di
processi e di funzioni diverse. In primo luogo, la
condizione per ascoltare l’altro - il punto di partenza di
ogni processo educativo nella forma empatica - è iniziare
la prassi educativa con un’epochè, un’operazione
fenomenologica del “mettere tra parentesi” quei pregiudizi
immediati che l’educatore ha acquisito a riguardo
dell’educando. In secondo luogo occorre mettere in chiaro
due aspetti caratterizzanti la relazione empatica:
1) l’immedesimazione con l’esperienza dell’altro
(sentire se stesso dentro le esperienze dell’altro);
2) la comprensione emozionale (una conoscenza
emotiva dell’altro).
Per rendere in modo icastico la categoria di empatia qui
rielaborata e offerta, la si potrebbe compendiare con
l’espressione sentire l’altro: “L’empatia – scrive Laura
Boella - insegna che tra gli esseri umani c’è una
circolazione di senso per cui ciò che viviamo di persona si
completa e si integra con ciò che si apprende
riconoscendo ciò che vivono gli altri. Ciò che non ci
21
Ivi, op. cit., p. 272.
165
appartiene, che è fuori di noi e forse anche estraneo,
nell’empatia diventa relazione, parola, ascolto”22.
Tuttavia, nella relazione empatica si evince in modo
eminente la costituzione polare dell’antropologia, per cui
si oscilla tra ciò che è in noi (interno) e ciò che è aldilà di
noi (esterno). Ciascun educatore si trova dinanzi questo
tipo di comprensione “affettiva” dell’interno, accogliendo
l’idea che l’“interno” si mostra a noi solo tramite delle
tracce23.
La psicologia dello sviluppo ha rilevato che già dal primo
anno di vita il bambino sperimenta “forme di empatia”.
Quella immediata è indubbiamente l’idea di “fusione” che
il bambino ha con la madre nella forma della “sintonia”. La
placenta è il primo luogo “che non appartiene né all’uno
né all’altro, ma permette la loro co-esistenza, garantisce
cioè l’esistenza di entrambi, ovvero la loro relazione”24.
Il punto d’inizio, di là da una simbologia evocativa
dell’universo femminile, inquadra la relazione educativa in
chiave generativo-ermeneutica, ossia a partire da un
rapporto uterino, poiché si è “chiamati a dare alla luce”.
Ebbene, “la nascita non è fine a se stessa, ma è l’accesso
a una realtà comunionale già implicata nel dato per cui
ciascuno di noi è in qualche misura responsabile di
favorire o di ostacolare la nascita dell’altro [_] L’esistenza
umana è un cammino di possibile nascita radicale”25.
22
L. Boella, Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, Raffaello Cortina editore,
Milano 2006, p. 83.
23
L’osservazione esterna è sempre un lavoro “delicato” di discernimento atto a
garantire l’alterità dell’altro.
24
L. Irigaray, L’ospitalità del femminile, il melangolo, Genova 2014, p. 14.
25
R. Mancini – F. Falappa – C. Canullo – S. Labate, Per un’antropologia della
creaturalità, il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009, p. 41.
166
D’altronde, “focalizzare l’attenzione sulla nascita come
paradigma della nostra condizione riporta un’attenzione
più lucida sul nostro essere-con-l’altro, per cui nessuno
nasce da solo e fin da principio siamo connotati da una
relazionalità ontologica”26.
L’atto del “dare alla luce”, infatti, non è una azione che
accade e si compie una volte per tutte: “la generazione è,
piuttosto, un’azione iterativa. Ogni azione - scriveva
Hannah Arendt - ha almeno due movimenti: il primo è
quello dell’archein, ossia del dare inizio e del generare;
l’altro è quello del prattein, ossia del far durare e del
portare a compimento. In breve: ciò che è stato fatto,
dev’essere continuamente “fatto essere” mediante la
cura, mediante l’educazione [_]”27.
L’attenzione per l’altro necessita una traduzione in
accoglienza, cura, accompagnamento, dal momento che
la persona non è un dato da registrare e da analizzare,
ma un essere vivente da scorgere e cogliere nel suo
essere reale, per accompagnarlo in un vero e proprio
cammino di personalizzazione28. Ed è proprio a partire dal
“grembo” che percepiamo l’essere custoditi e l’essere
amati29. Detto sinteticamente:
26
Ivi, p. 42.
M. Semeraro, La chiesa come «pedagogia di Cristo in atto»: una consegna
ininterrotta, in: UFFICIO C ATECHISTICO NAZIONALE, Incontriamo Gesù. Annuncio e
catechesi in Italia alla luce degli orientamenti nazionali, EDB, Bologna 2014, p. 22.
28
Nell’assumere il processo educativo come “cammino di personalizzazione”, vanno
segnalati, inoltre – ispirati dal personalismo di Emmanuel Mounier - alcuni atti originali
fondamentali per la costruzione di una relazione profondamente “empatica”, sono:
uscire da sé, comprendere, prendere su di sé, dare, essere fedele.
29
Cfr. M. Semeraro, Il ministero generativo. Per una pastorale delle relazioni, EDB,
Bologna 2016, p. 25.
27
167
L’educando è accolto in primo luogo per quello che egli è
effettivamente, il suo io reale; è necessaria qui quella competenza
che in psicoterapia viene definita “accuratezza empatica” [_]
L’educatore però accoglie e comprende l’educando oltre ciò che
egli è, lo vede in ciò che può essere e in ciò che deve essere: nel
suo sé autentico [_] L’educatore che, incontrando l’educando [_]
lo accoglie come un bene in sé, incomparabilmente prezioso, per
la sua esistenza attuale, ma anche per il suo compimento
secondo la forma propria. L’educatore grazie all’empatia vede
l’altro come soggetto proteso verso una sempre più compiuta
30
unità di senso.
L’idea di fondo che soggiace al processo educativo
pensato cammino di personalizzazione è quella di
ritrovare la forma, l’unità nel tutto, non ridurre l’altroeducando a sé, né tanto meno di eliminarlo come altro.
168
Il dialogo come scelta etica
Per meglio interpretare “l’empatia come categoria
pedagogica”, mi piace ricorrere, a guisa di esempio, allo
stile “empatico” di Papa Francesco. In una catechesi
rivolta ai parroci della diocesi di Roma ebbe a dire:
La vera Misericordia si fa carico della persona, la ascolta
attentamente, si accosta con rispetto e con verità alla sua situazione,
e la accompagna nel cammino della riconciliazione. E questo è
31
faticoso, sì, certamente .
30
A. Bellingreri, op. cit., pp. 64-65.
Francesco, Discorso del Santo Padre Francesco rivolto ai parroci di Roma giovedì 6
marzo 2014.
31
Il gesto del “farsi carico” caratterizza, identifica e qualifica
la relazione educativa ricca di umanità proposta e seguita
dalla Chiesa, dal momento che qualsiasi sua attività ha
come
obiettivo
la
Persona.
Il
cammino
dell’accompagnamento si risolve nella pazienza, nella
hypomoné, che segue pedissequamente i processi senza
bistrattare i limiti32. Questo iter relazionale deve essere
continuamente capace di ri-conciliazione. Così come
Gesù racconta nella parabola del servitore spietato, il
primo modo di vivere il perdono è la pazienza, e insieme
a questo la pietà, l’immedesimazione (Mt 18, 23-34)33,
tutti atteggiamenti che ciascuno è chiamato a rivivere
quotidianamente nella propria parabola esistenziale.
Il concetto di “prossimità” non è da considerare solo come
un appello agli uomini a vivere umanamente, ma è
centrale perché rimanda al senso dell’esistere. Senza
l’altro, il mio io non può esistere. È l’altro che in forma
dialogica fonda e distingue la mia identità. È lo stesso
papa Francesco ad affermare che “la vicinanza crea
comunione e appartenenza, rende possibile l’incontro. La
vicinanza acquisisce forma di dialogo e crea una cultura
dell’incontro”34.
L’educazione empatica, pertanto, che coincide con una
“educazione al dialogo”, esige un’educazione all’ascolto35
32
Cfr. Francesco, Dio nella città, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo (Mi) 2013, p.
48.
M. Naro, art. cit., p. 85.
34
Francesco, Decifrare la fuga di tanti fratelli, in Il Regno LVIII (2013) 15, p. 467. Nel
citare questo passaggio il teologo pastoralista Carmelo Torcivia afferma che «si tratta
di un discorso importante perché il Papa svolge la sua personale ermeneutica del
documento di Aparecida». In: G. Alcamo (cur.), Con il cuore di Padre. Rivelazione di
Dio e stile pastorale per la Chiesa, Paoline, Milano 2016, p. 248.
35
Cfr. A. Bellingreri, op. cit., p. 77.
33
169
in tutto il processo pedagogico: “l’esistenza autentica si
costruisce attraverso il dialogo che, per Buber, è il fulcro
su cui si fonda l’incontro e la base di tutte le dinamiche
della relazione educativa. È una critica al soggettivismo,
in quanto non si può riconoscere l’invito che si presenta
all’uomo nel volto di un’altra creatura”36.
Il verbo ascoltare ridisegna spazialmente la relazione
dell’uomo-con-l’uomo come capace di co-esistere nella
stessa “comunità”, ridisegna una nuova geografia la cui
coordinata non è quella del “contro” (homo homini lupus)
ma quella dell’ “accanto” (homo homini frater).
Aprirsi alla voce del “diverso” significa pertanto mettersi in
ascolto di ciò che può sconvolgere i nostri schemi, far
crollare le nostre certezze, provocare in noi
disorientamento. Significa dar spazio alla poiesi di una
nuova forma comunicativa per accogliere e comprendere
quanto è impossibile esaurire in una prospettiva
prettamente individualistica ed egocentrica. Un vero e
proprio decentramento del Soggetto che sovente
compare
nelle
proposte
filosofiche
dell’età
contemporanea.
Scrive diligentemente Laura Boella:
Esplorare l’esperienza dell’altro come possibilità interna alla nostra
esperienza, e che ne coinvolge l’intero orizzonte cognitivo, emotivo e
volitivo, apre una serie di nuovi profili del mondo. Riconoscere la
presenza dell’altro non è infatti solo un atto che riguarda il soggetto.
L’altro viene riconosciuto anche come esistente di per se stesso.
Viceversa, alle prese con l’altro, l’io si scopre ricettivo, non più
36
V. A. Donatello, Guardando all’altro mi scopro onni-debole anch’io...piuttosto che
onnipotente. Per un umanesimo davvero “inclusivo”, in: “Itinerarium” 23 (2015/3) 61,
pp. 73-84.
170
esclusivo padrone di se stesso. Come se nel reciproco
37
riconoscimento avvenisse una nuova nascita per entrambi .
L’atto di “entrare in rapporto con l’altro” e di scorgerlo
nella sua situazione, nei suoi sentimenti, per meglio
cogliere il suo modo di pensare, di guardare la realtà, di
comportarsi è la via maestra per costruire le relazioni
intersoggettive. Mettersi in ascolto è già com-patire,
ospitare, “aprire all’altro il proprio spazio interiore”38.
Con lo sguardo rivolto alla fragilità
Questa indagine sull’empatia sollecita una rinnovata
comprensione della comunicazione e della prassi
pastorale della Chiesa.
Sebbene il Giubileo straordinario della Misericordia
termini de iure il 20 Novembre 2016, de facto i suoi effetti
e i suoi frutti sono destinati ad informare vita natural
durante le “azioni”39.
Ci è lecito chiederci, alla luce di tali considerazioni, cosa
c’entra in tutto questo la Misericordia e come, eretta a
virtù pedagogica, può contribuire a trasfigurare, per
meglio abitare, le nostre relazioni educative?
La Misericordia interpella le nostre relazioni e ciò trova
giustificazione nel fatto che “il mistero della fede cristiana
sembra trovare in questa parola la sua sintesi”40. La
37
L. Boella, op. cit., XXIX.
E. Hillesum, Diario 1941-1943, a cura di J. G. Gaarlandt, Adelphi, Milano 1996, p.
49.
39
Quando ci si riferisce all’Azione non si vuole intendere la semplice gestualità,
espressività semplicisticamente detto, ma l’azione intesa come la “forma dell’umano”.
40
Francesco, Misericordiae Vultus, n° 1.
38
171
Misericordia
è
“istanza
motivante”41,
“categoria
generatrice”42, “forma della fede” e deve incarnarsi come
“stile” e “prassi”.
L’atteggiamento etico-pedagogico è da individuare in
questa dinamica tipica della Misericordia cristiana di
entrare in rapporto con l’altro, accompagnarlo e
prendersene cura.
Prima di ogni contenuto da veicolare, bisogna pensare al
modo in cui farlo. E pensare il modo significa, in altre
parole, avere a cuore la relazione educativa come canale
con cui possiamo giocarci ciò che la Dolto definiva
“umanizzazione della vita”. Un vero e proprio richiamo
etico-esistenziale alla cura dell’uomo “che ho in carico”43.
È la condizione stessa di fragilità in cui si trova l’uomo che
impone la necessità della cura e dell’attenzione reciproca.
La fragilità in sé, dunque, c’impegna alla cura, poiché
riecheggia la nostra condizione di finitudine umana. Ciò
che è fragile, tuttavia, assurge anche a qualcosa di
prezioso. Difatti, fragile e prezioso assumono il carattere
di un’endiadi in cui può riassumersi l’“identità paradossale
dell’umano”44. La “fallibilità e vulnerabilità, [_] sono la
testimonianza tangibile di un’antropologia del fragile, che
fa scendere il soggetto dal piedistallo dell’autosufficienza,
esponendolo al duplice vincolo – attivo e passivo –
41
M. Naro, art. cit., p. 57.
Espressione coniata dalla teologa Stella Morra. Per un approfondimento, si rimanda
alla lettura dell’articolo citato di Naro.
43
Si consideri l’ampia riflessione attorno al concetto di responsabilità nel ‘900 filosofico.
44
L. Alici, Il fragile, il prezioso. Bioetica in punta di piedi, Morcelliana, Brescia 2016, p.
37.
42
172
dell’aiutare ed essere aiutato”45. Ciò che è “fragile” è
degno di cura ed esige la nostra responsabilità.46
In prossimità del Convegno delle Chiese d’Italia di Firenze
(9 - 13 novembre 2015), Ernesto Diaco scriveva che:
Dopo la fine delle grandi costruzioni ideologiche e pienamente
immersi nel vortice narcisistico dell’auto-comunicazione odierna,
c’è grande bisogno di un aiuto a saper guardare le dimensioni
deboli della vita, a prendersi cura delle sue immancabili ferite, ad
accompagnare la vulnerabilità dell’essere umano con una cultura
del contatto, della sensibilità, della compagnia. Si tratta, spiega il
teologo austriaco K. Appel, di mostrare che il contributo del
cristianesimo a un nuovo umanesimo è nella fragile, spesso
fungente, narrazione della genesi di uno sguardo rivolto alla
fragilità, alla vulnerabilità, anche alla sensibilità e al sottrarsi
dell’esistenza umana. La parola cristiana centrale, “misericordia”,
47
ne dà testimonianza .
173
Ad ogni uomo è chiesto di “trasformare” i luoghi che
abitiamo in “luoghi elettivi della cura, dove la reciprocità
sperimenti ogni giorno il miracolo della restituzione: unica
replica morale di cui le persone umane sono capaci, per
vivere all’altezza del loro essere: fragile e prezioso”48.
Il paradigma relazionale espresso nel “sentire l’altro” ci
chiede di passare per la strada dell’amore
compassionevole, sì da “non vivere come l’altro né vivere
45
Ivi, p. 37.
Papa Francesco si è più volte soffermato sull’immagine di chiesa come “ospedale da
campo”, la cui missione specifica è quella di prendersi cura soprattutto dei feriti (poveri,
migrati, disabili, malati, divorziati, omossessuali).
47
E. Diaco, La chiesa italiana a Firenze: l’umanesimo della prossimità, in:
“Itinerarium” 23 (2015/3) 61, pp. 61-72.
48
Cfr. L. Alici, op. cit., p. 210.
46
con l’altro, ma vivere per l’altro: perché possa fiorire ed
essere in pienezza”49.
Tutto questo, trasposto in ambito ecclesiale-pastorale,
può contribuire all’abnegazione di un volto di Chiesa
rigido, perché essa, tramite il nostro essere-agire “ha
corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera”,
dunque è “una Chiesa lieta col volto di mamma, che
comprende, accompagna, accarezza”50.
Si può pertanto dire che “la Misericordia è tutto ciò che è
essenziale alla vita. La Misericordia è un fatto di grembo e
di mani. Dio perdona così: non con un decreto ma con
una carezza”51.
L’ascolto e il contatto, o diversamente l’incontro,
traducono l’atto che sovente è stato definito “empatia”, un
atto che interessa tutti i processi cognitivi, affettivi che
afferiscono a tutte le condizioni sociali. Credo siano i due
principi significativi” per additare una vera “conversione
pastorale” delle e dalle relazioni52.
L’accompagnamento pastorale deve trovare le proprie
fondamenta nell’humus antropico, perché nell’uomo
stesso esso può trovare le proprie risorse: “Quello da
cercare è il domandare vitale, cioè quello che si mette in
ascolto delle questioni essenziali, essenziali sono quelle
49
A. Bellingreri, op. cit., pp. 235-236.
Discorso di Papa Francesco a Firenze, apertura dei lavori.
51
E. Ronchi, Le nude domande del Vangelo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2016, p.
154.
52
La relazione empatica addita una conversione dell’intelligenza e del cuore ed ha
come scopo la “comunicazione interpersonale”. H. Franta, parlando del dialogo e
dell’ascolto nel rapporto educativo-empatico, propone quale compito prioritario quello
di educare la comunicazione. Questa, attraverso dei training di addestramento, può
diventare descrittiva e non giudiziaria, orientativa e non direttiva, flessibile e non
dogmatica, paritetica e non gerarchica, coinvolta e coinvolgente, non neutrale e, da
ultimo, spontanea in quanto non «costruita». A. Bellingreri, op. cit., p. 78.
50
174
che hanno a che fare con il nostro esserci, quelle
questioni che sentiamo necessario frequentare poiché ci
aiutano a trovare la giusta misura per abitare la
condizione umana”53.
Conclusione
La modalità del mettersi “in ascolto dell’altro” si propone
come chiave ermeneutica di una Chiesa che vive non
narcisisticamente paga della propria immagine, bensì
innestata e incarnata in uno spazio, consapevole del fatto
di essere-segno, misericordiosa e foriera di una prassi
ecclesiale che nasce e si nutre dalla missione54. La
Chiesa è chiamata, per prima, a prendersi cura degli
uomini e delle donne a costo di accidentarsi in un
movimento di “conversione” per una nuova e continua
epifania55.
Mi pare che l’esortazione apostolica Evangelii gaudium
delinea una traiettoria chiara da seguire. Così ci
ammonisce il papa:
53
L. Mortari, Un metodo a-metodico. La pratica della ricerca in Maria Zambrano,
Liguori editori, Napoli 2006, p. 133.
54
La chiesa è colta a partire dalla missionarietà. Cfr. Francesco, Evangelii Gaudium.
Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre
2013, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, pp. 54-56.
55
Si tratta di cominciare a pensare “un umanesimo nuovo che diviene autoespressione dell’ascolto delle dimensioni che intersecano l’uomo, per potersi tradurre
in tutti gli ambiti della fede comune (teologia, diaconia, magistero, azione pastorale,
diritto). Occorre riscoprire tutta l’umanità di Gesù nel dialogo col mondo, assumendo
una disposizione kenotica per meglio “entrare in rapporto con l’altro”, incidere sulla
realtà, per manifestare che è ancora possibile riconciliare l’uomo con l’altro uomo,
l’uomo a Dio, l’uomo a se stesso”. G. Pitarresi, Dire l’uomo nell’epoca della ‘crisi’. Per
un umanesimo in ascolto “dell’urlo dell’uomo solo”, in “ITINERARIUM” 23 (2015/3) 61,
p.44.
175
In una civiltà paradossalmente ferita dall’anonimato e, al tempo
stesso, ossessionata per i dettagli della vita degli altri,
spudoratamente malata di curiosità morbosa, la chiesa ha bisogno
di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e
fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia necessario. In questo
modo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono
rendere presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il
suo sguardo personale. La chiesa dovrà iniziare i suoi membri [_]
a questa arte dell’accompagnamento, perché tutti imparino
sempre a togliersi i sandali davanti la terra sacra dell’altro (cfr. Es
3,5). Dobbiamo dare al cammino il ritmo salutare della prossimità,
con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel
medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita
56
cristiana .
Con sguardo di vicinanza, rispettoso e pieno di
compassione: con questa misura è pensabile e
possibile una vera rivoluzione pastorale.
La Chiesa, spinta da questo Giubileo come ad una
conversione uterina, percorrendo la via della tenerezza
e orientata all’essenziale, deve essere capace di
spogliarsi per accogliere, di uscire da sé per essere
restituita a se stessa, di spendersi per assumere su di
sé le debolezze e le difficoltà di tutti e di ognuno in
particolare.
56
Francesco, Evangelii Gaudium, pp. 183-184.
176
Parola, responsabilità, perdono: una premessa filosofica
Romano Romani
La parola è sentiero e luce,
viandante e cielo
La storia degli esseri umani è storia della ricerca della
consapevolezza del bene e del male che essi hanno
compiuto e compiono. Nella totalità dei suoi aspetti, la
ricerca della consapevolezza è l’uomo nella sua umanità.
Poiché in ciascun uomo e negli uomini alla
consapevolezza corrisponde una inconsapevolezza e
anche il disumano, così, è dell’uomo.
Gli esseri umani possono compiere il bene e il male,
innanzitutto perché esistono, ma possono esserne
consapevoli o inconsapevoli perché parlano: la parola
implica in ciascun uomo e negli uomini la responsabilità
delle proprie azioni individuali e collettive. La
responsabilità di individui di altre specie animali, del loro
comportamento, sta sempre e unicamente dentro la
parola e la coscienza degli uomini.
Il bene e il male, dunque, esistono nella coscienza che se
ne ha. Al di fuori di tale consapevolezza essi non sono
che degli accadimenti privi, di per sé, di un significato
positivo o negativo. In natura, ovviamente, la positività o
177
negatività di un accadimento si dà sempre nel rapporto a
un vivente o al vivere. Nel caso del bene e del male nella
loro radicalità, il vivere è rappresentato per gli uomini dal
rispetto – bene - o dalla trasgressione – male – della
legge.
Nel suo essere legislatrice, dunque, la parola è costitutiva
del mondo. Ma anche: nel suo essere costitutiva del
mondo, la parola è legislatrice. Il mondo è conoscibile
dall’uomo perché è stato – è – costituito dalla parola.
Conseguenza necessaria di quanto ho scritto sopra, è
che gli esseri umani concepiscono sia la natura che la
loro società – le loro società – come regolate da leggi: la
prima – la natura – da leggi la cui forma resta sempre un
passo al di là della nostra possibilità di conoscerle, la
seconda – la nostra società – da leggi stabilite o da
stabilire, nella consapevolezza che la loro forma tende a
una perfezione che non potrà mai essere raggiunta. Una
consapevolezza non innata e naturale, ma acquisita con
sofferenza e innumerevoli ricerche, rivolte, cadute.
Il vuoto di conoscenza delle leggi della natura e quello
delle leggi che delimitano le società umane viene riempito
nell’animo umano e nella storia degli uomini, dal
sentimento e dall’idea del divino.
Questo sentimento e questa idea appartengono ad ogni
cultura e a ogni essere umano. Così come a ogni cultura
e a ogni essere umano appartengono la tensione al
conoscere e quella alla libertà e alla giustizia: per giustizia
deve intendersi qui la pace tra gli uomini e l’armonia degli
uomini con gli altri viventi.
Quanta è la distanza delle società umane, nella loro storia
e nel presente, da questa pace e questa armonia? Da
178
cosa deriva questa distanza? Quanto sono consapevoli
coloro che questa distanza mantengono e accrescono,
del male che fanno? Come reagire all’inconsapevolezza
con la quale gli esseri umani operano il male se non a
partire dal loro desiderio di divenire sempre più
consapevoli, che è desiderio e bisogno del bene? E
andare verso questo desiderio, riconoscerlo come
l’autentica natura di ogni uomo e dell’uomo, non è forse
perdonare?
Questo mi sembra debba essere il modo di intendere non
soltanto il senso del reciproco perdono degli uomini, ma
anche quello della misericordia di Dio, nella presenza
della quale consiste la speranza in un mondo migliore.
179
Con il volume Ultimes réflexions Marcel Conche presenta
le sue riflessioni “ultime”(?), dato l’approssimarsi del suo
novantaquattresimo compleannoanno e preoccupato – lo
dichiara nella breve prefazione ( pp. 5- 8 ) – che un
possibile deteriorarsi delle sue facoltà di giudizio possa
nuocere alla sua prospettiva filosofica. Percio’ confessa: “
Non posso più fidarmi del mio giudizio e rimango
sconvolto quando dubito di potere fidarmi ancora del mio
sapere” ( p.5). Sarebbe necessario il giudizio imparziale di
un giudice per incoraggiarlo a ricercare una più articolata
prospettiva filosofica o per dissuaderlo a continuare nella
sua attività, più che sessantennale, magari dopo una
pausa. Ma un giudice siffatto non esiste neppure per un
filosofo che, prigioniero dei propri pregiudizi, tendesse a
considerare “saggia” la soluzione proposta da un filosofo
che crede in Dio, la cui esistenza Conche nega
180
RESOCONTI
RÉFLEXIONS SU MARCEL CONCHE
Santo Arcoleo
180
risolutamente1. Un giudice imparziale potrebbe essere chi
mostrasse “di avere delle affinità “ con il suo pensiero,”
1
In molte pagine delle sue opere e nei colloqui privati , Conche ha sempre sostenuto
di considerarsi “agnostico” piuttosto che “ateo.”.Nel saggio Philosopher à l’infini ( PUF,
Paris 2005), ripercorrendo
le tappe della sua formazione, scrive: ”Sono stato
educato spiritualmente nella religione cristiana cattolica. Mi hanno insegnato che
“Dio” ha creato dal nulla il Cielo e la Terra, e successivamente , dopo la luce, il
firmamento, i pianeti, gli esseri viventi dell’acqua e dell’aria, l”uomo a sua immagine e
somiglianza; e che l’uomo ha disobbedito a Dio; e che la colpa di Adamo ha
introdotto nel mondo il male, il dolore e la morte” ‘( p.12). Un Redentore, venuto a
salvare l’uomo, é all’origine di questa riflessione: Dio, il mondo, l’uomo sono
l’esistenza, dalla quale nasce l’idea del Tutto, “ossia’l’infinito.” Conche enuncia una
verità diversa : Dio diventa una terribile minaccia per i peccatori e nello stesso
tempo una promessa di vita eterna ”felice” per le anime dei defunti- almeno per le
anime dei giusti” (p. 12 ). Nella sua infanzia e nella prima giovinezza Conche vive
,con paura “superstiziosa ,“la fede in Dio, realtà senza amore e sente estranea la
figura di Cristo, Dio fatto uomo, redentore, salvatore dell’umanità.” Il dogma cristiano
é ritenuto “un cumulo di credenze imposte”, la stessa bontà di Dio gli sembra
incompatibile con la sofferenza che c’é nel mondo, un aspetto approfondito in
Orientation philosophique ( PUF, Paris 1990), principalmente nel capitolo :La
Sofferenza dei bambini come male assoluto(pp. 41- 59). “ Perché privileggiare la
sofferenza dei bambini?Forse che gli adulti non ne conoscono altrettanto atroci? Di
queste sofferenze “esiste...una differenza radicale...L’adulto si mantiene lontano dalla
sua sofferenza. È “spavaldo” davanti al dolore, o lo “sopporta” pazientemente ,
disperandosi. Ma il bambino che soffre “ nudo, disarmato, dipendente, fiducioso,
stupito, suscita una pietà infinita . Abituato ad essere liberato dal male dalla forza
dell’amore da cui si sente protetto ed a vedere le difficoltà risolversi grazie alla virtù
dell’amore, il dolore lo sorprende. Non ha vacillato fuori dalla sfera materna,non é
caduto e, nella solitudine e nell’abbandono, di essersi abbandonato, di essere rinato,
egoista e segreto, volitivo e libero,creatore di se stesso.Avendo il suo centro ancora
fuori di sé, travolto dal dolore, non sa a chi rivolgersi. Accettare il faccia a faccia con il
dolore, sarebbe circoscriverlo, limitarlo . Al contrario egli si lascia assorbire da esso ,
come dall’illimitato”(pp.41-42). Conche, richiamando le tesi di Agostino, di Pascal e
di Kant, vuole indagare sulla sofferenza: la morte degli adulti per lui é uno scandalo
meno grave di quella di un solo bambino torturato. Egli distingue fra “ bambino” e
“innocente”: non ci é consentito subordinare la nostra disapprovazione ed il nostro
orrore alla soluzione di qualche altro problema, quale : il bambino é colpevole? Allora
puo’ avere un senso la sofferenza dell’innocente (Giobbe, Cristo) Per quanto concerne
il bambino, escludo questa possibilità. Si sente dire: il male non é che privazione,
illusione dovuta al carattere parziale - parziale dal nostro punto di vista sul Tutto-,
dissonanza necessaria dall’armonia universale, ombra in un quadro, momento
dialettico. Ci vuole tutta l’incoscienza di uomini sistematici per eludere in questo modo
la sofferenza dei bambini. Sono dissonanze assolute che rompono l’armonia (pp. 4142).
181
181
quasi un alter ego, che Egli ritiene di aver trovato in una
giovane donna,” mandata dal destino”: Chaïmaa,
studentessa marocchina, affascinata dalle sue opere, a
cominciare da Orientation philosophique2, preludio di un
incontro filosofico profondo con il pensiero e la persona
del Maestro“( p.7) il quale confessa.
Sentivo,leggendo la sua lettera (del 10 ottobre 2013) una forte
emozione creativa. Mi sembrava che Chaïmaa ed io dovessimo
necessariamente fare qualcosa insieme.
Ho deciso, d’accordo con lei, che la sua lettera sarebbe diventata il II
capitolo delle mie Ultimes réflexions e che lei mi avrebbe
accompagnato nel progredire del mio pensiero”(pp. 7-8). In questo
incontro verrebbero poste le basi per una collaborazione avente per
oggetto la verità “comune” ad entrambi, la nostra verità, scrive con
entusiasmo Conche.( p.8). Gli approfondimenti di queste premesse
vengono sviluppati nelle due parti che compongono il volume,
entrambe di XXV capitoli (rispettivamente di pp. 11- 145 e pp.149230), sulle quali verterà la nostra analisi.
Il capitolo iniziale: Flash- Back, una riflessione filosofica
sulle orme di Heidegger, analizza la” questione originaria
2
Su questo interessante scritto,, ripreso, aggiornato ed aumentato nella edizione
Les Belles Lettres, coll. Encre marine 2011 , cf. la recensione di Roger –Pol Droit in
Le Monde del 15/ II/ 1991
182
182
nel senso dell’essere”(p 11), fondamentale per
legittimarne il significato del senso dell’essere”3.
La divergenza con il filosofo tedesco nasce dall’eredità
della comune originaria “obbedienza “ cattolica, con
questa differenza fondamentale: Conche non accetta né il
“creazionismo “ né la tesi dell’”uomo peccatore”.
Fino al 1956, la nozione di Dio sopravviveva in me come una debole
fiammella, ma proprio allora é nata in me l’idea che nella sofferenza
dei bambini ( martirizzati ) c’é la rappresentazione del male assoluto,
incompatibile con l’esistenza di un Dio onnisciente, onnipotente ed
assolutamente buono. A partire da questo momento l’idea di Dio é
scomparsa totalmente dal mio orizzonte intellettuale, e- ne sono
certo-, da quel momento non é più cambiata, perché, come afferma
Nietzsche: “ Dio, non esiste nulla che si possa considerare tale ”.Per
Heidegger invece le cose sono andate diversamente ”[...] Solo chi é
stato radicato nel mondo cattolico, vivendolo realmente, potrà avere
qualche idea delle obligazioni che hanno influenzato il percorso del
mio interrogarmi, che ho vissuto fin qui, come scosse telluriche
sotterranee”.
Orientation philosophique riprende le stesse considerazioni che sono
alla base della sua interpretazione della teologia.“Abbandonata l’idea
di Dio, abbiamo dovuto abbandonare l’idea di Verità (assoluta) , l’idea
dell’uomo ( di uomo-essenza),l’idea di Mondo ( come totalità
significante) nello stesso tempo, dell’idea di Tutto e del livello di
Totalità, dell’idea di ordine, ed in fine, dell’idea di essere (1974, p.
17).
3
Heidegger é stato, nel pensiero di Conche, una “presenza” rilevante , proprio come
un altro grande interprete francese del XX secolo, Jean Wahl. Significativi e
numerosi sono i saggi di quest’ultimo
dedicati ad Heidegger, fra i quali
segnaliamo: Introduction à la pensée de Heidegger-, “Biblio- Essais” Le livre de
poche, Paris
1998, Vers la fin de l’ontologie.- Étude sur l’Introduction à la
“Métaphysique “ de Heidegger, SEDES, Paris 1956) ..
183
183
Abolito Dio, scompare l’ essere e rimane unicamente “cio’
che é” al di fuori di Dio , privo di essenza e che é
qualcosa in sé, senza consistenza ed essenza, mera
apparanza, della quale Hegel aveva già trattato nelle
pagine della Enciclopedia (1830, Add. Par. 112). Alla
fenomenologia dell’apparenza,6 Conche ha dedicato un
suo articolato saggio, nel quale, muovendo dal pensiero
di Pirrone, ha illustrato i fondamenti della filosofia scettica,
origine di “ una nuova nozione di apparenza: non
apparenza-di ( di un essere ) e neppure apparenza – per
(un essere,il soggetto),ma apparenza assoluta.
Diversamente da Heidegger, Conche non indaga sulla
legittimità della nozione “Dio”, ma ritiene più opportuno
interrogarsi sulla legittimità del concetto di “essere” ,
convinto che la sua origine, in Sein und Zeit, sia da
ricercare nel concetto comune di ”essere”. La rapida
analisi del Dasein - di cui trattano le prime due sezioni di
Sein und Zeit - avrebbe dovuto essere una indagine il cui
fine
non era soltanto quello di manifestare il significato temporale
dell’essere del Dasein, ma quello del significato temporale dell’essere
in quanto essere. Il “passaggio dall’esserci all’essere” avrebbe dovuto
essere l’oggetto della terza sezione di Sein und Zeit, che non é stata
7
pubblicata .
Ad esso Conche contrappone il concetto di “totalità”,
assente in Sein und Zeit, e cosi’ che il concetto di Totalità
diventa la prova del suo debito verso Heidegger.
Dasein, - in riferimento al paragrafo 44 di Sein und Zeit,viene tradotto da Conche con il termine“ l’aperto”, che egli
184
184
condivide con la traduzione di Martinaud, che cosi’
commenta l’intero brano:
Alla costituzione di essere del Dasein appartiene essenzialmente
riapertura (Erschlossenheit ) in generale [...] Cooriginario all’essere
del Dasein ed alla sua apertura é l’essere scoperto dell’essente
intramondano. Con i termini “soggetto”, “soggettività”, “coscienza”, “
per sé” , si rischia di chiudersi in se stessi, nel proprio intimo.
Certamente la coscienza “intenzionale” é coscienza di qualche cosa,
ed in questo caso bisogna andare fino alla nozione di “apertura”,
dove si dispiega la verità, con giudizi che sono “ la prova della verità
4
che essi suppongono .
Sensibile allo” charme” femminile5, Conche riprende il
concetto di “philia”6, fondamentale nel suo pensiero 7 e lo
collega alla Lettera di Chaïmaa” (17- 24) giovane
studentessa marocchina che scopre, leggendone le
opere, il maestro “ideale”, la “guida” che dà sicurezza, che
4
M. Conche, Ultimes réflexions, cit., pp. 15- 16.
Le figure femminili ed i valori della “ femminilità ” illuminano momenti fondamentali
della filosofia e della vita e si collegano a suggestioni, che si collegano a significative
reminiscenze letterarie. Sono molte le presenze femminili, ricordate nei suoi scritti ,
ma tre rivestono particolare importanza: Marcelle,la madre morta neldarlo alla luce;
la “nonna Maria”,presso la quale é vissuto nei primi anni di vita e “ Mimi’, la sua sposa,
donna di grande cultura, docente di latino e greco nel liceo di Tulle. Mimi lo ha
educato all’amore per la cultura classica, al gusto per il bello, facendogli scoprire ed
apprezzare i valori formativi delle varie attività spirituali. Molte pagine del volume Una
rievocazione di ricordi dedicati alla nonna “Marie”, alle zie, sorelle della mamma, Alice
e Pauline,e a Marie Thérèse(Mimi) é presente in molte pagine del volume: Épicure en
Corrèze, ( Stock, Paris 2014) nel quale rivivono le drammatiche realà degli anni
1942-44, anni difficili a causa della guerra, durante i quali non solo la formazione
culturale ma la stessa quotidianità erano particolarmente difficili..
6
M. Conche, De L’Amour. Pensées trouvées dans un vieux cahier de dessin,, Les
cahiers de l’égaré, 2003 ; rééd. Cécile Defaut, 2008 ; traduzione italiana: Sull’Amore,
Introduzione e traduzione italiana di S. Arcoleo, Quintessenza, Gallarate( Va ) 2010. Cf
anche: M. Conche, Analyse de l’amour et autres sujets, PUF, Paris 1997, Un vol. di
pp. 112.
7
M. Conche, Devenir grec, in Analyse de l’amour et autres sujets, op. cit., pp.67110,
5
185
185
la esorta ad aderire al “nichilismo ontologico”. Le radici di
questa lettera nascono dall’ascolto di una lezione
dedicata alla mitologia greca che, muovendo dai poemi
omerici, faceva riferimento al tema della saggezza
tragica”, da Conche analizzata nel saggio: Devenir grec8.
ChaÏmaa é affascinata dal mistero tragico, dal quale é
colpita “ la condizione umana”, che suscita in lei un
desiderio immediato: “Mi venne allora una gran sete di
leggervi, in seguito di alcune di queste citazioni”. Ma le
opere di Conche, difficilmente reperibili in Marocco,
richiedevano tempi lunghi per la loro ricezione
”Dopo tre mesi di attesa- scrive Chaïmaa-alla fine arriva il
primo:Tempo e destino, nel quale ho potuto scoprire il suo
pensiero sul tempo e la correlazione con l’uomo, il modo
con cui lei ha eliminato Dio per lasciare spazio alla
Natura, unica creatrice e “poetica”. Debbo a Lei lo slancio
che mi ha permesso di liberarmi dalla religione che rende
ciechi, da questo sentimento di colpa che non ho saputo
superare; negare dio mi aveva tormentato per lunghi anni
ed é grazie a Lei che sono riuscita a condannare dio per
la sua esistenza, ammesso che fosse esistente; poco
dopo ho ricevuto l’Orientation philosophique ed ho potuto
analizzare il suo pensiero attraverso i diversi problemi che
Lei ha messo insieme in questa sua opera”
La giovane studentessa manifesta i suoi progetti
ambiziosi: partecipare al concorso di ammissione alle
“grandes écoles”, trasferirsi in Francia per avviare la
8
M. Conche, Essais sur Homère, PUF , Paris 1999 ; rééd. Coll. Quadrige, Paris 2003.
Cf. la recensione: S. Arcoleo, Poésie et Philosophie. Marcel Conche interprète de
l’Iliade d’ Homère,, Revue philosophique, 1, 2001, pp. 27- 38.
186
186
rivalutazione dell’umano,
mortificato dall’economia.
che
ritiene
attualmente
Per quanto mi riguarda, quello che vedo mi impressiona, mi accorgo
di portare un enorme masso, come Sisifo,- é questa Ia mia situazione
-, salgo sulle montagne,lasciando le pianure, porto il mio masso fino
alla massima pendenza e ridiscendo con una espressione fiera e
degna della mia “condizione umana”. So che mi é negata la felicità,
so che la mia ricerca della verità puo’ rivelarsi un totale fallimento, ma
so che non tornero’ indietro, che scendero’ dalla montagna e
riprendero’ il mio masso, non me ne posso separare, ma so molto più
di tutto questo-e sono d’accordo con l’ affermazione di Camus: “salire
9
verso la vetta più alta basta a riempire il mio cuore di uomo” .
Le riflessioni di Conche sono dei “ segnavie” ed aprono
significative prospettive teoretiche a questa giovane
donna, che, muovendo da esse, desidera valorizzare la
sua scelta di filosofare, nella prospettiva di un “avvenire
aperto”, nel quale scorge la vera “ragione” della filosofia:
saggezza “aperta” che intende sviluppare all’infinito. “ La
ragione apre a Chaïmaa un lungo avvenire, che coinvolge
i suoi “perché infiniti”, di modo che, nel suo cammino,
coinvolge l’infinito.”, commenta Conche, che ritiene la
filosofia una opera non esclusiva della ragione; perché, se
cosi’ fosse, non ci sarebbe alcuna differenza fra filosofia e
matematica, discipline simili ma reciprocamente
autonome: .”.I filosofi che credono in Dio, da Descartes ad
Hegel, ne erano convinti”10. E se , nella loro originalità, i
sistemi di Descartes,Malebranche, Leibniz sono diversi,
essi tendono pero’ad una soluzione “metafisica” quando
9
M. Conche, Ultimes réflexions, op. cit., pp. 22- 23
M. Conche, Ultimes réflexions, op. cit., pp. 25-26
10
187
187
trattano di Dio, che assume, di volta in volta,
caratteristiche che non sono in grado di risolvere, ad
eszempio, il problema del male, quel male assoluto, sul
quale già Agostino aveva espresso la sua perplessità, che
si ripresenta quando si tenta di giustificare le sofferenze
di cui sono vittime i bambini11. Difensore dello spirito ”
libero” da ogni forma di pregiudizio , Conche sostiene che
la filosofia puo’ conciliare il carattere scientifico e la libertà
del filosofo; si tratta di un compito difficile con il quale si
sono misurati, senza riuscirvi, grandi filosofi decisi a
trasformare la filosofia in scienza. Il tentativo di
confrontare, fra le grandi opere filosofiche, i Principia
Philosophiae di Descartes, l’Ethica di Spinoza, la
Monodologia di Leibniz, con gli Elementi di geometria di
Euclide attesta che i testi filosofici non danno prove, ma
sono ricchi di “argomenti”. Apparentemente il cogito, ergo
sum cartesiano puo’ sembrare della stessa natura del
“punto fisso ed assoluto” ipotizzato da Archimede, mentre
per quanto concerne la filosofia l’appello cartesiano alla
11
Ho analizzato la riflessione di M. Conche sulla Shoha nel paragrafo: Le
sofferenze e la vita”spezzata” dei Campi. Riflessioni di Marcel Conche”, alle pagine
287- 295 del capitolo I filosofi del Novecento e la Schoah (pp. 257- 317) del volume
miscellaneo: Tenebre e nebbia contro l’abisso. Aspetti della riflessione storicofilosofica sulla ShoahTesti coordinati e raccolti a cura di Santo Arcoleo,
Quintessenza, Gallarate 2014.
188
188
“libertà che é in noi” ( Principia Philosophiae, I, 6) ci evita
di essere ingannati12.
Nel capitolo III (Prova o argomento? pp. 25- 30) vengono
esaminati i concetti di prova e di argomentazione,
fondamentali per la distinzione fra filosofia e scienza.
L’itinerario filosofico, da Descartes ad Hegel, é
caratterizzato dalla ricerca di una verità unica,
indipendentemente dalle differenze fra i sistemi filosofici,
ma considerare la filosofia una “scienza” potrebbe
snaturarne il significato fondamentale.
Chi dice filosofia dice soprattutto“ metafisica”, che non sarebbe solo
un discorso concernente la Totalità, ma una scienza della Totalità
Ora, in questo caso, la religione, con Dio onnisciente, sarebbe
dimostrabile o confutabile, almeno per quel tanto che ce la presenta
la metafisica- la metafisica creazionista. Pero’ alla religione manca la
13
parte dedicata alla dimostrazione .
La filosofia, che non é opera esclusiva della ragione,
riguarda “l’anima nella sua interezza.”; e, quando
volessimo riferirci alla “bontà” di Dio, dovremmo essere
capaci di “ spiegare la sofferenza, in primo luogo quella
12
Nelle riflessioni e nelle soluzioni che ne danno i filosofi, il problema della libertà si
presenta fondamentale non solo per l’universo politico-filosofico, ma anche per
quello letterario ed estetico, come é accaduto negli anni successivi alla prima guerra
mondiale. I filosofi, da Kant in poi, hanno dedicato, al problema della libertà dell’uomo,
argomentazioni sempre più puntuali, di origine giuridico- normativo e da quello
“passionale”, che , suggerisce Stanley Cavel (Cfr. La Passion, pp.333-386, in AA.VV.,
Quelle philosophie pour le XXIe siècle?- L’organon du nouveau siècle, GallimardCentre Pompidou, Paris 2001.); il “passionale” ha richiesto una maggiore attenzione
a partire dalla filosofia moderna, dalmomento che “ il regno del kantismo e
dell’utilitarismo nella filosofia morale universitaria, ha
avuto la tendenza
a
scoraggiarne l’interesse: il kantismo, a causa della morale austera che richiede;
l’utilitarismo, soprattutto nell’opera classica di Mill, perché la società austera impedisce
ad un gran numero di soggetti di avere passioni ”(p. 341).
13
M. Conche,Ultimes réflexions, cit., p. 26.
189
189
dei bambini” . È con questo argomento che Conche é
convinto di aver cancellato Dio dal suo “paesaggio
intellettuale”, nel quale non esistono elementi che
possano giustificarne l’esistenza, neppure facendo ricorso
alla libertà umana, grazie alla quale possiamo accettare o
rifiutare l’esistenza di Dio. La filosofia, considerata opera
della pura ragione, potrebbe avere un carattere
scientifico, ma
se é vero che alcuni grandi filosofi hanno voluto fare della filosofia
una scienza, nessuno vi riuscito: diversamente si insegnerebbero i
Principia philosophiae di Descartes e l’Ethica di Spinoza allo stesso
modo con cui si insegnano gli Elementi di geometria di Euclide.
Purtroppo non é cosi. I Principia di Descartes, l’Ethica di Spinoza, la
Monadologia di Leibniz, ecc., sono accettati in tale o tal’altro modo,
dalla piena libertà di ciascuno. Sarebbe diverso se queste opere
implicassero delle prove, che obbligano la libertà. Nessuna di esse
14
comporta una vera prova, ma soltanto degli argomenti .
La libertà, tema fondamentale della filosofia, é
“individuale”, legata alla personalità ed alla attività di ogni
singolo filosofo; percio’“ la storia della filosofia” coincide
con la storia di questa “libertà”, che riesce a valutare con
equilibrio il valore delle “emozioni”, che nascono dalla
contemplazione della natura, da eventi che lasciano
un’orma indelebile e da tutte le emozioni “impersonali”,
che danno origine alle idee” (p. 30).
14
M. Conche, Ultimes réflexions, cit., p. 28. Il rapporto filosofia- scienza é stato
chiaramente indicato nel titolo del “ Discours de la Méthode”, che cosi’ enuncia :
“Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les
sciences.
190
190
La libertà é strettamente legata alla morte e
all’innocenza15, due poli che caratterizzano la “struttura”
dell’essere umano, cosapevole del suo “destino di
morte”.La tesi heideggeriana , che considera l’uomo é
“essere per la morte”. ( zum Tode sein) ha un significato
distruttivo, radicale che é la fine di tutti i trattati di teologia
e, rigettando la follia monoteista, restituisce all’uomo la
libertà e, con essa, la morte. Il binomio: libertà –
innocenza, già presente nell’opera di Epicuro16, manifesta
il malessere e le difficoltà affrontate negli anni, attraverso
le sue meditazioni sul destino ultimo che attende l’uomo e
rigettando il monoteismo che gli ha consentito di
impadronirsi della propria morte...La morte in se stessa non é triste;
porta una immensa pace. É l’inizio di un nuovo mondo, un mondo nel
quale non esistiamo più ( almeno in carne ed ossa), ma vi esistiamo
ancora nel cuore dei viventi, ed io attraverso i miei libri.
Credere in Dio significa essere alienati da se stessi. La nostra morte
non é più nostra e la nostra libertà é una illusione. Grazie
all’incredulità, la morte “ritorna nostra”e noi riscopriamo la nostra
17
libertà. La libertà é incompatibile con l’esistenza di Dio .
Nel pensiero di Descartes Conche individua aspetti che
vanno“ all’unisono con le sue tesi.” L’argomento, con il
quale Descartes dimostra che Dio esiste, non ha valore.
Egli mostra che se esiste un essere sovranamente
15
M. Conche, Mort, liberté, innocence ”, ivi, pp. 31- 38
M.Conche, Épicure : lettres et maximes, texte, traduction, introduction et notes,,
rééd. PUF, Paris 2009 ( 8 .éd.).
17
Queste sue parole sembrano riecheggiare il sonetto di U.Foscolo: Alla sera”, del
quale ricordo di aver parlato con Lui durante gli incontri al ristorante “ Le Restant”.
“Forse perché della fatal quiete/ tu seil’immago, a me si cara vieni, o sera!...Vagar mi
fai co’ miei pensieri su l’orme/che vanno al nulla eterno; e intanto fugge/questo reo
tempo...”
16
191
191
perfetto, questo essere sovranamente perfetto esiste, ma
non dimostra che esiste un essere sovranamente
perfetto.
La libertà, liberata da Dio, non é ancora liberata da se
stessa in quanto libertà dell’uomo peccatore[...] La
nozione di un peccato che si trasmette da generazione in
generazione é una nozione religiosa che non ha altro
fondamento che un mito ed é dunque da rigettare”; lo
stesso Pascal, (nel fr. 434 Brunschwicg, ) ne rivela il
carattere assurdo ed immorale. Da qui ha origine la
severa contestazione del peccato originale:”
la dottrina del peccato originale e l’evangelizzazione cristiana delle
popolazioni non portarono benefici all’essere umano. Quest’ultimo,
convinto di essere cattivo per nascita ed incline al male, ha
cominciato a ritenersi peccatore ed all’origine di ogni sorta di peccato,
reale o immaginario. La sessualità ha perduto il suo carattere
primario e naturale. L’uomo non é diventato migliore, al contrario,e
18
non é stato più felice .
Abolito Dio, Conche celebra al suo posto la Natura19,
convinto che “ l’uomo é naturalmente buono quando si
trova nel suo stato normale”; ma quando lo abbandona ed
é “ dominato dall’odio, dalle pulsioni omicide “ compie
azioni criminali, dalle quali puo’derivare solo una “falsa
filosofia”.
All’esistenza di Dio, “vissuta” come un“tormento teoretico”
viene negato l’ attributo fondamentale: “pantocrator”,
18
M. Conche, Ultimes réflexions, cit., pp. 34- 35.
M. Conche, Présence de la Nature, PUF, Paris
“Quadrige” 2011.
19
2001 ; éd. augmentée, PUF,
192
192
creatore del Tutto ; sarebbe meglio separare Dio dalla
creazione ed occuparsi della conoscenza dei suoi
“disegni” che hanno preceduto la creazione20.
Contestando le “verità” della tradizione filosofico-religiosa
su Dio, Conche rigetta
il Dio onnisciente, completamente buono ed onnipotente della
tradizione monoteista, perché questo Dio, che é la causa totale di
tutto cio’ che accade, sarebbe la causa di tutti i mali, delle sofferenze
e delle catastrofi scatanate dalla natura e dagli uomini, cio’ che é
assurdo, soprattutto quando si considera la sofferenza dei fanciulli
martirizzati, nella quale vediamo un male “ assoluto”( p. 39).
Ma se togliamo a Dio i suoi attributi fondamentalionnipotenza, bontà completa, onniscienza- che ne é di
Dio? E Dio puo’essere definito senza i suoi attributi?
Non ci sarebbe assurdità se si separasse Dio dalla Creazione e se lo
si considerasse, ad esempio,prima della Creazione Si deve
ricercarne l’origine nel fatto che la religione e la teologia trattano
dell’essere, mentre gli uomini hanno a che fare con gli esseri . “Gli
esseri formano una moltitudine che non ha né inizio né fine, dunque
eterna, e questo presuppone che il tempo stesso sia eterno. Ora se
si deve dare una spiegazione del fatto che ci siano degli esseri,
20
Il tema é genuinamente agostiniano. Nelle Confessioni Agostino si pone un
problema filosofico- teologico, muovendo dalla domanda: Che faceva Dio prima della
creazione? e mette a nudo la incapacità ermeneutico-riflessiva dell’uomo di fronte ai
problemi dell’ineffabilità dell’Assoluto . Conche ripropone gli stessi problemi, in una
prospettiva che evidenzia notevoli cambiamenti nel corso della sua elaborazione.
Alla origine c’é ancora una volta Descartes, citato e riproposto nei nuclei
fondamentali del suo pensiero, criticati da Conche alla luce delle diverse
interpretazioni filosofiche del concetto di Dio – fondamentale quella di Spinoza di
“ens absolute infinitum”.- chiedendosi se quest’essere infinito possa essere la causa
dell’esistenza per tutti gli esseri. “ Ci sono sempre stati degli esseri e ce ne saranno
sempre: perché é inconcepibile che gli esseri si annullino, lasciando il posto al nulla”.
193
193
muovendo da un principio, e se si tratta non di tali o tal’altri esseri,
ma di tutti gli esseri contemporaneamente, il principio non puo’
essere passeggero o locale e particolare: é necessariamente
21
eterno” .
E se questo principio é “energia”, possiamo forse
sostenere che l’Essere sia “energia”?
“L’Energia c’é sempre, ma l’Energia é Vita, cio’ che non si
comprende nell’immutabilità. Dire “c’é l’Energia” é meglio
che dire” L’essere é Energia”. Il termine “essere”, in
effetti, é una parola, diciamo, del linguggio comune, ed é
ingannevole, perché, dicendo l’essere,come se cio’ che é,
durante il periodo in cui esso é, non cambia affatto, si
disconoscerebbe il cambiamento.. Le metafisiche che
fanno dell’Essere il principio di tutte le cose, rimangono
dipendenti dal linguaggio comune” In contrapposizione a
Cartesio ed a Heidegger, Conche ritiene che l’energia é
vita e che quando si afferma “c é Energia”22 si cerca di
andare oltre l’affermazione che “l’Essere é energia”,
perché “ il termine “essere” é un vocabolo che appartiene
al linguaggio comune e ci inganna perché, dicendo
l’essere, come se cio’ che é, nel tempo in cui esso é, non
cambiasse
affatto, non
si comprenderebbe
il
cambiamento. Le metafisiche che fanno dell’”Essere” il
21
M. Conche, Ultimes réflexions, cit., p. 41.
Il concetto di energia richiama non solo Bergson ma la divinità dell’antico Egitto
Heka, che si manifesta come energia impiegata dal dio che, creando il mondo,
mantiene in equilibrio il caos e l’ordine. Questa divinità é presente nell’ ampia
rassegna archeologica( iconografica ed ampiamente
documentata) nella
nuova,eccellente sistemazione, delle antichità egiziane del rinnovato e riordinato
Museo egizio di Torino.
22
194
194
principio di tutte le cose, sono indipendenti dal linguaggio
comune. Noi non diciamo “ l’Essere é Energia”: basta
dire” c’é Energia”. Questo implica la distinzione fra “c’é” e
“l’essere”. Prima della Creazione, secondo la Bibbia, c’era
il nulla= nulla= non si puo’ sostenere “ il nulla era”, perché
in questo caso sarebbe stato qualche cosa: il nulla,
appunto. In breve, c’é Energia”23, una tesi già presente
in Aristotele, che identifica Dio con una energia perpetua,
l’ eterno Vivente, e che acquista un significato particolare
in Descartes, che vede in Dio una Persona, mentre il
principio Energia é impersonale, non dista molto dalla
concezione eraclitea del Fuoco, energia che genera ogni
cosa!24
Particolarmente attento al significato della natura e delle
leggi che la governano25, Conche avverte che é improprio
ridurre la natura “all’universo del big- bang. Sarebbe
intollerabile considerarla limitata nello spazio e cominciata
nel tempo. Questo si puo’ dire del mondo, ma non della
natura. Quest’ultima si conosce solo andando oltre tutti i
23
M. Conche, Ultimes réflexions, op. cit., p. 43.
Conche , che ha reso “attuali” diversi filosofi e correnti filosofiche del pensiero
antico, greco e romano, di cui ha messo in luce, grazie ad accurate ricostruzioni
filologico -filosofico , aspetti che ne rinnovano e ne approfondiscono le interpretazioni.
Rimando , nell’ordine cronologico in cui sono state pubblicate, alle edizioni critiche ed
alle traduzioni, citandone le edizioni più recenti a : Épicure: lettres et maximes, texte,
traduction, introduction et notes ; rééd. PUF, Paris 2009 ; Anaximandre, Fragments et
Témoignages, texte traduit et commenté , PUF, Paris 2009 ; Parménide, Le Poème,
texte établi, traduit et commenté, PUF, Paris 2OO9 ; Héraclite, Fragments, texte
établi, traduit et commenté, PUF, Paris 2011 , alle quali si aggiungano : il saggio :
Sur Épicure, Encre marine- Les belles Lettres, Paris 2014, che riprende ed aggiorna
alcuni temi della filosofia di Epicuro , e la rinnovata edizione di : Lucrèce et
l’expérience,, rééd. PUF, Paris 2011. Di alcuni di questi saggi ho trattato nel mio :
In Itinere, op. cit., Novara 1999.
25
Cf. M. Conche, Présence de la nature, PUF, Paris 2001. Un volume di pp. 220
24
195
195
limiti. Che sia cosi’ é implicito nell’esperienza originaria,
l’esperienza greca della natura”26,
che ingloba pienamente tutto, in modo tanto evidente, che
non é possibile ipotizzare l’esistenza di un sovranaturale;
ed é proprio per questo che la natura rappresenta la
“totalità”:
essa é una presenza che non é modificata dalla differenza che si
stabilisce tra passato, presente e futuro. C’é un presente che é nel
tempo, fra il passato ed il futuro, ed esiste un altro presente che non
é nel tempo. Se cio’ che non é nel tempo é eterno, si puo’ dire che il
presente del “c’é” é un presente eterno. Il che significa che di tutto il
27
tempo c’é sempre stata qualche cosa .
Riprendendo dalle testimonianze, a partire
dagli
“Antesocratici” fino ai nostri giorni, vengono presentati i
contributi di discipline “complemantari” alla filosofia,
26
27
M. Conche, Présence de la Nature, op. cit., p.21
M. Conche, Présence de la Nature, op. cit., p. 89.
196
196
come la poesia, la politica, le scienze28 , le cui esigenze
sono sempre chiaramente definite.
Biologi, entomologi, chimici, fisici, astrofisici, psicologi ecc. osservano
o fanno esperimenti: l’oggetto del loro interesse scientifico é sempre
29
ben definito, ben messo a fuoco, niente affatto infinito .
Nella scienza non c’é alcun arbitrio : le scienze fisicomatematiche sono confluite nel sistema di Newton;
Fourier mediante il logos ha sviluppato la teoria del
calore, della quale si é servito Maxuell per la scoperta
della teoria elettromagnetica; infine il logos di Einstein;
sono gli strumenti di cui gli scienziati si servono per
raccogliere ed organizzare la totalità dei dati, che
permettono il progresso delle scienze. Secondo Conche
esiste un abisso fra i cosmoi degli scienziati e la natura,
che richiede di essere pensata continuamente.
28
Si vedano, ad es. le pagine dedicate a Rosa Luxembourg, significativamente
intitolate : “ Rosa Luxembourg: la Nature comme réconfort( pp. 147- 158) e quelle
dedicate a Rimbaud, L’appel de la Nature, Rimbaud, Le Bateau ivre( pp. 179- 206) e
La lumière Nature ( pp. 207- 215, senza trascurare il capitolo V :
La Nature et l’homme ou: le scepticisme philosophique et sa limite (pp. 87- 116), nel
quale le riflessioni sulla natura, sull’uomo, sulla società sono messi a confronto con i
problemi essenziali dei valori della politica- dell’individuo , del cittadino, dell’uomo, nella
consapevolezza che “tutti gli uomini sono cittadini della Città del mondo”( p.100 )” Oggi
l’umanità si trova in un momento critico della sua storia, quando per lei é necessario,
piùche mai, cercare di realizzare, se non il sogno zenoniano di fraternità universale,
almeno lo Stato, o il quasi Stato universale o, se si preferisce, “ mondiale” , come
sostiene Eric Weil ed inoltre- ma si tratta di un problema ancora più difficile- uno
stato universale nel quale regnerebbe la giustizia’(pp. 100- 101). Un approfondimento
di questi temi é stato messo in luce nella conferenza “ Naturalismo e Materialismo
metafisici” presentat il 19 marzo 2005,alla Sorbonne , e successivamente pubblicata
nel “ Bulletin de la Société française de Philosophie, 3, Juillet- Septembre 2005,
pp.4- 30
29
M. Conche, Présence de la Nature, cit., p. 93.
197
197
L’universo teoretico di Conche si estende ad una quantità
di problemi che nascono dal” cuore” stesso della filosofia,
con la ripresa di alcune problematiche, già oggetto di
riflessione negli scritti precedentemente pubblicati.
Nel capitolo VII, Essere liberi nella verità ( pp. 51- 58 )
contro la pretesa libertà dagli ingranaggi che tentano di
stritolarci (cfr. il caso Eichmann) viene posto il problema
della libertà autentica, fondata sull’autonomia del pensiero
e, soprattutto, sulla autonomia morale:” Non ci si puo’
limitare ad una definizione della libertà che annulla la
differenza fra i giusti e gli ingiusti, tra i buoni ed i cattivi,
tra Socrate ed un tiranno crudele. È insufficiente ogni
definizione che non integra le nozioni di verità, coscienza
(morale) e ragione (pp.56-57 ).
La vera libertà libera non si definisce unicamente
attraverso il rapporto dell’io concreto con l’azione che egli
compie, ma attraverso il rapporto della totalità dell’essere
umano con cio’che egli fa, ove “essere umano” significa
una ragione, una coscienza morale e, prima di tutto, idee
ritenute vere; puo’ anche accadere che le idee vere siano
considerate sia false che vere, e l’ingiustizia puo’ essere
presa per giustizia e il non diritto per il diritto.
Gli umani che prendono il falso per il vero (...) vivono nell’illusione.Ma
la loro libertà non é altrettanto illusoria, perché il loro essere
essenziale é coerente con quello che fanno. Essi pertanto non sono
tanto liberi quanto se vivessero non nell’illusione, ma nella
verità”.come se
fa é quella dell’uomo contemplativo ed é
completamente libero l’uomo la cui azione é fondata sulla ragione, e
30
per questo ha un significato dell’universale .
30
M. Conche, Ultimes réflexions, cit., pp. 56- 57.
198
198
L’uomo é collocato nella realtà nella quale vive ed, in
questa prospettiva, Conche richiama la teoria
antropologica di Montaigne, origine di una serie di
riflessioni interessanti. Fra gli uomini e gli animali esiste
una disparità evidente. : “ Non siamo né al di sopra né al
di sotto del resto . C’é qualche differenza , ci sono ordini e
gradi, ma é tutto all’interno sotto della stessa natura”. (p.
60 ).
L’uomo si trova a metà strada, senza alcuna eccellenza vera ed
essenziale”, il che non significa che l’uomo non abbia dei caratteri
che lo contraddistinguono: l’uomo , come gli animali, ha un proprio
linguaggio , e la differenza fra l’uomo e gli animali consiste nel fatto
che il carattere fondamentale dell’uomo é la “ libertà dello spirito: che
[l’uomo] sia il solo, fra tutti gli animali che abbia la libertà
dell’immaginazione( pensiero, spirito)[...] é un vantaggio che gli é
costato molto caro e del quale ha veramente poco da essere
contento, perché da esso nascono principalmente i mali che lo
opprimono:
peccato,
malattia,
irresolutezza,
turbamento,
31
disperazione .
Caratterizza l’uomo “l’aperto”, come scrive anche Rilke
nell’VIII elegia di Duino:
Con tutti gli occhi vede la creatura/ l’aperto( das Offene) [...] Cio’ che
é fuori, puro, solo dal volto/ animale lo sappiamo; perché già tenero /il
bimbo lo volgiamo indietro, che veda/ cio’ che ha forma e non
l’aperto, che/ nel volto animale è si profondo. Libero da morte/
Questa noi soli la vediamo;il libero animale/ha sempre dietro di sé il
31
M. Conche, Ultimes réflexions, cit., pp. 60-62.
199
199
tramonto/ e a sé dinnanzi Dio, e quando va, va/ nell’eterno come le
32
fonti vanno .
La giustificazione del proprio personale rigetto della
religione e di Dio é suggerita e riconfermata dalla ragione
e dalla verità alla quale essa approda“33. Ribadendo,
ancora una volta, il suo scetticismo, anche influenzato da
alcuni interlocutori cristiani che,“alienati felici” dai dogmi
del Cristianesimo, si rivelano deboli, incapaci di quella
forza interiore richiesta dalla verità34, Conche mette in
evidenza il “vulnus” che gli impedisce di credere in un Dio
unico e buono perché non potrebbero spiegarsi i gemiti
dei bambini di Varsavia, i bambini “atomizzati” di
Hiroshima, quelli ridotti a scheletri dalla fame, e gli orfani,
terribile risultato delle uccisioni di massa , ai quali si
aggiungano i fanciulli vittime degli psicopatici. Sono questi
gli elementi che caratterizzano il “ male assoluto”, ai quali
si debbono aggiungere le vittime dei bombardamenti di
Dresda e di Hiroshima (e perché no quelli di Cowentry?)
Esempi che ci presentano una cultura cieca, ai quali
soltanto la conquista autonoma della libertà puo’ mettere
fine.
32
Ho riportato , tralasciandone qualcuno, i primi tredici versi dell’OTTAVA delle Elegie
Duinesi di Rainer Maria Rilke, nella traduzione italiana di Giuliano Baioni della
edizione Einaudi- Gallimard, Biblioteca della Pléiade, Lonrai 1995, vv. 1- 13.
33
“Abbiamo rigettato la religione preoccupati dalla ragione e dalla verità. La nostra
scelta, non imposta né suggerita, ma libera sarà quella di ricercare la verità per mezzo
della ragione, la scelta filosofica. L’umano che saro’, che la mia amica sarà,
riconoscerà l’eguaglianza valoriale di tutti gli uomini, dotati tutti di ragione [...] Sarà
l’uomo filosofo, non frutto di mescolanze diverse, ma semplice, con la sua personalità,
i suoi modi di essere, il suo stile” (p. 79 ).
34
M. Conche, Ultimes réflexions, op. cit., pp. 81-82 –Capitolo XII, La preuve morale
200
200
Non c’é da meravigliarsi se spesso, in queste pagine,
Conche fa riferimento ad eventi del suo passato: cosi, in
Un artéfact (pp. 83- 87), ricordando la sua formazione e il
fascino del pensiero cartesiano, ci lascia un interessante
commento alle Méditations cartésiennes di Husserl, testo
fondamentale per la filosofia, non solo francese e non
solo del suo tempo35. L’analisi di quanto allora si
conosceva del pensiero husserliano, le riflessioni sulla
filosofia cartesiana, in molte pagine oggetto di riferimenti
precisi ed efficaci, rivelano una severa riserva, fortemente
critica, sulla epoché husserliana, considerata “un
atteggiamento contingente. Il risultato ne mette in’”
evidenza”la soggettività trascendentale, ma non
l’esistenza di una tale soggettività [...] Si tratta di una
evidenza che inganna, perché non esiste soggettività
trascendentale al di fuori dello sguardo che la fa nascere
(prima o dopo) ( p. 87). In molte sue opere Conche si
pone il problema della “significato ”di una possibile
metafisica, muovendo dalla riflessione critica sulla dottrina
kantiana, che “argomenta” ma non “prova”36 l’esigenza e
la costituzione di una metafisica come scienza. Egli si
riferisce, oltre che a Kant, a Descartes e all’intera storia
del pensiero, dai Presocratici al Medioevo, dalla filosofia
moderna alla contemporanea. Sorge spontanea la
domanda:
È necessario, prima di dedicarsi alla metafisica, interrogarsi sul
potere della ragione, cercare di sapere fino a che punto puo’
35
Voglio qui ricordare, en passant, le lezioni dedicate a Husserl della giovanissima
Sofia Vanni Rovighi e quelle dell’altrettanto giovane Enzo Paci che in Italia hanno
aperto la via alla conoscenza ed all’approfondimento della filoofia husserliana.
36
Cfr. in capitolo XIV , Argumenyt ou preuve (II) pp. 89- 92
201
201
condurre nel cammino verso la verità? Nientaffatto: come lo si
potrebbe sapere in anticipo? Kant si é limitato ad una concezione
fissista della ragione, ferma al sapere raggiunto al suo tempo:la
scienza newtoniana. Egli analizza gli a priori sui quali é fondata una
tale scienza (della quale, considerandola reale , mostra la possibilità)
37
e li iscrive strutturalmente nel soggetto umano .
I brevi capitoli XV -XXI ( pp. 93- 122 ), sono dedicati alla
scoperta dei momenti di un vissuto che hanno
accompagnato Conche a concepire la filosofia spesso
attraverso esperienze semplici ma significative. Cosi , nel
capitolo XV, (La faute envers l’animal, pp.93-95)ricorda
un episodio della quotidianità- la visita e l’eliminazione di
due cimici, in un momento di rabbia, e la “pacificazione”
con i loro successori che,alla fine, “ hanno tutte le fortune
di poter volare tranquillamente”; oppure, muovendo dal
clima politico, prende in considerazione il passato ed il
presente della storia della Crimea, le relazioni con la
Russia e con l’Ukraina, oggi in crisi politico- istituzionale e
la cui soluzione si presenta complessa e difficile. Nelle
pagine successive, non mancano riflessioni sulla vita
comune e sull’opera d’arte (XVI, La beauté de la vie, pp.
100 ), é pubblicata :Una lettera a Chaïmaa (XVII, pp. 101102), viene ripreso il concetto di “essere”, con riferimenti a
Montaigne, Heidegger, Eraclito (XVIII, Che significa
“essere”?, pp.103- 108). Si aggiungono alcune riflessioni
dedicate all’astuzia politica (XIX, La ruse en politique,
pp.109- 111), bene esemplificata nel capitolo XX (L’amitié
unilatérale, pp.213- 219), alla quale segue l’analisi della
37
M.Conche, Ultimes réflexions, op. cit., p. 92
202
202
politica internazionale e della storia, che illuminano
l’interesse per gli eventi che hanno cambiato la Russia,Egli si dichiara “pro-russo”- giustificando la sua adesione
con tre motivi: a) la lotta contro il capitalismo, polo
negativo della società , che fallisce per colpa della società
capitalista, la quale fa leva sui poteri reazionari; b) la
guerra degli anni 42-44 contro l’avanzata nazista; c) la
vittoria degli “umili” e degli “offesi” contro i conquistatori e
gli usurpatori, che dà vita non solo all’alleanza operai e
contadini ed a quella di tutti i lavoratori della Repubblica
dei Soviet, alla nascita dell’Armata rossa e della Marina
rossa. Emblematico rimane, nel 1927, il discorso di Stalin
ad una delegazione di operai americani: la società, nata
dalla rivoluzione, abolisce la proprietà privata e le classi
sociali e mette fine alla opposizione città - campagne,
industria –agricoltura; in essa scienza ed arti potranno
svilupparsi armonicamente e “l’individuo, libero dalla
preoccupazione del pane quotidiano e dalla necessità di
piacere ai ” potenti” o di obbedire ai “superiori” , sarà
realmente libero”. Questa analisi realistica sottolinea che
siamo ancora lontani dalla realizzazione di questo
progetto ideale ma il comunismo non deve considerarsi
una utopia, perché é stato realizzato e, sia pure in piccole
dosi, in Cina dove questa “spinta creativa” potrà
continuare. Non ci sono segni positivi su una prospettiva,
sulla quale, fra gli altri, Ernst Bloch non sarebbe stato
certamente d’accordo!
Soffermandosi su “l’etica del sofferenza” Conche ne
auspica l’estensione all’intera natura, e ritiene opportuno
insistere maggiormente sulla sofferenza dei bambini,la
“più forte”(XXI, La souffrance animale, pp.1,1- 122).
203
203
I capitoli XXII- XXV (pp. 123- 145), che concludono la
prima parte del volume, riprendono, corredati da
significative riflessioni interessanti, alcuni “grandi temi” del
pensiero di Conche, a cominciare da “l’ateismo”.
Muovendo da una certezza inoppugnabile: “è sicuro: per
essere filosofi bisogna essere atei” viene riproposta la
professione di fede di Prometeo:” In una parola, odio tutti
gli dei”( v.975),dalla quale derivano due considerazioni:/
”Odio tutti gli dei”, tesi che non si puo’ considerare come
una la premessa di una dissertazione sulla filosofia di
Epicuro, perché non solo gli Epicurei non odiavano gli dei,
ma li consideravano esempi di armonia e felicità, perché
fossero imitati dal “saggio”; 2/ “ Bruno Bauer fa notare a
Marx che una tale premessa é inopportuna quando non si
é ancora installati “in una cattedra””. Riprendendo le
denominazioni dei mesi del calendario esposte da Marx
nel Sistema di politica positiva, Conche si sofferma sul
mese ‘ Mosé’ e su quello della prima settimana, dedicato
a Numa, di essa il primo giorno, un lunedi, é dedicato a
Prometeo. Da qui ha avuto origine il percorso della
filosofia, separata dalla teologia, un percorso grazie al
quale la filosofia si rivolge al “mondo reale, che si offre
all’osservazione ed al ragionamento”(p. 125). Percio’
Heidegger considera Prometeo primo filosofo”( p. 125).
Alla tesi del ” cominciamento greco del filosofare”
aderisce Conche, che nella “Natura creatrice”, individua il
completamento dell’uomo. Collegato a questo il capitolo
XXIII,Trasmettre ( pp.129- 132), é una rivisitazione del
cristianesimo del IV e V secolo( XXIV,Christianisme, pp.
133- 138) nel suo aspetto “distruttivo”: il saccheggio e la
distruzione dei santuari pagani, descritti in una pagina del
204
204
De Templis di Libanio, che informa Teodosio I sulla
drammatica situazione nella quale vive la comunità
pagana, (pp. 133- 136), colpita al cuore: si smantellano le
biblioteche, i santuari vengono
distrutti dai monaci
cristiani (i guardiani dell’ordine) che abbattono i templi
ancora intatti e distruggono la vita religiosa pagana.
Il tempio aveva un’anima poiché era abitato dal dio. Non era il luogo
nel quale si riunivano i fedeli ma quello intorno al quale si svolgevano
processioni, feste,manifastazioni di gioia come se fosse la sede del
bene e del bello. Gli dei amavano essere venerati da gruppi di
dansatori, perché il culto era collettivo (pp. 136- 137).
Con l’avvento del Cristianesimo comincia la crisi della
tradizione religiosa pagana, sia pure parzialmente
assimilata, proprio come in parte viene distrutto l’ideale
greco, il bello, al quale viene opposto “il sublime”, con
questa differenza: “cio’ che é bello si vede, mentre cio’
che é sublime non si vede affatto (p. 138) .
Pascal, pensatore e scienziato non é l’Autore” di Conche
– come lo é invece Montaigne o Spinoza, o Platone - il più
grande fra i filosofi . Fra i pensatori Pascal si rivela
eccellente nelle matematiche, mentre in “geometria”sono
famosi la “retta di Pascal”, il “triangolo di Pascal “ed in
fisica, il “principio di Pascal”.
Nel Mémorial si legge : “Certezza. Certezza. Sentimento.
Gioia. Pace”;ed ancora: “Eternamente in gioia per un
giorno di esercizio sulla terra”.
Sono le premesse alla famosa “scommessa” a favore o
contro il cristianesimo (p. 141), che ha colpito
particolarmente Conche, che esprime la sua ammirazione
e l’ emozione per il frammento 553, nel quale Pascal
205
205
rivive la passione di Cristo: “Gesù é il solo sulla terra, che
non solo sente e condivide la sua pena, ma che la
conosce: il cielo e lui sono soli in questa conoscenza.
Soffre questa pena e questo abbandono nell’orrore della
notte”. Questa riflessione riesce a si cogliere uno stretto
legame con la sofferenza, il legame che collega il fanciullo
ebreo, perseguitato e gasato, a Gesu’, che s’immola sulla
croce. Ma é una frase del frammento 793 che “inebria”
Conche:” La distanza infinita fra i corpi e gli spiriti
manifesta la distanza infinitamente più infinita degli spiriti
dalla carità, perché essa é soprannaturale”. Pascal ci
lascia una “nuova visione” dell’universo ,che trova il suo
limite nella “natura” illimitata, infinita, nella quale l’uomo
“é” la sua realizzazione più profonda, solitario fra i solitari.
La seconda parte del volume si apre con il richiamo alla
solitudine (La solitude, pp.149-153) che mette a fuoco
“l’intimità del vivere” con la quale ogni uomo é
“assolutamentte solo con se stesso” (p. 149). Se c’é Dio,
al quale non sfugge “ nessuna emozione intima, nessun
pensiero segreto” l’uomo non é più solo, ma, se scarta
Dio , l’uomo si condanna alla più dura solitudine. Su
queste premesse, oggetto di un dialogo con Chaïmaa,
vengono introdotte una serie di riflessioni dedicate a “la
solitudine dell’uomo” (pp. 150- 151 ) che confluisce ne “la
solitudine del filosofo”(pp. 151- 153 ) per concludersi ne
“la solitudine dell’io”(p. 153). L’uomo “solo” deve trovare in
se stesso le risorse, i valori, la forza del vivere, facendo a
meno di dio ,-scritto in lettere minuscole,- presentato
senza i valori tradizionali : bontà, giustizia, amore. Un
dialogo a distanza con Claude- della quale vengono
riportati brani di una lettera che tratta della “teologia
206
206
dell’impotenza di Dio-” (pp. 155- 156), sollecita Conche a
dichiarare il suo scetticismo verso un’ ipotetica sofferenza
di Dio, perché
di essa non c’é “alcun effetto
visibile”(p.156). È difficile, forse anche impossibile
conoscere l’altro (III, La connaissance d’autrui, pp.157159) dal momento che anche nelle relazioni di amicizia
spesso non ci si intende completamente: noi non
conosciamo i nostri amici, né i nostri amici conoscono noi.
Conche presenta due “prove” circa l’incapacità” di
intendere i propri amici: a) se all’interno dell’orizzonte
intellettuale, nel quale Egli ha operato, fosse obbligato a
scegliere , in un dizionario di nomi propri non redatto in
ordine alfabetico, contrariamente a quanto i suoi amici
credono, gli piacerebbe essere posto accanto a Pascal. b)
una seconda tesi troviamo in una lettera inviatagli da
Françoise Dastur, nella quale si contesta l’interesse dei
media e del mondo editoriale a favore delle vicende della
Schoà, tralasciando sofferenze egualmente drammatiche,
alle quali vengono sottoposti i malati mentali, gli
handicappati, gli omosessuali, gli zingari; ad esse si sono
aggiunte, in tempi recenti, le sofferenze dei malati
terminali, di quanti sono stati colpiti dal Sida, dei feriti e
dei morti nelle guerre nelle aree più sensibili del mondo,
dall’Africa all’Asia, ed aggiungerei, quelle dei migranti,
ingannati dai viaggi della speranza , che spesso si
concludono nel grande cimitero del Mediterraneo.
Esistono sofferenze ancora più grandi, che sfuggono alla
nostra conoscenza, nascoste nell’ intimo di ciascuno di
noi. Ed é proprio la sofferenza che alimenta il pessimismo
di Conche, veicolato dalla solitudine (IV, Mon
pessimisme, pp. 161- 162), che puo’ essere attenuata
207
207
dall’amicizia (V, Structure de l’amitié, pp. 163- 166), nelle
sue diverse manifestazioni, dal semplice accordo fra due
persone alla gioia condivisa o alla realizzazione dei
medesimi valori, l’amicizia si manifesta come amicizia
comune, amicizia eccezionale, -poco importa che sia
perfetta o imperfetta,” é solo un fenomeno di superficie in
rapporto alla vita [...] L’amicizia abita in un luogo fuori
dalla storia, dove il tempo é assente. Non ci siamo che tu
ed io, e viviamo una pace condivisa[...]Si puo’ provare
grande gioia nella solitudine, ma nessuna é paragonabile
alla gioia dell’amicizia: gioia di non essere più solo”(pp.
165- 166).
L’uomo si realizza pienamente nella “sagezza tragica”(VI,
Sagesse tragique, volonté tragique, pp.167- 168); la
sagezza dell’ateo consiste nello scegliere di vivere la
propria vita non nell’abbandono, ma razionalmente e nel
volere autonomo; l’etica, a sua volta, si fonda su di“ una
scelta di vita in funzione di alcuni valori. Dal momento che
quest’etica riposa su una metafisica, essa é una sagezza.
E poiché questa metafisica insegna che la vita finisce nel
nulla, é un’etica tragica”(p. 167).
L’attività creativa dell’uomo, nella varietà delle sue
componenti, produce l’arte, la filosofia, ciascuna con la
propria “etica”, ma é falso sostenere che ognuno abbia la
sua “morale”.
L’ateismo nega la speranza dopo la morte. “La volontà
morale é volontà tragica,similmente al carattere
incondizionato dell’imperativo morale. Io debbo rispettare
l’altro, venire in suo aiuto. Compio il mio dovere con la
consapevolezza che questo non mi dà diritto a nulla, che
non c’é da aspettersi qualche cosa: cosa si puo’ attendere
208
208
dal nulla? (p. 168 ). Contro Kant, convinto che l’etica del
dovere assicuri all’uomo la sopravvivenza dell’anima e la
felicità “legandole all’esistenza di Dio”, Conche ipotizza
che “se l’agire morale é stato caratterizzato dalla
mancanza della preoccupazione di sé, non c’é più alcun
sé da ricompensare”( p. 168).
Diversi momenti di “causticità” rendono “vivaci” i capitoli:
VII- Beauté dérisoire( pp 169- 70), VIII, Vanité ou fierté
(pp.171- 172) IX, La personnalité structurée par l’histoire
(pp. 173- 176), X, Epicure et Socrate (pp. 177- 180), tutti
dedicati a riflettere su temi differenti , da quello esteticola bellezza della Venere di Arles o della Gioconda di
Leonardo- in rapporto ai valori dell’umanità:” chi dice”
umanità” dice vita e ragione (p.171), alla contrapposizione
“vanità- ragione” (p.172), nonché a considerazioni
politiche attuali , con riferimenti alla storia dell’Europa,
dalla difesa di Stalingrado alla insurrezione di Budapest,
agli
accordi
di
Ginevra
sul
riconoscimento
dell’indipendenza del Vietnam, e alla politica interventista
americana, da Roosevelt a Nixon e a G. Bush. Sono
soluzioni negative, che mettono in evidenza “l’incapacità
politica
dei
dirigenti
americani,
confermata
dall’inesperienza di Barack Obama che lascia il campo
libero all’arroganza israeliana ed al disprezzo di Israele
per il diritto delle genti” (p. 175). Un ulteriore tema di
riflessione é dedicato agli eventi che hanno caratterizzato
le trasformazioni politiche nella URSS - dal 1917 al 1991-,
che sono state oggetto di interpreazioni storiografiche
diverse, e non di rado contrapposte.. Sulla situazione
politica della Grecia classica, Conche si interroga sul
ruolo esercitato da Epicuro e da Socrate , entrambi
209
209
credenti nell’intervento degli dei in favore degli umani, e
“per uno, Epicuro, oggetti di conteplazione, per l’altro
dispensatori di consigli”(p. 177); considera “falso” il
giudizio di Heidegger sulla religiosità del Greci, dal
momento che gli Ateniesi, ed i Greci in generale,
credevano nei loro dei; ma resta il dubbio se, nei confronti
degli dei, si tratti di fede o di credenza . La scelta
heideggeriana fra fede e credenza inclina verso la fede e,
nella Lettera sull’Umanesimo Heidegger sostiene che “Dio
é diventato “Deità”, e puo’ essere pensato a partire dal
“sacro” (pp. 177-178 ), lungo un percorso che va dal
“Sacro” alla “Deità” a “Dio”.
Nella teologia si tratta di un Dio diventato concetto ed oggetto di
credenza,non del Dio della fede. È il motivo che spinge Heidegger a
suggerire ai giovani teologi di mettere da parte la teologia, di pensare
Dio a partire dalla fede e dalla vita in Cristo, “creando un loro proprio
linguaggio, come fanno i poeti (p.178 ).
I poeti ed i pensatori dell’antica Grecia cantavano il Dio
della fede, quel Dio al quale crede Socrate, quel Dio la cui
“voce” si manifesta in tanti modi. Come Socrate
concepisce Dio Epicuro che dichiara di fare dei sacrifici
seguendo la fede e la discrezione, nei giorni stabiliti,
“accompagnando tutti gli altri atti di culto in modo
conforme alla tradizione “ ( fr. 387 Us., citato a p. 179).
Le differenze tra Epicuro e Socrate, per quanto concerne
la religione, sono importanti : Socrate accetta la tradizione
popolare- si ricordi l’invito a sacrificare un gallo ad
Esculapio, dopo la sua morte; Epicuro non accetta questo
tipo di religione, e sostiene al contrario che, nella loro
felicità perenne, gli dei non solo non si curano degli
210
210
uomini, ma rimangono lontani ed indifferenti ai loro atti di
culto. “La vera pietà é quella del filosofo, perché li
conosce come sono in verità”( p. 180)
Dal capitolo XI (Cause et raison,pp.181-183 ) al capitolo
XXV (L’évolution de Descartes, pp. 227- 230) Conche
presenta un suo progetto dedicato alla indagine
storiografica, muovendo dal concetto di causa.: occorre
staccarsi dalla abitudine e dallo schema , con il quale
sono presentati gli interventi, ed analizzare i testi, i
problemi, le interpretazioni di prospettive filosofiche,
anche di quelle che, a parere di Conche, rimangono
estranei alla riflessione filosofica. Ne risulta un modo
“nuovo” di intendere gli eventi nella loro temporalità
perché si tratta delle “credenze” del filosofo, presentate
nella loro “verità”. In questa prospettiva i capitoli : XI,
Causa e ragione (pp.181- 183); XII, Natura e Linguaggio
(pp. 185- 186); XIII, Intuizioni e saperi (pp.187- 189); XIV,
Il libero arbitrio (pp. 191- 192) si possono considerare
“medaglioni” che approfondiscono forme di saperi, nei
quali é frequente il tema della “libertà”, che ritengo
fondamentale nell’intera opera di questo pensatore.
“Ci sono tre valori supremi: il bene, il vero, il bello. Nelle
nostre scelte non si deve mai perdere di vista il
raggiungimento del vero, o la realizzazione di qualcosa di
buono e di bello, con l’aiuto dei mezzi che non siano in
contraddizione con il fine. Perché,in questo caso, parlare
di “vera libertà?” Perché “é allora che l’uomo si esprime
completamente. Perché non é solo desiderio; é ragione e
coscienza morale. L’atto libero é l’espressione dell’uomo
totale”(p.192), dell’ uomo capace di “crearsi da sé”(XV, La
211
211
creazione di sé, pp. 193- 194), e sono “ saggezza e
felicità (XVI, Saggezza e felicità, pp. 195-196) i valori che
aiutano l’uomo- e specialmente il filosofo- a farsi carico de
“ i mali del mondo”, lottando contro ogni forma di
irrazionalità, denunciando le falsità e conducendolo , per
dirla con Nietzsche, ad una “ tragica felicità”(cf. p. 196) .
Una felicità alla quale né il materialismo, nelle sue varie
forme, né l’ateismo, né il panteismo, possono giungere:
Il materialismo che “spiega” cio’ che é superiore con cio’ che é
inferiore, degrada il superiore: l’uomo spiegato ricorrendo all’animale,
non é più l’uomo, l’anima, spiegata ricorrendo al corpo, non é più
anima, il pensiero,spiegato ricorrendo al cervello, non é più il
pensiero, la vita spiegata ricorrendo alla materia ed alle equazioni
chimiche, non é più la vita, ecc.”(p. 199).
212
Sulle orme di Montaigne -il filosofo preferito- Conche
elabora il suo programma filosofico, che gli permette di
scorgere i limiti della ragione umana (XVIII, C’est moy qui
je peins, pp. 201- 203) sia nell’agire che nei giudizi
formulati sui fondamenti del suo pensiero, confortato da
una lunga citazione del saggio:De Democritus et
Heraclitus (I, L), nel quale si mette in luce il valore della
libertà di giudizio.
Rompe con la tradizione, a rischio di ritrovare questo o quello che gli
viene dalla tradizione. Apre lo spazio ed il campo alla libera filosofia,
campo più tardi ostruito dai filosofi, come Descartes e Kant, che si
vanteranno di sostenere la religione con la ragione, tanto da fornirle,
andando contro Montaigne, una giustificazione universale. Con
questo perderanno la vera Natura della religione (p. 202).
212
Circa i modi con i quali distiguere le accezioni della verità
(XIX, La vérité dans la vie morale, pp. 205- 207) Conche
fa appello al linguaggio comune e, soprattutto, al
linguaggio filosofico, che ama distinguere fra “essere
vero”, filosofia vera”, “ una persona vera”, e ritiene che a
determinare la “verità” concorrono molti elementi, fra i
quali il principio della “eguaglianza naturale”, che
appartiene all’uomo e lo distingue dall’animale. La
“morale del giudizio”, del “giudizio naturale”, rivela l’intero
suo valore nel giudizio del saggio, che
va rigettata se il giudizio é stato formulato da un uomo qualunque; in
questo caso, o il giudizio sarà dipendente da influenze particolari o
siamo condotti ad una specie di anarchia morale (p. 207) .
213
Gli ultimi capitoli, XX, Divertissement (pp. 209- 212); XXI,
La détermination sociale, (pp. 213- 215); XXII, L’infini et
l’indéfini (217- 220); XXIII, Les niveaux de la liberté (pp.
221- 224); XXIV, Libre arbitre et grandeur (pp. 225- 226) ;
XXV, L’évolution de Descartes (pp. 227- 230) riprendono,
rispettivamente, alcune suggestioni di Pascal- che
vengono estese nell’approfondimento di “infinitoindefinito’- e di Descartes,- le cui problematiche
filosofiche, dalla metafisica all’etica, dalla scienza alla
morale sono spesso oggetto di analisi e meditazioni
critiche. A questo si aggiunga l’analisi del “ determinismo
sociale”, esposta, tenendo presente la sua propria realtà
socio- culturale, con le difficoltà non lievi con le quali si é
dovuto misurare e con la volontà mediante la quale é
riuscito ad affrontare e superare questi enormi problemi
213
riuscendo a diventare “uno dei migliori filosofi del suo e
del nostro tempo.”
Concludo questo profilo,certamente provvisorio e non
esaustivo, riportando una delle sue pagine più
significative , che risale al 2009 , tratta dalla rivista
L’enseignement philosophique, [6, juillet- août 2009, pp.
9- 20 ]:
I grandi filosofi ci offrono diverse possibilità per comprendere il
mondo, escludendo che la ragione, da sola, possa scegliere fra esse.
Pertanto essi ci offrono non solo diverse possibilità teoriche, ma
anche alcune possibilità di vita. I filosofi, in funzione delle loro filosofie
molto differenti, vivono in modi molto diversi il tempo della loro vita.
Almeno é cosi fra i Greci. Perché le filosofie teologizzate dell’epoca
moderna, in quanto opera di cristiani, non possono proporre altri modi
di vivere che quelli di vivere da cristiani, secondo le virtù cristiane,
talvolta con una punta di stoicismo. Descartes, Malebranche, Leibniz,
Berkeley, Thomas Reid, Kant, Hegel, non hanno modi di vivere molto
differenti, e Malebranche, Oratoriano, e il vescovo Berkeley,sono i
soli che dedicano molto tempo alla preghiera”(p. 18).
214
214
UNA LINEA INTENSIVA. RIFLESSIONI SU DELEUZE E
FOUCAULT A PARTIRE DA L’ORDINE DISCONTINUO
DI DEBORAH DE ROSA
CLAUDIO D’AURIZIO
“Non è certo che una vita o un’opera d’arte siano
individuati come soggetto, anzi, al contrario. Foucault stesso,
non lo si percepiva esattamente come una persona.
Anche in circostanze insignificanti, quando entrava in una stanza,
avveniva piuttosto qualcosa come un cambiamento d’atmosfera [_]
1
un insieme di intensità”
Gilles Deleuze
L’esergo è tratto da una conversazione con Claire Parnet
tenuta nel 1986, due anni dopo la morte di Michel
Foucault durante la quale Deleuze si sofferma
sull’eccezionalità della figura dell’amico nel milieu
culturale francese del secondo Novecento. Il nome di
Foucault indicherebbe un evento, una zona di speciale
intensità che non è possibile delimitare strettamente alla
sua persona2. Il recente libro di Deborah De Rosa,
L’ordine discontinuo3 dedicato alla disamina teoretica de
1
Deleuze, 1986a, p. 154.
Considerazione valida per la filosofia di Deleuze in generale che, secondo Jean-Luc
Nancy, “imprime un ‘divenire-concetto’ a dei nomi propri [_e] un ‘divenire-nomeproprio’ a dei concetti” (Nancy, 1998, p. 17).
3
De Rosa, 2016.
2
215
215
Le parole e le cose4, sembra assumere come punto di
partenza proprio questa constatazione. L’autrice s’occupa
d’indagare la figura e l’opera di Foucault, segnalandone
sia i legami concettuali con il proprio tempo, sia le
aperture e le connessioni con aspetti e problemi della
nostra contemporaneità. Il pensiero di Foucault diviene
tana labirintica da esplorare, diagramma di cui tracciare le
coordinate, campo di forze da misurare. Le parole
dell’intervista con la quale De Rosa apre il suo testo sono,
a riguardo, una chiara indicazione metodologica valida sia
per l’opera foucaultiana che per la propria ricerca:
‘scavare’, ‘indagare’ e ‘svuotare’ piuttosto che ‘costruire’ e
‘riempire’5. Tentiamo, dunque, d’assumere una simile
prospettiva per seguire e sviluppare alcune delle
indicazioni contenute ne L’ordine discontinuo e, più
precisamente, alcuni aspetti del rapporto tra la filosofia di
Foucault e quella di Deleuze. Sebbene il nome di
quest’ultimo non sia citato spesso nel testo, non sarà
difficile stabilire alcuni punti di contatto, alcune affinità
tematiche e concettuali che oltrepassano le reciproche
testimonianze di stima tra i due autori6. Crediamo esista
qualcosa come una linea intensiva di pensiero che li
colleghi, e che sia possibile seguirla alla luce dei preziosi
strumenti forniti da questa ricerca.
4
Foucault, 1966a.
Cfr. De Rosa, 2016, pp. 17-18.
6
Ricordiamo, ad esempio, la nota ‘profezia’ di Foucault secondo cui “un giorno, forse, il
secolo sarà deleuziano” (Foucault, 1970a, p. 54).
5
216
216
Una cornice: il Seicento
Una delle sezioni più intense del testo di De Rosa
consiste in una paziente e attenta rilettura del primo
capitolo di Le parole e le cose, in cui Foucault interpreta
Las Meninas, capolavoro pittorico di Diego Velázquez
(1599-1660)7. Realizzato nel 1656, questo dipinto ha
affascinato e intrigato generazioni di studiosi in virtù
dell’enigma che racchiude; sarebbe stato creato, infatti,
“con l’intento esplicito di sollecitare un numero infinito di
interpretazioni poiché [in esso] è la stessa
rappresentazione artistica a essere offerta allo spettatore
come problema”8. Foucault s’interessa al quadro,
sottolinea De Rosa, in quanto “rappresentazione della
rappresentazione
classica”9,
un
caso
di
metacomunicazione anomalo per la cultura seicentesca10.
All’interno del quadro è raffigurato il pittore intento a
dipingere una tela, mentre sono assenti dal primo piano i
personaggi più importanti, il re e la regina
(presumibilmente ritratti in uno specchio che occupa una
porzione dello sfondo). In virtù del carattere autoriflessivo
di questo dipinto, tale scambio di posti è leggibile come
“conseguenza del principio che regge l’episteme
classica”11. La mancanza della coppia reale è segno di
una ‘sparizione del soggetto’, elemento centrale per
un’episteme rappresentativa come quella seicentesca –
quest’ultima infatti, ricorda De Rosa, non poteva
prevedere “la messa in questione del soggetto nel suo
7
Foucault, 1966a, pp.17-30; De Rosa, 2016, pp. 45-59.
Nova, 1997, p. 12.
Foucault, 1966a, p. 30.
10
Cfr. De Rosa, 2016, p. 49
11
Ibidem.
8
9
217
217
carattere fondatore”12. La lettura del quadro da parte del
filosofo è quindi posta in relazione con quella fornita da un
altro protagonista del secolo scorso, lo psicoanalista
Jacques Lacan. Tale confronto intellettuale, che era stato
già oggetto d’interesse da parte dell’autrice13, è giocato
sulla nozione di centro. Esso, suggerisce Fabrizio
Palombi nella prefazione al testo, può essere letto “come
una disputa sull’individuazione del baricentro geometrico,
del fuoco ottico, teorico e, si potrebbe quasi dire,
narrativo, del capolavoro di Velázquez”14. Crediamo che
questo accostamento sia un contributo utile a chiarire
un’altra delle innumerevoli intersezioni tra l’indagine
psicoanalitica e ciò che è solitamente ascritto al dominio
della storia dell’arte, alle quali si va prestando sempre
maggiore attenzione. Ad esempio, in un saggio pubblicato
recentemente, Pio Colonnello ha indagato la lettura
freudiana delle Memorie di un malato di nervi di
Schreber15, intersecandone alcuni tratti con lo scritto di
Freud su Leonardo da Vinci16. C’è da aggiungere come
questo sia probabilmente uno dei casi più delicati poiché,
come sottolinea Colonnello, la lettura delle Memorie è “un
esercizio indiretto di psicoanalisi”17. In quest’occasione
Freud si confronta con uno scritto che, pur presentando
dei tratti artistici, non è un’opera letteraria o un affermato
capolavoro mentre, nel caso di Lacan qui esaminato,
siamo di fronte a un utilizzo ‘esemplare’ del quadro di
12
Ivi, p. 50.
Vedi De Rosa, 2014.
14
Palombi, 2016, p. 13.
15
Schreber, 1903 e Freud, 1911.
16
Colonnello, 2016 e Freud, 1910
17
Colonnello, 2016, p. 58.
13
218
218
Velázquez. La tela, infatti, è adoperata come modello per
illustrare alcuni aspetti relativi alla teoria dell’oggetto a
piccolo18. De Rosa ricostruisce minuziosamente
l’ambientazione e lo sfondo teorico delle sedute
seminariali tenute tra il Maggio e il Giugno del 1966,
appartenenti al XIII seminario lacaniano, ritenendo
“possibile affermare che queste lezioni siano nate grazie
alle pagine foucaultiane”19. Ci siamo dilungati su questa
sezione del libro perché ci permette di creare una prima
connessione, accennare a un primo punto di contatto con
l’opera di Deleuze. Riteniamo infatti, che l’interesse di
Foucault per l’episteme classica, interrogata in più luoghi
e con diverse finalità, possa essere proficuamente messo
a confronto con la lettura dell’epoca barocca compiuta da
Deleuze tramite il concetto di ‘piega’20. Non pensiamo che
gli obiettivi e gli strumenti concettuali di queste
interpretazioni siano riducibili gli uni agli altri o facilmente
equiparabili. Crediamo, piuttosto, che fra queste due
letture passi una linea comune, un filo rosso che permette
di tenerne insieme alcuni aspetti. Questo, a nostro parere,
dev’essere interpretato come un’influenza, un ascendente
della filosofia di Foucault sull’ultima stagione teorica di
Deleuze. Anticipiamo la nostra tesi: ci appare utile
rileggere, in stretta connessione, il testo che nel 1986
Deleuze scrive sul pensiero di Foucault e quello del 1988
sul Barocco, poiché alcune fra le questioni toriche e le
formulazioni filosofiche più interessanti del secondo
trovano il loro nucleo genealogico nel primo. La piegatura
18
Cfr. De Rosa, 2016, p. 51.
Ivi, pp. 50-51.
20
Ci riferiamo a Deleuze, 1988a.
19
219
219
è un’operazione che si compie su una linea; la linea è
l’elemento attraverso cui Deleuze legge aspetti e
implicazioni della soggettività in Foucault.
Situarsi nel mezzo
Nel capitolo iniziale del testo di De Rosa, dove vengono
affrontati aspetti di carattere metodologico, si cita il
seguente passo foucaultiano: “nessuno è [_]
responsabile di un’emergenza, nessuno può farsene
gloria; essa si produce sempre nell’interstizio”21. Questa
frase è utilizzata dall’autrice per introdurre un discorso
sulle diverse reazioni al libro di Foucault che si
produssero successivamente alla sua uscita. Quello di De
Rosa è un tentativo di “‘fotografare’, anche se
parzialmente, il momento di ‘emergenza’”22 mentre, a noi,
interessa segnalare la vicinanza tra questa formulazione
foucaultiana e un’altra, simile, appartenente a Deleuze23.
Quest’ultimo, in un’intervista di presentazione del suo
libro sul Barocco, afferma:
io ho la tendenza a pensare le cose come insiemi di linee [_] non è
la linea a trovarsi fra due punti, è invece il punto a essere all’incrocio
di più linee [_] Le cose e i pensieri germinano o crescono nel mezzo,
24
ed è lì che bisogna installarsi, è sempre lì che si produce la piega .
Ciò che ci sembra interessante è l’idea, comune ai due
autori, dell’emergenza (germinazione) come qualcosa da
21
Foucault, 1971, p. 39; cfr. De Rosa, 2016, p. 34.
De Rosa, 2016, p. 34.
Questa frase, peraltro, è contenuta in un saggio di Foucault su Nietzsche, autore
fondamentale per la formazione di entrambi i pensatori.
24
Deleuze, 1988b, p. 213.
22
23
220
220
rintracciare in un interstizio (nel mezzo). Per esempio,
questo è il caso del pensiero che, secondo Deleuze, “si
produce nell’interstizio, nella disgiunzione tra vedere e
parlare”25.
Inoltre, rileggendo il diniego contenuto nella citazione di
Foucault, secondo cui un soggetto non è responsabile di
un’emergenza, possiamo scorgere un altro tratto che
accomuna i due autori. Ci riferiamo a quei tratti che
Roberto Esposito ha riassunto con la formula “filosofia
dell’impersonale”26. De Rosa dedica le ultime pagine del
suo libro a questo aspetto del pensiero foucaultiano, e
all’interpretazione di Esposito. Istituendo un interessante
parallelo tra alcuni problemi di carattere matematico e
quella che sembra emergere come la struttura
predominante del soggetto contemporaneo, l’autrice
ricava una formula significativa per valutare l’opera di
Foucault. Secondo De Rosa, “il teorema di incompletezza
ha ormai perso il suo potere disorientante: il concetto di
limite costitutivo del sapere, di ‘finitudine’ dell’umano, si è
radicato nella nostra cultura, in quanto tratto caratteristico
dell’episteme che abitiamo”27. La consapevolezza della
finitudine umana come peculiarità del discorso culturale
contemporaneo è uno degli ‘effetti’ dell’opera di Foucault
che però, secondo un’esigenza del metodo foucaultiano,
non si può ricondurre alla semplice volontà dell’autore. In
altri termini, non si deve commettere l’errore di ridurre il
fascino e la pregnanza di un’opera al nome di colui che
l’ha generata poiché essa affonda inevitabilmente le
25
Deleuze, 1986b, p. 117.
Esposito, 2007, pp. 163-184.
27
De Rosa, 2016, p. 127.
26
221
221
proprie radici nella sua epoca. Bisogna, dunque,
articolare diversamente il rapporto che Foucault
intrattiene con la propria epoca e con quelle successive: il
groviglio di forze cui ci troviamo di fronte, dev’essere letto
secondo un’ottica differente.
Il dentro e il fuori
Durante la conversazione che abbiamo citato all’inizio,
Deleuze, riferendosi a uno scritto intitolato La vita degli
uomini infami28, individua nella linea uno dei concetti più
adatti per interpretare l’opera di Foucault. La linea in
questione è quella del ‘fuori’: questo termine non indica
un semplice spazio contrapposto all’interiorità del
soggetto, bensì “qualcosa di più lontano di qualunque
mondo esteriore [_] qualcosa di più vicino di qualunque
mondo interiore”29. Tale concetto appare in un saggio
foucaultiano del 1966 (stesso anno di pubblicazione di Le
parole e le cose), dal titolo appunto Il pensiero del di
fuori30. In questa circostanza, un pensiero del ‘di fuori’ (o
più comunemente del fuori) viene elaborato ed esplicato a
partire dall’opera di Maurice Blanchot. Gli scritti di
quest’ultimo, infatti, sarebbero in grado di farci avvertire
“la presenza reale, assolutamente lontana, scintillante,
invisibile [_] di questo stesso pensiero”31. Così, si può
elaborare un concetto adeguato di questo fuori, secondo
Foucault, solamente a patto di non concepire più il
linguaggio “come luogo della verità e legame del
28
Foucault, 1977b.
Deleuze, 1986a, p. 148.
30
Vedi Foucault, 1966b.
31
Ivi, pp. 115-116.
29
222
222
tempo”32, ma di concentrarsi sulla capacità di
proliferazione e sulla forza impersonale delle parole.
Nell’interpretazione di Deleuze, dunque, questo concetto
viene recuperato, ampliato e associato a quello di linea,
che funge da rappresentante di questo spazio ‘altro’,
paradossale poiché lo abitiamo e, insieme, ci abita. Quel
che spicca nella concettualizzazione e nel commento
deleuziano di questo ‘fuori’ è l’esigenza di non individuarlo
in opposizione al ‘dentro’ con cui siamo soliti identificare
la soggettività, bensì di concepirlo come elemento
assolutamente impersonale: è un fuori del pensiero, un
rovescio di esso, non un fuori dall’individuo concepito
come interiorità. Per questo motivo ci è sembrato
opportuno riferirci a una linea intensiva, che ci attraversa
e ci costituisce nel rapporto con questo ‘fuori’ del
pensiero, rintracciabile più facilmente, secondo Deleuze,
“ovunque il pensiero affronti qualcosa come la follia, la
vita o la morte”33. È, d’altronde, a partire dalla riflessione
su esperienze eccezionali (come testimoniato sin dalle
sue prime ricerche34) che Foucault ha potuto
intraprendere una straordinaria ricognizione dell’episteme
classica. L’insieme di ciò che rientra sotto questa
espressione è indicato da Foucault anche come il
‘Medesimo’ di un dato periodo storico, ossia una “sorta di
conoscenza implicita delle logiche secondo cui, di epoca
in epoca, le cose possono essere ordinate, diversificate o
assimilate”35; mentre la follia rappresenta “la grande
32
Ivi, p. 133.
Deleuze, 1986a,p. 147.
Basti citare la sua tesi di dottorato, Storia della follia nell’età classica (vedi Foucault,
1961).
35
De Rosa, 2016, p. 85.
33
34
223
223
Alterità che da sempre abita la società”36. Su
quest’aspetto il testo di De Rosa è estremamente diretto:
“senza una Storia della follia non ci sarebbe stata
neanche una ‘storia della somiglianza’ [_] L’idea di follia
come ‘Alterità’ della ragione costituirebbe, dunque, a
pieno titolo una condizione di possibilità per la nascita de
Le parole e le cose”37. Così Deleuze individua nella linea
di questo fuori “il nostro doppio”38, da non confondere,
sottolinea, con l’esteriorità, che sarebbe ancora una
forma39.
Per comprendere in che modo questo ‘pensiero del fuori’
interagisca con l’interpretazione deleuziana del Barocco
prendiamo le mosse dalla seguente citazione da
Foucault, scelta da De Rosa come esergo per l’ultimo
capitolo del suo testo: “Il mondo quale noi lo conosciamo
[_] è [_] una miriade d’avvenimenti aggrovigliati”40.
Traslando quest’affermazione l’autrice riconosce l’opera
di Foucault come un “groviglio di eventi, forze ed effetti
parziali”41 di cui seguire il percorso, descritto dalle linee
che lo attraversano. Ma un’idea simile, secondo cui il
mondo è leggibile come intreccio, tessitura, viluppo, la
ritroviamo al centro dell’universo barocco indagato da
Deleuze. In esso “ci sono pieghe ovunque: nelle rocce,
nei fiumi e nei boschi, negli organismi, nella testa o nel
cervello, nelle anime o nel pensiero”42.
36
Ivi, p. 86.
Ibidem.
38
Deleuze, 1986a, p. 148.
39
Cfr. Deleuze, 1986b, p. 116.
40
Foucault, 1971, p. 44; cfr. De Rosa, 2016, p. 105.
41
De Rosa, 2016, p. 105.
42
Deleuze, 1988b, p. 207.
37
224
224
L’immagine del groviglio, insomma, ci pare restituire una
rappresentazione fedele di entrambi i piani dell’edificio
che, secondo Deleuze, costituiscono l’universo barocco.
Quello basso, caratteristico della materia, è un brulichio di
forme, pieghe, vita, caratterizzato da una “ubiquità del
vivente”43 che rappresenta il momento di verità del
preformismo leibniziano. Mentre il piano superiore, quello
dell’anima, è abitato dalla monade “che esprime il mondo
intero”44 ed è perciò “infinitamente piena di pieghe”45.
Quest’ultima caratteristica della monade leibniziana (che
contiene il mondo nella sua interezza, nel suo “stato di
clausura”46) è particolarmente significativa per la filosofia
di Deleuze. Da una parte, infatti, essa consente di tenere
insieme il ‘fuori’ aggrovigliato delle serie infinite che
compongono il mondo e il ‘dentro’ oscuro, ermeticamente
sigillato, della monade. Dall’altra, il fatto che la monade
esprima “più chiaramente una piccola regione del
mondo”47, rende possibile individuare la piega
caratteristica che contraddistingue ogni singola monade.
Ciascuna di esse, in altre parole, è piegata diversamente
da ogni altra, poiché ognuna costituisce un punto di vista
assolutamente singolare sul mondo, che pure contiene
interamente.
Ciò che abbiamo tentato di mostrare è che
un’interpretazione così originale della filosofia di Leibniz e
del Barocco riprende e sviluppa motivi, concetti e spunti
già emersi nella lettura che Deleuze propone dei testi
43
Deleuze, 1988a, p. 16.
Ivi, p. 41.
Ibidem.
46
Ivi, p. 37.
47
Ivi, p. 41.
44
45
225
225
foucaultiani. Concetti come quelli di linea e di fuori,
sebbene siano ‘piegati’ diversamente (ci sia concessa
questa licenza terminologica) mantengono una centralità
teorica anche in questo libro, dalla testualità fitta e a tratti
vertiginosa.
Certo, si tratta di due pieghe diverse. La prima sembra
riguardare maggiormente le questioni legate al soggetto e
alle pratiche di soggettivazione; mentre la seconda è
descritta da Deleuze come un tratto operativo, un
concetto differenziale in grado di descrivere il mondo
barocco e la filosofia leibniziana nella loro interezza.
Nonostante ciò, riteniamo importante sottolineare e
indagare la contiguità concettuale di queste opere. A
riprova di quanto sostenuto vi è una banale evidenza che
ci è servita come punto di partenza: il concetto di piega
appare tematizzato per la prima volta, nell’opera di
Deleuze, proprio nella sezione finale del libro su
Foucault48. Esso poi appare proficuo anche per altre
operazioni concettuali, sulle quali non abbiamo lo spazio
per dilungarci, come, ad esempio, l’accostamento tra
alcuni aspetti della riflessione foucaultiana e quella di
Martin Heidegger49.
Genealogie foucaultiane
La nostra ricognizione ha tentato di utilizzare il bel libro di
De Rosa per approfondire alcune questioni che
riguardano da vicino i nostri interessi di ricerca.
48
Cfr. Deleuze, 1986a, pp. 125-162.
Vedi, ad es., Deleuze, 1986a, pp. 148-151; Deleuze, 1986b, pp. 143-151; e anche
Deleuze, 1988a, p. 18 e 50.
49
226
226
Vorremmo concludere riassumendo sommariamente altri
importanti contenuti nel testo che abbiamo sinora tenuto
in secondo piano. Oltre a una proficua interrogazione
degli esiti del pensiero foucaultiano, una parte importante
de L’ordine discontinuo è dedicata, per esempio, alla
ricostruzione dei debiti intellettuali che il pensatore
francese ha contratto con alcuni dei suoi maestri, nonché
alle ‘provenienze’ di alcune impostazioni metodologiche o
figure concettuali presenti in Le parole e le cose e, più in
generale, nella sua filosofia. Così fra gli autori che più
avrebbero contribuito direttamente alla formazione di
Foucault, l’autrice si concentra sulle figure di Jean
Hyppolite, Georges Dumézil e Georges Canguilhem.
Invece, tra le correnti e i movimenti cui l’opera del filosofo
sarebbe particolarmente vicina, secondo De Rosa
bisogna considerare attentamente gli storici dell’École des
Annales e lo strutturalismo, con il quale Foucault avrebbe
intrattenuto un rapporto definito come una questione di
‘etichetta’50. Le testimonianze dello stesso Foucault sul
tema, più che a sancire nettamente una sua adesione a
questo movimento (come d’altronde faceva Deleuze in un
noto saggio51), suggeriscono di leggere il suo interesse
per lo strutturalismo al fine di tentarne una ricostruzione
genealogica52.
Quest’ultimo termine, che spicca nel sottotitolo del testo –
Una genealogia foucaultiana–, costituisce il perno teorico
a partire da cui suggeriamo di leggere l’intero libro
nonché, à rebours, il titolo stesso. Come l’autrice
50
De Rosa, 2016, p. 90.
Ci riferiamo a Deleuze, 1968.
52
Cfr. De Rosa, 2016, p. 93 sgg.
51
227
227
sottolinea in un paragrafo teoreticamente intenso53, la
genealogia è “una via filosofica per indagare la storia”54
che si occupa di studiare la “formazione dispersa,
discontinua, e regolare insieme”55 dei discorsi. Un ordine
discontinuo è l’opera foucaultiana: il progetto genealogico
di De Rosa affronta con fermezza e tenacia gli obblighi
cui la lezione di un autore come Foucault ci impone.
Queste stesse pagine, in fin dei conti, non sono altro che
un tentativo di rispondere affermativamente all’appello
silenzioso sotteso a ogni pagina del libro di De Rosa:
concentrarsi sulle forze che compongono una determinata
formazione culturale, lasciandosi guidare dalle intensità
che in essa balenano.
Riferimenti bibliografici
228
ALLIEZ, E. (a cura di) (1998), Gilles Deleuze. Une vie philosophique,
Institut Synthélabo pour le progrés de la connaissance, Le PlessisRobinson;
CHATELET, F. (a cura di) (1973), Histoire de la philosophie. Idées,
Doctrines. Le XX siècle, vol. VIII, Hachette, Paris; tr. it. di L. Sosio,
Storia della filosofia. La filosofia del XX secolo, vol. VIII, Rizzoli,
Milano 1976;
COLONNELLO, P. (2016), L’ombra della madre tra Schreber e
Leonardo. Rileggendo due saggi freudiani del 1910, in “L’inconscio.
Rivista italiana di Filosofia e Psicoanalisi”, n. 1, pp. 57-71;
DELEUZE, G. (1968), A quoi reconnaît-on le structuralisme?, in
Châtelet (a cura di) (1973); tr. it., Da che cosa si riconosce lo
strutturalismo?, in Châtelet (a cura di) (1973), pp. 194-217;
53
Ivi, pp. 29-36.
Ivi, p. 40.
55
Foucault, 1970b, p. 50.
54
228
DELEUZE, G.(1986a), Un portrait de Foucault, in “L’Autre Journal”; tr.
it., Un ritratto di Foucault, in DELEUZE (1990), pp. 137-158;
DELEUZE, G. (1986b), Foucault, Les Éditions de Minuit, Paris; tr. it. di
2
P. A. Rovatti e F. Sossi, Foucault, Cronopio, Napoli 2009 ;
DELEUZE, G. (1988a), Le pli. Leibniz et le Baroque, Minuit, Paris; tr. it.
a cura di D. Tarizzo, La piega. Leibniz e il Barocco, Einaudi, Torino
2002;
DELEUZE, G. (1988b), La pensée mise en plis. Sur Leibniz, in
“Libération”, 22/9/1988; tr. it, Su Leibniz, in DELEUZE (1990), pp. 207216;
DELEUZE, G. (1990), Pourparlers, Les Éditions de Minuit, Paris; tr. it.
di S. Verdicchio, Pourparler, Quodlibet, Macerata 2000;
DE ROSA, D. (2016), L’ordine discontinuo. Una genealogia
foucaultiana, Mimesis, Milano;
DE ROSA, D. (2015), Vedere l’invisibile. Foucault e Lacan su Las
Meninas, in AA. VV., “Palinsesti”, vol. 3, Luigi Pellegrini Editore,
Cosenza 2015, pp. 275-290;
ESPOSITO, R. (2007), Terza persona. Politica della vita e filosofia
dell’impersonale, Einaudi, Torino;
FOUCAULT, M. (1961), Folie et déraison. Histoire de la folie à
l’âgeclassique, Gallimard, Paris; tr. it. di F. Ferrucci, Storia della follia
nell’età classica, Rizzoli, Milano 1963; nuova ed. 1980;
FOUCAULT, M. (1966a), Les mots e les choses, Gallimard, Paris; tr. it.
di E. A. Panaitescu, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze
umane, Rizzoli, Milano 1978;
FOUCAULT, M. (1966b), La pensée du dehors, in “Critique”, n. 229,
giugno 1966, pp. 523-546; successivamente in FOUCAULT (1994), vol.
I, pp. 518-539; tr. it. di C. Milanese, Il pensiero del di fuori, in ID.,
Scritti Letterari, a cura di C. Milanese, Feltrinelli, Milano 1971, pp.
111-134;
FOUCAULT, M. (1970a), Theatrum philosophicum, in “Critique”, n. 282,
novembre 1970, pp. 885-908; successivamente in FOUCAULT (1994),
vol. I, pp. 75-98; tr. it. di F. Polidori, Theatrum philosophicum, in “aut
aut”, n. 277-278, 1997, pp. 54-74;
FOUCAULT, M. (1970b), L’ordre du discours, Gallimard, Paris 1971; tr.
it. di A. Fontana, L’ordine del discorso, Einaudi, Torino 1972;
229
229
FOUCAULT, M. (1971), La génealogie, l’histoire, in AA. VV., Hommage
à Jean Hyppolite, P.U.F., Paris 1971, pp. 145-172; tr. it., Nietzsche, la
genealogia, la storia, in ID. (1977a), pp. 29-54;
FOUCAULT, M. (1977a), Microfisica del potere. Interventi Politici,
Einaudi, Torino 1977;
FOUCAULT, M. (1977b), La vie des hommes infâmes, in “Les Cahiers
du chemin”, n. 259, pp. 12-29; successivamente in FOUCAULT (1994),
vol. III, pp. 237-252; tr. it. di G. Zattoni Nesi, La vita degli uomini
infami, Il Mulino, Bologna 2009;
FOUCAULT, M. (1994), Dits et Écrits, 4 vol., Gallimard, Paris;
FREUD, S. (1910), Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci,
Franz Deuticke, Leipzig-Wien; successivamente in Gesammelte
Werke, vol. VIII, pp. 128-211; tr. it., Un ricordo d’infanzia di Leonardo
da Vinci, in ID., Opere Complete, vol. VI, BollatiBoringhieri, Torino
1974, pp. 207-284;
FREUD, S. (1911), Psychoanalytische Bemerkungen über einen
autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia
paranoides),
in
“Jahrbuch
für
psychoanalytische
und
psychopathologische Forschungen”, vol. III(1), Franz Deuticke,
Leipzig-Wien; successivamente in Gesammelte Werke, vol.VIII, pp.
239-320; tr. it., Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia
(dementia paranoides) descritto autobiograficamente, in ID., Opere
Complete, vol. VI, Bollati Boringhieri, Torino 1974, pp. 333-406;
NANCY, J-L. (1998), Pli deleuzien de la pensée, in ALLIEZ (1998), pp.
115-124; tr. it. di P. Di Vittorio, Piega deleuziana del pensiero, in “aut
aut”, n. 276, 1996, pp. 31-37; tr. it. di T. Auriemma in NANCY (2008);
pp. 11-21;
NANCY, J-L. (2008), Le differenze parallele. Deleuze e Derrida, a cura
di T. Ariemma e L. Cremonesi, Ombre corte, Verona;
NOVA, A. (a cura di) (1997), Las Meninas. Velázquez, Foucault e
l’enigma della rappresentazione, il Saggiatore, Milano;
PALOMBI, F. (2014), Foucault, Edizioni Rcs, Milano;
PALOMBI, F. (2016), Immagini foucaultiane, in DE ROSA (2016), pp. 715;
SCHREBER, D. P. (1903), Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken,
Mutze, Leipzig; tr. it. di F. Scardanelli e S. De Waal, Memorie di un
malato di nervi, Adelphi, Milano 1974.
230
230
UNA FILOSOFIA “MILITANTE”. TRACCE DI
LETTURA SU LA LOTTA PER LA SCIENZA DI
GIUSEPPE SEMERARI
Rossana de Gennaro
Filosofar “dal basso”
La lotta per la scienza1, scritto da Giuseppe Semerari
negli anni Sessanta2, fu uno dei testi di riferimento del
corso di filosofia teoretica che tenne nell’anno 1978793, dedicato al tema della scienza.
1
La nuova edizione del testo di GIUSEPPE SEMERARI, La lotta per la scienza,
Guerini e Associati, Milano 2013, è stata curata da Francesco Valerio e porta una
premessa di Fulvio Papi.
2
Il curatore Francesco Valerio nella Nota premessa al testo ricorda che le ricerche che
confluiscono in questa opera nella forma di sette saggi sono state realizzate tra il 1961
ed il 1964. Come risulta dalla bibliografia degli scritti di Semerari curata da Ferruccio
De Natale, riprodotta nel volume a cura di F. Fistetti e F. Semerari, La malinconia di
Hume. Sul pensiero di Giuseppe Semerari (Guerini e Associati, Milano 2007, alle pp.
131-155), il primo ed il terzo saggio erano inediti, mentre gli altri saggi che
costituiscono i capitoli del testo erano stati pubblicati su “aut-aut” e sul “Giornale critico
della filosofia italiana”. Il capitolo II, Le scienze nella crisi della ragione, su “aut-aut”,
1962, 69; il capitolo IV, La scienza della soggettività( con il titolo: La soggettività:
fenomenologia come marxismo), nel “Giornale critico della filosofia italiana”, 1964, vol.
XVIII; il capitolo V, La intenzionalità tecnica, su “aut-aut”,1962,72; il capitolo VI, La
comunicazione (con il titolo: Aporetica della comunicazione), nel “Giornale critico della
filosofia italiana”,1961, vol. XX; il capitolo VII, Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini, su “autaut”, 1963, 77.
3
Dopo l’edizione del 1965 l’opera fu ripubblicata nel 1979, come seconda parte del
testo Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini. Per un razionalismo filosofico-politico, Bertani,
Verona 1979. La prima parte era invece costituita dal testo della seconda edizione di
Scienza nuova e ragione, del 1966 (la prima edizione è del 1961), testo che è stato
recentemente ripubblicato, sempre da Guerini e Associati, quale primo volume delle
Opere di Giuseppe Semerari, a cura di Furio Semerari, con una premessa di Carlo
Sini.
231
231
Nel rileggerlo, nella nuova edizione per i tipi di Guerini,
ho avvertito un sentimento di nostalgia – la lettura mi
riportava agli anni della mia esperienza di studentessa
– avendo nello stesso tempo la possibilità di verificare,
a quasi cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione, la
straordinaria attualità del testo, che conferma
l’opportunità della riedizione delle principali opere del
filosofo barese. Si tratta di un’opera ricca di
interessanti indicazioni di ricerca storiografica e di una
grande varietà di temi, sempre trattati con grande
spessore teoretico, nella quale confluiscono molti dei
nuclei problematici affrontati dall’autore nel corso della
sua storia intellettuale, a definire una prospettiva
critica per la quale “la ragione non è una facoltà
psicologica, né essenza metafisica, né trascendentale,
né riducibile ad un modello logico-sintattico: è,
piuttosto, lotta per la ragione4.” E si coglie quella
tensione verso una riflessione eticamente orientata
che avevo apprezzato nel professore che, con l’ardore
del neofita, avevo scelto come maestro, quando,
appena iscritta, mi accingevo ad affrontare gli studi di
filosofia.
Per noi studenti le lezioni di Semerari erano il luogo
dove si costruiva una comunità di relazione e di
dialogo, al di là di quella sensazione di solitudine e di
atomismo che avvertivamo nell’ambiente universitario;
nelle due ore che dedicava, per tre volte alla settimana,
all’attività didattica, si sviluppava un clima di scambio e
di relazione che ci faceva, forse illusoriamente, sentire
4
F. Papi, Premessa alla nuova edizione, ne La lotta per la scienza, cit., p.XIII.
232
232
protagonisti
della
costruzione
del
filosofare.
Riconoscevamo, nella capacità del professore di
rivolgersi distintamente a ciascuno dei suoi studenti e
di coinvolgere nella relazione didattica tutti i suoi
ascoltatori, la manifestazione della pratica democratica
del “filosofare dal basso”, testimoniata dalle riflessioni
contenute in Filosofia e Potere. Essa significa:
Compiere un’assunzione empiristica per la quale l’uomo
materialisticamente determinato è il principio della
filosofia [_] Il “filosofare dal basso”[_] si mantiene in un
permanente stato di domanda, nel quale si rispecchia la
struttura problematica sia dell’uomo empiricamente
osservabile sia delle sue relazioni transazionali col
mondo.5
233
Sulla prima pagina il testo portava la seguente dedica:
Questo libro è dedicato ai giovani contestatori americani
di Berkeley, ai cinesi della rivoluzione culturale, ai francesi
del maggio del ’68, ai cecoslovacchi della primavera di
Praga, e a tutti gli altri – che, traducendola in azione,
hanno provato come la cultura possa diventare critica
vissuta e vivente di ogni potere reificato, strumento di
dominio dell’uomo sull’uomo.
La filosofia vi viene intesa come “pratica militante”,
capacità dei soggetti di rimettere al centro della propria
visione del mondo se stessi, il loro vissuto, i loro bisogni,
contro le certezze apparentemente consolidate; come una
scelta per la scienza – la espressione del livello più alto
5
G. Semerari, Filosofia e potere, Dedalo, Bari 1973, pp. 11-12.
233
del domandare – e rigetto di atteggiamenti fideistici che
mostrino i vigenti rapporti di potere sotto l’aspetto della
necessità.
Ripercorrere la molteplicità dei temi teoretici e la varietà
dei problemi affrontati nei sette saggi che compongono La
lotta per la scienza e coprono un arco di tempo compreso
tra il 1961 ed il 1965, è impresa ardua, che deve
assumere come riferimento il fervore intellettuale che
accompagnò fondamentali trasformazioni del tessuto
economico e sociale italiano in quegli anni, e la proiezione
e trascrizione che ebbero sul piano della riflessione
filosofica e nel dibattito politico in corso allora.
Sono gli anni in cui Semerari insegna, oltre che filosofia
teoretica, filosofia morale all’Università di Bari, e ha già
collaborato con numerose riviste di fama internazionale,
distinguendosi, nel panorama filosofico italiano, per
un’originale lettura della filosofia di Pantaleo Carabellese,
suo maestro6, e per il confronto con i temi del
neoilluminismo italiano, del quale sono interessante
6
La comprensione delle iniziali posizioni teoriche semerariane e della loro successiva
evoluzione non può non tenere conto del rapporto con la filosofia di P. Carabellese .
Secondo F. De Natale: “Sul piano teorico la riflessione carabellesiana ha costituito il
punto di avvio per la ricerca filosofica semerariana, permanendo sempre un costante
termine di riferimento, pur quando la distanza tra le rispettive prospettive filosofiche si è
fatta incolmabile e tangibile: dai primi scritti del 1948 e 1949, sino al volume del 1953
(Storia e storicismo), poi riedito il 1960 (Storicismo e ontologismo critico), ai lunghi
saggi degli anni Settanta poi raccolti nel volume del 1982 (La sabbia e la roccia.
L’ontologia critica di P. Carabellese), dalla edizione della carabellesiana La filosofia
dell’esistenza in Kant, del 1969, sino ai confronti tra Carabellese e Varisco del 1985 e
tra Carabellese ed Heidegger, del 1989, sono venti i contributi esplicitamente dedicati
a ripensare l’ontologismo critico.”
Cfr. F. De Natale, Filosofia come Lebensberuf. Brevi considerazioni sull’opera ed il
pensiero di Giuseppe Semerari, in Furio Semerari (a cura di) La certezza incerta. Scritti
di Giuseppe Semerari con due inediti dell’autore, Guerini e Associati, Milano 2008, p.
80.
234
234
testimonianza vari articoli e recensioni comparse tra il
1952 ed il 1954 nel “Giornale critico di filosofia”. Dal 1954
è redattore della prestigiosa rivista “aut aut”, diretta da
Enzo Paci.
Fulvio Papi, nella Premessa, sostiene che l’interesse
manifestato da Semerari per il problema della costituzione
della soggettività – centrale nel suo pensiero – deve
spiegarsi con la temperie storica: gli anni ‘50 erano quelli
della ricostruzione, del rifiuto di una definizione classista e
borghese della figura umana, dell’avvicinamento del ceto
intellettuale italiano alla classe operaia e contadina, e
della scoperta delle scienze sociali e della psicoanalisi
freudiana, quali potenti strumenti in grado di decostruire la
definizione idealistica ed astratta del soggetto per
raggiungere una più grande libertà teorica. In questo
clima intellettuale nasceva una prospettiva teoretica
radicalmente umanistica, volta ad una ridefinizione della
soggettività alla luce delle categorie teoriche offerte dal
marxismo, dalla fenomenologia, dalla psicoanalisi, dalle
scienze sociali, in grado di contribuire al progetto di una
rifondazione della ragione che fosse “la ricerca delle
condizioni oggettive e soggettive per il passaggio dalla
presente civiltà dei mezzi [_] ad una civiltà dei fini7.”
Semerari si proponeva di portare la conoscenza della
fenomenologia nel dibattito filosofico italiano, misurandosi
anche con l’esistenzialismo positivo di N. Abbagnano, con
7
Semerari, ripubblicando, nel testo Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini, le due opere,
Scienza nuova e ragione e La lotta per la scienza, scriveva nella Prefazione di non
aver affatto voluto creare una impossibile fusione tra fenomenologia e marxismo, ma
di avere lavorato alla “determinazione della critica della ragione come, insieme, critica
della economia politica e critica della funzione di potere della scienza nell’attuale
divisione classista della società.” Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini, cit., p. 10.
235
235
il relazionismo di Enzo Paci, e con la critica alla
volgarizzazione del marxismo, tramite un’originale
interpretazione del pensiero di Marx, letto secondo una
prospettiva che vi rintraccia un percorso unitario, dai
Manoscritti al Capitale.
Come afferma Rovatti8, la battaglia per fare accettare la
fenomenologia nella filosofia italiana è una battaglia per
una fenomenologia concreta; Semerari considera la
fenomenologia una filosofia della “porta aperta”9, una
prassi, anzi un agire; è una filosofia dell’ospitalità, che,
poiché è possibilità di ospitare i pensieri, è anche un agire
ed un’etica. Aprire il dibattito filosofico alla fenomenologia
era un’operazione nuova e coraggiosa, significava
prendere posizione contro i limiti concettuali dello
storicismo, ritrovare nella riflessione sulla costituzione
trascendentale della coscienza la possibilità di ricercare,
di possedere, il senso e il valore del divenire, contro tutte
le rinnovate edizioni dello storicismo e la limitazione della
filosofia a metodologia dell’interpretazione storiografica.
Riferirsi alle categorie del marxismo e della
fenomenologia non significava, d’altra parte, voler
realizzare un tentativo di sintesi fra due filosofie per molti
aspetti diverse ed intraducibili l’una nell’altra, ma farne
delle alleate nella comune lotta contro le varie forme di
8
Così si esprime P. A. Rovatti ne La fenomenologia di Giuseppe Semerari, un breve
saggio comparso nel volume
collettaneo La certezza incerta. Scritti di Giuseppe
Semerari con due inediti dell’autore, cit., pp. 181-203.
9
L’atteggiamento fenomenologico consiste nell’accettazione di un concetto vastissimo
di esperienza, al limite della indeterminatezza. “L’atteggiamento fenomenologico della
filosofia odierna risiede in una sorta di prassi della porta aperta motivata dalla
coscienza che quello che viviamo è sempre qualcosa di meno di quello che viviamo
pre-categorialmente.” G. Semerari, Il carattere del filosofare contemporaneo, in Da
Schelling a Merleau-Ponty, Cappelli, Bologna 1963, pp. 394-395.
236
236
feticismo (economico/sociale, politico/scientifico) “[_] in
base alla comune esigenza di radicalizzare la fondazione
della oggettività – si presenti questa come mondo civile o
naturalizzazione scientifica10.”
Mi pare opportuno partire, per una ricognizione del testo,
da quanto asserisce De Natale a proposito dei temi
principali che emergono nella riflessione di Semerari,
sostenendo che possono venire raccolti intorno ad alcuni
nuclei tematici forti, o dei Leitfaden che percorrono il suo
pensiero11.
Tra questi il tema della critica alle scienze nella loro
definizione formalistica e l’appello alla riflessione sulle
loro finalità; Semerari intendeva la scienza come presa di
posizione, scelta, collocazione nel dibattito – che è
sempre intellettuale e politico – per portare le ragioni della
vita nella costruzione del sapere, per farne una
progettazione razionale integralmente umana, per fare
degli uomini concreti legati nella comunità umana il
principio di imputazione e di auto-responsabilità delle
formazioni significanti.
La scienza è anche una delle principali strategie di
rassicurazione esistenziale ed è vista in rapporto al tema
della soggettività come corpo, fatticità, vissuto; si tratta di
un nucleo teorico al quale vengono funzionalizzate le
categorie teoriche della responsabilità, della possibilità,
della relazione, della comunicazione, specie laddove al
filosofo appare urgente un ripensamento delle finalità
della civiltà, alla luce della critica al tecnicismo, ed alla
10
11
G. Semerari, Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini, cit., p. 12.
F. De Natale, Filosofia come Lebensberuf, cit., p. 78.
237
237
inversione del rapporto mezzi/fini, per costruire una
comunità della relazione e della comunicazione.
Lotta per la scienza e principio di responsabilità
Il confronto con la fenomenologia di Husserl, tramite
l’interpretazione della Crisi delle scienze europee, è una
delle linee conduttrici della riflessione contenuta ne La
lotta per la scienza.
Sin dalle prime pagine della Prefazione, Semerari
chiarisce l’idea generale che guida la riflessione:
Il titolo del libro è giustificato dall’idea generale, che
sostiene le ricerche, essere la scienza oggi chiamata a
lottare su due fronti: da una parte, contro le restrizioni e i
blocchi a cui la costringono le sue versioni e
interpretazioni meramente formalistiche, e, dall’altra,
contro le resistenze antiscientifiche, forti soprattutto e nel
tuttora imperante modo prescientifico di concepire l’uomo
e nel campo delle relazioni ed istituzioni etico-sociali, ove
la scienza viene boicottata e stimata alla stregua di
un’insolente intrusa o, come diceva Dewey, di un vero e
proprio invasore.12
12
G. Semerari, La lotta per la scienza, op. cit., p. 1.
238
238
È lo stesso autore a sottolineare il legame teorico con le
riflessioni di Scienza nuova e ragione13 dove aveva
indicato nel narcisismo e nel masochismo della ragione le
due opposte, e false, in quanto complementari, alternative
del pensiero, per cui lo scientismo, da un lato, il nichilismo
irrazionalista, dall’altro, negano e conculcano lo spazio
della filosofia come pensiero critico.
Al centro dell’antropologia filosofica contemporanea,
Semerari vede il problema messo in evidenza da Husserl
nella Krisis, dell’imperialismo del modello fisicalistico delle
scienze; la chiusura dei linguaggi scientifici nel loro
assetto logico/formale è il presupposto perché le scienze
siano chiuse in quel tecnicismo assiologicamente
indifferente, dovuto alla frattura, ancora interna alla
mentalità scientifica, tra mondo della natura e mondo
umano, tale che l’applicazione degli strumenti scientifici e
dei risultati ha influenzato i mezzi piuttosto che i fini della
vita. La crisi delle scienze attraversa anche l’uomo,
teoricamente capace di scatenare – come Semerari dirà
nell’ultimo di questi scritti, Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini
– una potentissima progettualità razionale relativa ai
mezzi tecnici, capace di controllare il movimento delle
forze naturali, ma anche del tutto incapace di orientare
queste strategie e procedure tecniche verso delle finalità
13
Il rapporto teorico tra La lotta per la scienza e le altre due opere di G. Semerari, La
filosofia come relazione (prima edizione, “Centro librario”, Sapri 1961, ora edito da
Guerini e Associati, Milano 2009, a cura di F. De Natale) e Scienza nuova e Ragione
(prima edizione in Pubblicazioni dell’Istituto di Filosofia della Università degli studi di
Bari, Lacaita, Manduria 1961, vol. n. 3, pubblicato in seconda edizione nel 1966 da
Silva, Milano, e, più recentemente, nella nuova edizione di Guerini e Associati già
citata), viene sottolineato dall’autore nella stessa Prefazione, dove afferma che La lotta
per la scienza rappresenta lo sviluppo e la prosecuzione delle riflessioni contenute
nelle due precedenti opere.
239
239
razionali; se vi riuscisse, sarebbe capace di controllare se
stesso e il mondo umano in cui è implicato, con le sue
relazioni sociali e morali.
Nell’incipit del primo saggio, L’atteggiamento scientifico,
Semerari chiarisce che il rapporto tra la lotta per la
scienza e la ridefinizione della ragione è un nodo teoretico
fondamentale perché, argomenta l’autore, dopo la
profonda riforma della nozione di verità nella scienza e
nella filosofia, originata dal nuovo rapporto tra soggetto
esistente e verità,
Il problema della scienza appare assai più vasto di una
particolare impostazione culturale e del sapere qualche
cosa secondo una certa organizzazione logico-formale.
Esso concerne, prima di tutto, lo sforzo di
autoconservazione della specie, la lotta contro
l’insicurezza esistenziale e il pericolo della distruzione e
l’affrancamento dall’estraneo e dalla paura.14
Porsi il problema della scienza implica un allargamento di
prospettiva rispetto all’ impostazione che racchiude la
scienza nella sua organizzazione logica, formale,
sintattica. Coinvolge la riflessione circa il senso e la
direzione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche per
la civiltà umana.
Di fronte alle trasformazioni culturali introdotte
dall’ampliamento delle conoscenze tecnico-scientifiche,
così pervasive da incidere sulla stessa specie biologica,
la scienza deve assumere un atteggiamento di
14
La lotta per la scienza, cit., p. 11.
240
240
responsabilità se è suo compito approntare gli strumenti
per la riorganizzazione sociale ed elaborare risposte alle
domande che emergono dalla trasformazione del tessuto
storico; la riflessione filosofica non può evitare di
misurarsi con questa realtà, identificandosi, al limite, con
l’estrema problematicità del sapere scientifico.
Il filosofare contemporaneo deve tentare una
radicalizzazione ontologica della scienza. La riflessione
su di essa, ove si assuma il concetto fenomenologico di
intenzionalità, consente la tematizzazione della relazione
primaria con il mondo, che è il limite estremo del sapere
di una soggettività evidenziata come corpo e materialità,
criterio di definizione del significato della scienza,
principio di imputazione per cui se ne possa ravvisare il
senso, e rimanda alla funzione della filosofia come critica
immanente delle scienze15, decostruzione, ricerca
dell’origine.
La definizione dell’atteggiamento filosofico come
improntato da un’alta consapevolezza della propria
responsabilità di fronte al mondo umano, è un motivo
teorico che percorre come un filo conduttore gran parte
delle opere di Semerari, se non tutte. Il tema è stato
introdotto già nel saggio Il carattere del filosofare
contemporaneo, del 1962, che precede di qualche anno
la Lotta per la scienza.
Nel saggio, posto in Appendice ad una serie di studi
storiografici nei quali i modelli teorici prodotti dai filosofi
nel corso della storia del pensiero si offrono
all’interpretazione, “più che come terreno di riflessione
15
Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini, cit., p. 15.
241
241
storica, come contesto di discussioni tuttora aperte e
argomento di decisioni personali”, Semerari espone l’idea
che la filosofia sia sempre “presa di posizione”:
(Il filosofare contemporaneo) è il momento del pensiero umano che
noi fronteggiamo e che è come l’orizzonte nel quale vanno a
inscriversi i nostri sforzi personali di indagine e di comprensione –
quali che, poi, siano per essere la efficacia ed il risultato di questi
16
sforzi.
Fare filosofia è determinare il proprio posto nell’ambito
della filosofia militante. E’ individuare, attraverso il dialogo
con i pensatori del passato, il punto dove può introdursi la
propria personale opera; questo è scelta, coraggio della
verità. Grazie a questo coraggio la filosofia penetra sotto
la apparente chiarezza del discorso comune.
Riprendendo da Whitehead l’idea che vi sia continuità tra
filosofia e senso comune, Semerari sostiene che non è
importante dare una definizione di che cosa sia il
filosofare, quanto determinare le implicazioni etiche e
politiche della scelta del filosofare. E’ questa idea che la
filosofia abbia una connotazione etica, che contribuisca a
configurare l’orizzonte umano come progetto possibile,
che guida i saggi del testo La lotta per la scienza, dove il
concetto
di
responsabilità
viene
connesso
all’atteggiamento scientifico.
Altrove, tematizzando il nesso scienza-responsabilità17,
Semerari riprende le riflessioni presenti nel testo del
16
Il carattere del filosofare contemporaneo, cit., p. 386.
È uno dei Leitfaden, o fili conduttori della filosofia di Giuseppe Semerari secondo F.
De Natale, in Filosofia come Lebensberuf, cit, pp. 77-106.
17
242
242
1960, Responsabilità e comunità umana, dove, nella
Premessa, sosteneva:
Al livello scientifico la responsabilità è il recupero della intenzionalità
smarrita dalle scienze positive nel loro travolgente sviluppo moderno.
Proporre la questione della responsabilità dello scienziato come
persona e della indagine scientifica stessa è chiedersi se esista, e
quale sia, una teleologia immanente della umanità e se abbia pretesa
18
originale, nel momento presente, l’esercizio della filosofia.
È agevole riconoscere la continuità di queste affermazioni
con quelle contenute nel testo del ‘65 dove l’autore
ribadiva che l’enorme crescita delle scienze e delle
relative tecniche non deve esaurirsi in se stessa ma deve
essere interpretata dalla filosofia che ha il suo obiettivo
nella determinazione di ciò che è la ragione per l’uomo e
di ciò che rende la storia veramente umana. L’alta
responsabilità che la scienza ha presentemente tanto
rispetto alla cultura quanto rispetto al destino biologico
della specie umana, la realizzazione ed il successo della
possibilità che l’uomo sappia intervenire attivamente sulla
sua evoluzione sì da guidarla e determinarla,
sono largamente legate alla consapevolezza, che la scienza avrà di
se stessa e dei propri compiti, alla capacità che essa riuscirà a
19
dispiegare come forza di riorganizzazione cosmica e sociale.
Nel testo in analisi, il senso del filosofare è affidato alla
capacità di intessere un dialogo con i linguaggi delle
18
19
G. Semerari, Responsabilità e comunità umana, Lacaita, Manduria, 1960, p. 5.
La lotta per la scienza, cit., p. 4.
243
243
scienze, e di definire i contorni di un nuovo umanesimo
che accolga la lezione di queste ultime.
La soggettività come Leiblickheit
L’interesse nei confronti della definizione di un campo
fondazionale della soggettività umana vivente e di un
nuovo umanesimo, è un tratto comune a molte
esperienze della filosofia italiana tra gli anni Cinquanta e
Sessanta.
Una riflessione di Antonio Negri, sulla costituzione di
una Italian Theory20, sostiene la tesi che negli stessi anni
era in corso di formazione, nella filosofia italiana,
un’originale filosofia politica che si riannoderebbe a più
recenti riflessioni sul carattere carattere decostruttivo
della filosofia e sul biopotere. Che una nuova filosofia
politica si sia affermata in Italia, lo si deve allo sforzo
compiuto dal neoilluminismo italiano (Bobbio, Geymonat),
per costruire una cultura laica, aperta agli orientamenti
internazionali, al rapporto con la fenomenologia, introdotta
da Enzo Paci e Giuseppe Semerari, e alla filosofia
pragmatica e neopositivista di G. Preti ed E. Rossi-Landi;
tali esperienze, nel quadro tormentato delle discussioni
sul marxismo sovietico e sulla concezione del Dia-mat,
20
Cfr. T. Negri, Una rottura italiana, http//www.uninomade.org/negri-una-rottura-italiana
e,
dello
stesso
autore,
A
proposito
di
Italian
Theory,
http://www.sinistrainrete.info/filosofia/3416-toni-negri-a-proposito-di-italian-theory.
244
244
avrebbero alimentato un’antropologia filosofica nuova21.
Seguendo le indicazioni interpretative di Negri, le
riflessioni sviluppate da Semerari costituirebbero dunque
un importante contributo, grazie alla convinzione con cui
difese “l’eresia fenomenologica”, alla “definizione di un
quadro filosofico che investiva la vita”. Nella prospettiva di
Semerari sono la fenomenologia ed il marxismo a portarci
nel cuore del problema della soggettività che, nel quarto
dei saggi, intitolato La scienza della soggettività, viene
considerato “il maggiore problema del pensiero
contemporaneo”22.
Come dimostrano le riflessioni che accompagnano la
pubblicazione de La lotta per la scienza come seconda
parte di Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini, nel 1979,
Semerari non intendeva certo riferirsi all’esigenza di
rinnovare
la
fondazione
di
un
“soggetto”
sostanzialisticamente inteso:
La ricerca dello spazio per la soggettività, nella fenomenologia (oltre
che nel marxismo) non è nostalgia per un mitico soggetto pre-istorico
[...], bensì determinazione delle condizioni per le quali la incarnazione
21
Negri sottolinea che negli anni Sessanta, nella filosofia italiana, stava emergendo
una forte reazione alla duplice influenza del gramscismo togliattiano e del pessimismo
francofortese. L’elaborazione dei presupposti filosofici di un pensiero politico
dell’alternativa, da parte di Panzieri, era affiancata dall’elaborazione di numerosi
filosofi: “Sia sul terreno della fenomenologia, (Paci e Semerari), sia sul terreno di una
filosofia pragmatica e neo-positivista, Preti e il proto linguista Rossi-Landi, insistevano
sull’importanza della “relazione fenomenologica” e riattaccandosi all’ultimo Husserl o al
secondo Wittgenstein esigevano una radicale rottura con ogni hegelismo residuo.
Personalmente penso che questo sfondo teoretico sia stato molto più importante,
nell’elaborazione di un pensiero dell’alternativa, di quello che la storiografia
accademica insiste essere stata la critica dellavolpiana.” T. Negri, A proposito di Italian
Theory, cit., p. 3.
22
La lotta per la scienza, cit., p. 58.
245
245
istituzionale e oggettiva dei soggetti reali non possa diventare
23
alienazione e reificazione.
Di fatto – dice Semerari – la fenomenologia instaura una
forma di solidarietà con ogni altra filosofia in cui il
problema dell’alienazione del soggetto sia centrale. Dal
punto di vista della fenomenologia, la questione della
soggettività viene considerata tuttora aperta e non solo in
virtù di un canone metodologico “secondo cui ogni
problema va sempre ripreso daccapo e dalle radici”, ma
anche perché (corsivo mio) “non si può parlare
autenticamente di scienza, se l’oggetto della scienza non
sia, avanti ad ogni altro, la soggettività stessa di colui che
fa scienza e della scienza, in qualche modo, usufruisce
24
.”
Sul terreno della critica radicale alle forme dell’alienazione
umana che si costituisce su più fronti, la fenomenologia
incontra il marxismo come filosofia critica dell’alienazione
del soggetto.
L’atteggiamento fenomenologico coglie, oltre la
dimensione teoreticistica e gnoseologistica, il radicamento
del pensiero nella soggettività materiale, finita, corporea
(leibhaft)25, che è sede di bisogni ed è foriera di
insecuritas ed angoscia esistenziale, e che si struttura
come relazione con l’altro da sé, la natura, gli altri esseri
finiti. La fenomenologia viene collocata nel solco di
23
Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini, cit., p. 15.
La lotta per la scienza, cit., p. 58.
25
A riprova dell’importanza che il tema della soggettività come corporeità ha nelle
riflessioni di quegli anni, Semerari scriveva nel suo diario del 1963: “ È nel corpo che si
fa la schiavitù dell’uomo, la sua servitù al bisogno, ma è pure nel corpo che giacciono
le condizioni della libertà umana. Non, io ho un corpo: bensì io sono il mio corpo.”
G. Semerari, L’anno del Messico, Schena, Fasano 1996, p. 110.
24
246
246
un’evoluzione del pensiero moderno che passa per
Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Nietzsche e Freud;
assieme alla definizione antropologica marxiana ha dato
un contributo essenziale ad una nuova definizione della
scienza della soggettività, intendendola come struttura
problematica di corpo-tempo-relazione, ossia come
materiata degli strati precategoriali e pre-logici della
Lebenswelt.
Nel corso di un’intervista che rilasciò, molto tempo dopo,
alla rivista “Politica e Mezzogiorno”, Semerari ribadì di
avere svolto, tra gli anni ’50 e ’70, sia pure attraverso
ricerche di argomento diverso, una coerente indagine:
Il filo conduttore fu, per me, allora (ma tale è restato anche
successivamente) lo sforzo di determinazione ed elaborazione di una
filosofia come antropologia storica e critica che fosse sostenuta dal
discorso scientifico-positivo senza, per questo, diventare una filosofia
26
positivistica dichiarata o mascherata.
Con queste parole, Semerari riconosceva, come
elemento di continuità, nelle riflessioni da lui sviluppate
all’inizio degli anni ’50, l’aspirazione ad un razionalismo
filosofico politico che fosse capace di attingere ai risultati
delle scienze, senza ricadere nella posizione dogmatica
che consiste nel sostanzialismo della verità e in un
rinnovato feticismo dei fatti.
Nel testo in esame la definizione del termine “scienza”è
particolarmente interessante perché getta una luce
chiarificatrice sul senso del lavoro filosofico, che deve
26
Filosofia, scienza, politica – Intervista con Giuseppe Semerari di F. De Natale, in
“Politica e Mezzogiorno”, 1979, 3-4, p. 6.
247
247
procedere nel confronto e nella relazione dialogica
costante con essa, diventandone la problematizzazione
radicale.
“Intendiamo per scienza – dice Semerari – il
comportamento intenzionale o l’atteggiamento realizzato
come ricerca razionale della certezza e sicurezza
esistenziale27.”
Come “comportamento intenzionale” essa rimanda
sempre ad un atteggiamento pre-logico o pre-categoriale;
sicchè, ogni qualvolta sul piano filosofico si perda la
cognizione dell’attività intenzionale che la scienza
rappresenta, per cui “ne và” dell’individuo, si affaccia la
tentazione di scivolare nella soluzione rassicurante
dell’atteggiamento a-problematico, che si può assimilare –
dice Semerari – all’atteggiamento di accettazione del
totalitarismo in politica.
Quest’ultimo infatti consegna l’uomo alla tutela
rassicurante e paternalistica delle istituzioni e converte
paradossalmente il bisogno di sicurezza in nuova
angoscia ed incertezza:
L’organismo totalitario, reso entità autonoma per se stesso, finisce
per l’assomigliare sempre più a qualcosa di arbitrario e misterioso,
28
sorgente di instabilità e di inquietudine anzi che di sicurezza .
La possibilità che l’uomo smarrisca se stesso, come
principio di autodeterminazione e di responsabilità, è
legata, dunque, alla rinuncia ad un controllo critico sui
paradigmi interpretativi e sulle istituzioni che governano
27
28
La lotta per la scienza, cit., p. 19.
Ivi, p. 18.
248
248
rispettivamente la conoscenza e la prassi umana, e lo
sfilacciamento del tessuto della democrazia, alla
possibilità che l’uomo persegua la soluzione irrazionale a
quel bisogno ontologico di sicurezza che – sin dai saggi
dedicati alla filosofia di Spinoza29– è caratteristica
dell’uomo in quanto essere naturale esposto al rischio del
proprio esserci.
Nella definizione dell’atteggiamento scientifico si interseca
un altro tema importante nella riflessione di Semerari,
nelle cui opere è possibile rinvenire le tracce di un
costante interesse per l’esperienza culturale della
psicoanalisi 30.
La scienza è una delle possibili strategie del
rassicuramento umano: è il titolo sotto cui si raccolgono le
tecniche di rassicuramento relative al Corpo e alla Natura,
una della più potenti terapie, insieme alla Politica, alla
Religione, alla stessa Filosofia, contro l’insecuritas
esistenziale da cui l’uomo è affetto in maniera
29
Il confronto con la filosofia di Spinoza appare a Negri molto importante. L’interesse
per la filosofia spinoziana risale alla traduzione italiana (la prima) del Breve trattato su
Dio, l’uomo e la sua felicità, che G. Semerari curò nel 1952-53 (Sansoni, Firenze); lo si
ritrova, successivamente, in G. SEMERARI, I problemi dello spinozismo, e a
proposito della voce: B. Spinoza in Grande Antologia Filosofica, diretta da M. F.
Sciacca, coordinata da M. Schiavone, vol. XIII: Il pensiero moderno, Marzorati, Milano
1968, pp. 1-136.
30
Sul tema del rapporto del pensiero di Semerari con la psicoanalisi si sofferma
Rovatti: “C’era una sorta di interdetto nei confronti della psicoanalisi e una sorta di
ulteriore interdetto verso la coppia psicoanalisi-marxismo. Negli anni Sessanta le
tracce le possiamo trovare in Scienza nuova e ragione. Negli anni Sessanta Semerari
appartiene a quel gruppo di intellettuali di punta che cancellano questo interdetto e
fanno funzionare, in senso progressivo, sia il marxismo sia la psicoanalisi e la loro
congiunzione.” Cfr. P.A.Rovatti, Presenza della psicoanalisi in Giuseppe Semerari, in
Furio Semerari - Francesco Fistetti (a cura di), La malinconia di Hume, cit., p.96.
249
249
essenziale31; è il tentativo di rendere meno precaria ed
insicura l’esistenza e di guidare intelligentemente il
comportamento.
Per Semerari l’esercizio della filosofia, è un “[_] andare
alle spalle della Scienza, della politica, della religione, alla
ricerca di quell’origine che rende ragione del perché tali
tecniche di rassicuramento siano nate, scavalcando quel
come vengano di continuo elaborate al loro interno32.”
Al limite, l’atteggiamento scientifico deve investire la
Filosofia che deve problematizzare se stessa e sapersi
come un’altra delle tecniche di rassicuramento umano,
genealogia in cui si mostra la radice dell’insecuritas come
origine del sapere.
Questa idea dell’atteggiamento scientifico consente di
ripensare lo spontaneo legame tra l’esistenza e le
operazioni teoriche che è andato smarrito.
31
Semerari dedica penetranti riflessioni al tema della insicurezza essenziale dell’uomo,
in quanto non-può-essere-senza-cura, nella premessa al testo: Insecuritas. Tecniche e
paradigmi della salvezza, Spirali, Milano 1982 (seconda edizione 2000). Semerari
considera l’uomo insicuro in un modo essenziale perche egli non sussiste per se
stesso (selbstständig), in maniera autonoma, ma dipende sempre, in qualche misura,
dal rapporto con la Natura e con gli altri. Così si esprime in proposito: “La sua
possibilità di essere attivamente se stesso passa attraverso la necessità del suo
essere passivo nella dipendenza dalla Natura e Dagli Altri. Il dover dipendere da ciò
che, in linea di principio, non può tenere continuamente sotto presa e solo
parzialmente può far rientrare nel proprio potere decisionale, mette l’uomo nella
condizione della insecuritas, che, ripeto, è essenziale, perché gli si accompagna
indivisibilmente nel ciclo intero della sua esistenza, che non può fare a meno, se non al
prezzo della soppressione, dei rapporti con la natura e con gli Altri.” (p. 8).
La Scienza è il titolo sotto cui si raccolgono le tecniche di rassicuramento relative al
Corpo e alla Natura (tecniche della previsione); nell’ambito della scienza rientra anche
la Storiografia quale tecnica di rassicuramento verso il Passato (tecnica della
memoria). Anche il Passato, fino a quando è ignorato, può generare angoscia.
32
V. Meattini, La sabbia e la roccia. Il radicalismo critico-problematico di Giuseppe
Semerari, ne La malinconia di Hume, cit., p. 93.
250
250
Scienza ed esistenza
La radicalizzazione ontologica del problema della scienza
sollecita Semerari a ritornare33 sul significato del concetto
di scienza nuova o filosofia come scienza rigorosa.
All’argomento dedica anche le riflessioni de La lotta per la
scienza, nel saggio Sintassi e scienza nuova.
A proposito della crisi delle scienze e della razionalità,
che è l’effetto dell’imperio di una ragione formale, così si
esprime:
Per essa la scienza si scinde da ogni relazione che non
sia relazione con se stessa, auto-relazione, e si trasforma
in un fatto assoluto non giustificabile che con la sua
presenza di fatto.
La domanda circa la intenzionalità cade al di là dei limiti
della sintassi, perché la intenzionalità è etero-relazione,
movimento dal non-scientifico allo scientifico, laddove la
sintassi rimane chiusa nella scienza stessa, branca della
scienza nel suo insieme.34
La lotta per una scienza nuova, che richiama Vico e
coincide con la scienza rigorosa di cui parlava Husserl, è
un movimento del pensiero che riannoda il legame
interrotto fra le costruzioni teoriche e gli interessi e gli
scopi del mondo umano. La scienza rigorosa, nel
significato attribuitole da Semerari, è scienza di
quell’apriori pre-logico e pre-scientifico che è la relazione
originaria tra l’uomo, la natura e gli altri uomini. E’ a
partire da questa materialità in cui si incarnano i bisogni,
gli scopi e le aspettative umane, che la scienza diventa
33
34
Si era già occupato del tema nel testo Scienza nuova e ragione, cit.
La lotta per la scienza, cit., p.51.
251
251
progettazione razionale. Sono i rapporti di potere tra gli
uomini a determinare il concetto e l’uso che si fa della
scienza.
Se la fenomenologia è critica della pretesa delle scienze
di costituirsi come sistemi autoreferenziali, chiusi nel loro
formalismo logico-sintattico, il marxismo è critica radicale
della pretesa delle formazioni economico-politiche di
valere
come
inespugnabili
fortezze,
o
dati
naturalisticamente ovvi. Non si dà possibilità di lottare
contro l’alienazione umana senza rifarsi all’uno o all’altro
metodo critico. La critica della scienza non può fare a
meno della critica alle strutture economico-politiche a cui
quella scienza serve35. La “crisi delle scienze europee” si
andrà precisando come la crisi di una maniera
storicamente determinata di concepire e di praticare le
scienze – di una maniera funzionale ad un certo modello
di strutturazione produttiva e di gestione scientificotecnologica – che genera l’effetto alienante per cui alle
scienze di fatto corrispondono uomini di fatto.
Nella Prefazione a Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini
l’autore richiama l’attenzione sul fatto che la scienza, nella
35
Sul costante confronto di Semerari con i temi del marxismo, si veda il saggio di A.
Altamura, Il “marxismo aperto” di Giuseppe Semerari, ne La certezza incerta, cit. Nella
produzione semerariana degli anni Settanta si collocano numerosi testi che insistono
sul ruolo che si deve riconoscere al marxismo, come Filosofia e potere, Civiltà dei
mezzi, civiltà dei fini, la cura dei fascicoli monografici di “aut aut”, dedicati a La scienza
e i problemi dell’uomo (119-120, 1970) e a Dialettica della natura e materialismo (129130, 1972), ed il volume collettivo: G. Semerari, (a cura di), La scienza come
problema. Dai modelli teorici alla produzione di tecnologie: una ricerca interdisciplinare,
De Donato, Bari 1980. Non si tratta però di una “fase”della elaborazione teoretica di
Semerari. Dice Altamura: “La riflessione sul marxismo, infatti, presente già prima degli
anni Settanta, continuerà a rivestire una posizione centralissima fino agli ultimi scritti e
in modo particolare nel lungo e articolato saggio del 1995: Il modello materialistico.
Marx e la storia della filosofia[“. Id., Il “marxismo aperto” di Giuseppe Semerari, ne La
certezza incerta, cit., pp. 207-208.
252
252
sua riduzione formalistica e tecnicistica, appare la
giustificazione della forma alienante imposta alle relazioni
umane dall’organizzazione produttiva capitalistica.
Della scienza non esiste solamente una storia interna ma pure una
storia esterna , ossia il problema della scienza non si esaurisce nella
sintassi ma coinvolge gli interessi di classe a cui sono funzionali le
36
formali costruzioni scientifiche.
Qui Semerari chiarisce che l’attualità dei temi che aveva
proposto negli anni Sessanta, rispetto al dibattito aperto,
anni dopo, dalla filosofia strutturalista di Louis Althusser,
con la sua idea della Storia senza soggetto, consiste nella
proposta di un razionalismo filosofico-politico, che includa
la tematizzazione dei soggetti viventi tramite il concetto di
praxis.
Il misticismo della tecnica
È l’interesse per il tema dell’esistenza nella sua
dimensione storica, temporale e finita, a spingere il
filosofo a confrontarsi con le filosofie dell’esistenza, in
particolare la concezione heideggeriana della tecnica.
Heidegger è fra gli autori dei quali Semerari fornisce
un’originale interpretazione, attribuendo al filosofo moravo
36
Civiltà dei mezzi, civiltà dei fini, cit., p. 11.
253
253
l’atteggiamento che chiama malafede esistenzialistica37.
L’analisi heideggeriana circa il dominio della tecnica sul
mondo dell’uomo approda ad un nuovo misticismo
dell’Essere.
Il tema è nel saggio La intenzionalità tecnica, dove
l’autore esprime una critica radicale a quelle filosofie che,
facendo credere di parlare in nome dell’esistenza, non
fanno che riattualizzare il “misticismo”, l’atteggiamento di
passività e silenzio dell’uomo al cospetto delle formazioni
teoriche e pratiche delle quali perde la consapevolezza di
essere il principio di imputazione ed il fondamento.
Semerari si riferisce alla filosofia di Heidegger e alla sua
concezione della tecnica come “disvelamento” che
conduce alla negazione dell’uomo come progetto
possibile consegnandolo alla passività rilassata della
Gelassenheit:
Ho parlato altrove di una malafede teoretica di Heidegger. Mi sembra
che la posizione sulla questione della tecnica confermi questa
malafede. Nella lotta dell’uomo moderno contro i pericoli della sua
deiezione tecnicistica, la opposizione di Heidegger alla tecnica e alla
37
Nella seconda parte del testo Scienza nuova e ragione, intitolata L’analitica
esistenziale, Semerari intende l’analitica dell’esistenza come lo strumento essenziale
di cui deve fare uso la scienza rigorosa. Essa è la capacità di portare alla luce lo
“strato” dell’esperienza precategoriale, il suo senso primitivo e profondo e i bisogni che
vi si manifestano. Tutt’altro è il significato dell’analitica esistenziale condotta da
Heidegger in Essere e tempo. La malafede teorica consiste nell’occultare ciò che, in
apparenza, si vorrebbe tematizzare: l’esistenza dell’uomo. Heidegger si opporrebbe
solo in apparenza alla deiezione e all’alienazione tecnicistica, e consegnerebbe l’uomo
alla logica dell’appartenenza all’Essere. L’uomo non può fare altro che accettare di
appartenere all’orizzonte storico del disvelamento dell’Essere come al proprio destino;
ciò determina lo smarrimento del principio di responsabilità rispetto alla decisione sui
fini relativi a quel progetto razionale che è l’esistenza. La lettura attenta e
filologicamente curata della filosofia heideggeriana, da Essere e tempo ai testi
successivi alla Khere, sfocia in un giudizio critico negativo che assimila il filosofo
moravo alla tradizione mistico-tedesca germanica.
254
254
sua intenzionalità razionale, fatta sulla base della richiesta di un
disvelamento che non deve disvelare l’uomo ma un mitico ‘Quello’,
ha per risultato non la dissoluzione dei pericoli del tecnicismo, ma la
confusione delle carte sul tavolo della discussione ideologica, e, sul
terreno culturale, l’anacronistica e reazionaria ripresa della tradizione
38
mistica germanica e scolastica.
Semerari, invece, attribuisce alla tecnica un significato
radicalmente umano: è la possibilità di portare a termine
un progetto, è risolvere una situazione problematica. La
definizione
della
tecnica
poggia
sul
concetto
fenomenologico di intenzionalità; è una dinamica
intenzionale che conduce il soggetto a dare forma al
mondo e significato agli oggetti in rapporto all’uso che ne
fa. La tecnica esprime l’essenza creativa dell’uomo, è il
luogo di definizione della forma, è l’attività che attualizza i
possibili significati dell’essere, portandone a definizione
alcuni.
Il tema dell’alienazione umana, delle sue forme
economiche, politiche, scientifiche, si intreccia con quello
della tecnica.
La tecnica può essere contraddetta da se stessa quando,
per la perdita della propria intenzionalità, si riduce in
tecnicismo, che è un vero e proprio misticismo della
tecnica. Il tecnicismo (criptoidealisticamente) chiude la
tecnica in schematizzazioni meramente operative [_] La
conseguenza di tutto ciò è che il tecnicismo viene a
trovarsi oggettivamente affiancato al misticismo (e allo
spiritualismo in genere) nel disconoscere la tecnica (e la
38
La lotta per la scienza, cit., p. 92.
255
255
sua storia) come determinante ai fini della esplicazione
ontologica dell’uomo e della realizzazione della sua
responsabilità razionale.39
Essa, in quanto è progetto, volontà di appropriazione
intelligente e controllata della natura, è anche la
costituzione di una condizione di responsabilità dell’uomo
in rapporto al mondo. D’altra parte è l’uomo stesso ad
essere ontologicamente strutturato dal suo rapporto con
la natura, che avviene specialmente tramite la tecnica; gli
stessi fini umani sono storicamente costituiti entro
l’orizzonte storico in cui l’uomo è collocato.
Sottratta ad ogni problematizzazione, la tecnica determina
il tecnicismo – il misticismo della tecnica – e la
tecnocrazia, per la quale si strutturano rapporti di potere
tra gli uomini in virtù della loro capacità di gestire le
operazioni tecniche ma va smarrita la consapevolezza
circa i fini verso i quali le operazioni tecniche sono
orientate. Tanto il tecnicismo quanto la tecnocrazia
producono l’estraneazione dell’uomo rispetto a se stesso
e agli altri, e lo consegnano alla logica della accettazione
rassegnata e passiva delle strutture dell’essere come se
costituissero un orizzonte invalicabile.
L’autore respinge ogni soluzione teorica che, o con il
riferirsi al formalismo della ragione, o con l’atteggiamento
della “malafede esistenzialistica”, produca nuove forme di
accettazione mistica delle strutture dell’essere, ricalcando
quel paradigma parmenideo la cui ricorrenza coincide con
le differenti forme assunte, nella storia del pensiero, dalla
39
Ivi, p. 87.
256
256
visione sostanzialistica della verità, in una costante e
sempre rinnovata dialettica con il paradigma protagoreo40.
Considera il marxismo la posizione teorica in grado di
“liquidare” le due soluzioni del misticismo e del
tecnicismo; la visione marxiana dell’uomo gli appare la
definizione antropologica in grado di evitare ogni
ipostatizzazione, spiritualistica o materialistica, di una
natura umana, e di pensare la soggettività come tessuto
costituito dalla interazione tra natura e cultura, strutturata
all’interno di una realtà ontologica che è relazione tra
uomo-natura-altri uomini.
Le riflessioni che Semerari maturava negli anni Sessanta
rappresentano un fecondo solco teorico rispetto alla
definizione di temi che sarebbero diventati centrali nel
dibattito postindustriale, postmoderno e globalista. Lo
sostiene Negri, nel quadro di alcune riflessioni svolte in
margine alla questione del lavoro41, affrontando il
problema delle forme con le quali l’ontologia dell’operare
umano (la potenza produttiva) viene strutturata e
dominata, oppure si mette nelle condizioni di rivoltarsi, di
liberarsi e di perseguire la felicità.
Hardt e Negri, nelle analisi sviluppate in Impero42,
sostengono che, con la definizione toyotista e postfordista della organizzazione capitalistica del lavoro, lo
stesso processo di valorizzazione ha assunto una
connotazione immateriale, in quanto si realizza nei servizi
40
Per un’analisi degli atteggiamenti protagoreo e parmenideo, si veda Modello
parmenideo, modello protagoreo, in Giuseppe Semerari, Filosofia. Lezioni preliminari,
Guerini e Associati, Milano 1982, pp. 61-68.
41
T. Negri, Una rottura italiana: produzione vs. sviluppo, cit.
42
W. Hardt – T. Negri, Empire, The President and Fellows of Havard College, 2000;
Impero, trad. it. e cura di A. Pandolfi e D. Didiero, Rizzoli, Milano 2002.
257
257
cognitivi e quindi nel lavoro immateriale, trasformando la
stessa definizione del lavoro vivo.
L’analisi delle forme dell’alienazione deve tenere conto
dell’approfondimento e dell’estensione del comando
capitalistico sul lavoro, e alla categoria di pluslavoro e di
tempo alienato come sottrazione del tempo della vita
all’operaio dobbiamo sostituire quella del comando sulla
vita come valore d’uso, interamente funzionalizzata alla
formazione del profitto. Nel passaggio storico da una
società disciplinare ad una società di “controllo” emerge la
tematizzazione filosofica che non c’è più un “fuori”, perché
la vita è interamente coinvolta nella produzione e nella
riproduzione. La composizione sociale del lavoro salariato
soggetto al profitto è mutata, e la forza lavoro, nel postfordismo, viene ridefinita come lavoro diffuso, flessibile e
precario, espressione della vita messa al lavoro da un
biopotere che fa passare il suo comando anche attraverso
la dipendenza dell’uomo dalla tecnica.
L’attualità delle riflessioni di Semerari sulla scienza
consiste nel proporre il lavoro filosofico come critica
radicale al dogmatismo in tutte le sue forme (politico,
scientifico, istituzionale), e capacità di individuare,
attraverso il radicalismo dell’interrogazione, le nuove
forme del dominio, anche laddove siano invisibili.
Il necessario incontro tra fenomenologia e marxismo
consente di ricostruire il legame delle formazioni teoriche,
religiose, economiche, culturali, scientifiche, politiche, ed
istituzionali, con il corpo e con il vissuto concreto dei
soggetti, nella comune lotta per la ricostruzione di un
significato di verità a partire dalla presa di coscienza della
struttura temporale e quindi storica, del soggetto. Tale
258
258
operazione genealogica e decostruttiva affonda nei livelli
ante-predicativi e a-formali, e consente di ripensare il
valore della vita, oggi intesa solo come valore d’uso o
lavoro vivo da cui ricavare profitto.
Comunicazione e rifondazione della comunità umana
L’assunzione della prospettiva scientifica presuppone un
nuovo concetto di verità come allargamento dialogico,
risultato della comunicazione interumana, principio etico
di riorganizzazione e rettificazione delle relazioni sociali43.
Il tema del carattere etico della verità, che era al centro
delle riflessioni di Il carattere del filosofare
contemporaneo, ritorna nel quinto capitolo della Lotta per
la scienza, dove viene affrontato il problema della
comunicazione.
43
“Per il filosofare contemporaneo, la verità non nasconde l’uomo ma lo disocculta a
se stesso, non sopprime le dòxai ma le organizza progressivamente nell’orizzonte
problematico della coesistenza o socialità umana, secondo la prospettiva della
maggiore coordinazione e armonizzazione possibile. [_] Ciascuna dòxa è quantità di
verità, che per le dòxai è possibilità di qualificazione interrelazionale, sì che la verità
non sussiste altrove che nell’infinito connettersi, in agganci sempre più solidali e
comprensivi, delle dòxai-quantità.” G. Semerari, Il carattere del filosofare
contemporaneo, cit., p. 390.
259
259
Il presupposto dell’argomentazione è il principio di
relazione che attraversa per intero l’arco del pensiero di
Semerari costituendone una possibile chiave di lettura44.
Sono le riflessioni di La filosofia come relazione, dove
Semerari si confronta con la filosofia di Enzo Paci, a
chiarire la concezione ontologica dell’essere come
relazione fra uomo-Natura-altri e dell’uomo come
possibilità della relazione e della comunicazione, legata
alla consapevolezza del limite e della temporalità
dell’esistenza.
All’ontologia relazionale, in cui l’esistenza è vista come
relazione strutturale con l’essere, è legata l’idea che essa,
nella sua costitutiva finitudine, sia rapporto con il
possibile, tensione – spinozianamente: conatus – struttura
ontologicamente protesa verso l’essere senza mai
identificarsi con esso, progettualità.
Senza alcuna concessione all’ovvietà, e mettendo in
evidenza come la comunicazione non possa mai
considerarsi “pre-garantita”, ma sia sempre problematica
ed aperta, Semerari chiarisce i fattori culturali alla luce dei
quali il problema in esame assume tutto il suo spessore
problematico.
44
Ferruccio De Natale sostiene che il tema attraversa tutta la riflessione semerariana
sino all’ultimo corso di filosofia teoretica, tenuto nel 1995-96, dedicato al tema Analisi
della relazione e fenomenologia delle relazioni. Cfr. La filosofia come Lebensberuf, cit.,
p. Nella Premessa alla nuova edizione de La filosofia come relazione, (cit.), De Natale
chiarisce che il contesto storico in cui maturano le riflessioni contenute in questo libro è
la stagione filosofica del neoilluminismo italiano, la pubblicazione delle opere di Enzo
Paci, Dall’esistenzialismo al relazionismo, del 1957, di Giulio Preti, Praxis ed
empirismo, del 1957, di Ludovico Geymonat, Saggi di filosofia neorazionalistica,
Einaudi, Torino 1953.
260
260
Alla crisi della definizione sostanzialistica della verità
hanno contribuito tanto il neopositivismo che la
fenomenologia, per cui il sapere scientifico ha dovuto
rinunciare ad ogni pretesa di universalità ed oggettività;
abbiamo ormai rinunciato a trasferire sui linguaggi delle
scienze ogni attesa di definitività e di assolutezza; lo
sviluppo delle scienze ci ha reso consapevoli che il
mondo è il limite della possibile comunicazione e
dell’interscambio tra tutti i possibili convenzionali sistemi
di segni che le scienze rappresentano, il limite degli infiniti
giochi linguistici. L’applicazione allo studio dei
meccanismi di formazione del sapere di scienze come la
sociologia, la psicopatologia del linguaggio, la
psicoanalisi, ha dato un contributo fondamentale alla
destituzione della nozione di “coscienza pura”.
Per Semerari il lungo processo di decostruzione dei
linguaggi e dei significati con i quali interpretiamo il
mondo – di cui attribuisce il merito alla fenomenologia e
alla filosofia analitica – ha portato la filosofia a
confrontarsi con la dimensione intersoggettiva in cui sono
implicati il corpo, con gli strati di significatività materiale,
biologica, e psicologica, di cui è portatore, e la
rappresentazione dell’altro, intesa – come sostiene
Ricoeur – come un limite etico che impegna il pensiero a
porre, circa la comunicazione, il problema della
costruzione di una totalità etica e di un regno dei fini.
Se la concezione “sostanzialistica” della realtà rimanda ad
una visione antropologica che include l’uomo entro un
orizzonte statico di strutture necessarie, fisse, ed
ineludibili, la concezione dell’essere come relazione
storica consente di ripensare il problema della verità non
261
261
più in termini epistemologici ma in termini etici, come un
orizzonte possibile che può essere costituito all’interno di
una comunicazione sempre più ampia ed inclusiva.
L’originario fondamento non è la sostanza ma il
fondamento senza fondamento pre-garantito, la relazione,
in cui l’esistenza dell’uomo è incastonata come possibilità.
La comunicazione ha in sé la possibilità dell’aporia e
dell’errore proprio perché avviene all’interno di una
dimensione intersoggettiva determinata dalle variabili
legate alla dimensione fisica e materiale della corporeità
dei soggetti. Le aporie della comunicazione costituiscono
il principio metodologico che spinge il pensiero a ritornare
sull’interpretazione, a risolvere le fallacie della
comprensione.
Nelle considerazioni riassunte si fonda il principio della
radicalità dell’interrogazione critica che avrebbe informato
gli scritti dedicati al marxismo di Filosofia e potere45, dove
Semerari sosterrà con forza la necessità di mettere in
discussione le nuove forme assunte dal sostanzialismo
della verità nel Dia-mat, la rapresentazione del
materialismo volgare che, ricadendo in formulazioni
assolutistiche e dogmatiche della verità, mascherava le
cristallizzazioni di potere sedimentate nella burocrazia di
regime, nel Partito, nello Stato, nuove manifestazioni della
sclerotizzazione e della interruzione della comunicazione.
45
Cfr. G. Semerari, Filosofia e potere, capitoli IV (Il marxismo aperto delle democrazie
popolari) e V (Burocrazia, tecnocrazia e libertà), cit.
262
262
Una nuova teoria della civiltà
Affrontando il tema dell’insecuritas essenziale46 che
affligge l’uomo, Semerari avrebbe ribadito che ogni Teoria
della Civiltà è una sorta di Soteriologia generale, ossia
una tecnica di rassicuramento esistenziale accanto alle
altre, la Scienza, la Politica, la Religione, con le quali
l’uomo cerca di sottrarsi ai rischi ai quali la stessa
esistenza, come relazione con la Natura e con gli altri, lo
espone.
Vanno interpretate attraverso questa prospettiva le
riflessioni contenute nell’ultimo dei saggi della Lotta per la
scienza dove Semerari avverte la necessità, sia
scientifica che politica, di rettificare il concetto di civiltà e
di porre a fondamento di essa una capacità valutativa,
atta ad evitare tanto il dogmatismo quanto il relativismo.
E’ il concetto di cultura, in quanto non coincide col
significato di civiltà e si riferisce ai valori che potenziano
l’umanità, a rappresentare il criterio di valutazione della
civiltà, se la si intende, con Kant, come la capacità di
porre le condizioni perché l’uomo attui il suo essere
razionale e diventi in grado di scegliere i suoi fini
autonomamente e secondo ragione. Ciò equivale a
rappresentare la possibilità di definire una progettazione
razionale, da parte dell’uomo, dei suoi fini, ai quali
pervenire per mezzo della civiltà stessa.
La prospettiva adottata da Semerari appare distante
dalle forme pessimistiche della critica di Adorno, come
pure dalle utopie di altri pensatori della scuola di
Francoforte, come Marcuse, con cui pure condivide la
46
Il testo è Insecuritas, cit.
263
263
diagnosi secondo la quale la definizione formalistica della
scienza e della ragione ha fatto sì che la scelta dei fini
rimanesse del tutto priva di intelligenza; alle utopie e alle
nuove prospettive escatologiche bisogna sostituire la
considerazione della situazionalità storica dei mezzi come
pure dei fini, dice Semerari, la quale preserva dagli
opposti rischi del fanatismo e dell’utopismo. Tra lo slancio
verso un futuro messianicamente inteso come “di là da
venire” ed il restare intrappolati nelle strutture dell’essere
dato, senza riuscire a progettare altri orizzonti di
significato, c’è la possibilità di ricostruire un legame
razionale tra i mezzi e i fini tramite la auto-progettazione
razionale consapevole di se stessa che è la scienza
rigorosa. Nella prospettiva husserliana della strenge
Wissenschaft, deve essere possibile investire la scienza
delle ragioni della vita, utilizzare l’immenso potenziale
creativo ed organizzativo della tecnica per un nuovo
progetto di civiltà.
La lotta per la scienza propone di esercitare la riflessione
filosofica per cercare una forma di salvezza razionale
restando “figli della terra”47, per abitare consapevolmente
“quell’origine che non può essere altro che il mondo
esistenziale dell’uomo (Corpo, Natura, Altri) divenuto, per
47
L’espressione è di Platone e viene adoperata da Semerari nel saggio Comunità e
responsabilità umana, nel capitolo Esistenza, valore e comunità umana in Platone;
Semerari si riferisce alla capacità dell’uomo di creare la storia: “ Per creare la storia,
per essere cioè figli della terra, occorre essere capaci di libertà di fronte ad essa, in
grado di umanamente dominarla per i fini dell’uomo nella sua verità umana, occorre in
ogni caso essere amici delle idee.” (Giuseppe Semerari, Comunità e responsabilità
umana, Lacaita, Manduria 1960, p.166.) In questo contesto l’espressione è adoperata
per significare la capacita dell’uomo di guardare all’orizzonte ideale mantenendo un
atteggiamento libero e critico che si radica nella consapevolezza della propria
finitudine.
264
264
lui, dimora sicura, non più luogo di esilio, non più abisso
di angoscia e di terrore48.”
Quella di Semerari è un’opzione teoretica per una filosofia
del finito, e per un umanesimo problematico “[_] che non
oblia la finitudine dell’uomo, ma vede nell’uomo stesso,
nelle sue capacità di intessere “rapporti” – cioè nel suo
essere un centro di relazioni temporalmente determinate
– il punto di imputazione del “senso” della storia49.”
Spesso Semerari fa riferimento alla metafora della scala
di wittgenstein per descrivere cosa sia stata la filosofia in
rapporto alla scienza concepita come autonoma
coscienza metodologica e sintattica. Nelle pieghe del
discorso de La lotta per la scienza c’è un’appassionata
difesa del ruolo della filosofia, a cui viene restituita l’alta
dignità di un’interrogazione socratica sul senso della
scienza per l’uomo, e sul rapporto teleologico della
conoscenza con i valori, contro ogni sua “dichiarazione di
morte” che derivi dalla sua riduzione ad “ancella” di una
Ragione formale, così come anche dalla sua limitazione
in una definizione di tipo storicistico-idealistico.
La definizione della filosofia come scienza rigorosa
costituisce anche un prezioso punto di riferimento nella
didattica della filosofia, circa il senso del filosofare, che
non è il restare intrappolati nella “filastrocca delle
opinioni”: è cercare il senso delle cose, è restituire il
mondo della vita, della morale, dei valori, della
conoscenza, alla “presa” della riflessione razionale,
evitando di abbandonarlo al dominio dell’ignoranza o ai
surrogati della scienza.
48
49
G. Semerari, Insecuritas, cit., p. 17
F. De Natale, Filosofia come Lebensberuf, cit., p.94.
265
265
Come asserisce Francesco Valerio nella Nota del
curatore, premessa al testo, ripubblicare oggi La lotta per
la scienza appare non soltanto un atto di doveroso
omaggio alla memoria di un “maestro” del pensiero,
riconoscendone il contributo all’emancipazione della
riflessione filosofica dalla servitù nei confronti del
dominante modello storiografico idealistico degli anni
Cinquanta; è anche rispondere al bisogno teorico di
“ricollocare al centro della riflessione contemporanea il
problema della costituzione di una razionalità oltre il
moderno, di una nuova razionalità critica, non prigioniera
di una logica lineare della razionalità che sia in grado di
recuperare sul piano ontologico la potenza creativa delle
soggettività nella loro dinamica relazionale”50.
La riflessione circa un progetto possibile di razionalità che
sfugga alla logica della strumentalità tecnico-scientifica e
al dominio del “pensiero unico” è affidata alla capacità dei
soggetti di ritrovare il potere di autodeterminazione che è
implicito in un’ontologia del finito. Fare filosofia per
ritrovare il senso della lotta e della resistenza al processo
pervasivo di espropriazione dell’umano appare così il
messaggio più attuale che Semerari ci abbia lasciato.
50
F. Valerio, Nota del curatore, in G. Semerari, La lotta per la scienza, cit., p. XXV.
266
266