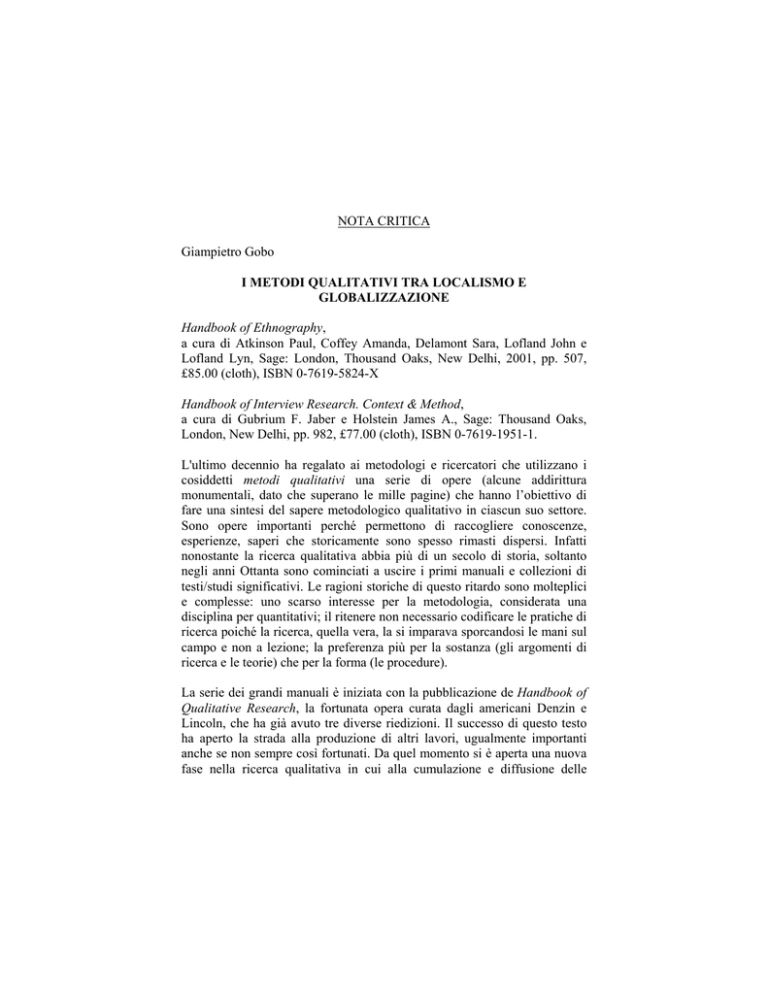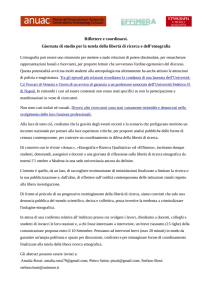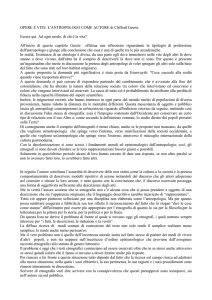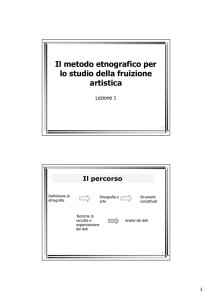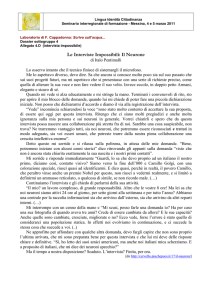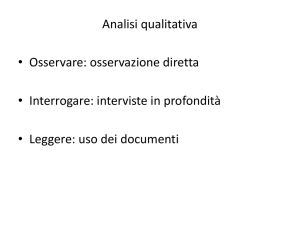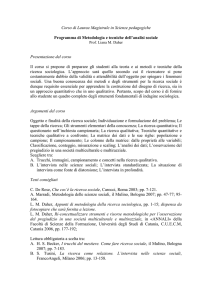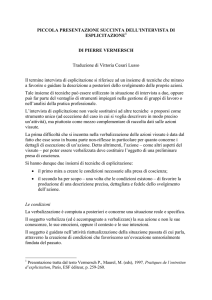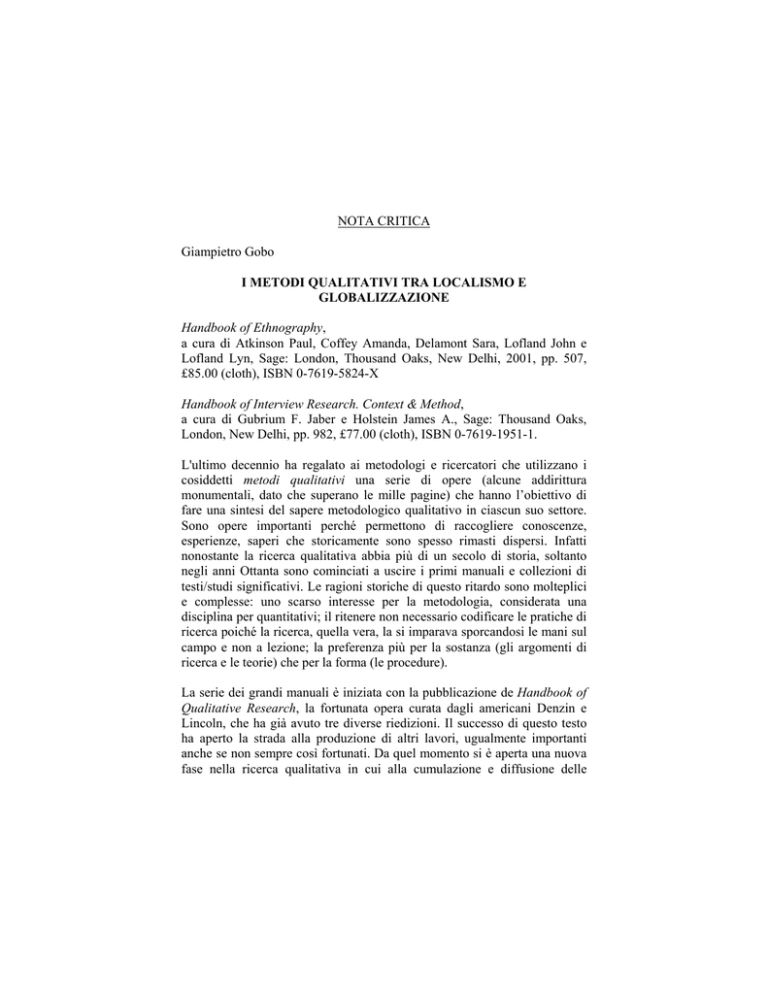
NOTA CRITICA
Giampietro Gobo
I METODI QUALITATIVI TRA LOCALISMO E
GLOBALIZZAZIONE
Handbook of Ethnography,
a cura di Atkinson Paul, Coffey Amanda, Delamont Sara, Lofland John e
Lofland Lyn, Sage: London, Thousand Oaks, New Delhi, 2001, pp. 507,
£85.00 (cloth), ISBN 0-7619-5824-X
Handbook of Interview Research. Context & Method,
a cura di Gubrium F. Jaber e Holstein James A., Sage: Thousand Oaks,
London, New Delhi, pp. 982, £77.00 (cloth), ISBN 0-7619-1951-1.
L'ultimo decennio ha regalato ai metodologi e ricercatori che utilizzano i
cosiddetti metodi qualitativi una serie di opere (alcune addirittura
monumentali, dato che superano le mille pagine) che hanno l’obiettivo di
fare una sintesi del sapere metodologico qualitativo in ciascun suo settore.
Sono opere importanti perché permettono di raccogliere conoscenze,
esperienze, saperi che storicamente sono spesso rimasti dispersi. Infatti
nonostante la ricerca qualitativa abbia più di un secolo di storia, soltanto
negli anni Ottanta sono cominciati a uscire i primi manuali e collezioni di
testi/studi significativi. Le ragioni storiche di questo ritardo sono molteplici
e complesse: uno scarso interesse per la metodologia, considerata una
disciplina per quantitativi; il ritenere non necessario codificare le pratiche di
ricerca poiché la ricerca, quella vera, la si imparava sporcandosi le mani sul
campo e non a lezione; la preferenza più per la sostanza (gli argomenti di
ricerca e le teorie) che per la forma (le procedure).
La serie dei grandi manuali è iniziata con la pubblicazione de Handbook of
Qualitative Research, la fortunata opera curata dagli americani Denzin e
Lincoln, che ha già avuto tre diverse riedizioni. Il successo di questo testo
ha aperto la strada alla produzione di altri lavori, ugualmente importanti
anche se non sempre così fortunati. Da quel momento si è aperta una nuova
fase nella ricerca qualitativa in cui alla cumulazione e diffusione delle
conoscenze si è aggiunta una diversa consapevolezza epistemologica e
metodologica, che ha emancipato molti di questi metodi dal clima
positivista in cui erano nati. Tuttavia la maggior parte di essi non si è ancora
emancipata da un’ultima caratteristica di quel clima: una dose ancora
eccessiva di (inconsapevole) etnocentrismo.
Sono infatti in circolazione una sacco di riviste scientifiche che nel loro
nome oppure nelle loro intenzioni dichiarano di essere “internazionali”.
Proposito lodevole anche se raramente realizzato. Un organismo è
internazionale (vedi per esempio l’International Sociological Association)
quando è composto da molte nazioni, anche se non tutte con lo stesso peso.
Invece queste riviste sono quasi interamente gestite da americani e inglesi,
con qualche canadese o australiano, e pochissimi studiosi non anglofoni.
Dove starebbe l’internazionalità? Di conseguenza queste riviste pubblicano
con grande facilità i risultati di una ricerca condotta su un gruppo di
volontariato di un sperduto paese del mid-west, mentre sono restie ad
accettare un paper su una fabbrica di televisori in Italia perché troppo
«local». E’ forse Topeka più internazionale di Abbiategrasso?
L’equivoco nasce dal confondere la diffusione mondiale di una lingua
(l’inglese ora, il latino o il francese qualche secolo fa) con i contesti di
ricerca, i confini nazionali, il modo di trattare gli argomenti, il tipo di
pubblico a cui l’autore si rivolge, che sono ancora locali. In altre parole non
basta scrivere in inglese per essere internazionali. Purtroppo questa
confusione è molto radicata tant’è che, è un noto luogo comune, per uno
studioso britannico avere una reputazione internazionale significa essere
conosciuti negli… Stati Uniti. Questo equivoco, nato probabilmente negli
anni Cinquanta dopo la seconda guerra mondiale (con la divisione del
mondo di due blocchi contrapposti), si è ulteriormente espanso dopo la
caduta del muro di Berlino. In precedenza vi era forse una maggior
consapevolezza dei propri limiti culturali; infatti alle riviste nate prima del
secondo conflitto mondiale si davano nomi come American Journal of
Sociology, American Sociological Review, American Sociologist, American
Anthropologist, American Ethnologist, British Journal of Sociology e così
via, che testimoniavano il limite nazionale del loro lavoro.
Di etnocentrismo soffrono quasi tutti i manuali di metodi qualitativi: sono
scritti per più del 90% da autori anglofoni e gli International Advisory
Board (il comitato di studiosi che ha il compito di leggere i capitoli e con la
loro presenza di legittimare l’opera) sono anch’essi composti al 90% da
2
autori anglofoni: studiosi dell’Europa Continentale, dell’America Latina,
dell’Asia o dell’Africa si contano sulla dita di una mano.
Sarebbe però un errore attribuire una eccessiva intenzionalità a questo
fenomeno. In altre parole i curatori di queste opere sono persone aperte,
colte e sensibili al problema dell’insufficiente internazionalità delle loro
opere. Per esempio i curatori dell’Handbook of Ethnography, introducendo
la seconda parte relativa alle aree tematiche in cui è stato impiegato il
metodo etnografico, scrivono:
Pochi autori in Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia sono a conoscenza di
ricerche condotte nell’Europa continentale. Studiosi al di fuori degli Stati
Uniti possono al massimo non essere aggiornati sulla ricerca americana,
mentre raramente gli americani sono in grado di leggere letteratura non
americana. Alcuni dei nostri autori sono riusciti meglio di altri a coprire la
ricerca mondiale relativamente al proprio settore; alcuni referees erano
angosciati dall’etnocentrismo più di altri. Noi non abbiamo cercato di
riconciliare queste opposte prospettive: per cui alcuni nostri capitoli sono
più cosmopoliti di altri. Ad esempio, il capitolo di Smith sull’area del lavoro
si basa prevalentemente sulla letteratura americana, mentre Gordon et al. si
sono occupati delle ricerche in campo scolastico di tre continenti e di dieci
Paesi (p. 174).
Il problema, di non facile soluzione anche per i curatori meglio intenzionati,
nasce dal fatto che le lingue nazionali rimangono il limite principale alla
globalizzazione dei saperi in campo accademico. Anche al curatore più
internazionalista e inclusivo mancheranno spesso sia i contatti con autori di
Paesi non anglofoni che la conoscenza delle ricerche che in essi si
producono, a meno che gli autori non pubblichino con prestigiose case
editrici inglesi o americane (cosa peraltro non facile per un autore che non
insegni in un paese anglofono). Per cui è naturale che questi manuali
risultino, al di là della volontà dei curatori (è bene ripeterlo) coloniali e
etnocentrici.
Handbook of Ethnography
3
I principali curatori di questo manuale sono tre sociologi inglesi di chiara
fama che hanno usufruito dell’apporto dei coniugi Lofland, due sociologi
urbani americani di lungo corso. E’ un’opera importante perché sancisce la
riconquista del metodo etnografico da parte della sociologia e segna il
definitivo abbandono di un’etnografia di stampo positivista e realista in
favore di un’etnografia narrativa, di cui Atkinson è stato uno dei precursori
in campo sociologico. Come sottolineano i curatori nell’Introduzione (p. 2)
molti antropologi continuano ancora a identificare la sociologia con il
sondaggio e a considerarsi i (gelosi) custodi del metodo etnografico. Inoltre,
al di là di alcuni capitoli in tono minore, questo manuale rappresenta una
pietra miliare nella storia dell’etnografia.
Anche se formalmente diviso in tre sezioni, dal punto di vista tematico il
manuale può essere considerato composto da cinque parti: l’uso
dell’etnografia all’interno dei diversi approcci; i suoi principali campi di
applicazione; i problemi metodologici che si incontrano in una ricerca
etnografica; i temi della riflessività e rappresentazione; il futuro
dell’etnografia. Come avvertono i curatori, l’etnografia è un territorio così
ampio, differenziato, dai confini incerti e sfuggente a precise
categorizzazioni (p. 1) che appare impossibile una sua trattazione completa
ed esaustiva.
La prima parte è composta da una decina di capitoli che descrivono, dal
punto di vista storico e teorico, il matrimonio tra etnografia e i vari approcci
intellettuali. Ad esempio Mary Jo Deegan, contrariamente all’idea che la
Scuola di Chicago fosse un luogo in cui regnasse caoticamente una pluralità
di metodi, sostiene che al suo interno si fosse formata una scuola di
etnografia, un sotto-gruppo coeso, potente e prolifico (p. 11). Paul Rock
descrive la relazione tra etnografia e interazionismo simbolico, mentre
James D. Faubion passa in rassegna l’antropologia culturale. La sociografia
o studi di comunità è l’oggetto del capitolo di Lodewijk Brunt, mentre Liz
Stanley riesuma la mass-observation, un approccio dimenticato ma
comunque interessante, che ha avuto la sua fortuna in Inghilterra negli anni
Trenta e Quaranta e che si proponeva di studiare i comportamenti delle
masse nei grandi rituali (ad esempio il giorno dell’incoronazione di Giorgio
VI, avvenuta il 12 maggio 1937) oppure la classe operaia alle prese con gli
acquisti, i consumi e le spese quotidiane. Melvin Pollner e Robert M.
Emerson scrivono un interessante pezzo sui rapporti tormentati tra
etnografia e etnometodologia, avanzando (com’è nel loro carattere) una
4
proposta di riconciliazione. Ilja Maso delinea i punti di contatto tra
l’etnografia e la fenomenologia di Alfred Schutz, mentre Kathy Charmaz e
Richard G. Mitchell scrivono un capitolo su come fare Grounded Theory.
Infine Peter K. Manning, al fine di mostrare le potenzialità dell’utilizzo
congiunto di semiotica ed etnografia, svolge una divertente analisi semiotica
dell’uso del cap nell’ambiente universitario, un copricapo con visiera
storicamente indossato dei giocatori di baseball che è diventato un
indumento di moda fra gli studenti.
La seconda parte si apre con una serie di capitoli che fanno una rassegna
dei principali studi etnografici in sei settori. Michael Bloor si occupa della
sociologia della medicina, un campo molto vasto che spazia dagli ospedali
alle case di riposo, dalle istituzioni psichiatriche all’interazione medicopaziente, dai malati di Alzeheimer ai tossicodipendenti o malati di Aids.
Tuula Gordon, Janet Holland e Elina Lahelma scrivono un bel capitolo
comparativo sulle ricerche etnografiche in campo scolastico condotte in
dieci differenti Paesi. Dick Hobbs compie una rassegna storica degli studi
condotti in Inghilterra e Stati Uniti su varie forme di devianza (hooligan,
gang, tossicodipendenti, mod e rocker, ecc.) così come Vicki Smith svolge
lo stesso compito con l’etnografia del mondo del lavoro. La seconda parte
del libro si chiude con due capitoli interessanti, dedicati a oggetti di studio
che hanno avuto un recente incremento: la sociologia della scienza e della
tecnologia (David Hess) e lo studio dell’infanzia (Allison James).
La terza parte raccoglie quattro contributi su temi e territori interdisciplinari
che rappresentano nuovi filoni dello sviluppo futuro degli studi etnografici,
la direzione verso cui si muovono sempre più studiosi: la cultura materiale
(Christopher Tilley), i cultural studies (Joost Van Loon), la comunicazione
(Elisabeth Keating), la sociologia visuale (Mike Ball e Greg Smith). I primi
due capitoli descrivono i tratti salienti dei rispettivi approcci e si muovono
in una prospettiva più filosofico/politica che empirica. Invece il capitolo
sull’etnografia della comunicazione fa una sintesi dei principi teorici e dei
termini chiave (competenza comunicativa, comunità linguistica, repertorio,
evento linguistico, evento comunicativo ecc.) di questo importante
approccio, nato all’inizio degli anni Sessanta a opera di due antropologi:
Dell Hymes e John Gumperz. Il capitolo sull’antropologia e sociologia
visuale, oltre a una ricostruzione storica e epistemologica di questa
prospettiva, fornisce anche alcuni spunti metodologici in un settore che è
ancora alla ricerca di una sistematizzazione delle pratiche.
5
La quarta parte è quella più prettamente metodologica, con osservazioni,
consigli pratici, esperienze. E’ certamente una delle parti più interessanti e
utili ed è un peccato che non gli sia stata riservata la centralità che meritava;
d’altra parte i curatori stessi non hanno voluto confezionare un libro di
ricette sul come fare etnografia (p. 321). In questa parte troviamo un
capitolo di Christopher Wellin e Gary Alan Fine dallo spunto molto
originale e ironico: i due autori sostengono che sebbene ci siano stati molti
studi etnografici sul lavoro e le professioni, il lavoro e la professione
dell’etnografo sono stati quasi sempre trascurati oppure consegnati a
episodiche riflessioni autobiografiche. I due autori invece scelgono di
applicare le teorie sociologiche, lavoriste e organizzative, alla pratica
istituzionale di fare etnografia. E' un saggio velatamente pessimista, che
parla dei rallentamenti nella carriera che un etnografo subisce negli Stati
Uniti: le ricerche etnografiche richiedono molto tempo, rallentandone così
la produzione di pubblicazioni, e inoltre sono ancora viste con diffidenza
dai valutatori, cioè coloro che assegnano fondi per la ricerca. Tutti questi
aspetti finiscono per penalizzare la carriera accademica dello studioso. Il
capitolo successivo riguarda l’etica della ricerca etnografica (Elizabeth
Murphy e Robert Dingwall), in cui i diritti degli osservati, le responsabilità
degli etnografi e i rischi di questo tipo di ricerca vengono, per una volta,
affrontanti non in modo astratto. I due autori discutono quattro principi che
guidano la ricerca etnografica: il non danneggiare i soggetti (nonmaleficence), il loro rispetto (autonomy or self-determination), la
restituzione (beneficence) e l’equità (justice). Robert M. Emerson, Rachel I.
Fretz e Linda L. Shaw dedicano un bel saggio alla stesura delle note
etnografiche, una pratica importante ma spesso trascurata specie dalle
etnografie di ispirazione postmoderna. Nigel Fielding, noto esperto delle
problematiche relative all’uso dei programmi informatici per la ricerca
qualitativa, svolge un paragone fra i diversi software utili alla elaborazione
dei dati testuali raccolti (note etnografiche, documenti, memos).
Uno spazio apposito viene dedicato all’intervista etnografica (Barbara
Sherman Heyl), quell’insieme di colloqui informali, conversazioni e scambi
che avvengono sul campo. L’autrice tratta questo importante argomento in
una prospettiva postmoderna. Un saggio originale nel panorama etnografo è
quello scritto da Jim Mienczakowski, il quale descrive l’utilità della
simulazione sociale (Ethnodrama), metodo che nella ricerca applicata è
molto diffuso ma visto ancora con diffidenza dall’accademia. Martin
6
Cortazzi si occupa dell’analisi narrativa; fra i molti modelli ormai esistenti
egli sceglie di esporre il modello che il sociolinguista William Labov ha
costruito negli anni Settanta e che è stato riutilizzato nelle ricerche sul
razzismo condotte da Teun A. Van Dijk.
Questo capitolo anticipa la quinta e ultima parte, che tratta argomenti di
moda e cari alla prospettiva postmoderna: riflessività, rappresentazione,
emozioni, intimità e potere dell’autore. I primi due capitoli di questa parte
riguardano le storie di vita nella ricerca etnografica (Ken Plummer) e il
rapporto tra autobiografia, intimità ed etnografia (Deborah Reed-Danahay).
Al di là dell’intrinseco valore dei due saggi, essi rappresentano bene una
deprecabile tendenza attualmente in atto, quella di dilatare i confini
dell’etnografia fino a comprendere ricerche diversissime da punto di vista
metodologico. Tutto diviene etnografia: dalla storia orale all’osservazione,
dal soggiornare sul campo pochi giorni a diversi anni. In altri termini la
parola ‘etnografia’ si sta annacquando, perdendosi in una molteplicità di
significati, talvolta contrastanti e contraddittori. Parodiando una vecchia
battuta, verrebbe da dire “si fa presto a dire etnografia”.
Il manuale termina con tre capitoli in cui l’etnografia è presentata all'interno
della prospettiva postmoderna. Ad eccezione di un interessante saggio di
Beverley Skeggs sull’etnografia femminista, i capitoli di Jonathan Spencer e
Patti Lether sull’etnografia dopo il post-modernismo ripropongono, con il
solito tono sacerdotale che caratterizza alcuni autori postmoderni, concetti
già molto noti. Peraltro Lether, nella sua nota biografica, ci informa che è
sua aspirazione imparare a suonare la fisarmonica. La ringraziamo per
questa informazione di vitale importanza.
Handbook of Interview Research. Context & Method.
Gubrium e Holstein sono due studiosi americani molto noti nel campo della
ricerca qualitativa. Oltre a essere esperti di intervista, hanno condotto
diverse ricerche etnografiche utilizzando anche gli strumenti dell’analisi del
discorso e della conversazione. Il loro manuale è decisamente ambizioso
perché mira a essere esaustivo e completo, proponendo una sorta di
«enciclopedia» (p. xi) dell’intervista, un testo a struttura modulare
consultabile a seconda dell’interesse del lettore per una specifica voce.
Anche se l’obiettivo è facilitato dal fatto che l’intervista è un metodo più
7
circoscritto, dai confini meno mobili rispetto all’etnografia, i due curatori
hanno prodotto un’opera talmente strutturata e sistematica che non ha
paragoni nel settore e di cui è difficile trovare dei limiti. Peraltro le
soluzioni grafiche adottate rendono la lettura particolarmente riposante e
godibile.
Questo manuale, oltre a essere enciclopedico, ha anche un messaggio (a
story) che i curatori riprendono continuamente sia nella Prefazione che nel
primo capitolo introduttivo: l’intervista non è una semplice tecnica, uno
strumento neutrale di raccolta delle informazioni, ma è diventata parte
integrante della società contemporanea (p. xii). L’intervista nasce in
particolare momento della storia della società incarnandone alcune forme
culturali. Più precisamente, riprendendo gli articoli degli anni Cinquanta di
David Riesman, Mark Benney e Everett H. Hughes, l’intervista nasce agli
inizi del Novecento, è un prodotto della modernità e ne interpreta il
«modern temper». L’intervista è un prodotto di quelle mutate relazioni
sociali, in cui gradualmente divenne normale la conversazione tra estranei,
esporre pubblicamente le proprie opinioni, e più recentemente mettere in
piazza le proprie emozioni e sentimenti. E’ una delle «tecnologie del self»,
come direbbe Michel Foucault, uno degli apparati per l’invenzione moderna
della soggettività, una pratica istituzionale volta a creare l’idea di individuo
e mettere in luce i punti di vista personali. Come scrivono i curatori,
riprendendo alcuni scritti di David Silverman, l’intervista e la società si
costituiscono mutualmente tant’è che oggi noi viviamo nella «società
dell’intervista»; non solo perché l’intervista (intesa in senso lato) è una delle
forme sociali oggi più diffuse di raccolta delle informazioni (dal poliziotto
al medico, dal commesso al giudice, dall’assistente sociale al manager,
dall’insegnante allo psicoterapeutica, dal confessore al giornalista, dal
selezionatore del personale all’operatore di call center, tutti praticano
quotidianamente una qualche forma di intervista), ma anche perché
attraverso la radio e la televisione l’esposizione (e qualche volta
l’esibizione) del proprio self ogni giorno entra prepotentemente nelle nostre
case: i talk show, gli spettacoli di intrattenimento, i reportage, i sentimenti
catturati al bordo di un campo di calcio, le emozioni rubate sui luoghi di una
tragedia o di un disastro, sono solo l’ultima trasformazione dell’intervista.
Il libro si propone di analizzare e illustrare compiutamente sia l’intervista
discorsiva che l’intervista standardizzata. In realtà, anche per il background
eminentemente qualitativo dei due curatori, la seconda risulta alquanto
8
sacrificata. Da questo punto di vista Gubrium e Holstein hanno tentato
un’impresa impossibile, a meno di non ampliare spropositatamente un’opera
che è già di mille pagine: trattare congiuntamente e in modo completo due
metodi in realtà diversissimi, accomunati fondamentalmente e solo dal fatto
che in essi l’interazione si svolge tra due persone estranee.
Il manuale si apre con due capitoli introduttivi: uno dei curatori (di cui ho
già parlato), l’altro di Jennifer Platt che ricostruisce una storia
dell’intervista (sia qualitativa che standardizzata) attraverso alcuni testi
fondamentali (ma soltanto) inglesi e americani, dagli anni Quaranta ad oggi.
La prima parte del manuale presenta i principali modelli di intervista:
standardizzata (Royce A. Singleton Jr. e Bruce C. Straits), qualitativa
(ovvero l’intervista che mira a cogliere il punto di vista dei partecipanti su
alcuni argomenti o relativamente alla vita di un’organizzazione — Carol
A.B. Warren), in profondità (nel senso che coglie l’esperienza e le emozioni
di un soggetto — John M. Johnson), le storie di vita (Robert Atkinson) e il
focus group (David L. Morgan). La prima parte si chiude con un saggio di
Andrea Fontana su come le tendenze postmoderne abbiano recentemente
trasformato l’intervista, solo quella non standardizzata ovviamente.
La seconda è una delle parti più interessanti e riuscite del volume. Tratta
della relazione con i diversi soggetti reclutati a seconda dell’argomento di
ricerca. Solitamente i manuali di metodologia presentano l’intervista in
termini generali, come se ogni intervista fosse guidata da principi e criteri
simili. Invece le interviste sono diversissime fra loro perché sono diverse le
categorie di soggetti intervistati: interagire con bambini e adolescenti
(Donna Eder e Laura Fingerson) comporta approcci, strategie, modalità di
ascolto differenti dall’intervistare uomini adulti (Michael L. Schwalbe e
Michelle Wolkomir), donne (Shulamit Reinharz e Susan E. Chase), gay e
lesbiche (Travis S.K. Kong, Dan Mahoney e Ken Plummer), che si
autodefiniscono ‘terzo genere’, anziani (G. Clare Wenger), persone di etnie
diverse da quelle dell’intervistatore (Christopher Dunbar Jr., Dalia
Rodriguez e Laurence Parker), elite (leader religiosi, politici, top manager,
filantropi ecc. — Teresa Odendahl e Aileen M. Shaw) e persone malate
(Janice M. Morse). Ovviamente la lista non è esaustiva; si potrebbero
inserire i poveri e gli analfabeti, le persone che soffrono di problemi
psichiatrici o di disabilità fisiche, le vittime di terrorismo, disastri
ambientali, incidenti tecnologici e altre ancora. Tuttavia l’attenzione che i
curatori riservano per i distinctive respondents è davvero encomiabile.
9
Interessante anche è la terza parte dedicata alle situazioni in cui avviene
l’intervista: in Paesi diversi (cross-cultural) da quello dell’intervistatore
(Anne Ryen), in ambienti medici (Kathleen A. Zoppi e Ronald M. Epstein),
in psicoterapia (Gale Miller, Steve de Shazer e Peter De Jong), nel
giornalismo (David L. Altheide), al commissariato di polizia (Ian K.
McKenzie), nel sistema scolastico (William G. Tierney e patrick Dilley),
nella selezione del personale (Gary P. Latham e Zeeva Millman).
Ovviamente i curatori hanno fatto necessariamente una selezione
(certamente criticabile) di ambienti e situazioni che sarebbero
potenzialmente moltissimi.
Gli aspetti più tecnici della gestione dell’intervista compongono la quarta
parte, anch’essa molto interessante e ben strutturata, con capitoli che
rispondono a ciascuna delle domande classiche che un novizio si pone:
come porre le domande e ottenere buone risposte (Jeffrey C. Johnson e
Susan C. Weller)? Come faccio a convincere un soggetto non interessato a
farsi intervistare (Patricia A. Adler e Peter Adler)? Quali sono i vantaggi e i
limiti di una intervista faccia-a-faccia rispetto a una telefonica (Roger W.
Shuy)? Come condurre un’intervista con l’aiuto di un sistema
computerizzato (Mike P. Couper e Sue Ellen Hansen)? Può l’intervista
standardizzata diventare più flessibile tenendo conto delle caratteristiche
dell’interazione (Nora Cate Schaffer e Douglas W. Maynard)? Quali sono i
benefici e gli svantaggi di condurre una ricerca mediante interviste in
internet (Chris Mann e Fiona Stewart)? Come si trascrive un testo di
un’intervista per mantenerla ‘viva’ (Blake D. Poland)? Come si può
condurre un’analisi testuale mediante i programmi informatici oggi
disponibili (Clive Seale)?
Un’altra parte particolarmente felice è la quinta, in cui vengono presentati i
principali approcci e strategie di analisi del materiale tratto da un’intervista.
Sono cinque le prospettive che si confrontano in questa sezione, le quali
nascono da e rispondono a particolari problemi di ricerca e obiettivi
conoscitivi a volte incommensurabili: la grounded theory (Kathy Charmaz),
l’analisi narrativa di storie personali (Catherine Kohler Riessman), la
storia orale (Richard Candida Smith), l’analisi narrativa organizzativa
(Barbara Czarniawska), l’analisi istituzionale (Marjorie L. DeVault e Liza
McCoy) volta alla studio dei processi di negoziazione e delle relazioni di
potere tra istanze locali, organizzazioni e amministrazioni governative,
l’etnometodologia (Carolyn D. Baker). Altre prospettive, più note in
10
Europa, sono assenti nel volume: ad esempio le tedesche Ermeneutica
oggettiva o strutturale di Ulrich Oevermann (un allievo di Habermas) ed
Ermenutica collettiva di Rainer Zoll. Tuttavia al lettore viene offerta
un’ampia gamma di approcci da cui scegliere.
La svolta postmoderna è ampiamente rappresentata anche in questo volume.
Essa si concentra nella sesta e ultima parte dedicata alla riflessività e ai
problemi della rappresentazione. Autori del calibro di Norman K. Denzin
(per l’intervista riflessiva), di Carolyn Ellis (sul ruolo e gli effetti
dell’esperienza del ricercatore sull’intervista), Paul Atkinson e Amanda
Coffey (che rivisitano in modo acuto, in un saggio peraltro molto bello e
istruttivo, la relazione tra osservazione partecipante e intervista), Charles L.
Briggs (sul potere e la diseguaglianza sociale riprodotte nell’intervista) ben
delineano gli effetti della svolta postmoderna sui concetti cardine della
metodologia quali quelli di attendibilità, validità, realtà, verità. Anche se la
prospettiva postmoderna ha tanti ammiratori quanti detrattori, tuttavia essa
ha prodotto una riflessione a cui la metodologia tradizionale non può più
sottrarsi.
Giampietro Gobo
professore associato,
insegna Metodologia della ricerca sociale
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano
e-mail: [email protected]
http://www.sociol.unimi.it/corsi/met_ric_soc/
11