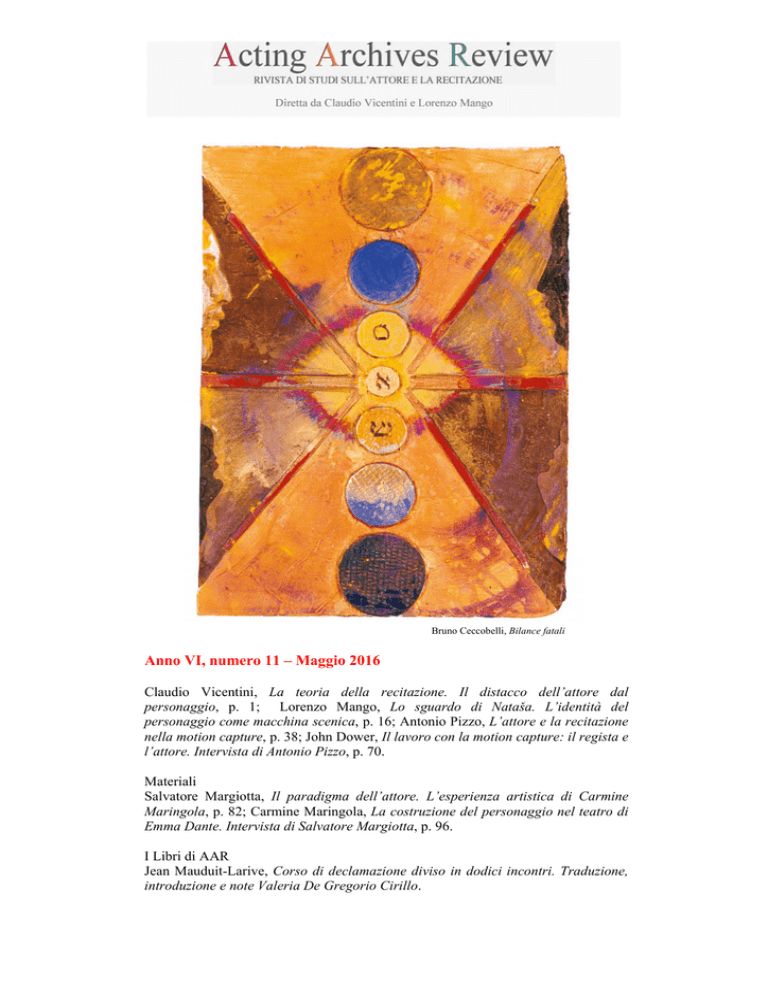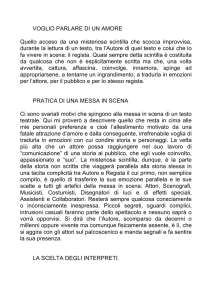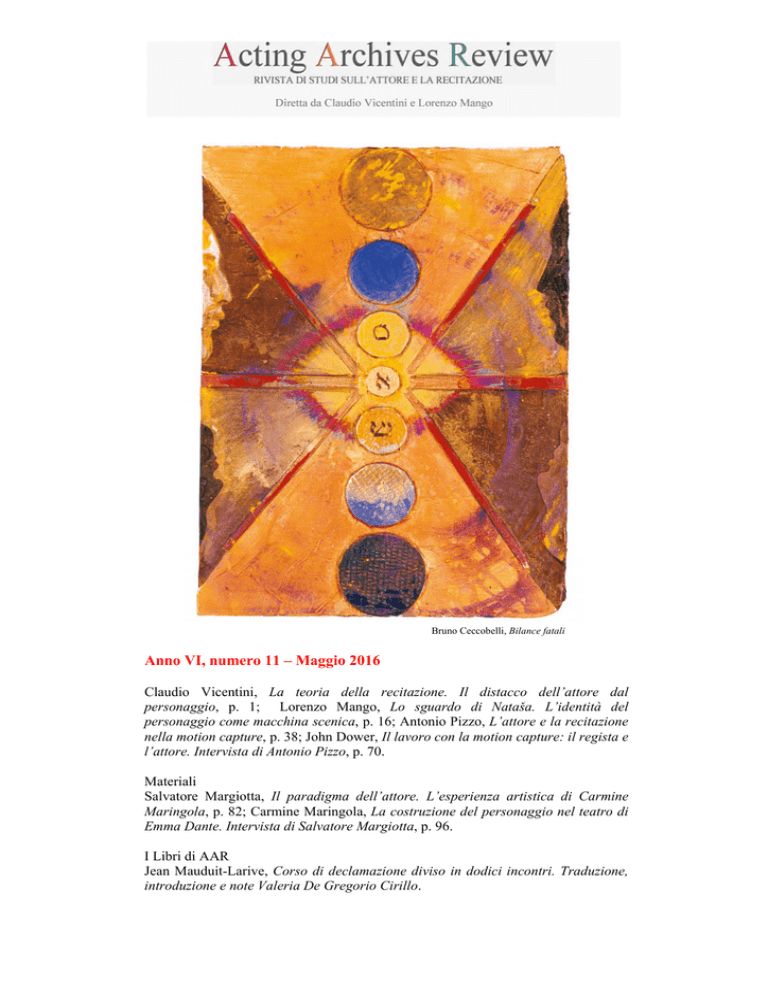
Bruno Ceccobelli, Bilance fatali
Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Claudio Vicentini, La teoria della recitazione. Il distacco dell’attore dal
personaggio, p. 1; Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša. L’identità del
personaggio come macchina scenica, p. 16; Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione
nella motion capture, p. 38; John Dower, Il lavoro con la motion capture: il regista e
l’attore. Intervista di Antonio Pizzo, p. 70.
Materiali
Salvatore Margiotta, Il paradigma dell’attore. L’esperienza artistica di Carmine
Maringola, p. 82; Carmine Maringola, La costruzione del personaggio nel teatro di
Emma Dante. Intervista di Salvatore Margiotta, p. 96.
I Libri di AAR
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri. Traduzione,
introduzione e note Valeria De Gregorio Cirillo.
Acting Archives Review
n. 11, maggio 2016
Direzione Claudio Vicentini e Lorenzo Mango
Direttore responsabile Stefania Maraucci
Comitato scientifico Arnold Aronson (Columbia University), Silvia Carandini (Università di Roma, La Sapienza),
Marco De Marinis (Università di Bologna), Mara Fazio (Università di Roma, La Sapienza), Siro Ferrone (Università di
Firenze), Pierre Frantz (Université Paris Sorbonne), Flavia Pappacena (Accademia Nazionale di Danza), Sandra Pietrini
(Università di Trento), Willmar Sauter (Stockholms Universitet), Paolo Sommaiolo (Università di Napoli “L'Orientale”)
Redazione Review: Salvatore Margiotta, Mimma Valentino, Daniela Visone; Essays: Laura Ricciardi, Barbara
Valentino
Peer Review. Gli articoli vengono esaminati da revisori esterni. Gli articoli richiesti e concordati dalla direzione della
rivista secondo il programma editoriale sono sottoposti alla valutazione interna dei direttori o dei membri del comitato
scientifico, secondo le competenze.
______________________
Rivista semestrale
Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 82 del 21/10/2010
ISSN: 2039-9766
www.actingarchives.unior.it
Sito: www.actingarchives.it
Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Claudio Vicentini
La teoria della recitazione.
Il distacco dell’attore dal personaggio
La regola del distacco
Nella considerazione ecologica delle nozioni usate nello studio della
recitazione si collocano, accanto all’identificazione, due concetti chiave, il
‘distacco’ (l’attore rappresenta il personaggio manifestandone i sentimenti
senza provarli), e la ‘dislocazione’ (l’attore mentre recita rende visibile la
propria presenza accanto alla figura del personaggio).1 Tuttavia anche la
dislocazione viene per lo più indicata come distacco, e l’impiego delle due
nozioni, sovente confuse, si è ampiamento diffuso in omaggio a una sorta di
vulgata della teoria brechtiana dove il distacco e la dislocazione appaiono
connessi nella produzione dell’effetto di straniamento (far apparite
straordinari e quindi oggetto di attenzione critica fatti e comportamenti
consueti), al punto da essere sovente intesi come sinonimi, o quanto meno
come tecniche inseparabili.
Le origini e lo sviluppo delle sue nozioni sono però indipendenti. Sono
nozioni elaborate tra la metà del settecento e gli inizi dell’ottocento nel
tentativo di rispondere a un problema assolutamente lontano dalla nozione
di straniamento (che è inesistente prima di Brecht), e apparentemente
insolubile: come rendere sulla scena un personaggio inadatto a manifestarsi
nella realtà umana dell’attore. Nelle risposte a due diverse forme di
«irrappresentabilità» del personaggio veniva messa a punto prima la
nozione di distacco, e poi quella di dislocamento.
Il distacco è teorizzato per la per la prima volta nell’Art du Théatre à Madame
*** di Antoine-François Riccoboni apparso nel 1750. Secondo una
convinzione indiscussa, posta a fondamento della teoria della recitazione fin
dalle prime formulazioni d’epoca greca e romana, l’adesione emotiva è un
aiuto prezioso o addirittura indispensabile alla resa delle espressioni che
l’attore manifesta interpretando il personaggio. All’adesione emotiva erano
attribuite due funzioni: imprimere spontaneamente sul volto e
nell’atteggiamento l’espressione richiesta dalla parte, e caricarla di
un’energia particolare che contagiava lo spettatore coinvolgendolo nello
stato emotivo rappresentato.
Contro questo postulato Antoine-François Riccoboni muoveva un’obiezione
destinata a diventare celebre. Se un attore prova davvero il sentimento che
Sulla considerazione ecologica delle nozioni impiegate nello studio del teatro vedi C.
Vicentini, Per un’ecologia delle nozioni di lavoro. L’identificazione dell’attore con il personaggio,
«Acting Archives Review«, n. 7, maggio 2014 (www.actingarchives.it).
1
© 2016 Acting Archives www.actingarchives.it 1 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 manifesta perde la capacità di controllare le proprie espressioni, rendendole
false e confuse, o addirittura pericolose. Questo pericolo, ma solo
sporadicamente e in termini assai generici, era già stato considerato dalla
letteratura precedente. Si ricordava il tragico episodio di Montdory colpito
da paralisi sulla scena del Théâtre du Marais nell’agosto del 1637 mentre
pronunciava con eccessiva veemenza le imprecazioni del personaggio di
Hérode nella Mariamne di Tristan. Si ricordava anche la fine di Montfleury
morto trent’anni dopo in seguito ai furori declamatori con cui aveva
interpretato la follia di Oreste nell’Andromaque di Racine. Ma non era
necessario arrivare a tanto. Le insidie dell’emozione potevano avere effetti
meno tragici ma comunque devastanti. Nelle Réflexions sur l’eloquence de ce
temps del 1671 René Rapin citava il caso di un avvocato trascinato dal suo
discorso al punto da ingarbugliare la pronunzia e diventare incomprensibile.
In tempi più recenti Grimarest aveva osservato che un’eccessiva passione,
realmente provata da un avvocato, poteva alterarne la voce e impedire
un’efficacia scelta delle parole, e Jean Poisson aveva ribadito l’esigenza di
regolare l’adesione emotiva nel parlare in pubblico perché altrimenti la voce
si soffocava e la memoria si smarriva.2
Si trattava però dei danni provocati da un evidente eccesso emotivo. Con
Antoine-François Riccoboni la questione si poneva in termini diversi. Non
riguardava soltanto un’eventuale sovrabbondanza di adesione sentimentale.
Si stabiliva piuttosto una regola assoluta che escludeva sempre e comunque
la partecipazione interiore, più o meno intensa che fosse: «se si ha la sfortuna
di provare realmente quello che si deve esprimere», stabiliva l’Art du Théatre
à Madame ***, «non si è in grado di recitare». Veniva proposto un esempio
che doveva apparire inequivocabile:
Se in un punto di intenerimento vi lasciate trasportare dal sentimento della
vostra parte, il vostro cuore si troverà ad un tratto serrato, la vostra voce si
soffocherà quasi del tutto; se cade una sola lacrima dai vostri occhi, dei
singhiozzi involontari impacceranno il gosier, vi sarà impossibile proferire una
sola parola senza dei singulti ridicoli. Se dovete allora passare subitamente alla
più grande collera, ciò vi sarà forse possibile? No, senza dubbio. Cercherete di
rimettervi da uno stato che vi priva della facoltà di proseguire, un freddo
mortale si impadronirà dei vostri sensi e per qualche istante non reciterete più
che macchinalmente. Cosa ne sarà in quel momento dell’espressione di un
sentimento che richiede molto più calore e forza del primo? Quale orribile
scompiglio ciò non produrrà nell’ordine delle sfumature che l’attore deve
percorrere affinché i sentimenti appaiano legati e sembrino nascere gli uni dagli
altri?3
R. Rapin, Réflexions sur l’eloquene de ce temps, Paris, Barbin et Muger, 1671, pp. 69-70 ; J.-L. Le
Gallois de Grimarest, Traité du Récitatif, Paris, Jacques Lefèvre et Pierre Ribou, 1707, p. 118 ; J.
Poisson, Réflexions sur l’art de parler en public, s.l., 1717, p. 25.
3 A. F. Riccoboni, L’arte del teatro, tr. it., introduzione e note di E. De Luca, Napoli, Acting
Archives, , 2015, p. 182, www.actingarchives.it (Books).
2
2 Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio Dunque anche gli stati d’animo moderati, come l’intenerimento – diversi
dagli impeti del furore tragico, dall’odio, dalla disperazione – trascinano
l’attore in una sorta di confusione espressiva. Poi Antoine-François
Riccoboni passava a un secondo esempio:
Un attore entra in scena, le prime parole che sente devono causargli una
sorpresa estrema, coglie la situazione e tutto a un tratto il suo viso, l’aspetto e
la sua vice marcano uno stupore da cui lo spettatore è colpito. Può egli
veramente essere sorpreso? Egli conosce a memoria ciò che gli verrà detto:
giunge a bella posta perché glielo si dica.4
La conclusione, di nuovo, era chiara. Esistono circostanze e scene in cui
l’adesione emotiva è impossibile.
Il distacco inteso come regola assoluta della recitazione veniva ribadito nel
Paradoxe sur le comédien di Diderot, composto tra il 1773 e il 1777 e pubblicato
parecchio tempo dopo, nel 1830.5 Qui le considerazioni e gli esempi si
moltiplicavano e riguardavano due generi di argomenti assai diversi. Gli
argomenti del primo genere sottolineavano l’inaffidabilità dell’adesione
emotiva. Nessuno può decidere di provare un sentimento quando vuole, e
dunque, osservava Diderot, nessun attore potrebbe produrre l’espressione
dettata dalla parte nel preciso momento in cui viene richiesta dallo sviluppo
del dramma.6 Inoltre, affidandosi alla propria sensibilità emotiva, l’attore
sarebbe soggetto alle interferenze dei sentimenti della sua vita privata che
turberebbero lo stato interiore necessario alla resa del personaggio: «avrà
anch’egli un padre, una madre, una moglie, dei figli, dei fratelli» e
«bersagliato al pari di noi e colpito da una serie infinita di disgrazie», non
potrebbe il più delle volte recitare.7 Infine la gamma di stati d’animo di cui
ognuno dispone è limitata e definita dalla sua personalità individuale, perciò
un interprete non riuscirebbe mai a provare passioni che gli sono estranee.
Incapace di recitare due personaggi differenti «potrebbe eccellere soltanto in
alcuni punti di una medesima parte».8 Da tutto questo Diderot traeva una
regola del distacco non dissimile da quella di Antoine-François Riccoboni: la
recitazione richiede sempre un atteggiamento «freddo e tranquillo», spoglio
da qualsiasi elemento emotivo prodotto dalla sensibilità dell’interprete.9
A Diderot non sfuggiva però che la stessa recitazione, per quanto fredda e
distaccata, poteva di per sé provocare nell’attore uno stato emotivo che
Ivi, p. 184.
Diverse argomentazioni contenute nel Paradoxe, erano già note, sia pure in un ambito
ristretto, prima del 1830. Diderot le aveva esposte in un articolo, Observations de M. Diderot sur
une brochure intitulée Garrick ou les acteurs anglais, pubblicato in due numeri, il 15 ottobre e il 1
novembre del 1770, sulla «Correspondance littéraire», periodico manoscritto.
6 D. Diderot, Paradosso sull’attore, tr. it. a cura di P. Alatri, Roma, Editori Riuniti, 1989, p. 73.
7 Ivi, pp. 116-117.
8 Ivi, p. 135.
9 Ivi, p. 75.
4
5
3 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 definiva «fittizio» (acquis ou factice)10. Di un «calore» prodotto dall’azione
recitata, che investe progressivamente lo stato emotivo dell’attore, si era del
resto già parlato. Vi aveva accennato d’Aubignac nella Pratique du théâtre
ricordando che talvolta Montdory, «per animarsi un po’» prima di recitare
le battute della parte, passeggiava «dondolando la testa, alzando e
abbassando gli occhi e assumendo diversi portamenti secondo il sentimento
da esprimere».11 Di un «fervore» prodotto dall’azione che anima la resa
emotiva dell’interprete accennava, diverso tempo dopo, Jean Dumas
d’Aigueberre in un saggio del 1730 riferendosi alla recitazione della Duclos.12
Nel 1734 Aaron Hill spiegava che la stessa postura fisica assunta dall’attore
nel recitare la parte, l’atteggiamento, le azioni compiute, lo emozionavano
facendogli provare «i veri sentimenti delle passioni recitate».13 Anche
Antoine-François Riccoboni aveva osservato che l’attore quando interpreta
«i pezzi di grande passione» sente per un effetto naturale della recitazione
«un’emozione vivissima».14 Tuttavia, mentre d’Aubignac, d’Aigueberre e
Aaron Hill individuavano in un fenomeno del genere un aiuto alla resa del
personaggio, e Riccoboni, paladino del distacco, non pareva né apprezzarlo
né condannarlo, Diderot compiva un passo ulteriore. La sensibilità fittizia gli
offriva l’occasione per denunziare l’effetto nefasto che l’emotività - in
qualsiasi forma e comunque prodotta - provoca nella resa della parte.
L’attore deve resistere al sentimento fittizio con una «volontà di ferro»,
compiendo un’assoluta rinuncia a riempire i suoi gesti e le sue espressioni
con ogni scampolo di emotività.15
Di fronte a una prescrizione così perentoria e nonostante il carattere assoluto
della regola gli argomenti di Diderot, così come quelli di Antoine-François
Riccoboni, non riuscivano in realtà ad escludere l’adesione emotiva come
una delle possibili componenti della recitazione. Dimostravano che la
partecipazione interiore non era sufficiente perché non soddisfaceva alcune
importanti esigenze dell’interpretazione attorica: il controllo espressivo, la
difesa da interferenze emotive estranee alla resa della parte, la varietà dei
personaggi da rappresentare, la necessità di esibire in ogni momento del
dramma l’espressione richiesta. Ma tutto ciò non spiegava perché non
potesse costituire almeno un sostegno per rendere più efficaci i gesti e le
espressioni dell’attore, sia pur impostati, studiati, meditati e
meticolosamente eseguiti con procedure diverse. Se poi era vero che l’empito
emotivo portato a un estremo livello era comunque dannoso perché
Ivi, pp. 82, 87,111.
F. H. d’Aubignac, La pratique du théâtre, Paris, Antoine de Sommaville, 1657, p. 281.
12 J. D. d’Aigueberre, Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen, tr. it., introduzione e
note di V. De Gregorio Cirillo, Napoli, Acting Archives, 2012, p. 232, www.actingarchives.it
(Books).
13 A. Hill, Lettera a Marshall, 24 ottobre 1733, in The Works of the Late Aaron Hill, 4 voll., London,
Printed for the Benefit of the Family, 1753, vol. I, p.158.
14 A. F. Riccoboni, Art du Théatre à Madame ***, cit., p. 183.
15 D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., pp. 87, 111.
10
11
4 Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio distorceva e bloccava l’espressività dell’attore, non era detto che dovesse
sempre arrivare a questi eccessi. Come spiegava John Hill in The Actor, pochi
anni dopo l’uscita del testo di Riccoboni, un bravo attore deve essere in grado
di regolare la propria sensibilità evitando «di sentire in modo tale da perdere
l’uso della voce», e dimostrarsi capace di «controllare le sue passioni in modo
che queste non disturbino le sua espressione».16
Posta in questi termini – la partecipazione emotiva non è sufficiente per
recitare una parte – la nozione di distacco si riduceva a un’ovvietà. Ma nel
dibattito teorico del tempo la regola del distacco, nella sua formulazione
assoluta e radicale, assumeva un’importanza determinante. Nel 1728 Luigi
Riccoboni, padre di Antoine-François, aveva infatti pubblicato Dell’arte
rappresentativa, e illustrando le regole da seguire sulla scena aveva posto
l’adesione emotiva come fondamento dell’arte dell’attore, base primaria di
ogni altra operazione tecnica necessaria alla resa della parte. Veniva così
inaugurata la moderna concezione emozionalista della recitazione, poi
ampiamente sviluppata nel Comédien di Rémond de Sainte-Albine.17
La regola del distacco formulata da Antoine-François e da Diderot si
presentava come critica diretta a questa concezione.18 Se l’adesione emotiva,
per la propria instabilità, richiedeva un essenziale ricorso ad altre risorse
della tecnica attorica, non poteva evidentemente essere posta a fondamento
della recitazione. Ma qui si apriva un problema di ampia portata. Liquidata
la posizione di Luigi Riccoboni e Rémond de Sainte-Albine, l’opposizione
antiemozionalista si trovava impegnata a delineare una diversa teoria della
recitazione, fondata su altre basi, e soprattutto, come prescriveva la
formulazione della regola del distacco, escludendo ogni apporto
dell’emozione dell’attore alla resa del personaggio. Era un compito improbo
e destinato al fallimento. L’esigenza che lo muoveva finiva però con
l’orientare per tutto l’ottocento e il primo novecento una parte della
discussione sull’arte dell’attore in una direzione sostanzialmente sterile:
discutere se la recitazione dovesse valersi di strumenti esclusivamente
emotivi, o esclusivamente razionali.19 Una contrapposizione in cui, nel pieno
J. Hill, The Actor, London, R. Griffiht, 1755, p. 54.
L. Riccoboni, Dell’arte rappresentativa. Capitoli sei, London, 1728; P. Rémond de SainteAlbine, Le comédien, Paris, Dasaint & Saillant et Vincent fils, 1747.
18 Antoine-François fa esplicito riferimento alla teoria paterna (esposta dopo il trattato del ’28
nelle Pensée sur la déclamation, Paris, Briasson, Delormel, Praul, 1738) in una nota dell’Art du
théâtre, di tono ambiguamente rispettoso: «So che in questo articolo sono completamente
all’opposto dell’opinione di mio padre, come si può veder nei suoi pensieri sulla
declamazione. Il rispetto che devo alla sua decisione, riconoscendolo come mio maestro
nell’arte del teatro, e sufficiente a persuadermi che ho torto; ma ho creduto che la mia
riflessione, vera o falsa, non sarebbe stata inutile al lettore» (cit. p. 183). Ed è in diretta
polemica con un’opera derivata dal Comédien di Rémond de Sainte-Albine (Garrick ou les
acteurs anglais) che Diderot compone il Paradoxe. Per la ricostruzione della vicenda e la
consultazione dei relativi testi vedi il «Catalogue» di Acting Archives (www.actingarchives.it)
alla voce Paradoxe sur le comédien.
19 È interessante notare che Luigi Riccoboni e Rémond de Sainte-Albine fondando la
recitazione sull’adesione emotiva non escludevano affatto il ricorso, quando necessario, al
16
17
5 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 del dibattito, George Henry Lewes ravvisava acutamente una sorta di
irrisolvibile «antinomia», resa in questi termini:
se l’attore perde ogni potere sulla propria arte sotto l’influsso disturbante
dell’emozione, perde anche ogni potere sulla sua arte in proporzione alla sua
insensibilità all’emozione. Se davvero sente, non può recitare; ma non può
recitare se non sente». 20
L’antinomia, appunto, in cui restavano per lungo tempo impantanate senza
troppo costrutto le appassionate schiere degli emozionalisti e degli
antiemozionalisti.
La differenza di attore e personaggio, l’illusione e la regola della quarta
parete
Di ben altra importanza era invece la seconda serie di argomenti contro
l’impiego dell’adesione emotiva esposti nel Paradoxe. Erano basati sulla
differenza tra le condizioni della vita reale e della rappresentazione teatrale.
Già l’ampiezza del palcoscenico e della sala, spiegava Diderot, richiedono
una portata espressiva superiore a quella impiegata negli interni della realtà
quotidiana. La voce o il gesto spontaneamente prodotti dal sentimento
dell’attore che si immerge nelle circostanze immaginarie del dramma (un
colloquio in un salotto borghese, un dialogo sussurrato in segreto) risultano
insufficienti e devono essere sostituiti da una voce e un gesto appositamente
costruiti. Ma ciò che soprattutto rende inutilizzabile l’adesione emotiva è la
differenza che riguarda i personaggi, che sono diversi, osservava Diderot,
dai concreti individui umani: sono creature fantastiche create dall’autore,
«fantasmi immaginari della poesia» o «ippogrifi, con i loro movimenti, il loro
portamento, le loro grida».21
La differenza riguarda sia i personaggi della commedia che quelli della
tragedia. Questi sono dotati di straordinaria potenza e di grandezza, sono
ragionamento e alle risorse tecniche per mettere a punto l’espressività dell’interprete, e
talvolta per rendere a freddo il comportamento del personaggio mediante la semplice
imitazione esteriore. Un solo testo, rimasto praticamente sconosciuto, L’art du comédien di
Tournon de la Chapelle del 1783 (tr. it., introduzione e note di V. De Gregorio Cirillo, L’arte
dell’attore, Napoli, Acting Archives, 2013, www.actingarchives.it (Books), sembra forse
seguire un’impostazione emozionalista «pura». Anche nella bibbia novecentesca della
dottrina emozionalista, Il lavoro dell’attore su se stesso, Stanislavskij dedicava diverse pagine al
«controllo scenico» spiegando che i gesti che vanno bene nella vita quotidiana, a teatro, «con
migliaia di persone», non appaiono abbastanza precisi e completi. Di qui il lungo lavoro
tecnico prescritto dell’attore per rendere i gesti della recitazione adatti alla scena (Il lavoro
dell’attore su se stesso, edizione riveduta e corretta a cura di F. Malcovati, Roma-Bari, Laterza,
2004, pp. 483-490). La polemica antiemozionalista si era insomma fin dagli inizi costruita un
falso bersaglio sul quale si era paradossalmente riconosciuta anche una parte dello
schieramento emozionalista, impegnata a sostenere una tesi (la totale sufficienza
dell’adesione emotiva) che non era mai stata formulata.
20 G. H. Lewes, Gli attori e l’arte della recitazione, tr. it. e cura di Edoardo Giovanni Carlotti,
Milano, Costa e Nolan, 1999, p.110.
21 D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., p. 84.
6 Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio percorsi da passioni infinitamente più intense di quelle delle persone reali, e
richiedono perciò espressioni smisurate rispetto a quelle prodotte dai
semplici sentimenti umani. I personaggi della commedia, anche se
apparentemente più simili a noi, sono figure tipiche, che condensano in sé i
tratti specifici di un’intera categoria di persone. Devono perciò dotarsi di
espressioni caratteristiche, differenti da quelle dettate dai moti dell’animo
del semplice individuo umano.22
Diderot delineava quindi una teoria della recitazione fondata
sull’imitazione, scandita in un processo che comprendeva precisi passaggi.
L’attore, studiando il testo del dramma, forma nella sua immaginazione la
figura del personaggio. Le indicazioni del testo non sono però sufficienti per
la resa scenica che richiede la definizione di toni, pause, gesti, movimenti e
dettagli d’ogni genere. L’attore ricrea perciò nella propria mente la figura
ricavata dal testo. Nei casi migliori, ad opera dei grandi attori, l’immagine
ricreata può rivelarsi più potente ed efficace di quella fornita dall’autore, nei
casi meno felici, più inerte e scolorita. Comunque, fissata questa immagine
mentale, l’attore la imita con il proprio corpo e la propria voce, studiando e
memorizzando toni, gesti ed espressioni che ripete con la massima
precisione di fronte al pubblico.
Una simile teoria non sfuggiva ovviamente ad alcune obiezioni. Era difficile
pensare che il processo di ricostruzione fantastica del personaggio potesse
svolgersi senza una qualche partecipazione emotiva dell’attore. E poi
l’imitazione del personaggio tramite gesti ed espressioni fisiche non poteva
non comportare una corrispondente reazione interiore dell’interprete. Su
quest’ultima questione Diderot, come si è visto, interveniva appellandosi
alla «volontà di ferro» dell’attore che avrebbe respinto l’affiorare di
un’emozione fittizia. Però la faccenda era di ben altra portata, e destinata a
inaugurare un importante capitolo della teoria della recitazione otto e
novecentesca. A partire da Lessing che com’è noto già nel 1754, sulla
Theatralische Bibliothek ne aveva percepito l’estrema importanza. L’anima,
aveva scritto, «mediante l’impressione ricevuta dai sensi si porrà da sola in
quello stato conforme ai suoi movimenti, atteggiamenti e toni». E aveva poi
ripreso l’argomento nella Hamburgische Dramaturgie, scorgendovi un
presupposto per la definizione di una «grammatica» del linguaggio del
corpo, parte essenziale dello studio della recitazione.23
Ivi, pp. 106-107, 123.
G. E. Lessing, Auszug aus dem ‘Schausplieler’ der Herrn Rémond de Sainte-Slbine, in Theatralische
Bibliothek, I, Berlin, Voss, 1754, p. 249; e Drammaturgia d'Amburgo, tr. it. a cura di P. Chiarini,
Roma, Bulzoni, 1975, pp. 21-23. Il progetto lessinghiano veniva com’è noto realizzato nelle
Ideen zu einer Mimik di J. J. Engel, 2 voll., Berlin, Mylius, 1785-1786. Il naturale riflesso emotivo
provocato dalle espressioni, dai gesti e dagli atteggiamenti del corpo veniva considerato
anche nella trattatistica inglese, nell’Inchiesta sul bello e il sublime di Edmund Burke (tr. it. a cura
di G. Sertoli e G. Miglietta, Palermo, Aesthetica, 2006, pp. 139,140), e negli Elements of
Elocutions di J. Walker (2 vollumi.,London, Printed for the Author, 1781, vol. II, pp. 278-280 e
288-290).
22
23
7 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Ma non meno importanti erano le conseguenze della differenza stabilita da
Diderot tra la concreta umanità dell’attore e l’universalità e la potenza
espressiva del personaggio. L’attore deve rappresentare un essere
profondamente diverso da sé, evitando in particolare l’esibizione dei
prodotti dell’emotività personale, «troppo umani» per la figura del
personaggio. Deve dunque lavorare a freddo, costruendo senza parteciparvi
le espressioni adatte alla parte. Se poi la recitazione è perfetta, spiegava
Diderot, il pubblico si lascerà trarre in inganno e riterrà che le espressioni del
personaggio non siano finte, ma prodotte da sentimenti reali. 24 E qui l’intera
costruzione del Paradoxe finiva con l’inciampare in una singolare
contraddizione. I sentimenti «reali» che il pubblico avverte dietro le
espressioni recitate sono assolutamente identici a quelli che prova un concreto
essere umano, quale è l’attore che le recita, tant’è vero che è difficile sradicare
la convinzione diffusa (contro cui tutto il il Paradoxe è diretto) che sia proprio
il sentimento vivo e presente nell’interprete a produrre le espressioni esibite
al pubblico. Insomma, per quanto la qualità meramente umana
dell’interprete debba essere occultata dietro l’apparenza di un essere
«diverso», e il suo patrimonio emotivo annullato, il prodotto finale della
recitazione apparirebbe agli occhi degli spettatori un impossibile ibrido, in
cui si ritroverebbero strettamente combinati lo scarto (espressivo) e la
sovrapposizione (emotiva) tra essere umano e immagine fantastica, tra attore
e personaggio.
Il tentativo operato da Diderot nel Paradoxe si impigliava così in un
complesso di convinzioni radicate nella cultura teatrale settecentesca. Il
personaggio era concepito – e da Diderot non meno che da tutti gli altri
autori - come una macchina emotiva, diretta a provocare le più immediate e
autentiche reazioni sentimentali dello spettatore. Questa non era sua unica
funzione, ma l’efficacia di ogni altro compito o significato che gli veniva
assegnato appariva proporzionale agli effetti emotivi che la sua figura
riusciva a produrre. Il bombardamento emotivo provocato dalla recitazione
costituiva poi un contributo essenziale all’illusione drammatica, l’effetto per
cui la rappresentazione teatrale doveva indurre lo spettatore ad attribuire
una qualche forma o livello di realtà a ciò che era di fatto una finzione.25 Non
a caso la letteratura teatrale del tempo conservava un ampio repertorio di
aneddoti in cui i risultati estremi dell’illusione drammatica venivano riferiti
alla straordinaria bravura degli attori, in momenti di particolare tensione.
Negli Anecdotes dramatiques Clément e La Porte raccontavano come la Clairon
in una scena dell’Ariane di Thomas Corneille, nella parte della protagonista,
si dovesse dolorosamente tormentare chiedendosi chi mai potesse essere la
sua rivale, e uno spettatore commosso, le lacrime agli occhi, non si fosse
D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., p. 81.
Sull’illusione drammatica e la sua costruzione vedi più avanti, in questo stesso numero di
«Acting Archives Review», le considerazioni dell’articolo di L. Mango, Lo sguardo di Nataša.
L’identità del personaggio come macchina scenica, «Acting Atchives Review», n. 11, maggio 2016,
pp. 16-38.
24
25
8 Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio trattenuto. Proteso verso di lei, con voce soffocata, l’avvertiva: «è Fedra, è
Fedra!».26 Ma capitava di peggio, come l’incidente descritto da d’Hannetaire,
occorso alla Dumesnil nella parte della scellerata Cleopatra della Rodogune
di Pierre Corneille. Mentre sta per spirare in preda alla rabbia tra orribili
maledizioni viene colpita da un pugno poderoso sferrato «da un vecchio
militare» che esplode: «va cagna, vattene al diavolo!».27
Non possiamo ovviamente sapere se questi episodi fossero realmente
avvenuti o se appartenessero solo alla leggenda. Ciò che importa è però che
fossero coltivati dalla letteratura teatrale settecentesca, che attribuiva loro un
preciso significato. Per Clément e La Porte l’intervento dello spettatore che
avverte la Clairon è un elogio «particolarmente lusinghiero» alla sua arte,
mentre d’Hannetaire aggiunge che la Dumesnil, terminata la
rappresentazione, ringraziava il manesco militare: la sua interpretazione, gli
dichiarava, non avrebbe potuto ricevere elogio migliore.
Ma perché l’illusione drammatica potesse realmente decollare, innescata
dalla capacità emotiva della recitazione, era necessario che la figura scenica
del personaggio coincidesse totalmente con la figura dell’attore in modo che
questo finisse con lo scomparire di fronte agli occhi del pubblico. Era la
convinzione che si affermava in modo perentorio nello sviluppo della
trattatistica settecentesca segnando il definitivo passaggio dalla concezione
«oratoria» alla concezione «drammatica» della recitazione.28 L’errore
caratteristico, che comprometteva la perfetta coincidenza delle due figura
era, ammonivano i trattati dell’epoca, lo spostamento del raggio d’attenzione
dell’attore, che si allontanava dall’azione recitata per dirigersi sul pubblico
in sala. Si moltiplicano così le raccomandazioni: l’attore non deve mai vagare
con lo sguardo sui palchi o la platea, ammiccare, accennare e rivolgersi a
questo o quello spettatore, perché si mostra allora «altro» rispetto al
personaggio. Già nella prima metà del secolo l’insistenza su questo punto
era diventata un luogo comune, costituendo il presupposto su cui verrà
definita la nozione di «quarta parete», introdotta agli inizi dell’ottocento da
Leigh Hunt. In un pezzo dedicato a John Bennister, attore e manager del
Drury Lane, Hunt osservava come questi non sembrasse curarsi
assolutamente degli spettatori. Quando applaudono, scriveva Hunt,
Bannister non si ferma per godersi l’applauso e se non può proseguire nel
dialogo continua nell’azione: il palcoscenico sembra essere «la sua stanza»
di cui il pubblico costituisce «la quarta parete». Il palcoscenico deve essere
appunto considerato «una stanza reale», o un qualsiasi altro ambiente
J. M. Clément e J. de La Porte, Anecdotes dramatiques, 3 vol., Paris, Duchesne, 1775, vol. I, p.
90.
27 J. N. d’Hannetaire, Observations sur l’art du comédien, s.l., Aux dépens d’une société
typographique, 1774, p. 280.
28 Così, ad esempio, l’elogio tributato da Marmontel a Baron, alla voce Déclamation théâtrale
nel quarto volume dell’Encyclopédie. La sua bravura consisteva nell’indurre lo spettatore a
«dimenticare» l’interprete che svaniva nella figura rappresentata. Ma l’affermazione di questo
principio è comunque motivo ricorrente nei trattati dell’epoca.
26
9 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 «astratto dalla moltitudine che osserva». Proprio, proseguiva Hunt, come la
stanza in cui adesso sto scrivendo», e un attore che si permette di guardare
il pubblico e apprezzarne visibilmente gli applausi «è ridicolo, come lo sarei
io se guardassi ad ogni momento il riflesso dei miei sorrisi in uno specchio,
o mi inchinassi alle case dall’altra parte della strada».29
Di fronte al complesso di queste convinzioni, incardinato sull’esigenza
dell’illusione drammatica, sulla necessità di produrre emozioni vive e
immediate e sulla richiesta di mantenere una perfetta coincidenza tra la
figura dell’attore e quella del personaggio, teorizzare una differenza
sostanziale tra la realtà umana dell’interprete e quella immaginaria del
personaggio, e poi renderla in una concreta pratica recitativa costituiva, per
Diderot come per qualsiasi altro autore, un compito impossibile.
L’effetto di dislocazione
In una prospettiva assai diversa da quella di Diderot il problema della
irrappresentabilità del personaggio mediante i mezzi espressivi della
recitazione umana si ripresentava nel saggio di Charles Lamb, On Garrick,
and acting; and the plays of Shakespeare, considered with reference to their fitness
to stage, pubblicato su «The Reflector» nel 1811.30 Per Lamb la recitazione
consisteva essenzialmente nell’ impersonare «la passione e i rivolgimenti
della passione», esponendone gli effetti esteriori «agli occhi e agli orecchi
degli spettatori».31 Non gli sembrava un’operazione particolarmente
complicata: «si tratta soltanto», spiegava, «di alzare o abbassare di un tono o
due la voce, di sussultare con aria presaga per annunciare l’approssimarsi
dell’effetto drammatico», e «la finzione di qualsiasi emozione è così
contagiosa che, quali che siano le parole, basteranno l’aspetto e il tono per
renderla accettabile e farla passare per profonda abilità nel rappresentare le
passioni».32 Il carattere delle impressioni visive e uditive ricevute dallo
spettatore è del resto tanto forte e istantaneo da imprimere nel suo animo la
figura rappresentata in un’immagine densa di emozioni che perdura nel
tempo e nella memoria. In questa immagine interprete e personaggio sono
fusi in una forma inscindibile che si iscrive in modo incancellabile nella
mente dello spettatore.
Per chi va spesso a teatro è difficile dissociare l’idea di Amleto dalla persona e
dalla voce del signor K. [Kemble]; parliamo di Lady Macbeth, ma in realtà
L. Hunt, Critical Essays, London, Printed for John Hunt, 1807, pp. 60-61.
C. Lamb, On Garrick, and Acting; and the Plays of Shakespeare, considered with Reference to their
Fitness to Stage, «The Reflector», n. 4, 1811. Il saggio veniva ripubblicato da Lamb con un
nuovo titolo On the Tragedies of Shakespeare, considered with Reference to their Fitness for Stage
Representation nell’edizione delle sue opere, The Works of Charles Lamb in Two Volumes, London,
C. and Jollier, 1818. La traduzione italiana di G. Melchiori, Sulle tragedie di Shakespeare
considerate dal punto di vista della loro possibilità d’essere rappresentate si trova nel primo dei due
volumi curati da G. Baldini, La fortuna di Shakespeare, Milano, Il Saggiatore, 1965.
31 Ivi, p.217, 219.
32 Ivi, p. 222.
29
30
10 Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio pensiamo alla signor S. [Siddons]. Né questa confusione è commessa soltanto
da persone illetterate […], è anzi un errore dal quale le persone per altro verso
assi colte trovano quasi impossibile liberarsi. 33
Il personaggio creato dall’autore, materializzandosi nella figura concreta e
presente dell’attore, moltiplica dunque la capacità di impatto su quanti ne
vengono a contatto. Ma qui emerge il primo limite della recitazione.
Attraverso gli strumenti dell’espressione fisica possono essere rese solo
poche e semplici passioni, come «l’ira o il dolore». Ciò non appare troppo
importante per il teatro perché «più la passione è rozza e materiale, e più
presa l’attore ha sugli occhi e sull’orecchio del pubblico».34 Impoverisce però
i personaggi che nella configurazione originaria prodotta da un grande
autore, e trasferita nelle più sottili sfumature del testo scritto, possiedono una
superiore profondità di carattere, pensieri e passioni. Nel tessuto verbale del
testo è infatti possibile ritrovare non solo le più elementari passioni provate
dai personaggi, ma anche «le operazioni e i moti interiori» del loro animo»,
il «quando, il perché e il come essi siano commossi», ossia «l’intima struttura»
del loro mondo interiore.35
Materializzandosi nelle capacità espressive dell’attore il personaggio perde
insomma la sua profondità interiore, si spoglia di ogni grandezza e si mostra
come «un uomo nella sua semplice ed evidente forma umana». Re Lear
diventa «un vecchio barcollante sulla scena, scacciato dalle figlie in una notte
di pioggia», una figura che produce nel pubblico la più semplice ed
elementare reazione: «vorremmo offrigli un ricovero e offrirgli aiuto».
Mentre ben altra è la sua autentica dimensione originaria:
La grandezza di Lear non sta nelle sue dimensioni fisiche, ma in quelle
intellettuali […] È la sua mente che viene messa a nudo. La guaina di carne e di
sangue appare troppo insignificante perché ci si possa pensare; ed egli stesso
infatti non la cura. Sulla scena noi non vediamo altro che infermità e debolezze
fisiche, l’impotenza dell’ira; leggendo invece, noi non vediamo Lear, noi siamo
Lear, siamo nella sua mente, siamo sostenuti da una grandezza che sconcerta
la malizia delle figlie e le tempeste; nelle aberrazioni della sua ragione
scopriamo una possente e irregolare capacità di raziocinio, non ridotta a
metodo dagli scopi ordinare della vita, ma che esercita le proprie facoltà al pari
del vento che soffia dove vuole, libero contro la corruzione e gli insulti
dell’umanità.36
Un secondo limite della recitazione risiede nella sua stessa impostazione, per
cui un interprete fisicamente presente deve esibire tutto ciò che fa e dice al
pubblico che l’ascolta e l’osserva. Il che rende il personaggio raffigurato,
quando pronuncia le sue battute, una sorta di «oratore». Ogni sua parola,
moto, affetto per quanto nascosto, solitario o segreto nelle situazioni
Ivi, p. 218.
Ivi, pp. 217, 219.
35 Ivi, pp. 217, 222-223.
36 Ivi, p. 229.
33
34
11 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 delineate dal dramma, si spoglia di intimità, e le sue riflessioni, anche
quando sono private e inconfessabili, risultano di fatto dette a qualcuno. I
colloqui amorosi di Romeo e Giulietta, «quella musica dolce e argentina dei
dialoghi notturni degli amanti», la dolcezza «intima e sacra «del colloquio
nuziale fra Otello e Desdemona, tutte «queste cose» per «il difetto intimo
della rappresentazione teatrale», per il fatto di essere esposte a un vasto
pubblico, sono «intorbidate e allontanate dalla lor vera natura». E se «i nove
decimi di quel che Amleto fa» è «un dibattito fra lui e il suo e senso morale,
effusioni delle sue solitarie meditazioni che sfoga ritirandosi negli angoli,
nelle segrete stanze, nelle più recondite parti del palazzo», tutto ciò non può
essere rappresentato dall’attore «che gesticola, che viene a gridarle a un
pubblico, a confidarsi con quattrocento persone alla volta». Il personaggio di
Amleto «patisce» così, «a venir messo in mostra a guisa di pubblico maestro
di scuola per dar lezioni alla folla».37
Sulla scena, dunque, solo i personaggi semplici, superficiali e
immediatamente melodrammatici possono vivere convenientemente,
mentre le figure più profonde, sfumate, ricche, complesse come quelle del
corpus shakespeariano si sviliscono e deturpano: creature dell’immaginario,
destinate a schiudersi solo nella lettura privata e solitaria del testo, risultano
di fatto irrappresentabili.
Il saggio di Lamb poteva indubbiamente apparire un’anacronistica
condanna del teatro, arte dagli strumenti rozzi e approssimativi di fronte alla
più sofisticate possibilità della parola letteraria. Poteva inoltre sembrare
legato alla visione dello stile di recitazione impiegato in quegli anni sulle
scene inglesi, destinato più tardi a trasformarsi assumendo strumenti
espressivi sempre più sofisticati. Ed è questo il rilievo che verso la fine del
secolo gli sarebbe stato mosso da Percy Fitzgerald, curando la raccolta degli
scritti teatrali di Lamb.38 Ma in realtà Lamb conduceva un’operazione teorica
estremamente importante. Muoveva infatti da una concezione decisamente
attardata della recitazione, tipica della visione settecentesca (impersonare
attraverso le facoltà fisiche dell’attore la passione e i rivolgimenti della
passione), mettendo però in discussione due parametri essenziali di questa
visione. Innanzi tutto la pretesa che l’attore potesse (dovesse) scomparire
dietro il personaggio. In ciò Lamb non scorgeva nulla di buono: vi ravvisava
solo un’ingombrante fusione, in cui se le due figure apparivano
indistinguibili, il personaggio si «materializzava» perdendo le sue qualità. E
poi la convinzione che l’attore, fuso nel personaggio, potesse (dovesse)
immergere tutta la sua concentrazione nella situazione drammatica, mentre
di fatto, per la natura stessa della recitazione, la sua intera prestazione era
strutturalmente rivolta al pubblico presente in sala. Nel dimostrare
l’irrappresentabilità dei personaggi shakespeariani ciò che entrava in
Ivi, pp. 219-221.
P. Fitzgerald, A Commentary, in C. Lamb, The Art of the Stage, as set out in Lamb’s Dramatic
Essays, with Commentary by Percy Fitzgerald, London, Remington, 1885, pp. 167-198.
37
38
12 Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio questione erano insomma i due parametri su cui, per la concezione
settecentesca, si costruiva l’effetto dell’illusione drammatica.
Non era una faccenda da poco. I suoi risultati sarebbero emersi alcuni anni
dopo, favoriti dall’osservazione dello stile recitativo degli migliori interpreti
della comedy of manners, genere, lamentava Lamb, ormai quasi sparito dalle
scene. Si trattava di una recitazione capace di «derealizzare» il personaggio
in modo da disegnarne la figura senza conferirgli la pesante concretezza
dell’individuo umano e conservargli invece la dimensione di «creazione
fantastica» dell’autore.39 Era il caso di John Bannister che nella parte di Ben
in Love for love di Congreve rendeva il personaggio «una deliziosa
apparizione», evitando l’ovvia soluzione di ridurlo a un «uomo reale», la cui
più adeguata collocazione sarebbe, osservava Lamb, «non dietro il sipario»
ma tra il pubblico, «nella prima o seconda galleria».40
Nelle pagine del saggio venivano rilevate due procedure adatte a favorire
l’effetto di derealizzazione. La prima consisteva nel sottolineare il carattere
«recitato» degli atteggiamenti dell’attore, come faceva, ricorda Lamb, Palmer
nell’interpretazione di Joseph Sufarce in The school for scandal. La sua
recitazione evidenziata, con «modi altamente artificiali», neutralizzava la
spiacevole impressione che avrebbe potuto produrre la subdola ipocrisia del
personaggio se le sue azioni e i suoi comportamenti avessero assunto una
più evidente dimensione «reale». Trattata in questo modo, la figura
rappresentata si sottraeva all’immediato giudizio morale dello spettatore,
prestandosi invece senza alcuna difficoltà al suo piacevole divertimento. La
seconda procedura era creare un canale diretto di comunicazione con il
pubblico. L’attore poteva infatti «sdoppiarsi», recitare per gli spettatori
mentre la figura che incarnava parlava agli altri personaggi, e assumere due
voci, «ambedue plausibili», di cui una, «supplementare» e più «decisamente
istrionica» era diretta soltanto al pubblico.41 Per Lamb esistevano insomma
modalità recitative, almeno per i personaggi di un particolare repertorio, in
cui l’efficacia dell’interpretazione dipendeva dalla capacità dell’interprete di
distanziarsi dalla figura rappresentata e di infrangere, nell’atto stesso in cui
faceva agire il personaggio sulla scena, il confine della quarta parete.
Mediante queste due procedure, che lavorano in direzione opposta alle
esigenze dell’illusone drammatica, si ponevano le basi per costruire l’effetto
di dislocazione. E proprio in un saggio successivo, significativamente
Sono le osservazioni esposte in The Old Actors , apparso in tre parti sul «London Magazine»
nel febbraio, aprile e ottobre del 1822. Il saggio veniva successivamente ripreso e pubblicato
da Lamb con tre diversi titoli, On Some of the Old Actors; On the Artificial Comedy of the Last
Century; On the Acting of Munden. Cito da The Works of Charles and Mary Lamb, edited by E. V.
Lucas, vol. II, Elia and the Last Essays of Elia, London, Methuen, 1903.
40 Ivi, pp. 140-141.
41 Ivi, pp. 140, 144-145.
39
13 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 intitolato Imperfect dramatic illusion, Lamb procedeva alla loro precisa
definizione.42
L’argomento centrale del saggio era, di nuovo, l’irrappresentabilità di alcuni
personaggi teatrali. Ma si trattava ora di personaggi assai diversi da quelli
del saggio shakespeariano. Irrappresentabile non era più il personaggio
profondo e articolato nei meandri della sua interiorità. Era il personaggio
macchiato da vizi morali, o comunque caratterizzato da atteggiamenti in
grado di provocare il disgusto e la repulsione dello spettatore. Il problema,
in questa chiave, non era nuovo: era stato ripetutamente discusso dai teorici
della scena e appariva difficile da risolvere, soprattutto quando riguardava
qualche perfido malvagio. L’unico rimedio sembrava essere la perizia
dell’autore che organizzava sapientemente il testo per ridurre la carica di
spiacevolezza del personaggio. D’Hannetaire si dichiarava certo che Molière
avesse introdotto Tartuffe solo nel terzo atto perché il pubblico non lo
avrebbe sopportato per tutta la commedia.43 Ducis nell’aggiustare l’Otello di
Shakespeare per la scena francese, dopo aver trasformato Iago in un compito
gentiluomo veneto amico dl Moro, arrangiava la trama in modo che la
scelleratezza dell’infame venisse rivelata agli spettatori solo alla fine, dopo
la morte di Desdemona.44 E via dicendo. Ma in tempi recenti il problema
aveva investito anche la resa attorica e nel 1807 Iffland aveva dedicato alla
questione un apposito saggio sulle pagine dell’«Almanach fürs Theater»
spiegando come dovesse essere recitato il personaggio di Franz Moor dei
Masnadieri di Schiller.45
I personaggi considerati da Lamb non erano certo tanto torbidi e truci. Ma i
termini della questione non cambiavano e per Lamb riguardavano
direttamente gli effetti dell’illusione drammatica. Secondo l’opinione
comune, osservava, un dramma è recitato bene o male in proporzione
all’illusione scenica che viene prodotta. Ma bisogna distinguere fra la
tragedia, in cui il necessario, intenso impatto emotivo è strettamente legato
alla consistenza dell’illusione scenica, e la commedia in cui l’impatto
emotivo viene mediato e orientato dal divertimento che è chiamata a
produrre. E ciò è facilmente dimostrabile. La tristezza, il dispiacere che la
narrazione di un evento doloroso provoca, spiegava Lamb, si dissolvono non
appena si comincia a dubitare del fatto e della sincerità di chi lo racconta: «le
nostre lacrime si rifiutano di scorrere». Quando invece si tratta di un storia
divertente chi ascolta può ridere allegramente anche se dubita o non crede
C. Lamb, Imperfect Dramatic Illusion, «The London Magazine», August 1, 1825; poi
ripubblicato con il titolo Stage Illusion in The Last Essays of Elia, London, Edward Moxon, 1833.
43 D’Hannetaire, Observations sur l’art du comédien, cit., pp. 246
44 Avertissement in Othello ou Le More de Venise, tragédie par le citoyen Ducis, Chez André, Paris
s.d., p. V.
45 A. W. Iffland, Sulla rappresentazione del malvagio e del macchinatore, in Teoria della recitazione,
tr. it., introduzione note di D. Minichiello, Napoli, Acting Archives, 2012, pp. 290-301,
www.actingarchives.it (Books).
42
14 Claudio Vicentini, Il distacco dell’attore dal personaggio affatto alla realtà dell’accaduto.46 Perciò mentre la rappresentazione della
tragedia esige una recitazione che tende al massimo livello di illusione
drammatica, la commedia consente una recitazione che la riduce,
derealizzando quando è necessario il personaggio sulla scena. Il che si rivela
quanto mai opportuno quando si tratta di figure odiose, o imbarazzanti,
incisivi esempi di ipocrisia, avarizia e soprattutto di viltà. Derealizzate,
erodono l’emotività repulsiva che ispirerebbero, e presentandosi come figure
immaginarie, creazioni artificiali, possono assumere un aspetto divertente e
piacevole agli occhi dello spettatore.
Per raggiungere questo effetto è però necessaria «un’arte squisita» in cui
l’attore dà prova «della sua più alta abilità».47 La tecnica consiste in
un’operazione, in buona parte nascosta, che agisce sugli spettatori senza che
questi ne divengano pienamente consapevoli. L’attore, con una continua
emissione di sotto-segnali – sguardi e gesti particolari - prodotti anche nei
momenti più accesi dell’interpretazione e sempre eseguendo quello che è
richiesto per rendere esattamente la figura del personaggio, mostra al
pubblico di essere in pieno possesso del suo autocontrollo tecnico e
psicologico, e che dunque tutto quello che fa e dice non è altro che
«recitazione».48 I sotto-segnali non devono mai essere vistosamente espliciti,
non devono mai compromettere la coerenza del profilo delineato, in modo
che lo spettatore possa scorgere nella figura rappresentata ogni preciso
«sintomo» del carattere del personaggio e dei suoi atteggiamenti. Il prodotto
finale, realizzato con gli strumenti del tutto materiali dell’interprete
fisicamente presente, sarà allora un’immagine che alla percezione del
pubblico apparirà perfettamente «somigliante» al reale, ma artificiale e priva
di effettiva realtà. Dunque staccata dalla presenza concretamente umana
dell’attore e «diversa» da lui. E per quanto riguarda l’irrappresentabile
personaggio macchiato da vizi morali, il pubblico resterà pienamente
consapevole che l’attore che lo recita non sarà «neppure la metà» spregevole
quanto la figura che rappresenta.49
C. Lamb, Stage Illusion, in The Works of Charles and Mary Lamb, vol. II, cit., pp. 164-165.
Ivi, p. 163.
48 Ivi, pp. 163-164.
49 Ivi, p. 163.
46
47
15 Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Lorenzo Mango
Lo sguardo di Nataša
L’identità del personaggio come macchina scenica
C’è una bella pagina di Guerra e pace in cui Nataša, una volta giunta a Mosca,
è condotta all’Opera a vedere uno spettacolo teatrale. La ragazza, tutta presa
dall’innamoramento per il Principe Andrej e sconvolta dall’incontro
traumatico che ha avuto con la sorella di lui, è turbata ed osserva quanto
accade sulla scena come proiettato in un mondo distante. Vede una donna
molto grassa vestita di bianco, seduta su un panchetto; un uomo in pantaloni
attillati che le si avvicina cantando e agitando le braccia. Poi ancora i due che
si prendono per mano e cantano insieme. Nello stato d’animo in cui si trova,
scrive Tolstoj, «vedeva soltanto dei cartoni dipinti e delle donne e degli
uomini vestiti in modo strano che, in quella luce abbagliante, si muovevano
e cantavano stranamente».1 Quello di Nataša è uno sguardo tutto particolare.
Guarda a ciò che accade sulla scena fermandosi al dato più immediato
dell’azione, non riesce ad andare al di là, a passare dall’azione agita
all’azione narrativa. Certo c’è il dato emozionale a determinare un simile
blocco. Tolstoj vuole rappresentare quella condizione in cui ci troviamo
quando, tutti presi da noi stessi e dai nostri turbamenti, ci isoliamo dal
mondo pur continuando a reagire come se ci fossimo, ma la nostra
percezione si ferma al dato più immediato, senza riuscire a rielaborarlo. Il
riferimento al teatro, però, è particolare e ci consente di introdurci dentro il
problema che intendiamo affrontare, vale a dire quando ed in che modo si
determina a teatro la relazione tra ciò che materialmente accade e ciò che si
finge che accada?
Facciamo un altro esempio. Siamo a teatro e vediamo un attore che agisce
sulla scena: si muove, parla, si relaziona ad altri attori, i quali, a loro volta,
agiscono, parlano si relazionano tra loro. Il nostro attore, poi, lo troviamo
presente in momenti diversi dell’azione – e così gli altri – così che ci diventa
man mano familiare, in quanto ha un aspetto e fa delle cose che sono coerenti
tra di loro. Riconosciamo in lui una persona, così come ci accadrebbe di fare
nella realtà. Quando è che noi spettatori siamo in grado di trasformare
percettivamente questo attore in un personaggio e a quali condizioni?
Si tratta di una ipotesi diversa, ma complementare, allo ‘sguardo di Nataša’.
Il problema che il nostro ipotetico spettatore ideale ha non è di essere
sovrastato da un’onda emotiva che lo rende distante e fondamentalmente
indifferente a quanto gli accade di fronte, ma di cercare di cogliere i nessi, i
passaggi, i meccanismi semantici che legano, se lo legano, quel fare, così
1
L. Tolstoj, Guerra e pace, trad. it. Enrichetta Carafa D’Andria, Torino, Einaudi, 1990, p. 657.
16 © 2016 Acting Archives www.actingarchives.it Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša materiale e così ‘astratto’, che si celebra dinnanzi ai suoi occhi ad un altro
ipotetico fare, quello di un personaggio. Può apparire, quella che sto
proponendo, un’ipotesi di scuola, ma è tale solo in parte. Prendiamo il caso
di un classico di Bob Wilson, Einstein on the beach, o Tango glaciale di Mario
Martone. In entrambi i casi si tratta di spettacoli in cui il nostro spettatore
avrebbe rintracciato una serie di attori caratterizzati da un aspetto e da un
‘modo’ scenico coerente per tutto lo spettacolo, inseriti dentro una serie di
situazioni di relazione che suggerivano una qualche forma di racconto.
Insomma avrebbe avuto la tentazione di rintracciare dentro quegli attori dei
personaggi ma poi, al momento di nominarli quali personaggi, non avrebbe
saputo esattamente cosa dire. Il caso di Einstein on the beach è, poi, ancora più
particolare: il personaggio dello scienziato avrebbe potuto essere facilmente
identificato ma, poi, non si sarebbero potute rintracciare situazioni narrative
coerenti con la sua identità che lo avrebbero reso attivo in quanto
personaggio drammatico e non solo citazione visiva.
La nostra ipotesi, dunque, pure se astratta ed utilizzata come uno strumento
retorico di argomentazione, non è poi così di scuola come poteva sembrare
in un primo momento, ma corrisponde, piuttosto, a quella che potremmo
definire la condizione primaria, originaria ed aurorale della percezione del
personaggio da parte dello spettatore. Torniamo, allora, a porci la nostra
domanda: quando è che noi spettatori siamo in grado di trasformare
percettivamente un attore in un personaggio e a quali condizioni? Perché si
cominci a parlare di personaggio – come accadeva anche in Einstein on the
beach o in Tango glaciale – è necessario che i segni scenici che vediamo in scena
si organizzino in una maniera sistematica. Che le ‘azioni agite’ definiscano
un qualche tipo di orizzonte rappresentativo. Devono cioè, anzitutto in loro
stesse, dire qualcosa di altro rispetto al loro semplice ed immediato accadere,
devono proporre, in una maniera più o meno definita, una rappresentazione,
sia essa reale o immaginaria, ma comunque una rappresentazione, vale a
dire la manifestazione di un mondo che non riguarda quanto l’attore X o
l’attrice Y fanno effettivamente in scena, ma quanto fingono di fare. In
secondo luogo è necessario che le diverse, distinte situazioni
rappresentative, siano messe in una relazione di tipo narrativo tra di loro,
così che i singoli eventi vengano riferiti ad un principio unitario che si riflette
anche sull’attore: non solo, come è ovvio, egli è sempre se stesso sul piano
materiale della sua presenza fisica, ma lo è anche su quello della sua
esistenza rappresentativa. Ciò che ritorna in passaggi diversi dello
spettacolo, proprio perché i passaggi sono relazionati in modo narrativo tra
di loro, è un soggetto stabile, una identità continua, caratterizzata da un
nome, un volto, un corpo. In altri termini: un personaggio.
L’insieme di questi elementi individua quelle che definirei come le
coordinate minime del personaggio teatrale. Sono coordinate che fanno
appello ad una dimensione narrativa, che evidenziano, cioè, e rendono
riconoscibile il personaggio teatrale anzitutto come soggetto di un racconto
drammatico, di un racconto, cioè, che si propone come il montaggio di tanti
17 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 diversi e distinti presenti, come un sistema di situazioni sceniche che fanno
sviluppare la narrazione attraverso una dialettica che le lega le une alle altre
(in questo la narrazione drammatica è radicalmente diversa dalla narrazione
letteraria, come enunciato già da Aristotele, in quanto manca il trait d’union
di una voce narrante discorsiva, qualunque essa sia). Possiamo, dunque, dire
che il personaggio interviene nella consistenza materiale dello spettacolo
anzitutto come funzione narrativa primaria. Personaggio e narrazione
drammatica sono, nella nostra tradizione occidentale, due principi
intimamente connessi tanto che difficilmente riusciamo a pensare l’uno
senza l’altro. In linea anche solo teorica sarebbe possibile, invece, pensare ad
un personaggio senza racconto e viceversa, impresa ancora più ardua, ad un
racconto che proceda senza personaggi. Una parte consistente della ricerca
teatrale novecentesca – e sul piano delle pratiche sceniche e su quello della
drammaturgia letteraria – si è interrogata proprio su questa possibilità
linguistica.
La funzione narrativa del personaggio ha un’altra implicazione importante:
lega in maniera significativa il personaggio ad una dimensione referenziale.
La percezione del personaggio quale soggetto è una delle componenti
rappresentative principali (se non la principale in assoluto) dello spettacolo;
di contro la percezione dell’attore rappresenta, per molti versi, qualcosa che
precede la rappresentazione. Nel personaggio vediamo il richiamo ad un
mondo che è diverso rispetto al qui ed ora dell’azione agita dello spettacolo,
nell’attore vediamo, invece, il qui ed ora.
È proprio questa condizione ad aver indirizzato decisamente il personaggio
verso il luogo in cui la dimensione rappresentativo-narrativa si esplica con
più compiutezza: il racconto verbale, la parola, la letteratura teatrale. Tanto
che noi consideriamo abitualmente il personaggio come una preesistenza
letteraria che si manifesta in scena attraverso l’attore e trattiamo il
personaggio come un individuo, nel senso che gli attribuiamo quella
coerenza di segni che fa di un individuo un individuo (non a caso si è arrivati
a proporre quella pratica veramente singolare che è l’indagine psicanalitica
del personaggio, come se questi avesse o potesse mai avere un inconscio).
L’esito di questo stato delle cose consiste nel considerare il personaggio
teatrale come un surrogato della persona umana, come la simulazione di un
soggetto. Qualcosa, in fin dei conti, che vive (astrattamente verrebbe da dire)
primariamente, se non solo, nello spazio virtuale del racconto drammatico,
distanziandosi, invece, dalla sua consistenza scenica e agendo di fatto,
contraddicendo l’assunto che abbiamo poco sopra enunciato, come qualsiasi
altro personaggio letterario, destinato a esistere nello spazio virtuale della
pagina e in quello immaginario del lettore, anziché come parte della realtà
concretamente visibile della scena.
Il personaggio è, per eccellenza, parte di quella preesistenza drammatica che
noi chiamiamo ‘testo letterario drammatico’, un mondo che, pur se
ovviamente si sa essere ‘aperto’ (in quanto può esistere solo nella
concretezza dell’azione scenica), tende ad essere considerato come un
18 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša assoluto chiuso in se stesso. Il personaggio preesiste, nella tradizione
occidentale, perché ha la pretesa di esistere prima di essere realizzato
scenicamente. In quanto funzione poetica, il personaggio teatrale vive in un
universo immaginario. Ma l’universo immaginario di chi? Dello scrittore, ci
risponderebbe Pirandello, ma in tal caso sarebbe una figura non
comunicativa, chiusa nell’assoluta estraneità a qualsiasi altro mondo che non
sia quello del suo creatore. Del lettore, ci risponderebbe Maeterlinck, che,
ragionando nei termini di uno spettatore di teatro che interloquisce
dialetticamente con il suo ‘se stesso’ come lettore, sosteneva che qualcosa era
morto in lui il giorno che aveva visto Amleto materializzarsi sulla scena,
perché la faccia, il corpo, la voce di quell’attore non erano quelli del ‘suo’
Amleto, dell’Amleto, cioè, che pensava di aver conosciuto nelle pagine e nei
versi di Shakespesare. Salvo restando l’aporia di fondo che caratterizza l’atto
di leggere anziché vedere il teatro, aporia che Maeterlinck accetta senza
farsene un problema: il ‘lettore di teatro’ è, per molti versi una figura
impropria, o, quanto meno, una figura non prevista.
Nonostante tutte le contraddittorietà del caso – che esplicitano subito come
la questione del personaggio teatrale sia basata, in gran parte, sulla
ambiguità della sua collocazione e categorizzazione – non si va lontano dal
vero se si sostiene che la tradizione occidentale ha ipostatizzato la nozione
di personaggio come entità preesistente e, per molti versi, indipendente
rispetto alla scena. Tanto che ha dato luogo all’ipotesi di un processo
reversibile tra pagina e scena. Il personaggio della pagina, cioè, è pensato
come un tutto individuale completo, che si traduce nel personaggio della
scena (che cambia di volta in volta, di attore in attore, di epoca in epoca) per
tornare, poi, alla pagina nella sua condizione inaugurale, in attesa di un
nuovo inveramento scenico. È una ipotesi, questa, che distingue decisamente
il mondo drammatico del personaggio, risolto nella sua virtuale consistenza
letteraria, e quello scenico, esperito nel qui ed ora dell’azione
rappresentativa.
Detto questo, si potrebbe pensare che il personaggio – ed i problemi ad esso
connessi – siano tutti rinchiusi nella sua dimensione drammaturgicoletteraria. Che, cioè, i processi che ne caratterizzano l’identificazione e quelli
che ne determinano la natura in momenti storici e contesti culturali diversi
siano una questione eminentemente letteraria. In realtà, come la storia del
teatro infinitamente dimostra, tale processo non è mai reversibile al cento per
cento, nel senso che il contatto produce una contaminazione, ragion per cui
il personaggio che torna nella pagina non è mai esattamente quello che ne
era uscito, come dimostra il ‘nostro’ Amleto che è figlio tanto
dell’immaginario shakespeariano ed elisabettiano quanto di quello
romantico.
Tuttavia, come la storia del teatro infinitamente dimostra, tra la figurazione
letteraria e il personaggio scenico si produce un contatto che opera una sorta
di contaminazione: il personaggio che torna nella pagina non è mai
esattamente quello che ne era uscito, come dimostra il ‘nostro’ Amleto, che è
19 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 figlio tanto dell’immaginario shakespeariano ed elisabettiano quanto di
quello romantico.
La realtà scenica del personaggio non è, insomma, indifferente alla natura
profonda del personaggio, a ciò che è, cioè, in sé, come personaggio
drammatico teatrale e non solo come elemento della messa in scena. Il che
rende necessario considerare la questione del personaggio partendo dalla
sua condizione scenica, non giungendo ad essa da un altrove, la pagina, dove
il personaggio avrebbe, comunque, una sua esistenza, o almeno una
preesistenza compiuta e autonoma. Di qui l’idea di parlare di una possibile
identità del personaggio teatrale come macchina scenica, dove l’espressione
macchina sta ad indicare un sistema linguistico che agisce e funziona
semanticamente a partire dalla consistenza scenica di ciò che accade di fronte
ai nostri occhi di spettatore e non di fronte al nostro sguardo virtuale di
lettori.
Il personaggio come costruzione iconica
Già Anne Ubersfeld, qualche anno fa, ammoniva sulla impossibilità a
continuare a trattare il personaggio teatrale come un ‘Io idealizzato’.2 Lo
faceva, la studiosa francese, nel quadro di una più complessiva analisi dei
meccanismi di funzionamento del sistema comunicativo del linguaggio
teatrale. Con ‘Io idealizzato’ intendeva indicare quell’assetto del
personaggio teatrale occidentale che noi, più prosaicamente, stiamo
chiamando ‘surrogato del soggetto individuale’. Non possiamo, né
dobbiamo, continuare a considerare come tale il personaggio teatrale perché
i codici linguistici del teatro si sono modificati, scrive la Ubersfeld. Il
Novecento ha messo in scacco proprio questa sua condizione, rivelandola
come illusoria, e così è possibile e doveroso guardare al personaggio, come
struttura semantica, da una angolazione diversa. «Nella prospettiva
semiologica contemporanea» – scrive – il personaggio «diventa il luogo di
funzioni, e non più la consapevolezza di un essere».3
L’affermazione della Ubersfeld – che poi si sofferma ad analizzare quali sono
i processi che legano personaggio a funzione, a cominciare dalla sua
condizione attanziale nella struttura del racconto – è interessante perché se è
tesa a smontare quella simulazione dell’io che è alla base della nostra
concezione del personaggio teatrale, resta, tutto sommato, sostanzialmente
ancorata a una dimensione testuale letteraria. Detto schematicamente, il
personaggio trasformato in funzione dalla Ubersfeld è ancora,
sostanzialmente, il personaggio virtuale della pagina ed è curioso notare
come la posizione della Ubersfeld, spostando il centro del personaggio
dall’io al racconto, riproduca, per molti versi, la concezione aristotelica del
personaggio, lì dove, nella Poetica, il personaggio è dato subalterno rispetto
al racconto, di cui diventa, di fatto, una funzione.
2
3
A. Ubersfeld, Theatricón. Leggere il teatro, Roma, edizioni La goliardica, 1988, p. 98.
Ivi, p. 97.
20 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša Proviamo, invece, a spostare il piano dell’analisi, indirizzando il discorso
attorno al personaggio, come funzione rappresentativa, decisamente e
direttamente verso la materia scenica. Torniamo, allora, ancora una volta alla
nostra ipotesi di scuola e alla resa del personaggio come complesso di segni
offerto allo spettatore. Poniamo che un attore indossi una corona. Anche se
non ci sono altri elementi che richiamino direttamente la regalità, quel segno
si trasforma subito in un segnale referenziale, il ‘segnale Re’. Se, viceversa, la
medesima corona fosse indossata arbitrariamente ora da uno ora da un altro
degli attori, pur rimandando comunque al concetto di regalità non
riuscirebbe a trasformarsi nel ‘segnale Re’. Perché quel segnale visivo
assuma una funzione caratterizzante è necessario che sia pertinenza di un
solo personaggio, che sia costante nel corso dello spettacolo e che si leghi ad
altri segni della rappresentazione (soprattutto a quelli verbali).
Pur nella sua semplicità, e se si vuole nella sua rozzezza, questo esempio ci
aiuta a comprendere come un singolo segno visivo concorra a definire un
primo livello del personaggio teatrale, anche quando gli altri segni non si
siano ancora dichiarati. Quando, ad esempio, nella celeberrima seconda
scena del primo atto dell’Amleto il Re Claudio si rivolge alla Corte, gli
attributi visivi della regalità riescono ad anticipare le sue parole e creano, per
lo spettatore, il contesto referenziale in cui porle: è un Re che parla. Da questo
punto di vista gli indicatori visivi del personaggio (quello della corona è,
ovviamente, un esempio base) sono di grande aiuto per quella che potremmo
definire l’economia della ricezione dello spettatore. Ognuno di noi, infatti, si
trova, di fronte ad uno spettacolo, per un tempo più o meno lungo (o anche
solo per un istante) nella condizione di Nataša. Per superare quello sguardo,
siamo chiamati ad un processo di collazione e rielaborazione di segnali
diversi che ci consenta di vedere personaggi che agiscono lì dove ci sono
attori che si muovono. Gli indicatori visivi – se sono indicatori pertinenti – ci
aiutano in questa direzione, consentendoci di economizzare sul piano della
ricostruzione del virtuale attraverso il reale.
Se sono pertinenti, questi indicatori, abbiamo detto; se c’è una corona a
segnalare un Re; se, insomma funzionano in una chiave rappresentativa.
Possono, però agire, e lo fanno spesso, in una direzione diversa (e ce ne
occuperemo tra poco). Per adesso ci interessa notare solo come essi
concorrano a definire il tratto semantico del personaggio, come, cioè, siano
parti di un sistema linguistico che dice il personaggio prima ancora di dire
una sua possibile interpretazione.
Possiamo provare, così, a generalizzare un poco la nostra ipotesi e sostenere
che il processo di identificazione del personaggio ha una forte, se non
proprio determinante, componente visiva. Verrebbe da dire che il
personaggio teatrale assomiglia quasi di più a un personaggio della pittura
che a uno della letteratura. O forse dovremmo dir meglio che è una sorta di
ibridazione tra i due, ma che il primo impatto sullo spettatore è di tipo visivo.
Non sembri paradossale quanto sto per dire ma mi sembra che il tipo di
approccio che lo spettatore ha nei confronti del personaggio e del racconto
21 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 teatrali assomiglia moltissimo a quello di chi si trova di fronte ad un ciclo di
affreschi, che abbiano un soggetto narrativo unitario (ad esempio quello
famosissimo della Basilica superiore di Assisi). In questo caso mi sembra
indubitabile che ci sia una precisa indicazione di tipo narrativo, ma ciò che
‘fa storia’ è, e non può che essere altrimenti, l’immagine. Occorre, però, che i
segni che ‘fanno racconto’ siano disposti in un sistema coerente, che cioè, ad
esempio, gli indicatori visivi siano di pertinenza esclusiva di un singolo
personaggio e non siano condivisi con altri se non in parte. Il caso di Giotto
ci aiuta particolarmente perché la sua non è una pittura rappresentativa nel
senso moderno e descrittivo del termine (ammesso che l’autore sia lui e non
Cavallini o la sua scuola come alcuni sostengono oggi, ma il discorso non
cambia). I tratti somatici, per dirne una, sono più una pertinenza condivisa
che non un segnale di individuazione soggettiva, perché Giotto dipinge volti
e figure più per modelli che per ritratti. Ce ne sono, però, altri, di segni, che
ci consentono di distaccare San Francesco dagli altri frati e di farne un
personaggio. Gran parte di tali indicatori non riguardano la pertinenza
fisiognomica (in quanto, ad esempio, il personaggio è trattato come un
ritratto), ma l’attitudine fisica, il gesto, la postura, la collocazione
nell’insieme. Il San Francesco degli affreschi di Assisi è tale perché ‘fa’ prima
ancora che perché ‘è’.
È un passaggio concettuale fondamentale che ci è di grandissimo aiuto se
proviamo ad applicarlo al teatro. La ‘macchina visiva’ del personaggio
pittorico come la ‘macchina scenica’ del personaggio teatrale è un sistema di
segni che funziona su più piani: quello iconico (quello di un’immagine, cioè,
che abbia una valenza comunicativa e semantica propria) e quello del
comportamento, cioè dell’azione (sia nel senso rappresentativo – ciò che si
finge di fare – che in quello scenico – ciò che effettivamente si fa). Ma non
basta, c’è una terza componente decisiva nel processo di identificazione
scenica del personaggio teatrale ed è ciò che questo personaggio dice, quindi
ciò che proviene dal testo.
In quest’ottica il meccanismo convenzionale di identificazione dialettica del
personaggio tra pagina e scena che prevede un ‘prima’ della pagina e un ‘poi’
della scena appare invertito e si apre la possibilità di considerare il processo
scenico come ciò che determina il ‘chi è’ del personaggio, sia quando questi
discenda da un libro preesistente (e sia, quindi, almeno potenzialmente già
noto al pubblico) sia, ancor di più, quando quel personaggio si presenta per
la prima volta di fronte ad un pubblico e quindi la conoscenza che si avrà di
lui non può appigliarsi a nessuna informazione preliminare. Sono i modi
scenici a caratterizzarne l’esistenza teatrale, allora, a costituirne l’identità.
L’Amleto che noi leggiamo non è quello interpretato da Burbage, non solo
perché noi moderni ne diamo un’interpretazione diversa, ma perché essi
sono costitutivamente diversi, appartenendo a due mondi scenici distanti; a
corpi, immagini, gesti, portamenti, comportamenti e dizioni diverse. Il
personaggio nascerebbe, allora, secondo questa ipotesi primariamente e non
22 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša secondariamente (cioè come ‘interpretazione di’) come fatto teatrale. La
‘macchina scenica’ è la forma linguistica di tale nascita.
Proviamo a fare un esempio. I personaggi della Commedia dell’Arte sono,
per antonomasia, personaggi scenici, perché nati dall’improvvisazione e dal
mestiere degli attori e perché non hanno quel luogo virtuale che li accoglie e
li identifica che è il testo letterario. Questo non significa, però, che siano privi
di una loro identità (tanto che anche per essi si è tentati, talvolta, di proporre
una interpretazione psicologica, o magari sociologica) e, oltretutto, è
accaduto loro di migrare dalla scena alla pagina, e non penso solo a Goldoni
ma a tanta drammaturgia settecentesca ed anche ad episodi più tardi.
Dunque quello della Commedia dell’Arte è un personaggio a tutti gli effetti.
Prendiamo il caso di Arlecchino. Siro Ferrone ne ha ricostruito genesi e
vicende attraverso la biografia del suo inventore, Tristano Martinelli, uno dei
grandi attori della seconda metà del Cinquecento.4 Ferrone, tra le altre cose,
parte da due considerazioni: come è possibile che una figura di origine
demoniaca – come è quella cui si rifà il nome di Arlecchino – sia potuta
trascorrere in teatro e come mai lo stesso Arlecchino abbia una
configurazione così diversa da quella degli altri personaggi della grande
famiglia degli Zanni (e, più in particolare, del Secondo Zanni)? Ferrone
affronta entrambe le questioni come parte di uno stesso processo generativo.
Tristano Martinelli avrebbe costruito il suo ‘nuovo’ personaggio
intervenendo su più piani. Avrebbe, anzitutto, pensato ad un aspetto visivo,
e ad un costume in primo luogo, che lo distaccasse dai consueti sacconi
bianchi e slargati tipici degli Zanni, sostituendoli con un abito in cui le
‘toppe’ del rammendo si trasformavano in un inedito ed esuberante grafismo
cromatico. In secondo luogo avrebbe trasformato le brache e la casacca
informi in una sorta di tuta aderente per adattarla al suo fisico scattante, che
gli consentiva di introdurre una nota acrobatica, non del tutto estranea alla
natura dello Zanni, ma nemmeno così universalmente sottolineata come è
nel caso di Arlecchino. A questo, poi, avrebbe aggiunto il dato faunesco e
demoniaco della maschera, questo sì veramente pertinenza esclusiva del suo
personaggio, lì dove le maschere della Commedia dell’Arte giocavano,
invece, soprattutto sul priapismo di nasi di lunghezza smisurata.
Insomma Martinelli avrebbe costruito l’identità di Arlecchino attraverso
l’elaborazione di un sistema di segni in cui agiscono, in primo luogo, la
dimensione iconica e quella del comportamento scenico. Ma anche il terzo
elemento cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, la componente
verbale, è presente nella costruzione della maschera di Arlecchino. Il dialetto
bergamasco tipico degli Zanni, scrive Ferrone, si trasforma in Arlecchino in
una lingua franca, ibridata, degenerata e scomposta, una lingua adatta,
scrive suggestivamente, al re dei diavoli.
Ci troviamo, insomma, nel caso di Arlecchino di fronte ad un personaggio la
cui identità (ed il cui destino drammaturgico di essere un demone/non più
4
S. Ferrone, Arlecchino. Vita e vicende di Tristano Martinelli, Roma-Bari, Laterza, 2006.
23 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 demone) è costruita da quegli elementi che ne definiscono la macchina
scenica e che agiscono, in questo caso, come un sistema coerente e coeso,
ciascuno, cioè, in una relazione stretta ed univocamente direzionata con gli
altri. Si determina, così, una vera e propria identità stabile del personaggio,
tanto che un altro grande attore dell’Arte, Pier Maria Cecchini, biasima, certe
modificazioni che stanno intervenendo nei modi e nel costume di
Arlecchino, perché lo trasformano da Secondo Zanni, quale deve essere, in
una sorta di amoroso, non rovinando, così, solo la sua immagine scenica, ma
inquinando anche la sua funzione drammaturgica, la sua ‘parte’ in quel
sistema di scrittura teatrale complessa che è l’improvvisazione.5 Arlecchino,
in conclusione, è un personaggio perché ha una identità stabile che nasce
dalla scena e si trasferisce in un ‘altrove’ che, pur senza risolversi nel corpo
di carta di un personaggio scritto, è una soggettività che eccede il qui ed ora
della sua manifestazione scenica, e viene tutelata e trasmessa in quanto tale.
Lo sguardo selettivo
Spostiamo, adesso, radicalmente l’asse del discorso e proponiamo un nuovo,
diverso, esempio ‘di scuola’. Nella scena di uno spettacolo è previsto che un
gruppetto di persone giochi a carte sullo sfondo. Per realizzare questa scena
si convocano gli operai che lavorano in teatro, che indossano i loro abituali
indumenti da lavoro e si mettono realmente a fare una partita. Lo spettatore
vede quell’immagine come reale, ma non più reale di quanto la percepirebbe
se ad agire fossero degli attori professionisti che simulassero il gioco. D’altro
canto potrebbe anche guardare al nostro gruppetto sullo sfondo della scena,
come ad un gruppo di attori e valutarne l’interpretazione – trovandola
magari innaturale. Quello che ho scelto non è un esempio a caso ma ne
rielabora uno tratto da un saggio di Michael Kirby sul concetto di recitazione
e sulla dialettica che si istituisce tra essa e quella che vi viene definita come
‘non recitazione’.6 Kirby propone uno schema articolato ai cui estremi si
trovano i due termini in gioco e il cui corpo, viceversa, è rappresentato dalle
tante possibili ibridazioni intermedie (che nel suo discorso diventano
altrettante stazioni di passaggio). Una, proprio subito a ridosso della ‘non
recitazione’, è quella che riguarda l’esempio appena citato. Kirby la definisce
‘azione ricevuta’, a significare che la dimensione recitativa è determinata
dallo sguardo dello spettatore che attribuisce al fare scenico il valore di
rappresentare. È una modalità intermedia tra recitazione e non recitazione
che non implica, dunque, una specifica dimensione operativa, coinvolgendo
«L’abito adunque vorrebb’essere moderato, il quale si è molto allontanato e a gran passi dal
convenevole, posciaché in vece de’ tacconi o rattoppamenti (cose proprie del pover’uomo),
portano quasi un recamo di concertate pezzette, che li rappresentano morosi, lascivi e non
servi ignoranti, sì che lo sconcerto dell’abito par che indizi quello dell’ingegno», P. M.
Cecchini, Frutti delle moderne comedie et avisi a chi le recita, Padova, Guaresco Guareschi al Pozzo
dipinto, 1628, p. 24.
6 M. Kirby, Recitare e non recitare, «Acting Archives Review», a. I, n. 1, maggio 2011
(www.actingarchieves.it).
5
24 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša più che l’attore (o il presunto attore, come nel caso dei giocatori di carte) lo
sguardo di chi assiste, a cui è affidato, di fatto, il compito di identificare ciò
che ha di fronte in termini di recitazione. Si tratta, nei termini dello sguardo
di Nataša, di agire in quel territorio di limite che mette in relazione e
distingue ciò che è pura attualità dell’azione scenica e ciò che costruisce un
personaggio. Al livello dei giocatori di carte citati da Kirby, tale confine è
labile: lo spettatore può assumere come realtà rappresentativa, sul piano
della finzione scenica, ciò che, viceversa, è un puro momento di realtà
fattuale, perché quegli operai non sono attori, perché non recitano né
interpretano alcun personaggio, perché lo stesso gioco delle carte è reale e
magari c’è anche chi vince e chi perde davvero dei soldi. Eppure, nonostante
abbia tutti gli elementi per contraddire l’elemento rappresentativo, non solo
non lo fa, anzi, lo ribadisce. È portato ad agire, in altri termini, con quello che
potremmo definire, per restare al nostro gioco terminologico, uno sguardo
di Nataša al contrario: non vede la ‘cosa’ al posto della rappresentazione, ma
legge in termini di rappresentazione qualsiasi cosa avvenga nello spazio
deputato del palcoscenico e dello spettacolo. Qualsiasi cosa? Non proprio.
Qualsiasi cosa sia plausibilmente coerente con la situazione narrativa. Se,
difatti, come sovente accade, i cambi di scena vengono realizzati a vista,
nessuno spettatore si sogna di vedere nei tecnici vestiti cogli gli abiti di tutti
i giorni una strana anomalia rispetto al uno spettacolo ‘in costume’ e se a
compierlo, quel cambio di scena, sono invece gli attori stessi, alla stessa
maniera nessuno, immagino, ritiene che siano i personaggi a dedicarsi a quel
lavoro. Insomma la zona liminare che distingue i due piani di realtà di cui è
costituito uno spettacolo, viene transitato in direzioni diverse a condizioni
diverse. L’elemento di soglia può essere individuato nella coerenza
rappresentativa. Collocati all’interno di uno spettacolo con un esile o nullo
livello rappresentativo, cioè non organizzato secondo una direttrice
narrativa lineare e coerente, come potrebbe essere un happening, i nostri
giocatori di carte resterebbero un frammento di reale e spostare e ricollocare
gli arredi scenici da parte degli attori sarebbe vissuto come un momento non
disorganico rispetto al tutto dell’azione spettacolare.
Ponendosi un problema non dissimile ma riferendolo alla questione della
presenza dell’oggetto in scena e della sua riconducibilità a un piano di realtà
Anne Ubersfeld ha introdotto un concetto importante, quello di denegazione.7
Cosa intende la Ubersfeld con tale espressione? Vuole valutare come il senso
di realtà che producono gli oggetti scenici sia un dato più problematico di
quanto non sembri, in quanto la loro presenza scenica mette in gioco la
questione della loro autenticità.
Una cosa autentica (un vero cristallo, un vero gioiello, ecc.) quando la
vediamo su di un palcoscenico – scrive – perde molto della consistenza reale
che avrebbe nella vita quotidiana e, all’inverso, noi tendiamo a percepire
come ‘reale’ ciò che, viceversa, in scena è posticcio e simulato (un fondo di
7
A. Ubersfeld, Theatricón. Leggere il teatro, cit. pp. 37-38.
25 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 bottiglia per un cristallo, un oggetto di plastica per un gioiello, ecc.). Sembrare
è condizione sufficiente a significare la realtà. Non conta la sua consistenza
materiale ma la sua immagine. Il reale da elemento certo e stabile viene
trasformato in un dato ambiguo. La cornice ideale del palcoscenico comporta
una perdita di statuto dell’oggetto, la sua messa in problema nei confronti
dello sguardo. Vedo quello che la situazione mi spinge a vedere.
Il ragionamento della Ubersfeld si può applicare, con tutte le dovute
approssimazioni e i dovuti adeguamenti, anche per quello che riguarda il
personaggio. La percezione di realtà che noi abbiamo, o presumiamo di
avere, in teatro è sempre viziata da un margine di ambiguità, già solo per il
fatto di trovarci in una situazione artificiale. È come se il nostro sguardo di
spettatori fosse sottoposto a un destabilizzante strabismo, che si risolve
senza danni perché, nella realtà della scena, i segni attoriali sono disposti per
lo più in modo da limitare l’ambiguità della presenza scenica, essendo
direzionati il più possibile a costruire un’identità non contraddittoria del
personaggio. Identità che si esprime, prima di ogni altra cosa, attraverso
degli indicatori visivi.
Un contributo a comprendere questo particolare processo percettivo ci viene,
nuovamente, dal saggio di Kirby.
Se qualcuno per la strada ha stivali da cowboy, come tanti, questo non basta
per identificarlo come un cowboy. Se porta anche un cinturone di cuoio e
perfino un cappello da cowboy, non lo vediamo ancora come un costume,
neanche a nord del Texas. È solo un modo di vestire. Ma se compariranno
sempre più elementi di un abbigliamento western (fazzolettone al collo,
sopracalzoni di cuoio e speroni, per esempio) noi arriveremo al punto che o
vedremo un cowboy o qualcuno che ‘impersona’ un cowboy. Il punto esatto
della gradazione in cui si verifica questa identificazione dipende da diversi
fattori, il più importante dei quali è il luogo o contesto fisico, e inoltre può
variare non poco da persona a persona.8
La percezione di realtà, all’interno di un contesto quotidiano non
caratterizzato (se ci trovassimo, ad esempio, non per strada ma a un rodeo)
necessita di un accumulo segnico significativo. Per ‘vedere’ ci devono essere
forniti una serie di elementi coerenti tra loro che ci consentano di
raggiungere il ‘punto esatto’ di gradazione che consente l’identificazione. Se
il contesto quotidiano è caratterizzato (ne nostro caso, un rodeo)
l’identificazione è più facile e richiede un minor numero di segni specifici. A
teatro, poi, «se qualcuno ha una calzamaglia nera e stivali da cowboy può
bastare perché sia identificato come un cowboy». La cornice, il contesto
compiono essi stessi una parte consistente del lavoro di identificazione.
D’altro canto, potremmo aggiungere a completamento dell’assunto di Kirby,
se sto assistendo a una messa in scena dell’Amleto e un regista fa indossare
all’attore che interpreta il personaggio del titolo degli stivali da cowboy, mi
sarebbe difficile pensare che quello sia realmente (nella realtà della
8
M. Kirby, Recitare e non recitare, cit., p. 173.
26 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša rappresentazione) un cowboy, e sarei piuttosto portato a chiedermi, invece,
quale possibile intenzione semantica risieda in quella singolare scelta
registica.
Non appena, dunque, affrontiamo il personaggio all’interno di un contesto
di natura rappresentativa, che mette in gioco, cioè, il riferimento a una realtà
‘altra’ il sistema di segni della macchina scenica del personaggio presenta
inevitabili margini di scollamento e di ambiguità, sollecitando nello
spettatore il suo latente sguardo di Nataša, che risulta evidentissimo nella
forzatura argomentativa degli esempi messi in campo ma che riguarda la
dimensione rappresentativa in sé, non solo quando è, in una qualche misura,
in un verso o nell’altro (giocatori di carte o Amleto in stivali) estremizzata.
Consideriamo il caso di un personaggio la cui identità scenica abbia un
chiaro ed esplicito riferimento a quella di un testo letterario di riferimento e
con essa sia coerente. Un personaggio nato nella pagina, dunque,
preesistente alla sua manifestazione scenica, la cui resa interpretativa non si
discosti in maniera significativa dalla sua dimensione narrativa (nessun
Amleto in stivali, per intenderci). Tale coerenza si esprime anzitutto sul
piano del costume, ma poi su quello del comportamento scenico, della
gestualità e della dizione. Su altri piani, però, più legati alla presenza fisica
che alla recitazione e, quindi, meno considerati a un livello espressivo, cosa
succede? Se è alto come farà a diventare basso come il dottor Hinkfuss? Se è
grasso come farà a diventare magro come Don Chisciotte? Si dirà che non è
importante: quella sera, in quello spettacolo, Hinkfuss sarà alto e Don
Chisciotte grasso. Ma c’è qualcosa di ancora più elementare e preliminare.
Consideriamo il caso di un abitué del teatro che sia andato a vedere uno
stesso attore interpretare dei personaggi diversi. Cosa sarà portato a pensare,
se cade vittima dello sguardo di Nataša (senza, però, esserne fagocitato al
punto da dimenticare di essere a teatro e con quale scopo): che tutti quei
personaggi si assomigliano. È la questione della faccia dell’attore. Questione
tutt’altro che irrilevante e meno paradossale di quanto possa sembrare. Tutta
una certa scuola di attori ha fatto, e fa, ricorso al trucco proprio per costruire
un volto unico ed irripetibile ad ogni singolo personaggio. Claudio Vicentini,
analizzando le diverse procedure attraverso cui un attore costruisce il suo
personaggio, ne ricorda una che fa al nostro proposito: definirne l’immagine
fisica partendo dalla caratterizzazione dei tratti del viso. Laurence Olivier ad
esempio, scrive Vicentini, aveva bisogno di definire i tratti del volto per
avviare la definizione del carattere del personaggio e, quindi, avviare i canali
dell’interpretazione. Per costruire il suo Shylock era partito cercando un naso
adatto, come aveva già fatto in occasione del Riccardo III, per rendersi conto
però, strada facendo, che il personaggio dell’usuraio si caratterizzava meglio
attraverso la bocca «che per il suo usuraio deve essere particolarmente larga,
mobile, sensibile», non la sua, insomma, ma quella del personaggio. «Il
truccatore non basta – aggiunge però Vicentini – perciò Olivier ricorre al
27 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 dentista che gli costruisce una dentatura finta adatta allo scopo».9 Tutto
questo lo fa per potersi sentire nella parte ma, se invertiamo il punto di vista,
tutto questo consente anche allo spettatore di vedere il personaggio vedendo
il meno possibile l’attore, un attore il cui volto è diventato plastico, vorrei
dire: trasparente.
Esiste una tipologia di attore che potremmo definire ‘senza faccia’, nel senso
che ha una straordinaria e camaleontica capacità metamorfica. Basti pensare,
oltre al caso di Olivier che è particolarmente emblematico, alla sensazione
che si prova di fronte ai ritratti fotografici di Stanislavskij nei panni dei suoi
diversi personaggi. Non solo l’atteggiamento, i tratti complessivi della figura
risultano diversi ma è proprio il viso a cambiare profondamente i suoi
lineamenti. D’altronde era lo stesso Stanislavskij a sostenere la centralità del
trucco. Nella prospettiva, anche lui, dell’accesso interpretativo al
personaggio, espresso dal concetto di ‘truccare l’anima’, ma con ricadute
evidenti e forti anche sul piano della ricezione. Ma in molti altri casi, l’attore
conserva la riconoscibilità dei suoi tratti somatici (con casi estremi in cui fa
di questo una maschera, come Carmelo Bene). Cosa succede, allora, ai fini
della percezione del personaggio? Un fenomeno singolare che ci introduce
in un nuovo territorio dei meccanismi di funzionamento della macchina
scenica: lo sguardo dello spettatore, ai fini della identificazione del
personaggio, tende a considerare la faccia invisibile, o quanto meno non
significativa. Sembra una bestemmia: l’arte dell’attore occidentale si basa in
una maniera sostanziale sulla mimica. Non penso sia possibile negare questo
assunto. Ma bisogna riconoscere che lo sguardo dello spettatore opera in
modo selettivo: vede nella mimica le espressioni del personaggio e,
contemporaneamente, non vede le stesse espressioni utilizzate la sera
precedente dallo stesso attore per un personaggio diverso. Se è uno
spettatore particolarmente accorto può essere in grado di distinguere i due
piani, quello dell’attore e quello del personaggio, valutandoli separatamente.
Più comunemente i due piani, invece, si contaminano reciprocamente. Di
sicuro, però, nello stesso momento e nello stesso luogo agiscono due sistemi
di segni, interagenti ma anche diversi.
Il gioco degli indicatori visivi
C’è una definizione di Coleridge che ci aiuta a comprendere meglio le
dinamiche percettive, ma anche concettuali, di cui stiamo parlando: il teatro,
dice, è sospensione volontaria dell’incredulità. Coleridge lo afferma per
sostenere che esiste, necessariamente e per forza, un a priori che precede la
percezione del teatro e la rende credibile, a prescindere dai criteri di
verosimiglianza scenica che si intendono applicare. In questa sede questo a
priori – che è un dato empirico e non culturale – lo stiamo chiamando
sguardo selettivo, concetto che abbiamo provato ad applicare alla condizione
9
C. Vicentini, L’arte di guardare gli attori, Marsilio, Venezia, 2007, p. 117.
28 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša base della ricezione del personaggio, in quanto somigliante e diverso dal suo
interprete, ma che ha implicazioni assai più complesse.
Anzitutto cerchiamo di capire meglio cosa intendiamo con tale definizione.
Sostanzialmente che, ai fini della identificazione del personaggio, alcuni
segni si fanno denotatori di identità, diventano quindi segnali del
personaggio, altri restano segni e segnali di altro. È una situazione
determinata dal modo che un attore ha di costruire i segni visivi del suo
personaggio e di indirizzarli al pubblico. L’attore istituisce un sistema
comunicativo in cui alcuni dei segni sono proiettati in primo piano, altri
lasciati sullo sfondo, altri, infine, resi addirittura invisibili. È come se,
implicitamente, dicesse allo spettatore: guarda questo e ignora quest’altro.
Lo spettatore si trova di fronte, dunque, un sistema complesso ed ambiguo
ed è chiamato a navigarci dentro. La costruzione del personaggio nasce dal
percorso compiuto dentro questa ambiguità.
Per aiutarci facciamo di nuovo ricorso alle arti visive. Nella pittura tre
quattrocentesca l’iconografia dei santi è affidata ad un preciso e singolare
sistema di segni. Tranne casi particolari, come quello di Giovanni Battista,
tali segni riguardano solo in parte l’intera persona ma sono attributi iconici
legati per lo più al martirio. Per il resto – tratti somatici, abbigliamento – i
segni risultano, di fatto, generici. Non indicano il personaggio ma ad
esempio, come nel caso delle sante martiri, giovinezza, bellezza, purezza,
virtù. Segni che le rendono simili lì dove l’indicatore del martirio le
distingue. Se io sto cercando di individuare di che santa si tratti dovrò
guardare una sola cosa, l’attributo del martirio, e vedere il resto come sfondo.
Facciamo il caso, adesso, del personaggio teatrale, come poteva venire
inscenato nel Settecento. Prendiamo, a titolo d’esempio, l’immagine di
Lekain e della Dusmenil, nella Semiramide di Voltaire o anche Garrick nel
Macbeth.
Ciò che vediamo non corrisponde certo al personaggio storicamente inteso
che è il tipo di identificazione che noi moderni, non gli uomini del Settecento,
attribuiamo al personaggio quando lo riteniamo attendibile, credibile.
Perché il costume non ha, quando le ha, se non vaghe assonanze con quello
dell’epoca del personaggio e perché il sistema di gesti, che riusciamo a
cogliere nell’immagine, è decisamente estraneo al comportamento di
qualsivoglia persona reale.
Ciò che vedeva lo spettatore settecentesco era un sistema ibrido tra forme del
reale, la figura umana, e forme artificiali, le forme, i modi, lo stile della
recitazione, a cominciare dal tono declamatorio della dizione e
dall’impostazione codificata della gestualità. Il risultato era quello strabismo
di cui abbiamo parlato, a proposito un contesto completamente diverso, in
precedenza. Per vedere il personaggio, lo spettatore doveva necessariamente
vedere l’attore, cioè tutti quei tratti personali di stile che riguardavano il
modello recitativo e il modo personale di interpretarlo. È un procedimento
che si fonda da un lato sulla riconduzione del personaggio a un modello
super-individuale, il tipo, che è sintesi di persone e non persona esso stesso,
29 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 e dall’altro sulla selezione dello sguardo: dare a vedere ciò che serve per
costruire il tipo.
1. Lekain e Mademoiselle Dumesnil nella Semiramide (stampa inglese del 1772 in O. G. Brockett,
Storia del Teatro, a cura di C. Vicentini, Venezia, Marsilio, 2016).
2. David Garrick e Hannah Pritchard come Macbeth e Lady Macbeth (Dyce Collection in Victoria
and Albert Museum Collections (Civico Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo Ernesto
Rossi).
La macchina scenica del personaggio settecentesco concorre dunque a
definire il personaggio come figura che eccede la individualità singolare.
Attraverso di essa lo spettatore avrebbe visto il tipo cui si riferisce ogni
singolo personaggio. Ma vedeva anche altro, una grammatica espressiva
riferita ad un sistema formale di visualizzazione delle passioni. Vedeva,
30 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša dunque, una tipizzazione che eccedeva la dimensione stessa del personaggio
per riguardare principalmente, se non esclusivamente, l’attore ed il suo
modo – o diremmo meglio il modo codificato – di trasmettere le passioni. Di
tutto questo lo spettatore settecentesco era tutt’altro che inconsapevole.
Quando si recava a teatro sapeva ben distinguere il piano dell’attore da
quello del personaggio. Detto altrimenti sapeva selezionare ciò che
riguardava l’abilità attorica e ciò che consentiva di individuare il
personaggio.
Forse, e sottolineo questo forse, per un lungo tratto non c’è stato altro
personaggio che questo. Non perché, come si usa dire, il teatro si faceva
direttamente in scena (o almeno non solo per questo), ma perché non si
sapeva, o solo voleva, immaginare un tipo di personaggio diverso da quello
che si vedeva in scena, un personaggio i cui denotatori visibili agissero in
modo distinto rispetto a quelli dell’attore, facendo del personaggio quello
che era: una funzione rappresentativa.
Lo sguardo di Nataša era, però, sempre in agguato e il teatro sapeva giocarci
sopra, facendone parte del gioco scenico. Il motivo del travestimento – tanto
presente nelle trame teatrali dall’antichità in poi – gioca proprio su questo
aspetto. Si pensi, ad esempio, al gioco semantico messo in moto quando
Viola si traveste in Orsino, ne La dodicesima notte. Lo spettatore vede,
dinnanzi ai suoi occhi, una macchina scenica che esalta quella condizione
ambigua che caratterizza i suoi segni, instabilmente disposti tra realtà e
rappresentazione. Vedeva, infatti, quello spettatore un attore maschio che
interpretava un personaggio femminile che, a sua volta, ne interpretava uno
maschile. Una vera e propria mise en abîme, che mette in scacco la pretesa
coerenza comunicativa dei segni rappresentativi.
Il motivo del travestimento incide, però, anche più tecnicamente, sul dato
della selezione dello sguardo. Nella Mandragola è necessario, ad un certo
punto, ricorrere a dei travestimenti per condurre a buon fine l’inganno ai
danni di Messer Nicia. Callimaco dovrà mascherarsi per trasformarsi nel
garzonaccio che dovrà giacere con donna Lucrezia ed ‘assorbire’, così, il
venefico influsso della pozione fecondatrice. Per far questo sarà sufficiente
che Callimaco distorca in una smorfia i tratti del viso e diventerà
irriconoscibile. Quando Messer Nicia racconterà della paradossale ispezione
cui lo ha sottoposto, lui, che pure con Callimaco ha avuto a che fare, non lo
riconosce. Come d’altronde fra’ Timoteo diventa irriconoscibile quasi solo
grazie alle due noci che si è messo in bocca. Il gioco comico consiste nel fatto
che lo sguardo dello spettatore e quello del personaggio spettatore (Messer
Nicia) non coincidono. Il primo vede il tutto, e riconosce il personaggio
originale dietro quello travestito, il secondo vede solo il segnale denotatore
e quindi il suo sguardo si ferma al primo livello, quello del travestimento.
Quel segnale – la smorfia di Callimaco tanto per intenderci – si staglia sul
resto dei segni visivi, funzionando come segnale del nuovo personaggio
travestito. L’efficacia del gioco comico è determinata dall’ambiguità tra i
31 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 segni, ambiguità che richiama, per sineddoche, quella che sovrintende alla
costituzione stessa del personaggio teatrale.
Una situazione analoga, d’altronde, si determina anche in casi diversi, non
motivati da una ragione comica. Prendiamone in esame uno soltanto. Nel Re
Lear Edgar, scacciato dal padre, decide di assumere una identità posticcia
quella di Tom di Bedlam. Basta che si copra il volto di sudiciume, cinga i
fianchi con uno straccio, si impiastricci i capelli e diventa immediatamente
irriconoscibile a tutti e, in primo luogo, a suo padre. Anche in questo caso
saremmo di fronte al caso del doppio sguardo, come per La Mandragola, con
la differenza, non irrilevante, che il gioco simulacrale del travestimento non
va incontro a nessuna esigenza comica. Si tratta, invece, della messa in
evidenza della costruzione posticcia del personaggio attraverso segnalatori
iconici che ne definiscono l’identità secondo un procedimento che ripropone,
anche in questo caso, il meccanismo della mise en abîme (il gioco retorico è
replicato, oltretutto, anche nel caso di Kent, secondo lo schema del
raddoppiamento speculare che è tipico del Re Lear). Nel caso di Edgar, poi,
c’è un ulteriore elemento su cui vale la pena di soffermarsi almeno un
momento. Edgar, infatti, anticipa e dichiara verbalmente il suo cambiamento
– che non riguarda solo l’aspetto fisico ma anche i modi comportamentali –
enunciandolo in un monologo al pubblico, così che questi, di fronte alla
presenza di un personaggio apparentemente ‘nuovo’ sia in grado di creare
un ideale collegamento tra il folle Tom e il saggio Edgar. Evidentemente il
fatto che l’interprete fosse lo stesso non era sufficiente a testimoniare della
sovrapposizione tra i due personaggi, dimostrando quanto il viso dell’attore,
se non contestualizzato, non sia sufficiente a dichiarare l’identità del
personaggio: niente di più facile e di più comune che un attore fosse
chiamato ad interpretare più ruoli. Dunque nel gioco semantico della
macchina scenica del personaggio interviene, in una maniera decisiva, anche
l’elemento verbale. Il problema è creare di volta in volta un equilibrio tra i
diversi segni definendo i confini di una identità instabile, che funziona solo
grazie al meccanismo di integrazione dello spettatore.
La macchina scenica del personaggio è, dunque, un sistema aperto, ambiguo
e multidirezionale che si stabilizza nell’atto della fruizione dello spettatore.
Si tratta di un procedimento che è implicito in tutta la vicenda del teatro
occidentale – e viene esplicitato nella forma del travestimento – ma che, nel
Novecento, viene assunto consapevolmente e tematizzato. Che la ‘macchina’
sia tale non è più solo il risultato del dialogo di convenzioni rappresentative
ed esigenze narrative ma un procedimento che viene investigato per quello
che è e per quello che può produrre. L’ambiguità dei segni scenici da
problema diventa risorsa. Non si tratta di creare un sistema coeso ma di
operare per scarti e montaggio di elementi divergenti o incongrui che
definiscono l’identità del personaggio partendo da presupposti diversi da
quelli dell’Io idealizzato e della simulazione di identità soggettiva.
Durante la preparazione de Il Principe costante Jerzy Grotowski lavorò
lungamente con Ryszard Cieślak per la costruzione del personaggio di Don
32 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša Fernando. Non si trattava di ridare una identità credibile al personaggio
storico di Calderón ma di costruirgliene una nuova, non rappresentativa,
così da evidenziare la chiave del martirio, del percorso di purgazione e di
offerta sacrificale di sé. Elementi, questi, da proporre non come sostegno di
una argomentazione narrativa, ma come elementi costitutivi della istituzione
del rito teatrale che doveva legare spettatore ed attore. Si trattava, dunque,
di operare una radicale e sostanziale riscrittura del personaggio, così che pur
restando in un qualche modo (ad esempio attraverso le parole) legato al
personaggio calderoniano, quello di Cieślak fosse qualcosa di
profondamente diverso, addirittura di irriconoscibile. Ciò che doveva
emergere era il filo tematico e simbolico che univa idealmente uno all’altro.
Come fece lavorare allora Grotowski il suo attore? Anzitutto gli chiese una
perfetta memorizzazione del testo così che esso divenisse una sorta di
patrimonio automatico di Cieślak, che gli consentiva di entrare ed uscire
dalle parole con assoluta disinvoltura. In secondo luogo lo indusse ad un
percorso di ricerca e di scavo interiore che lo facesse risalire a quella
condizione così particolare ed aurorale che è il primo innamoramento
adolescenziale. L’attore doveva cercare di rivivere quel particolare stato
emotivo, quella condizione in cui meraviglia, stupore, fascinazione si
mescolano insieme mettendoci in una condizione che ci distacca decisamente
dal nostro io precedente. Questo stato emozionale doveva trasmettersi
soprattutto attraverso il linguaggio del corpo. Sarebbe successo, così, che le
parole del Principe don Fernando avrebbero dialogato col senso di stupore e
di superamento del sé determinando quella che lo stesso Grotowski avrebbe
definito una preghiera di carne. In più il regista aveva inserito nella partitura
della recitazione tutta una serie di riferimenti iconografici alla figura di
Cristo.10 Accadeva, così, che lo spettatore vedeva un corpo spiritualizzato
che aspirava a superare i suoi limiti (e, a tratti indiscutibili segnali
cristologici) mentre ascoltava le parole di Calderón. Si determinava, in
questo modo, una macchina scenica che funzionava sulla discontinuità dei
suoi diversi elementi, che non diceva mai esplicitamente: questo
personaggio è un mistico, ma proponeva uno schema di segnalatori visivi
che mettevano il pubblico nella condizione di non riuscire a vedere altro che
quello.
Un simile esempio ci aiuta a comprendere meglio come funziona, proprio
come sistema comunicativo, la macchina scenica del personaggio, ma ci
introduce, anche, a come tale sistema si presenti nel contesto novecentesco.
L’ambiguità che al sistema è connaturata e che, in epoca premoderna, si
tentava, in una qualche misura, di ridurre o arginare, nel teatro moderno è
eletta a vera e propria strategia linguistica. La scelta che allora viene fatta è
di tradire la presunta identità psicologica del personaggio per farne, proprio
attraverso i linguaggi della scena, una figura problematica, una soglia tra il
J. Grotowski, Le Prince constant de Ryszard Cieslak, in Ryszard Cieslak, acteur-emblème des années
soixante, a cura di G. Banu, Actes Sud-Papiers, Arles, pp. 13-21.
10
33 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 qui ed ora dell’evento ed un altrove che non è più di tipo rappresentativo. Il
personaggio non coincide con l’attore, nel senso che non deve
necessariamente schiacciarsi nella condizione immanente del performer, ma
non può, né vuole, più essere una identità soggettiva e individuale. Se il
personaggio si trova inevitabilmente ad affrontare una condizione di soglia
tra stati diversi (la realtà e la rappresentazione), nel teatro del Novecento si
trova come imprigionato dentro tale soglia. Di lui, in fondo, non riusciamo a
dire compiutamente nulla se non che ‘non è’: non solo l’azione agita, non
certo un’azione che sia separabile dall’accadere scenico e tradursi in racconto
verbale. Una condizione, questa, stupefacente e per dei versi anche
minacciosa, che viene straordinariamente espressa da Antonin Artaud in un
passo de La messa in scena e la metafisica. Quando parla della «pantomima non
pervertita», cioè di quella forma scenica in grado di dare corpo sensibile alla
dimensione spirituale della natura (distante in questo da quella simulazione
dell’umano in cui si è decaduto il teatro), Artaud afferma che essa dovrà
risolversi in un sistema ideografico, in un sistema di segni geroglifici, che
dichiarano un mondo ma non lo definiscono «al modo di quell’alfabeto
orientale che rappresenta la notte come un albero sul quale un uccello ha già
chiuso un occhio e incomincia a chiudere anche l’altro».11 Il personaggio
geroglifico – unica alternativa credibile al personaggio psicologico – è,
dunque, per Artaud il frutto di un sistema di segni, la macchina scenica, che
non tradisce la sua ambiguità interna, anzi la esalta.
Una conclusione in forma di piccolo apologo
D’altronde questa ambiguità non solo è funzionale ad un teatro
antirappresentativo, come vuole essere quello di Artaud ma è uno degli
elementi di fascinazione del teatro. Vorrei, così, concludere il discorso con
una sorta di piccolo epilogo/apologo che mi piacerebbe intitolare: la pancia
di Ernesto Rossi e i capelli della Duse.
Specializzato in parti di amoroso, Rossi era famoso per le sue interpretazioni
di Romeo, che continuava ad incarnare anche quando era in là negli anni.
Le foto che abbiamo lo documentano come un Romeo assai poco credibile,
eppure il pubblico del tempo ne era affascinato. Tutta una serie di segni, che
appartenevano al corpo dell’attore, dicevano che quello non poteva essere il
corpo del personaggio e, invece, il pubblico non vedeva la pancia di Rossi
ma solo il corpo idealizzato di Romeo, un corpo fatto di parole, le parole di
Shakespeare. Testimonia bene questa aporia, rivelandone anche il
superamento (se non totale almeno parziale), la ricezione del pubblico. La
ricostruisce Sonia Bellavia, parlando delle tournée tedesche di Rossi. L’attore
risultava ai critici tedeschi – scrive – ed in realtà lo era, un po’ troppo vecchio
per il personaggio: «Tuttavia in alcuni momenti, scrisse il critico di ‘Die
Presse’, Rossi seppe far scordare la sua inadeguatezza al ruolo» e un altro
11
A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 1978, p. 157.
34 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša importante critico del tempo Jacob Minor «ne parlò come il miglior Romeo
che avesse mai visto».12
3. Ernesto Rossi come Romeo (Civico Museo Biblioteca dell'Attore di Genova, Fondo Ernesto
Rossi in Sonia Bellavia, La voce del gesto, Roma, Bulzoni Editore, 2000).
In sostanza quanto era accaduto sembra essere questo: lo sguardo dello
spettatore aveva selezionato i segni scenici riducendone l’ambiguità: aveva
cancellato idealmente, in tal modo, ciò che poteva introdurre elementi di
S. Bellavia, La voce del gesto: le rappresentazioni shakespeariane di Ernesto Rossi sulla scena tedesca,
Bulzoni, Roma, 2000, p. 123.
12
35 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 contraddizione nel definire una identità credibile del personaggio.
Nell’interpretazione di Rossi, in sostanza, agiva un indicatore, la
temperatura emotiva, in grado di metterne a tacere altri che erano
vistosamente in contrasto con essa, quelli legati al suo aspetto fisico. Questo
avveniva grazie a due fattori sostanziali: una non completamente definita, a
quell’altezza cronologica, nozione di physique du rôle, e l’attenzione
concentrata, viceversa, su una qualità del personaggio che proverei a definire
come immateriale, in quanto determinata dal gioco scenico tra capacità
declamatoria e intensità espressiva, assunte come qualità autonome della
recitazione applicate secondariamente al personaggio. Un gioco scenico in
cui l’età e la corporatura, in termini più generali l’aspetto fisico, perdevano
ogni funzione di indicatore espressivo.
Profondamente diverso il caso della Duse. Quando, dopo un lungo silenzio,
l’attrice ritornò in scena nel 1921 decise di impersonare il personaggio di
Ellida ne La donna del mare di Ibsen. Nei panni, cioè, di una giovane donna
problematica e misteriosa. La Duse aveva già, a quella data, più di
sessant’anni, eppure non fa niente per mascherare la sua età. Entra in scena,
così, tra lo stupore generale senza trucco e, soprattutto, con i suoi bianchi
capelli raccolti in una treccia.
Mirella Schino ha ricostruito in dettaglio lo spettacolo e, soprattutto, la
dinamica percettiva che, legando l’attrice ai suoi spettatori, li sedusse e li
ammaliò. «Il perno – scrive – il filo d’oro con cui legò i suoi spettatori fu
senza dubbio la sua bella treccia bianca».13 Non a caso è essa che torna
insistentemente in tutte le recensioni come un valore dell’interpretazione
della Duse e non un limite.
Le recensioni – scrive ancora la Schino – sono piene dei capelli bianchi della
Duse, come se fossero stati il colpo e la vera sorpresa della serata, la bravura
particolare della Duse, il segno della sua magnificenza d’attrice.14
Ma come facevano a essere un valore, quei capelli bianchi? Come riuscivano
a non infrangere l’illusione scenica di una donna che avrebbe dovuto, a rigor
di testo, avere trent’anni di meno? e che di un attore poco più che trentenne,
Memo Benassi nei panni dello Straniero, doveva fingere di essere ancora
perdutamente innamorata? Non doveva succedere a lei quanto successo a
Rossi con la sua pancetta inopportuna?
Non successe, anzi accadde esattamente il contrario. I capelli bianchi della
giovane Ellida risultarono una sorta di valore aggiunto. Di sicuro perché in
essi i fedeli ammiratori che l’avevano lasciata più di dieci anni prima in
grado ancora di essere una convincente amorosa, videro la risposta che
l’attrice dava all’inquietante incedere della vecchiaia, un momento di
passaggio cruciale per le attrici nate come prime donne e in particolare di
M. Schino, Racconti del Grande Attore. Tra la Rachel e la Duse, Città di Castello, Edimond, 2004,
p. 256.
14 Ivi, p. 259.
13
36 Lorenzo Mango, Lo sguardo di Nataša quelle che giocavano una parte importante del loro talento sulla
fascinazione, ed era il caso della Duse che aveva fatto di una strana,
misteriosa e inusuale sensualità una componente consistente della sua
fortuna. Incanutita e senza trucco, ella non fingeva di essere quella che non
poteva più essere e affidava sé come attrice, prima ancora che sé come Ellida,
allo sguardo degli spettatori, i quali, d’altronde, non erano certo lì riuniti per
vedere il dramma di Ibsen ma per tornare ad ammirarla. L’indicatore
espressivo che la Duse lanciò al suo pubblico diceva: io sono qui, sono
diventata questa ma i miei personaggi d’elezione sono sempre gli stessi e, in
particolare la piccola, sensuale donna dei fiordi che amava oltre ogni cosa.
Avrebbe potuto mostrarsi così com’era diventata in una parte nuova, di
madre nobile magari com’era l’usanza, ma non lo fece. Fece, invece, una
scommessa e la vinse.
Ma non possiamo ridurre quanto accadde in quella serata torinese del 1921
solo a questo, altrimenti rischieremmo di considerarlo una sorta di feticismo
di massa. La Schino non cade in questa trappola. La treccia bianca è messa al
centro del discorso ma all’interno di un quadro ricostruttivo più complesso
in cui giocano i toni sussurrati della recitazione, la riduzione espressiva del
movimento, la capacità di suscitare la più viva emozione attraverso il più
ridotto e sommesso gioco scenico. Insomma la Duse aveva costruito un
sistema espressivo, per il suo ritorno alle scene, al cui interno agiva anche,
con una funzione speciale, il candore della treccia.
Uno dei motivi per cui la Duse scelse questa parte – scrive la Schino – potrebbe
essere dunque proprio il desiderio di sottolineare il più possibile i propri capelli
bianchi, di far sì che lo spettatore non potesse non notarli.15
Ne esalta, in altri termini, la realtà di presenza scenica semanticamente
attiva, in grado di comunicare al pubblico. Il personaggio di Ellida si
manifestò, davanti agli occhi degli spettatori, non nonostante quei capelli
bianchi, ma proprio grazie ad essi. La ambiguità dei segni rappresentativi,
che avrebbe dovuto inibire la costruzione del personaggio, la rese, invece,
possibile in una maniera unica e irripetibile. Come fu Ellida quella sera, non
sarà mai più, né mai più potrà essere. Era entrato in gioco anche in quel caso,
anzi forse soprattutto in quel caso, l’appello allo sguardo selettivo dello
spettatore. Non invitato, però, stavolta a ignorare quanto poteva incidere
sulla credibilità della coerenza visiva del personaggio ma a leggere dentro e
oltre il personaggio. A lavorare dentro la zona ambigua della sua macchina
scenica, restando folgorato da uno scarto espressivo in grado di risignificare
in una maniera radicale e radicalmente moderna il gioco dei segni e della
loro economia rappresentativa.
15
Ivi.
37 Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Antonio Pizzo
L’attore e la recitazione nella motion capture
∗
Cosa è la motion capture
Il termine inglese ‘motion capture’ indica una tecnologia relativamente
recente ma cresciuta velocemente e molto diffusa nella moderna industria
dell’intrattenimento. Nel corso del nostro discorso continueremo a
utilizzare il termine inglese (traducibile con «cattura del movimento»)
perché è quello internazionalmente accreditato. È un metodo per registrare
il movimento di un corpo reale in uno spazio 3D in forma dati che poi
vengono trasferiti a una figura generata dal computer. La mappatura tra il
corpo reale del performer e il corpo digitale è possibile grazie a un insieme
di specifiche che permettono la compatibilità dei dati tra la figura umana e
il personaggio sintetico 3D.1
Certo, la stessa idea di registrare il movimento risale ai primi pionieri della
fotografia, come gli studi di Eadweard Muybridge, la cronofotografia di
Étienne-Jules Marey o lo stroboscope di Harold Edgerton; tutti nel tardo
XIX secolo. È però opinione comune che la moderna nozione di motion
capture di un attore, allo scopo di fornire un’apparenza di realismo a un
personaggio animato, sia nata con il Rotoscope di Max Fleischer nel 1915.2
Questo fu il primo strumento in cui «partecipanti reali forniscono il
modello di movimento umano per tradurlo in un altro medium».3 Sebbene
sia famoso per essere stato adoperato in Biancaneve di Disney (allegato 1), il
Rotoscope fu utilizzato per la prima volta nella serie animata Out of the
Inkwell (allegato 2), dove il protagonista, era un clown chiamato Koko.4
Il processo di ricalcare a mano i singoli fotogrammi delle riprese dal vero di
un soggetto ha dato all’animazione un aspetto molto naturale. L’utilizzo del
Rotoscope, oppure di altre tecniche e metodi per tracciare il movimento reale,
Allegati all’articolo: materiali video ed iconografici consultabili on line su Acting Archives
Review, numero 11 – Maggio 2016 (www.actingarchives.it cliccando su ‘Review’).
1 Oggi, questo standard è generalmente fornito da Humanoid Animation (H-Anim) ed è
utilizzato per modellare e animare umanoidi, cfr. http://h-anim.org. Per una breve
descrizione delle metodologie utilizzate nella motion capture rimandiamo alla Panoramica
sui sistemi di motion capture al termine di questo articolo.
2 Cfr. M. Kitagawa, B. Windsor, MoCap for Artists: Workflow and Techniques for Motion
Capture, New York, Focal Press, 2012.
3 A. Grey, A Brief History of Motion-Capture in the Movies, «uk.ign.com», 11 luglio 2014,
http://uk.ign.com/articles/2014/07/11/a-brief-history-of-motion-capture-in-the-movies
(ultimo accesso 25 agosto 2015).
4 Cfr. R. Fleischer, Out of the Inkwell: Max Fleischer and the Animation Revolution, Lexington,
The University Press of Kentucky, 2005.
∗
38 © 2016 Acting Archives www.actingarchives.it Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture è diventato rapidamente una pratica standard nei film di animazione in cui si
tendeva a un grado più alto di realismo.5
Tutte queste tecniche (la cronofotografia, lo stroboscopio, il Rotoscope)
erano, in sostanza, sistemi per trasformare il movimento di un corpo nello
spazio tridimensionale in una sequenza di silhouette bidimensionali su una
pellicola o un disegno. La moderna motion capture non solo registra le
coordinate tridimensionali x, y, z, di un numero di punti nello spazio in un
determinato momento e secondo un preciso intervallo di tempo, ma, grazie
allo standard H-Anim, definisce formalmente la corrispondenza tra il corpo
catturato e il personaggio digitale.
La motion capture ha visto i suoi primi utilizzi nelle ricerche mediche o
militari nei tardi anni Settanta; e fu solo negli anni Ottanta che entrò nel
mondo dell’intrattenimento, quando fu utilizzata in uno spot pubblicitario
intitolato Brillance (1985, allegato 3) ): qui, un sistema appositamente
realizzato registrava i movimenti di un’attrice così da dare qualità
realistiche a un sensuale robot.6
La tecnologia si è diffusa negli ultimi tre decenni, e sempre più attori hanno
avuto modo di sperimentarla. I processi che utilizzano la motion capture
solitamente prevedono: un performer che realizza alcuni movimenti del
corpo, una serie di marcatori (di solito delle piccole sfere che riflettono la
luce infrarossa) posti su specifici punti del corpo, uno studio di
registrazione equipaggiato con strumenti adatti a registrare i marcatori
nello spazio (normalmente luci infrarosse e speciali videocamere), un
computer e un software che trasferiscono (in tempo reale) le informazioni
sul movimento a uno scheletro digitale; infine, un personaggio virtuale che
sarà animato utilizzando i movimenti registrati.
Nelle prossime pagine cercheremo di rilevare come questa tecnologia è
intervenuta nel lavoro degli attori e se ne ha modificato o meno le pratiche.
Nell’industria cinematografica e in quella dei videogame la motion capture
è stata sviluppata e utilizzata per catturare le performance degli attori e per
animare personaggi digitali in 3D.7 Ciò ha favorito l’utilizzo di un altro
termine: ‘performance capture’. Il termine indica una pratica che tende non
solo a catturare il movimento (camminare, saltare, strisciare, ecc.) ma a
registrare l’intera performance dell’attore, laddove quest’ultima è
considerata un’attività più complessa e ricca della mera attività fisica. In
questo contesto, il termine ‘performance’ riecheggia molto quello di
‘recitazione’, e implica un comportamento deliberativo, un’emozione che lo
motiva, e qualche tipo di interazione con altri agenti. Dunque, la
D. Hayes, C. Webster, Acting and Performance for Animation, New York and London, Focal
Press, 2013, p. 185.
6 Cfr. M. Kitagawa, B. Windsor, MoCap for Artists: Workflow and Techniques for Motion
Capture, cit., p. 7; cfr. anche M. Delbridge, Motion Capture in Performance. An Introduction,
New York, Palmgrave Macmillan, 2015, p. 15.
7 M. Delbridge, Motion Capture in Performance. An Introduction, cit., p. 26.
5
39 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 performance capture utilizza di solito le tecnologie più accurate per
cogliere tutte le sfumature dell’azione umana, e mira a catturare non solo i
movimenti ma, per così dire, anche le loro motivazioni e il loro significato.
Tuttavia, le differenze tecnologiche non sono sostanziali e quindi anche i
procedimenti della performance capture ricadono nell’ambito della motion
capture e possono essere indicati con questo termine.
La recitazione e le tecnologie digitali
Se intendiamo osservare come il lavoro dell’attore sia influenzato dai nuovi
media o da tecnologie digitali, dobbiamo considerare la questione come
parte della lunga storia degli impatti della tecnologia sull’arte della
recitazione.8 A tal proposito, Barbara Flueckiger nota che «l’apparato
filmico ha sempre frammentato, trasformato e aumentato il corpo umano –
davanti o dietro la macchina da presa».9 Quindi, al fine di discutere della
recitazione nella motion capture per la produzione cinematografica
digitalmente arricchita, dobbiamo essere coscienti che ogni apparato di
registrazione influenza la performance e che ogni tipo di strumento di
presentazione (video, audio) aggiunge il proprio contributo all’esperienza
del pubblico.10
Alcuni autori come Sharon Marie Carnicke hanno ritenuto che tali
influenze operino comunque su alcuni ‘processi di base’ della recitazione
che resterebbero relativamente stabili nel corso del tempo.
La mia esperienza come attrice e regista e le mie conoscenze sulla storia della
recitazione mi inducono a credere che la recitazione è – in fondo – una forma
d'arte discreta, che si è – nel corso dei secoli – variamente adattata a tutte
quelle tecnologie che inquadrano il lavoro degli attori e lo presentano al
pubblico, quali che siano, l’arco di proscenio, la lente della fotocamera, o lo
schermo di un computer. In altre parole, la storia della recitazione dimostra
che i processi di base della recitazione – in quanto radicati nel corpo e nella
voce dell'attore – rimangono relativamente stabili, mentre le mutevoli
Per una rapida introduzione all’argomento cfr. A. Pizzo, Attori e personaggi virtuali, «Acting
Archives Review», n. 1, maggio 2011, pp. 83-118.
9 B. Flueckiger, Digital Bodies, capitolo tratto da B. Flueckiger, Visual Effects. Filmbilder aus
dem Computer, Marburg, Schueren, 2008, tradotto dal tedesco da Mark Kyburz e rivisto da
Barbara Flueckiger, 2010, p. 1, reperibile in
http://www.zauberklang.ch/BodiesFlueckiger.pdf.
10 Come sottolinea Mark J. P. Wolf, è ampiamente riconosciuto che «la performance nel film
è consistita quasi sempre in qualcosa di più della semplice registrazione degli attori; le
performance cinematografiche tipicamente sono, fino a un certo punto, costruite in
postproduzione mediante tecnologie digitali», The Technological Construction of Performance,
«Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies», vol. 9,
fasc. 4, 2003, pp. 48–59:48. Per una discussione sulle conseguenze della trasmutazione del
corpo in un’immagine sullo schermo cfr. M. Morse, Body and Screen, «Wide Angle», vol. 21,
fasc. 1, 1999, pp. 63–75.
8
40 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture tecnologie del palcoscenico e dello schermo inducono continuamente gli attori
a ripensare il modo in cui utilizzano i loro corpi e voci nella loro arte.11
Questa distinzione non appare però troppo utile per studiare in una
prospettiva storica, fino agli ultimi sviluppi della motion capture, il
fenomeno della recitazione. Le nozioni di ‘corpo’ e ‘voce’ appaiono, infatti,
inutili (o almeno troppo generiche) se separate dalla modalità e dal
medium. È invece piuttosto importante considerare, come dice Carnicke,
che se le performance sullo schermo «sono sempre un ibrido tra l’attività
umana e gli interventi tecnologici» la recitazione resta comunque «il
dominio dell’attore»12. Le specifiche modalità e media producono,
nell’attore, diversi gradi di autorialità sul risultato finale della sua
performance.13 Mark Wolf, a proposito, dice:
Il teatro ha una lunga tradizione nel migliorare la performance, laddove il
trucco, le luci, i costumi, e via di seguito, sono serviti a enfatizzare alcuni
aspetti del lavoro dell’attore sul palco. In ogni caso, poiché era richiesta la
presenza fisica dell’attore, il potere di controllare e modellare una
performance era principalmente nelle sue mani. 14
Ma i set cinematografici sono diventati ambienti tecnologicamente assai
complessi. Oltre il montaggio, gli effetti in post produzione sono diventati
sempre più centrali e influenti. Così come la riprese sono solo uno dei
passaggi nella realizzazione di un film, possiamo anche dire che la
registrazione della performance di un attore è solo una piccola parte della
creazione di un personaggio sullo schermo.
Il cinema digitale ha reso il lavoro degli attori ancor più fuso nella
produzione e post produzione. Peter Kiwitt, nel descrivere il cinema
digitale, è molto chiaro a riguardo.
Sì, in alcuni casi il fotogramma ripreso dal vivo è solo una piccola parte
dell'immagine finale. Ma anche prima dell’avvento degli effetti visivi, ogni
fotogramma era sempre solo un potenziale pezzo del puzzle di
postproduzione. È la natura stessa del cinema che rende il crogiolo della
produzione in definitiva soltanto una fase intermedia del processo di
narrazione.15
S. M. Carnicke, Emotional Expressivity in Motion Picture Capture Technology, in J. Sternagel,
D. Levitt, D. Mersch (a cura di), Acting and Performance in Moving Image Culture. Bodies,
Screens, Renderings, Bielefeld, transcript Verlag, 2014, p. 322.
12 Ivi, p. 331.
13 Per la teoria della recitazione cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione. Dall’antichità al
Settecento, Venezia, Marsilio, 2012. Cfr. Anche l’importante lavoro di J. Naremore, Acting in
the cinema, Berkeley, University of California Press, 1988; Uno studio più recente è quello di
J. Sternagel, D. Levitt, D. Mersch (a cura di.), Acting and Performance in Moving Image Culture.
Bodies, Screens, Renderings, cit.
14 M. J. P. Wolf, The Technological Construction of Performance, cit., p. 48.
15 P. Kiwitt, What Is Cinema in a Digital Age? Divergent Definitions from a Production
Perspective, «Journal of Film and Video», vol. 64, fasc. 4, 2012, pp. 3–22: 6.
11
41 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Gli ambienti di green-screen, gli elementi della motion capture, e altri effetti
visivi ora fanno sì che la gamma di possibilità della produzione
cinematografica possa estendersi in un continuum fisico / digitale.16
È questo un progresso in continuo sviluppo, sebbene ci siano – e,
probabilmente, ci saranno sempre – produzioni cinematografiche e
televisive che faranno leva meno sugli effetti digitali e più sulla ripresa dal
vivo e il montaggio, è indubbio che il mercato di massa (negli Stati Uniti,
ma anche nella nuova industria nel medio e lontano Oriente) chiede
sempre più effetti speciali (FX) e immagini generate al computer (CGI) nei
prodotti d’intrattenimento. In quello che potremmo definire «il cinema
delle attrazioni realoded», lo stesso ruolo degli attori è stato ridefinito.17
Nell’era digitale – scrive Peter Kiwitt – l’animazione ha ampliato i propri
confini. Attraverso effetti visivi l’animazione può affiancarsi perfettamente
all’azione dal vero; d’altro canto, e sempre di più, l’azione dal vero appare
incompleta senza di essa. Ed ora è anche entrata a far parte del regno dei
nuovi media, in particolare dei giochi interattivi. 18
In questa situazione «gli attori – ha osservato Mark Wolf – diventano solo
un altro elemento nel mix e, attraverso i processi digitali, i loro corpi sono
separati dagli ambienti e sfondi in cui compaiono».19
Nel quadro degli effetti speciali e delle immagini generate dal computer,
progressivamente negli ultimi decenni, le tecnologie digitali (sia in pre- sia
in post-produzione) hanno sfumato i confini tra i film ripresi dal vero e
quelli di animazione.
Inoltre nel cinema digitale il pubblico si è abituato a stabilire una relazione
emotiva con ciò che potremmo definire il risultato di una mistura tra
riprese di attori tradizionali ‘a base di carbonio’ e personaggi sintetici
realizzati con la grafica al computer.20 Carnicke pensa che ciò non faccia
alcuna differenza per quanto riguarda il lavoro del critico o dello studioso
che voglia analizzare e valutare la recitazione di un agente sullo schermo, e
ritiene che «le performance create attraverso la motion capture, come quella
Ivi, p. 18.
Seguendo la famosa definizione elaborate da Tom Gunning (The Cinema of Attractions:
Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde, «Wide Angle», Vol. 8, nn. 3 and 4, Fall 1986), il
concetto è stato messo in relazione con la produzione cinematografica altamente
spettacolare in W. Strauven (a cura di), The Cinema of Attractions Reloaded. Film culture in
transition, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006. Chiaramente, riprendo la
definizione da quest’ultimo.
18 P. Kiwitt, What Is Cinema in a Digital Age? Divergent Definitions from a Production
Perspective, cit., p. 6.
19 M. J. P. Wolf, The Technological Construction of Performance, cit., p. 51.
20 Riprendo la sardonica definizione di attore a base di carbonio, per intendere ‘in carne ed
ossa’, da B. Flueckiger, Visual Effects. Filmbilder aus dem Computer, cit., p. 14, la quale, a sua
volta, cita S. Billups in un’intervista concessa a P. Parisi, The New Hollywood, «Wired», Issue
3, 12 dicembre 1995,
http://www.wired.com/wired/archive/3.12/new.hollywood_pr.html.
16
17
42 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture di Gollum [nel Il signore degli anelli], possono essere sottoposte allo stesso
tipo di analisi e valutazione come qualsiasi altra performance sullo
schermo»21.
Ma in questo modo, concentrando l’attenzione sul prodotto finito – la
recitazione di un «agente» di fronte al pubblico – viene eluso il problema
dell’autorialità: come si configura il contributo dell’attore nella produzione
dell’‘agente’.
Recitazione o/e animazione?
L’idea di catturare il movimento umano affonda le radici nell’analisi del
comportamento fisico-motorio di un essere vivente, e si è concentrata sulla
resa dettagliata del movimento come un insieme di stati differenti nel corso
del tempo. Ha avuto inizio con l’obiettivo di sviluppare una migliore
conoscenza del movimento umano e animale e presto è diventata una
metodologia per ricreare le qualità realistiche delle azioni. Per questa
ragione, la motion capture è collegata strettamente, fin dagli esordi, con
l’animazione di figure non umane disegnate, sintetiche, artificiali. Come
nota Barbara Flueckiger:
Dall’inizio dell’animazione dei personaggi realizzata al computer, la motion
capture è stata considerata la tecnica ideale per dotare l’animazione di più
personalità, poiché l’intenso lavoro di animazione fotogramma per
fotogramma comporta una estesa divisione del lavoro.22
Ora, se nel cinema tradizionale i registi o i montatori, nonostante l’impatto
che possono avere sulla resa finale del lavoro dell’attore, non hanno mai
chiesto di essere direttamente accreditati come autori della recitazione, gli
animatori hanno sempre chiesto di essere riconosciuti come i creatori della
recitazione dei loro personaggi. A partire dalle origini della loro arte, il
lavoro degli animatori è consistito nell’abilità di dare vita a un’illustrazione
grazie a una tecnica ben strutturata e che è stata poi codificata alla Disney
con il nome di Illusion of Life.23 Insieme con i progressi delle tecniche di
animazione e con l’utilizzo di personaggi sintetici sempre più realistici, gli
animatori hanno dovuto imparare a produrre performance sempre più
sofisticate e raffinate.
Negli anni recenti, i personaggi creati al computer hanno migliorato le loro
azioni ed espressioni per diventare più avvincenti. In circa un decennio, da
Toy Story (1995) di John Lasseter fino a Kung Fu Panda (2008) di Osborn e
Stevenson, i personaggi animati hanno aumentato la complessità delle
proprie attività: per esempio, sono sempre più attenti a manipolare oggetti
mentre parlano, e hanno una maggiore mobilità facciale insieme con un più
S. M. Carnicke, Emotional Expressivity in Motion Picture Capture Technology, cit., p. 332.
B. Flueckiger, Visual Effects. Filmbilder aus dem Computer, cit., p. 30.
23 Thomas, Frank, Ollie Johnston, Disney Animation: the Illusion of Life, New York, Abbeville
Press, 1981.
21
22
43 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 alto numero di espressioni.24 Questo spiegherebbe perché ormai è diffusa
tra gli animatori l’abitudine a prendere lezioni di recitazione così da
migliorare la propria abilità di creare personaggi credibili sullo schermo.25
E anche se oggi nell’industria cinematografica e, parzialmente, in quella dei
videogame, l’animazione dei personaggi fa ampio ricorso alla motion
capture le informazioni sul movimento devono essere sempre
supervisionate e trattate da un animatore per correggere una miriade di
imprecisioni o migliorare la corrispondenza tra il soggetto ripreso e il
personaggio da animare. 26
La produzione di una figura animata con il semplice impiego del computer
si svolge essenzialmente in tre fasi. Modellazione (la creazione di una
figura statica 3D), Rigging (la definizione dei punti di controllo – cioè una
sorta di scheletro – del modello 3D che gli autori possono muovere per
creare l’animazione), Animazione (l’aggiunta di movimenti fotogramma
per fotogramma). È chiaro che l’ultima fase gioca un ruolo centrale nella
resa di un personaggio realistico sullo schermo: il movimento è
generalmente considerato un fattore chiave per dare vita alle immagini
generate dal computer (come ha ben dimostrato John Lasseter con il sui
Luxo Jr. del 1986, il suo cortometraggio di due minuti prodotto dalla Pixar,
allegato 4).27
A partire da questo processo, il nuovo sviluppo tecnologico ha reintrodotto
il lavoro dell’attore e, stabilito il modello 3D di un personaggio con il suo
rigging, l’animazione può essere condotta applicando i movimenti di un
Cfr. A. Pizzo, Attori e personaggi virtuali, cit., p. 14.
In anni recenti, Ed Hooks, ex attore e insegnate di recitazione, ha orientato i suoi
insegnamenti verso gli animatori. Cfr. E. Hooks, Acting for Animators, New York and
London, Routledge, 2011 (terza edizione). Un altro rilevante libro sull’argomento, con una
descrizione più dettagliata della linea produttiva è D. Hayes, C. Webster, Acting and
Performance for Animation, cit.
26 La questione del rapporto tra animazione e motion capture è stata dibattuta a lungo ed è
ben riassunta da Yacov Freedman, il quale ricorda anche che «un’immagine viene registrata,
per essere sicuri, ma in termini pratici, i dati sono impossibili da visualizzare […] fino a che
non siano passati attraverso più livelli di modifiche digitali. La motion capture, quasi per
definizione, richiede un’animazione aggiuntiva per avere successo come opera
cinematografica». Y. Freedman, It is Real … Or it is Motion Capture. The Battle to Redefine
Animation in the Age of Digital Performance, «The Velvet Light Trap», n. 69, Spring 2012, pp.
38-49:39.
27 Va anche detto che la motion capture non sempre è lo strumento migliore per creare
personaggi animati. Ci sono esempi in cui l’utilizzo della più classica animazione al
computer funziona meglio. Come nota Scott Richmond: «L’impossibilità di alcuni gesti
atletici di Spider-Man hanno determinato l’utilizzo di specifici effetti visivi, e non il
contrario. Acrobazie tanto complesse richiederebbero davvero una forza sovrumana, e
pertanto il film si avvale dell’animazione tradizionale fotogramma per fotogramma, poiché
la motion capture non potrebbe restituire l’effetto giusto per il sovrumano onere atletico di
Peter». In questi termini, la motion capture entrerebbe nella produzione dei film di
animazione soprattutto per le sue qualità economiche, in quanto metodologia meno costosa
per create comportamenti realistici per esseri umani o animali. S. C. Richmond, The
Exorbitant Lightness of Bodies, or How to Look at Superheroes: Ilinx, Identification, and Spider-Man,
«Discourse», vol. 34, fasc. 1, 2015, pp. 113–144.
24
25
44 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture attore così come sono stati registrati in una sessione di motion capture. Vari
registi hanno per ciò intravisto la possibilità di fondere la performance
reale di un attore con il chimerico mondo dei film di animazione. Il primo
successo riconosciuto in questo senso è stato Polar Express, del 2004
(allegato 5), il film fantasy scritto, prodotto e diretto dal Robert Zemeckis.28
Il film è stato interamente animato utilizzando la tecnica di performance
capture (motion capture con marker passivi). In questo caso, la sezione
animazione della Academy ha mostrato di avere
dubbi circa il fatto che un tale inteso uso della motion capture possa
intendersi come animazione […] Alla fine, il fattore dirimente fu che la
pellicola era ricorsa alla manipolazione fotogramma per fotogramma (in altre
parole, animazione) sulle immagini ottenute con la motion capture. Polar
Express, dunque, ha richiesto così tanto lavoro addizionale che è stato
considerato ammissibile nella categoria miglior film d’animazione».29
Tutto ciò, ovviamente, induce gli animatori a ribadire la preminenza del
proprio ruolo autoriale. Spesso, anzi, considerano l’utilizzo della motion
capture un imbroglio, come è apparso chiaro nella famosa dichiarazione
che Pixar ha posto alla fine di Ratatouille (il film di Brad Bird del 2017) in
cui si leggeva: «La nostra garanzia di qualità: 100% genuina animazione!
Nessuna motion capture o altre scorciatoie sono state usate nella
produzione di questo film».
Il lavoro degli attori sembra così ‘diminuito’ dalle rivendicazioni degli
animatori che lo confinano in un ruolo accessorio e di supporto all’interno
di ciò che l’Academy considera il genere d’animazione. Di contro, mentre la
motion capture fatica a trovar posto negli Oscar come animazione, allo
stesso tempo viene rifiutata come performance dal vero, impedendo agli
attori vedere riconosciuta la propria opera al fianco di quelle prodotte con
riprese dal vero. La casa di produzione New Line ha esercitato non poche
pressioni perché Andy Serkis fosse candidato come miglior attore non
protagonista per il ruolo di Gollum nel Il signore degli anelli: le due torri di
Peter Jackson nel 2002 (allegato 6). Sebbene abbia vinto il premio per il
cinema MTV nel 2003 come ‘miglior performance virtuale’, Serkis non è
stato mai nominato per gli Oscar.30 Da allora, c’è stata una continua
Y. Freedman, It is Real … Or it is Motion Capture. The Battle to Redefine Animation in the Age
of Digital Performance, cit., p. 40.
29 Ivi. Freedman sottolinea anche che l’8 luglio 2010 l’Academy stabilì una nuova regola per
la categoria animazione dell’83° Oscar. La regola è restata attiva fino alla 88° edizione e
recita: «Si definisce film di animazione un film con un tempo di esecuzione di più di 40
minuti, in cui il movimento e le performance dei personaggi siano creati utilizzando la
tecnica fotogramma per fotogramma. La motion capture di per sé non è una tecnica di
animazione. Inoltre, un numero significativo dei personaggi principali deve essere animato,
e l’animazione deve apparire in non meno del 75% della durata del film»,
http://www.oscars.org/sites/default/files/88aa_rules.pdf.
30 http://www.mtv.com/ontv/movieawards/2003/.
28
45 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 polemica riguardo la scelta di premiare o meno un attore la cui
performance fosse realizzata mediante la motion capture. 31
Nel corso degli anni, mentre Serkis diventava famoso per altri e anche più
incredibili ruoli in performance capture (con una speciale inclinazione per
le scimmie, così come King Kong nel film eponimo, o Cesare nei due
capitoli de Il pianeta delle scimmie), la discussione si è fatta più intensa
coinvolgendo anche altri attori (ad esempio, Zoe Saldana in Avatar di James
Cameron). Come ricorda Pamela Robertson Wojcik, il problema va oltre le
categorie degli Oscar:
Il caso di Serkis, insieme con le polemiche sulla natura della recitazione in
Hulk (2003) e la recente trilogia di Star Wars (1999, 2002, 2005), mettono in luce
una crisi nella concezione della recitazione, una crisi che sembra storicamente
e tecnologicamente determinata: il problema della recitazione nell’era
digitale.32
La riluttanza dell’Academy ad accettare le performance in motion capture
degli attori – secondo Wojcik – rivela l’inclinazione a considerare il corpo
dell’attore come prova chiave della presenza.33 Infatti, alcuni puristi
potrebbero essere scettici all’idea che qualcuno che ha fornito i movimenti a
un personaggio sintetico possa essere premiato nella stessa categoria di un
attore che ha recitato dal vero. Ciononostante, Wojcik sfida questo
scetticismo e nota che se la stessa Academy ha premiato John Hurt per il
ruolo di John Merrick interpretato nel film The Elephant Man di David
Lynch, ciò vuol dire che:
mentre i trucchi teatrali, come il make-up e le protesi, sono visti come
integrazioni alla buona recitazione, gli effetti cinematografici, come gli effetti
speciali e digitali sono visti come intralci.34
In altri termini, sarebbe solo una questione di percezione differente di ciò
che è stato ‘aggiunto’ (l’integrazione della protesi e l’intralcio degli effetti
speciali) allo stesso tipo di lavoro; dunque il performer irriconoscibile
dietro il pesante trucco potrebbe non essere molto diverso dal performer
nascosto dietro la marionetta digitale. Tuttavia credo che il parallelo tra la
maschera e la marionetta digitale sia fuorviante. La prima comporta la
presenza dell’attore nel qui ed ora della recitazione (sia nelle riprese di un
film, sia in uno studio televisivo o su un palcoscenico); la seconda prevede
una scelta di manipolazioni di dati precedentemente acquisiti (il
movimento). La performance di John Hurt riguarda la creazione di un
H. Hart, When Will a Motion-Capture Actor Win an Oscar?, «Wired», gennaio 24, 2012,
http://www.wired.com/2012/01/andy-serkis-oscars/.
32 P. Robertson Wojcik, The sound of film acting, «Journal of Film and Video», vol. 58, fasc. 1–
2, 2006, pp. 71–83: 71.
33 Ivi.
34 Ivi.
31
46 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture personaggio nel corso della produzione del film, mentre la creazione di una
marionetta digitale, anche utilizzando la motion capture, è un processo che
ha luogo soprattutto in post produzione. La logica dell’Academy riconosce
come recitazione tutto ciò che accade, in maggior parte, nella produzione e
rifiuta ciò che è frutto prevalentemente di elaborazioni successive.
Comunque, seguendo il suggerimento di Woicik, vale la pena notare che la
maggior parte del pubblico – a prescindere al dibattito sugli Oscar per la
recitazione – è a proprio agio con i personaggi sintetici, sebbene sia
cosciente che sono stati creati con strumenti digitali. In sostanza, il pubblico
sembra non avvertire come cogente il problema dell’autorialità. La
corrispondenza tra ciò che è stato registrato dal vero e quello che appare
sullo schermo è meno importante di quello che potrebbe sembrare. Anche
se l’Academy non nomina alcun attore «se tutti i dialoghi sono stati
doppiati da un altro attore», dal punto di vista del pubblico il corpo (e
l’illusione di fisicità) della performance è tanto importante nel cinema che il
doppiaggio in un’altra lingua non è più percepito come uno spiazzamento
della voce.35 Per lo meno, in paesi come l’Italia, dove è norma comune
doppiare i film stranieri, la sospensione dell’incredulità degli spettatori non
risente del fatto che tutti gli attori stranieri parlano un perfetto italiano.
Infine, Wojcik nota anche che nella saga de Il signore degli anelli non è certo
solo la performance di Gollum a dipendere pesantemente da effetti
digitali.36 Lo stesso potrebbe essere detto per la sua controparte Frodo, così
come per centinaia di altri personaggi in quello che generalmente
consideriamo un film dal vero.
Andy Serkis è attivamente impegnato nell’imporre l’autorialità dell’attore
agli occhi del pubblico, e ha anche assunto il ruolo di ambasciatore della
motion capture. In effetti il personaggio di Gollum ha inaugurato una
nuova strada nella recitazione per la motion capture, sebbene non fosse il
puro risultato della sola motion capure.37 Nel 2002, Gollum è stato creato
con un mix di motion capture e riferimenti fotogramma per fotogramma.
Serkis ha lavorato sul set con gli altri attori, coperto interamente da una
tuta aderente bianca tale da produrre un sufficiente contrasto con
l’ambiente del set, in modo che gli animatori potessero utilizzarlo come
riferimento per il personaggio sintetico. Ha anche ripetuto le stesse azioni
in uno studio per la motion capture così da fornire i movimenti da
utilizzare sul personaggio. E, naturalmente, ha registrato la voce che ha
reso Gollum tanto famoso.38 In sintesi, Gollum è il frutto di un lavoro
Cfr. La regola 6 in https://www.oscars.org/sites/default/files/88aa_rules.pdf.
P. Robertson Wojcik, The sound of film acting, cit., p. 80.
37 Barbara Flueckiger ricorda che «i professionisti e pubblico hanno salutato Gollum, il
memorabile personaggio folletto ne Il Signore degli Anelli che accompagna i protagonisti nel
loro cammino, come un esempio di successo di un personaggio digitale», Digital Bodies, cit.,
p. 17.
38 N. Broughall, How Weta changed motion capture tech for Dawn of the Planet of the Apes,
«Techradar», 21 novembre 2014, p.1,
35
36
47 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 composito dello stesso Serkis e dell’intervento di animatori, anche se poi il
personaggio viene considerato unitario dal pubblico (e come tale promosso
dall’attore). Dobbiamo immaginare il lavoro di Serkis e degli animatori
come quello di artisti che intervengono, strato su strato, sui vari elementi
che compongono la figura di un quadro. Meglio ancora, somiglia alla
creazione di una foto con l’utilizzo dei diversi livelli di lavoro in un
software per l’elaborazione digitale dell’immagine. Affinché il personaggio
non appaia come una sorta di Frankenstein, l’attore deve essere capace di
gestire in tempi diversi i singoli contributi alla composizione senza perdere
il senso di organicità della figura finale.39
Nel corso degli anni la tecnologia è cambiata permettendo la registrazione
delle informazioni sul movimento anche in ambienti esterni. Nel 2014, per
Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, la Weta Digital, la compagnia
incaricata per tutti gli effetti speciali, portò la motion capture a un livello
superiore (allegato 7). Come ricorda Dan Lemmon, il supervisore degli
effetti speciali:
[i progressi] consentono ai personaggi e agli attori che interpretano i
personaggi di connettersi con il pubblico a un livello che non siamo mai stati
in grado di raggiungere prima. Ciò che rende questi film unici e speciali è
quanto i nostri personaggi digitali recitano e quanto sono integrati con il resto
del film [...] Abbiamo fatto molto per portare gli strumenti della motion
capture sul luogo delle riprese, fuori degli studi dedicati. Li abbiamo resi
portatili [...] Abbiamo eseguito moltissime registrazioni nelle foreste pluviali
[...] Avere l’intero sistema messo insieme in un modo che fosse relativamente
discreto e veloce da installare significava che avremmo potuto permettere agli
attori che interpretano le scimmie di essere nel set di lavoro con gli altri attori
che interpretano gli umani. Condividevano l’immediatezza della scena.40
Uno degli elementi chiave di questo sviluppo è stato il passaggio dai
marcatori che riflettevano la luce infrarossa a quelli che emettevano un
proprio segnale, vale a dire il passaggio dalla tecnologia passiva a quella
attiva (motion capture con marcatori attivi)41. La squadra aveva già
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/how-weta-changed-motion-capturetech-for-dawn-of-the-planet-of-the-apes-1273893.
39 La metafora di Frankenstein mi è stata suggerita da John Dower nell’intervista che appare
in J. Dower, Il lavoro con la motion capture: il regista e l’attore. Intervista di Antonio Pizzo,
«Acting Archives Review», n. 11, maggio 2016, p. 72.
40 B. Robertson, Weta Digital VFX Supe Dan Lemmon on Dawn of the Planet of the Apes,
«http://www.studiodaily.com», 9 febbraio 2015,
http://www.studiodaily.com/2015/02/weta-digital-vfx-supe-dan-lemmon-dawn-planetapes/ (ultimo accesso 28 agosto 2015). Cfr. anche N. Broughall, How Weta changed motion
capture tech for Dawn of the Planet of the Apes, cit., p.1,
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/how-weta-changed-motion-capture-techfor-dawn-of-the-planet-of-the-apes-1273893.
41 N. Broughall, How Weta changed motion capture tech for Dawn of the Planet of the Apes, cit., p.
1. Per la distinzione tra marcatori attivi e passivi vedi la Panoramica sui sistemi di motion
capture in appendice a questo articolo.
48 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture sperimentato la tecnologia attiva nel 2011, durante le riprese de L’alba del
pianeta delle scimmie, ma quelle prime tute erano troppo fragili, con cavi e
fili che si rompevano facilmente. Quindi, per il secondo film, la Weta ha
sviluppato un sistema che utilizzava marcatori attivi con luci led infrarosse
posti all’interno della tuta, che funzionavano meglio nella foresta dove la
maggior parte del film doveva essere girato. Il regista Matt Reeves nel
ricordare come tutte le scene fossero girate con gli attori che indossavano
una tuta con i marcatori led e una camera fissata alla testa, sottolinea che:
Abbiamo aggiunto gli effetti visivi dopo, così c’è un’intera versione di questo
film che abbiamo visto per lungo tempo dove non ci sono scimmie […] Ci
sono solo tutti gli attori nelle loro tute e la cosa pazzesca è che appare ancora
una esperienza emotiva incredibile. 42
L’affermazione intende spostare l’attenzione dagli effetti di post
produzione all’evento dal vero che si svolgeva durante le riprese. Così,
come per Gollum nella saga de Il signore degli anelli, o come per i giganti blu
di Avatar, l’immediatezza della recitazione è messa in evidenza rispetto al
lavoro degli animatori, e quindi viene accreditata un’autorialità preminente
dell’attore nella creazione del personaggio.
Serkis è sempre stato molto chiaro nell’assimilare la sua recitazione nella
motion capture con quella nei film ripresi dal vero.
Non c’è differenza. Recitare è recitare. La performance capture è una
tecnologia non un genere; è solo un altro modo di registrare la performance di
un attore.43
Nella sua esperienza, i ruoli che ha interpretato in motion capture erano
simili a quelli per i film tradizionali ma molto diversi dalle pellicole di
animazione.
Vivi, respiri e prendi decisioni per il personaggio dalla prima all’ultima
pagina, per l’intero arco emotivo. In un film di animazione, sono decisioni
prese da un gruppo. Ci sono 50 persone che creano un solo personaggio.44
Il modo in cui descrive il proprio lavoro è nient’altro che recitare ma per un
diverso tipo di camera.
La performance capture è solo una tecnologia che coglie tutto quello che fai,
ma per quanto riguarda impersonare un ruolo, fisicamente e mentalmente, o
per le ricerche che bisogna fare, non cambia da qualsiasi personaggio che
J. Medeiros, Andy Serkis is changing the face of film-making, «wired.co.uk», 6 luglio 2014,
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2014/08/features/planet-of-the-apes-andyserkis (ultimo accesso 10 febbraio 2016).
43 T. Appelo, Andy Serkis on Who Sends Him Hate Mail; Why Oscar Should Rethink Animated
Category (Q&A), «The Hollywood Reporter», 1 dicembre 2011.
44 Ivi.
42
49 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 interpreti come attore. Siamo creature di fantasia e ci induciamo a credere che
siamo assassini, amanti, ecc., quindi ciò che indossi è solo un rivestimento
superficiale. Non ho mai fatto una distinzione tra il realizzare una
performance in motion-capture e una senza la tecnologia motion-capture,
perché è solo un diverso insieme di telecamere.45
Le parole che Serkis utilizza sottolineano sempre il primato della
performance, non solo quando si tratta di un personaggio altamente
realistico (e ciò vale sia per un folletto sia per una scimmia) ma anche
quando si tratta di un’immagine resa con stile da cartone animato, come
quando ha interpretato Capitan Haddock nel Tintin di Spielberg (allegato
8).46 Questa pellicola è stata realizzata completamente in grafica al
computer, ma anche Il pianeta delle scimmie ha fatto un ampio uso di
elaborazione e creazione digitale di immagini: ed entrambe sono state
filmate utilizzando la motion capture.
È molto interessante essere in due film di quest’anno, che si presentano molto
diversi ma usano lo stesso processo. La stessa società per gli effetti visivi,
Weta Digital, ha realizzato scimmie che sembrano del tutto reali così come ha
prodotto una gamma di colori e uno stile che rende onore al materiale
originario di Tintin. Ciò che Steven stava cercando di fare era di avere il
meglio dei due mondi, in cui è possibile creare il look, le sensazioni e la
sensibilità di Hergé [il fumettista creatore Tintin], ma con la possibilità di
performance emotivamente vere. La tecnologia permette agli attori di entrare
in quei mondi. 47
Serkis dice che mentre guardava Capitan Haddock sullo schermo poteva
ancora riconoscere le proprie scelte recitative.48 Quindi, poiché la parte del
processo che concerne la recitazione è interamente uguale, lui pensa che la
recitazione per motion capture dovrebbe essere compresa nella tradizionale
categoria di miglior attore negli Oscar.49
A prescindere dal contributo di Serkis, la polemica tra animatori e attori
all’interno dell’industria cinematografica non è semplice da riassumere.
M. Stern, Motion Capture Maestro Andy Serkis on ‘Dawn of the Planet of the Apes’ and
Revolutionizing Cinema, «The Daily Beast», 8 luglio 2014,
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/07/08/motion-capture-maestro-andyserkis-on-dawn-of-the-planet-of-the-apes-and-revolutionizing-cinema.html (ultimo accesso
10 marzo 2016).
46 Val la pena notare che Tintin non è stato nominato per la categoria film d’animazione
degli Oscar. Sappiano che, anche se Serkis non fu nominato come miglior attore, il primo
capitolo della saga del Pianeta delle scimmie è stato nominato come miglior effetti speciali nei
lungometraggi. S. J. Snyder, The Oscars vs. Motion Capture: Tintin and Apes Snubs Raise Big
Questions
About
the
Academy,
«Time»,
8
febbraio
2012,
http://entertainment.time.com/2012/02/08/the-oscars-vs-motion-capture-tintin-and-apessnubs-raise-big-questions-about-the-academy/, (ultimo accesso 28 agosto 2015).
47 T. Appelo, Andy Serkis on Who Sends Him Hate Mail; Why Oscar Should Rethink Animated
Category (Q&A), cit.
48 Ivi.
49 Ivi.
45
50 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture Anche le scelte fatte dalla stessa Accademy sembrano, in qualche modo,
contraddittorie, come sottolineato da Freedman per Il curioso caso di
Benjamin Button (David Fincher, 2008, allegato 9).
Brad Pitt è stato il prima attore a ricevere una nomination agli Oscar per una
performance in larga parte sintetica. (Anche dopo la prima ora del film, nella
quale Pitt appare solo via motion capture, le successive immagini sono state
spesso ringiovanite digitalmente). Benjamin Button esisteva solo come un
complesso ibrido di immagini generate al computer, trucco facciale, e diversi
corpi fisici, ma la performance è stata attribuita a un solo attore.50
Bisogna anche dire che questo lungo dibattito può essere visto come una
parte di un discorso più ampio sullo Star System di Hollywood, e questa
crescente attenzione posta sulla performance degli attori nella motion
capture può anche essere una strategia di marketing. Come suggerito da
Barbara Flueckiger, l’attore funziona come un proxy così da assicurare il
collegamento tra il personaggio e una figura reale; l’attore ha una sorta di
delega a rappresentare il personaggio animato presso il pubblico e in
questo modo, portando con sé le caratteristiche della star, consolida una
ben nota strategia industriale per vendere i prodotti d’intrattenimento.
Accanto alla costruzione narrativa, il modello proxy è una tecnica affidabile
per stabilire una base solida per la coerenza del personaggio. Inoltre, un proxy
aggiunge un altro aspetto alla rappresentazione dei personaggi: la loro
esistenza nella vita reale. [...] Tale esistenza e le sue conseguenti associazioni
immettono un più ampio significato nella costruzione del personaggio, vale a
dire, proprio quella storia che i personaggi digitali non possiedono. Lo studio
e Peter Jackson sono stati variamente e giustamente criticati [...] per aver posto
troppa enfasi sulla recitazione, mentre gli straordinari risultati della squadra
di grafica al computer, soprattutto il team di animatori di Raitt, sono stati
minimizzati. Dal punto di vista della ricezione psicologia, tuttavia, tale messa
in primo piano è stata una mossa intelligente, perché nell’attribuire questo
risultato a una sola persona, si permette al personaggio digitale di
raggiungere qualcosa di simile ad una presenza fisica, e ciò ha una
concretezza maggiore rispetto alle operazioni astratte e incomprensibili di una
schiera di animatori. 51
La campagna promossa da Serkis è stata indubbiamente efficace stando al
gran numero di interviste e commenti sul suo lavoro come attore per la
motion capture. Ma il modello di proxy, come sembra suggerire Judith
Roof, appare comunque messo in discussione all’interno di una sorta di
equivoco sulla recitazione nel cinema.
Y. Freedman, It is Real … Or it is Motion Capture. The Battle to Redefine Animation in the Age
of Digital Performance, cit., p. 46.
51 B. Flueckiger, Visual Effects. Filmbilder aus dem Computer, cit., p. 45. Il termine «proxy» può
essere tradotto in italiano come ‘supplente’, ma Flueckiger evidentemente lo utilizza nella
sua accezione più propriamente informatica in cui è intesto come ‘tramite’ o ‘interfaccia’ tra
due terminali in una rete. Dunque l’attore proxy è il collegamento tra due finzioni: il
personaggio del racconto e il personaggio pubblico.
50
51 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Serkis esemplifica un’estetica dell’assenza come una serie di precisi rinvii. Il
suo corpo letteralmente assente mette in gioco l’ingannevole economia di
esche virtuali offerte da apparati di suoni e immagini stratificati.
La presente assenza o l’assente presenza di Serkis sono un risultato di una
serie di tentativi di produrre cinematograficamente l’illusione della presenza
spazio-temporale in cui, per definizione, niente nel cinema è in realtà ‘lì’ ad
eccezione delle onde luminose e sonore risorte per l’occasione.52
La motion capture, insieme agli interventi digitali, attacca la nozione di
attore come tramite unitario e indispensabile per il personaggio, e
soprattutto cambia la relazione storicamente stabilita tra l’immagine
costruita dell’attore e l’immagine del personaggio. Dal Rick di Bogart, fino
al James Bond di Connery, e ancora Etan Hunt di Cruise o Terminator di
Schwarzenegger, oppure il Capitan America di Chris Evans, sono tutti
potenti personaggi inventati, profondamente legati ai propri interpreti. In
anni più recenti, la relazione tra questi due elementi costitutivi (attore e
personaggio) si è rilassata e indebolita, a causa degli effetti speciali. Certo
Serkis sta mirando a un punto in cui la sua performance sarà collegata
direttamente a lui come attore (con tutto il portato dello star system) anche
se il personaggio sullo schermo non gli somiglia affatto, e magari è un
gigantesco strano mostro. Concordo però con Wojcik quando sostiene che:
Le discussioni sulla recitazione cinematografica devono trovare un modo per
tenere conto del ruolo della tecnologia nella performance. Invece di affermare
un’identità tra voce e corpo o di una non identità tra la recitazione e la
tecnologia, dobbiamo descrivere la performance nel film come non auratica e
sempre già mediata.53
In questa ottica la disputa di autorialità tra attori e animatori sulla resa
finale del personaggio non sembra poter avere una soluzione teorica
univoca. Mentre la tecnologia continuerà a svilupparsi, la connessione tra
interprete e personaggio si indebolirà tanto da poter perdere le similitudini
apparenti tra i due elementi. Ci troviamo in una situazione in cui il lavoro
dell’attore può essere con buona approssimazione rappresentato in uno
spettro che va da recitazione dal vero a recitazione digitale. E questo
spettro rappresenta la quantità di autorialità che l’attore ha sul prodotto
finale della sua performance. Il prodotto finale può essere il risultato di un
singolo individuo al quale si può riconoscere l’intera e organica
responsabilità per quello che il pubblico vede, o può essere un lavoro
collaborativo tra diversi individui (per esempio attori e controfigure),
oppure può essere il complesso e stratificato risultato di diversi artisti (per
esempio, l’attore, il direttore degli effetti speciali, e gli animatori). Il
personaggio diventa sempre più un testo con molti autori, i cui lavori
J. Roof, The Actor Who Wasn’t There: Economies of Absence in Virtual Ecologies, «University of
Toronto Quarterly», vol. 83, fasc. 3, 2014, pp. 625–644: 626.
53 P. Robertson Wojcik, The sound of film acting, cit., p. 80.
52
52 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture possono essere vicendevolmente dipendenti. Il che riguarda appunto il
livello di autorialità dell’attore, mentre non si tratta affatto di stabilire quale
su questo spettro sia ‘vera’ recitazione e quale no; è una questione di
realismo e credibilità, o di coerenza con l’obiettivo estetico dell’opera.
Ciò che comunque appare invece abbastanza chiaro è che i media stanno
testando i limiti del pubblico. Piuttosto che preoccuparsi di veder i propri
prodotti inclusi in una specifica categoria, l’industria sta sfidando i confini
tradizionali tra i generi e tra processi produttivi. Questo è possibile perché
il cinema digitale sta superando il problema del ‘quasi ma non abbastanza’
realismo dell’immagine, cioè la cosiddetta ‘uncanny valley’.54 Si potrà
verificare, in generale nel cinema e nella televisione, ciò che per adesso è
stato anticipato nel mondo dei videogiochi. Una volta che la tecnologia sarà
capace di rendere assolutamente realistici i personaggi digitali, potrà darsi
il caso che la recitazione non sarà territorio esclusivo degli attori, del loro
corpo e della loro voce, ma anche il terreno nel quale artisti digitali
creeranno i propri personaggi. Freedman intravede una diminuzione delle
differenze tra i diversi tipi di produzione cinematografica.
Se una tecnologia identica può essere utilizzata per creare sia un film dal vero
sia uno di animazione, quest’ultimo potrebbe essere considerato in termini di
scelta estetica piuttosto che una tecnica di produzione.55
In altri termini, la distinzione, una volta basata su due pratiche produttive
differenti, adesso non ha più senso perché i sistemi di produzione sono
cambiati. Se il film è fatto mediante animazione o azione dal vero è
rilevante solo in quanto opzione stilistica dell’autore. Non è importante se
Serkis vincerà la sua battaglia con l’Academy o meno, fin quando il
pubblico sarà capace di sentirsi emotivamente coinvolto con i personaggi
sullo schermo (in qualunque modo essi siano stati creati). Ogni persona del
«Questa confusione tra reale e digitale è diventata possibile nei film solo di recente,
quando i registi hanno raggiunto una pietra miliare lungamente attesa: hanno attraversato
la ‘valle misteriosa’ [the uncanny valley]. Il termine è stato usato per anni per descrivere un
problema affrontato da coloro che utilizzano la computer grafica per rappresentare
personaggi umani realistici. Quando queste creazioni smettevano di sembrare cartoni
animati e cominciavano ad avvicinarsi al fotorealismo, i personaggi in qualche modo hanno
cominciato a sembrare raccapriccianti, piuttosto che accattivanti. Alcune persone addirittura
sostenuto che il problema non potesse essere risolto; oggigiorno appare solo una questione
di ricerca e di potenza di calcolo», T. S. Perry, Digital Actors Go Beyond the Uncanny Valley,
«spectrum.ieee.org/», 27 maggio 2014,
http://spectrum.ieee.org/computing/software/digital-actors-go-beyond-the-uncannyvalley (ultimo accesso 10 marzo 2016). Il termine originale fu coniato dallo studioso di
robotica Masahiro Mori in un articolo del 1970, e recentemente riproposto in una traduzione
inglese in
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/humanoids/the-uncanny-valley
(ultimo
accesso 10 marzo 2016).
55 Y. Freedman, It is Real … Or it is Motion Capture. The Battle to Redefine Animation in the Age
of Digital Performance, cit., p. 47.
54
53 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 pubblico, una volta seduta difronte lo schermo, piuttosto che riflettere se
ciò che sta osservando è animazione o azione dal vero, metterà alla prova la
credibilità del personaggio. I personaggi sono sempre stati in qualche modo
creati da qualcuno, sono costruzioni culturali e tecniche, inventati da
qualche autore e restituiti alla nostra fruizione dalle battute scritte da un
autore o dette da un attore, oppure ancora realizzate dalle incredibili
potenzialità della grafica computerizzata su uno schermo: in ogni caso,
sono tutti costruzioni artificiali.
Un nuovo territorio per attori e registi
Come sappiamo, l’ambiente nel quale l’attore compie il proprio lavoro è di
enorme importanza. Normalmente, la motion capture avviene in studi
equipaggiati con speciali luci e telecamere. Ciò ha quasi sempre costretto
l’attore a lavorare in un ambiente alquanto asettico. D’altro canto,
sappiamo che c’è una larga parte di produzioni cinematografiche nelle
quali la scena (o una sua parte) è realizzata con oggetti reali posti davanti a
un blue screen. Spesso, anche sul palcoscenico teatrale, l’attore deve
costruire il proprio ambiente immaginario a partire da uno spazio in cui
compaiono solo pochi elementi. Eppure, gli oggetti reali sul set
cinematografico o gli elementi sul palcoscenico sono lì non solo per gli
attori ma anche per la cinepresa o il pubblico. Nello studio di motion
capture, le camere non vedono questi elementi perché stanno registrando
solo le informazioni pertinenti ai movimenti degli attori. Presumibilmente
il luogo in cui avviene la registrazione non necessita di alcun oggetto e
scenografia perché i dati di movimento potranno essere applicati a un
personaggio virtuale inserito in scene create o filmate altrove.
Quindi nel caso della motion capture con marcatori passivi, l’ambiente è
piuttosto peculiare (se lo compariamo con le riprese di un film dal vero):
uno spazio chiuso privo di riferimenti all’ambiente della storia,
completamente inondato da una luce bianca diffusa.56 Questa condizione
può essere abbastanza insolita per l’attore tanto che, di fatto, è divenuta
abitudine comune fornire agli attori elementi di scenografia trasparenti (in
genere fatti con griglie metalliche) che possano simulare pareti, porte, e gli
studi regolarmente aggiungono anche alcuni oggetti di scena (sedie, tavoli,
pedane) per creare un più efficace senso dello spazio in cui l’azione
dovrebbe avvenire. In alcuni casi, gli attori maneggiano oggetti (se
necessari) per aumentare il realismo del movimento. Normalmente, questi
ultimi sono anche marcati in modo da essere registrati e utilizzati per
Serkis ricorda: «A volte, quando sei in uno studio di motion capture, e stai girando un
film, per esempio come Tintin, ti trovi in un ambiente molto asettico, molto arido. È un po’
come lavorare su un palcoscenico teatrale durante le prove, così che ti devi fare un gran
lavoro interiore e utilizzare la tua immaginazione», in C. Ktorides, Dawn of the Planet of the
Apes’ Andy Serkis: ‘It’s so Much Easier Working on Primates’, «DIY», 17 luglio 2014,
http://diymag.com/2014/07/17/dawn-of-the-planet-of-the-apes-andy-serkis-interview
(ultimo accesso 10 marzo 2016).
56
54 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture l’animazione, mentre i primi lì solo con lo scopo di aiutare l’attore ad avere
qualche riferimento materiale ma non appariranno come informazioni
registrate (allegato 10).
Abbiamo visto che la tecnologia adesso permette al regista di girare in
motion capture anche direttamente nella location (come nel caso dei
marcatori attivi utilizzata in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie). In
questo caso l’ambiente non è più il vuoto dello studio ma può essere ogni
tipo di location reale (una foresta, una strada, ecc.), e l’attore si ritrova in
una condizione più familiare. Sappiamo però che ciò non esclude l’utilizzo
di uno studio per rigirare la stessa scena. Anche se le informazioni di
movimento sono state registrate sulla location, è infatti molto comune che
la scena (o alcune delle scene) venga ripetuta in uno studio di motion
capture. Ciò accade per fornire agli animatori un maggior numero di
informazioni e riferimenti su cui lavorare.
Prima che la registrazione possa aver inizio, è necessario svolgere le
seguenti operazioni: indossare una speciale tuta; fissare i marcatori e, a
volte, sistemare la telecamera sul capo; infine, eseguire la cosiddetta posa a
‘T’, con i piedi paralleli, le gambe minimamente divaricate, il busto eretto e
le braccia estese verso l’esterno all’altezza delle spalle. Delbridge spiega che
«questa posa (attualmente adottata come uno standard) mantiene tutti i
marcatori ad una relativa distanza tra loro per evitare che ci siano equivoci
nella costruzione del modello».57
Tra gli altri movimenti che l’attore esegue c’è una serie, chiamata range of
motion, necessaria a calibrare lo scheletro del personaggio virtuale
(normalmente include la rotazione degli arti e del busto) (allegato 11). Una
volta svolta questa routine, l’attore è collegato allo scheletro digitale, e
questo può essere utilizzato per animare, in tempo reale, una figura
virtuale che somiglia al personaggio che sarà restituito in post produzione.
Sempre Serkis, spiega che:
Quando calibri il tuo avatar, sei una specie di marionetta e burattinaio allo
stesso tempo [...] lo stai controllando in quel modo. E tu sei responsabile per il
rapporto che hai con il tuo avatar, se te ne danno l’opportunità.58
Una volta che ci si trova nello studio, o sulla location, e avendo già calibrato
il proprio avatar, il tipo di compito che l’attore deve svolgere può variare
molto a seconda del tipo di produzione. Nella produzione di un
lungometraggio, all’attore può essere richiesto di recitare le proprie battute
in una scena con uno o più compagni; in un videogame gli può venir
chiesto di eseguire innumerevoli varianti della stessa azione.
M. Delbridge, Motion Capture in Performance. An Introduction, cit., p. 27.
J. Medeiros, Andy Serkis is changing the face of film-making, «wired.co.uk», 6 luglio 2014,
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2014/08/features/planet-of-the-apes-andyserkis (ultimo accesso 10 marzo 2016).
57
58
55 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Sebbene non esista ancora una letteratura abbastanza ampia sulle modalità
attoriche della recitazione in motion capture, alcuni contributi hanno
tentato di concentrarsi sui suoi caratteri peculiari. Daniel Kade, che ha
discusso una tesi sull’argomento, sottolinea quattro requisiti fondamentali
per l’attore nella motion capture. Il primo è abbastanza generico e si
riferisce a «buone tecniche di recitazione»; gli altri (immaginazione,
linguaggio del corpo, atletismo, competenze specifiche), sebbene anch’essi
alquanto generici, appaiono più rilevanti.59
L’immaginazione è una qualità che è normalmente associata con il lavoro
degli attori ma acquista un significato specifico nelle caratteristiche
condizioni ambientali della motion capture. Nella sua tesi, Kade sostiene
che «il normale spazio in cui si recita nella motion capture non è un
ambiente di recitazione naturale per un attore, soprattutto quando lo
paragoniamo a un palcoscenico o alla recitazione cinematografica», a causa
dell’assenza di riferimenti reali o fisici (come la scenografia, gli oggetti, gli
ingombri).60 Ritiene, quindi, che gli spazi attuali della motion capture siano
più impegnativi per gli attori proprio perché sono privi di una scenografia
reale (o realistica).61 Kades affronta il problema da un punto di vista
tecnologico e crede che un elemento chiave per lo sviluppo di un sistema di
motion capture migliore sia la progettazione di un ambiente immersivo. Di
conseguenza conclude che la creazione di una certa quantità di contenuti
visivi virtuali aiuterebbe di molto il lavoro degli attori.62
Un altro caso specifico, sempre centrato sul punto di vista dell’attore, è la
serie di esperimenti condotti da Delbridge: varie sessioni di motion capture
con attori provenienti da diversi tipi di formazione. Qui il ricercatore ha
testato svariati compiti pratici per verificare come gli attori reagivano al
nuovo ambiente e come si adattavano alla tecnologia. Ebbene, anche in
questo caso, la metodologia prevedeva un qualche tipo di supporto visivo;
in particolare, un ampio schermo posto difronte agli attori in modo che
potessero vedere, in tempo reale, i propri avatar nella ricostruzione virtuale
di un tipico teatro elisabettiano. L’esperimento mirava a testare in che
modo gli attori erano capaci di fondere l’esperienza dello spazio reale
(tuttavia asettico) nel quale si muovevano con il palcoscenico virtuale in 3D
nel quale si muovevano gli avatar.63
Kade e Delbridge, seppur in prospettive dissimili, si concentrano su come
superare il problema dell’eccessiva freddezza asettica dell’ambiente nel
Cfr. D. Kade et al., Towards Stanislavski-based Principles for Motion Capture Acting in
Animation and Computer Games, in P. Tavares et al., 2nd International Conference in Illustration
and Animation, 277–293, Porto, IPCA, 2013.
http://www.confia.ipca.pt/files/confia_2013_proceedings.pdf, p. 289. Discuteremo di
queste qualità nelle pagine seguenti.
60 D. Kade, Towards Immersive Motion Capture Acting Design, Exploration and Development of an
Augmented System Solution, Licientiate Thesis, Malardalen University, 2014, p. 4.
61 Ivi, p. 14.
62 Ivi, p. 9.
63 Cfr. M. Delbridge, Motion Capture in Performance. An Introduction, cit.
59
56 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture quale si esegue la motion capture e sottolineano la mancanza di fisicità
nello spazio come uno dei maggiori problemi dei sistemi di motion capture.
Entrambi insistono sull’esigenza di fornire un qualche riferimento spaziale
agli attori. La soluzione di Kade ammicca al possibile uso della motion
capture come interfaccia per i nuovi videogame immersivi in 3D. Dulbridge
sembra prefigurare la possibilità di mostrare in tempo reale i personaggi
virtuali come elementi di uno spettacolo teatrale dal vivo.
Eppure, l’industria del cinema e dei videogame non sembra porre molta
enfasi sul problema dei riferimenti visivi. Per esempio, il regista John
Dower preferisce evitare che i propri attori si osservino su uno schermo o
sui monitor perché ritiene che ciò li distragga dalla recitazione.64
Inoltre, se è importante mettere l’attore nelle condizioni migliori per
adoperare la propria immaginazione, ciò non deve necessariamente
condurre alla simulazione di ambienti, perché si sottovaluterebbe proprio
l’abilità degli attori a creare il mondo in cui agire. E come sottolinea Dower,
l’attore deve concentrarsi sulla propria presenza piuttosto che distrarsi con
gli schermi e i monitor. Quasi tutte le affermazioni degli attori a proposito
della loro esperienza nella motion capture hanno messo in evidenza la
potente sensazione di essere liberi di immaginare il mondo piuttosto che la
difficoltà di recitare in uno spazio vuoto. E in ogni caso, poiché i progressi
tecnologici hanno reso possibile la cattura del movimento in luoghi diversi
dagli studi, il problema della necessità di operare in ambienti realistici
sembra in larga parte obsoleto, o per lo meno non dissimile da ciò che
accade nel cinema tradizionale. Assai più importante appare invece
l’attenzione che l’attore deve prestare alla propria presenza in termini di
concentrazione e selezione dei compiti da portare a termine. Piuttosto che
visualizzare i dettagli del luogo in cui il personaggio virtuale apparirà,
l’attore deve essere innanzitutto cosciente che i suoi movimenti saranno
solo una parte di una più ampia composizione del personaggio e calibrarli
conseguentemente.
Il che apre la questione essenziale del linguaggio del corpo. Si tratta di una
competenza che acquista maggiore rilevanza nella motion capture, se
confrontata con ogni altro ambiente in cui si recita, perché il più delle volte
l’obiettivo principale delle riprese è proprio catturare l’espressività del
movimento. Di solito, le espressioni facciali sono fornite dagli animatori o
da altri attori, mentre i movimenti del corpo sono la diretta registrazione
dei movimenti dell’attore. Per esempio, in Il curioso caso di Benjamin Button,
il viso digitalmente invecchiato del personaggio interpretato da Brad Pitt è
stato sovrapposto al corpo di un attore che interpreta il bambino. Nel
videogame 007 Legend, come ricorda il regista John Dower, un attore in
motion capture ha prestato i movimenti del corpo ma non la voce o il
Cfr. J. Dower, Il lavoro con la motion capture: il regista e l’attore. Intervista di Antonio Pizzo,
«Acting Archives Review», n. 11, maggio 2016, p. 70-81.
64
57 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 viso.65 Anche nelle più recenti e avanzate applicazioni della motion capture
(dalla saga del Pianeta delle scimmie alla versione animata in 3D di Tintin) il
compito principale degli attori era creare azioni e comportamenti
emotivamente significativi per i propri personaggi, mentre gli animatori
avrebbero utilizzato i loro volti come riferimento nella realizzazione di una
efficace spettro di espressioni.
Inoltre, il linguaggio del corpo è cruciale in termini di atletismo, il che è
soprattutto essenziale nei videogame in cui l’attore deve sia realizzare
performance fisiche complicate sia restituire l’emozione nel movimento.
Quindi, come sostiene Kade, «l’attore deve essere in forma. Avere capacità
atletiche, essere uno stuntman, un danzatore o simile, in molti casi può
essere d’aiuto».66
Per ultimo, un attore di motion capture dovrebbe avere una sufficiente
conoscenza della tecnologia. Nella motion capture, un attore che conosce la
posa a ‘T’ e il range of motion, farà risparmiare tempo all’operatore per la
calibrazione. E poi conoscere l’importanza dei marcatori permetterà
all’attore di chiedere subito il rimpiazzo se uno di essi va perso nell’azione.
Questo tipo di conoscenza include anche una consapevolezza delle norme
da rispettare nello studio di motion capture.
A volte, queste norme sono simili a quelle vigenti nelle produzioni
televisive o cinematografiche con un calendario serrato, come ad esempio
la necessità di imparare le battute o l’azione nello stesso giorno delle
riprese.
Ma in ogni caso i requisiti per la recitazione in motion capture sono ancora
abbastanza generici e quindi non esiste una specifica tecnica di
addestramento. Ciononostante, corsi e laboratori stanno diventando
numerosi. Il gruppo che va sotto il nome di The Mocap Vault nel Regno
Unito è uno di quelli più impegnati nel diffondere la formazione (sia con
un generoso archivio di video, sia con una serie di laboratori in Europa e
negli Stati Uniti). La motion capture, anche se non è ancora diffusa nelle
tradizionali scuole di cinema, sta diventando famosa nelle università e nelle
società private, dove è sempre più facile incontrare corsi e lezioni ad essa
dedicate.67 A un primo sguardo, i contenuti di questi corsi inducono a
pensare che la preoccupazione principale sia far fare agli studenti
l’esperienza diretta della nuova tecnica, anche se non dice molto riguardo
uno specifico metodo di recitazione. Non c’è bisogno di sottolineare che la
Cfr. Ivi.
D. Kade, Towards Stanislavski-based Principles for Motion Capture Acting in Animation and
Computer Games, cit., p. 289.
67 Una semplice ricerca sul web dovrebbe mostrare la pervasività della motion capture nella
formazione. Possiamo ricordare ad esempio che Vicon ha collaborato a corsi di formazione
in motion capture con la Bradford University (UK); la Mount St. Mary's University
(Maryland, USA) tiene regolarmente corsi di recitazione per motion capture; Organic
Motion ha fornito la tecnologia in un master della New York University Tisch School of the
Arts Asia (Singapore).
65
66
58 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture diffusione di questi corsi è dovuta all’enorme crescita del mercato per la
motion capture nel cinema e nel videogame, ed è certo che, tra le varie
opportunità che un attore può cogliere per migliorare la propria carriere,
nell’ultimo decennio, la formazione in motion capture è la più recente.
Woody Schultz, presidente della commissione nazionale per la
performance capture nella Screen Actors Guild (il sindacato degli attori
cinematografici negli Stati Uniti), che ha un’ampia esperienza nel campo,
dice che la motion capture sta cambiando il lavoro dell’attore, specialmente
grazie ai videogame di fascia alta.
L.A. Noire ha impiegato più di 200 attori. Si tratta di attori molti dei quali non
erano mai venuti in contatto diretto con la performance capture e ora hanno
questa esperienza. Rispetto a 10 anni fa, molti più attori adesso comprendono
di prima mano che l’approccio alla performance capture non è diverso da
qualsiasi altro lavoro nel campo della recitazione.68
I videogame rappresentano poi un caposaldo nella industria della motion
capture e sono il campo in cui molti attori troveranno nuovi lavori, e dove
sta emergendo una nuova professione: il che non è stato ancora del tutto
compreso. Come ci dice David Cage, della Quantic Dream, l’esperienza
della recitazione del videogame ha qualcosa di differente.
Dirigere gli attori in performance capture è un lavoro molto speciale [...] Non
è come essere il regista sul set. È probabilmente più impegnativo del lavorare
con i green screen. Raramente si gira un intero film con il green screen; qui
invece si gira l’intero videogame. Quindi il ruolo del regista per tutto il tempo
è quello di spiegare cosa sta succedendo, e cercare di ricreare la realtà sul set
così l’attore sappia cosa fare. È un’esperienza molto diversa per gli attori.
Il primo giorno si può leggere nei loro occhi ‘che ci faccio qui? Queste persone
sono pazze!’ [...]. Invece il secondo giorno sembrano rendersi conto: aspetta
un minuto, sono libero. Io non so quello che questi tipi stanno facendo, ma in
realtà non mi danno alcun vincolo. Non c’è la telecamera, nessun faro
puntato, né segni sul pavimento, niente fili di qualsiasi tipo. Non devo
preoccuparmi del suono o di altro, quindi sono libero di recitare.69
Considerazioni finali
Sebbene l’ambito sia ancora troppo giovane per permettere ai ricercatori di
definire un qualche tipo di tendenza storica o tecnica recitativa, è possibile
metter in luce alcune considerazioni teoriche circa il cambiamento che può
essere intravisto nella recitazione per la motion capture.
Poiché la recitazione nella motion capture è stata ampiamente utilizzata nel
videogame, bisogna tener conto della nozione di storia interattiva e le sue
H. Hart, When Will a Motion-Capture Actor Win an Oscar?, cit.
P. Davison, David Cage: ‘We Can Use Technology to Say Something’, «USGamer», 4 settembre
2013,
http://www.usgamer.net/articles/david-cage-we-can-use-technology-to-say-something
(ultimo accesso 10 marzo 2016).
68
69
59 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 conseguenze per il lavoro dell’attore. David Cage, in un tentativo di
definire alcune peculiarità della recitazione in un ambiente di motion
capture, tende a compararla con il senso di libertà che l’attore deve
raggiungere in quello che lui chiama ‘teatro minimale’, dove il palcoscenico
è uno spazio vuoto e deve essere riempito mediante un atto
d’immaginazione.70 In questo nuovo territorio – lui suppone – la maggiore
differenza è introdotta dalla nozione di interattività.
Ci sono differenze fondamentali, in particolare per l’elemento interattivo – ciò
richiede non solo di registrare diverse battute e scene a seconda delle scelte
del giocatore, ma anche di considerare come il prodotto finito viene ‘girato’.71
Nella produzione di videogame, a un attore può venir richiesto di eseguire
differenti azioni per riprodurre le diverse scelte che il giocatore può fare.
Oppure, gli si può chiedere di fare la stessa azione (come essere colpito da
un colpo di arma da fuoco) in una lunga serie di variazioni. In breve,
l’attore deve recitare il proprio personaggio secondo differenti opzioni
inventate per tutti i possibili sviluppi della trama. Invece che avere una
singola catena di cause ed effetti sulla quale fare affidamento per
l’elaborazione del personaggio, l’attore deve creare un intero set di
possibilità Questo set deve essere costruito sulla base di poche
caratteristiche chiave (personalità, fisicità, motivazioni, ecc.) e deve essere
coerente con la trama generale. Possiamo descrivere queste condizioni
riferendoci a quanto accade nelle tradizionali prove di uno spettacolo: qui
gli attori tenteranno diverse soluzioni per una singola azione e, magari con
l’aiuto del regista, ne selezioneranno solo una. Nel caso della motion
capture, l’attore deve avere una simile e ricca immaginazione per fornire
soluzioni multiple per l’azione, ma la differenza è che tutte potranno essere
usate durante le sessioni di gioco.
Così come in quello che è definito virtual storytelling possiamo far
riferimento alla narrativa come database, la nozione di interattività nel
videogame ci induce a pensare alla performance dell’attore come un
archivio di comportamenti. 72 Mark Wolf dice:
Dopo poco più di un secolo di tecnologia cinematografica, gli attori oggi sono
diventati database di unità performative separabili in una serie di elementi
singoli, ciascuno dei quali può essere manipolato e ricombinato in post
produzione [...].73
Ivi.
Ivi.
72 Per la nozione di narrativa database cfr. L. Manovich, Database as a genre of new media, «AI
& Society», v. 14, n. 2, 2000, pp. 176-183; L. Manovich, Database as Symbolic Form,
«Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies»,
giugno 1999, vol. 5, n. 2, pp. 80-99.
73 M. J. P. Wolf, The Technological Construction of Performance, cit., p. 55.
70
71
60 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture Del resto, nei videogame, la nozione di attore come database chiama in
causa il linguaggio filmico anche durante l’azione giocata e non sono
durante le clip narrative. Come sottolineato da John Dower, nei videogame
una larga parte dell’attività è lasciata al giocatore che è libero di guidare il
personaggio e, il più delle volte, fare questo significa anche selezionare il
punto di vista e l’inquadratura dell’azione. Queste decisioni, precisa
Dulbridge, «possono essere prese dopo la ripresa, in diverse varianti o,
infatti, dallo stesso utente, a seconda dell’interfaccia».74
Nei moderni videogame, il giocatore affronta la narrazione mediante lo
schermo; pertanto, anche se la motion capture non richiede l’inquadratura,
il risultato finale dell’azione catturata ne avrà comunque bisogno.
Naturalmente l’inquadratura cinematografica nei videogame è spesso
gestita da un algoritmo e rappresenta un elemento importante per il
successo del lavoro. Infatti, per evitare la tradizionale, e molto diffusa,
inquadratura in soggettiva, Cage e la Quantic Dream hanno sviluppato un
software (utilizzato in Heavy Rain e in The Sorcerer) che crea inquadrature
cinematografiche più originali mediante nuovi punti di vista e diversi lenti
ottiche virtuali.75
Questo ci introduce a un altro elemento principale che è stato messo in luce
da molti di coloro che hanno lavorato con la motion capture: il fatto che
l’attore perde sia la nozione di inquadratura sia il punto di vista del
pubblico. In un ambiente di motion capture, a prescindere dalla tecnologia
utilizzata (marcatori ottici, inerziali, ecc.) la nozione chiave è il volume
dove l’attore è ripreso, cioè la quantità di spazio in cui le informazioni sono
raccolte. Delbridge ricorda:
A seconda della registrazione che si fa, il volume sarò regolato di
conseguenza. Le variabili includono: il numero di oggetti e il tipo di
performance da catturare; le proprietà fisiche del luogo in cui i cui gli attori
devono interagire tra di loro.76
Dal suo punto di vista, la motion capture induce un «approccio teatrale alla
performance» proprio perché registra l’intero evento «in tempo reale e
senza essere ostacolato dai limiti dello strumento di registrazione (come
l’inquadratura)». Nei termini utilizzati da Delbridge, la libertà che si prova
nella motion capture:
è liberà degli ostacoli tradizionali che incontriamo nell’allestimento profilmico
e nella continuità narrativa della produzione cinematografica. Si
abbandonano le onerose ripetizioni richieste per il continuo riallestimento e
M. Delbridge, Motion Capture in Performance. An Introduction, cit., p. 30. Cfr. anche P.
Davison, David Cage: ‘We Can Use Technology to Say Something’, cit.
75 Ivi.
76 M. Delbridge, Motion Capture in Performance. An Introduction, cit., p. 30.
74
61 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 l’inquadratura degli dell’ambiente, lasciando emergere l’intrinseca teatralità
della performance.77
Suppongo che si possa controbattere all’affermazione che la teatralità della
performance consista nell’assenza di un certo tipo di elementi tecnici
connessi alla produzione cinematografica ricordando che anche il
palcoscenico teatrale può essere un ambiente altamente tecnologico in cui
recitare. Quindi, piuttosto che individuare una diretta ascendenza teatrale
della recitazione per la motion capture, preferirei considerarla come
appartenente alla categoria della recitazione per speciali tecnologie di
ripresa.
Non c’è comunque alcun dubbio, come abbiamo visto, che la linea di
produzione per questo tipo di prodotti è diversa da quella del tradizionale
film dal vero. Per lo meno ipoteticamente, la registrazione non ha bisogno
di prendere decisioni riguardo l’inquadratura. Ants Farrel, un tecnico di
motion capture che ha lavorato con Weta Digital, dice:
Tradizionalmente, se si vuole catturare una scena – per esempio, due attori a
un tavolo – bisognerebbe coprire tutti gli angoli e ciò prenderebbe un intero
giorno di lavoro [...]. Con la performance capture, gli attori possono
semplicemente recitare la scena come farebbero in teatro. Le telecamere
disposte intorno al volume registreranno tutto. Poi il regista dovrà solo
entrare nel volume con la sua telecamera virtuale e riprodurre la scena più e
più volte e tagliarla a suo piacimento.78
Dunque, se l’attore in motion capture, proprio come l’attore nel cinema,
recita per uno strumento tecnologico (e non per un pubblico dal vivo), la
differenza è che nei film dal vero gli attori recitano per la cinepresa, mentre
nella motion capture recitano per il volume. Yacov Freeman ricorda:
Come sostiene Robert Zemeckis, la funzione della motion capture è di
registrare una performance, ma l’obiettivo della motion capture è quello di
eliminare efficacemente la cinepresa. Trasportando gli attori su un palco
completamente digitale, la motion capture permette ai registi di creare le
scene senza mai guardare in un obiettivo, gestire le immagini in modi che
sfidano la fisica, e provare di una quantità infinita di angoli durante in
montaggio, mantenendo per tutto il tempo il peso e la ‘verità’ indicale del
cinema tradizionale.79
Nel campo di questa nuova cinematografia, un ulteriore elemento
problematico per il tradizionale lavoro dell’attore è il montaggio all’interno
Ivi, p. 4.
J. Medeiros, Andy Serkis is changing the face of film-making, «wired.co.uk», 6 July 2014,
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2014/08/features/planet-of-the-apes-andyserkis.
79 Y. Freedman, Is It Real . . . or Is It Motion Capture?: The Battle to Redefine Animation in the Age
of Digital Performance, «The Velvet Light Trap», vol. 69, fasc. 69, 2012, pp. 38–49:47-48.
77
78
62 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture della stessa ripresa. Il cinema digitale ha largamente aumentato le
possibilità di composizione della scena con diversi livelli d’immagini, al di
là del semplice effetto di blue screen. Oggi, il regista ha la possibilità di
aggiungere diversi livelli, virtualmente quanti ne desidera, a una singola
scena, e quindi può eseguire un montaggio all’interno della stessa ripresa.
Mark Wolf ritiene che:
Proprio come il cinema ha scomposto lo spettacolo teatrale in una serie di
scatti, gli effetti speciali compongono la ripresa e le stessa performance in
elementi componibili.80
E Yacov Freedman dice:
Steve Starkey, il produttore di The Polar Express e Beowulf, ha spiegato che
registrando le informazioni della performance di un attore a 360 gradi,
Zemeckis è in grado di determinare molti elementi cruciali – come il
posizionamento della camera, l’illuminazione, e l’arredamento – in qualsiasi
momento durante la produzione con una facilità e flessibilità che erano
precedentemente impensabili. La motion capture, a quanto pare, sfuma anche
le tradizionali differenze tra pre-produzione, produzione e post-produzione.
Inoltre, dà il regista un maggiore controllo della performance senza sacrificare
l’attore, e permettendo una visione artistica più chiara, più diretta per l’attore
e il regista.81
Per il montaggio all’interno della ripresa, l’attore deve tenere a mente che le
diverse azioni eseguite in una scena non solo potrebbero essere
temporalmente connesse con altre (come accade nel montaggio), ma deve
sapere anche che la sua azione può essere parte di una composizione
complessa dove, per esempio, l’azione di altre persone sul set possono
essere aggiunte o rimosse. Quindi è abbastanza normale che un attore di
motion capture possa trovarsi a dover produrre un certo numero di
informazioni (le azioni) in una situazione dove gli altri attori con cui è in
diretto contatto fisico, spariranno nella composizione finale mentre altri
personaggi saranno aggiunti.
Infine c’è un cambiamento più profondo per il lavoro dell’attore e deriva
dall’idea di spogliare la recitazione delle ultime connessioni, mediate o
immediate, con la realtà corporea, riducendola a pura informazione
digitale. Delbridge dice:
I dati della performance catturati contribuiscono a un linguaggio che non è
fugace, come una performance dal vivo, né preservato in modo organico e
chimicamente, come nella pellicola, ma viene memorizzato immaterialmente
in una forma conosciuta come dati.82
M. J. P. Wolf, The Technological Construction of Performance, cit., p. 57.
Y. Freedman, cit., p. 42.
82 M. Delbridge, Motion Capture in Performance. An Introduction, cit., p. 30.
80
81
63 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Nel caso di un attore in uno spettacolo teatrale, possiamo vedere il suo
corpo esposto sul palcoscenico. Gli attori televisivi o cinematografici sono
per lo meno coscienti che un fascio di luce offrirà l’illusione dei loro corpi
allo sguardo del pubblico. Anche le voci degli attori che doppiano i
personaggi animati conservano una qualche senso della fisicità delle onde
sonore che hanno prodotto. L’attore in motion capture fornisce solo un
insieme di dati digitali, una sorta di istruzione che sarà eseguita da qualcun
altro (di solito un animatore). È a anche vero che attualmente ogni tipo di
informazione che è stata registrata in digitale può essere digitalmente
elaborata (accade per il suono e per l’immagine), ma con la motion capture
la natura stessa dell’attività dell’attore è di fornire un determinato tipo di
informazioni. La performance dell’attore è astratta in una lista di
informazioni, e quindi diventa un testo, una partitura tanto quanto i diversi
tipi di notazione nella danza. Questa partitura può essere eseguita (e anche
manipolata) per produrre un evento differente dall’originale del quale sono
stati registrati i dati. Il cinema e la televisione hanno già spinto la
performance dell’attore nel campo testuale, ma continuano a mantenere un
simulacro dell’evento originale. La motion capture sembra avere la
possibilità di rimuovere tutti i riferimenti all’evento dal vivo e comunque
conservare il realismo dell’azione e le informazioni emotive che il pubblico
è in grado di riconoscere.
Ciò ci porta all’ultima considerazione. Abbiamo detto che nella motion
capture il movimento può essere astratto in una lista di dati; quindi l’azione
del vivo del performer può essere codificata in un testo così come un
software è capace di tradurre automaticamente le note prodotte da un
pianoforte in una partitura musicale. Una partitura può essere eseguita ma,
inutile dirlo, ogni esecuzione è anche la traduzione di un testo in un evento.
Si potrebbe quindi ritenere che l’attore di motion capture non esegua
performance ma fornisca testi che gli animatori poi eseguiranno. Le
informazioni fornite dagli attori possono essere utilizzate in situazioni
diverse da quelle immaginate al momento della registrazione; il ritmo del
movimento può essere cambiato, la durata può essere modificata;
probabilmente l’unica cosa che resta è l’atmosfera emotiva dell’azione, così
come un testo può essere letto o eseguito in diversi modi ma (a meno che
non lo si cambi radicalmente) esso manterrà il suo senso originario.
La motion capture gioca con la nostra innata capacitò di percepire le azioni
umane come significanti e costruire un senso attraverso di esse. Adesso che
siamo abituati al potere evocativo delle ombre su uno schermo, potremo
iniziare a elaborare il potenziale di una serie di puntini distribuiti nello
spazio e nel tempo.
64 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture Panoramica sui sistemi di motion capture
Negli ultimi tre decenni la tecnologia per catturare e tracciare a 360 gradi le
informazioni spaziali e temporali di un movimento si è sviluppata ed è
cambiata secondo i diversi campi di applicazioni e scopi. Qui di seguito
elenchiamo i sistemi utilizzati, mettendo in luce solo le differenze
tecnologiche più rilevanti.83
Sistemi ottici
Fino ad oggi, i sistemi più diffusi e utilizzati per la cattura del movimento
sono quelli ottici. Tutti questi sistemi ottengono la tracciatura del
movimento grazie a una registrazione ottica: una serie di videocamere
registrano l’azione in uno spazio predefinito. Sotto il termine ‘sistema
ottico’ includiamo diverse tecnologie.
Esistono innanzitutto i sistemi con marcatori, e sono quelli in cui il
movimento viene registrato mediante il posizionamento di una serie di
marcatori sul corpo del performer. In sostanza non si registra il corpo ma
solo la posizione di questi marcatori.
I sistemi di motion capture più diffusi si basano su marcatori passivi. I
marcatori passivi sono, di solito, piccole sfere bianche ricoperte da un
materiale retroriflettente che le rende tracciabili da videocamere sensibili
alla luce infrarossa. Un dato numero di queste videocamere viene puntato
in un dato spazio, normalmente chiamato ‘floor’. Più grande è lo spazio e
più telecamere sono necessarie. Il performer indossa una tuta elastica
aderente in lycra o spandex sulla quale sono attaccati con il velcro, in punti
specifici del corpo, i marcatori (tradizionalmente tra 35 e 50) che riflettono
la luce infrarossa. Ogni camera è equipaggiata con un proiettore di luce
infrarossa in modo da illuminare l’intero spazio. Il livello di sensibilità
della camera è regolato in modo da registrare solo il riflesso emanato dai
marcatori, e nessun’altra luce. Tutte le camere sono connesse a un software
che elabora e immagazzina in una memoria le informazioni registrate. Uno
dei passi più importanti in questo processo è il momento in cui si calibrano
le camere, ossia quando si mettono in relazione le camere con l’ambiente
reale indicando al software la posizione di ognuna rispetto le altre. Ciò di
solito avviene grazie allo stesso software. Un operatore muove al centro
dello spazio una bacchetta a forma di ‘T’ dove sono fissati alcuni marcatori
in posizioni specifiche; le informazioni registrate dalle camere permettono
al software di calcolare le posizioni relative e creare un riferimento
Una descrizione dettagliata dei sistemi utilizzati è al di là degli scopi di questo articolo. La
rete offre un ampio ventaglio di informazioni, e la pagina dedicate da Wikipedia può essere
un buon punto di partenza
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Motion_capture&oldid=676025973
(ultimo
accesso 25 agosto 2015). Il libro che ancora rappresenta il riferimento principale sulla motion
capture per l’animazione è MoCap for Artists: Workflow and Techniques for Motion Capture di
M. Kitagawa e B. Windsor, Focal Press, 2012.
83
65 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 tridimensionale per ognuna di esse. Dopo questo passo il sistema è capace
di registrare le informazioni x, y, z di ogni marcatore nello spazio. Quindi,
se ci sono almeno due camere calibrate che ‘vedono’ un marcatore, il
sistema ottiene un punto di posizione in uno spazio tridimensionale. Per
procedere alla cattura del movimento di un corpo umano, il software non
solo localizza i marcatori sul corpo del performer ma li abbina anche con i
punti di uno scheletro virtuale secondo lo standard H-Anim. Ciò vuol dire
che i punti nello spazio sul corpo del performer vengono mappati
univocamente su uno scheletro umanoide e che, ad esempio, secondo le
regole dello standard, il marcatore sulla testa del performer deve essere
abbinato al punto estremo in alto sul cranio dello scheletro umanoide. Le
informazioni sono quindi passate a un altro software che crea una
immagine 3D sullo schermo e sono registrate per essere poi applicate su
qualsiasi personaggio digitale, a patto che sia possibile comparare i punti
dello scheletro nel software di cattura con altrettanti punti del personaggio
da animare.
Pur basata su principi identici, la motion capture con marcatori attivi
rappresenta un miglioramento della tecnica passiva perché utilizza
marcatori LED connessi via cavo alla tuta di motion capture. Invece che
utilizzare la specifica illuminazione infrarossa nell’ambiente, le camere
registrano una luce diffusa dagli stessi marcatori. Questi ultimi, infatti,
emettono un proprio segnale luminoso, e quindi possono comunicare un
identificativo univoco (per esempio illuminandosi individualmente per un
micro secondo a intervalli definiti). Ciò riduce la necessità di complessi
algoritmi per eliminare la sovrapposizione e la confusione tra differenti
marcatori. Inoltre, il vantaggio di questa tecnica consiste nel non richiedere
un’illuminazione specifica realizzabile solo in uno studio e permette di
catturare i movimenti in ambiente aperto. Lo svantaggio è che il performer
deve indossare anche una batteria o un caricatore. Questo sistema è
preferito nei casi in cui la registrazione del movimento deve avvenire in
contemporanea alle riprese di un’azione dal vero e l’azione deve svolgersi
in esterni, in una location reale, dove non sarebbe possibile gestire
condizioni di luce strettamente controllate (è stato il caso di Apes Revolution
- Il pianeta delle scimmie).
Sebbene l’immagine del performer vestito con la tuta aderente punteggiata
dai marcatori sia diventata iconica per la motion capture, esistono altri tipi
di sistemi ottici, che si basano su riprese video, ma senza marcatori. Questa
tecnica non ha bisogno di marcatori perché utilizza algoritmi in grado di
riconoscere, all’interno di una normale ripresa video, i contorni e la
posizione di un dato soggetto e seguirne i movimenti. Il risultato può
variare di molto, a seconda del numero di camere utilizzate e dagli
algoritmi impiegati. Gli strumenti possono essere molto semplici, come ad
esempio tre telecamere, disposte rispettivamente su due lati e in alto, che
permettono di individuare la posizione del corpo calcolando la posizione
su tre piani che rappresentano le tre dimensioni. Oppure si può ricorrere a
66 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture configurazioni più elaborate (magari con più camere) in grado di
riconoscere più persone alla volta e avere una maggiore risoluzione nella
cattura del movimento (per esempi il dettaglio delle singole parti del
corpo). In genere, questo tipo di tecnica richiede che il performer sia
inserito in un ambiente con sfondo e pavimento neutri o addirittura
opportunamente marcati con linee o altri segni specifici, in modo che sia
più facile isolare i contorni della figura e seguirne i movimenti nello spazio
tridimensionale. Chiaramente, l’accuratezza di questi sistemi si basa sulla
capacità di elaborare i dati, e quindi sullo specifico algoritmo utilizzato.
Però, in genere, nelle informazioni raccolte in questo modo, lo spettro di
errore tende a essere più grande rispetto alle soluzioni con i marcatori. Più
recentemente, questi sistemi sono stati ulteriormente sviluppati
perfezionando lo strumento di raccolta dati. L’esempio più conosciuto è la
Kinect che (grazie alla sua telecamera, al suo sensore di profondità e a una
serie di microfoni) è capace di fornire una ragionevole cattura dei
movimenti del corpo anche se utilizza un unico punto di vista.84 Tra le
soluzioni commercializzate, una delle più famose è OpenStage 2. La casa
produttrice sostiene che sia l’unico sistema professionale sul mercato che
permette una cattura accurata senza marcatori.85
Sistemi elettromeccanici
Se abbandoniamo il vasto mondo della motion capture ottica, cioè quella
che utilizza riprese video, entriamo in un campo in cui le soluzioni sono
indubbiamente disparate e meno diffuse, ma dove comunque s’incontrano
soluzioni che hanno suscitato un certo interesse. È il caso, ad esempio, della
motion capture meccanica che è stata utilizzata, oltre che per misurazioni
scientifiche, anche in alcuni esperimenti di teatro o danza. In questi casi è
molto comune utilizzare strumenti elettro meccanici applicati alle giunture
e ad altri punti del corpo. Normalmente un sistema simile consiste di
elettro goniometri – sensori fondati sulla tecnologia dei potenziometri o dei
trasduttori, progettati per misurare gli angoli. Questi strumenti possono
essere posti uno ad uno sul corpo del performer oppure possono essere
combinati in un costume indossabile. Quando questo costume è composto
di elementi rigidi e articolazioni snodabili prende solitamente il nome di
esoscheletro. Questa tecnologia, in genere, non ha lo scopo di misurare gli
spostamenti in uno spazio tridimensionale, bensì quello di registrare
l’ampiezza degli angoli formati dagli snodi del corpo. Soluzioni di questo
tipo vengono di solito preferite in teatro e nella danza perché sono
abbastanza economiche, possono essere utilizzate in qualsiasi tipo di
ambiente e non richiedono alcuna speciale illuminazione. L’esoscheletro,
Cfr. J. Han, L. Shao, D. Xu, J. Shotton, Enhanced Computer Vision with Microsoft Kinect
Sensor: A Review, «IEEE Trans. Cybernetics», vol. 43, n. 5, 2013.,
85 Cfr. www.organicmotion.com (ultimo accesso 10 marzo 2016).
84
67 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 ad esempio, è stato utilizzato da Marcel·lì Antúnez Roca in Afasia (1998) e,
con alcune lievi modifiche, in molte delle sue successive performance.86
Meno diffusi sono i sistemi che utilizzano sensori sul corpo per misurare il
campo magnetico a bassa frequenza generato da un trasmettitore. Sia i
sensori sia i trasmettitori sono connessi a una unità di controllo elettronica
che mette in relazione le loro posizione nello spazio. Le unità sono connesse
a una stessa rete con un computer sul quale è attivo un software capace di
rappresentare queste posizioni nello spazio tridimensionale. Con questa
tecnologia è possibile tracciare il movimento nello spazio senza l’ausilio di
illuminazione o sfondi specifici. Bisogna però dire che questi sistemi sono
molto influenzati dalle interferenze di altri campi magnetici (per esempio
ogni oggetto metallico, tutti i tipi di cablaggio o le fonti elettriche) e per
questa ragione incontrano più difficoltà ad essere utilizzati in ambiti
teatrali o cinematografici dove sarebbe praticamente impossibile evitare
questo tipo di disturbi.
Sistemi inerziali
Recentemente, la miniaturizzazione della tecnologia ha rilanciato le
possibilità dei sensori inerziali per la motion capture. Questa soluzione è in
parte simile al quella ottica con marcatori attivi ma con la differenza che al
posto dei marcatori si utilizzano speciali sensori (normalmente wireless)
posti sul corpo o sull’oggetto del quale si vuole catturare il movimento. I
sensori sono in grado di trasmettere direttamente i dati della propria
posizione al software. Sebbene esistano diversi tipi di sensori inerziali, il
più delle volte si utilizzano giroscopi. Così come accade nei sistemi ottici, i
dati di posizione sono mappati su uno scheletro e, quindi, più elevato è il
numero dei sensori, più accurata è la registrazione del movimento.
Probabilmente assisteremo alla crescita nella diffusione di questa
tecnologia, magari nel mercato di consumo di base (così come è accaduto
per la Kinect), soprattutto grazie al suo basso costo ma anche perché non ha
bisogno di uno studio appositamente attrezzato ed è capace di raccogliere
dati in un spazio più ampio e articolato. Tra i sistemi inerziali, quello che
sta ricevendo più attenzione è chiamato Perception Neuron.87
Cattura delle espressioni facciali
Nel cinema, e a volte nel videogame, la motion capture è spesso accoppiata
alla registrazione dei movimenti del viso. Si tratta di una serie di
metodologie di ripresa che mirano a catturare, sempre in forma di dati
numerici, le informazioni dettagliate delle espressioni facciali dell’attore
così da applicarle al personaggio digitale. Naturalmente, il movimento dei
muscoli facciali richiede un sistema capace di registrare i dettagli a un
altissimo livello di granularità e finezza, se comparato, ad esempio, con la
86
87
Cfr. A. Pizzo, The Kaleidoscopic Career of Marcel·lì Antúnez Roca, «The Scenographer», 2015.
Cfr. https://neuronmocap.com/ (ultimo accesso 10 marzo 2016).
68 Antonio Pizzo, L’attore e la recitazione nella motion capture tracciatura del corpo nello spazio. Anche in questo caso possiamo
distinguere tra i sistemi con o senza marcatori. Quelli privi di marcatori,
naturalmente, sono considerati meno ingombranti per l’attore. Di solito, la
cattura si svolge mediante una videocamera ad alta risoluzione che registra
il viso dell’attore da un punto di vista fisso. In questo caso l’attore deve
rimanere con il corpo immobile per tenere il proprio viso in una data
inquadratura. Quando la produzione richiede che corpo e viso siano
registrati nello stesso momento l’attore indossa un elmetto con sopra una
camera puntata sul proprio viso, così da potersi muovere liberamente nel
set.
69 Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 John Dower
Il lavoro con la motion capture: il regista e l’attore
Intervista di Antonio Pizzo
∗
John Dower è un regista con circa vent’anni di carriera. Dopo aver studiato
in due scuole di cinema nel Regno Unito e in Polonia (la Northern Film
School in Leeds e la The Polish National Film School in Lodz), ha iniziato la
sua carriera come regista di cinema e televisione. Tra le sue numerose
attività, Dower ha diretto per la BBC dieci episodi della soap EastEnders, e
diverse pellicole, tra i quali The Day after Stonewall Died vincitore del premio
come miglior cortometraggio al Cannes Short Film Festival. Dower ha
avvicinato per la prima volta l’ambito della fiction interattiva quando ha
curato la regia di alcune sequenze di Signs of Life, una serie televisiva
interattiva trasmessa sul web, di circa due ore, prodotta da Endemol e BBC.
Nel 2009 è stato assunto per dirigere le riprese in motion capture di Milo, il
personaggio protagonista del videogame Milo & Kate, progettato da
Microsoft e Lionhead. Da allora, Dower ha lavorato in diversi videogame,
incluso l’ultimo basato sul personaggio di James Bond, 007 Legend, con la
Activison/Eurocom. É stato regista di motion capture nel Regno Unito e
negli Stati Uniti e ha lavorato come direttore del doppiaggio in diversi
videogame. Dower è uno dei co-fondatori di The Mocap Vault,
un’importante società con sede in Inghilterra e in California che si dedica
alla formazione e alla produzione nel campo della motion capture. La
società, a partire dai principi di base, permette agli attori, registi e
animatori di ricevere una formazione che copre tutti gli aspetti
dell’industria della motion capture. Dower insegna anche creazione del
personaggio e narratività per il corso in Games Design and Development
presso la National Film School (NFTS), e insegna recitazione per il cinema
presso la scuola di teatro di East 15 e ALRA.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Come hai iniziato a lavorare nella motion capture?
Ho iniziato come regista per il cinema e per la televisione. Mi sono formato
in una scuola di cinema a Leeds e poi in una in Polonia. Quando sono
ritornato in Inghilterra ho cominciato a girare alcuni cortometraggi e poi a
lavorare in TV. Subito dopo aver lavorato in Eastenders, mi sono reso conto
che il lavoro iniziava ad annoiarmi per la rigidità di quello che la TV aveva
∗
L’intervista ha avuto luogo il 19 agosto 2015 a Brixton (Londra - UK).
70 © 2016 Acting Archives www.actingarchives.it John Dower, Il lavoro con la motion capture: il regista e l’attore da offrirmi. Quindi ho visto un annuncio on line sulla rivista del sindacato
dei registi, dove la Lionhead Studios cercava un regista con esperienza di
cinema o teatro per lavorare a un personaggio di un videogame. Mi piaceva
l’idea; così ho fatto domanda e ho ottenuto il lavoro. In seguito, ho lavorato
lì per tre anni, a tempo pieno su una produzione per un videogame
intitolato Milo e Kate. E questa fu la mia prima esperienza con la motion
capture.
Puoi descrivere quali sono le qualità che aiutano un regista a entrare nel mondo
della motion capture?
Al tempo in cui ho fatto domanda alla Lionhead Studios, la compagnia
aveva visto già una decina di registi, ma nessuno era risultato adatto. Il
problema con i candidati registi precedenti era questo: non comprendevano
come fosse possibile che il giocatore potesse avere il controllo della storia.
Dal loro punto di vista, normalmente, è il regista ad avere il controllo sulla
narrazione. Credo che io sia stato l’unico a trovarmi a mio agio con
quell’idea e non essere sospettoso, anzi interessato. A parte questo, ho
ricevuto una positiva impressione dall’ambiente che ho incontrato. Quanti
vi lavoravano apparivano tutti aperti e disponibili. La persona che si
occupava dell’assunzione era un animatore che voleva lavorare con
narratori e con registi che fossero interessati ai personaggi e agli attori.
Come ti definiresti, in quanto regista?
Sono un regista interessato ai personaggi. Più vado avanti e più credo che
ciò che un regista fa è inventare storie e creare personaggi con i quali
raccontarle. Recentemente ho tenuto diverse lezioni e spesso mi son trovato
a discutere di quanto dovremo occuparci di storie interattive. Quando ero
studente, il film era la forma d’arte più importante, e magari ciò era vero
tra gli anni Sessanta e Novanta: era la più importante forma di narrazione
per il grande pubblico. Non è più così. Adesso ci sono molti modi differenti
di raccontare storie (televisione, cinema, internet, videogame, narrativa
interattiva, smartphone e tablet). Sono molto più possibilista adesso che
allora.
In generale, pensi che la motion capture rappresenti una nuova opportunità di
lavoro per i registi?
In questo campo non c’è molto spazio per i registi freelance. Per esempio, io
lavoro ancora nel cinema e nella televisione, e anche come insegnante. Fino
ad oggi, molte delle persone impegnate nella direzione di motion capture
sono animatori. Penso che questo rappresenti un problema per la motion
capture, e anche per i videogame. Le società produttrici di videogame
preferiscono stipulare contratti lunghi e temono che i registi gli impongano
71 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 il proprio modo di lavoro. Del resto, il problema reale è che il regista di
cinema è considerato il principale narratore, e questo si scontra con un
ambiente lavorativo in cui il regista non è più la figura più importante della
squadra. La situazione cambia con i registi che provengono dalla
produzione televisiva. In questo tipo di produzioni il regista non è il capo;
ha molti altri ruoli sopra di lui (per esempio i produttori, gli autori).
Dunque, se un regista proviene dalla televisione e lavora nel videogame,
troverà una situazione alquanto simile. Per quanto mi riguarda posso
contare due importanti esperienze nella motion capture per il videogame:
Milo e Kate, del quale ho detto prima, e 007 Legends che mi ha impegnato
per quattro mesi, e per il quale ho diretto le sequenze non interattive
[cutscenes]. Inoltre, poiché il regista avrebbe dovuto dirigere anche le voci,
penso che in questo caso sia stato assunto perché avevano bisogno di
qualcuno che si sentisse a proprio agio a lavorare con attori molto famosi,
come Judi Dench.
Come hai condotto il lavoro in questo caso?
È stato un processo molto complicato nel quale ho avuto la fortuna di
lavorare con il mio socio in The Mocap Vault, Oliver Hollis-Leick, che ha
interpretato il ruolo di James Bond nel videogame. Avevo precedentemente
registrato la voce, con un altro attore, in uno studio di Londra, poi abbiamo
riprodotto le registrazioni di questi dialoghi nello studio di motion capture
dove giravamo le scene. Nello studio, Oliver ha registrato il corpo, e in
seguito abbiamo catturato i movimenti del viso (a volte eseguiti da un altro
attore). Quindi ci sono state occasioni in cui la performance finale era la
composizione di tre diverse persone. Alla fine, naturalmente, proprio per
questa ragione, c’è il rischio che il prodotto finale possa sembrare una sorta
di Frankenstein. Spero che questo tipo di metodologia produttiva sia
abbandonato nel tempo. D’altronde, questo processo può essere necessario
quando lavori con grandi star e non le puoi trascinare in uno remoto
studio, e fargli indossare una tutina aderente, o averli per tutti il tempo che
desideri perché ti costerebbe troppo. Inoltre, nel caso di 007 Legend, non
abbiamo potuto registrare corpo e viso nello stesso momento perché allora
(ho svolto il lavoro tre anni fa) non avevamo ancora a disposizione le
camere per il viso (il sistema utilizzato adesso che permette di riprendere le
espressioni facciali dell’attore nello stesso momento in cui catturi i
movimenti).
Di solito fornisci una qualche motivazione quando chiedi agli attori di recitare
un’azione, anche semplice, nella motion capture?
Sempre. Quando dirigo, cerco sempre di suggerire la situazione in cui il
personaggio si trova. In un certo senso, è il tradizionale lavoro del regista.
Qual è il tuo obiettivo? Perché sei qui? Cosa vuoi? In che direzione vai?
72 John Dower, Il lavoro con la motion capture: il regista e l’attore Quale è il tuo background? Se, per esempio, lavoro alla registrazione dei
dialoghi, devo solitamente andare a un ritmo veloce, e quindi è importante
indicare agli attori il contesto in cui sono: l’azione si svolge nella caverna di
un drago? Sei in una foresta? Devi parlare sottovoce? Sei in una stanza? Gli
attori devono sapere come appaiono i loro personaggi e quali sensazioni
hanno. Inoltre, se non hai la possibilità di mostrargli un modello (o
un’immagine), spesso l’unica possibilità che ti resta è di raccontargli una
storia.
Pensi che queste indicazioni possano aiutare l’attore a rendere meglio anche nella
motion capture, così come accade nella registrazione della voce?
Si. Ciò che conta nella motion capture è la fisicità. Quindi è
importantissimo che l’attore comprenda dove si trova, cosa accade. Nella
motion capture, in generale, non c’è molto tempo per le prove.
Normalmente, bisogna lavorare in fretta. Eppure, penso che i bravi attori
sappiano cosa chiederti. Anche senza molto tempo per le prove, sanno cosa
devono sapere. Magari ti chiedono come sarà vestito il personaggio, dove
sarà, dove va e cosa vuole. Gli attori hanno bisogno di conoscere queste
informazioni, e poi, una volta che le conoscono, tutto è più chiaro e
possono iniziare il loro lavoro.
Normalmente distribuisci il copione, o altro tipo di script, agli attori prima delle
riprese?
Quando lavori con la motion capture nei videogame devi considerare un
problema specifico. Prendiamo ad esempio 007 Legends: io ero autorizzato
ad avere l’intero script di tutte le scene, ed era circa cento pagine. Gli attori,
al contrario, non potevano averlo; gli veniva data solo la singola scena da
girare il giorno seguente, o addirittura lo stesso giorno. Ciò accade perché
le produzioni sono molto preoccupate che possano trapelare informazioni
sulla storia. Come puoi immaginare, se ciò accadesse, ne parlerebbe tutta
Internet. La diffusione d’informazioni sulla storia preoccupa l’industria del
videogame molto più che quella cinematografica. Di tanto in tanto, nei
nostri corsi, Oliver Hollis-Leick ha sottolineato questo problema. Lui è un
attore di motion capture con molta esperienza e centinaia di ore di lavoro
negli studi. Non è raro che riceva la scena sono mezz’ora prima di iniziare a
girare. Quindi deve essere in grado di comprendere rapidamente la
situazione e, in pochi minuti, realizzare ciò di cui ha bisogno di sapere al
fine di eseguire efficacemente le sue azioni. Puoi immaginare come
reagirebbe un attore tradizionale se gli dessi la scena, magari anche
abbastanza lunga, solo mezz’ora prima di eseguirla. Inoltre, l’attore deve
anche superare il problema di vestire una stupida tutina con numerosi
pallini bianchi appiccicati, e magari anche un elmetto con una telecamera in
testa. In più, l’attore si trova in uno studio che non somiglia a nessun altro
73 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 posto dove probabilmente ha già lavorato e possono mancargli gli elementi
dai quali aveva imparato a trarre le proprie indicazioni, i propri riferimenti
per la creazione del personaggio.
Quali tipi di riferimenti (ambiente, oggetti, personaggi) devi indicare agli attori
nella motion capture?
Penso che i riferimenti siano importanti al fine di ottenere una buona
performance. Una delle cose ripetute spesso da Andy Serkis, famoso per i
personaggi di Gollum nella saga de Il signore degli anelli e di Cesar in quella
de Il pianeta delle scimmie, è che la motion capture è qualcosa simile alla
pura recitazione. Lui è un ottimo ambasciatore per la motion capture e ha
sempre detto che l’immaginazione è la qualità più importante. In una
sessione di motion capture, in teoria, tu vorresti mostrare agli attori quante
più informazioni possibili. Fondamentalmente è quello che sta facendo
James Cameron con i sequel di Avatar, per i quali ha allestito uno studio di
produzione virtuale e, per esempio, può mostrare agli attori come apparirà
la giungla in cui si trovano. Quindi, qualsiasi cosa possa aiutare gli attori,
devi tentarla. A volte, però, non è possibile mostrare ciò che vorresti. Ad
esempio, le compagnie di videogame sono rinomate per non essere
organizzare come le produzioni cinematografiche e non sono in grado di
concedere agli attori abbastanza spazio e informazioni. Quello che un
attore ha bisogno di sapere è importante allo stesso modo sia per i film sia
per i videogame: è importante se si desidera una recitazione di qualità. Alla
The Mocap Vault ci concentriamo nel migliorare le performance in motion
capture e quindi tendiamo a fornire quante più informazioni e oggetti,
quanti più stimoli e riferimenti ci è possibile. Ma se per qualche motivo non
è possibile, in qualità di regista, devi raccontare una storia che risponda a
quello che gli attori devono sapere.
Dopo aver visto un ‘making of’ del Tintin di Spielberg, ho trovato interessante
come il regista lavorasse con gli attori in uno studio di motion capture. Lui era
molto vicino agli attori, molto concentrato sulle loro azioni. Pensi che la motion
capture induca un modo specifico di dirigere gli attori?
É interessante che tu abbia menzionato Spielberg. Lui parla molto agli
attori e lo fa anche nei film girati dal vero. È un ottimo esempio da
utilizzare perché è un ottimo direttore d’attori. Uno dei motivi per cui mi
piace lavorare in motion capture è che ti permette una relazione primaria
con gli attori. Puoi stare a mezzo metro da loro e parlarci mentre recitano. È
grandioso. Non devi preoccuparti delle lenti dell’obiettivo o delle luci: puoi
concentrarti sull’attore.
74 John Dower, Il lavoro con la motion capture: il regista e l’attore Quanto è importante che non ci si debba preoccupare di inquadrature e ottiche delle
camere?
Nella motion capture l’inquadratura e le ottiche possono essere decise dopo
la registrazione. Questo è strabiliante per un regista perché così puoi
separare la performance dalla cinepresa. Mentre mi trovavo a Los Angeles,
nel momento in cui Spielberg stava girando Tintin, nello stesso studio, un
giorno l’ho visto definire le inquadrature per quello che era stato girato la
settimana prima. Io stavo girando una sessione di motion capture ed è stata
una sensazione incredibile quella di poter lavorare nello stesso spazio e
nello stesso momento anche se stavamo facendo due produzioni differenti
Quanto sei concentrato su come l’immagine apparirà sullo schermo e quanto su
cosa fa l’attore?
Penso che il risultato finale debba essere preso in considerazione anche
mentre si gira in motion capture. Per un grande film, come ad esempio
Tintin, la produzione realizza l’intero storyboard, magari anche in versione
animata, e probabilmente decide in precedenza anche l’illuminazione.
Credo che nelle grandi produzioni il regista di norma sappia come e dove
apparirà l’attore nel risultato finale. E questo vale anche per i videogame;
per esempio, per la realizzazione di Uncharted 1 hanno usato un regista
teatrale che lavorava sulla performance e un direttore dell’animazione che
lavorava sul visual.
In ogni caso, ho la sensazione che nella motion capture sia possibile curare
la performance in modo più concentrato, più focalizzato rispetto al cinema.
E per questo credo che, forse, i registi che sono più attenti agli attori
potrebbero riuscire meglio nella motion capture rispetto a quelli che hanno
una matrice più visiva.
Quanto controllo hai sugli elementi nella resa finale del lavoro?
Quando ho fatto la motion capture per 007, ho collaborato con un direttore
dell’animazione che aveva il compito di mettere tutto insieme. Dovevamo
condividere una visione complessiva di come avrebbe funzionato il tutto, e
avevamo storyboard animati per tutte le scene. Una particolarità di quel
videogame è che, per il 95%, è tutto soggettiva da James Bond. Per questo,
abbiamo piazzato uno dei marcatori sulla testa dell’attore e l’abbiamo
accoppiato a una camera virtuale; grazie a questo espediente, potevamo
vedere sullo schermo come sarebbe risultata la camera in soggettiva.
Oliver, che interpretava Bond, ha dovuto abituarsi a non poter muovere
troppo la sua testa perché ciò avrebbe reso l’immagine instabile e mossa.
Nello stesso tempo ha dovuto imparare a puntare la testa laddove fosse
necessario per la ripresa. Anche se poi non abbiamo sempre utilizzato la
camera virtuale sulla sua testa, per noi è sempre stata un importante
75 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 riferimento. In sostanza, abbiamo concordato con lui come avremmo girato
le scene e io ho diretto la camera attraverso di lui.
Ciò vuol dire che Oliver guardava anche uno schermo mentre giravate?
No. Solo io lo facevo. Non puoi lasciare che gli attori guardino uno
schermo. Appena cominciano a osservarsi su uno schermo o su un monitor
iniziano i problemi. Lo stesso vale quando lavori in un film; devi assicurarti
che non ci siano monitor nei quali gli attori possano vedersi, perché c’è il
rischio che si preoccupino di come appaiono. Non mi è mai piaciuta l’idea
di avere un grande schermo con la performance perché a quel punto gli
attori lo guardano e si distraggono. A mio avviso, non ha senso. So che
alcuni studi proiettano le immagini su uno schermo. Ma in quel caso io
dovrei perdere molto tempo a convincere gli attori a non guardarle. Gli
attori devono concentrarsi sulla propria performance.
The Mocap Vault tiene corsi per attori di motion capture. Puoi dirci qualcosa a
riguardo?
Abbiamo tenuto cinque seminari di recitazione in motion capture, e due
meeting (uno a Los Angeles e uno a Londra). In questi meeting abbiamo
lavorato con attori, animatori e registi. Abbiamo anche registrato una
sessione di zombie visibile sul nostro canale youtube.1 Ci piacciono gli
zombie perché se un attore avrà occasione di lavorare in motion capture è
molto probabile che sarà per un videogame e, ancora più probabile, che ci
siano zombie.
Puoi descrivere il tipo di formazione che avevano gli attori con i quali hai lavorato,
e cosa insegnate nei vostri corsi?
Devo confessare che quando ho lavorato nel cinema ero un po’ scettico
circa la formazione teatrale. Ciò detto, mi è capitato in seguito di insegnare
in scuole di teatro dove tenevo corsi di recitazione cinematografica. Lì ho
cominciato a rispettare di più la preparazione teatrale e, adesso, mi rendo
conto che questa può fare la differenza nella qualità dell’attore e nelle sue
possibilità di trovare lavoro. Per quanto riguarda la motion capture, è
sicuramente un vantaggio. Quando dirigo film, devo passare molto tempo
a convincere gli attori a non preoccuparsi di come appaiono: non devono
pensare alla parrucca o al trucco ma a ciò che accade dentro di loro. Voglio
che l’attore si concentri sul personaggio, non su come appare.
Probabilmente l’attore teatrale riesce meglio di altri ad essere naturalmente
Cfr. il canale youtube all’indirizzo
https://www.youtube.com/channel/UC7JkokMS2XUFZte1k6iEFkw (ultimo accesso 10
marzo 2016).
1
76 John Dower, Il lavoro con la motion capture: il regista e l’attore consapevole della propria presenza. Quando sei sul palcoscenico, se non
pensi che qualcuno deve poterti osservare da decine di metri di distanza,
probabilmente la tua performance non sarà abbastanza efficace. Credo che
questa sia la differenza. Gli attori di motion capture devono comprendere
in che modo la loro fisicità, i loro gesti e il loro intero corpo comunicano,
altrimenti accade che gli attori diventano rigidi e pensano solo alla parte
superiore del corpo, come quegli attori televisivi che sono abituati solo ai
primi piani e ai campi medi. Quindi, nella motion capture, è bene che gli
attori abbiano una formazione che li aiuti a comprendere il proprio tipo di
fisicità e come questa comunichi al pubblico. Più lavoro nella motion
capture e più mi convinco che un attore non possa avere successo in questo
ambito senza avere una qualche formazione teatrale nel movimento.
Nei nostri corsi discutiamo ingenerale della relazione tra corpo e camera
ma sottolineiamo anche che gli attori devono comprendere gli animatori.
Per questo preferiamo i laboratori in cui ci sono attori e animatori. In un
corso che abbiamo recentemente tenuto a Stuttgart, c’erano sei animatori,
quattro direttori tecnici e otto attori. È stato ottimo perché averli tutti lì
insieme ha reso più semplice farli intendere gli uni con gli altri.
L’animatore vede l’attore come una sorta di marionetta, e l’attore deve
accettare di esserlo. Ma se l’attore riesce a far capire all’animatore di cosa
ha bisogno per rendere migliore quella marionetta, allora il risultato sarà
straordinario.
In molte lezioni sottolineiamo l’importanza del movimento ma forniamo
anche quella sorta di competenze che si imparerebbero in una scuola di
teatro. Il più delle volte dobbiamo far capire agli attori che non devono
essere spaventati dalla tecnologia, anche se può intimorire, perché molto
probabilmente loro già hanno le abilità necessarie. Il nostro obiettivo è di
far capire agli attori come funziona la motion capture e dar loro fiducia. Ma
soprattutto cerchiamo di insegnare ciò che da loro vorrebbero gli animatori.
Allo stesso modo di quando insegno agli studenti di recitazione
cinematografica che devono capire cosa accadrà alla loro performance nelle
mani dei montatori, gli attori di motion capture devono capire che la loro
performance sarà trasformata in qualcos’altro.
Quindi ritieni che per un attore sia fondamentale avere una conoscenza generale
della tecnologia per lavorare nella motion capture?
Certo. Ogni attore che lavora con qualsiasi media deve averne una certa
conoscenza. Anche gli attori che lavorano in teatro devono sapere cosa fa
uno direttore di scena, cosa accade quando si apre il sipario, quando le luci
provengono da un determinato lato e cosa succede se ci si volta. La tecnica
in teatro è importante tanto quanto quella nel cinema: come funziona la
cinepresa, le ottiche.
77 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Ti sei mai accorto che un attore potesse non sentirsi a suo agio nella tuta da motion
capture?
Si, può accadere. Ci sono momenti in cui devi registrare con qualcuno che
non è preparato a indossare una tuta che lo espone così tanto. La gente può
esserne molto imbarazzata: è aderentissima, puoi vedere tutto, nulla è
lasciato all’immaginazione, e può intimorire l’idea di doverla indossare.
Naturalmente, devi fare in modo che la troupe dimostri sensibilità a
riguardo. Per esempio, non devono fissare le ragazze. In generale,
specialmente con i sistemi ottici di motion capture, l’attore deve essere in
forma e abbastanza muscoloso perché se il performer ha molta ciccia che
traballa allora anche i marcatori appariranno traballanti. E ricordati che i
marcatori sono collegati tra di loro da uno scheletro che non deve essere
traballante o elastico.
Credi che ci siano caratteristiche specifiche della motion capture che possano
indurre l’attore verso una particolare modo di recitare? Così come, ad esempio, è
accaduto con la recitazione cinematografica dove l’attore ha imparato a
concentrarsi sull’inquadratura?
In qualche modo le sfide sono le stesse. Anche nella motion capture, l’attore
deve sapere dov’è la camera virtuale. Se ti dicono che l’azione che stai
registrando sarà vista in primo piano o in campo medio, allora devi recitare
di conseguenza. In ogni caso si tratta di un problema molto comune. Per
esempio, se stai gesticolando ma sei in un campo lungo, devi fare in modo
che si vedano le tue mani; se sei in un primo piano, basta quasi che l’azione
sia solo pensata più che agita.
Nella motion capture ci avviciniamo al momento in cui l’accuratezza della
cattura sarà ottima (sebbene non al cento per cento), a seconda del budget.
Magari verrà il giorno in cui la performance potrà essere registrata secondo
le necessità dell’inquadratura selezionata dal giocatore. Per altro, il
giocatore già controlla la camera in molti videogame, e questo rende la
regia e la recitazione per la motion captue molto complicate. Come regista,
e come attore, devi sempre scendere a compromessi perché non sei mai
sicuro di come verrà vista la scena. Devi mettere in piedi una performance
che non sia né troppo grande né troppo piccola, perché è probabile che
l’animatore ti dica che non ha spazio sufficiente sugli hard disk per
conservare tutti i diversi tipi di ripresa. Comunque, ciò detto, le cose stanno
cambiando. Oggi gli attori di motion capture devono eseguire non più
centinaia bensì migliaia di movimenti. Quando giri in motion capture per i
videogame, devi scomporre in singole azioni sia le clip non interattive sia le
scene di gioco. Le scene non interattive sono come dei piccoli film, ma sono
in genere di numero limitato. Le scene di gioco possono consistere di
migliaia di movimenti in cui l’attore si accovaccia, sale una scala, si mette in
posizione per sparare. Se c’è abbastanza spazio di memoria e se l’animatore
78 John Dower, Il lavoro con la motion capture: il regista e l’attore vuole una grande accuratezza nella resa realistica del videogame, allora
può anche accadere che si ripetano le stesse scene in modo che possano
essere viste da diversi punti (per esempio, da vicino e da lontano), e l’attore
può di conseguenza variare la propria performance.
In ogni caso si tratta di un lavoro molto fisico, ed è interessante notare che
nella motion capture si può individuare un’azione finta, anche dai semplici
dati, dai soli puntini che si muovono sullo schermo. Se, per esempio, il
personaggio deve maneggiare un’ascia ma l’attore ha tra le mani un
oggetto troppo leggero, è possibile riconoscere, anche dai puntini sullo
schermo del computer, che il movimento è finto, che non possiede il peso e
la dinamica di un’ascia.
Quindi ritieni che l’inquadratura è importante anche nel caso della motion capture
perché l’immagine sarà alla fine vista in uno schermo?
Come regista io riesco a vedere la differenza tra le scene che ho girato in cui
il personaggio doveva essere visto da una lunga distanza o quelle in cui era
osservato da vicino. Girerei le scene in modo diverso. Anche nel caso della
recente realtà virtuale, non possiamo ignorare che c’è sempre uno schermo,
una prospettiva.
Quanto della performance dell’attore viene conservato nella resa finale? O, in altre
parole, quanto è grande in percentuale il contributo dell’animatore nel personaggio
sullo schermo.
Nella motion capture penso che la performance sia più importante. La
performance deve essere di buon livello. L’attore ha la capacità di fornire la
continuità del personaggio durante tutto il processo di animazione. Per
produrre un tipico film d’animazione occorrono moltissime persone e, a
volte, gli animatori si concentrano solo sulla scena sulla quale stanno
lavorando. Quando ho lavorato con gli animatori, ho capito che somigliava
un po’ alla direzione di attori. È importante essere sicuri che ci sia una linea
di continuità della storia e del personaggio, perché se la perdi, ogni scena
risulterà diversa dalle altre.
Se ci riferisce ai grandi film come quelli in cui lavora Andy Serkis,
probabilmente la performance conta per il 75% o il 65% del risultato finale.
Di certo è più performance che animazione. Probabilmente Serkis
preferirebbe dire che si tratta del 100%, e che per lui si tratta solo di un
make-up digitale, un lieve ritocco. Ma non possiamo dimenticare che una
considerevole parte del lavoro è svolta dagli animatori. D’altro lato, anche
se molti animatori non sarebbero d’accordo, bisogna riconoscere che non è
solo una questione di buona animazione. È una miscela. Ciononostante, ci
sono produzioni, come il videogame 007 Legends, dove questa miscela è al
50%, perché la performance deve essere molto ritoccata e ripulita.
79 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016 Sappiamo che l’animazione di qualità costa molto. Sarebbe cinico considerare la
motion capture solo come una maniera economica per fornire agli animatori
movimenti realistici?
Beh, questo sarebbe abbastanza cinico da parte tua. Del resto, anche io sono
alquanto cinico rispetto la motion capture perché, a volte, il risultato mi
sembra un po’ troppo rozzo, specialmente nei videogame. Forse perché non
sono un buon giocatore di videogame, ma in genere trovo grezzi questi
prodotti. Non c’è la raffinatezza che s’incontra nel buon teatro o in un buon
film.
D’altro canto, dovremmo riconsiderare la motion capture nel suo insieme.
Quando abbiamo tenuto il meeting a Los Angeles, abbiamo incontrato John
Ruth, uno dei più grandi esperti di motion capture che abbia mai
incontrato, e lui ci ha detto che non bisogna intendere la motion capture
come una cosa a sé stante, ma come parte di una produzione virtuale, un
nuovo territorio nel quale stiamo entrando. Non si tratta solo di catturare la
performance degli attori, ma anche di una produzione in cui tutto, scene,
costumi, personaggi, luci, sta diventando virtuale. Avatar è il principale
esempio. Oggigiorno possiamo iniziare a realizzare film in cui si fondono,
senza soluzione di continuità, la produzione virtuale e quella dal vero. A
questo scopo, abbiamo bisogno delle informazioni di movimento accurate,
tali che soddisfino il nostro desiderio di creare personaggi realistici. La
motion capture sta diventando il sistema per soddisfare questo bisogno.
Questo è ciò che sta realmente accadendo.
Penso inoltre che la motion capture possa offrire al regista l’opportunità di
raccontare storie visivamente incredibili in misura prima inimmaginabile.
Magari non si tratta di un’evoluzione dell’arte ma certo questo progresso
sta rispondendo a qualcosa di più grande che non possiamo nemmeno
comprendere. Probabilmente queste innovazioni s’incroceranno con quelle
nella narrazione interattiva,
Potresti dirci come gli sviluppi tecnologici nella motion capture hanno influito sul
lavoro con gli attori?
Ho iniziato a lavorare nella motion capture nel 2007, e penso che si ponga
troppa attenzione sul lato tecnologico. Normalmente tendo a chiedere alle
persone che lavorano con me di dimenticarsi della tecnologia, perché,
anche se è importante comprenderla, non bisogna considerarla come la
cosa più importante. La cosa più importante è raccontare le storie, essere il
personaggio ed essere sinceri. Inoltre, credo che gli sviluppi più
significativi nella motion capture non stiano avvenendo nelle soluzioni di
alto costo perché sono quelle in qualche modo intoccabili: sono le cose che
fanno a Hollywood.
È il lato meno industriale della motion capture che mi interessa. Sai che ci
sono diversi sistemi: quello ottico della Vicon, quello basato sui contorni
80 John Dower, Il lavoro con la motion capture: il regista e l’attore della Kinect. Ma ci sono anche i sistemi con marcatori inerziali come ad
esempio la Perception Neuron. Hanno dato uno di questi ultimi sistemi a
Oliver che ha poi condotto alcuni esperimenti. Il punto del sistema Vicon è
che è accurato al livello del millimetro. Le tute inerziali magari non sono
così accurate ma riescono comunque a fornire dati molto precisi e molto
realistici. Oliver ha utilizzato una tuta inerziale sui due piani di casa sua: ha
sistemato la centralina per la raccolta dati in una stanza e poi è andato al
piano di sopra, poi in cucina e in giardino, e il sistema registrava i dati da
tutti questi luoghi. Questo è stupefacente e non potrebbe essere fatto con i
sistemi ottici per i quali c’è bisogno di uno studio equipaggiato.
Ma la cosa ancor più interessante è che questi sistemi sono economici.
Magari con una tuta che costa 500 dollari uno sviluppatore indipendente,
un giocatore o un regista indipendente, magari un attore in vena di
sperimentazioni, potrebbero tutti iniziare a inserire la motion capture nella
produzione dei loro video. Trovo molto interessante che gli attori possono
lavorare su un sistema che costa solo 500 dollari e comunque fare un ottimo
lavoro. Penso che questo sarà molto importante e diffuso in futuro. Con
l’arrivo di tutti questi nuovi sistemi, magari in breve, saremo in grado di
catturare una performance, forse anche le espressioni facciali, e poi dopo
solo un’ora avere pronta una scena in animazione, anche perché la pulitura
dei dati è diventata più facile e i software di interpolazione sono più
accurati.
Sono sicuro che tra dieci anni potremo comprare un sistema che non costa
molto e con un semplice laptop potremo registrare una performance e
mostrarla agli amici poco dopo. Sta per accadere presto, ed è questo che
cerchiamo di promuovere con il nostro studio. Dalle produzioni
indipendenti e a basso costo nasceranno le cose più interessanti e io penso
che sarà di lì che arriverà la vera innovazione.
81 Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Salvatore Margiotta
Il paradigma dell’attore.
L’esperienza artistica di Carmine Maringola∗
Quando si fa riferimento al teatro di Emma Dante si pensa inevitabilmente
ad un teatro dove l’attore è tutto:1 motivo cardine della personale ricerca
scenica, elemento essenziale e fondante la costruzione drammaturgica.2
Numerosi e ben documentati sono ormai gli studi – sia in chiave storicocritica, sia analitica – che fanno luce sull’attività di uno dei registi ed autori
più significativi per la storia del teatro italiano, e non solo, degli anni zero.3
Improntati alla ricostruzione della poetica registica, volti a scandagliare i
prodromi alla base dell’operazione drammaturgica, tesi ad evidenziare le
peculiarità del percorso artistico di Emma Dante gli studi di riferimento
offrono un quadro approfondito ed esaustivo. Non sempre, però, viene
offerto uno spazio cospicuo per raccontare l’esperienza attorica all’interno
di questo particolare approccio. Se da un lato è infatti semplice imbattersi
nella ricostruzione delle tecniche alla base del lavoro proposto dalla Dante,
dall’altro non risulta così frequente trovare indagini o ricerche imperniate
sul reale apporto creativo offerto degli attori di Compagnia Sud Costa
Occidentale, nonostante la presenza di alcuni performer, da diversi anni,
sia costante e stabile, in alcuni casi fin dall’esordio della regista. Che tipo di
relazione instaura l’attore con le tecniche laboratoriali? Come costruisce la
parte? Quali sono gli strumenti del suo lavoro?
Sono tutte questioni che risultano interessanti se affrontate anche dalla
prospettiva di chi rielabora sul versante performativo, traduce in azione le
intuizioni generatrici e generative dell’autrice, soprattutto considerata la
∗
Allegati all’articolo: materiale iconografico, consultabile on line su Acting Archives
Review, numero 11 – Maggio 2016 (www.actingarchives.it cliccando su “Review”)
1 «Voi siete le mie cavie… però siete anche il motore di tutto» (P. Bologna, Verso Purgatorio,
in Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, a cura di A. Porcheddu, Civitella in Val di Chiana,
Zona, 2006, p. 148).
2 «Chiedo agli attori di essere anch’essi autori, perché sono loro il veicolo più importante»
(Citato in G. Distefano, Sicilia audace, «Primafila», n. 116, 2005, p. 7). Relativamente a questa
impostazione ‘trasversale’ della creazione drammaturgica di stampo maieutico, scrive la
Bottiroli: «Emma Dante riesce a governare i suoi attori attraverso una dinamica circolare di
costante scambio a livello drammaturgico. Sono due le fasi della composizione: quella
iniziale in cui mette a punto un’architettura a livello di fabula e forma, e quella conclusiva,
quando incorpora nella struttura di partenza i materiali gestuali e verbali offerti dagli attori
durante le prove» (S. Bottiroli, I felici pochi di Emma Dante. La grazia scomoda del teatro,
«Culture teatrali», autunno, n. 19, 2008, p. 171).
3 Si vedano i fondamentali Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit.; A. Barsotti, La lingua
teatrale di Emma Dante. Mpalermu, Carnezzeria, Vita mia, Pisa, Edizioni ETS, 2009.
© Acting Archives
www.actingarchives.it
82 Salvatore Margiotta, Il paradigma dell’attore
formazione degli attori, forgiata su precise, personali ed esclusive esigenze
tecnico-espressive:
Al mio gruppo – precisa la Dante – ho insegnato, e insegno tuttora, però il mio
insegnamento è un insegnamento molto furbo: perché a me serve, mi serve per
fare i miei spettacoli. Quindi non è un insegnamento fine a se stesso. Insegno,
formo l’attore che poi aderisce al mio progetto: non formo un attore e punto.4
La dimensione tecnica della formazione attorica è quindi inscindibilmente
legata alla sua applicazione progettuale, cioè alla costruzione della parte e
di conseguenza alla creazione drammaturgica dello spettacolo nel suo
complesso, tanto da consentirci di poter definire come ‘paradigmatico’ –
rispetto alla proposta artistica della regista – il contributo creativo offerto
dai suoi interpreti.
Centro propulsivo dell’operazione teatrale è pertanto il laboratorio,
occasione in cui riprendere e approfondire l’impostazione metodologica,
incontrare nuovi compagni di lavoro, sviluppare il nuovo progetto
scenico:5
L’autrice – scrive Anna Barsotti – mette in mano “un’idea” drammaturgica
iniziale ai suoi attori e con essi la rielabora e la sviluppa, attraverso studi e
laboratori, improvvisazioni individuali e collettive6
La schiera, che permette una prima modalità di approccio all’ascolto di sé
in relazione agli altri, è l’esercizio cardine del training. Mutuato
dall’esperienza compiuta con Gabriele Vacis tra il 1995 e il 1998, questo
esercizio viene riproposto dalla Dante in maniera personale. Non più la
schiera – appunto – di attori che percorre per ore «dieci passi dal fondo del
palco verso il proscenio e viceversa, seguendo una immaginaria linea retta,
con lo scopo di mantenere lo stesso ritmo»,7 ma una sorta di estenuante e
apparentemente caotico itinerario fatto di geometrie orizzontali e incroci
obliqui con l’obiettivo di far perdere l’orientamento ai componenti del
gruppo e contemporaneamente stimolare un ascolto più intenso.8 Come
spiega la stessa regista «su questo esercizio si costruisce il personaggio:
4 E. Dante, La strada scomoda del teatro, intervista a cura di A. Porcheddu e P. Bologna, in
Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 76.
5 «Io scelgo gli attori per la storia che ho in mente, perché li ritengo adatti. Studio non solo
l’anatomia del loro corpo, ma il modo in cui guardano, in cui gesticolano, in cui si muovono.
Da questo, lentamente, capisco cosa “dipingere” su di loro, cioè qual è la qualità del
linguaggio e della parola che serve loro» (Ivi, p. 57).
6 A. Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. Mpalermu, Carnezzeria, Vita mia, cit., p. 110.
7 Citato in F. Antonelli, C. Bellofiore, Conversando con Emma Dante. Estratti di un teatro
“bastardo”, «Atti & Sipari», ottobre, n. 1 , 2007, p. 46.
8 Cfr.: E. Dante, La strada scomoda del teatro, intervista a cura di A. Porcheddu e P. Bologna, in
Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 36.
83
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
come cammina, come guarda, come parla».9 La camminata, il modo di
tenere la testa o un braccio sono i primi strumenti di cui il corpo si dota per
portare alla luce il personaggio, anche se appena abbozzato, «il primo
germe – come testimoniato Sabino Civilleri, una delle presenze storiche
della Compagnia Sud Costa Occidentale – di ciò che Emma chiama “il
fantasmino”».10 Tale considerazione è ripresa anche da un altro elemento
storico della compagnia, Manuela Lo Sicco, quando afferma:
Dopo che, attraverso questa camminata hai costruito un tuo mondo e hai
trovato questo “fantasmino”, è come se le situazioni nascessero da sé, perché
sei arrivato ad essere un certo personaggio e non puoi fare altro che agire
secondo quello che sei.11
A questo punto viene generato un processo di costruzione-rievocazione del
vissuto del personaggio attraverso una vera e propria ‘intervista’ condotta
dalla Dante sulla base della quale l’attore, improvvisando, è chiamato a
rispondere alle domande alterando la sua voce, spingendosi ulteriormente
nella direzione della trasformazione in un altro da sé. È un lavoro di scavo
a quattro mani – e più in generale corale – che tende verso un disegno
autoriale generale precostituito, ma che parallelamente vive e si nutre di
dettagli figli dell’ispirazione e della rielaborazione fino al punto in cui «[…]
per una strana alchimia, tutto coincide: il tempo, lo spazio, la battuta…».12
La parte, come del resto l’intero spettacolo, viene così creata
progressivamente ‘con e attraverso’ l’attore sulla scorta di un processo
rivelatore.13 Un teatro di «prototipi (o archetipi) di un umanità minima
secondaria» popolato, come efficacemente rilevato da Porcheddu, da
«maschere messe in situazione» spogliate, fin dalla loro prima comparsa,
da «derive psicologizzanti».14
L’introduzione di un abito-costume, l’utilizzo di musiche che
rappresentano sia il metronomo delle sessioni laboratoriali, sia una sorta di
tavolozza drammatica con la quale accordare colore e atmosfera ai diversi
momenti, l’inserimento di oggetti da trovarobato di seconda mano che
Ivi.
S. Civilleri, Uno spazio dove tutto è possibile, intervista a cura di P. Bologna, in Palermo
dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 180.
11 M. Lo Sicco, Giocare a nascondino in un campo minato, intervista a cura di P. Bologna, in
Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 174.
12 E. Dante, La strada scomoda del teatro, intervista a cura di A. Porcheddu e P. Bologna, in
Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 53.
13 «Lei ci scrive addosso il copione. Durante le prove, i laboratori, lei tenta in tutti i modi di
farci entrare nelle vene e nei muscoli quelle parole, di farcele “vomitare” per digerirle […]»
(M. Lo Sicco, Giocare a nascondino in un campo minato, intervista a cura di P. Bologna, in
Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 175).
14 A. Porcheddu, La tribù tragica di Emma Dante, in Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit.,
p. 102.
9
10
84
Salvatore Margiotta, Il paradigma dell’attore
aiutano ad amplificare le dinamiche fisico-gestuali15 sono tutti momenti di
un processo di creazione collettiva il cui obiettivo è portare in scena
un’opera autentica e pulsante che eluda ogni cliché di sorta:16
Essere ubriaco o essere zoppo – afferma Emma Dante – non significa,
necessariamente, zoppicare e sbandare, perché ogni ubriaco vive l’ubriachezza
in modo personale: e non è detto che non si riesca a camminare dritti. Ma se
l’attore fa l’ubriaco, camminando storto e sbandando […] non fa altro che
seguire un’impostazione standard, che è appunto il cliché.17
Affidandosi all’improvvisazione, osservando regole dettate, infrante e
ricomposte ad ogni sessione dalla regista, l’attore sperimenta la verità
dell’azione, il bisogno di compiere un gesto necessario, la rielaborazione
della testimonianza; mette a punto, cioè, gli strumenti con i quali ‘origina’
la parte, crea dunque il personaggio, coniugando un incessante
allenamento fisico allo sviluppo di processi sinaptici di ridefinizione,
l’integrazione drammaturgica all’invenzione espressiva.18
Questioni relative alla elaborazione di una grammatica fisico-gestuale,
all’incarnazione di un’idea di recitazione quale parte integrante e
costitutiva della progettazione drammaturgica, alla costruzione della parte,
al lavoro sul personaggio nell’orizzonte di una progettualità teatrale – e più
in generale poetica – condivisa con Emma Dante vengono qui affrontate
con Carmine Maringola, attore diventato sempre più centrale negli
spettacoli firmati dalla regista.19
Nato nel gennaio del 1974 Maringola si avvicina al teatro nella metà degli
anni novanta, periodo in cui frequenta la facoltà di Architettura presso
l’Università Federico II di Napoli. Il primo approccio è legato al teatro di
strada, proposto da gruppi e personalità vicine ai movimenti di protesta
studentesca. In questo contesto l’attore si avvicina alla dimensione
«Per me gli oggetti, in scena, sono vivi come sono vivi gli attori: gli oggetti sono attori
importanti» (E. Dante, La strada scomoda del teatro, intervista a cura di A. Porcheddu e P.
Bologna, in Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 64).
16 «La ricerca di verità dell’artista palermitana è condotta attraverso un teatro […] capace di
svelare, nel tempospazio di uno spettacolo, passioni e fatti, segreti e bugie, ricordi sommersi»
(A. Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. Mpalermu, Carnezzeria, Vita mia, cit., p. 14)
17 E. Dante, La strada scomoda del teatro, intervista a cura di A. Porcheddu e P. Bologna, in
Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 60.
18 «L’essenziale per noi è scoprire le nervature, applicare il nostro talento in un processo
artistico e allenarci tutti i giorni per mettere a disposizione di questa storia la nostra
esperienza di vita. Vogliamo entrare consapevolmente in un processo di autorialità per
generare le parole prima di pronunciarle»
(http://www.emmadante.com/sud-costa-occidentale/). Consultato il 7 marzo 2016.
19 Maringola è anche scenografo in Cani di bancata, Le pulle, Acquasanta, Il castello della Zisa,
Ballarini (la Trilogia degli occhiali è co-firmata dalla stessa Dante), Io, Nessuno e Polifemo e di
tutte le regie liriche della Dante (La muta di Portici, Feuersnot, Gisela!, La Cenerentola), eccezion
fatta per Carmen.
15
85
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
performativa di matrice politica ed entra in contatto con un sostrato teorico
nutrito dagli insegnamenti e dall’esperienza di Antonin Artaud e del
Living Theatre. Per Maringola, in questo periodo, non sembra possa
esistere nessun’altra possibilità di esperienza scenica se non quella
consumata all’interno di queste dinamiche che non si sviluppano sulla base
di una relazione mercificata tra l’atto creativo, il gesto performativo e il
‘pubblico’ e che puntano tutto, invece, su una relazione autentica con un
soggetto sociale-interlocutore. Qualsiasi altra forma di teatro – a cui l’attore
ha accesso da spettatore – è da considerarsi ‘già vista’, estetizzante o
compromissoria.
L’incontro con il Living Theatre, attraverso la frequentazione di alcuni
workshop, e l’esperienza in Germania con l’Alchemical Theatre,
formazione attiva fin dai primi anni ottanta che coniuga il gusto per la
contaminazione (teatro, danza, musica, cinema) alla performance gestuale,
consentono di entrare in contatto con una dimensione più strutturata
dell’evento scenico, innescando una maggiore curiosità verso la costruzione
drammaturgica del fatto performativo. Curiosità ulteriormente alimentata
dalla partecipazione a laboratori brevi e a sessioni di lavoro occasionali con
alcuni dei registi più attivi sul territorio partenopeo sul finire degli anni
novanta.
Il contatto con realtà ‘di gruppo’ organizzate sull’idea di una ricerca
comune e la frequentazione con registi che considerano il teatro – al di là
delle singole esperienze, più o meno legate al contemporaneo – come uno
strumento di costruzione scenica del racconto spingono Maringola a
fondare un collettivo di lavoro stabile con una propria sede operativa.
Nasce così Tutuguri, un ensemble che sorge dalle ceneri delle esperienze
universitarie e che approfondisce il discorso performativo in un’ottica
drammaturgicamente più compiuta.
Dopo aver preso uno spazio in vico Paradisiello, nel centro di Napoli,
organizzato come quartier generale ma anche come ‘cantina’ polifunzionale
in grado di accogliere anche proposte esterne al gruppo, Tutuguri sviluppa
e ‘mette in strada’ i suoi lavori.20 Tra la fine degli anni novanta e l’inizio del
In questa primissima fase il gruppo è ancora impegnato nella proposta di azioni figlie
dell’esperienza maturata con il teatro di strada. Tra queste si ricorda una performance
ispirata a Il teatro e la peste di Antonin Artaud: «Vestiti come appestati, e nella finzione lo
erano. Recitavano il ruolo di ammalati che alla fine muoiono in strada nella performance
liberamente tratta da «La peste» di Antonin Artaud, testo sacro del teatro di ricerca, e nuovo
cimento per il gruppo del Living Theatre Tutuguri di Napoli, ieri mattina in trasferta a San
Giorgio a Cremano. L'azione è durata 10 minuti, poi sono stati cacciati via. Spettacolo
sospeso dall' intervento di vigili e carabinieri. Incompresi e respinti dal loro palcoscenico che
era la strada, il mercatino rionale che ogni mercoledì si tiene tra via Recanati e via
Sandriana. «Anche insulti e botte», denuncia l' attore della compagnia Carmine Maringola.
Ma è stata la folla a scatenare la rivolta. «Fa troppa impressione», dicevano.«Così spaventate
i bambini», urlavano tutti. La performance consisteva nella simulazione dei sintomi della
peste fino alla morte di tutti gli attori. Scene forti, raccapriccianti. «Per questo è intervenuta
20
86
Salvatore Margiotta, Il paradigma dell’attore
duemila il gruppo comincia progressivamente a confrontarsi con la
scrittura e la direzione collettiva di ¿, Angolo di muro, Bombe di guerra, lavori
sempre incentrati su una fortissima componente performativa declinata sul
versante fisico-gestuale che però presentano motivi narrativi più spiccati e
denotano un’attenzione per il codice della scena maggiore rispetto al
recente passato. Il teatro infatti in questa fase non è più la strada, ma la sala
di alcuni dei principali spazi off della città: TNT Occupato, Officina 99,
Spazio Libero di Vittorio Lucariello. È questo il momento in cui Maringola
cerca di far convogliare le esigenze espressive del collettivo verso la sua
visione autoriale. Comincia a proporre idee e testi su cui fondare nuovi
percorsi progettuali, conduce buona parte delle attività laboratoriali, si
riserva il ruolo di regista in due spettacoli Le lacrime amare di Petra von Kant
e Jenin. Gli allestimenti non sembrano però appagare l’indole demiurgica di
Maringola, che nel frattempo ha anche conseguito la laurea in architettura
(2001).
La ‘tentazione’ registica, unita agli esempi artistici offerti dagli spettacoli
firmati dai maestri della scena contemporanea, ‘osservati’ da spettatore,
sembra fargli invece comprendere definitivamente la sua reale attitudine:
‘diventare’ attore, fare di questa vocazione il proprio mestiere. Quella
professionale è, però, una dimensione che Maringola avverte da subito
essere inconciliabile con buona parte delle esperienze maturate fino a quel
momento. C’è bisogno di un bagaglio tecnico diverso, come diverso deve
cominciare ad essere l’approccio alla pratica scenica e il lavoro sul testo:
non più riduzione-montaggio di suggestioni poetico-letterarie, come
nell’ultima fase di Tutuguri, ma un testo che nasce specificamente per la
scena o un ‘classico’. Nei primissimi anni del duemila, forte di queste
convinzioni, l’ex performer-studente inizia a prepararsi e a sostenere una
serie di provini dagli esiti non particolarmente felici. È lo scontro con una
realtà che pur affascinandolo dal punto di vista professionale in parte lo
demoralizza, in quanto esperienza da compiere ‘a freddo’, priva di un
tempo di gestazione durante il quale potersi confrontare con un discorso
poetico di fondo o assecondare una visione drammaturgica. Ad ogni modo,
dopo un periodo di duro lavoro, Maringola riesce finalmente ad ottenere
una scrittura. Ad ingaggiarlo è il Teatro Lelio di Palermo. Qui, l’attore ha
modo di seguire un percorso artistico più disciplinato, opposto a quello
sostenuto negli anni napoletani. I suoi strumenti di lavoro sono ora:
presenza del testo, rimandare le battute a memoria, impostazione, dizione,
intonazione. Strumenti applicati alla recitazione dei ‘classici’ (L’uomo, la
la polizia urbana», spiega il sindaco Ferdinando Riccardi. «I vigili aggiunge hanno solo
evitato il possibile panico per una performance che in un altro spazio non avrebbe creato
problemi». Lo spettacolo rientrava nel programma del «Maggio Solidale» organizzato dal
Comune di San Giorgio» (P. Russo, Recitano 'La Peste' scacciati come untori, «La Repubblica»,
3 maggio 2001).
87
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
bestia e la virtù di Pirandello, Romeo e Giulietta di Shakespeare, favole
riadattate), allestiti tanto in occasione di matinée, quanto per un pubblico
adulto.
Nel 2005 avviene l’incontro con Emma Dante, alla quale l’attore si legherà
sentimentalmente, preludio ad un quasi inevitabile rapporto di stretta
collaborazione. Dopo aver partecipato ai training della regista in qualità di
uditore, nel 2006 si unisce al gruppo di Sud Costa Occidentale e prende
parte al ciclo di laboratori ispirati a I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij
dai quali nascerà Cani di bancata. È l’occasione in cui Maringola realizza il
segmento più solido della sua formazione.
Il momento è propizio per nuovi innesti in compagnia: oltre alla presenza
di Manuela Lo Sicco, Sabino Civilleri e Gaetano Bruno, c’è bisogno di
reclutare nuovi elementi in quanto il disegno accarezzato dalla Dante è
quello di affrontare un lavoro sulla mafia scandagliandone gli aspetti più
disparati. Per far ciò, oltre a condurre sessioni in tutta Italia, la regista ha in
mente di organizzare un lavoro corale su coordinate diverse dalle occasioni
precedenti e soprattutto confrontarsi, per la prima volta, con un gruppo
numericamente più cospicuo.
La drammaturgia maieuticamente ordita dalla Dante ruota intorno al
personaggio di
Un uomo qualunque [che] riceve un favore da un mafioso camorrista […], cioè
un falso certificato grazie al quale entra nelle ferrovie fingendo un difetto di
vista. Deve portare gli occhiali, ma con quelli non vede e provoca la morte di
un collega. In cambio del lavoro gli si chiede di partecipare a una riunione
della cosca perché la mammasantissima vuole scombinare le gerarchie e
dimostrare che chiunque può farne parte.21
Lo spettacolo fa leva sul personaggio portato in scena da Manuela Lo Sicco,
Mammasantissima,
una madre padrona, una dea feroce che giudica e manda e che raccoglie
attorno a sé i suoi figli, cioè i suoi affiliati, offrendo loro un banchetto di carni
crude, sul grande tavolo in verticale, una vera e propria cupola mafiosa, dove
tutti si siedono secondo un rigido ordine che può essere invertito se si cade in
disgrazia22
Messa in scena dalla «livida componente liturgica»23 – nello spettacolo sono
infatti presenti ‘riletture’ dei dieci comandamenti, del Padre nostro (Madre
nostra per l’occasione) e del rito eucaristico, ultima cena condita da rutti e
21 E. Dante, Io, le donne e la mafia, intervista a cura di P. Polidoro, «Il Messaggero», 27
novembre 2006.
22 M. G. Gregori, La mafia è una donna anzi una mamma sanguinaria e spietata, «l’Unità», 28
novembre 2006.
23 R. Palazzi, La mafia senza coppole e gessati, «Il Sole 24 Ore», 3 dicembre 2006.
88
Salvatore Margiotta, Il paradigma dell’attore
sputi24 – Cani di bancata frantuma i luoghi comuni sulla criminalità
concentrandosi su «un crudo ed emblematico ritratto della mafia di oggi,
del cerimoniale e delle nuove strategie di un suo vertice».25
Carmine Maringola – anche scenografo dello spettacolo – è Gegè ‘u
farmacista, uno dei nove figli-appartenenti al clan. Con l’obiettivo di
accordare la propria parte al disegno corale, l’attore fa leva su una
gestualità agile e aggressiva – come quella osmoticamente riflessa da tutti
gli affiliati – che trova il culmine nelle sequenze più squisitamente
coreografiche. In completo da uomo e cappello da donna a falda larga anni
cinquanta Gegè partecipa in qualità di pedina alla grottesca Mafiopoli
organizzata da Mammasantissima, strategico gioco di società-scontro tra gli
esponenti del clan per avvicinarsi al trono, occasione in cui i diversi ‘cani’
hanno la possibilità di raccontare l’esperienza della propria escalation e il
ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione.
Maringola elabora una partitura fatta di corse ai piedi di Mammasantissima
e acrobatici balzi sulla sedia. Il suo racconto, incentrato sulle relazioni avute
con i trafficanti di mezzo mondo e sul commercio di innumerevoli sostanze
stupefacenti, segue un ritmo serratissimo che si salda alle intonazioni
‘sgarbate’ del dialetto napoletano e alla gestualità esasperata.
Nel 2007 Maringola partecipa all’Alkestis, una produzione del Luzerner
Theater sulla base di un progetto di riscrittura dell’opera euripidea firmata
da Kurt Steinmann e Anke Zimmerman, sempre firmato dalla Dante. La
mano della regista è particolarmente riconoscibile nell’essenzialità
dell’impianto scenico (un enorme tavolo rotondo e la presenza di fiori e
cibo), per la compresenza di musica classica e pop-mainstream (da Mozart
ai Chemical Brothers)26 e l’impiego di Sabino Civilleri e Carmine Maringola
– che interpretano rispettivamente Eracle e Thanatos – all’interno di un cast
composto da attori di lingua tedesca. La loro presenza serve a creare
contrapposizione drammaturgica tra il mondo degli umani e quello degli
dèi, contrapposizione soprattutto linguistica evidenziata dall’uso del
tedesco da un lato e del napoletano e del siciliano dall’altro.
Per Maringola lo spettacolo rappresenta più che altro una sorta di ritorno
all’impostazione seguita al Lelio: lavora sul testo traducendo le battute di
Thanatos, recita in napoletano e l’esuberanza fisica, tipica di Sud Costa
Occidentale, è limitata a qualche momento più coreografico.
Dopo questa parentesi più ‘accademica’ nel 2008 lavora assieme alla Dante,
Civilleri e Lo Sicco all’apertura dello spazio in Via Polito 5 a Palermo, La
24 L. Dalisi, Messa in scena della mafia. Cani di bancata: il metodo maieutico di Emma Dante,
Edizioni Dantes & Descartes, Napoli, 2009, p. 43.
25 Emma Dante: io siciliana vi dico che la mafia è donna, intervista a cura di Rodolfo Di
Giammarco, «la Repubblica», 31 ottobre 2006.
26 Cfr.: C. Russo, Costruzione dell’oralità nell’operazione teatrale di Emma Dante, in AA. VV.,
L’oralità sulla scena. Adattamenti e transcodificazioni dal racconto orale al linguaggio del teatro,
Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli, 2015, p. 216.
89
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Vicaria, che diverrà fin da subito il quartier generale di Compagnia Sud
Costa Occidentale, all’insegna dell’autogestione e dell’autofinanziamento.
La dimensione della sede stabile, cercata fin dai tempi di Tutuguri,
unitamente a un progressivo coinvolgimento nelle attività pratiche,
favorirà la rapida maturazione artistica di Maringola. L’apertura de La
Vicaria coinciderà con la partecipazione al nuovo progetto sul tema della
transessualità e della prostituzione e la presenza nei laboratori preparatori
alla Carmen, prima regia lirica della Dante.
Il 2009 è l’anno di debutto de Le Pulle, operetta amorale, «fiaba
trasgressiva»27 in cui la Dante sperimenta la canzone – con le musiche
originali di Gianluca Porcu – come trait d’union tra le diverse storie
raccontate. Il motivo narrativo è il mondo della transessualità affrontato
come in un viaggio onirico compiuto dallo spettatore tra le pieghe della
prostituzione e condotto da Mab, ‘regina’ delle fate danzante, cantante e
parlante, interpretata dalla stessa regista.
Il disegno corale strutturato sulla giornata tipo delle pulle (trucco, cibo,
vestizione, svestizione) è frantumato dagli ‘assolo’ di ciascuna protagonista
e inframezzato dai numeri musicali.
Maringola, anche scenografo come in Cani di bancata, porta in scena Stellina,
travestito che fantastica della sua vita con l’innamorato Rocco, sognando
una famiglia e una normalità impossibili.28 La partitura fisica oltre a
sottolineare le battute, rafforzandone spontaneità e crudezza, sfocia
spessissimo in momenti coreografici scattanti, puntando su una estrema
tensione muscolare. La recitazione gioca su una spossante e incalzante
logorrea che impedisce al personaggio di avere un dialogo reale con le altre
pulle. Termini e abbreviazioni di derivazione inglese si mescolano a un
napoletano che pesca a piene mani anche dalla cultura pop di stampo
adolescenziale, mentre il registro recitativo oscilla tra il trasognato e il
puerile, eccezion fatta per il momento in cui si verifica un aspro litigio con
Ata, momento in cui Stellina tira fuori una mascolinità – vocale e fisica –
fino ad allora insospettabile. Asprezza e aggressività fisico-gestuali sono
tratti che emergono progressivamente giungendo al culmine nel quadro del
matrimonio con Rocco (Mab-Emma Dante con una calza sul viso e un
cappello): l’inginocchiarsi davanti al sacerdote, la bocca spalancata in una
sorta di urlo raggelato sulle note della marcia nuziale, il segno della croce
ripetuto nervosamente, la firma degli atti.
Dopo aver interpretato, alla fine del 2010, il ruolo del prete-guida in
Carmen, nel 2011 Maringola è ‘O Spicchiato in Acquasanta, primo capitolo
della Trilogia degli occhiali, trittico che ha come minimo comun
R. Palazzi, Fiabe da incubo per squillo fatate, «Il sole 24 ore», 15 febbraio 2009.
Cfr.: M. Di Caro, La giostra sfrenata delle "Pulle" che nasconde un abisso di dolore, «la
Repubblica», 4 agosto 2009.
27
28
90
Salvatore Margiotta, Il paradigma dell’attore
denominatore la presenza degli occhiali, ‘inforcati’ da tutti i personaggi
«per difendersi dal mondo e per guardarlo come meglio credono».
Protagonista dello spettacolo – secondo monologo dopo Il festino (2007)
nella teatrografia della Dante – è un mezzo mozzo, imbarcato da quando
aveva 15 anni, ancorato al palcoscenico come alla prua di una nave
immaginaria. Lasciato dall’equipaggio sulla terraferma – che «per lui è
‘n’illusione» – «l’uomo rivive l’abbandono» con «le voci della ciurma, del
capitano, [che] gli rimbombano nella testa».29
Maringola disegna il personaggio di un reietto innamorato del mare – e per
questo ritenuto folle – nonostante le prese in giro e i soprusi da parte del
personale di bordo, capace di slanci lirici visionari, teneri e malinconici:
Aggio visto a barriera corallina… – recita – e ‘u sole dirimpetto alla luna ca si
lanciavano i raggi, li annodavano e li facevano scennere dintra ‘o mare… aggio
visto ‘o mare ca pigliava colore… e un pesce spada ca teneva due spade… e ‘na
medusa gigantesca ca s’arravugliava nei raggi d’o sole e d’a luna…. e ‘o pesce
palla ca dintra d’isso teneva futuro e passato… aggio visto il polipo arlecchino
coi tentacoli ‘i tutti ‘i colori e i pisci tropicali ca ci ballavano sopra e sotto… e il
Cristo di Rio, aggio visto, ca si tuffava dal Corcovado, a petto ‘i palomma….
aggio visto l’atro lato d’o munnu…. ‘o Giappone, a ro steveno ‘i pisci cu l’occhi
a mandorla…. e un galeone di tre secoli fa, chino ‘i gente che ballava e che
cantava i canzoni ‘i n’a vota… e n’iceberg…. enorme… ca si scioglieva in
lacrime di cristallo, dintra all’abisso d’o mare….30
Acquasanta è figlio di un lavoro che Maringola affronta in maniera totale e
di una ispirazione che si riflette in momenti di improvvisazione pura
talmente densi e ricchi di motivi narrativi da spingere la Dante a scegliere
nuovamente la soluzione del monologo, nonostante il progetto di partenza
prevedesse la presenza di un altro personaggio.31 L’attore, oltre a costruire
la parte del protagonista, dà vita ai personaggi del marinaio e del capitano,
ordendo un racconto articolato capace di restituire la complessità della
rievocazione di quanto vissuto in mare da ‘O Spicchiato, sempre al limite
tra il ricordo e la proiezione. Utilizzando in maniera espressiva tre ancore
che calano dall’alto, legate alle caviglie e in vita, Maringola anima un
personale teatrino di ‘pupi’ che mette in scena la grottesca quotidianità, tra
toni sgradevoli e ironia imbelle, della vita di questo equipaggio. Nei
momenti di relazione con la ciurma, la partitura fisica è impostata su una
composizione gestuale fatta di movimenti che ricordano quelli delle
marionette: bruschi, quasi improvvisi, a scatto e poco fluidi. Quando il
racconto torna, invece, in prima persona l’elemento fisico-gestuale recupera
Dal programma di sala di Acquasanta.
Ivi.
31 I primi laboratori furono infatti organizzati con la presenza di un altro attore, Onofrio
Zummo, poi dirottato su Il castello della Zisa, un altro segmento del progetto Trilogia, proprio
in virtù dell’esuberanza creativa espressa da Maringola fin dalle prime sessioni.
29
30
91
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
fluidità, non rinunciando a momenti più puramente coreografici come nella
scena della tempesta,32 in grado di innescare complicità ed empatia nello
spettatore.
Il registro vocale passa dalla impostazione roca, quasi strozzata e severa
dell’equipaggio a quella dimessa, impastata e a tratti balbettante, intenerita
e naϊve del protagonista che si lancia in tirate evocative e malinconiche,
dichiarazioni d’amore al mare e numeri musicali in cui canta Maruzzella e
una struggente Indifferentemente.
Nel 2012 Maringola prende parte al progetto di ripresa da parte della Dante
di Medea. Il senso di insoddisfazione della regista per il risultato finale del
lavoro andato in scena nel 2004, interpretato da Iaia Forte e Tommaso
Ragno, ha prodotto una tensione ininterrotta verso la tragedia di Euripide
che la Dante prova, a distanza di anni, a ‘rifare sua’ nuovamente
coinvolgendo gli attori di Sud Costa Occidentale e ripensando la
scenografia in maniera estremamente scarna ed essenziale. Nasce così Verso
Medea, spettacolo-concerto che rivede, come nella prima versione, la
presenza in scena dei musicisti Enzo e Lorenzo Mancuso. In una Corinto
ritratta come un paese del sud Italia, Medea – interpretata da Elena
Borgogni – si vendica dell’abbandono di Giasone uccidendo il loro unico
figlio, appena messo al mondo, negando così ogni «possibilità di stirpe alla
città».33
Maringola compare nel doppio ruolo di una Matriarca e di Giasone. Come
rispecchiato dall’andamento dello spettacolo, la sua performance oscilla tra
il registro fisico-vocale con il quale abitualmente lavora l’attore e quello più
squisitamente interpretativo. Nei panni di una delle donne di Corinto la
sua recitazione è estremamente fisica. Alla pari del coro, l’attore propone
una partitura di gesti spediti, sussulti nervosi, come ad esempio nella scena
del parto della protagonista, vissuto dalle corinzie come una minaccia.
Quando interpreta Giasone l’impianto recitativo si attesta, invece, su
un’impostazione di più ampio respiro, rifacendosi a un registro lirico di
natura relativamente classica.
Un intervento di stampo interpretativo ancora una volta, come per Verso
Medea, su un testo preesistente, è il contributo richiesto a Maringola nel
2014 per il suo coinvolgimento nel successivo Io, Nessuno e Polifemo, nel
quale ricoprirà il ruolo di Odisseo. Lo spettacolo nasce come
teatralizzazione di un testo scritto dalla Dante nel 2008 in occasione del
32 ‘O Spicchiato è in ‘acqua’ e prova a risalire sulla nave dopo essere finito in mare. Il
capitano lo accusa di essere caduto perché sportosi incautamente dal parapetto, mentre lui
afferma di aver perso l’equilibrio per controbilanciare la virata.
33 Citato in R. Di Giammarco, La Medea di Emma Dante: "Una madre che è donna-bambina, la
tragedia è nella mia Sicilia", “la Repubblica”, 13 marzo 2014. Nella rilettura offerta dalla
Dante, Medea mette al mondo un solo bambino e non due come nel testo di Euripide.
92
Salvatore Margiotta, Il paradigma dell’attore
reading-evento Interviste impossibili Live, diretto da Gabriele Vacis.34
All’origine dell’operazione vi era la ripresa di un format radiofonico in
onda su Radio Rai tra il 1974 e 1975 nel quale attori come Paolo Poli, Mario
Scaccia, Carmelo Bene – per citare qualche nome – interpretavano le
‘interviste’ (impossibili perché frutto dell’immaginazione creativa) scritte
da diversi autori come Italo Calvino, Edoardo Sanguineti, Umberto Eco,
Alberto Arbasino realizzate a personaggi storici, letterati, o artisti. Per
questa nuova e singolare riedizione Emma Dante sceglie di ‘intervistare’
Polifemo (incarnato da Salvatore D’Onofrio già in scena in Cani di bancata e
Verso Medea), il ciclope protagonista del canto IX de l’Odissea, raggiunto
nella sua spelonca che successivamente scopriremo essere in realtà il suo
stesso occhio andato distrutto.35
L’operazione meta-riflessiva sul mito e la sua attualità diventa metateatrale nel settembre 2014 in occasione del 67° Ciclo Spettacoli Classici al
Teatro Olimpico di Vicenza che offre l’opportunità alla regista, in qualità
anche di direttrice artistica della manifestazione, di trasformare in
spettacolo Io, Nessuno e Polifemo. Oltre ad immaginare un lavoro più
complesso dal punto di vista scenico, avvalendosi delle coreografie di
Sandro Maria Campagna e delle musiche eseguite dal vivo da Serena
Ganci, la Dante pensa di introdurre anche il personaggio di Odisseo – citato
ma mai presente nel testo originale – allo scopo di realizzare un disegno
drammaturgico più articolato. Il conflitto tra le dramatis personae, da sempre
uno dei tratti distintivi della scrittura teatrale della regista, levigato e
appena accennato dalla relazione intervistatore/narratore-ciclope nella
versione reading, viene sviluppato a partire dal lavoro con Maringola. Pur
avendo un disegno di partenza, il contributo dell’attore è determinante per
far rivivere in scena lo ‘scontro’ insanabile tra il re di Itaca e Polifemo. Ad
un ciclope bonario, raggirato, quello ritratto sulla pagina dalla Dante e
portato sul palco da D’Onofrio – vittima di un’effrazione, che coglie in
flagrante i naufraghi con «caciotte al collo tipo collane hawaiane e gli
agnellini al guinzaglio come cani da passeggio, pronti a spostarsi da
un’altra parte per continuare il rave» – si contrappone l’Odisseo di
Maringola: arrogante, spavaldo, macho, «bello, giovane e forte»,
eccessivamente sicuro di sé, che confonde la Dante con Dante Alighieri. 36
In perfetto accordo con le altre presenze sceniche il personaggio messo a
punto dall’attore – diversamente da ‘O Spicchiato o Stellina – non esprime
Organizzato all’Auditorium Parco della Musica di Roma nel 2008 (4 febbraio, 10 marzo, 26
maggio), l’evento vede la partecipazione di Paolo Bonacelli, Roberto Herlitzka, Vittorio
Sermonti, Carlo Lucarelli, Andrea Camilleri, Alessandro Baricco, Vinicio Capossela,
Gianrico Carofiglio, oltre alla stessa Emma Dante. Il testo è pubblicato in Corpo a corpo –
Interviste impossibili, a cura di V. Alferj, B. Frandino, Milano, Einaudi, 2008.
35 Cfr.: C. Russo, Costruzione dell’oralità nell’operazione teatrale di Emma Dante, cit., p. 218.
36 Come nella versione reading del 2008, la Dante è attrice nei panni di se stessa in qualità di
intervistatrice.
34
93
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
la cifra fisico-gestuale emersa nelle esperienze precedenti. Come Polifemo e
la stessa Dante, Odisseo è in completo nero e camicia bianca (nel suo caso
sbottonata). Quando non ha le mani in tasca, i suoi gesti sono in funzione
delle battute, servono cioè a sottolineare e rafforzare la dimensione
espressiva del dato verbale. Maggiore dinamismo e vigore, tipici del lavoro
di Sud Costa Occidentale, si trovano nella coreografia di matrice televisiva
– con tanto di partner-ballerine in abiti succinti, paillettes e parrucche
colorate – composta da pose pelviche e piroette, frutto di un momento di
improvvisazione emerso dal lavoro sulla parte, proposto da Maringola e
formalizzato da Campagna.
L’approccio risponde a precise esigenze drammaturgico-spettacolari
dettate dalla Dante e riviste con l’attore sia durante la fase di scrittura
testuale, sia in quella relativa a prove e allestimento. Una volta ricevuto il
copione, Maringola traduce le battute in napoletano, ricorrendo a un
vocabolario anche poco corrente, e si concentra sull’impostazione del
registro recitativo attraverso il quale accordare al suo Odisseo toni di
sfrontatezza misti a licenziosità.
Dopo due episodi più interpretativi, l’attore torna ad affrontare momenti di
gestazione dal più ampio respiro, riprendendo il consueto lavoro
laboratoriale di costruzione della parte nel successivo Operetta burlesca.
L’omosessualità è il tema al centro della nuova operazione condotta dalla
Dante, motivo già affrontato in Le Pulle su basi completamente diverse.
Mentre nello spettacolo del 2009 la dimensione tragica scaturiva infatti
dall’incompatibilità tra la conduzione della propria vita da travestito e il
vissuto quotidiano (‘la normalità’), qui il tormento del protagonista è
dettato dall’impossibilità di manifestare – ancor prima di viverla – la
propria sessualità.
Il protagonista è Pietro, quarantenne che convive forzatamente con i
genitori in un paese della Campania. «L’unica sua libertà è scappare di
mercoledì a Napoli: per far shopping e ballare, ma soprattutto per
camminare», perché anche «camminare per strada è un problema per chi
nasce in un paesino».37 Dopo lo shopping rientra a casa, si chiude in
camera, mette su la musica, si veste da donna – indossando gli abiti
acquistati – e balla, assaporando così piccoli scampoli della sua vera
natura.38
«Varietà» e nel contempo «spogliarello dell’anima»39, Operetta burlesca
esprime un perfetto equilibrio tra momenti brillanti e divertenti e passaggi
stillanti disincanto e solitudine, soprattutto nel finale quando si manifesterà
Dal programma di sala di Operetta burlesca.
Il gioco della trasformazione, caro al burlesque, è ben incarnato dai segni scenici,
essenziali come sempre. I vestiti appariscenti sono sistemati su quattro bambole gonfiabili,
posizionate sul fondo della scena, mentre sul proscenio si trova una lunghissima fila di
scarpe.
39 Dal programma di sala di Operetta burlesca.
37
38
94
Salvatore Margiotta, Il paradigma dell’attore
con palese brutalità l’impossibilità di vivere alla luce del giorno – e non nei
termini di storia parallela tra amanti – l’amore per Ciro, titolare di un
negozio di scarpe, che si rivelerà essere sposato da anni.40
La partitura gestuale passa dai movimenti sciolti, naturali e immediati dei
dialoghi tra Pietro e i genitori – entrambi portati in scena da Francesco
Guida – o degli assolo, nei quali l’attore sfrutta massicciamente la sua
presenza in proscenio, a quelli più energici e vivaci delle coreografie
all’interno dei numeri musicali, momenti nei quali il protagonista proietta il
suo io reale e i propri desideri.41 Quando la narrazione segue la storia
familiare e individuale di Pietro il registro recitativo si attesta su toni
sommessi, affabili, con una lievissima inflessione effeminata, elementi
capaci di tratteggiare un personaggio bonario e un po’ sprovveduto con cui
è difficile non stabilire una forte empatia, mentre il racconto degli incontri
con Ciro viene riportato attraverso l’utilizzo del falsetto acuto e incalzante
caro a Stellina. La dialettica tra queste due modalità espressive è
evidenziata dall’alternanza del ritmo della partitura gestuale. Nel momento
in cui Pietro racconta alla madre del suo amore per Ciro, la sua fisicità è
assolutamente controllata e la recitazione si attesta su toni franchi e
sentiti.42
Dopo aver preso parte in qualità di docente alla Scuola dei mestieri dello
spettacolo del Teatro Biondo Stabile di Palermo, condotta dalla Dante,
Maringola è attualmente impegnato nel progetto lirico Macbeth di Giuseppe
Verdi, del quale curerà la scenografia, e nei laboratori preparatori al nuovo
lavoro teatrale Bestie di scena, il cui dato di partenza è il cliché attorico
all’interno dell’esperienza portata avanti in Compagnia Sud Costa
Occidentale nei precedenti spettacoli da ciascun partecipante.43
Il primo studio dello spettacolo, intitolato Principe di nome Azzurro di cognome, approntato
per un Palermo Pride nel 2012, presentava un impianto totalmente diverso dalla versione
finale. La struttura e il genere si rifacevano apertamente all’operetta. Francesco Guida non
interpretava, come accade invece nella versione definitiva, alternativamente il ruolo dei
genitori, ma era una sorta di presentatore d’avanspettacolo che introduceva la storia del
protagonista, storia raccontata in prima persona da Pietro senza mostrare particolari qualità
né nella danza, né nel canto pur essendo paradossalmente il protagonista di una vicenda
narrata attraverso musica e numeri coreografici.
41 Vestito da donna e con tacchi vertiginosi Pietro danza con il suo alterego-riflesso
femminile (Viola Carinci).
42 Questo progressivo e metaforico annichilimento raggiunge l’acme nel finale: Pietro è
nudo, seduto in silenzio e immobile, mentre sul proscenio la danzatrice-alterego esegue la
coreografia che il protagonista propone ad inizio spettacolo.
43 Ciascun attore riprende la parte che ha caratterizzato il proprio lavoro nel teatro di Emma
Dante, il proprio ‘cavallo di battaglia’: Sabino Civilleri riprende, ad esempio, la parte della
scimmia de La scimia, mentre lo stesso Maringola è alla prese con la ‘vaiassa’ alla base
dell’esperienza creativa compiuta su Stellina.
40
95
Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Carmine Maringola
La costruzione del personaggio nel teatro di Emma Dante
Intervista di Salvatore Margiotta
Raccontami della tua formazione da attore.
La mia formazione non è di stampo accademico. Mi sono avvicinato al
teatro negli anni in cui frequentavo l’università, mentre studiavo presso la
facoltà di architettura. Culturalmente parlando, è un mondo che mi ha
sempre affascinato, ma dal punto di vista pratico sono entrato in contatto
con quella che potremmo definire ‘la pratica scenica’ nel periodo delle
occupazioni universitarie, durante i primissimi anni novanta. Cominciai a
frequentare alcuni collettivi di teatro ‘politico’ che, parallelamente
all’organizzazione delle manifestazioni di piazza, ragionavano anche su
come veicolare in maniera efficace e creativa il dissenso giovanile e
studentesco. Era un fermento nel quale i nomi di riferimento erano Artaud
e il Living Theatre soprattutto.
A me colpiva l’idea di fare teatro senza aver bisogno del contenitore
convenzionalmente e istituzionalmente
riconosciuto, così come mi
interessava sempre più approfondire l’aspetto secondo il quale l’atto
creativo poteva anche essere qualcosa di non esteticamente accattivante, nel
quale l’importanza capitale era rappresentata dall’attitudine e dall’urgenza
espressiva.
Nel tempo si era venuto a creare un vero e proprio gruppo di lavoro che,
spostando sempre più l’accento sulla preparazione e sulle questioni
creative, cercava di mettere al centro della propria attività il rapporto tra
matrice performativa e elemento di protesta. Erano momenti, quelli
dell’esibizione – quando, una volta scesi in strada, si proponeva la
performance – che tenevano insieme lo studio urbanistico e sociale della
città, la fotografia, l’happening, il reading.
Dopo i primi contatti con gruppi più ‘consapevoli’ – nel frattempo avevo
seguito dei seminari svolti dal Living, preso parte ad alcuni laboratori di un
gruppo tedesco che si chiamava Alchemical Theatre con Martin Reckhaus,
con loro sono stato a Monaco e ad Amburgo – mi sono sentito sempre più a
mio agio in questa veste di performer, o comunque di studente della facoltà
di architettura sempre più impegnato e coinvolto con il teatro. Cominciavo
ad entrare di più nei meccanismi di costruzione e anche di formalizzazione
di un evento scenico e la mia curiosità era sempre più stimolata, infatti
provavo a partecipare a tutti i workshop intensivi di cui riuscivo ad avere
notizia.
© Acting Archives
www.actingarchives.it
96 Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
Mentre frequentavi workshop e laboratori, cominciavi a lavorare anche
episodicamente con i registi e gli artisti che incontravi?
No. Ero totalmente concentrato su di me, curioso di scoprire cosa realmente
mi interessava fare all’interno del contesto teatrale. Era come se mi fossi
messo alla ricerca di un maestro che dovevo ancora trovare.
E in questa ricerca ti impegnavi anche in qualche forma di reale attività pratica?
Sì, perché oltre a seguire workshop e laboratori, con un gruppo di amici e
conoscenti mettemmo su una formazione il cui nome era ispirato a un
momento di Per farla finita col giudizio di Dio di Antonin Artaud: Tutuguri.
Avevamo uno spazio nostro, un luogo minuscolo in vico Paradisiello,
completamente gestito da noi, dove organizzavamo corsi di yoga,
ospitavamo laboratori, e parallelamente portavamo le nostre cose negli
spazi off presenti a Napoli: Spazio Libero, TNT Occupato, Officina 99. In
questa fase è cominciato anche un momento di confronto serrato con tutto
ciò che significa il ‘fare teatrale’ perché una volta che ci davano uno spazio,
da quel momento eravamo noi a fissare un minimo di piano luci, stabilire
l’intervento o meno della musica o del sonoro, ragionare sulla presenza di
oggetti scenici o elementi scenografici, decidere come essere vestiti in scena.
Era una novità: il confronto con il luogo chiuso, il buio, il pubblico.
Insomma era la prima volta che mi trovavo ad affrontare le questioni della
formalizzazione in senso stretto e del contenitore scenico, per quanto
sicuramente non paragonabile al ‘teatro’, alla macchina produttiva che tutti
conosciamo.
Come gestivi, in questa fase, la vocazione teatrale in relazione alla formazione
professionale rappresentata dagli studi d’architettura? Avevi deciso di dedicarti al
teatro completamente?
Nel frattempo mi ero laureato. Anche con il massimo dei voti. Insomma,
ero architetto. Però, già verso la fine del percorso di studi, avevo capito che
non era ciò che volevo fare. Infatti, subito dopo, cominciai a fare provini
come attore con esiti non incoraggianti, ma dopo poco riuscii a trovare una
scrittura presso un teatro palermitano, il Teatro Lelio, dove si
organizzavano matinée per i ragazzi delle scuole, ma anche repliche per un
pubblico adulto: sei mesi di spettacolo all’anno, tre testi a stagione, che mi
indussero a sentire l’odore della professione.
Tornando al tuo primo gruppo, Tutuguri, hai ricordi più precisi di quella
esperienza?
97
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Non era la ‘professione’. Era ancora la ‘rivoluzione’: la performance come
atto politico, provare a ‘cambiare il mondo attraverso l’arte’. Ma in fondo è
stata un’esperienza che mi ha permesso di capire molte cose, al di là
dell’assenza di disciplina. Ad un certo punto ebbi anche la pretesa di fare il
regista, prima preparando Le lacrime amare di Petra von Kant di Fassbinder,
poi presi un testo molto bello di Tahar Ben Jelloun, Jenin, e lo
rappresentammo all’Albergo dei Poveri. Un’esperienza che ricordo con
piacere per l’entusiasmo e per la presenza dello stesso autore, che mancava
da Napoli da molti anni, ma non propriamente per il risultato artistico.
Ci sono spettacoli visti in questo periodo che pensi abbiano inciso sulla tua
formazione?
Amleto, la veemente esteriorità della morte di un mollusco della Socìetas
Raffaello Sanzio rappresentò un’autentica folgorazione. Lì ho capito che
c’era qualcuno in grado di raccogliere la lezione di Artaud, declinarla
secondo esigenze assolutamente personali e riproporne la potenza.
Seguivo anche Arturo Cirillo. La sua Piramide di Copi mi aveva dato la
percezione di un teatro onesto in grado di conciliare una certa tensione
ideologica alle esigenze produttive del teatro. Ebbi modo di apprezzare
anche La tempesta di Davide Iodice.
Di Emma Dante avevo visto mPalermu e Carnezzeria e seguivo anche Latella,
in particolar modo avevo apprezzato tantissimo I Negri e Querelle di Genet.
Hai citato alcuni dei registi napoletani tra i più importanti. Per un attore campano
il rapporto con il teatro napoletano è qualcosa di ineludibile: penso soprattutto a
molte riprese di Eduardo. Nella tua esperienza attorica hai maturato un rapporto
con la tradizione teatrale napoletana?
Da un lato ho instaurato un rapporto di natura territoriale: seguivo molto le
programmazioni del Teatro Nuovo e di Galleria Toledo, dove ho visto e
apprezzato il lavoro dei registi che citavo. Riguardo a Eduardo, da
bambino, credevo addirittura di essere uno suo parente [risate], perché
Gino Maringola, l’attore che interpreta Pasqualino in Natale in casa Cupiello,
era uno zio di mio padre e quando mi portavano a teatro ai miei occhi i
limiti tra la vita reale e la scena non erano perfettamente definiti. Tornando
alla domanda, di sicuro il mio primissimo approccio da spettatore è stato
con il teatro di Eduardo, ma – se non per un discorso di mera fascinazione
per quel mondo – non ha avuto alcun ruolo formativo sul mio percorso,
anzi proprio perché in un certo senso ‘imposto’ dalla famiglia l’ho
metabolizzato come un elemento dal qual rifuggire con decisione fin dagli
anni dell’adolescenza.
A Palermo, invece, cominci a fare l’attore professionista.
98
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
Sì, c’era stato un passaggio durante le battute finali dell’esperienza con
Tutuguri. Avevo capito che non mi interessava provare a fare l’autore di
teatro, cioè il regista, costruire una drammaturgia scenica, organizzare il
lavoro. Sentivo forte il richiamo della dimensione performativa, e di quel
processo di trasformazione, fisica e emotiva, che in generale l’attore innesca
sia durante le prove, sia quando è in scena. E anche per una certa tendenza
all’esibizionismo [risate]. Sopratutto, però, avevo anche cominciato a capire
di aver bisogno di un maestro. Avevo abbandonato quell’atteggiamento
tracotante che non mi aveva permesso di apprezzare una serie di
esperienze proposte da altri, dai contemporanei, e che invece mi aveva
ottusamente fatto infognare in una serie di schemini che mi ero creato sulla
base delle suggestioni care alla rivoluzione teatrale anni settanta.
Un modo totalmente nuovo di considerare il tuo impegno a teatro.
Il fatto di considerare la scena come una dimensione professionale in cui
realizzarsi, mi entusiasmava e mi metteva a contatto con cose che prima, in
fondo, contestavo senza averle conosciute realmente: studiare la dizione,
lavorare su un testo, l’intonazione, prove tecniche, tempi precisi erano tutti
elementi che stavo cominciando a conoscere sul serio e che
rappresentavano degli strumenti di lavoro necessari.
Ed è durante questo periodo palermitano che conosci Emma Dante?
Sì. Conoscevo il suo teatro da spettatore e fin da subito nei suoi lavori ho
riconosciuta l’aura del maestro che mi auguravo di incontrare. Lei,
Castellucci, Brook erano per me in quegli anni artisti di cui ammiravo
l’opera, il discorso e ai quali avrei potuto affidarmi completamente.
Segnavano una via: ai miei occhi riuscivano a fare la rivoluzione restando a
teatro, erano in grado di utilizzare il teatro contestandone gli aspetti più
corrivi (la supremazia del testo, della dizione), ed erano in grado di farlo
avendo successo, senza sacrificare nulla dell’integrità del proprio
approccio.
La fortuna ha voluto che in una delle repliche al Lelio, Emma si trovasse tra
il pubblico. Era il 2005, si trattava di un Romeo e Giulietta in cui io facevo
Mercuzio.
Come è stato il primo approccio?
Io ero interessato, come dicevo, tantissimo al suo lavoro, ma per un anno
abbiamo preso a frequentarci non pensando assolutamente a un’ipotesi di
unione artistica. Anzi, dopo esserci legati sentimentalmente, pensando
sopratutto a salvaguardare la nostra storia, decidemmo, promettendocelo,
99
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
che non avremo mai lavorato insieme. Fu inevitabile, però, entrare in
contatto con il quotidiano di Compagnia Sud Costa Occidentale: il lavoro, i
laboratori, l’immaginario dispiegato e così, occasionalmente, ho cominciato
anch’io a prendere parte a qualche sessione.
Quando ha avuto luogo la tua prima partecipazione concreta al lavoro della
compagnia?
In occasione di Cani di bancata. Emma aveva cominciato i primi laboratori al
Palladium, a Roma, avendo come riferimento I fratelli Karamazov. Io lo
rilessi in quel periodo e durante un laboratorio a Torino fui invitato proprio
da Emma a partecipare. Ero tesissimo: l’idea di trovarmi dentro ciò che
avevo visto da uditore devo ammettere che mi spaventava. Mi convinsi e
senza nessuna forzatura decidemmo che alla fine potevo far parte di quel
cast. Il laboratorio andò bene, poi però durante le prove ebbi difficoltà a
capire come potesse diventare ‘spettacolo’ ciò che avevo sperimentato
durante la costruzione. Non mi era chiaro come potesse formalizzarsi la
spontaneità dell’improvvisazione. Cercai, sulle prime, di vivere le prove in
maniera più fredda, come quando al Lelio provavo le mie battute,
aspettando indicazioni precise che non giunsero mai, ma subito capii che
non era possibile perché vedevo gli altri viverle in maniera diversa.
Ma in maniera più concreta, cosa pensavi fosse inconciliabile?
È difficile da spiegare. Il momento delle prove, successivo alla fase
laboratoriale, è un momento in cui da un lato riprendi ciò che hai proposto,
ripulito, ricontestualizzato e riplasmato da Emma, e dall’altro questa
riproposizione non è sterile. Devi tenere sempre aperta una possibilità
nuova, perché anche in questa fase potrebbe arrivare un’indicazione,
un’imbeccata che non solo è in grado di modificare la partitura attorica, ma
che può anche essere capace di ridefinire drammaturgicamente alcuni
elementi a cui è ancorato il personaggio.
Durante le prove per Cani di bancata non riuscivo a tenere aperte queste
‘parentesi’ senza sconfinare nell’improvvisazione pura durante il processo
di formalizzazione. Mi aspettavo delle indicazioni precise che non sono mai
giunte perché non fa parte del modo di intendere la regia di Emma. Solo
durante le repliche cominciai a capirci qualcosa in più, forse perché ormai il
mio personaggio, Gegè ‘u farmacista, rappresentava già un dato di fatto e
quindi qualcosa che potevo mettere più a fuoco ad un certa distanza. Ma
più probabilmente perché cominciavo a lavorare con questa metodologia in
maniera più costante. Data dopo data sentivo di entrare in una relazione
più stretta non solo con il mio personaggio, ma con l’intero disegno
drammaturgico. Cominciavo a sentirmi a mio agio nell’intero ingranaggio.
100
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
Avevamo lavorato diversi mesi senza aprire bocca, a quattro zampe,
letteralmente, su una suggestione precisa: «da questo preciso momento
siete dei cani». Ci sta che la prima volta uno arrivi alla fase successiva di
lavoro senza troppe sicurezze.
Quando hai avuto la piena percezione, e anche la consapevolezza, di essere parte
integrante del processo di costruzione della parte?
Non in Cani di bancata dove sostanzialmente, a conti fatti, ‘recitavo’. La
consapevolezza l’ho avvertita ne Le Pulle. Lì l’indicazione tematica era
«lavoriamo sulla prostituzione e la transessualità», mentre la suggestione
poetica era incarnata dalle bambole. Durante i laboratori mi è davvero
successo qualcosa, sentivo gradualmente di essermi ‘trasformato’ e di
‘diventare’ un altro da me. All’inizio lo richiamavo attraverso degli artifici:
un modo di camminare, di parlare, tenendo le gambe in un certo modo,
mentre successivamente ho incontrato la naturalezza, capendo finalmente
cosa significava improvvisare con Emma Dante. Lei sente che questo
personaggio sta emergendo, ne percepisce la dimensione autentica, e
comincia a metterlo in alcune situazioni, lo interroga, facendone emergere
il tessuto, e anche un vero e proprio vissuto, drammaturgico: come si
chiama, l’età, cosa fa, ricordi. Se con Cani di bancata ero un po’ più
spettatore, cercando di capire soprattutto cosa stesse accadendo intorno a
me, interessandomi al lavoro degli altri compagni, ne Le Pulle avevo
pienamente compreso cosa significasse produrre uno spettacolo
instaurando un dialogo effettivo tra il mio lavoro attorico-drammaturgico e
quello registico-autoriale di Emma. Ero riuscito finalmente a sentirmi a mio
agio in quel solco creativo, nel quale l’attore è chiamato a liberare il proprio
estro stando però contemporaneamente a certe regole via via dettate e
introdotte da Emma. È il reale obiettivo del lavoro a cui è chiamato ciascun
attore di Sud Costa Occidentale: frequentare questa zona interstiziale tra
creazione performativa e creazione autoriale.
Tu dici: «mi sentivo trasformato, ero diventato un altro da me». Puoi spiegarmi
meglio questa esperienza?
È recitare certo, io non sono in trance, ma è più complesso e più
emotivamente coinvolgente, perché quelle parole le senti tue, anche se in
quel momento non sei tu. È un riferirsi al personaggio come ad una sintesi
tra prima e terza persona, ma non c’è né distacco, né tanto meno piena
aderenza. Nella fase di ricerca, durante i laboratori, una volta avvertita la
trasformazione, l’empatia è quasi totale, ma è proprio in questo che noti lo
scarto con la fase di costruzione dello spettacolo. Non sei più dentro quel
mondo che hai evocato, totalmente immerso e basta, sei borderline perché
si continua a tenere una tensione con quel vissuto, con quell’immaginario
101
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
evocato, ma al tempo stesso sei anche vigile, pronto a cogliere le indicazioni
e i suggerimenti, le altre sollecitazioni.
Durante la fase laboratoriale è come essere posseduti. Se devi interpretare
Amleto parti dal testo e di conseguenza sei a conoscenza anche del destino
di quel personaggio e conosci anche tanti aspetti della sua vita: è un
principe, ha sedici-diciassette, ha perso suo padre… nel nostro caso questo
itinerario va costruito. Si parte dal movimento con la schiera e si cerca di
‘scoprire’ la camminata, un modo di muoverti. Poi, arriva anche un abito
che ti viene ‘lanciato’ da Emma. Solo dopo qualche tempo, anche una
settimana dopo la scoperta di questa dimensione fisica, arriva l’inserimento
della parola e questo avviene gradualmente. Emma parte da una vera e
propria intervista che non è legata all’andamento del disegno
drammaturgico che ha in mente, anche perché esiste un tema alla base dei
laboratori, ma lo spettacolo è da fare. In questa intervista viene fuori
l’identità drammatica del personaggio: come si chiama, quanti anni ha, cosa
sta pensando… nel rispondere alle domande, l’attore usa una voce che non
è più la sua e da questo momento in poi inizia la vera e propria fase di
costruzione perché comincia non solo a confrontarsi con queste domande,
ma anche a integrare le indicazioni registiche. Sulla base delle risposte, che
evidentemente connotano il personaggio con un certo tipo di immaginario,
Emma aggiusta il tiro sottolineando che un personaggio che si chiama in un
determinato modo, che viene da un preciso contesto sociale, che ha l’età che
dice di avere e ha fatto certe esperienze non può ad esempio parlare in
falsetto, ma deve avere una voce grave, oppure probabilmente balbetta. In
questa fase sei più attento a tenere insieme le tessere del puzzle che sta
emergendo da questa relazione attore-regista, poco dopo però avviene uno
scarto. In seguito, a camminare per ore nello stesso modo, riprendere e
integrare gesti e movimenti frutto di mesi di lavoro… Acquasanta ad
esempio è frutto di un lavoro durato circa un anno e mezzo… ritrovare
evocazioni e spaccati con cui hai costruito il vissuto del personaggio,
riprenderne la voce, le inflessioni, modulazioni cominci a sentire di essere
nel pieno di un processo di trasformazione, hai la netta percezione di essere
diventato qualcos’altro. Anche le emozioni non sono più le tue.
Indipendentemente dalla costruzione dello spettacolo, che avviene in una
fase ancora successiva, l’attore capisce che, partendo dal nulla assoluto, è
stato in grado di costruire qualcosa, qualcosa di pulsante, vivo.
La base di partenza è dunque il training. In molti interventi e in alcuni saggi gli
esercizi utilizzati sono citati e descritti: la schiera, il girotondo,1 il cinematografo e
Cfr.: L. Dalisi, Messa in scena della mafia. Cani di bancata: il metodo maieutico di Emma Dante,
Edizioni Dantes & Descartes, Napoli, 2009, p. 65.
1
102
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
le capitali del mondo.2 Ma cosa significa realmente per un attore, ad esempio,
prendere parte alla schiera?
Dal punto di vista tecnico significa tentare di trovare un primo grado di
gestualità del personaggio, provare ad evocarne la dimensione fisica
attraverso soprattutto la camminata. Poi, sai, fare dieci-dodici passi avanti e
indietro e in obliquo per ore, seguendo un percorso preciso, con le braccia
parallele al corpo, senza mai guardare a terra, osservando un ritmo comune
a quello di tutti i compagni è già qualcosa che ha a che fare con un mantra,
una sorta di transfert ipnotico, nel senso che ti mette in una particolare
predisposizione e quello che successivamente viene fuori partendo da
quella condizione non è riconducibile alla logica o alla razionalità. Di sicuro
lavora anche la dimensione emotiva, ma questa è condizionata anche dal
fatto di quanto tu sia più o meno calato in quel dato momento in quella
situazione. È anche questo il motivo per il quale su alcune parti si lavora
più approfonditamente, mentre altre suggestioni restano solo potenziali e
non vengono riprese durante le fasi successive. Le corde emotive vengono
toccate in prima battuta dalle musiche che Emma sceglie in quel momento.
Così già ti ritrovi in una messa in situazione. Un altro momento importante
è sicuramente rappresentato dalle indicazioni che ti vengono date: «sei
arrabbiato», «sei felice», «è successo questo». Il corpo gradualmente
comincia a modificarsi, magari se viene fuori un lieve difetto fisico quello è
già un primo elemento che cominci a tenere e su cui cominci a modificare la
camminata. Nel frattempo è già iniziato un dialogo con l’immaginario
drammaturgico di Emma che rielabora questi primi momenti
metaforicamente, narrativamente generando nuove messe in situazione.
Consultando un po’ di interviste, Emma Dante parla spesso di «fantasmini che
devono venire e alla luce»3 e fa spesso riferimento al suo teatro come un «teatro in
cui non c’è psicologia, ma carnalità».4
L’incorporeo e la fisicità, l’estremamente materico, questa dicotomia, come si
coniuga all’interno dell’esperienza attorica?
Il fantasmino è la prima traccia di una presenza altra che successivamente
con il lavoro può diventare il personaggio. È una sorta di prima
apparizione. Anzi, è una vera e propria apparizione perché è la prima cosa
che Emma vede. Se non c’è questa prima manifestazione di questa presenza
durante la schiera è superfluo procedere con il lavoro. È impossibile. La
fase successiva di costruzione, quella in cui si comincia ad assegnare la
2 Cfr.: P. Bologna, Verso Purgatorio, in Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, a cura di A.
Porcheddu, Civitella in Val di Chiana, Zona, 2006, p. 149.
3 E. Stancanelli, Come fa un aereo a volare, in Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 83.
4 E. Dante, La strada scomoda del teatro, intervista a cura di A. Porcheddu e P. Bologna, in
Palermo dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 51.
103
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
voce e a trovare una dimensione gestuale, rappresenta quello che tu hai
definito come ‘materico’: è la carnalità di cui evidentemente parla Emma. È
la conquista a cui giungi quando lei si relaziona a te chiamandoti con il
nome del personaggio.
Ritorniamo a Le Pulle, spettacolo nel quale – dicevi – hai cominciato a sentirti
finalmente a tuo agio con questa impostazione di lavoro. Come hai costruito il
personaggio di Stellina?
Il tema – dicevo – era la transessualità e la prostituzione. Il terrore era
quello di cadere nel cliché. Fare il femmeniello è una sfida ardua per un
attore. Ricordo che dopo le prime sessioni di lavoro posi una questione
centrale nella mia relazione con il motivo della transessualità: non pensare
all’uomo che fa la donna, bensì all’essere di sesso femminile da cui ero più
affascinato in quel periodo. La risposta fu: mia nipote, che all’epoca aveva
circa cinque anni. Un elemento assolutamente dissonante rispetto al
discorso sulla prostituzione che stavamo indagando. Non si trattava di
imitare. Durante un’improvvisazione emerse questo elemento della donnabambina con un atteggiamento e un approccio infantili – forse questo
aspetto affiorò perché la suggestione di fondo che ci era stata assegnata era
«le bambole» – che trovò il coronamento nell’utilizzo del falsetto utilizzato
dal mio personaggio per raccontare il suo vissuto in maniera sognante,
delicata anche se si trattava di esperienze terribili. È qui che razionalmente
capii l’interconnessione con mia nipote. All’epoca ero infatti solito farmi
lunghe chiacchierate al telefono con lei, cosa che evidentemente aveva
assunto un elemento centrale non solo nella mia vita da zio, ma anche nella
mia ricerca.
Come è nato invece ‘O Spicchiato di Acquasanta?
La traccia di lavoro era «la povertà». Acquasanta è uno dei tre segmenti di
quella che s’intitola La trilogia degli occhiali. Gli altri due, Il castello della Zisa
e Ballarini, avevano come temi rispettivamente «malattia» e «vecchiaia». Ad
incarnare il tema ci sono arrivato per gradi. La scintilla vera e propria si
innescò quando durante un’improvvisazione arrivarono dei pantaloni di
velluto a coste, cinque-sei taglie in più rispetto alla mia. Una volta stretta
una cintura in vita per tenerli su, camminavo in una maniera che
chiaramente non era più la mia. Parallelamente erano un segno, un
elemento che mi raccontava qualcosa, mi comunicava una povertà estrema
– cosa che fino ad allora era solo una traccia e che invece in quel momento
cominciavo a sentire sulla mia pelle – e suscitava in me empatia, oltreché
aiutare a calarmi più concretamente in una messa in situazione su cui poter
innestare dei miei personali spunti narrativi: un episodio, un ricordo, un
personaggio. S’innesca un processo rievocativo. Solo in seguito alla
improvvisazione pura e cruda capisci di aver pescato nel tuo vissuto. Ci
104
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
sono magari tratti della personalità di tuo zio, tic del tuo professore di
chimica, ma è qualcosa a cui non ricorri né razionalmente, né
intenzionalmente. In Aquasanta ad esempio mi sono ‘ispirato’ a un
parcheggiatore abusivo di Palermo, Renato Malfatti, presente anche nel
film Via Castellana Bandiera, che ho conosciuto perché bazzicava il luogo
dove avevo ormeggiata una barchetta. Un uomo da una vita travagliata, exmarinaio che mi raccontò i motivi dei suoi anni da imbarcato e anche quelli
per i quali non lo era più. Ma, come nel caso di Stellina, ovviamente non si
tratta di ‘imitare’. Renato non potrebbe mai parlarti del divenire come
invece fa ‘O Spicchiato e ad ogni modo se imitassi tradirei l’obiettivo
fondamentale del nostro approccio e cioè giungere ad un’autenticità.
Infatti, quando cominciai ad ‘appassionarmi’ a Renato l’unica cosa che
m’imposi era quella di passare molto tempo con lui senza razionalizzare e
organizzare ciò che mi raccontava durante le nostre chiacchierate. Cercavo
di essere semplicemente aperto e ricettivo, provando a partecipare con
empatia alle sue storie. Non si trattava di prendere appunti, cartacei o
mnemonici.
Abbiamo cominciato in due…
Quindi la forma del monologo non faceva parte del disegno originario?
No. Non si sa mai che struttura avrà lo spettacolo. La stessa Emma non sa
molto della struttura finale quando inizia il lavoro su un nuovo progetto.
Si comincia sempre in gruppo, il cui numero è ovviamente variabile perché
magari si inizia un nuovo laboratorio mentre altri attori sono impegnati con
le repliche degli spettacoli in tournée. Ad ogni modo si comincia senza
sapere nulla della struttura, così come gli stessi attori non sanno se alla fine
ciò che hanno sviluppato troverà uno sbocco concreto. Puoi anche fare sei
mesi di laboratori per poi scoprire di non far parte dello spettacolo. Questo
per alcuni può risultare deprimente, perché può toglierti certezze
professionali, lavorative, anche quelle intimamente connesse alla tua sfera
‘creativa’. Ma contemporaneamente non si può dire d’aver perso tempo
perché non prendere parte ad uno spettacolo può coincidere comunque con
una crescita artistica esponenziale.
Cosa portò a scegliere la soluzione del solo personaggio in scena?
‘O Spicchiato cominciò a essere un personaggio prevaricante sull’altro che
stava portando alla luce Onofrio Zummo. Non so se per una questione di
corde, fatto sta che si stava venendo a creare una sorta di rapporto
sbilanciato tra le due presenze in quanto il dialogo, la relazione quasi non
c’era, c’erano questi veri e propri soliloqui di quello che stava diventando
‘O Spicchiato. Di qui, poi anche la scelta drammaturgica del monologo.
105
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Continua a raccontarmi del lavoro su Acquasanta.
È stato un processo graduale. Come sempre, ma per quello spettacolo
accaddero episodi e situazioni che rasentano la magia.
Era estate. Durante le pause di lavoro andavamo a rilassarci in barca. Mi
tuffavo per cercare di pescare polpi, ma l’unica cosa che trovavo erano
delle ancore che Emma introdusse in una delle fasi di costruzione dello
spettacolo. Fu una svolta.
In che senso la loro introduzione rappresentò una svolta?
Cominciammo a considerarle non come oggetti di scena. Attaccandole al
mio corpo, facendole roteare, muovere divennero presenze vive. Questo in
me creò proprio uno sblocco psicologico che mi permise di percepire la
presenza di quegli oggetti in maniera dinamica, come delle propaggini: e
quali potevano essere le propaggini di un mezzo mozzo? Magari un
equipaggio e quindi ci poteva essere un capitano e sicuramente un
marinaio.
Dunque un esempio concreto di ciò che raccontavi prima: l’attore che si ritrova a
rielaborare, integrare e continuare ad inventare.
Sì. È l’innesco di un momento di formalizzazione nel quale comunque devi
avere una soglia di attenzione volta a recepire e rielaborare l’indicazione
registica. Non ripeti ciò che hai fatto in un impianto più formalizzato e
neppure si tratta di prove tecniche utili ad asciugare quanto emerso in
laboratorio. Riprendi ciò che ti viene richiesto di riprendere e integri.
Le ancore mi sono state attaccate al corpo. Era inevitabile pensare ai pupi o
alle marionette, o più in generale a muoversi in un certo modo. Di qui,
l’incidenza che questa situazione ha avuto sulla partitura fisica creata nella
relazione tra i tre personaggi, quando si ‘ritrovano in scena’
simultaneamente.
In Acquasanta tu ricopri appunto tre ruoli. Le domande, questa vera e propria
intervista tenuta dal regista all’attore per scoprirne il vissuto, come si sono
strutturate visto che a un certo punto ti sei ritrovato solo?
Nel teatro di Emma, durante la fase di costruzione, il conflitto tra
personaggi è un aspetto fondamentale. Fin dalle prime battute, da quando
viene introdotto l’elemento vocale all’interno del processo di costruzione
della parte, emerge il carattere di un personaggio, il colore, le corde della
sua personalità. Emma, dopo aver messo a fuoco questo, comincia a far
relazionare i diversi personaggi tra loro per far venire a galla la dimensione
narrativa potenziale di questi rapporti. Quest’aspetto viene scandagliato
più agilmente in gruppo. Lì ero da solo e quindi questo elemento, all’inizio,
106
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
fu percorso con difficoltà, almeno fino a quando non ‘avvertimmo’ le altre
due ancore a me legate come presenze altre. Una volta emerso che ‘O
Spicchiato non era solo, Emma era libera – sicura di trovare risposte – di
porre domande tanto al capitano, quanto al marinaio che ormai si erano
‘aggregati’ all’esperienza che stavamo conducendo.
Di fronte al teatro di Emma Dante si ha l’impressione di assistere a partiture
fisiche rigorosamente formalizzate. Ho visto tre volte Acquasanta e potrei giurare
di averti osservato fare gli stessi movimenti nelle stesse posizioni. Come si concilia
questo rigore con la dimensione estremamente creativa raccontata fino a ora?
Lo spettacolo, quando arriva al debutto, non ha più nulla di improvvisato.
Tra una ripresa e l’altra delle repliche, magari tra date distanti, può
cambiare in qualche dettaglio, ma si tratta di cose che possono servire
all’attore per sentirsi meno a suo agio, recuperare qualche insicurezza che ti
rende più pronto, più ricettivo, per spezzare la routine. Detto questo, il
rigore c’è, ma è dettato dalla disciplina di riprendere le sessioni di lavoro
dallo stesso punto in cui si è conclusa quella del giorno prima. È una
costruzione che si fonda già su una sorta di osservazione disciplinata,
quindi non è frutto di un’anarchia alla quale porre ordine successivamente,
in maniera tecnica. Il magma drammaturgico e attorico che scaturisce dai
laboratori è immediatamente messo a fuoco fin da subito, quindi si
riprendono battute dette in un determinato modo, posizioni, gesti. Si
riprendono questi elementi sempre ricominciando dal training. È una
ripresa graduale che alla fine della sessione ti porta automaticamente a
‘ripassare’ delle cose e ad averne create delle nuove da riprendere il giorno
dopo.
Mi sembra un aspetto interessante perché molte delle esperienze di teatro
contemporaneo, e del contributo che al loro interno offre l’attore, vengono spesso
liquidate come esperienze in cui o è presente pochissimo rigore o c’è una ricerca fine
a se stessa di sterile parossismo tecnico.
Dal canto mio posso affermare che l’aspetto tecnico mi affascina
notevolmente. Vedere un attore bravo per me è sempre motivo di interesse.
Però è una dimensione che per ora non mi interessa vivere. Io mi reputo
capace di lavorare su un testo in maniera accademica e sono in grado, una
volta che mi ci metto, di restituirlo come la dizione radiofonica vorrebbe.
Ma quello che mi chiedo è: questo mi interessa? A chi interessa? Certo,
spesso sia dalla critica, sia dall’ambiente, un attore di Sud Costa
Occidentale viene considerato in maniera un po’ limitata, come uno che è in
grado di fare solo certe cose. Personalmente, credo che ci sia un modo
errato di considerare il bagaglio tecnico di un attore come quello che solo
l’accademia è in grado di darti. Non penso che esista ‘un’unica e sola
107
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
tecnica’, ma ‘la tecnica’ che in un dato momento del tuo percorso o di un
particolare progetto ti serve per lavorare sulla dimensione espressiva, per
costruire un mondo.
Altre esperienze, invece, più sperimentali spesso danno anche a me la
sensazione di avere poca sostanza alle spalle.
Però una volta costruita una parte, completato il suo processo di formalizzazione,
questa potrebbe essere ‘ripetuta’, eseguita da un altro attore? Te lo chiedo perché
prima mi parlavi della difficoltà, durante il momento di varo di un nuovo progetto,
ad avere piena disponibilità degli attori che fanno parte di Sud Costa Occidentale,
perché in giro per il mondo.
Sarebbe impossibile. Sì, certo è possibile farlo tecnicamente, ma sarebbe un
esercizio di stile. A chi e a cosa servirebbe un’operazione del genere? A
Emma per rivendicare una sorta di dispotismo? A me attore certo non
serve. ‘O Spicchiato o Stellina sono stati portati alla luce partendo dalla
rielaborazione personale delle suggestioni registiche. Non è che venga
meno solo l’intervento creativo. Sarebbe ancor più sterile che lavorare su
un testo o con su una regia di ferro. Ciò che viene universalmente
apprezzato nei nostri spettacoli è l’autenticità. Un attore che imita un altro
attore, anche con precisione chirurgica, non verrà mai percepito come
autentico, perché i suoi gesti, le cose che dice, come le dice di fatto non
potranno mai risultare vere. Dietro ciò che facciamo in scena c’è un
processo che come abbiamo detto pesca dalla verità, da vissuti e esperienze
reali. I miei sono personaggi cuciti sulla mia pelle, ma con la mia stessa
pelle.
In qualche caso, quasi isolato, possiamo anche essere sostituiti da altri
compagni. In Verso Medea, ad esempio, possiamo essere intercambiabili. Ma
perché? Perché si tratta di un altro tipo di spettacolo. Non solo si parte già
da un testo, da un classico, ma si rielabora uno spettacolo già andato in
scena, elaborato su presupposti molto diversi da quelli fino ad ora
raccontati e con l’obiettivo di correggerne le parti che meno avevano
convinto Emma nella versione con Iaia Forte. È confrontarsi con un altro
teatro proprio.
Uno degli aspetti più significativi del tuo lavoro, così come quello svolto dagli altri
componenti di Sud Costa Occidentale, è incarnato dal ritmo della recitazione. Si
legge spesso che l’andamento della performance derivi da una particolare relazione
che Emma Dante innesca tra attore e musiche durante i laboratori.
La musica è il primo strumento che abbiamo per improvvisare movimenti.
Si tratta di musiche diversissime: dalla classica all’elettronica e al rock.
Alcuni motivi vengono abbandonati fin da subito, altri restano lungamente
perché aiutano a creare anche una particolare atmosfera utile per
108
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
l’improvvisazione e per la sua stessa ripresa in fasi successive. L’obiettivo
finale, però, è quello di interiorizzarle. Tu attore infatti hai la
consapevolezza netta che quando ti vengono tolte, quando cioè riesci a
muoverti o dire certe cose come se quella data musica fosse ancora in
diffusione, rispettando il ritmo che è scaturito da quella relazione,
riproponendo la stessa tensione drammatica, è il momento in cui lo
spettacolo sta andando verso la sua formalizzazione. Sai che la strada
imboccata è quella che ritroverai alla prima.
Eppure gli spettacoli di Emma Dante, anche quelli in cui tu sei in scena, non sono
completamente privi di musica. À
Sì, perché evidentemente, oltre a quelle più squisitamente tecniche, legate
al lavoro con l’attore, ci sono anche delle motivazioni drammaturgiche che
riguardano magari aspetti connessi a una maggiore efficacia narrativa di
certe situazioni. Ad esempio in Acquasanta, quando ‘O Spicchiato fa la sua
dichiarazione d’amore al mare, un attimo prima si sente il pezzo dei Sigur
Ros Starálfur e per me, come per il pubblico, quella musica ‘è’ il mare. Non
mi serve per ‘colorare’ la parte in quel momento, rappresenta una vera e
propria seconda ‘presenza’ sul palco. Percepita così, dal punto di vista del
performer, la musica non serve più né per creare atmosfera, né per il ritmo,
ma produce drammaturgia, recita con me. Così come è drammaturgia, per
fare un esempio meno lontano, in Operetta burlesca, dove la musica e i
numeri musicali concretano i sogni del protagonista che riesce a vivere la
propria condizione solo così, sotto forma di tensione onirica.
L’attore ha un margine di autonomia nella scelta delle musiche? Tu hai mai portato
in sala una proposta che ti sembrava potesse aiutarti per sviluppare un
personaggio?
Non fa parte del gioco. È chiaro, però, che in qualità di compagno di vita di
Emma le propongo dischi o musicisti che mi appassionano in un
particolare momento. Tra queste cose c’è poi spesso qualcosa che la
incuriosisce perché ne riconosce una potenzialità anche sul piano scenico,
ma non è un aspetto che viene scandagliato nel rapporto attore-regista. Per
il nuovo lavoro le ho fatto ascoltare un po’ di composizioni di Nils Frahm e
infatti è un periodo in cui stiamo lavorando spesso sulle sue musiche.
Vedremo se ne resterà traccia concreta nello spettacolo.
Torniamo alla costruzione della parte. Ad un certo punto, dopo il primo lavoro
fisico, attraverso ‘l’intervista’ il personaggio interagisce con il regista con la ‘sua’
voce. Come consideri, che ruolo ha nel tuo lavoro l’elemento vocale?
109
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
A me interessa il dato sonoro, ma non sono affatto concentrato su una
ricerca che tende all’astrattismo, ad una ricerca sulla natura sonora del dato
verbale. Ricerco la musicalità, ma una musicalità che sia in grado di
raccontare qualcosa, provo a pescare dal mio vissuto una lingua che
immediatamente sia in grado di evocare il mondo di un personaggio in
maniera concreta. Non sono un attore che si concentra sulla modulazione
per esempio, però appena mi viene richiesto di dar voce ad un personaggio
io automaticamente comincio a lavorare sulla timbrica e lo faccio – in
questo caso sì – inizialmente per imitazione. Nel caso di ‘O Spicchiato il
modello era un professore di chimica che avevo avuto al liceo. La molla era
scattata pensando al fatto che il personaggio che stavo costruendo era
sostanzialmente un folle, uno che «si era innamorato dell’infinito». E questo
professore – che ai nostri occhi di studenti aveva degli atteggiamenti da
outsider rispetto al restante corpo docente – per me era un personaggio
della stessa natura di ‘O Spicchiato, quindi da questa suggestione ho
cominciato a improvvisare con questa voce bassa con un andamento spesso
dimesso. Nel caso di Stellina l’aggancio, come dicevo, era mia nipote. La
voce in falsetto viene da lì, però la dimensione romantica e la logorrea
derivano, invece, da un’amica un po’ particolare, la classica persona che ti
fa una domanda, ma non ti lascia rispondere e, anzi, incalza con quella
successiva facendo botta e risposta da sola. Va detto, però, che nella mia
esperienza creativa non stavo dando questa voce a un travestito, ma alla
‘mia bambola’. Avevo rielaborato in questi termini l’immaginario stabilito
da Emma. Evidentemente stavo cercando di portare alla luce questo
fantasma assegnandogli una sorta di purezza primordiale.
Poi però a un certo punto c’era un corto circuito: usavi anche una voce maschile.
Sì, ma quella era proprio la mia voce. Succedeva in occasione
dell’esplosione del litigio con Ata. Il registro diventava spigoloso, rude,
tesissimo. Durante i laboratori capimmo che quello forse era il momento in
cui il personaggio poteva togliersi la maschera. E per me attore togliermi la
maschera di Stellina significava restare con il mio corpo, il mio volto, la mia
voce.
Operetta burlesca è un altro lavoro sull’omosessualità. Come hai costruito la
parte di Pietro considerando che avevi già affrontato la tua ricerca su questo tema
in Le Pulle?
All’inizio ho affrontato il lavoro con difficoltà. Ero troppo a mio agio. Stavo
bypassando la fase di ricerca ancorandomi a un personaggio che aveva
funzionato: Stellina. Sapevo che aveva fatto divertire, commuovere,
innamorare. Nella mia testa quindi era tutto intoccabile. C’era bisogno di
scardinare questa relazione che avevo instaurato con quella parte. Avevo
110
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
cominciato a riprendere la voce in falsetto, utilizzare tacchi alti, i vestiti da
donna. Ma l’obiettivo non poteva essere quello di riportare Stellina sulla
scena. Abbiamo capito che bisognava distruggere tutto, eliminare le
certezze. Per fare ciò Emma mi ha ‘costretto’ a lavorare in pigiama.
L’immaginario omosessuale mutuato da Le Pulle a quel punto è
immediatamente svanito. Non esisteva più quel clichè autoindotto a cui mi
ero rivolto durante la prima fase di laboratorio. Non avevo più questa sorta
di protezione artificiale alla quale mi ero abbarbicato per cominciare il
nuovo lavoro, per avere delle sicurezze. Successivamente, riflettendo, ci
siamo anche convinti, man mano che il lavoro cresceva, che il personaggio
di Stellina de Le Pulle poteva essere utilizzato come si utilizza una
maschera. Quindi riparlare di omosessualità, motore tematico dal quale il
progetto si prefiggeva di partire, muovendo consapevolmente proprio dal
personaggio nato per Le Pulle. Ma questo è accaduto solo dopo aver
affrontato e risolte le contraddizioni emerse nei primi momenti di
elaborazione. Una volta recuperate le condizioni di creazione autentica, di
improvvisazione totale, è stato possibile inserire un elemento più legato
alla formalizzazione, alla scelta drammaturgica.
Non è impensabile, tra qualche anno, preparare uno spettacolo sulla guerra
e infilarci ‘O Spicchiato-soldato, connotato cioè militarescamente.
In questa modalità di fare teatro l’attore è tutto, per questo ormai da
qualche tempo si è inaugurato un percorso di costante sottrazione. Già
all’inizio non era un teatro con una scenografia particolarmente elaborata…
Le sorelle Macaluso non ha praticamente niente. In Operetta burlesca ci sono
pochissime cose, per certi versi ininfluenti. Quando cominci a lavorare non
c’è un testo, non c’è un’indicazione precisa. Quello che hai sei tu: il tuo
corpo, la tua voce. Devi solo assecondare questa tensione alla
trasformazione a cui il training inevitabilmente ti porta. Poi, può anche
finire che dopo quattro mesi di laboratorio il tuo lavoro non si completi,
non giunga ad una maturazione, formalizzazione perché evidentemente
non si è evoluto, non è cresciuto rispetto alle improvvisazioni iniziali e quel
‘fantasma’, che eri riuscito ad evocare all’inizio, resta in un limbo, non
viene portato alla luce.
Questo racconto è interessante perché fino ad ora hai posto particolarmente
l’accento sulla dimensione istintiva del tuo essere attore. Questa esperienza di
iniziale impasse sembra, invece, averti fatto scoprire alcuni aspetti più teorici e
riflessivi del tuo lavoro.
In parte è vero. Certo, non ho l’attitudine didattica di Sandro [Maria
Campagna] per esempio. Però sto riscoprendo questa cosa ultimamente.
Anche il riflettere sulle questioni affrontate nei diversi spettacoli.
Nella recente esperienza con la Scuola dei mestieri dello spettacolo, in
collaborazione con il Teatro Biondo, per un progetto con alcuni giovani
111
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
allievi che trae ispirazione dall’Odissea, ho fatto parte del corpo docenti. Ho
portato la mia esperienza in ciò che forse mi riesce meglio per indole,
istintivamente, cioè l’improvvisazione. Chiaramente non ho formalizzato
una tecnica, appunto la dimensione pedagogica mi appartiene molto poco,
ma ho fatto esempi pratici su come ho risolto una questione per sviluppare
a fondo un aspetto, come è nato un certo momento prendendo spunto dal
mio lavoro. In fondo, ciò che costantemente ripeto è di tenere alta la
curiosità: crearsi un bagaglio di esperienze umane, innanzitutto, tali da
metterti in contatto con un certo tipo di realtà, una realtà abitata da
personaggi outsider, vivere questi rapporti nella maniera più autentica
possibile con estrema sensibilità. Questo è quello che può aiutarti a
costruire un personale immaginario poetico in relazione – chiaramente – a
questo specifico esempio di teatro.
La tua vita immagino sia, però, cambiata. Sei impegnato quotidianamente con il
teatro, frequenti altri attori e artisti e i contesti sono teoricamente ben diversi da
quelli sui quali hai plasmato quasi tutti i tuoi personaggi. Come credi di poter
alimentare il bagaglio di esperienze di vita al quale facevi riferimento?
Dici che mi sono imborghesito? [risate]. È in effetti un aspetto su cui mi
sono concentrato anch’io ultimamente. L’inizio dei laboratori su Operetta
burlesca ha forse portato un po’ alla luce questa problematica. Oltre a
quanto detto precedentemente, il mondo rievocato in fondo era quello gay
napoletano degli anni della mia giovinezza che frequentavo da ‘scugnizzo’
avendo avuto molti amici che appartenevano a quella realtà, una realtà
anche molto dura. L’aggressività è un tratto che viene da questi ricordi.
Però, sì, è un mondo, sono esperienze pregresse a questa mia ‘nuova’ vita.
La strada la frequento sempre meno e non ti nascondo che è una cosa che
un po’ mi manca. Forse non è un caso che stiamo lavorando su uno
spettacolo il cui motivo di partenza è: ‘gli attori’.
L’impianto degli spettacoli di Emma Dante riflette sostanzialmente un impianto
frontale. I personaggi si rivolgono sempre a ciò che hanno davanti a sé, alla platea,
anche quando le dinamiche che regolano i loro rapporti si fanno più intense o
concitate, come se fossero prigionieri di questa relazione con un al di là scenico. Si
tratta di una sigla stilistica, della cifra registica o intervengono altre motivazioni
magari connesse al lavoro svolto dagli attori?
Questa frontalità esiste perché, una volta in scena, siamo ‘orfani’ di Emma.
Lei è il nostro primo spettatore. Lo è già fin dalla schiera. Anche questo è il
motivo per cui negli spettacoli ci rivolgiamo al pubblico, siamo quasi
sempre frontali allo sguardo dello spettatore, cerchiamo la sua presenza,
perché non avendo più quella del regista ne cerchiamo un’altra. È
importantissimo perché è un sostegno per la nostra performance. In
112
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
Acquasanta mi relaziono con il pubblico, gli chiedo anche dei soldi
sottoforma di profferta. In Operetta burlesca racconto direttamente a un
destinatario concreto la mia storia. Proviamo a trovare degli escamotage
drammaturgici affinché l’attore possa ritrovare la relazione che lo ha
aiutato a mettere a punto la sua partitura. La ricerca di uno sguardo, anche
se diverso, anche se non più legato a logiche creative, è fondamentale per
ritrovare condizioni tecniche e espressive che hanno originato l’atto
creativo.
Molti registi chiedono però ai propri attori di cancellare la presenza del pubblico al
fine di essere concentrati e risultare più convincenti.
Per noi è fondamentale, invece, afferrarne la presenza. Intendiamoci, noi
cerchiamo un rapporto con il pubblico in quanto interlocutore perché
siamo costretti a sostituire il nostro interlocutore abituale e privilegiato.
Non ci interessa l’interazione ludica, ma il coinvolgimento emotivo.
Dobbiamo avere un destinatario, perché un destinatario c’era fin dall’inizio,
da quando quel personaggio è nato, da quando quella particolare
situazione si è generata. Ritrovare questa condizione è indispensabile per
ritoccare certe corde. In Operetta burlesca il rapporto con il pubblico è
dichiarato. Pietro entra in scena e dice: «Signore e signori, ladies and
gentlemen, mesdames et messieurs questa sera vi racconterò una storia».
E come hai vissuto il fatto che in Verso Medea questa relazione giocata sulla
frontalità non è praticamente prevista?
In Verso Medea io, come gli altri, ho lavorato sul testo. Sì rielaborato, rivisto
attraverso lo stesso contributo e intervento degli attori, ma chiaramente non
si tratta di un lavoro generato dalla relazione con Emma. Non ti nascondo,
infatti, di aver provato una buona dose di imbarazzo in molti passaggi. Mi
sentivo finto. O per meglio dire la mia esperienza d’attore si consumava
all’interno di una cornice che convenzionalmente prevede e pretende
questo tipo di rapporto. Io non rimando mai a memoria la parte perché le
parole mi vengono fuori appena recupero certe condizioni. In Verso Medea
non solo sentivo l’esigenza di doverlo fare, ma l’avere questa percezione
del pubblico diversa dal solito mi portava pure a non essere ‘pulito’ nella
recitazione.
La nuova versione l’abbiamo messa a punto in due settimane. Un tempo
ridottissimo in relazione a quello abituale. Ma perché? Perché c’era un
testo, la compagnia ha una forza di base e sulle specificità degli attori la
regia può lavorare in una maniera più classica, anche se il risultato non è
mai di stampo accademico. Lo spettacolo funziona. Personalmente, però,
sembrerà paradossale, mi sento meno sicuro di quando vado in scena con
Acquasanta o Operetta burlesca. Pur avendo ben chiaro e precisamente fissato
113
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
il mio intervento attorico, la parte, essendo qualcosa non scaturita da me,
dal mio corpo, dalla mia immaginazione, la sento più esterna. Devo
forzarmi a tenere alta la soglia dell’autocontrollo, devo essere
estremamente concentrato e vigile, perché le dinamiche sono meno
naturali.
A proposito del ritrovare certe condizioni. Un aspetto che colpisce è che per
riprendere un personaggio durante la fase di costruzione, tu spiegavi, si riparte
sempre dagli stessi elementi: la schiera, la postura, la camminata, la voce, etc. Cioè,
si dà luogo a una ripresa progressiva e graduale delle condizioni che hanno
permesso di costruire la parte per recuperare il personaggio. Questo processo lo
affronti anche durante le repliche?
Il training è sempre alla base di ogni approccio successivo, ma ognuno
riprende i contatti con il proprio personaggio in modi e tempi gestiti
secondo dinamiche assolutamente individuali. Da questo punto di vista mi
reputo fortunato. Mi basta rifare leva su alcuni motivi ‘ritualistici’ anche
pochi minuti prima di andare in scena.
Puoi accennare a qualche esempio concreto?
In Acquasanta, dopo essermi legato le ancore al corpo, sistemato nella
barchetta, per ‘entrare nella parte’ mi basta pochissimo: infilarmi gli
occhiali, augurarmi “medda” [merda] così come parla lui e sistemarmi la
fila tra i capelli con il pettine. Mi basta questo per rievocare quella roba lì
che si vede in scena. Su quest’aspetto c’è un aneddoto curioso: mi è capitato
di riprendere questo spettacolo per alcune date quasi contemporanee ad
Operetta burlesca, dove ho i capelli rasati. Non avere quell’appiglio fisico,
quell’innesco ritualistico, del sistemarmi la fila mi ha messo in seria
difficoltà un attimo prima di andare in scena. Anche la mancanza della
barba – in Operetta recito completamente depilato – ha rappresentato
motivo di panico perché non riuscivo a entrare in contatto con ‘O
Spicchiato. Ho temuto di non riuscire a riprendere uno spettacolo che,
fortuna vuole, faccio da anni.
Quello che raccontavi di Verso Medea mi porta a riprendere la questione del testo.
Hai lavorato altre volte come interprete di un’opera d’autore?
Sì, nell’Alkestis. Facevo Thanatos. Si trattava di un lavoro commissionato
dal Teatro di Lucerna in Svizzera. Lo spettacolo doveva essere recitato da
attori tedeschi, attori che non avevano mai lavorato con Emma. Il testo di
Euripide era stato riscritto da Kurt Steinmann e riadattato da Anke
Zimmerman per l’occasione. Di fatto Emma ne firmava la regia, quindi
anche per lei era un’esperienza diversa dal solito. Ancora più diversa di
114
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
quella legata alla Medea del 2004. Ebbe, però, modo di coinvolgere due dei
suoi attori: me e Sabino Civilleri. La nostra ‘diversità’ attorica servì a creare
una contrapposizione drammaturgica tra il mondo degli dèi e quello degli
umani. Riscrivemmo le nostre battute del testo, che recitavamo in
napoletano e in siciliano, ma per il resto il lavoro si basava sul mandare a
memoria il copione, assegnare le intonazioni, modulare l’intensità,
rispettare il ritmo. Un lavoro molto tecnico.
È giusto, però, parlare dell’elaborazione di un testo scritto anche nei lavori
originali?
Il testo c’è nel senso che Emma ha l’esigenza di stenderlo e magari di
pubblicarlo. Ma noi attori non abbiamo mai un copione. Io personalmente
non saprei cosa farmene. Mi destabilizzerebbe. Significherebbe ‘dire un
testo scritto’, cosa in netto contrasto con l’esperienza attorica che quelle
parole le ha pure prodotte.
Ti racconto un aneddoto: in occasione della pubblicazione de La trilogia
degli Occhiali fu organizzata una presentazione alla quale partecipai in
qualità di lettore di alcuni passaggi di Acquasanta. Io mi sono ritrovato lì,
davanti a un leggio con il libro aperto e non sono riuscito a leggere un testo
che conoscevo a memoria: assurdamente mi impappinavo!
Ancora oggi, visto che è uno spettacolo che abbiamo ancora in repertorio,
quando lo riprendo e può capitare di confrontarmi con qualche buco di
memoria non vado a rivedere il testo pubblicato, ma do uno sguardo a una
versione che mi sono scritto di mio pugno.
Eppure ne La strada scomoda del teatro, l’intervista curata da Andrea
Porcheddu e Patrizia Bologna, si legge: «dopo le improvvisazioni fatte assieme
torno a casa e scrivo». E ancora: «scrivo dopo le prove, e l’indomani porto quello
che ho scritto. Cioè formalizzo, da sola, quello che abbiamo fatto insieme».5 Che
relazione c’è tra questa formalizzazione solitaria e il lavoro che l’attore svolge
successivamente?
Non c’è nessuna relazione tecnica. Ce n’è sicuramente una drammaturgica
che è chiaramente qualcosa che però riguarda fondamentalmente solo
Emma e che ‘passa’ in una maniera segreta nel lavoro con l’attore. La
stesura evidentemente aiuta lei a chiarirsi meglio alcune questioni
progettuali, di disegno complessivo, ma non rappresenta un elemento – per
l’attore – dal quale ripartire.
Puoi fare un esempio?
5
E. Dante, La strada scomoda del teatro, cit., p. 57.
115
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Ne Le Pulle Emma aveva capito che il sogno di Stellina era il matrimonio.
Prima che ci arrivassi io nel mio percorso. Infatti in una delle sessioni, ad
un certo punto, l’ho vista scomparire, e poco dopo è tornata lanciandomi
un bouquet. E in rapida successione un tutù bianco e poi un velo. A quel
punto ho indirizzato le mie improvvisazioni in quella direzione, la
direzione che quei materiali mi evocavano. Ora non so se quell’idea le fosse
venuta in quel momento o se l’avesse annotata da qualche parte, ma non
posso non pensare al fatto che se ne avessimo parlato, discusso come si
discute dell’interpretazione davanti a un testo, io mi sarei preparato una
‘scena’ che, sono sicuro, sarebbe stata fallimentare perché scollegata,
forzata rispetto a quanto era emerso fino a un secondo prima durante
l’improvvisazione.
Vorrei restare ancora un momento su questo aspetto. In riferimento a Cani di
bancata, la Dalisi, nel suo Messa in scena della mafia, parla di un vero e proprio
copione che quotidianamente veniva ‘fissato’ e ‘passato’ anche agli attori.6
Quello era però un progetto diverso. Il tema era la mafia, ma il lavoro di
costruzione drammaturgica non fu affrontato come al solito. Bisognava per
forza di cose sostenerlo in maniera diversa, ragion per cui tutti abbiamo
affrontato un lavoro di documentazione e reperimento di materiali
informativi molto scientifico. Ognuno si occupava di un segmento specifico
delle attività legate alla criminalità organizzata. Io, ad esempio, mi
occupavo delle droghe e della sanità. Erano tutti aspetti che chiaramente
non potevano essere affrontati con le sole improvvisazioni.
Eleonora Lombardo ricopriva un ruolo ben preciso. Era assistente alla
drammaturgia. E c’era anche Linda Dalisi che documentava il lavoro.
Questo per dire che fin dall’inizio era un tipo di operazione immaginata da
Emma in maniera completamente diversa.7 Più veicolata se vogliamo, ma
anche un po’ sperimentale in quanto tentava di mettere in contatto quel
6 «[…] Emma si è avvalsa di un’assistente alla drammaturgia, Eleonora Lombardo, e ha
costruito giorno dopo giorno un copione. Con grande sorpresa, gli attori della Compagnia
Sud Costa Occidentale si sono trovati di tanto in tanto dei fogli per le mani… “E questo
cos’è?” Erano le prime bozze del copione! Alla fine si sono anche abituati a chiedere a
Eleonora di poter avere “la versione aggiornata” di questo o quel pezzo, o addirittura
dell’intero copione. Foglietti scritti a mano, stampe, ristampe: si sono dovuti adattare a
questo nuovo salto di Emma» (L. Dalisi, Messa in scena della mafia. Cani di bancata: il metodo
maieutico di Emma Dante, cit., p. 26).
7 Vale la pena sottolineare come in effetti il testo pubblicato di Cani di bancata sia una
riduzione più fedele al testo recitato rispetto a tutti gli altri lavori presentati e poi pubblicati
dalla Dante (Cfr.: G. Bruno, Forza e verità in scena, intervista a cura di P. Bologna, in Palermo
dentro. Il teatro di Emma Dante, cit., p. 167). Per uno sguardo complessivo sui rapporti tra
scena e testo nel teatro della Dante si rimanda a: A. Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante.
Mpalermu, Carnezzeria, Vita mia, Pisa, Edizioni ETS, 2009.
116
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
modo così aperto di intendere la costruzione drammaturgica con una
modalità più classica di costruire il testo.
Come ha influito quest’impostazione sul lavoro dell’attore?
Mah, io ero alla prima esperienza in compagnia quindi posso parlare col
senno di poi, perché in quel momento non avevo un pregresso con il quale
rapportarmi. Rispetto alle esperienze fatte successivamente con Le Pulle o
Acquasanta e Operetta, Cani di bancata forse è un lavoro del quale nemmeno
Emma fu pienamente convinta. Quello che ricordo è la sensazione che il
tema spesso diventava preponderante rispetto al lavoro attorico, alla
costruzione della parte. L’argomento era più forte. Ti sentivi in dovere di
forzare, indirizzare una situazione verso un ‘discorso’ preciso, a tesi quasi.
In effetti, ripensandoci, è forse il lavoro in cui mi sono sentito più ‘guidato’
attraverso input registici in senso più stretto. C’era l’esigenza di
formalizzare ciò che scaturiva dalle improvvisazioni in maniera quasi
immediata, cosa che consuetamente avviene più in là rispetto alle sessioni
laboratoriali.
Restiamo su questa questione del rapporto tra il lavoro creativo aperto e la presenza
di una traccia scritta. Io, Nessuno e Poliremo è tratto da un testo preesistente
non destinato alla scena. Quando è diventato spettacolo, come è stato immaginato
l’inserimento di Odisseo? È un personaggio costruito a tavolino, partendo dal testo
e sul testo, o sei stato coinvolto direttamente lavorando con le improvvisazioni?
La ‘teatralizzazione’ di un lavoro che nasce non per essere agito sulla scena
è un’esigenza nata su un invito. Emma fu coinvolta nel contesto del 67°
Ciclo Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza e decise che la
manifestazione poteva rappresentare l’occasione per trasformare in
spettacolo quella che fino a quel momento era stata una sua personale
incursione nel reading. Si era venuta quindi a creare l’esigenza di
sviluppare la drammaturgia di partenza con musiche, movimenti e magari
di aggiungere un altro personaggio, dare voce al ‘grande assente’ di cui si
parlava costantemente nella versione Interviste impossibili: Odisseo. La sua
costruzione nasce e muore sulla carta. Ma anche in questo caso il progetto
era diverso da ciò che solitamente viene ‘pianificato’. Si trattava di costruire
una parte testuale da inserire in una drammaturgia scritta e preesistente.
Però, è stato interessante perché non mi è stato chiesto di interpretare la
parte di Odisseo. Ho effettivamente contribuito alla stesura di questo pezzo
mancante. La traccia narrativa mi è stata chiarita da Emma, quindi già ero a
conoscenza della piega che avrebbe preso il testo: Odisseo evocato, messo
in relazione con Polifemo, quali argomenti e questioni considerare, etc. Io
ho offerto una serie di spunti, degli stimoli che sono effettivamente stati
accolti, come quello di rileggere il mito in qualità di imbroglione, di uno
117
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
sciupafemmine. Una volta ricevuta la parte scritta l’ho tradotta in
napoletano al fine di ‘calzarla’ al meglio e sentirla mia il più possibile. Il
balletto di stampo televisivo, un po’ ispirato a Michael Jackson, è invece
frutto di un’improvvisazione nella quale facevo un gestaccio a Polifemo.
All’interno del teatro di Emma Dante hai immediatamente cominciato ad occupare,
fin dal tuo ingresso con Cani di bancata, il ruolo anche di scenografo. Come è nata
questa esigenza?
Da quando ho avuto i primi contatti con Compagnia Sud Costa
Occidentale, prima ancora di diventare uno degli attori, ho cominciato a
curare tutti gli aspetti visuali e grafici del loro lavoro. Dal primo sito
Internet alle locandine passando per le foto degli spettacoli. Tutte questioni
che hanno bisogno anche di un confronto, all’interno del quale
inevitabilmente portavo sensibilità e formazione che derivavano dai miei
studi di architettura. Direi che quindi è stato un percorso naturale essere
giunto a curare anche le scene negli spettacoli in cui cominciavo a dare il
mio contributo da attore. Ero già dentro un meccanismo creativo, non mi
servivano particolari indicazioni per realizzare le scene. È un’esperienza
confluita anche nelle regie liriche di Emma ad eccezione della Carmen.
Cosa significa per uno scenografo lavorare all’interno di un meccanismo che tende
all’essenzialità, alla quasi assenza di scene?
Non è facile. Parliamo di un regista che detesta la scenografia perché
considerata come un elemento che può trascinare l’esperienza teatrale nel
suo complesso verso la finzione. Emma sente sempre il rischio di cadere nel
posticcio. Poi, va aggiunto, in alcuni casi alcuni elementi che
successivamente risultano scenografici vengono integrati attraverso un
inserimento di tipo drammaturgico. È il caso, ad esempio, delle ancore di
Acquasanta. Ma ne potrei citare tanti altri. Ad ogni modo, si cerca sempre di
tenere ciò che risulta davvero indispensabile o all’azione o al disegno
complessivo.
Per conto mio, quando ragiono da scenografo, sposo in toto questo tipo
d’impostazione. Mi appartiene in termini di sensibilità. Al di là dell’essere
attore che recita in un contesto spettacolare quasi sempre spoglio. Il gusto
che ho maturato anche da architetto va in questa direzione. Mi sono sempre
interessato alla tendenza minimalista.
Tutto questo immagino sia impossibile realizzarlo con le opere liriche.
È un modo totalmente diverso di intendere la produzione che chiaramente
non può non andare a modificare l’impostazione consueta. In questi casi
dobbiamo per forza convivere con l’idea di un precostituito, prevedendo –
118
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
lasciandoci ispirare dalla musica e dal libretto – un impianto tecnico ed
espressivo e rappresentativo che inevitabilmente va ‘calcolato’, anche se
proviamo, credo riuscendoci, a lavorare durante le prove per sottrazione.
Tutto deve essere funzionale.
Questa dell’essenzialità, della sottrazione è una questione riconducibile a un
discorso di natura poetica?
Poetica – perché l’esigenza è quella di avere un palco più possibilmente
vuoto –, ma anche pratica. Il fatto di non provare con gli elementi definitivi,
ma con quelli provvisori, che magari hanno dimensioni diverse o anche un
peso diverso, porta spesso, ad esempio, a cancellare la presenza di
praticabili, perché poco organici rispetto ai risultati dati dalle prove. Infatti,
sto sviluppando la tendenza a immaginare le scenografie in base ai
materiali che so potenzialmente di poter avere fin da subito.
Da dove e da cosa parti quando cominci a lavorare ad una scenografia?
Parto sempre da una materia e da una suggestione legata a una certa
tendenza artistica. Nel caso di Cenerentola8 ho affrontato il pop-surrealism…
Ray Caeser è un grande estimatore di quest’opera e questo collegamento è
stato per me fonte di grande ispirazione. Da un materiale – in questo caso
era un tessuto teatrale, colorato che a un certo punto viene fatto cadere
dalle finestre, ma anche gli stucchi – e da una particolare fascinazione poi
sviluppo tutto il resto, sempre nel rispetto di un gusto e di uno stile molto
minimali, essenziali. Quando presi parte a La muta di Portici lavorai
nell’esatta direzione opposta alla magniloquenza, allo sfarzo ‘suggeriti’
dalla stessa opera. La presenza del Vesuvio era rappresentata dalla pietra
lavica, quella del Palazzo Reale era invece espressa da un lampadario e due
quadri. Per Gisela! ho ‘ridotto’ Napoli a un teatro ambulante mentre il
cambio di ogni scena era sottolineato sempre da una nuova apertura di
sipario che ne celava un altro che a sua volta si apriva rivelandone ancora
un altro e così via. Nella mia impostazione Napoli era ‘il teatro’. Potrei
tranquillamente sbizzarrirmi facendo costruire macchine teatrali, ma
significherebbe lavorare ad un disegno distante dalla regia e dalla mia
stessa sensibilità.
Rispetto al tuo ruolo, invece, di scenografo per gli spettacoli in cui sei attore, mi
sembra che Le Pulle avesse un impianto scenografico più ‘pensato’.
Si fa riferimento a La Cenerentola, opera lirica di Gioacchino Rossini andata in scena il 22
gennaio 2016 al Teatro dell’Opera di Roma.
8
119
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Sì, credo lo si possa definire un tipo di lavoro, dal punto di vista
scenografico, più vicino a quello che svolgo per le regie liriche. Una volta
che la drammaturgia era andata abbastanza definendosi, cominciarono i
confronti tra me e Emma per comporre le scene. Decidemmo per questi
veli.
L’impianto, sempre molto scarno comunque, poteva ritrarre all’occorrenza
un bordello o un interno. C’erano tre séparés retrattili in fila, ai lati dello
spazio scenico, e sullo sfondo un fondale damascato, coperto da due tende
rosse.
Ricordo che vivemmo con difficoltà il fatto di non riuscire a provare lo
spettacolo con la scenografia che poi ci avrebbe accompagnati per tutte le
repliche. Ne realizzai una versione ‘povera’ e ridimensionata alla Vicaria,
ma lo spazio non è certo quello di un teatro all’italiana, se non altro perché
è di gran lunga meno alto, a questo aggiungici che le scene definitive
arrivarono a teatro poco tempo prima del debutto. Alla fine decidemmo di
semplificare l’impostazione di partenza, che aveva delle potenzialità
maggiori, giocava su una maggiore articolazione, perché altrimenti avrebbe
significato tenere qualcosa di posticcio, per il gusto di farlo, perché
l’avevamo pensato in un certo modo, ma ‘staccato’ dalla nostra relazione
fisica con lo spazio, quella sperimentata con le scene realizzate a Palermo.
Eccezion fatta per Le Pulle, appunto, e comunque sempre entro certi limiti, le altre
scene da te firmate sembrano più orientate a cercare una strettissima relazione tra
l’azione attorica e il segno drammaturgico. In quali spettacoli questo rapporto, a
tuo avviso, è più forte?
Questo rapporto era presente già ai tempi di Cani di bancata. L’impianto
scenografico era costituito da undici sedie di altezza decrescente disposte
su due file per riprodurre la struttura gerarchico-piramidale che regolava le
relazioni tra Mammasantissima e i suoi affiliati. Una volta spostate, e
quindi utilizzate dagli attori, queste sedie diventavano altro: ad un certo
punto, ad esempio, servivano per ‘animare’ la festa della Madonna
dell’Arco.
Sulle tavole del palco c’era una vera e propria segnaletica, a noi utile per
ristabilire di volta in volta la posizione delle sedute, che sfruttammo anche
da un punto di vista espressivo. Ad esempio, c’era un momento in cui
Sandro Maria Campagna incassava un cazzotto e, anziché cadere steso
assumendo una posa casuale, finiva per ‘incastonarsi’ nella forma
disegnata sul palco di una sagoma ritratta in una precisa posa. L’idea era
quella di ispirarsi alle caselle dei giochi da tavolo come il Monopoli o Il
gioco dell’oca nelle quali i vari personaggi finivano per vedersi di volta in
volta ridefinito il proprio ruolo gerarchico all’interno del clan.
Però, come ho avuto modo di dire in precedenza, tengo molto alle scene di
Acquasanta. Quella sensazione di magia, quel clima surreale, nel quale
120
Carmine Maringola, La costruzione del personaggio
scoprivamo quanto funzionali fossero certi elementi e quali orizzonti
creativi dispiegassero, ancora oggi mi sembra un’esperienza unica.
Oltre alle ancore, inserite nelle prove e utilizzate come raccontato in
precedenza, i timer che caricavo a vista all’inizio dello spettacolo
stabilivano una relazione molto stretta con la mia recitazione. L’idea di
partenza era quella di attaccarli in tutto il teatro in modo che il pubblico
ascoltasse il ticchettio durante tutta la durata dello spettacolo proprio sopra
la sua testa. Successivamente, considerata la poca fattibilità, decidemmo di
fissarli alla ruota della bicicletta, posta in alto, in corrispondenza della
posizione occupata da ‘O Spicchiato. Il ticchettio era un modo per
riprodurre in scena il rumore della sala macchine, della navigazione, ma
più in generale i timer mi davano il tempo: sapevo di dover arrivare ad un
punto preciso del testo nell’esatto momento in cui tutti i dispositivi si
mettevano a suonare.
Chiudendo, mi sembra che il tuo percorso artistico, fino ad oggi, abbia teso a una
circolarità: la costante dell’elemento gruppo, lavorare in uno spazio stanziale,
anche superare ruoli e specialismi.
In effetti sono passato da un gruppo, Tutuguri, a una compagnia teatrale,
quella del Lelio, a un’altra compagnia. Non è una questione di stabilità, di
abitudine. Ha a che fare con le condizioni di base per fare teatro, per
alimentare e sviluppare l’esperienza del teatro. Forse da qualche anno sto
realmente vivendo quello che avevo sognato con Tutuguri ma che allora
non avevo messo a fuoco. Però, credo che appunto già all’epoca avevo
capito che la dimensione di gruppo, la questione di lavorare in uno spazio
tuo, nel quale ospitare laboratori, fare i tuoi laboratori, dare la possibilità di
far crescere un progetto e anche farci i lavori di ristrutturazione di tuo
pugno erano tutti aspetti fondamentali per ‘essere attore’ in maniera totale.
Magari è anche questa la ragione per la quale io sento come assolutamente
distante la dimensione del provino o – almeno in questo momento – quella
di essere diretto da un regista che si occupa più della messa in scena e
meno della creazione drammaturgica.
L’esperienza dello stare in compagnia la reputo davvero fondamentale per
il mio percorso. Alla Vicaria mettiamo a punto il nostro linguaggio e
affiniamo la nostra poetica. E non sarebbe possibile farlo altrove, con altri
ritmi e altre esigenze. Lì se ci sono una serie di situazioni che funzionano
abbiamo modo di sperimentarle fino in fondo, fino a quando ci va di stare
in quello spazio. Lì ci sono i nostri materiali: giochi, abiti, musiche, tutto
quello che ci serve per costruire il nostro teatro.
121
Jean
Mauduit-Larive CORSO DI DECLAMAZIONE
DIVISO IN DODICI INCONTRI
I Libri di AAR
Jean Mauduit-Larive
CORSO DI DECLAMAZIONE
DIVISO IN DODICI INCONTRI
Traduzione, introduzione e note di Valeria De Gregorio Cirillo
I Libri di AAR
Titolo originale: Cours de déclamation, divisé en douze séances
Paris, Imprimerie de Charles, 1804
Traduzione introduzione e note di Valeria De Gregorio Cirillo
Copyright © 2016 Acting Archives
Acting Archives Review, Napoli, Maggio 2016
ISSN: 2039-9766
ISBN: 9788894096729 INDICE
7
PREFAZIONE
38
Nota alla traduzione
CORSO DI DECLAMAZIONE DIVISO IN DODICI INCONTRI
PRIMO INCONTRO
40
43
45
48
Introduzione. Delle passioni considerate nei loro rapporti con l’arte
drammatica
Capitolo I. Dell’uomo
Capitolo II. Della donna
Capitolo III. Qualità solitamente necessarie a coloro i quali si
avviano alla carriera teatrale
SECONDO INCONTRO
52
57
Capitolo IV. Della voce e dei suoi effetti; della pronuncia e
dell’articolazione
Capitolo V. Della vista e dell’udito
TERZO INCONTRO
60
Capitolo VI. Della sensibilità in genere e dei ricordi
QUARTO INCONTRO
69
Capitolo VII. Delle emozioni e delle sensazioni
QUINTO INCONTRO
78
82
Capitolo VIII. Sull’espressione visibile
Capitolo IX. Dell’immaginazione
5
SESTO INCONTRO
87
94
Capitolo X. Dell’ispirazione
Capitolo XI. Della seduzione
SETTIMO INCONTRO
99
104
Capitolo XII. Della nobiltà e della dignità
Capitolo XIII. Del coraggio
OTTAVO INCONTRO
108
112
Capitolo XIV. Della verità
Capitolo XV. Del cuore buono e del cuore malvagio e delle
sfumature di entrambi
NONO INCONTRO
114
117
Capitolo XVI. Della gelosia
Capitolo XVII. Dell’imitazione servile, dell’affettazione e della
maniera
DECIMO INCONTRO
121
125
Capitolo XVIII. Delle sfumature e delle opposizioni
Capitolo XIX. Della dizione semplice e della declamazione; di
alcune amarezze legate all’arte drammatica
UNDICESIMO INCONTRO
132
Capitolo XX. Di alcune circostanze favorevoli o sfavorevoli al
talento e al successo
ULTIMO INCONTRO
142
146
Capitolo XXI Cause dello scadimento dei talenti; sale di spettacolo,
ecc.
Capitolo XXII Della critica, della necessità e dei mezzi per salvare i
teatri
6
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
PREFAZIONE
Dal vissuto della pratica teatrale alla teoresi, potrebbe così intitolarsi il
percorso memoriale che con solerte acribia Larive restituisce al pubblico dei
raffinati connaisseurs che lo hanno acclamato per più di un ventennio sul
più prestigioso palcoscenico dell’Europa dei Lumi e che ora possono venire
a conoscenza dei meccanismi esperiti nel modo di farsi interprete dei
grandi testi della tragedia classica fra Seicento e Settecento.1 Si scoprono
nelle sue pagine i rituali scenici, la persistenza dei codici interpretativi, le
sottigliezze del linguaggio drammaturgico, le problematiche del corpo, la
concretizzazione della mimesi del reale, ma anche la portata
dell’immaginazione e la spazialità metaforica del teatro.
Scrittura di una riscrittura, come lo stesso Larive rievoca nell’Introduction, il
Cours de déclamation si fonda sulle Réflexions sur l’art théâtral pubblicate nel
1801, che sono inserite in questa edizione del 1804 seppur con qualche
piccola modifica, costituendo la parte preponderante degli ultimi capitoli.2
Ma già nel 1795 Larive aveva affidato a «Le Moniteur» un articolo in cui
affrontava la tematica che al momento gli stava a cuore, quella cioè della
decadenza dell’arte teatrale; articolo che era stato per altro integralmente
riproposto nelle Réflexions.3
Era in qualche modo prassi comune che, una volta lasciato il palcoscenico,
un artista cercasse di prolungare la propria presenza offrendo lezioni di
recitazione, quando non editando le esperienze vissute; forse l’esempio
fondamentale per Larive era stato quello di Mlle Clairon.4 Tale percorso non
desta meraviglia, anzi costituisce persino argomento di commediole, come,
per esempio, il breve atto unico del Maître de déclamation.5 Rainville ha
deciso di abbandonare la scena, ma non vuole tornare in seno alla famiglia
che non ha mai condiviso la sua scelta di essere attore e a Bonneval che gli
chiede a quali risorse pensi di poter far ricorso per vivere, risponde:
Vedi, per una più completa conoscenza di Larive nella società del tempo, Valeria De
Gregorio Cirillo, Un attore e il suo repertorio dall’Antico Regime alla Restaurazione: Jean Mauduit
Larive, Napoli, Liguori, 2010. Da questo testo sono tratte alcune parti che figurano nel
presente lavoro.
2 Cours de déclamation, divisé en douze séances, par Larive. De l’imprimerie de Charles, À Paris,
chez Veuve Tilliard et Fils, Libraires, An XII, 1804, e precedentemente: Réflexions sur l’art
théâtral par J. Mauduit-Larive, À Paris, chez Rondonneau, Au dépôt des Lois, An IX [1801].
3 Quelques réflexions sur la décadence des théâtres, «La Gazette nationale ou Le Moniteur»,
rubrica Variétés, 10 aprile 1795, anno III, pp. 817-818.
4 Sui lunghi e proficui rapporti intercorsi fra Larive e Mlle Clairon, Cfr.: Memorie d’Hyppolite
Clairon e riflessioni sulla declamazione teatrale, traduzione, introduzione e note a cura di
Valeria De Gregorio Cirillo, in AAR, anno IV, n° 8, novembre 2014.
5 Commedia in un atto in prosa, pubblicata anonima, ma attribuita a Le Vacher de Charnois,
A Paris, chez Cailleau, M.DCC.LXXXIV. Rappresentata per la prima volta a Parigi al Théâtre
des Variétés Amusantes il 14 novembre 1782.
1
7 AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Le troverò nella professione che ho esercitato fino a oggi. Sarò Maître de
déclamation e questo gusto generalizzato per gli spettacoli mi dice che gli
scolari non mancheranno. Il caso me ne ha già procurato qualcuno che, per
riconoscenza o entusiasmo, ha gettato le prime fondamenta della reputazione
di cui ho bisogno. Il più difficile è fatto, la mia attività farà il resto.6
Bonneval cerca di dissuaderlo e di aprirgli gli occhi su un mestiere difficile
e contraddittorio: «Eh! Amico mio, dopo quindici anni non è ora di
rinunciare del tutto a una condizione seducente quanto iniqua, nella quale
dopo anni di successo conquistati con mille crudeli amarezze, si trova
spesso, come unica ricompensa, l’ingratitudine di coloro che abbiamo
deliziato?».7
Larive non limita il proprio impegno alla mera istanza pedagogica, ma
decide di pubblicare in un’opera organica quanto il tempo e la pratica
hanno supportato il suo essere in scena; la scelta del termine déclamation del
titolo ribadisce la centralità di quella problematica nella trattatistica
settecentesca.8 La déclamation, come ricorda Hérault de Séchelles nelle sue
Réflexions sur la déclamation, uno degli ultimi testi teorici del secolo,
corrisponde in parte all’actio degli antichi, e consiste in «tre cose, la
memoria, la voce e il gesto: tutte e tre si esercitano con l’esempio, la
riflessione e la pratica».9
Questo il programma che Larive si prefigge: partendo proprio da quanto il
palcoscenico gli ha insegnato e dal confronto con i partner, analizzare,
sostenuto dai testi drammaturgici, la pratica teatrale nonché ogni aspetto,
anche meccanico, che vi partecipi: voce, gestualità, mimica del volto,
immedesimazione, sensibilità, emozione, e fattori esterni come i costumi e i
meccanismi della ricezione.10
Le Maître de déclamation, cit., scena 1, p. 4.
Ivi, p. 5.
8 Si rimanda per un approccio puntuale al fondamentale studio: Claudio Vicentini, La teoria
della recitazione. Dall’antichità al Settecento, Venezia, Marsilio, 2012.
9 Hérault de Séchelles, Œuvres Littéraires, publiées avec une Préface et des Notes par Émile
Dard, Paris, Perrin, 1907 («Réflexions sur la déclamation», pp. 153-180, qui p. 153). Le
Réflexions, redatte probabilmente nel 1789, apparvero postume sul «Magasin
encyclopédique» nel 1795. Fra i testi teorici del tempo ricordo quelli che contengono nel
titolo il termine déclamation: Grimarest, Traité du recitatif dans la lecture, dans l’action publique,
dans la declamation et dans le chant. Avec un traité des accens, de la quantité & et de la ponctuation,
1707; Ravaillère, Essai de comparaison entre la déclamation & la poésie dramatique, 1729;
d’Aigueberre, Seconde lettre du souffleur de la Comédie de Rouën, au garçon de caffé, ou entretien
sur les défauts de la Déclamation; Luigi Riccoboni, Pensées sur la déclamation, 1738; Dorat, La
Déclamation théâtrale, poème didactique en quatre chants, 1771; Mlle Clairon, Mémoires et
réflexions sur la déclamation théâtrale, 1798.
10 Una seconda parte delle lezioni confluirà in un secondo volume diviso in due tomi: Cours
de déclamation prononcé à l’Athénée de Paris, par J. M. Larive, Lecteur de sa Majesté la Reine
d’Espagne, Correspondant de l’Institut de France, Membre de l’Académie Royale des Sciences et des
Beaux-Arts de Naples, Membre associé de la Société Philotechnique, etc., etc., tome second, en deux
6
7
8
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Larive lega inoltre strettamente l’insegnamento delle regole e dei princìpi
della recitazione alla propria esperienza personale, ai sentimenti,
atteggiamenti, moti interiori tratti dal proprio vissuto che hanno
accompagnato scoperte, soluzioni, rese sceniche di passaggi poetici del
repertorio interpretato. La narrazione ci rende così partecipi del percorso
induttivo di uno sperimentatore per il quale l’aderenza al personaggio è il
pensiero perspicuo nell’impegno esecutivo della tragedia: raccontare il
palcoscenico significa raccontare se stesso e la ricerca di una propria norma
rappresentativa.
***
Jean Mauduit è nato a La Rochelle il 6 agosto 1747,11 ultimo di cinque figli,
il padre aveva un commercio ben avviato di spezierie, ma forse poco capiva
il figlio che prima fugge in un’abbazia e poi a Honfleur, fin tanto che viene
spedito dal genitore a Santo Domingo. Il viaggio costituisce un tassello del
suo romanzo di formazione: emozioni, vicissitudini, accadimenti diventano
il sostrato irrinunciabile su cui edificare la futura personalità attoriale. Egli,
infatti, costituirà i personaggi attraverso un percorso memoriale di cui non
farà mai a meno, come ribadisce a più riprese nel Cours. Il filo costante del
ricordo è il supporto unico per rappresentare il pathos dei personaggi e per
dar loro il suggello della verità colta direttamente dalla realtà esperienziale.
La sua formazione teatrale viene riletta e presentata alla luce della maturità,
molti sono gli aneddoti che si riferiscono all’apprendistato in provincia e ai
debutti alla Comédie-Française, ricordi a volte divertiti e ironici, tal altra
ammantati di rimpianti e di pessimismo. Conosciuto con lo pseudonimo di
Larive, scelto in ricordo dell’ubicazione dell’impresa commerciale paterna
di La Rochelle, situata in un luogo denominato «la petite Rive», il suo nome
d’arte viene trascritto indifferentemente nelle grafie: La Rive, Larrive, de La
Rive, Delarive.
Il primo esordio alla Comédie-Française avviene nel dicembre 1770 e,
secondo la prassi in uso, il debuttante è tenuto a recitare nel repertorio in
programmazione, in modo che i componenti della compagnia e il pubblico
possano giudicare la validità della sua preparazione. Si presenta con sette
tragedie sostenendo successivamente la parte di Zamore nell’Alzire di
Voltaire, quella del Conte nel Comte d’Essex di Corneille, di Achille
nell’Iphigénie en Aulide di Racine, di Edipo nella tragedia eponima di
parties, [première partie, seconde partie], A Paris chez Delaunay,1810, (d’ora in poi citato in
nota come Cours, 1810, seguito dal numero della parte [I o II] e della pagina).
11 Non tutte le note biografiche su Larive riportano la data esatta di nascita: la Biographie
universelle ancienne et moderne par une société de gens de lettres (biographie Michaud), Paris, A.
Thoisnier Desplaces, 1843-1858, ad esempio, lo fa nascere nel 1744; Jean-Charles Harel nel
Dictionnaire théâtral, ou Douze cent trente-trois vérités sur les directeurs, régisseurs, acteurs, Paris,
chez J.-N. Barba, 1825, nel 1746; il Grand Dictionnaire universel nel 1749.
9
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Voltaire, di Cinna nel Cinna di Corneille, di Oreste nell’Iphigénie en Tauride
di Claude Guimond de La Touche e di Orosmane nella Zaïre di Voltaire.12
Mlle Clairon che lo aveva preparato all’esordio e presentato in società lo
segue trepidante dalla buca del suggeritore, dirigendo «il suo allievo a ogni
verso, a ogni passo, con gli occhi, la voce i gesti».13 Presenza scenica nella
parte di Zamore, portamento elegante e capacità vocale ben adeguata sono
i punti evidenziati dal «Mercure de France» che esprime un giudizio
lusinghiero sul talento del giovane esordiente: «Un aspetto favorevole, una
voce che ha forza e bellezza, vari passaggi ben compresi e ben sentiti nelle
parti recitate, e in più le lezioni della celebre attrice che ha presieduto al suo
debutto, danno su di lui speranze lusinghiere già confermate dai successi e
che aumentano di giorno in giorno».14
Terminato l’obbligo dei débuts, l’attore inizia la seconda fase del suo
impegno come double di Lekain e di Bellecour nelle prime parti tragiche e
comiche: reciterà fra il 23 febbraio e il 4 settembre 1771 in quarantadue
spettacoli.15 Al termine di tali prove, che sembravano aprirgli il
palcoscenico parigino, Larive abbandona il teatro per un insieme di ragioni
mai ben chiarite, consegnando una concisa annotazione nel Cours; ma
probabilmente non soddisfatto dal ruolo riconosciutogli di pensionnaire
(tappa obbligata per chi desiderava essere ammesso alla Comédie), perché
aspirava a diventare immediatamente sociétaire, come poi accadrà al suo
rientro.
Scrive Papillon de La Ferté nel suo Journal: «Lunedì, sono stato all’Assemblea degli attori.
[…] La sera, sono andato a vedere il debutto del sieur La Rive, allievo di Mlle Clairon.
Sebbene avesse perso la testa per la paura, il pubblico gli ha però trovato delle doti», Journal
de Papillon de La Ferté, intendant et contrôleur de l’Argenterie, Menus-Plaisirs et Affaires de la
Chambre du Roi (1756-1780), publié avec une introduction et des notes par Ernest Boysse,
Paris, Ollendorff, 18872, p. 286.
13 Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, Etc., éd.
Maurice Tourneux, Paris, Garnier, 1877-1882, 16 voll., «Correspondance littéraire», vol. IX,
gennaio 1771, p. 236.
14 «Mercure de France», gennaio 1771, p. 189. I «Mémoires secrets» registrano una grande
affluenza di pubblico alla rappresentazione dell’Alzire, dato che la prova del nuovo attore
veniva da tempo annunciata e che «la particolare attenzione di Mlle Clairon nel formarlo ne
aveva fatto concepire un’altissima opinione», Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la
République des lettres en France, depuis 1762 jusqu’à nos jours; ou Journal d’un observateur,
contenant les analyses de Pièces de Théâtre qui ont paru durant cet intervalle, les Relations des
Assemblées littéraires, les notices des livres nouveaux, clandestins, prohibés; les Pièces fugitives, rares
ou manuscrites…, Londres, John Adamson, 1777-1789, 36 voll., vol. XIX, 5 dicembre 1770, p.
287.
15 Larive ha recitato le seguenti parti: Achille (due rappresentazioni), Antiochus in Rodogune,
princesse des Parthes di Corneille (tre), Cinna (quattro), Conte di Essex (due), Orazio figlio ne
Les Horaces di Corneille (due), Giasone nella Médée di Corneille (tre), Lyncée
nell’Hypermnestre di Lemierre (due), Oreste (quattro), Pèdre nell’Inès de Castro di Lamotte
(tre), Rhadamiste in Rhadamiste et Zénobie di Crébillon (quattro), Rovere in Gaston et Bayard
di de Belloy (dodici), Sévère nel Polyeucte, martyr di Corneille (una).
12
10
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Nel lasso di tempo tra il 1771 e il 1775, quando Larive tornerà a Parigi per
ripresentarsi alla Comédie-Française, recita per circa due anni anche a
Bruxelles nella compagnia di Jean-Nicolas d’Hannetaire direttore del
Teatro della città.
Il «second début de M. La Rive» avviene il 29 aprile 1775 nella parte di
Oreste, e questa volta la prova è coronata da un consenso unanime, tanto
che viene nominato di lì a poco «sociétaire à demi-part».16 I comédiens
avevano infatti bisogno, e con un certa urgenza, di un attore capace di
sostenere le parti di Lekain la cui salute declinante non cessava di
preoccuparli. Il «Mercure de France» annuncia la presenza di Larive
nell’Œdipe, ribadendo i giudizi positivi in sintonia con quanto già espresso
in passato:
il giovane attore era già comparso quattro anni fa su questo palcoscenico dove
aveva annunciato i talenti che ha da allora perfezionato. Una bella voce, un
aspetto interessante, grande intelligenza, una nobile semplicità
nell’elocuzione, anima e fuoco nella passione, una recitazione naturale e
agevole, frutto della natura e di uno studiato talento, fanno sperare che
quest’attore avrà i più grandi successi su questo palcoscenico e che sosterrà
l’onore della scena francese.17
In questa attività iniziale, Larive si divide tra opere tragiche e comiche, lo si
vede alternativamente interpretare Maometto, il Cid, Gengis Khan in
sostituzione di Lekain partito per Berlino e Alceste; ma colpisce il suo
impegno soprattutto in parti nuove per lui: è Clitandre nelle Femmes
savantes, il Conte nel Glorieux, Damis nella Métromanie, Valère nel Joueur, il
Conte di Clarendon nell’Eugénie, Valère nel Tartuffe e Dom Juan nella pièce
di Molière. Grimm ne annota il successo soprattutto nel personaggio di
Clitandre, riconoscendogli una qualche analogia con Dufresne al quale
proprio Lekain era, a suo tempo, succeduto. Un altro pregio di Larive, oltre
a quello di saper recitare nei due generi, è la capacità di «parlare nella
tragedia, e di parlare senza ampollosità e senza familiarità».18
Che non sembri inutile accennare diacronicamente al repertorio di Larive, è
tramite questo che l’attore ha affinato la sua arte scenica e successivamente
16 Le nomine erano di competenza dei quattro Gentilshommes de la Chambre du Roi che, a
turno, si occupavano dell’organizzazione degli spettacoli. Il calcolo dei compensi degli attori
era fatto sulla base di 23 parti intere e fisse sulle entrate annuali, e di altre voci (feux,
spettacoli a corte, gettoni di presenza nei vari comitati…) proporzionali all’impegno
realmente assolto. Così l’attore, secondo parametri di merito e di anzianità, diventava
sociétaire di un quarto di quota, di mezza quota e infine «à part entière». Cfr.: per i
meccanismi amministrativi del teatro, Claude Alasseur, La Comédie française au XVIIIe siècle,
Paris-La Haye, Mouton, 1967. Nella lista cronologica dei comédiens, Larive occupa il 168°
posto, La Comédie-Française, 1680-1980, catalogue de l’exposition, Paris, Bibliothèque
Nationale, 1980.
17 «Mercure de France», vol. I, giugno 1775, p. 181.
18 «Correspondance littéraire», vol. XI, maggio 1775, p. 74.
11
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
elaborato le sue teorie, sintetizzando la ricaduta sul pubblico delle proprie
emozioni lungamente vagliate nel testo poetico, approfondendo i rapporti
tra gli attori in scena alla ricerca di quel prezioso equilibrio espressivo che
tenga conto di ogni nuance atta a delineare la fenomenologia dell’eroe
impersonato.
Dal repertorio di Lekain interpreta la parte di Nerone (Racine, Britannicus)
e Larive prova a distaccarsi dal suo modello non volendo rappresentare
solo la crudeltà del personaggio ma anche la giovinezza mutevole legata
alla virtù e al rispetto, pur se le passioni cominciano a modificarne il
carattere. L’attore racconta, in età matura, di aver fatto parte a Lekain di
alcune perplessità circa l’interpretazione più appropriata e che questi gli
aveva confidato di non essere del tutto soddisfatto dalla propria
esecuzione. Larive ne attribuisce il limite al fatto che il volto di Lekain, di
per sé severo, poco si adattava alla mobilità richiesta dall’ambiguo carattere
di Nerone: «c’è tra il crimine e la virtù una sfumatura molto difficile da
cogliere, gli slanci non sono abbastanza pronunciati per cambiare
l’espressione naturale del volto»19 e nella scena con Junie, ad esempio,
Lekain non riusciva a esprimere nella giusta misura le diverse gradualità
dei sentimenti. Quello che Larive lascia intendere in filigrana è uno
scrupoloso percorso fenomenologico: qualsiasi personaggio si voglia
rappresentare, bisogna ogni volta coglierlo nel suo divenire psichico.
L’impegno del Nostro è assai arduo in quanto si vede continuamente
paragonato al mostro sacro, all’interprete prediletto di Voltaire, al sublime
rappresentante dell’arte attoriale, al tragico per eccellenza. A detta di
Grimm la rassomiglianza fra lui e Lekain è improponibile, come si evince
dall’esteso brano che la «Correspondance littéraire» dedica a Larive, dove il
critico riesce a evidenziare, con rara competenza espositiva, le
caratteristiche e le capacità espressive del giovane attore:
Ha ricevuto dalla natura tutto ciò che l’altro ha dovuto conquistare a forza
d’impegno e di fatica. Con tratti pieni di nobiltà e ben delineati, una statura
elegante ed equilibrata, un portamento naturalmente disinvolto e aggraziato,
ha voce gradevole e sonora, anche se ancora un po’ velata, la pronuncia pura
e chiara […] ha quell’istinto che intuisce e coglie facilmente quanto può
interessare o piacere, ha inoltre quella grazia semplice e nobile che esprime
senza sforzo ciò che il gusto gli fa percepire e tali doni naturali servono forse
in maggior misura nell’arte della declamazione che le conoscenze più
approfondite.20
Gli inizi di una carriera per l’attore non sono certamente facili: inserirsi in
un consesso pieno di fazioni e di rivalità, ma anche imporsi con uno stile
proprio, quando si è tenuti poi a riempire spesso un ruolo di rimpiazzo,
19
20
Cours, 1810, I, p. 95.
«Correspondance littéraire», vol. XI, maggio 1775, pp. 73-74.
12
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
significa essere facile preda per le critiche. Ma alla soglia dei trent’anni
Larive è giunto alla completa maturità della modulazione della voce, che
gli permette di variare i toni nelle più svariate sfumature foniche:
La voce era incantevole: piena, potente, dolce, sonora e di una così prodigiosa
flessibilità che non si saprebbe come fare se si volessero contare le corde di un
simile strumento per trovare un limite alla sua estensione e una misura per le
inflessioni che, a volontà dell’attore secondo il suo animo e le sue passioni,
servivano a modificare i suoni, alzarli, abbassarli e spezzarli, qualunque fosse
la gamma della voce, dal comando all’obbedienza, dalla gelosia alla fiducia,
dall’odio all’amore, dal furore alla tenerezza, dalla tempesta del cuore alla
calma perfetta dei sensi.21
Una certa distanza che Larive prende dopo il 1778 dalla scena parigina è
forse dovuta a ragioni complesse: la morte di Lekain aveva comportato la
necessità di ristabilire nuovi equilibri all’interno dei sociétaires e Larive
viene a trovarsi in competizione con Monvel da un lato e con Molé
dall’altro. Mentre con quest’ultimo vanno divise le prime parti tragiche, per
la commedia – territorio privilegiato di Monvel – Larive è ben disposto a
rinunciarvi. I «Mémoires secrets», già in febbraio, segnalavano le divisioni
che laceravano gli attori per l’eredità del repertorio di Lekain: Molé
pretendeva di aver diritto a scegliere per primo le parti per ragioni di
anzianità (era sociétaire dal 1761); Monvel ne reclamava altre più consone
alla sua fisicità «in modo che non restavano a Larive che una decina di parti
dette, in termini tecnici, i taureaux [tori], e cioè le parti a teatro più violente
che richiedono polmoni di cui entrambi sono sprovvisti».22 Larive,
appellandosi ai regolamenti, osservava invece che essendo stato assunto
come rimpiazzo di Lekain, tutte le sue parti gli appartenevano. La
contestazione vivacissima con ingiurie e minacce sarà gestita dal duca di
Duras, il cui giudizio è salomonico: le parti saranno divise fra i contendenti
esattamente in tre.
Larive si cimenta anche nella scrittura teatrale: il suo Pyrame et Thisbé viene
rappresentato alla Comédie-Française interpretando la parte del
protagonista.23 Per la «Correspondance littéraire» nuoce forse al
21 Jean-Nicolas Bouilly, Soixante ans du Théâtre-Français. Par un amateur, né en 1769, Paris,
Charles Gosselin, MDCCCXLII, pp. 47-48.
22 «Mémoires secrets», vol. XI, 21 febbraio 1778, p. 132.
23 Il modello cui si rifà è costituito dal Pygmalion di Rousseau. La scène lyrique è
rappresentata il 2 giugno 1783 (5 repliche), la musica composta da Antoine Laurent Baudron
che aveva elaborato la parte musicale del Barbier de Séville. Il soggetto di Piramo e Tisbe,
tratto da una favola d’Ovidio nel racconto di una delle Miniadi (Metamorfosi, IV, vv. 55-166),
era già stato più volte trattato, in modo ironico da Shakespeare nel A Midsummer-night’s
dream (1598) e nel Romeo and Juliet (1595-96); e poi, in particolare, da Théophile de Viau (Les
Amours tragiques de Pyrame et Thisbé) nel 1623; da Jean Puget de La Serre nel 1629 (Le Pyrame);
da Jacques Pradon nel 1674 e, più tardi, nel 1781, da un certo Martineau. Cfr.: per uno studio
sulla presenza di questo mito nelle opere teatrali, ma senza nessun accenno al testo di
13
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
melodramma, il fatto che il racconto sia molto conosciuto, e che si passi
dall’idillio iniziale alla scena tragica del finale senza alcuna transizione; pur
seguendo da vicino Ovidio, l’autore «ha sviluppato varie circostanze nel
modo più felice e più idoneo a formare un quadro drammatico».24 Le
analisi proposte dalla stampa testimoniano l’attenzione data all’evento. Il
«Mercure de France», dopo aver stilato un dettagliato riassunto del lavoro,
passa all’analisi delle due scene. La prima «ha calore, energia, entusiasmo,
movimento e sensibilità. I sentimenti che occupano, agitano e dilaniano il
cuore di Piramo, sono ben delineati e la loro progressione è condotta con
arte il che dimostra la conoscenza del cuore umano».25 La seconda invece
non si situa in linea con la precedente e per due ordini di ragioni, entrambe
collegate all’argomento; lo spettatore si aspetterebbe, dopo le esternazioni
drammatiche e dolorose di Piramo, una più marcata sottolineatura nel
dolore di Tisbe, e invece entrambi agiscono nell’identica modalità
rappresentativa e nel medesimo registro emozionale. Larive, nello sforzo di
offrire un pathos più accentuato al dolore di Tisbe e di risolvere la
necessaria diversità tra le due scene – anche se non c’è ideologicamente una
gran differenza tra la presenza di un velo insanguinato e quella del corpo
dell’amante che si è ucciso per disperazione – non esita a contravvenire alle
regole delle bienséances, e a far ricorso a una più realistica ed esplicita
angoscia della donna, che apparirà «prona, quasi sdraiata sul corpo
dell’amante, che stringerà fra le braccia e coprirà di baci e di lacrime»,
offrendo «uno spettacolo al quale la nostra delicatezza non può abituarsi»,26
eppur significativo del sentire di Larive.
Che il Nostro sia ormai un personaggio di grande rilevanza è dimostrato
dal fatto che al Salon del 1785 venga esposto il suo busto, opera di JeanAntoine Houdon,27 che aveva già ritratto varie celebrità in campo artistico
come Gluck, Molière, Voltaire, Diderot, Rousseau…28 Con il capo
leggermente volto a sinistra, nell’espressione drammatica del Bruto
voltairiano, drappeggiato in una ricca toga trattenuta sulla spalla sinistra
da una fibula a forma di medaglione, la scultura ricorda i modelli della
Larive: Laura Rescia: «Pyrame et Thisbé dans le théâtre dramatique et lyrique aux XVIIe et
XVIIIe siècles», Le Héros légendaire sur les scènes du théâtre et de l’Opéra, Actes du 9e Colloque
International publiés par la Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de
l’Opéra et du Ballet, sous la direction d’Irène Mamczarz, Firenze, Leo S. Olschki Editore,
«Teatro studi e testi», 2001, pp. 157-171.
24 «Correspondance littéraire», vol. XIII, luglio 1783, p. 328.
25 «Mercure de France», 14 giugno 1783, p. 101.
26 Ivi, p. 102.
27 Un modello in terracotta era già stato esposto al Salon del 1783, n° 251; la statua in marmo
è in mostra al Salon, nell’agosto-settembre 1785, n° 227.
28 Probabilmente commissionato dall’attore stesso, il busto in marmo, che porta la data del
1784, sarà offerto dal figlio Achille alla Comédie-Française dove è attualmente collocato nel
foyer degli artisti.
14
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
statuaria classica romana e ricalca, come mette in evidenza Louis Réau,29 i
busti dell’imperatore Caracalla. Lo scultore, in questo lavoro, ha reso con
viva partecipazione il carattere di Bruto escusso dalla storiografia per
riportarlo nella temperie dell’accadimento teatrale; il volto ha tratti di una
profonda concentrazione psicologica, pronto, nelle labbra serrate, nel
corruccio dei sopraccigli, nello sguardo intenso, ad aprirsi all’accusa nei
confronti di Cesare che scaturisce dalla sua idea di libertà repubblicana.
Forse per la distanza che lo spettatore prende dai testi classici, forse per la
noia di riproposte svuotate d’interesse, sta di fatto che in quella stessa Zaïre
in cui aveva tante volte trionfato, Larive viene fischiato dal pubblico della
Comédie; il suo orgoglio non accetta un simile affronto e prende
l’immediata decisione di lasciare il teatro con tutta l’amarezza di essere
stato trattato ingiustamente. Grimm, nel relazionare i fatti e la decisione del
Nostro di abbandonare le scene, ne ritraccia la figura attoriale e i momenti
salienti del suo percorso artistico:
La natura gli aveva prodigato privilegi che accorda raramente, e c’erano molte
parti, come quelle di Montaigu, di Bruto, di Edipo, di Cinna, di Oreste, etc.,
nelle quali il suo talento era illimitato. I suoi compagni, ad eccezione di Molé,
hanno fatto tutto quanto dipendeva da loro per fargli cambiare la decisione,
ma i loro tentativi sono stati inutili.30
Larive non intende ragioni: «gli infami non mi rivedranno più»31 urla, e
l’immediata richiesta di pensionamento viene accettata dal duca di Duras.
Larive si trova così, alla data cardine del 1789, al di fuori delle tante
discussioni e controversie che agitano il mondo teatrale, delle petizioni e
osservazioni che oppongono drammaturghi e interpreti alla vigilia del
riconoscimento del diritto d’autore, della liberalizzazione dei teatri32 e della
proclamazione dei diritti civili fino ad allora preclusi agli attori.33 Non
partecipa all’esaltante scrittura collettiva del Cahier des doléances, né tanto
29 Louis Réau, Houdon sa vie et son œuvre, Paris, F. de Nobele, 1964, 2 voll., vol. I, p. 380. Busto
che lo studioso mette in parallelo, per il carattere teatrale e declamatorio, con quello della
cantante Sophie Arnould (1744-1802), ritratta, nel 1775, nella parte di protagonista
dell’Ifigenia in Aulide di Gluck.
30 «Correspondance littéraire», vol. XV, giugno 1788, p. 271.
31 Ivi.
32 In base al decreto sulla libertà dei teatri (legge del 13 gennaio 1791, sostenuta da Le
Chapelier e Mirabeau) era stata data la possibilità a qualsiasi cittadino di aprire un nuovo
spazio scenico.
33 Gli attori, come ben si sa, non godevano di tutti i diritti civili ed erano anche messi al
bando dalla Chiesa; Larive, come già aveva fatto Mlle Clairon, prenderà posizione per la
sepoltura cristiana degli artisti. L’occasione gli sarà dettata dai tempestosi funerali di Mlle
Raucourt, morta il 15 gennaio 1815 cui il parroco di Saint-Roch negava l’ingresso in chiesa.
Fu l’intervento provvidenziale di Luigi XVIII a salvare la situazione che ne comprese
immediatamente la valenza politica e il discredito che sarebbe ricaduto sull’autorità della
prima Restaurazione.
15
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
meno alle assemblee degli attori che ora vengono pubblicate in esili
opuscoli, che documentano quanto la prise de parole da parte di ogni
categoria sociale sia una preziosa acquisizione cui sarebbe pregiudizievole
rinunciare.
Nel 1790 Larive accetta di tornare in scena dopo lunghe trattative condotte
con molta circospezione da parte dei sociétaires che, non vedendo di buon
occhio le novità che Talma voleva imporre nella sua fulminea ascesa, si
trovavano nella necessità di avere a disposizione un attore in grado di
contrastarlo. Dopo il successo straordinario di Talma nel Charles IX di
Marie-Joseph Chénier, lui e Dugazon si erano sentiti autorizzati a dettar
legge.34 L’abate Gouttes, già vicario del Gros-Caillou e presidente
dell’Assemblée nationale, amico di Larive da lunga data, con un intervento
risolutivo era riuscito a convincerlo, evocando la sua presenza quale atto di
civismo: non permettere che si addebitasse la decadenza del teatro
nazionale alla nuova assise politica.
Se la scelta di riportare Larive sul palcoscenico di primo acchito può
sembrare efficace e produrre frutti immediati, nel tempo si rivela perdente
come sottolinea, con estrema concretezza, e a distanza di anni, Fleury che
ha partecipato a quelle sofferte decisioni:
Dirò che quel ritorno fu un nostro vero torto, ben inteso non voglio negare il
prestigio del talento di Larive che è fuori discussione, ma a causa dello spirito
di quel ritorno deciso non tanto per il talento quanto piuttosto per l’influenza
e il contrappeso. […] non avevamo riflettuto che bisogna cambiare diplomazia
secondo i tempi; procedevamo sempre su antichi errori e quando
chiamavamo Larive per opporre il despotismo degli antichi regolamenti alla
giovane tirannia che ci minacciava, non pensavamo che con un’altra nazione
stava per apparire un altro teatro, che questa nuova nazione aveva bisogno di
attori nuovi, attori giovani come lei, con i nervi tesi come lei, senza legami col
passato, pronti ad affrontare ogni rischio.35
Per il suo rientro, nel maggio 1790, Larive sceglie d’interpretare Edipo,
l’affluenza del pubblico è notevolissima e all’apparire in scena, si scatena
un entusiasmo irrefrenabile. L’articolo che gli dedica il «Moniteur
universel» è assolutamente ditirambico:
Il modo in cui Larive ha reso la parte di Edipo ha suscitato un’ebbrezza
generale […]. Mai questo attore ha riunito in una sola parte un così gran
numero di quelle bellezze essenziali che annunciano un talento profondo e
consumato. Una dizione pura, una nobiltà al tempo stesso fiera e sensibile,
una conoscenza ragionata degli effetti, tutte le risorse dell’anima, del patetico,
dell’intelligenza, l’impiego di forme felici negli sviluppi pittoreschi del corpo,
34 E dire che, come riporta Frédéric Loliée: «Larive aveva rifiutato come orribilmente
antipatico il carattere del re-assassino», La Comédie-Française. Histoire de la Maison de Molière,
1658-1907, Paris, Lucien Laveur, 1907, p. 149.
35 Mémoires de Fleury, de la Comédie-Française, de 1757 à 1820, précédés d’une introduction et
publiés par J.-B.-P. Lafitte, Paris, Charles Gosselin, 1844, 2 voll., vol. II, p. 14.
16
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
e quell’arte difficile di passare da un sentimento all’altro, da un tono rapido
ed elevato a un tono più semplice e smorzato, senza nulla precipitare.36
Di tutt’altra natura e di diversa impostazione ideologica, l’articolo del
settimanale le «Révolutions de Paris» in cui ci si sorprende di dover
constatare che, malgrado l’avvento del regno della libertà, il gusto per gli
spettacoli e l’infatuazione per gli attori non siano mutati e che il ritorno
sulle scene di Larive provi tuttora la persistenza dell’abitudine alla
schiavitù: «le lodi più disgustose hanno subissato questo eccellente attore;
le dichiarazioni degli scrittori, anche patrioti, che hanno parlato della sua
recitazione in Edipo confrontate con quello che hanno detto di più saliente
sulla causa della patria e della libertà, eccitano nel contempo indignazione
e pietà».37
Cambia per altro anche il pubblico, recensendo la sua esibizione nella parte
di Bruto nella Mort de César di Voltaire, l’articolista non vuole soffermarsi
tanto sulla recitazione, quanto sull’effetto prodotto negli spettatori
dall’unica tragedia che inneggi alla libertà. Il teatro era gremito «da quella
classe intermedia che oscilla tra la ricchezza e la miseria, tra le grandi
conoscenze e l’ignoranza, e la cui voce costituisce la vera opinione
pubblica».38
La sua presenza non basta tuttavia a risollevare le sorti del teatro né a
contrastare il successo di Marie-Joseph Chénier e di Talma, sostenuti da
una personalità forte come quella di Mirabeau. Sempre più lo spazio
teatrale va delineandosi come spazio politico; ne fa un’amara constatazione
Larive durante una tournée, a Caen, notando una disaffezione da parte del
pubblico: «I musicisti, sebbene controvoglia, suonavano ogni sera e due
volte piuttosto che una il Ça ira; e la ricca clientela, irritata da quest’aria, si
asteneva dal mostrarsi a teatro».39
Il «Mercure de France» offre un’acuta analisi della situazione, col
sottolineare che le divergenze che affliggono il teatro si ricollegano ad
aspetti generali relativi a strutture e organizzazione. In una congiuntura
confusa e conflittuale:40 vanno superati i dissensi personalistici, né va
dimenticato che il Théâtre-Français ha fatto la gloria della Francia. Nessuno
persegue lo scopo di distruggere il teatro, bensì solo gli odiosi privilegi sui
quali si è a lungo fondato e gli attori, spogliandosi dei pregiudizi legati
all’Ancien Régime, dovrebbero riconoscere le trasformazioni in atto,
«Le Moniteur universel», n° 126, giovedì 6 maggio 1790.
«Révolutions de Paris», n° 44, 8-15 maggio 1790, p. 229.
38 Ivi.
39 Paul d’Estrée, Le Théâtre sous la Terreur (Théâtre de la Peur) 1793-94, d’après des publications
récentes et d’après des documents révolutionnaires du temps imprimés ou inédits, Paris, Émile-Paul
frères, 1913, p. 372.
40 «Mercure de France», sabato 20 novembre 1790, pp. 113-114.
36
37
17
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
accettando come giudice il Tribunale della Municipalità, unico garante per
rinnovare il passato splendore.
Ma non tutto, nella libertà proclamata da ogni parte, ha riflessi positivi.
Alla riapertura della stagione, il 2 maggio 1791, si è ormai consumata la
scissione tra gli attori della troupe: da una parte i novatori, i «rouges» o
«démocrates», Talma in testa seguito da Dugazon e Grandmesnil, da Mlles
Lange, Desgarcins, Simon e Mme Vestris, che si uniscono alla compagnia
delle Variétés Amusantes dando vita al Théâtre de la République; e
dall’altra i «noirs» o «monarchistes» legati alla tradizione monarchica,
Fleury, Naudet, Dazincourt, Molé, Mlles Contat e Raucourt, e naturalmente
Larive. Si realizza così, in modo repentino e traumatico, quel desiderio di
un secondo teatro ufficiale, già sostenuto in passato, che avrebbe dovuto
favorire una maggiore libertà nel repertorio e un’apertura alla
rappresentazione di testi ingiustamente detenuti da una minoranza.41
Gli eventi politici si ripercuotono sul teatro: nel 1792 l’equilibro dello stato
viene sovvertito, il 20 aprile la Francia rivoluzionaria è entrata in guerra
contro l’Austria, il 20 giugno, giorno anniversario del giuramento del Jeu
de Paume e della fuga del re, le Tuileries sono invase dalla folla che sfila
durante otto ore davanti a Luigi XVI; il manifesto del duca di Brunswick,
affisso a Parigi il primo agosto, che minaccia rappresaglie militari
durissime contro la città in caso di oltraggio alla famiglia reale, provoca
l’insurrezione popolare: le Tuileries sono assalite dalla folla e la famiglia
reale viene imprigionata dal governo rivoluzionario dalla Commune nella
torre del Tempio. I massacri di settembre insanguinano la città: le prigioni
sono prese d’assalto dai rivoluzionari che fanno strage dei detenuti,
soprattutto aristocratici e preti refrattari. Il 21 settembre, dopo la vittoria di
Valmy, la Convention abolisce la monarchia e proclama la Repubblica
francese, una e indivisibile. I vocaboli di Monsieur e Madame sono banditi e
sostituiti da citoyen e citoyenne, il voi viene accantonato per un tu egualitario
e anche le pièces dovranno essere corrette in tal senso.
In questo periodo Larive deve aver scelto di tenersi lontano da Parigi, solo
il 27 settembre torna nel Philoctète i cui introiti saranno devoluti alle spese
per la guerra e, segno della nuova temperie, alla fine dello spettacolo «M.
Bourgeois, autore del Théâtre du Vaudeville, ha cantato l’inno dei
Marsigliesi». Le difficoltà affrontate dagli attori sono sotto gli occhi del
pubblico anch’esso invischiato in una spirale di violenze e di precarietà.
Fra settembre e dicembre Larive recita in tredici spettacoli, sempre del suo
repertorio classico, riesumando Pygmalion e Zaïre, nostalgico di un teatro
Con l’abolizione della censura e del monopolio sulle opere di loro appartenenza, quel
famoso repertorio che i comédiens avevano difeso per decenni contro ogni possibile
ingerenza, le opere dei drammaturghi morti da più di cinque anni diventano di dominio
pubblico, mentre quelle degli autori in vita possono essere rappresentate previo formale
consenso scritto.
41
18
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
che non sia solo di propaganda politica e che il pubblico sembra
apprezzare, riprendendo anche l’Alzire di Voltaire dove interpreta, lo stesso
personaggio di Zamore con cui aveva debuttato. Larive non può certo dirsi
un attore già superato perché ha solo quarantacinque anni, eppure l’astro
nascente di Talma lo relega in un limbo ripetitivo, in cui continua a
riproporre le grandi tragedie ormai ‘classiche’ che fanno parte di un
bagaglio connotato Ancien Régime. Il suo ritorno sulle scene, se ha
certamente deliziato una parte di pubblico ancora legata agli stereotipi
tragici consolidati, non ha prospettato nuove aperture che corrispondano
alle istanze, anche politiche, del momento storico.
Nel 1793, la presenza di Larive figura una sola volta il 9 gennaio nel
Mithridate. Pochi giorni dopo, il 21, a conclusione di un processo farsa
iniziato l’11 dicembre, Luigi XVI viene condannato a morte e ghigliottinato.
La Convention non risparmia il teatro, che viene tenuto sotto stretta
sorveglianza, ripristinando una forte censura ideologica: il decreto del 2
agosto obbliga gli attori a recitare opere inneggianti alla rivoluzione e a
rappresentare gratuitamente, una volta ogni decade, alcune tragedie come
Brutus, Caïus Gracchus e Guillaume Tell in grado di alimentare nei cuori
l’amore per la libertà.42 Il decreto aggiunge che i teatri dove si fossero
rappresentate «pièces volte a corrompere lo spirito pubblico e a ricondurre
all’amore della monarchia» sarebbero stati immediatamente chiusi e i
proprietari arrestati,43 sorte che doveva toccare agli attori della Comédie,
tra cui ovviamente Larive, arrestato nel mese di settembre. L’anno
successivo, il 25 fiorile anno II (14 maggio 1794), viene ristabilita la censura
preventiva: i teatri sono tenuti a comunicare in anticipo il repertorio e i testi
epurati da ogni termine che ricordi l’Ancien Régime.
Come poter continuare a comporre tragedie, si domanda Ducis, quando «la
tragedia corre nelle strade. Se metto i piedi fuori casa, il sangue mi arriva
alle caviglie. Per quanto rientrando sbatta i piedi per togliere la polvere
dalle mie scarpe, mi dico come Macbeth: Questo sangue non scomparirà. […]
Dramma temibile quello in cui il popolo recita la parte del tiranno».44
Larive, pur provato nel fisico e nel morale dopo la prigionia di cui racconta
nel Cours e che termina con la fine del Terrore, riprende la sua attività
tornando in scena il 24 termidoro anno II (11 agosto 1794) nel Guillaume
Tell. La sala del faux-bourg Germain è stata rinnovata nell’interno secondo
aggiornati canoni che si vogliono «popolari», eliminando in particolare le
separazioni tra i palchi per ottenere un unico spazio semicircolare ad
anfiteatro. Sono stati inoltre soppressi i palchi prospicienti il palcoscenico
42 Tragedie rispettivamente di Voltaire, di Marie-Joseph Chénier (3 atti in versi,
rappresentata per la prima volta al Théâtre de la République il 9 febbraio 1792) e di
Lemierre.
43 «Journal des spectacles», agosto 1793.
44 Jean-François Ducis, Œuvres, Bruxelles, Lacrosse Libraire-Éditeur, 1834, 4 voll., vol. II, p.
174.
19
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
che ponevano il pubblico troppo vicino agli attori alterando così l’illusione
teatrale e sostituiti, ai lati del proscenio, da grandi nicchie dipinte dove
figurano le statue della Libertà e dell’Uguaglianza. Malgrado la
partecipazione del pubblico, la compagnia, formata in modo raccogliticcio,
non ritrova un’unità produttiva e le diserzioni che si susseguono portano
alla chiusura del teatro già a fine dicembre.
I tempi oscuri del Terrore, tendono a essere rimossi, ma in pari tempo si
avverte la necessità di rivelare il mostruoso progetto oscurantista
appartenuto ai sostenitori di Robespierre di «annientare tutto quanto possa
illuminare ed elevare la specie umana»45 come afferma La Harpe nel
discorso pronunciato in apertura del Lycée républicain, tremenda ekphrasis
degli orrori appena trascorsi e che Larive doveva ben conoscere:
Mi sembra di vederli ancora quei briganti dal nome di patrioti, quegli
oppressori della nazione dal nome di magistrati, riversarsi a ondate fra noi
con le loro vesti grottesche che definivano quelle del patriottismo, come se il
patriottismo dovesse essere assolutamente ridicolo e sporco; con il loro tono
volgare e il linguaggio brutale che definivano repubblicano, come se la
volgarità e l’indecenza fossero essenzialmente repubblicane; con il viso
stravolto e gli occhi torvi e feroci, segni della cattiva coscienza; gettando
dappertutto i loro sguardi, al tempo stesso stupidi e minacciosi, sugli
strumenti scientifici di cui non conoscevano neanche il nome, sui monumenti
delle arti che erano loro estranei, sui busti di quei grandi uomini di cui
appena avevano sentito parlare; e si sarebbe detto che l’aspetto di tutta quella
magnificenza letteraria, di quel lusso innocente, di quelle ricchezze della
mente e del talento, risvegliassero in loro un odio sordo e feroce, una rabbia
interiore, nascosta nelle pieghe più nere del loro amor proprio che istiga in
segreto l’uomo ignorante e perverso contro tutto ciò che vale più di lui.46
Uno degli ultimi interventi del Directoire in campo di politica teatrale, viste
le difficoltà finanziarie delle compagnie, è di sollecitare gli attori a
ricostituire l’antica Société des comédiens nella sede definitiva del Théâtre de
la République, rue de la Loi, che riapre il 30 maggio 1799. Al momento del
ricongiungimento, le prime parti tragiche, in virtù delle sue funzioni e
dell’anzianità, sono appannaggio di Larive; ma, come ricorda Lanzac de
Laborie, l’attore, prematuramente invecchiato, «non riceveva più dal
pubblico del Consulat che sarcasmi», tanto che si sospettava che si trattasse
di una montatura supportata dai giornali per disorganizzare la compagnia
appena ricostituita, rendendo Larive inviso agli spettatori.47 Le traversie
della Rivoluzione hanno lasciato ferite profonde che il tempo non riesce a
La Harpe, De la guerre déclarée par nos derniers tyrans à la Raison, à la Morale, aux Lettres et
aux Arts. Discours prononcé à l’ouverture du Lycée Républicain, le 31 décembre 1794, Paris, chez
Migneret, an IV, 1796, p. 5.
46 Ivi, p. 4.
47 Léon de Lanzac de Laborie, Paris sous Napoléon, Le Théâtre-Français, Paris, Plon, 1911, 8
voll., vol. VII, p. 65.
45
20
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
sanare, presenti nel ritratto che dell’attore traccia Fabien Pillet e che
sembrano condizionarne la recitazione:
Le sofferenze provate da questo celebre attore tragico sotto il regime
decemvirale (è stato messo fuori legge da un comitato rivoluzionario) hanno
un po’ alterato i suoi mezzi e in particolare la forza della voce e si nota con
rammarico che vuol ovviare a questo indebolimento con sforzi un po’
esagerati. […] Questi lo portano lontano dal vero, sostituendo così un
leggerissimo difetto con un difetto reale e vistoso. La voce che gli resta è
ancora la più bella che abbiamo a teatro ed è solo risparmiandola che può
sperare di renderle la sua primitiva estensione.48
Larive non ha nessuna intenzione di rinunciare a talune prime parti che,
secondo Pillet, non sono più consone alle sue capacità, anzi questi
suggerisce all’attore di operare una divisione con Talma attenendosi alle
parti che richiedono i modi diretti e leali della cavalleria. Questo
significherebbe per Larive un cambiamento confacente all’età, anche se in
fondo ha solo cinquantadue anni e all’epoca non si era poi troppo attenti
alla verosimiglianza fisica, ma il Nostro non prenderà in conto tali
suggerimenti e le rappresentazioni che lo vedranno protagonista tra
settembre 1800 e maggio 1801 attingono alla tradizione del suo repertorio
(Spartaco, Vendôme, Filottete).
Se la presenza di Larive al Théâtre-Français poteva all’inizio aver
preoccupato Talma, visto che il pubblico ne aveva in qualche modo
sollecitato il ritorno e che Pillet aveva salutato l’attore come «il più
veramente tragico perché lui solo nobilita l’animo dello spettatore»,49 le
prove che offre, malgrado sprazzi di alta drammaticità, restano discutibili.
Larive, in certe parti tragiche, non è più molto convincente, la voce non è
più la stessa di un tempo e solo a sprazzi riappare l’antica energia.50
Che si tratti della ripresa di Rhadamiste et Zénobie o dell’Orphelin de la Chine,
la critica si divide sulla situazione scenica in cui la provata abilità
dell’attore non sempre tira fuori il meglio dell’arte, anzi talvolta scade nel
sotterfugio del mestiere, restringendo le sottigliezze espressive in forme
volubili e caratteriali a detrimento di un registro intonativo naturale.
Il 25 fiorile Larive interpreta Oreste nell’Andromaque: è la sua ultima
apparizione. Così Mlle George, che si reca per la prima volta a teatro,
ricorda lo spettacolo nei suoi Mémoires:
Il pubblico sempre dimentico e ingrato trattò male quel talento pocanzi così
tanto omaggiato. Larive, allievo della famosa Clairon, finì male una carriera
percorsa con tanto fulgore; non ebbe l’intuito di ritirarsi in tempo. Che
tristezza assistere a quello spettacolo! Larive fischiato senza pietà. Nessun
48 La Lorgnette de spectacle par un journaliste [Fabien Pillet], A Paris, chez Hollier, an VII de la
République, pp. 149-150.
49 Ivi, p. 149.
50 «Journal des débats», 23 nevoso anno IX.
21
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
ricordo da invocare… «Il pubblico non vuol più saperne di voi; andatevene,
voi che mi avete fatto trascorrere serate così emozionanti, non voglio più
sentirvi, non me ne ricordo. Andatevene, il cuore spezzato, l’amor proprio
umiliato. Questo non ci riguarda più. Andatevene!…». Ah! che brutto
mestiere!51
Larive, senza quelle felici prerogative fisiche che un tempo avevano sedotto
gli spettatori, non può offrire che i requisiti di un mestierante, le cui
capacità interpretative sono ormai irrimediabilmente appannate, dopo
questo increscioso episodio decide di ritirarsi definitivamente dalle scene.
Intanto il Nostro aveva intrapreso una sorta di carriera pubblica: era infatti
stato nominato dal prefetto, nel luglio 1800, «adjoint municipal» del
comune di Montlignon dove ormai aveva stabilito la propria dimora,
avviando anche delle imprese commerciali. Sarà successivamente sindaco
di Montlignon, pur con varie interruzioni fra il 1801 e il 1816. Tali nuove
incombenze non inficiano tuttavia i legami col teatro, ché anzi Larive dà
inizio alla sua nuova carriera di critico e di insegnante.52
Ottiene infine un riconoscimento di grande prestigio con la nomina di
lettore ufficiale del re Giuseppe Bonaparte assurto al trono di Napoli;
rivestendo nel contempo l’incarico di direttore del Teatro del Fondo dove
da poco era attiva una compagnia teatrale francese; lui stesso parteciperà a
un ridotto numero di spettacoli (Iphigénie en Aulide, Tancrède, Philoctète,
Mahomet, Œdipe, Adelaïde du Guesclin, Cid).53
Gli accenni che nei suoi scritti Larive dedica al soggiorno partenopeo sono
quasi inesistenti, eppure al suo occhio di attore non sfugge quanto a Napoli
ci si esprima più col corpo che con la voce, in una sorta di continua e
personalissima pantomima: «I Napoletani non conoscono le modulazioni;
tutti gridano nel parlare e sempre sullo stesso tono; è forse l’origine dei
gesti che fanno, a ogni cosa che dicono, per sostituire quanto l’espressione
Mémoires inédits de Mademoiselle George, publiés d’après le manuscrit original par P.-A.
Cheramy, Paris, Plon-Nourrit, 1908, p. 13.
52 Il 25 maggio 1802, Larive era stato nominato «associé non résident» della classe di
Letteratura e Belle Arti (sezione di Musica e di Declamazione) dell’Institut de France; nel
1803 diventerà membro corrispondente della classe e, infine, nel 1816, corrispondente
dell’Accademia di Belle Arti.
53 Scrive a proposito del ruolo di Don Rodrigo nel Cid: «È uno fra quelli che ho prediletto e
che ogni attore sensibile deve aver caro; Baron lo interpretava ancora a settanta anni e il
pubblico era estasiato nel vederlo. Ho osato recitarlo a sessanta anni nel teatrino di corte di
Sua Maestà a Napoli e oserei credere che questa parte è così favorevole che ringiovanisce chi
la rappresenta perché nessuno ha mosso un rimprovero sul mio fisico e nessuno è sembrato
accorgersi che Rodrigo aveva il doppio degli anni di Don Diego; questa è la prova che gli
attori che hanno conservato il loro aspetto e sanno vestirsi con grazia, freschezza ed
eleganza, possono suscitare un’illusione tale che il pubblico, pervaso da ciò che dicono,
ritrovando il personaggio, dimenticano l’età dell’interprete» (Cours, 1810, I, p. 62).
Sull’attività di Larive a Napoli, Cfr.: Valeria De Gregorio Cirillo, I «Comédiens Français
Ordinaires du Roi». Gli spettacoli francesi al Teatro del Fondo nel periodo napoleonico, Napoli,
Liguori, 2007.
51
22
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
della pronuncia non consente».54 Pur se calato in una dimensione più di
evasione che di previdente organizzatore, Larive riesce a focalizzare quanto
sia essenziale, per la verità scenica e al di là dei codici prescrittivi, la
fisiologia del corpo, a volte addirittura dominante rispetto alla
comunicazione verbale.
Ma la sua presenza non sembra molto gradita alla compagnia per cui,
quando Giuseppe lascia Napoli per Madrid, Larive torna a Parigi (maggio
1808). Qui parteciperà a qualche spettacolo dato per beneficenza e brillerà
ancora in alcuni scelti salotti nel ruolo di fine dicitore.
Muore a ottandue anni, il 30 aprile 1827.
***
Idealità, pantomima, verosimiglianza, modalità espressive, rispetto dei
caratteri, declamazione, questi e molti altri sono i problemi cui Larive
dedicherà le sue riflessioni di saggista, confluite nei volumi del Cours.55
Eppure in lui non appare nessuna intenzione dogmatica di iscriversi nella
ricca trattatistica settecentesca che si sviluppa soprattutto a partire da Le
Comédien di Rémond de Sainte-Albine (1747); mai infatti Larive fa
riferimento ad alcun testo, né pare interessato ad astrazioni tecnicistiche,
perché considera che tutto proviene dall’esperienza e dall’interrogazione
della memoria e basta allora verbalizzare le proprie emozioni e le proprie
impressioni per lasciarle come motivo di insegnamento alle nuove
generazioni in una continuità elettiva così come era avvenuto per lui:
Educato alla vecchia scuola, le prime impressioni che ho ricevuto sono ancora
incise nel mio animo. Le Dumesnil, le Clairon, i Lekain, i Brisard, ecc., erano
allora i bei strumenti della tragedia: l’uno non rassomigliava all’altro, ma si
riunivano tutti in un centro comune d’interesse, di calore e di sentimento che
alimentava di continuo la scena, non lasciandola mai languire. Ogni attore si
serviva dei propri mezzi naturali, non c’era nulla di gigantesco o di forzato,
tutto era nobile, energico, patetico e travolgente; era un focolare ardente che
comunicava agli spettatori quel calore vivificante dell’animo che risveglia,
stimola e mette in moto ogni passione. Non mi nascondo che è impossibile
Cours, 1810, I, p. 302.
Si riassumono cronologicamente gli interventi teorici di Larive, cui si è in parte già
accennato: 1795, Quelques réflexions sur la décadence des théâtres, articolo pubblicato su «La
Gazette nationale ou Le Moniteur universel»; 1801, Réflexions sur l’art théâtral par J. MauduitLarive; 1804, corso di lezioni tenute da Larive all’hôtel de Choiseuil, rue Neuve-GrangeBatelière, che sarà pubblicato nello stesso anno col titolo Cours de déclamation, divisé en douze
séances; 1806, Moyens de régénérer les théâtres, de leur rendre leur moralité, et d’assurer l’état de
tous les Comédiens, sans dépense pour le Gouvernement; 1810, Cours de déclamation prononcé à
l’Athénée de Paris, par J. M. Larive (2 volumi).
54
55
23
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
insegnare questa magia teatrale che solo l’anima può dare: il genio non si
apprende.56
Certamente però Larive conosce gli scritti di Mlle Clairon che aveva dato
alle stampe nel 1798 i suoi Mémoires et réflexions sur l’art dramatique e,
tramite lei, avrà avuto modo di frequentare Marmontel né gli saranno
sfuggiti i vari Mémoires di attori che via via vengono pubblicati.
Il «Journal des débats», annunciando il secondo incontro del Cours de
déclamation tenuto da Larive all’hôtel de Choiseuil, rue Neuve-GrangeBatelière n° 3, dà conto dei contenuti e della dinamica delle lezioni. È
un’ottima occasione per verificare se l’attore, che ha esercitato la
professione per più di trent’anni con successo e sinceri applausi, è
altrettanto abile come docente.57
L’impostazione del corso e gli argomenti che saranno trattati sono visti
esclusivamente in funzione dell’arte teatrale, così le diverse tematiche prese
in esame non vogliono costituire né un corso di morale né una
disquisizione di stampo filosofico, bensì offrire una riflessione sul modo di
esprimere ogni passione e sui più segreti trucchi del mestiere. Le lezioni
sono strutturate in due parti distinte: nella prima vengono presentate
osservazioni di tipo generale, mentre nella seconda è declamata una scena
in rapporto con i concetti analizzati. Se alla base del Cours si prospettava
l’istanza di una finalità didattica, Larive intende offrire nella seconda parte
una raffinata riflessione sul repertorio tragico. Egli rilegge con acume e
sensibilità i testi alla luce delle necessità della messa in scena e ne sottolinea
i nodi di pathos, diversificando le tipologie dei personaggi, e gli atti di
parola correlati a una complessa intertestualità.
Il quotidiano riporta alcuni brani letti durante la prima lezione quali
figurano in modo identico nel Cours. Che si tratti di una lettura, ciò non
sorprende più di tanto, ormai si legge dappertutto, persino al Collège de
France! – chiosano i critici – ma in questo caso la lettura costituisce un
indubbio vantaggio perché si ha modo di osservare la maniera di porsi di
Larive e «la compostezza del suo portamento: nessun disagio, nessuno
scoppio di voce, nessuna falsa intonazione, era un modo di leggere
ragionevole, sapientemente armonioso e tale da potervi ravvisare persino le
Cours, 1810, I, pp. 2-3. Non è sembrata opportuna un’analisi comparatistica del Cours che
ne definisse i legami intertestuali con la prassi scenica e le teorie coeve sull’arte dell’attore;
nella sua funzione paideutica è evidente che Larive abbia voluto offrire una rilettura
compendiaria, seppur fondata su esperienze personali, delle riflessioni e delle ricerche
editate in quegli anni e il più possibile esaustiva delle tematiche escusse. Si rimanda per i
testi ai lavori di Sabine Chaouche in particolare a: Sept Traités sur le jeu du comédien, de l’action
oratoire à l’art dramatique, 1657-1750, Paris, Champion, 2001; Écrits sur l’art théâtral, (17531801), 2 voll., Paris, Champion, 2005; La Philosophie de l’acteur. La dialectique de l’intérieur et de
l’extérieur dans les écrits sur l’art théâtral français (1738-1801), Paris, Champion, 2007.
57 «Journal des débats», 14 nevoso anno XII (5 gennaio 1804).
56
24
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
sfumature della punteggiatura».58 Avendo parlato del modo in cui rendere
i sentimenti di una profonda sensibilità, Larive ha offerto come esempio la
lunga scena del secondo atto tra Pirro e Filottete nel Philoctète di La Harpe.
La scelta non poteva essere più indovinata, non solo il personaggio di
Filottete aveva costituito uno dei successi ricorrenti dell’attore, ma il brano
era anche stato declamato con una verità senza pari e tanto più apprezzato
in quanto non c’erano né i costumi, né il fascino del palcoscenico a distrarre
il pubblico e si potevano così seguire da vicino
le diverse gradazioni con le quali l’attore mostrava la postura […]. Ha
soprattutto stupito gli spettatori nel rendere il dolore che Filottete provava per
la ferita. Disteso su uno scranno, facendo degli sforzi come per strappare dal
cuore il veleno che lo divorava, aveva le forme maschie, nobili e terribili del
Laocoonte.59
Larive aveva contato sulla presenza di Ducis di cui era stato applaudito
interprete (Hamlet, Macbeth, Œdipe chez Admète, Roméo et Juliette) e teneva
quindi al suo giudizio. Ma il drammaturgo, trasferitosi a Versailles, si
scuserà di non essere potuto intervenire dato che l’invito gli era pervenuto
in ritardo. Nella sua lettera Ducis, nel rammaricarsi dell’assenza, scrive a
Larive di aver letto sulla stampa e di essere al corrente del successo della
sua iniziativa «su un’arte in cui avete raccolto tanti applausi fra i quali
bisogna mettere in evidenza quelli che sono dipesi dal vostro carattere
leale, franco, impetuoso, nemico della meschina affettazione e dei doni
esteriori che è raro incontrare assieme».60
I corsi di declamazione dovevano avere una grande reputazione e un largo
seguito se il giovane Stendhal che, arrivato a Parigi nel 1799, si era col
tempo accorto della propria pronuncia difettosa, aveva deciso – come
racconta nella Vie de Henry Brulard – di «scacciare gli ultimi resti del parlare
strascicato della sua regione»,61 e aveva scelto la scuola di rue GrangeBatelière, dove prendere lezioni di recitazione assieme al cugino, Martial
Daru. La loro partecipazione ai corsi di Larive durerà pochi mesi (dal 3
fruttidoro anno XII [21 agosto1804] a dicembre), gli preferiranno quelli di
Ivi.
Ivi. L’analisi del testo di La Harpe con il commento di Larive figurano nel Cours, 1810, II,
pp. 286-326. Oltre al Philoctète, Larive reciterà in altre tragedie del repertorio di La Harpe: Le
Comte de Warwick (5 luglio 1775); Les Barmécides (11 luglio 1778), Jeanne Ire, reine de Naples (12
dicembre 1781), Coriolan (2 marzo 1784), creandone per la prima volta le parti,
rispettivamente del Conte, di Aaron-Al Rachid, di Louis, re di Ungheria e di Caius Marcius,
detto Coriolano.
60 La lettera del 23 nevoso a firma di Ducis, «Président de la Classe de la langue et de la
littérature française dans l’Institut national», è riportata in fac-simile da E. Mareuse: «Une
lettre de Ducis à Larive», Versailles, Librairie E. Bernard, 1921, pp. 1-20, qui p. 3, [extrait de
la «Revue de l’Histoire de Versailles et de Seine-et-Oise», 22e année, 1920].
61 Stendhal, Œuvres complètes (49 voll., 1967-1974): Vie de Henry Brulard, texte établi, annoté et
préfacé par Victor Del Litto, Genève, Cercle du Bibliophile, 1968, 2 voll., vol. II, p. 115.
58
59
25
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Dugazon. Ma la frequentazione di Larive non era stata inutile e l’intervento
dell’attore aveva portato Stendhal a guardare in modo diverso al suo
progetto drammaturgico, il famoso Letellier, cui lavorerà per più di
vent’anni senza mai condurlo a termine:
Una parola di Larive sulla parte di don Giovanni, che giudica superba, mi
apre gli occhi. La pièce ha mille difetti, ma il personaggio si trova in molte
situazioni. È, come le pièces di Shakespeare, ricca d’azione e il gran difetto
della scena francese è di esserne priva. Stavo per cadere in questo difetto per
Letellier, se le parole di Larive, non mi avessero aperto gli occhi.62
Nel Journal littéraire Stendhal riprende e sposa l’idea di fondo di Larive e
che cioè tutto passa attraverso la sensibilità che si nutre e si affida alla
reminiscenza, essenziale non solo per l’attore ma anche per il
drammaturgo:
Per rappresentare il patetico alto: Ermione, Fedra, ecc., l’uomo che possiede
un’anima sensibile e appassionata non deve che ricordare ciò che ha provato,
scegliere fra i sentimenti quelli più consoni al personaggio che mette in scena,
costruire l’intreccio in modo da provocare, su anime simili alla sua,
l’impressione più forte di commozione, sensibilità o ammirazione ed
esprimere tutti quei sentimenti in versi col ritmo il più confacente possibile.63
Il suo giudizio su Larive appare altalenante e improntato a una sorta di
fruizione immediata di quanto l’attore può offrire di sé e sembra aprirgli
nuovi spiragli sul proprio io: «Mi esorto oggi, secondo quanto hanno detto
ieri Larive e sua moglie, a osare essere naturale, a osare essere me stesso»64
e dargli una rinnovata sicurezza. Durante i corsi i due allievi recitano
evidentemente alcune scene dei classici, il 24 agosto in particolare la prima
di Athalie e la prima di Venceslas; la loro interpretazione suscita
l’approvazione di Larive dato che qualche giorno dopo così annota il
diarista: «Questa mattina da Larive che ci dice che non troverebbe due
allievi a Parigi con le nostre predisposizioni». Il 19 settembre si recano a
Montlignon da Larive per l’intera giornata «Giornata piacevole, soggiorno
incantevole», scrive Stendhal .65
Il testo del Cours, intessuto di ricordi personali e di aneddoti secondo la
pratica memorialistico-introspettiva sovente frammentaria propria del
tempo, inizia, con un certo sussiego, sotto l’egida della «divina Verità» (cui
per altro sarà dedicato il capitolo XIV) ispiratrice e guida dell’autore. Il
corso si articola in dodici séances secondo un percorso speculativo in
62 Stendhal, Œuvres complètes, cit., Théâtre, 1971, 2 voll., vol. II, 23 brumaio XIII [14 novembre
1804], p. 114.
63 Journal littéraire (Œuvres complètes, cit.), 1970, 3 voll., vol. II, 13 f[ruttidoro] XII [31 agosto
1804], p. 153.
64 Ivi, 29 brumaio XIII [20 novembre 1804], p. 175.
65 Ivi, p. 152, 156 e 163-164.
26
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
apparenza assai lineare, quello cioè di analizzare quali siano i moventi che
suscitano le passioni e su cui si fonda ogni drammaturgia. Spetta quale
compito essenziale all’attore sceverare il pathos, conoscerne la provenienza,
le incrinature, i percorsi diacronici per poterlo dominare e interpretare.
Specchio fedele dell’uomo, l’attore è tenuto a farne il modello performativo
non solo nelle varie corporeità, ma anche nelle più complesse fisionomie
morali; lui stesso deve poter sentire e successivamente rappresentare le
passioni nella loro molteplicità, dall’amore alla gelosia, dalla seduzione al
coraggio, dalla generosità alla meschinità, insomma in tutte le sfumature e
in ogni livello possibile di emotività e di sentimento per adattarli, con
maniacale osservanza, ai ruoli creati dai drammaturghi. Su quest’ultimo
punto Larive è categorico, l’attore non deve mai dimenticare di essere
soltanto l’esecutore dei sentimenti espressi dall’autore e deve attenervisi
scrupolosamente, pur rivestendoli delle proprie capacità artistiche,
altrimenti l’equilibrio andrebbe compromesso.66 Non per questo gli attori
devono rinunciare all’immaginazione che ben controllata costituisce il
tramite necessario per il raggiungimento del sublime.
La lunga esperienza scenica, la diuturna frequentazione dei testi, lo scavo
psicologico costituiscono un patrimonio che Larive sente di poter
trasmettere ai giovani che vogliono abbracciare la sua stessa carriera, da lui
un tempo intrapresa sotto il crisma della natura, aggiungendo che proprio
la natura gli ha insegnato a osservare la complessità delle umane
differenze, sorta di labirinto inestricabile di opposti istinti, di genialità, di
caratteri dalle contrastanti qualità morali e fisiche, di sensibilità e di
passione. Alcune considerazioni sono particolarmente interessanti e
dimostrano quanto il metalinguaggio del corpo sia essenziale al suo
assunto; il corpo dell’attore deve infatti sapersi adattare a ogni situazione
ed esprimere il non detto. In queste affermazioni sembra già anticipare
talune teorie recitative proprie dell’attività drammatica moderna, quando
la dinamica corporea non supporta la voce, ma ad essa supplisce ed è il
corpo stesso a farsi voce.
Ma come raggiungere lo spettatore se non tramite l’anima, enfatizza Larive,
tratteggiando un sistema emozionale forse un po’ ingenuo, riassumendo
poi il suo pensiero in un sintetico aforisma: «La fisionomia è nell’anima, il
volto non ne è che l’interprete». Per lui il potere di Melpomene si attesta
nella sua unicità in quella prassi salvifica secondo il dettato moralistico di
Come suggeriva Le Vacher de Charnois, tramite il personaggio di Rainville, bisogna
«parlare con la propria parte», il che significa «ben approfondire il carattere, studiare le
situazioni, apprezzarne tutte le frasi, conoscerne la forza e definirne ogni senso;
immedesimandosi nella frase ci si predispone a dar vita alle parole, colore all’espressione,
risonanza alle idee», proponendo poi un paragone con la pittura: bisogna disegnare,
preparare le tinte e distribuirle con gusto, evitare la monotonia, grazie all’arte delle
sfumature, inserire ombre e contrasti abbellendoli con una leggera patina, Cfr.: Le Maître de
déclamation, cit., p. 11, scena 2.
66
27
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
una corrente di pensiero del tempo per cui, grazie all’immediatezza con cui
le passioni vengono rappresentate e percepite dallo spettatore, i vizi
saranno cancellati e si assisterà al trionfo della virtù.
L’attore per riuscire necessita naturalmente di doti fisiche, innanzi tutto di
una voce di grande sensibilità. Dimentico di sé, nel trasferire la propria
natura nell’immagine concreta dell’eroe impersonato, egli realizza
l’insostituibile illusione teatrale in cui attore e spettatore comunicano
all’unisono in una rara simbiosi del tutto irripetibile per confondersi nelle
passioni del personaggio. Ma Larive sa quanto sia difficile raggiungere un
giusto equilibrio e mette in guardia da quelle che definisce intonazioni
calcolate, atte a stupire o ad atterrire, ma insufficienti a commuovere e a far
scorrere – secondo l’espressione ossimorica ricorrente nel tempo – le
lacrime deliziose, garanzia di un’emozione condivisa.
L’evocazione continua della sensibilità naturale costituisce il limite della
poetica teatrale di Larive che, portando sul palcoscenico il proprio doppio
emozionale, pur con le dovute sfumature imposte dal personaggio, non
arriva sempre a sorvegliarlo col pericolo di scadere nel manierismo e nella
monotonia: gli manca, insomma, quel sangue freddo che Diderot
identificava nella recitazione di Mlle Clairon, quell’autocontrollo che solo
può «temperare il delirio dell’entusiasmo».67 Eppure – come racconta
Hérault de Séchelles – il metodo di Larive di mandare a memoria i testi
comportava un approccio progressivo tale da penetrare all’interno della
logica autoriale e da offrirgli la giusta distanza dall’opera:
Ho sentito dire da Larive che aveva a lungo studiato le sue parti, una strofa
dopo l’altra. Questo modo lo affaticava parecchio; ne ha immaginato un altro
con il quale si trova meglio: legge dieci, venti volte una parte nella sua
interezza senza neanche impararla, basta comprenderla. Questo metodo è
identico a quello di cui ho parlato: cogliere l’insieme.68
Le riflessioni sulla voce appaiono piuttosto ovvie: interprete delle passioni,
la voce deve variare le modulazioni all’infinito ed essere articolata
correttamente, la pronuncia deve raggiungere la perfezione. La voce va
naturalmente adattata all’età dei personaggi e tutto va filtrato attraverso la
mente e i sentimenti: ogni voce avrà una sua sonorità e un suo colore
distintivo.
Parimenti l’espressione dei sentimenti va regolata secondo archetipi
significanti per la loro dimensione estetica, come possono essere alcuni
capolavori della statuaria classica così non c’è dolore dell’anima che non
riporti a Niobe, come non c’è dolore fisico paragonabile al Laocoonte; per
67 Denis Diderot, Paradoxe sur le comédien, présentation par Sabine Chaouche, Paris, GF
Flammarion, 2000, p. 53. Esaminandone la recitazione, Diderot commenta che, una volta
raggiunta la perfezione assoluta nella resa di un personaggio, non è più all’emotività che
ella si affida ma al ragionamento.
68 Réflexions sur la déclamation, cit., pp. 159-160.
28
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Larive essi costituiscono i modelli perfetti che bisogna tener in conto per
esprimere il patimento tragico nella sua elevatezza. Le lacrime non saranno
le stesse se si piange per un antico ricordo o per indignazione, per
disperazione o per gioia.
Eppure non è sempre facile trovare il giusto equilibrio e in passato lo stesso
Larive era venuto meno alla corretta interpretazione del tormento tragico;
così scriveva nel 1788 Le Vacher de Charnois censurandone in parte la
tecnica recitativa nella tragedia di Lefèvre, Hercule au Mont Œta: «La
sofferenza di Ercole non deve essere quella di un criminale sulla ruota; al
contrario più cerca di rinchiudere il dolore in se stesso e manifestarlo solo
con lamenti mal articolati o con grida per metà soffocate, dirò: ecco un eroe,
mi interesserà tanto più se si sforzerà di reprimere il proprio strazio».69 In
effetti per il critico la «decenza teatrale» scaturisce non tanto dal vissuto
dell’attore o da codici precostituiti quanto da una totale acquiescenza
all’ethos del personaggio. Purtroppo non sempre l’interprete sembra
attenervisi e, per una propensione perversa all’eccesso, che forse soddisfa la
platea ma non il fine intenditore, cade nella trappola della stravaganza e
della dismisura:
Da dove proviene questa tendenza sbagliata degli attori? – s’interroga il conte
di Vaublanc – Dal fatto che non possono limitarsi a vedere nei più bei ruoli,
persino quelli di Racine, quanto effettivamente racchiudono. Per loro non è
abbastanza; vogliono vedere ed esprimere al di là e quel al di là da loro ideato
è molto scioccante anche se esalta il parterre.70
Nulla sfugge alla prassi classificatoria di Larive, e definire le emozioni
appare essenziale al suo assunto. Due sono gli esempi evocati, si tratta dei
celebri emistichi, l’uno di Voltaire, il proverbiale: «Zaïre, vous pleurez!» di
Orosmane, l’altro il raciniano «Vous y serez, ma fille» di Agamennone.
Entrambi segnano l’acme di percezioni contrastanti: gelosia e amore in
Orosmane, conoscenza della morte imminente della figlia sacrificata dal
padre, nell’Iphigénie. Già analizzati da Rémond de Sainte-Albine essi
vengono ripresi da Diderot nel suo Paradosso, ma in tutt’altra chiave: non è
l’emozione a dettarli ma uno studio lungo e scrupoloso. L’illusione teatrale
non può basarsi sulla mera emotività che è impossibile risuscitare ogni
volta con identica intensità e vigore, ma a questa aporia Larive non ha
saputo dare risposta: convinto della supremazia della sensibilità sulla
disciplina, ha continuato su una strada che ha portato a un progressivo
inaridimento. Per Larive sensazioni ed emozioni differentemente percepite
riflettono in parte la teoria dei climi cara ai filosofi del tempo, riprendendo
Conseils à une jeune actrice avec des notes nécessaires pour l’intelligence du texte. Par un
cooperateur du Journal des Théâtres, Paris, 1788, p. 25.
70 Mémoires de M. le Comte de Vaublanc, avec avant-propos et notes, par M. Fs. Barrière, Paris,
Firmin Didot, 1857, pp. 129-130.
69
29
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
princìpi di derivazione ippocratica; e se l’attore deve adeguarsi alle
molteplici sfumature dei personaggi che porta in scena, deve anche essere
cosciente dell’individualità del pubblico: solo il vero talento riesce a
riportare tutto all’unità e a un unico centro d’interesse.
Nella lezione sull’Expression visible, Larive analizza l’espressività degli
occhi, dei gesti, dei muscoli, dei tratti del volto, una sorta di specchio
dell’anima che, anche in assenza della parola, sa rivelare la successione dei
sentimenti.71 Se le parole manifestano solo a metà il pensiero, l’espressione
visibile lo dilata all’infinito fino ad annullare gli effetti di parola e a
stravolgerne il significato, mostrandosi particolarmente efficace nei
momenti di svelamento della passione amorosa. Comunque l’espressione
sa farsi interprete del pathos che assume diverse intensità secondo i codici
sociali e culturali, ma anche inconsci, della società. In questo contesto,
Larive evoca l’efficacia dell’ispirazione, quel discrimine espressivo che
divinizza la battuta di Joad o rende irripetibile il momento del
riconoscimento fra Vendôme e Nemours, e che informa tutto il personaggio
di Zamore.
Anche l’espressione dell’amore si manifesta in attitudini corporee diverse
se si tratta di un sentimento epurato da ogni fisicità o ispirato da un intento
seduttivo: nobiltà e dignità sono qualità fondamentali e non mere
prerogative estetiche.72 Il discorso teorico di Larive procede sulla falsariga
della padronanza di fattori innati e sulla capacità istintiva dell’attore di
adeguarsi a codici interpretativi alti e plurali, soffermandosi
sull’impulsività soggettiva, sulla risorsa delle emozioni individuali, sulla
potenza espressiva dei più nobili sentimenti, sposando insomma la teoria
emozionalista. Si tratta di riportare in superficie e di riattualizzare le
sensazioni vissute senza alcun filtro. Tutt’al più il futuro attore dovrebbe
prendere come modello di studio la storia e l’osservazione della società: lui
stesso ricorda di aver ricercato negli incontri con l’aristocrazia a Versailles i
modelli ideali di nobiltà e dignità, requisiti indispensabili per un attore
tragico. Natura e verità devono ispirare la vita dell’attore, pur essendo la
sua arte una continua menzogna.
Tenere in conto la realtà è il principio su cui Larive fonda il suo magistero.
Attento a non farsi trascinare dall’orgoglio del successo, l’attore non deve
Le modalità gestuali erano certamente al centro della sua pratica scenica; annota Hérault
de Séchelles: «Mme Larive mi ha detto che suo marito era soprattutto attento a limitare
l’opposizione fra il corpo e il braccio, cosa che dà in effetti al gesto molta grazia», Réflexions
sur la déclamation, cit., pp. 175-176. E ancora: «Sarà meglio lasciar cadere il vostro braccio il
meno possibile. Ho visto Larive e i buoni attori variare talmente il movimento delle braccia
durante parecchi versi, e persino intere tirate, sicché il braccio non cadeva che raramente e
solo alla fine», Ivi, p. 179.
72 Quante volte avrà ripetuto fra sé la battuta di Oreste à Hermione nell’Andromaque di
Racine: «L’amour n’est pas un feu qu’on renferme en une âme. / Tout nous trahit, la voix, le
silence, les yeux», atto II, scena 2, vv. 575-576.
71
30
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
contare solo sull’attrattiva dell’aspetto fisico, né omologare i caratteri
secondo cliché fissi imitando servilmente modelli di successo perché
ognuno ha proprie capacità espressive e non è detto che una certa tipologia
sia valida in assoluto. La sua impostazione dogmatica rimane in bilico fra
fattori innatisti e empiristi.
Larive affronta infine il tema della déclamation, problematica a lungo
dibattuta fra i fautori della tragedia parlata o declamata, che rifletteva
l’opposizione tra tragedia in versi e tragedia in prosa che alcuni autori,
come Houdar de La Motte, avevano tentato, senza successo, di introdurre
in Francia. Il verso non va appiattito in forma prosastica che ne
annullerebbe ogni bellezza, ma può essere diversamente interpretato,
secondo una declamazione tragica o una declamazione epica e lirica.
L’attore deve avere la necessaria sensibilità per evitare di cadere nello
stravagante con una recitazione artefatta o, all’opposto, nel triviale, ma
sapere declinare la sublime semplicità di Mlle Dumesnil. Le definizioni
ossimoriche piacciono a Larive obbligato a districarsi fra la déclamation e la
nobile parlata dei personaggi tragici. La declamazione tragica sarà necessaria
per esempio nelle arringhe, in alcuni récits, o nelle profezie; non esiste
tuttavia una regola generale, le circostanze richiedono infinite variazioni.
L’attore disporrà anche della giusta sensibilità per focalizzare l’attenzione
del pubblico non sulle parole, ma sulle cose, cioè su quanto la parola è
portatrice di senso.
In un percorso così complesso gli attori hanno la continua necessità di
essere sostenuti e incoraggiati dal pubblico per cui gli applausi del parterre
sono forse più necessari dei successi di botteghino. Mille sono i mezzi per
distruggere un attore e fare della sua arte un vile mestiere; esperienza che
Larive stesso ha attraversato. L’opposizione âme/esprit, sensibilità e
razionalità, si ripropone continuamente all’attore che, obbligato a
dimenticare il proprio carattere per identificarsi nei personaggi, è mosso da
opposte passioni, da una esaltazione costante e da una immaginazione
inquieta; altre antitesi da lui prospettate quelle ad esempio fra cœur/tête e
vizio/virtù.
Se nel Cours molti sono i precetti riguardo alla dizione, alla duttilità della
voce, alla giustezza dei movimenti, all’espressione della passione quasi che
l’attore aderisca al sublime, nell’opuscolo che Larive pubblicherà nel 1806,
Moyens de régénérer les théâtres, de leur rendre leur moralité, et d’assurer l’état de
tous les Comédiens, sans dépense pour le Gouvernement,73 si colgono invece i
tratti tipici dell’organizzazione teatrale, il cui ruolo non può essere avulso
dall’interesse dello Stato: in tale ambito l’attore acquista ed esercita un
sensibile progetto di apertura artistica, nonché di socialità educativa
Par J. Mauduit-Larive, Correspondant de l’Institut, et Membre associé de la Société
Philotechnique, À Paris, de l’imprimerie de Porthmann; si tratta di un opuscoletto di quindici
pagine.
73
31
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
improntata al bene comune. I teatri, afferma Larive, sono diventati
essenziali per l’istruzione pubblica, visto il numero di spettatori che li
affollano e visto quanto le rappresentazioni dei classici, di Corneille,
Molière, Racine e di Voltaire in particolare, abbiano contribuito a svelare i
più intimi segreti del cuore umano e a «insegnare all’uomo a conoscere
l’uomo»74 e quanto debbano continuare a farlo.
A proposito dello statuto degli attori nella società rinnovata in cui sono
finalmente riconosciuti quali cittadini con pari dignità e diritti, Larive
chiede la protezione del governo per la loro sopravvivenza, soprattutto in
vecchiaia, sottolineando come, proprio i passati pregiudizi, ne avessero
svilito il mestiere. Per questa ragione bisogna scegliere in modo oculato chi
debba e possa essere destinato al palcoscenico: «L’attore che non proverà
con le sue predisposizioni di poter aver talento e con la sua condotta di
poter assolvere decentemente la professione, non deve avere il dritto di
dedicarsi al teatro».75 Scelti quindi gli attori con i requisisti necessari,
bisognerà anche trovare buoni amministratori per curare gli spettacoli e
direttori giusti cui affidare l’organizzazione generale, fissando poi un
quadro delle spese e delle retribuzioni. In tal modo sarebbe più facile la
gestione con un organigramma preventivo, atto a impedire agli
amministratori da un lato le difficoltà di bilancio e dall’altro gli
arricchimenti illeciti. Bisognerebbe infine che lo Stato si facesse carico della
costruzione di nuovi teatri senza che le compagnie fossero obbligate a
pagare spesso somme rilevanti ai privati che li danno in affitto. La crisi
insomma appare assai complessa perché legata a molteplici fattori.
Larive, sostiene che la sola scuola valida per il progresso dell’arte del
palcoscenico sia quella del pubblico e che l’ispirazione resti un fattore
personale: «Solo nel proprio animo il grande attore attinge i veri segreti
dell’arte e solo esercitandola in pubblico può sviluppare il proprio talento e
non in lezioni mandate a memoria, soffocando i moti del cuore».76
L’apertura di un Conservatorio a Parigi potrebbe incentivare la pratica
teatrale, ma senza alcuna imposizione interpretativa che appiattirebbe la
recitazione a mera modalità meccanica.
Moyens de régénérer les théâtres…, cit., p. 3 e aggiunge una riflessione, già in precedenza
enunciata e comune a una larga trattatistica settecentesca: «Tutti i capolavori del nostro
teatro sembrano esser stati creati solo per rendere gli uomini migliori, istruirli mostrando
loro tutti i pericoli del vizio e tutti i vantaggi procurati dalle virtù». Virtù che nel progetto
eudemonistico s’identifica con la felicità. Ben diversa all’epoca la posizione di Rousseau di
cui è nota l’avversione per il teatro da lui visto quale corruttore della moralità ed espressa
nella Lettre à D’Alembert (febbraio 1758), riallacciandosi così alla condanna della Chiesa, e in
particolare ai testi di Pierre Nicole (Traité de la Comédie, 1667) e di Bossuet (Maximes et
réflexions sur la Comédie, 1694).
75 Ivi, p. 7.
76 Ivi, p. 12.
74
32
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Come già in precedenza accennato, nel 1810, a completamento delle lezioni
del 1804, Larive pubblica il Cours de déclamation prononcé à l’Athénée de
Paris,77 in due volumi, in cui antologizza varie scene del repertorio
drammatico con annotazioni di tipo interpretativo. Rivendicando il
primato di essere l’unico ad aver pensato di indicare «toni, intonazioni e
sfumature» della recitazione e anche tempi e pause.78 Ogni scena analizzata
viene commentata quasi verso per verso: le sottolineature ne indicano
le parole di valore sulle quali l’attore deve portare la forza dell’espressione e
dei sentimenti; bisogna che l’essenza di ogni verso e di ogni pensiero sia più o
meno sentita in ragione di una maggiore o minore energia, forza, eroismo,
pateticità dei diversi gradi di sensibilità e dei diversi sentimenti che devono
essere espressi,79
se poi la sottolineatura è doppia o tripla essa indica «la progressione della
forza dell’espressione».80 Viene anche data attenzione alle pause e ai silenzi,
assolutamente indispensabili per segnare il passaggio da un’idea alla
successiva, con la conseguente necessità di un cambiamento di tono.81
Per definire in maniera «sensibile e positiva il vero modo della
déclamation»,82 Larive è convinto – come già affermato negli scritti
precedenti – che bisogna partire dall’analisi dettagliata delle opere, dei
caratteri e delle diverse parti del repertorio tragico. La magia teatrale,
appannaggio dei grandi interpreti, sfugge a ogni prassi didattica: ma se il
genio non può essere insegnato, non per questo si deve rinunciare al
tentativo di costituire un metodo di apprendimento. Il pericolo della
L’Athénée, si trovava rue Saint-Honoré sull’area dove sorgeva il Théâtre de l’Opéra,
distrutto da un incendio nel 1781. Fondato da Pilâtre de Rozier con il patrocinio dei fratelli
di Luigi XVI, era stato denominato dapprima Musée, poi Lycée per prendere la
denominazione finale di Athénée nel 1804 allorché il termine Lycée era stato riservato
all’ordinamento scolastico in virtù della legge dell’11 floreale anno X (1° maggio 1802). Con
un abbonamento annuo, oltre alla possibilità di leggere la stampa quotidiana e i volumi
della biblioteca, si poteva assistere ai concerti e seguire i corsi tenuti dai migliori specialisti
del tempo su quasi tutti gli argomenti dello scibile umano. È qui che La Harpe aveva
inaugurato il primo insegnamento di storia letteraria l’8 gennaio 1786, lezioni che
confluiranno nel Lycée ou Cours de littérature ancienne et moderne.
78 Il Prince de Ligne, nella lettera XIV in cui accennava all’intonazione della voce e alle
diverse possibili sfumature, avanzava una proposta: «Vorrei che si stampasse in corsivo ciò
che deve essere messo in evidenza dall’attore, e con dei punti il tempo che si deve
prendere… È spesso come un punto in musica. Dopo la pausa ci si slancia», Lettres à Eugénie,
Paris, 1774, p. 116.
79 Cours, 1810, I, p. 20.
80 Ivi, p. 21.
81 Larive annuncia volta a volta i cambiamenti necessari. Per fornire un esempio, riprendo
qui la successione che propone per la prima battuta di Abner (Athalie, vv. 1-24): « tono
mellifluo, tono solenne, tono grave e cupo, tono di rimpianto, tono di disprezzo, tono
d’indignazione, tono di timore», pp. 21-24.
82 Ivi, p. 1.
77
33
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
monotonia dovuto all’uniformità dei suoni «che tornano a ogni frase»,83 –
uniformità propria della rima baciata dell’alessandrino che alterna rime
maschili e rime femminili e rifiuta come poco corretto l’enjambement –
costituisce uno degli inconvenienti più comuni, e può essere superato
graduando energia, sensibilità, elevatezza e distinguendo tra stile nobile e
stile familiare. La proposta di Larive consiste in «una dizione sostenuta,
varia e facile che si conforma ai diversi sentimenti che si vogliono
esprimere; è necessaria infine un’estrema precisione nell’articolazione e
nella punteggiatura che sole dividono le frasi e le differenziano».84 Per
Larive il linguaggio raciniano è quello della perfezione ideale:
Le sue idee che uniscono il sublime al naturale, la versificazione che offre nel
contempo tutta la ricchezza della poesia e tutta la semplicità della prosa,
ingenerano una magia incantevole, una seduzione potente e godibile che ha
per effetto di persuadere il lettore deliziosamente impressionato che gli
sarebbe facile fare altrettanto,85
e inizia infatti il Cours dall’analisi di Athalie, mentre, volendo rispettare
l’ordine cronologico, sarebbe stato più corretto – ed egli lo ammette –
partire dal Cid. Se l’ammirazione di Larive per Racine è incondizionata, di
Corneille loda la straordinaria immaginazione capace di creare personaggi
d’eccezione: Nicomède, Émilie, Cleopatra, Augusto «sono caratteri di una
natura colossale, di un effetto eminentemente tragico».86 Le pièces, di cui
vengono esaminate più di una scena nei due volumi del Cours, sono
rispettivamente – nell’ordine in cui le presenta Larive –, nel primo: Athalie,
Le Cid, Britannicus, Venceslas, Phèdre, Les Horaces, Iphigénie e nel secondo:
Cinna, Andromaque, Rodogune, Mithridate, Nicomède, Philoctète; alla fine un
breve spazio viene dedicato all’analisi di alcune scene tratte da tre tragedie
di Voltaire (Tancrède, Mahomet, Œdipe) e dal Gaston et Bayard di de Belloy;
per quanto concerne la commedia viene analizzata solo una scena del
Misanthrope di Molière.
Se si esclude Nicomède, Larive ha recitato in tutte le opere citate, con una
dichiarata predilezione per Racine il cui stile puro ed elegante è inimitabile:
«è l’autore per eccellenza per la chiarezza e la magia della bella dizione,
quella che può esprimere le passioni in tutta la loro profondità e sviluppare
con quell’energia che incanta e avvince, senza calcoli né sforzi, gli attori e
gli spettatori».87 L’analisi porta non solo sui ruoli maschili, ma anche su
quelli femminili, descrivendone prima la funzione nella diegesi, poi le
Ivi, p. 8.
Ivi, p. 10.
85 Ivi, p. 48.
86 Ivi, p. 51. Soltanto i primi due personaggi non figurano tra quelli citati nel Cours del 1804:
Nicomède è il protagonista della tragedia eponima Nicomède, Théâtre de l’Hôtel de
Bourgogne, 1651; Émilie è la figlia di Toranius, vittima di Augusto nel Cinna.
87 Ivi, p. 11.
83
84
34
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
caratteristiche e l’evoluzione, pronto a mettere in luce i punti di snodo del
racconto e gli strumenti fonici e declamatori per realizzarli.
Un tema già adombrato, e sul quale ritorna con insistenza, è quello della
necessaria nobiltà per l’arte teatrale: «la tragedia è caratterizzata solo dalla
nobiltà, senza di essa degenera in dramma, genere mostruoso che il buon
gusto dovrebbe per sempre bandire;88 senza nobiltà tutte le azioni grandi
ed eroiche sono svilite e distrutte; tutti i bei movimenti mancano d’anima e
d’energia».89 Non c’è ruolo, nella tragedia, che non manifesti un diverso
grado di nobiltà, requisito che deve essere presente non solo nella dizione,
ma anche nelle pause, nei gesti, nello sguardo, nel portamento e in ogni
espressione del volto. In quanto poi a quel variare all’infinito delle nuances
di un testo drammaturgico, esso si riflette soprattutto nelle capacità
interpretative, come scrive Larive a conclusione dell’analisi di Mithridate:
Ho tuttavia motivo di credere che quando gli attori avranno ben formato la
loro recitazione, sarà per loro facile animarla e darle vivacità, scatto e
sensibilità in modo più o meno intenso; si deve avvertire che non è nel potere
degli uomini indicare i moti dell’animo: le vive sensazioni sono date solo
dalla natura che si conforma all’organismo di ogni individuo, quelle di uno
non possono confarsi all’altro e questi processi intimi sono imperscrutabili.90
Dopo questo lungo excursus sulle tragedie, nel capitolo intitolato
Observations générales, Larive si sente in dovere di tracciare un profilo, o
piuttosto un modello di perfezione ideale, delle qualità fisiche e morali
degli attori, necessarie a rappresentare al meglio le parti loro affidate.
Accenna poi ad alcuni aspetti generali relativi alla complessione fisica
dell’oratore (ancora !) e dell’attore consistenti nell’armonico portamento del
corpo, nella facilità dei movimenti, nella postura della testa e delle spalle,
nello sviluppo della cassa toracica, essenziale per la voce. Per quanto
concerne gli altri requisiti naturali, le loro variazioni sono illimitate quanto
le diverse tipologie dei sentimenti da esprimere. Una capacità elementare,
ma di ardua acquisizione, consiste nella perfezione del gesto collegato alla
mimica dello sguardo, l’associazione di queste due espressioni deve
imporsi tanto da sostituirsi alla parola. L’effetto prodotto dimostra quanto
la gestualità abbia potere espressivo totalizzante. Smentendo poi quanto
88 Alla fine del Cours, ribadendo la propria convinzione, scrive di non voler azzardare alcun
suggerimento su come recitare il dramma: «genere barbaro e falso che si è insinuato a teatro
quasi di contrabbando, ma che non vi è mai stato accettato legalmente né autorizzato. […]
richiederebbe una declamazione anfibia e cioè metà borghese e metà tragica e di
conseguenza lontana dai veri princìpi che non riconoscono in arte che le due grandi
divisioni», II, p. 394. Larive ha recitato in un esiguo numero di drammi: una
rappresentazione del Père de famille di Diderot (1777, personaggio di Saint-Albin); una
dell’École des mœurs ou les Suites du libertinage di Fenouillot de Falbaire (1776, Lord Belton);
sei di Eugénie di Beaumarchais (1775, Lord comte de Clarendon).
89 Cours, 1810, II, pp. 179-180.
90 Ivi, pp. 206-207.
35
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
affermava Marmontel, fedele all’actio oratoria e per il quale il gesto segue la
parola, Larive afferma che al contrario la prima reazione è quella del gesto
che comunica prima della parola.
Anche la pronuncia richiede un esercizio continuo alla ricerca della giusta
intonazione: il fascino dell’espressione dipende dal modo di esprimersi che
non deve essere né precipitoso né eccessivamente misurato. L’abilità
articolatoria affina e fortifica i suoni, abilità legata a un mezzo fisico, poiché
dipende dalla conformazione della bocca e dalla mobilità delle labbra.
L’arte di trovare il giusto fraseggio resta legata allo stile dell’autore e al
ritmo richiesto dalla frase e, a seconda delle situazioni esterne delle
passioni che dominano i personaggi e del loro temperamento, la dizione
assumerà caratteristiche diverse. Così quella di Zamore, nell’Alzire, sarà
«rapida, viva e animata» a causa del suo stato d’animo dimidiato fra amore
e vendetta; quella di Edipo sarà «cupa e pensosa»; Tancredi dovrà dar
prova di una «parlata sincera e articolata»; Maometto presenterà «una
recitazione imperiosa e molto audace».91 Sintetizzando infine le sue
riflessioni, divide i personaggi in due categorie: «Augusto, Agamennone,
Acomat, Joad, Maometto e molte altre parti di questo tipo esigono una
dizione più autorevole, più approfondita, più sostenuta rispetto a
Mitridate, don Diego e il vecchio Orazio. Questi ultimi sono più vivamente
mossi e trascinati dalla passione che dalla forza del ragionamento».92
Naturalmente non mancheranno interferenze atte a correggere
l’impostazione generale della recitazione e sarà compito dell’attore
individuare i necessari cambiamenti d’espressione nello sviluppo
drammatico. Le parti infatti – aggiunge Larive – «sono composte da una
quantità di sfumature, di dettagli che solo un tatto fine e delicato può
cogliere e rendere, ma che l’arte non può insegnare».93
L’ultimo argomento affrontato da Larive (Costumes) è relativo
all’abbigliamento sclerotizzato in moduli seicenteschi che con Lekain e Mlle
Clairon inizia timidamente a modificarsi: parrucche, cappelli piumati,
vistosi gioielli, guanti con le frange, hanches di crine, guardinfante, tonnelets,
ricchi tessuti di raso e velluto, merletti man mano tendono a scomparire
anche se la realtà storica è lungi dall’essere rispettata.
Qualche suo tentativo era stato notato dalla critica, così nell’interpretare
Agis, re di Sparta, nella tragedia eponima di Laignelot, Larive sentendosi
libero di recitare in un’opera inedita sceglie di innovare l’abbigliamento,
presentandosi in scena con una semplice tunica, novità però non da tutti
Ivi, pp. 343-344.
Ivi, p. 345.
93 Ivi, pp. 346-347. Su due esempi focalizza la sua riflessione: sul monologo di Tancredi in
attesa dell’incontro segreto con Aménaïde e sul dialogo fra Maometto e Zopire (atto II, scena
5).
91
92
36
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
apprezzata.94 Per Fleury, la scelta è senz’altro positiva anche se non in linea
con gli altri interpreti dello spettacolo: «Il nuovo costume adottato per
impersonare Agis sembrò originale, storico, di ottimo gusto e rispondente
alla sua nobile figura. Ne fummo tanto più colpiti che gli altri attori erano
vestiti in modo eterogeneo o ridicolo, chi con abiti alla greca, chi alla
romana».95 Lo stesso Larive racconta di aver condotto ricerche sui costumi
spartani e di aver osato «mostrare Agis come doveva essere vestito. Questo
nuovo costume sembrò così straordinario e tutti mi fecero così tante critiche
che dovetti, per giustificarmi, rifarmi all’autorità di un celebre pittore da
me consultato».96
Le Vacher de Charnois, per illustrare i Costumes des grands Théâtres de Paris,
sceglierà di raffigurare Filottete nella scena in cui implora Pirro:97 l’attore
indossa una tunica bluastra su cui insiste un ruvido mantello di lana
tendente al marrone. Qualche perplessità deriva dal fatto che, trovandosi
egli in un luogo desertico, porti un cimiero attico, non proprio in linea con
la situazione dell’eroe. Calza coturni con lacci di cuoio attorno alle caviglie,
ma gli altri interpreti non lo seguono in questo abbigliamento innovativo il
che ne accentua la stravaganza.
Sicché Larive non può che sottolineare, nella conclusione finale del trattato,
come le novità da lui introdotte e il significato delle sue scelte non siano
compiutamente comprese né accolte in modo corretto: la pettinatura corta,
l’assenza di cipria, la tunica leggera, appaiono sconvenienti, ci vuole tempo
per invalidare una ritualità consolidata e aprirsi alla semplificazione:
Fui allora trattato come un innovatore fazioso, come un audace frondista. Non
piacqui né a corte né in città; tutti furono d’accordo che questo primo passo
verso il miglioramento era il capolavoro del ridicolo. Un intendente dei
Menus-Plaisirs mi mosse rimproveri sostenendo che era indecente mostrare a
corte un Romano senza che fosse incipriato. Eliminai le hanches e dissero che
sembravo una vespa; indossai le prime tuniche e dissero che sembravo un
uomo in camicia.98
94 Pierre Peyronnet riporta la parodia che ne fece Goulard, autore del Théâtre-Italien; alla
domanda del Senato che gli chiede conto dello strano abbigliamento, definito gotico, AgisLarive risponde: «Sono i drappeggi di un pittore, sono secondo gli antichi!», La mise en scène
au XVIIIe siècle, Paris, Nizet, 1974, p. 115. La parodia fu rappresentata il 2 agosto 1782 dai
Comédiens italiens e lo stesso Larive l’evoca ironicamente nel Cours, 1810, II, p. 398.
95 Mémoires de Fleury…, cit., vol. I, p. 297.
96 Cours, 1810, II, pp. 397-398.
97 N° XIX, venerdì 1° settembre 1786, pp. 8-9.
98 Cours, 1810, II, p. 397.
37
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
NOTA ALLA TRADUZIONE
- I volumi del Cours non sono mai stati ristampati, attualmente è
disponibile un reprint (Hachette-Livre BnF) e possibile la lettura en ligne
sul sito della Bibliothèque numérique Gallica (gallica.bnf.fr).
- Si è scelto di tradurre il termine séance del titolo del corso con il termine
incontro in quanto si tratta di un soggetto protagonista rispetto a un
uditorio a cui vengono offerti alcuni aspetti della recitazione, limitati a una
esposizione psicologica dei personaggi teatrali e della loro fonazione,
interpretati dalla voce di Larive. Più precisi esempi di dizione e di
declamazione vengono invece espressi in modo particolareggiato nella
seconda parte del suo Cours del 1810. Verosimilmente il termine séance è
stato adoperato come forma di suggestione teatrale di chi associava
l’uditorio alle sue esperienze. Infatti séance può esprimere tanto lo
spettacolo in sé quanto una riunione, una sessione, una seduta.
- Per le pièces citate si danno in nota, tra parentesi, le date della prima
rappresentazione; se non altrimenti specificato il palcoscenico è sempre
quello della Comédie-Française (Cfr. Alexandre Joannidès, La ComédieFrançaise de 1680 à 1900 – Dictionnaire général des pièces et des auteurs, Paris,
Plon, 1901).
- I nomi dei personaggi citati da Larive sono stati normalizzati.
- Le note in corsivo sono di Larive, quelle in tondo della curatrice.
38
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
CORSO DI DECLAMAZIONE
DIVISO IN DODICI SEDUTE
Alla verità
Divina verità, solo a te devo questo modesto lavoro; ti ho scelta come guida
e hai accondisceso a ispirarmelo.
Oso darlo alle stampe sotto la tua protezione.
Veglia sul suo destino; consiglia quelli che vorranno giudicarlo; sarò allora
sicuro che sopravvivrò ai detrattori.
Sincero e puro come te, non ho cercato di agghindarlo con grazie
menzognere.
I tuoi figli fedeli sono raramente dotati di quella sublime eloquenza che
sola ha la capacità di abbellire e di rendere incantevole ogni cosa. Ma
godono del vantaggio inestimabile di sopravvivere alla menzogna che sotto
mille forme diverse vuole di continuo imitarti.
Al tuo cospetto tutto ciò che essa ispira impallidisce e si cancella, tu sola sei
immortale, che con te il mio lavoro entri nei cuori, giudicato da loro non
paventerà gli strali avvelenati della mente.
39
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
PRIMO INCONTRO
Delle passioni considerate nei loro rapporti con l’arte drammatica
Introduzione
L’accoglienza lusinghiera riservata dal pubblico alle riflessioni che ho osato
presentare su una delle arti più splendide e difficili,99 ha incoraggiato la
giusta diffidenza che ho di me stesso. Per questo ho pensato che non
potevo occupare in modo migliore la libertà concessami dal mio ritiro dalle
scene se non dedicandomi a nuove riflessioni sulle cause che, nelle
rappresentazioni drammatiche, danno libero corso alle passioni senza le
quali non esisterebbero né arte del teatro né attori.
Quelle prime osservazioni richiedevano maggior spazio e sviluppo, mi
sono servite di base per un nuovo lavoro, solo esse mi hanno fornito tutte le
scoperte che ho poi fatto nelle mie esperienze e in quelle degli altri. Hanno
quindi il diritto di ricomparire in questo lavoro, incorniciate, per così dire,
da una nuova serie di idee da loro prodotte.
Il pilota più provetto non potrebbe, nello stesso istante, evitare uno scoglio
e descriverlo; in una crisi violenta le angosce che si avvertono tolgono i
mezzi per ben definirle. Ma l’uomo, giunto a un’età in cui la ragione
riprende tutti i diritti su di lui, può, in un perfetto equilibrio, giudicare in
modo giusto gli impulsi ai quali ha ceduto nel vortice della vita.
I giovani sono dominati dalle passioni, non voglio dire che l’uomo maturo
sappia dominarle, ma in lui si affievoliscono, lo condizionano meno e
allora, affrancato da quello che esse hanno di più pressante, può definirle e
descriverle.
Nulla è più necessario agli uomini della perfetta conoscenza delle cause
primarie che agiscono sull’animo, sulla mente e sulla ragione; l’attore ha
bisogno di qualcosa di più: deve conoscere e saper far muovere a volontà
gli impulsi segreti che suscitano in noi quegli slanci straordinari che
sublimano l’uomo al disopra di sé. Bisogna che apprenda a elevare lo
spirito al tono di quelle azioni eroiche che soggiogano le sensazioni100 dei
suoi simili, suscitandone l’ammirazione e l’entusiasmo.
L’uomo è la creatura più perfetta, la sua immaginazione per quanto si sia
sforzata di dare a Dio la forma più imponente in grandezza e in maestà,
non ha trovato nulla al disopra di quella dell’uomo. Quando è dotato di
quel fuoco sacro, fonte delle passioni nobili e delle azioni sublimi, può ciò
che vuole. Esser destinato per professione a rappresentarlo in tutte le
passioni e in tutte le azioni che con mille sfumature differenti diversificano
Larive si riferisce alla sua pubblicazione del 1801: Réflexions sur l’art théâtral, par J. MauduitLarive, cit.
100 Un letterato da me consultato su questo lavoro mi ha avvertito che non davo alla parola
sensazioni il senso attribuito dai filosofi. C’è nel gergo teatrale un’accezione che ho creduto dover
conservare e che, almeno spero, non sarà né oscura né equivoca per nessuno.
99
40
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
il suo grande carattere, è un compito ben difficile da assolvere! È quello
dell’attore.
Oserei dire che una parte dell’immaginazione vivace e fervida dei letterati
che hanno partorito i capolavori, oggetto della nostra ammirazione, è
indispensabile per coloro i quali sono la voce di quei capolavori. Si può
tanto meno contestar loro il merito che hanno nel rappresentarli, in quanto
possono, nell’impossibilità di assurgere alla loro altezza, affievolire e
cancellare praticamente tutte le bellezze dei grandi personaggi che vi
agiscono e parlano.
Il talento dell’attore è lo specchio fedele che deve presentare l’uomo
all’uomo; deve realizzarlo non solo con i suoi tratti fisici, ma con la sua
fisionomia morale e così fedelmente, sotto una luce così vera, affinché
ciascuno possa riconoscere la propria anima, la propria energia, le proprie
passioni, i difetti, le virtù e i vizi. Per riuscire in questo difficile scopo è
necessario che l’attore possa sentire, provare ogni passione, ogni sfumatura
e ogni gradazione possibile di emozioni e di sentimenti.
Deve, cosa ancor più difficile, mitigarli, adattarli, se mi è lecito esprimermi
così, al genio multiforme degli autori, esaltarli e dirigerli senza sussulti,
senza sforzi, subordinando le proprie impressioni a quelle che
appartengono ai diversi caratteri delle parti che gli sono affidate. Non
ignoro che solo i nostri grandi maestri dovrebbero poter trattare un
argomento così complesso e delicato. Se l’insieme di idee e di penetrazione
che mi è propria non mi permette di approfondire i segreti del cuore
umano, mi permette almeno di render conto delle mie sensazioni.
Il libro della natura essendo aperto indistintamente a tutti, cercherò, senza
pretese, di approfondire quanto mi è stato permesso di vedervi; quello che
non ho potuto intuire nel cuore degli altri, lo troverò nel mio; darò un conto
fedele dei primi impulsi che hanno emozionato la mia sensibilità, scosso il
mio animo e dato libero corso al mio essere morale, facendomi conoscere e
provare i diversi sentimenti che ho portato in scena.
So che è logico pensare che ci sia dell’orgoglio nel credere di poter arrogarsi
una certa autorità, ma un uomo nato sensibile e raffinato, che ha esercitato
per trentatré anni una delle arti fra le più difficili, può avvalersi degli slanci
felici procurati dal favore del pubblico per osare, senza tema, sollevare un
lembo del velo che nasconde troppo spesso all’uomo di teatro l’uomo della
società. La natura è stata la mia guida, che mi sia quindi permesso di
trasmettere, a coloro i quali vogliono percorrere la stessa carriera, quanto la
natura mi ha insegnato a osservare. Se alcuni dettagli appaiono meticolosi,
devono essermi perdonati in considerazione degli effetti che ne sono
derivati o delle conseguenze che ne traggo. Un grande incendio inizia
spesso con una scintilla, la passione più violenta con un solo sguardo o una
sola parola.
41
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Il sentimento che mi anima è solo l’amore della mia arte e il vivo desiderio
di vederla rigenerarsi è l’unico motivo che dirige la mia penna. Ho voluto
esser utile soprattutto ai giovani.
Per mettere questo lavoro alla portata di ogni grado d’attenzione, ho
creduto di doverlo dividere in capitoli; nei primi parlo dell’uomo in
generale e sviluppo, in quelli successivi, le diverse passioni cui è soggetto,
considerandole sempre nel loro rapporto con l’arte teatrale.
Tratto in seguito dei moti interiori e dei segni esteriori che caratterizzano
tutte queste passioni e cerco, per quanto possibile, di scoprirne le cause
prime. Le sole parole di sensibilità, di nobiltà, di eroismo, ecc., ecc., non
possono rivelare alla gioventù la fonte primaria in cui trovare gli impulsi
segreti che devono esser messi in moto in un’arte in cui la rappresentazione
degli affetti appassionati muta continuamente e dove non è mai permesso
di esser passivi. Analizzare e mostrare ogni sfumatura che distingue
ciascuna di queste passioni costituisce lo scopo primario di questo lavoro;
che io possa essere abbastanza ben ispirato da assolverlo!
42
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
CAPITOLO I
Dell’uomo
Per presentare fedelmente l’uomo all’uomo, bisognerebbe conoscerlo nella
sua totalità; bisognerebbe saper distinguere e definire tutte le sfumature
sensibili che differenziano il suo essere e che lo formano, consolidandosi,
dall’esistenza più debole al più alto grado di energia. È un labirinto nel
quale si sono addentrati autorevoli filosofi, ma di cui forse non hanno
ancora percorso ogni anfratto. Come infatti, con lo spirito più acuto e lo
sguardo più lungimirante, cogliere le cause prime che determinano
ineluttabilmente nell’uomo il genere d’impressioni che deve percepire, di
idee che deve immaginare, di passioni che deve provare? Ve ne sono alcuni
ai quali la natura non ha accordato, in istinto, ciò che offre comunemente
agli animali più comuni; ve ne sono altri che sono l’immagine della
divinità, che possono tutto ciò che vogliono e che sembrano nati per
soggiogare i cuori come gli imperi; l’uno nasce coraggioso e intrepido,
mentre l’altro timido e timoroso; la natura, che sembra gettarli
indistintamente in questo mondo, dà pur tuttavia a ognuno un carattere
distintivo e una fisionomia particolare. Questa diversità nell’uomo è tanto
più sorprendente, che tutti hanno pressappoco una stessa conformazione;
ma lo è ancor di più quando le qualità morali e fisiche sono in
contraddizione e per così dire in ragione inversa le une in rapporto alle
altre. Molti di quelli che la natura ha più favorito per statura e bellezza del
sembiante, lo sono meno per i doni dello spirito e dell’anima di quelli ai
quali ha rifiutato gli stessi privilegi e che spesso hanno in forza,
penetrazione e genio ciò che i primi hanno in debolezza, lentezza e
stupidità. Quali possono essere i motivi di questa varietà infinita? Proviene
dalla differenza del sangue, degli umori, dell’educazione o dall’insieme di
queste differenze? Si vedono uomini coltissimi dei quali è stata curata
scrupolosamente l’educazione che, in possesso di una gran memoria, sono
al di sotto della mediocrità e non hanno un solo pensiero giusto. Se ne
vedono di ignorantissimi, ricchi di spirito naturale e persino di genialità.
Non dovremmo concludere che il carattere primitivo che riceviamo dalla
natura è il solo che ci resti per tutta la vita? L’educazione lo raffina e a volte
lo sviluppa, ma non ha mai avuto il potere di cambiarlo.
Tuttavia la natura non può essere meno generosa con gli uomini di quanto
non lo sia con i vegetali. Tutti ricevono in egual modo la linfa che li nutre e
proporzionalmente alle loro necessità. Tutti i terreni, è vero, non hanno le
stesse qualità, in alcuni i succhi nutritivi sono più favorevoli alla
vegetazione. Sarebbe lecito pensare che la differenza che esiste tra gli
uomini dipenda essenzialmente dalle qualità elementari di chi ha dato loro
la vita, dal diverso grado di passione, d’intelligenza, di età e di forza? Forse
i grandi uomini dipendono soltanto dalle propizie inclinazioni fisiche e
morali dei loro genitori.
43
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Comunque sia, l’uomo, dalla costituzione più forte della donna, raddoppia
in un certo qual modo viepiù le proprie forze quando ha la giusta
intelligenza di intraprendere solo quanto esse possono sopportare. Simile,
se oso permettermi questo paragone, a quelli che per mestiere portano dei
fardelli, deve come loro valutare i propri mezzi e per applicare all’arte
teatrale queste massime generali, se gli attori le avessero ben presenti in
mente, non cercherebbero mai di esprimere ciò che non sentono, bensì di
dare a ciò che sentono l’espressione più energica. Si convincerebbero che
l’uomo che nel morale e nel fisico non è padrone di se stesso, non potrà mai
mostrarci il grand’uomo e che colui che sa disporre di sé, saprà presto
disporre degli altri.
Il compito dell’attore può esser ben assolto solo quando ha l’arte di ricevere
e suscitare un’approvazione unanime; non può farlo se non scavando nel
cuore di ogni spettatore, inducendo tutti a confondere le loro sensazioni
personali in una sensazione generale, questo è il talento dell’anima, solo
l’anima ha il privilegio di parlare alle anime e di governarle a suo
piacimento. Cosa sono, in confronto, tutti i modesti calcoli e le vane risorse
dello spirito? Lo spirito parla solo alle passioni mediocri e non produce che
emozioni superficiali, l’anima ne produce di profonde, essa sola sembra un
raggio emanato dalla divinità, in essa sola s’accende il fuoco del genio, essa
nobilita l’uomo, lo trasporta e lo colloca sulle più alte vette.
L’anima dell’attore veramente emozionato, comunica in un rapporto
diretto con quella degli astanti e in questo felice momento, elevato al di
sopra degli uomini e di se stesso, dispone a suo piacimento di chi lo ascolta.
Divina Melpomene! a te devo le più meravigliose sensazioni della mia vita;
se in questo momento potessi raffigurarti con l’intensità che provo!
Trasmetterei al mondo intero il desiderio di vivere sotto le tue leggi e di
tributare ai tuoi altari profanati i dovuti onori. Sì, la voce di Melpomene è
l’unica che abbia il potere di elettrizzare le anime. Ognuno ritrova la
propria nelle grandi emozioni che prova; che l’uomo ascolti la propria
anima, che l’alimenti dei nobili sentimenti, delle passioni eroiche, dei
virtuosi slanci d’entusiasmo che Melpomene esprime e che mette in atto nei
suoi incantevoli spettacoli, allora tutti i vizi vergognosi scompariranno e la
virtù riacquisterà il suo impero!
44
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
CAPITOLO II
Della donna
La donna è nata più debole e più sensibile dell’uomo, non può avere né la
sua energia né la sua forza; ma la natura, sempre generosa, ne compensa la
debolezza con il potere insito in lei. La debolezza della voce ci seduce con le
sue inflessioni armoniose e commoventi. Il suo timido sguardo penetra nel
nostro animo e presto prevale sull’arditezza del nostro. La delicatezza del
suo sembiante chiede in aiuto la nostra forza e il suo ritegno riservato le
offrono, a nostro svantaggio per finezza tatto e prontezza, armi più temibili
di quelle che dobbiamo alla forza stessa. La donna ha ricevuto dalla natura
il potere di provocare in noi sensazioni che vincono e soggiogano ogni
altra. La nostra energia e quella vigoria di carattere di cui andiamo così fieri
è come se svanissero nell’ebbrezza che ci ispira. Da padroni che credevamo
di essere ci ritroviamo suoi schiavi ed è allora che diventa tanto più
pericolosa in quanto ottiene ciò che vuole e in genere vuole sempre ciò che
può. La donna fu creata per l’uomo, la natura le ha fornito ogni seduzione
necessaria alla nostra felicità. Nel darle la voluttà le ha fatto dono del
pudore, regalo tanto più prezioso in quanto lui solo alimenta la fiaccola
dell’amore; la donna dolce e sensibile nel diffondere la voluttà su quanto ci
circonda, calma il nostro ardore, attenua quell’umore altero sempre pronto
a esacerbarsi e a inasprirsi e dissolve le nubi che avvolgono l’orizzonte
della nostra felicità; da lei riceviamo, nei nostri figli, i più preziosi frutti
dell’amore. Come diventa più importante e più cara quando è depositaria
di questo magnifico fardello! Tutto in lei ispira l’amore più tenero e il più
religioso rispetto, i suoi dolori, di cui noi siamo la causa, e la sua costanza
nel sopportarli sono altrettanti nuovi vincoli che ci seducono. I piaceri
dell’anima, uniti a quelli dei sensi, assumono una forma totalmente nuova
alla vista di una tenera madre che stringe fra le braccia il figlio del nostro
amore.
Ci sono voluti altri mezzi per attrarci, entusiasmarci e ispirarci una
passione travolgente, ma nell’esercitare queste virtù semplici e modeste,
mostrandosi circondata da queste creature commoventi, la donna ha potuto
legare per sempre il cuore più volubile.
La donna appassionata raramente fa i conti con se stessa, del tutto presa dal
sentimento che la domina; da tale abbandono derivano le sue grandi virtù e
a volte anche i suoi grandi crimini. Simile a un torrente che trascina nel suo
corso ciò che ne impedisce il passaggio, si butta senza ritegno, sfida ogni
resistenza e travolge ogni ostacolo. Mette così in moto tutti i meccanismi
della seduzione, sottomette al suo volere le grazie del sesso, senza
disattenzione o indugio persegue l’oggetto che l’infiamma e si ferma solo
nell’istante in cui è sicura di trionfare. Ciò che forse contribuisce in maggior
misura a infondere nelle passioni violenza e tenacia è la sua educazione
orientata quasi interamente a conoscerle e a reprimerle o per lo meno a
45
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
nasconderle. Quando arriva al momento in cui la passione dell’amore
l’infiamma, non osa lasciar trapelare il minimo indizio; sempre chiusa in se
stessa, cela col pudore i moti segreti che l’agitano, concentra l’amore in
fondo all’animo fino al momento in cui, non potendo più resistere alla
passione che la consuma, viene tradita da uno sguardo o da un sospiro. Lo
scoppio è tanto più forte quanto la resistenza è stata più energica e sofferta.
Allora spesso soccombe, le forze si sono consumate nella resistenza, una
volta vinta, l’artificio e la virtù si sono logorate e quella fiaccola così
fulgida, al momento della disfatta, si offusca e si consuma all’istante.
In generale le donne sono infedeli solo quando smettono di amare; in altri
termini sono meno soggette all’infedeltà che all’incostanza. Quelle che
amano più intensamente sono anche le più portate a vendicare il loro
orgoglio ferito, quelle che riuniscono alla sensibilità la dignità del sesso
vanno incontro a poche disavventure nel loro modo di amare o di odiare; il
loro cuore si dà alla prima emozione che ha provato, o piuttosto ne prova
solo una, ma lo riprendono al primo vizio che scoprono nella persona in cui
avevano creduto veder riunita ogni perfezione; da quel momento tutto è
finito, le ferite del cuore di una donna sensibile e delicata sono incurabili.
Nelle donne dal carattere meno innocente e meno nobile, quando la voluttà
svanisce viene sostituita dall’indifferenza o dal libertinaggio e così i veri
piaceri sono perduti per sempre. I tormenti suscitati da una vera passione
sono preferibili ai piaceri senza passione.
Il ristretto numero di donne veramente sensibili ama col cuore, le donne
appassionate con i sensi, tutte le altre con la testa. Queste ultime sono le più
incostanti, trascorrono la vita nella ricerca del piacere che sfugge sempre
loro nel momento in cui credono di averlo raggiunto.
Gli uomini sono spesso infedeli con i sensi senza che il cuore partecipi alle
emozioni suscitate alla vista di una bella donna; in questo caso è quasi
sempre sulle donne che deve ricadere il torto degli uomini. La donna che si
rispetta è sempre rispettata, l’uomo osa qualsiasi cosa con quella che vuol
piacere a tutti, non osa nulla con chi si ammanta di modestia e di decenza.
Donne! guardatevi dal cominciare a risvegliare i sensi dell’uomo se volete
dominarne il cuore e lo spirito; i sensi una volta eccitati sfuggono al
controllo dell’uomo; in voi, come in lui, i sensi in delirio sono indomabili.
Fedra ne è una prova evidente; i sensi consumano la sua ragione e il suo
pudore, l’amore, un amore forsennato la trascina malgrado ogni suo sforzo.
Venere la pervade totalmente e la spinge agli eccessi estremi del crimine.101
La maggior parte delle giovani che si avviano al teatro credono che il loro
compito sia assolto quando hanno fatto sentire una voce armoniosa e
mostrato un aspetto grazioso e occhi languidi. Non è così che si esprime il
turbamento delle grandi passioni, non così possono essere rappresentate
101 Venus tout entière, scrive Larive, ricordando i celebri versi del capolavoro raciniano
(Phèdre, atto I, scena 3, v. 306).
46
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Semiramide, Roxane in Bajazet, Ermione e quella Fedra la più terribile e la
più perfetta di tutte le parti di passione.102 Ciò che le rende difficili è
soprattutto il fatto che si esige dalle attrici che le recitano, che persino nei
grandi sconvolgimenti dell’anima, testimonianza del loro turbamento e
della loro agitazione, mantengano sempre la decenza adeguata al loro
sesso. La donna, anche quando è travolta dalla passione che la mette fuor
di sé, non deve esprimere l’amore come l’uomo, l’uomo ha le sue sfumature
espressive così come la donna ha le proprie, altrimenti le nozioni morali
sarebbero sovvertite e tutte le convenzioni profanate.
Di solito in entrambi i sessi il primo sentimento dell’amore è timido e
timoroso. Comincia con gli sguardi, si fortifica con la voce, si accresce nel
cuore e si consuma nei sensi.
Potrebbe sembrare che in questo capitolo mi sia poco occupato dell’arte
drammatica, eppure vi si ricollega totalmente. Che le giovani attrici lo
leggano e vi riflettano, servirà a sostituire l’esperienza, farà loro conoscere,
con poca fatica, i meccanismi che devono far funzionare per esprimere nel
modo giusto le passioni delicate e soprattutto quelle grandi e travolgenti.
Personaggi rispettivamente delle tragedie di Voltaire, Sémiramis, 29 agosto 1748 e di
Racine, Bajazet, Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, inizi gennaio 1672; Andromaque, Théâtre de
l’Hôtel de Bourgogne, novembre 1667.
102
47
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
CAPITOLO III
Qualità solitamente necessarie a coloro i quali si avviano alla carriera
teatrale
Il teatro esigerebbe dall’attore ogni perfezione fisica e morale, ma come
riunirle in un unico individuo che a sua volta riunisce in quello che si
definisce il suo ruolo tanti caratteri diversi e forme opposte? Se l’attore è
bello e dall’aspetto di un Apollo, non potrà mostrarci le forme di Ercole, se
ha quelle di Ercole gli sarà impossibile darci l’dea della grazia nobile,
flessuosa e delicata di Apollo. Achille e Gengis Khan, Tancredi e Maometto
esigono corporature e voci diverse.103 Tuttavia queste parti appartengono al
medesimo ruolo.104 Come allora osare definire le qualità necessarie alle
prime parti?105
Personaggi rispettivamente delle tragedie di: Racine, Iphigénie en Aulide, [Ifigenia in
Aulide], Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne 1674-1675 e di Voltaire: L’Orphelin de la Chine
[L’Orfano della Cina], 20 agosto 1755; Tancrède, 3 settembre 1760; Mahomet, ou le Fanatisme
[Maometto o il fanatismo] (9 agosto 1742). Sull’opposizione fra i personaggi di Tancredi e di
Maometto, Larive ritornerà nella seconda parte del suo Cours: «Maometto parla con la sua
audacia, mentre Tancredi col suo cuore e la sua sensibilità. La recitazione di Tancredi deve
essere sensibile nelle sue inflessioni, quella di Maometto che è guidato solo dalla politica,
deve avere una specie di durezza inscindibile da un carattere crudele e che nulla può
commuovere», Cours, II, pp. 355-356.
104 La pretesa di legare per sempre ai ruoli le parti che per una volta sono state loro attribuite,
costituisce un grande ostacolo al perfezionamento dell’arte teatrale. In occasione di una nuova pièce,
un grande attore, capace di diversificare il proprio talento, assume una parte non appartenente a
quelle da lui solitamente recitate. Ha successo e dopo di lui gli attori che subentrano nel suo ruolo,
senza ereditare la molteplicità dei suoi talenti, non vogliono rinunciare a quella parte. Viene mal
recitata durante la loro vita e spesso persino dopo di loro. L’amor proprio li acceca sugli interessi
stessi del loro amor proprio.
105 Alla fine della seconda parte del Cours del 1810, Larive propone una divisione schematica
e un modello ideale di alcuni ruoli maschili (Les Rois, Premier rôle en homme, Jeune premier),
senza però specificare quali siano le prime parti. È evidente che Larive si identifichi nel
Premier rôle en homme (prime parti maschili) e descriva se stesso nel raffigurare le
caratteristiche dell’attore esemplare: «La statura più adatta a questo ruolo deve essere di
cinque piedi e cinque pollici [circa un metro e settantacinque], ben proporzionata: in genere
grazia e nobiltà dipendono dalla perfezione delle forme. Il viso deve essere ovale, i capelli
scuri, gli occhi di un bel taglio neri e vivaci, le sopracciglia pronunciate, i denti bianchi e ben
proporzionati, un insieme maschio e vigoroso, grande sicurezza, libero e agile nei
movimenti, il temperamento sanguigno e ribelle, un registro vocale chiaro e vellutato che
possa prestarsi a ogni tipo d’espressione, un’articolazione sostenuta e agile, un’anima
ardente e duttile che permetta di immedesimarsi in qualsiasi carattere. Con queste qualità
un attore sarà degno di una grande considerazione che non può acquisirsi legittimamente se
non recitando ugualmente bene tutte le parti e immedesimandosi in tutte le diverse passioni
che sono alla base dei generi eroico, cavalleresco, encomiastico, sensibile e terribile: chi può
facilmente mettere in moto qualsiasi slancio tragico, è il solo meritevole di una grande
celebrità, impossibile da meritare con un unico genere che ridurrebbe l’attore a cinque o sei
parti. Lekain che era ben lungi dal possedere le qualità fisiche di cui ho appena parlato,
aveva tutte quelle dell’anima: portava fino al delirio l’espressione di ogni passione, solo lui
fu all’altezza della sua reputazione», Cours, II, pp. 328-329.
103
48
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
La perfezione dell’arte sembrerebbe esigere sia quella delle forme che dei
costumi. L’occhio dello spettatore sarebbe offeso nel vedere recitare
Tancredi col costume di Maometto; eppure vede spesso, senza
sorprendersi, un uomo basso impersonarne uno alto, un giovane
impersonare un vecchio e un vecchio un giovane. Ciò è sicuramente
sconcertante in chi è privo di un evidente talento. La sola magia del talento
fa dimenticare agli spettatori ciò che manca all’attore sul versante
dell’aspetto. Mlle Clairon, una donna molto minuta, sembrava avere in
scena una statura nobilissima e imponente. La nobiltà d’animo si trasmette
al corpo o la supplisce.
La natura, avara dei suoi doni, non li elargisce tutti a un solo individuo.
Colui che non ha per natura quei difetti difficilissimi da correggere con
l’arte, che accanto a una grande sensibilità ha una passione marcata per il
teatro, può, con coraggio e costanza, avventurarsi in questa difficile carriera
e deve ancora stimarsi felice se ottiene qualche successo. Ma ci vuole ben
altro per raggiungere il più alto grado di perfezione richiesto dall’arte. È
necessario associare a una sensibilità spontanea, una viva immaginazione,
uno spirito giusto, un tatto acuto e delicato. Coloro i quali sono dotati dalla
natura di queste preziose qualità hanno quasi sempre il fisico adatto alle
parti principali, solo il morale mette in moto il fisico. La fisionomia è
nell’anima, il volto non ne è che l’interprete.
In più è necessaria una voce vigorosa, morbida e sensibile che possa
identificarsi con i sentimenti dell’animo e confondersi talmente con quelli
che l’attore vuole comunicare con l’espressività della fisionomia, con il
gesto che deve sempre accompagnare o precedere l’azione, da risultare un
insieme perfetto e che costituisce un tutt’uno. Quest’unità e questo accordo,
necessari in tutte le arti e senza i quali non esiste un grande attore,
s’incontrano ben difficilmente e molto raramente. Quasi altrettanto il vero
ardore che scaturisce dall’anima. Molti hanno l’ardore solo nella mente,
altri nel cuore, altri infine, che non provano nulla, ne hanno uno artificioso
che può abbagliare per un po’ il pubblico, ma che mai potrà sedurlo. Per
dirla in breve è necessario, grazie a una grande mobilità, poter imbeversi di
tutti i caratteri dimenticando quello personale, trasportare la propria anima
in quella degli eroi rappresentati e confonderle al punto che non si possa,
per così dire, ritrovare se stessi se non dopo essersi allontanati dal teatro e
spogliati dal costume. Chi è abbastanza fortunato da raggiungere un tale
grado di illusione teatrale non ha bisogno né di statura né di sembiante:
l’anima abbellisce tutto, ha il privilegio esclusivo di attirare a sé i cuori e di
trascinarli, di soggiogarli, di far loro credere e vedere ciò che vuole. L’arte
di essere veramente tragico dipende dunque solo dalle emozioni
dell’anima: è un talento d’ispirazione. Da questo derivano a volte quei
rapidi scambi di emozione tra attore e spettatore che costituiscono l’effetto
più magico e il vero trionfo dell’arte.
49
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Spesso l’anima dell’attore infiammata dagli applausi si esalta e gli suscita
quei felici slanci che uno studio per quanto approfondito non gli avrebbe
mai dato, spesso poi riceve e comunica a chi è in scena con lui impressioni
inattese. Se le persone che lo affiancano sono sensibili a queste impressioni,
se sono giusti nella dizione e nell’intonazione, l’attore ben ispirato diventa
sublime e allora può abbandonarsi ai moti delle passioni più intense e
l’animo degli spettatori, trascinato dall’illusione, s’identifica in un certo
senso con il suo. Se al contrario tutto è gelido intorno a lui, presto sentirà se
stesso agghiacciarsi, la verità scompare, la terribile verità tragica viene
sostituita solo dall’arte. L’attore a disagio nei movimenti si esprime male, lo
avverte e il suo imbarazzo aumenta nei momenti in cui avrebbe più
bisogno di naturalezza e di libertà. Chi ha un corpo armonioso si presenta
sempre in modo nobile e spontaneo. L’imbarazzo è dannoso tanto alla voce
quanto ai movimenti; l’attore la cui voce è falsa o noiosa, seppur dotato di
reale sensibilità, non è mai vero. La sua intonazione appare quasi sempre in
una sorta di contraddizione con i sentimenti che prova e che vuole
esprimere. È impossibile rendere tutti i begli effetti della tragedia con
intonazioni prestabilite. Si può stupire il pubblico, lo si può anche
terrificare, ma non intenerire. Le sue emozioni, quelle che fanno scorrere
lacrime così deliziose, mai sono prodotte da quegli scoppi a comando, da
quelle convulsioni spaventose che lasciano freddi gli spettatori o non
ispirano che orrore. Se non sempre dipende da noi essere veri e sensibili,
dipende da noi, per lo meno, l’essere decenti nelle espressioni e nei
movimenti.106 Si direbbe che ad alcuni attori risulti più facile provare e
rappresentare il terrore piuttosto che ispirarlo: chi pensa di provocare la
sensibilità con sforzi e scoppi, non ne avrà mai; quando parla il cuore, il
petto, la testa, tutte le fibre attinenti gli obbediscono e appaiono sollecite nel
fornirgli i mezzi necessari alla sua esplosione, ma quando solo la testa
vuole sostituire il cuore lo comprime e lo soffoca, ne risulta un frastuono
senza emozione e scoppi senza effetto.
Sarebbe difficile analizzare gli elementi che costituiscono gli stati d’animo
del pubblico riunito. Due o tremila persone, provenienti dal centro o dalle
periferie di una città, si ritrovano, senza conoscersi, alla stessa ora e nello
stesso luogo. Inizia lo spettacolo e quelle stesse persone, diventate l’essere
collettivo che si chiama pubblico, assumono contemporaneamente gli stessi
stati d’animo e li restituiscono agli attori dai quali li hanno ricevuti; se
hanno il talento di commuovere il pubblico, esso diventa appassionato e
animato, da freddo e indifferente qual era; se ne sono privi, il pubblico,
106 Potrei qui ricordare il giudizio di Garrick vedendo recitare Mlle Duclos che, per la bellezza del suo
volto e la sensibilità della sua voce, suscitò le lacrime degli spettatori senza che il suo animo fosse
commosso da ciò che diceva di veramente tragico. Dopo la tirata più energica e straziante, di colpo
restituì al viso la sua abituale serenità, ciò che fece dire a Garrick: «È veramente una bonacciona, non
prova rancore».
50
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
fattosi distratto, comunica questa disattenzione agli attori, la
rappresentazione langue; si era venuti alla ricerca di profonde emozioni,
non ne consegue che noia.
51
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
SECONDO INCONTRO
CAPITOLO IV
Della voce e dei suoi effetti; della pronuncia e dell’articolazione
Per l’attore, l’organo fra tutti il più prezioso è quello della voce, delegata
com’è a manifestare ogni nostra sensazione e a esprimere i diversi
sentimenti che ci turbano. La voce è l’interprete delle passioni, deve essere
sempre a loro sottoposta, deve, modificandosi con maggiore o minore
intensità, forza, calore o sensibilità, eccitarle, elevarle a nostro piacimento
nell’anima di chi ci ascolta.
Il suo accento varia di continuo, le modulazioni ne sono infinite. Di volta in
volta tonante o sensibile, imperiosa o supplichevole, esprime e ispira il
coraggio, la collera, il terrore, la speranza, la tenerezza e tutte le sfumature
della più delicata sensibilità; il suo impero è un incanto:107 soggiogare,
trascinare, far scorrere le lacrime o fermarle, sono gli effetti dei suoi incanti.
Ma per produrli non deve essere alterata da alcun difetto di pronuncia,
anche il minimo dovrebbe far escludere dal primo teatro quelli che vi si
indirizzano.108 La erre moscia, il zetacismo, gli accenti guascone, normanno,
provenzale sono incompatibili con l’eloquenza drammatica e comunque
con ogni tipo di eloquenza. Nell’attore tragico si esigono tutte le qualità
della voce, non si può esserlo con difetti essenzialmente comici.
Si era più severi in passato su imperfezioni di questo genere di quanto non
lo si sia oggi; il minimo difetto di voce, per quanto dotati di talento, era
motivo sufficiente per essere esclusi dal primo teatro della nazione. In
effetti questo teatro deve essere per la lingua pronunciata ciò che è il
Dizionario dell’Accademia per la lingua scritta, deve servire da autorità.109
Un tempo il Théâtre-Français faceva a tutti da scuola, persino agli stranieri,
e ci si avvaleva della sua pronuncia in caso d’incertezze. Ma negli ultimi
anni dell’Ancien Régime, la gente di corte aveva creato un linguaggio
estremamente ridicolo che, per dare al loro parlare maggior spigliatezza o
mollezza, privava la lingua di nobiltà e grazia e i nostri damerini si sono
permessi di portare in scena queste imperfezioni. Altre cause hanno poi
generato altri difetti nella pronuncia della lingua. Sarebbe ormai tempo di
porvi rimedio, si dovrebbe formare una commissione davanti alla quale
convocare coloro i quali osano svilire, svigorire e disonorare sulla scena la
lingua dei Corneille, dei Racine e dei Voltaire. Non sta a me attribuire un
ordine fra queste celebrità, ma mi sembra che sia soprattutto a Racine che il
Dico della voce quanto La Fontaine affermava sulla favola: «È propriamente un incanto».
Primo teatro di Francia è per antonomasia il Théâtre-Français, o Comédie-Française i cui
attori che dipendono dal potere regio sono cooptati per acclarate doti interpretative.
109 Il Dictionnaire de l’Académie française (pubblicato nel 1694) era stato voluto da Richelieu
quale dizionario di lingua normativa, la redazione dei ‘Quarante’ dell’Académie française,
fondata nel 1635, si era rivelata di un’estrema lentezza.
107
108
52
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
teatro debba la sua perfezione che è e resterà il vero modello di questa bella
arte e che infine non invecchierà se non quando il buon gusto, già stanco
degli attacchi che gli portiamo di continuo, ci avrà interamente
abbandonati. Non è forse una barbarie sfigurare, con una pronuncia
scorretta, un linguaggio così eloquente, così armonioso, così puro? Cosa di
più ridicolo di pronunciare la erre moscia e di declamare Racine con un
accento guascone?
Per ben parlare si deve articolare distintamente pronunciando le diverse
consonanti e ciò dipende dal lavoro delle varie parti della bocca.
Particolarmente quello delle labbra dà alla voce grazia ed espressione; si
avrà una bella dizione declamando con esattezza e articolando con
chiarezza, non lasciando mai uscire i suoni senza che vengano modificati e
in un certo qual modo affinati dalle labbra. La voce, per quanto bella possa
essere, non sedurrà mai uscendo da una bocca molle e inerte.
Benché la voce sia in genere in rapporto diretto con una maggiore o minore
forza o sensibilità di ogni individuo, è possibile, esercitandola di continuo,
farla diventare più espressiva, aggraziata e precisa. Una voce debole che
pronuncia distintamente è superiore a una voce forte che articola con
mollezza.
Il lavoro della bocca e delle labbra soprattutto è, lo ripeto, ciò che la rende
vigorosa, sonora, duttile e sensibile; ciò dà alla parlata quella nobiltà
seducente che lusinga e incanta l’udito. Ma per questo è necessario che le
corde siano mantenute nella loro freschezza e nella loro sensibilità
primitiva e che non siano né forzate né arrochite, la gente del popolo ha la
voce rauca per averne usato le fibre con grida forzate e con l’abuso di
liquori forti che disseccano, a lungo andare, tutte le parti umide della gola e
del palato, così necessarie per modificare i suoni e articolare perfettamente
le parole.
È molto raro che un solo individuo riunisca tutte le qualità della voce, ma si
può, tramite un esercizio continuo, domarla, dirigerla, graduarla senza
scatti e senza sforzi, in modo da poterne padroneggiare le inflessioni e
ottenere quei mezzi toni che incantano e pervadono l’anima. La voce, come
il corpo, ha una crescita e diversi gradi di forza, ogni parte ha un’età,
un’espressione, una voce; la perfezione dell’arte esige che l’attore assuma il
volto, la voce e i gesti adeguati all’età, alla forza e all’espressione di
ciascuna parte. Da questo difficile lavoro dipende in larga misura la vera
magia del teatro. Quando l’attore è ben penetrato nella sua parte e
permeato dal sentimento dominante, i muscoli del viso, i gesti, la voce sono
in sintonia; tutto mantiene un perfetto insieme, tutto in lui procede in
accordo, solo allora appare l’attore consumato, il grande attore o piuttosto è
allora che l’attore scompare e che il pubblico incantato non vede e non
ascolta più in lui che il personaggio rappresentato.
53
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
La voce è l’eco dei sentimenti e del pensiero. L’attore, compenetrandosi
intensamente in ciò che vuole esprimere, ascoltando con attenzione,
persuadendosi che nulla deve essere detto senza esser stato pensato dallo
spirito e sentito dal cuore, riflessivo quando necessario e appassionato
quando l’azione l’esige, sarà sicuro di disporre a suo piacimento di ogni
suono; non sarà più esposto alle dissonanze, troppo abituali tra due
personaggi che parlano tra loro senza ascoltarsi. In questo ultimo caso,
diventato troppo frequente sulle nostre scene, solo la memoria agendo sugli
interlocutori, la voce fattasi vaga e senza direzione, esce dal suo centro
naturale, non riceve più che intonazioni di testa o di petto, diventa
monotona e falsa e perde inevitabilmente ogni verità, ogni sfumatura,
espressività e calore.
Se ci si impegnasse a conoscere in modo adeguato tutti gli effetti della voce
si intuirebbe quasi sempre, proprio dal suono, chi parla. La voce di una
persona sincera e vera è in genere più estesa e sonora, il suono è più chiaro
e più morbido di quella di una persona falsa che la costringe a una dolcezza
forzata che mai seduce l’osservatore attento. L’ipocrita dà alla voce un certo
tono mellifluo che inganna solo chi predilige la bassa adulazione e chi va
incontro all’errore. La franchezza ha una voce che le assomiglia, che
l’annuncia e l’esprime.
A volte il suono della voce si imprime nel ricordo più profondamente dei
tratti del volto. Persino a distanza di tempo può risvegliare di colpo le
emozioni che erano state suscitate. Che mi sia permesso di evocare ora, e
anche nel seguito di questo lavoro, alcuni aneddoti che via via
riaffioreranno alla mia memoria: avranno almeno il merito di evitare la
monotonia e di fornire forse qualche piacevole diversivo ai precetti da me
proposti.
Circa quindici anni fa, un mese dopo aver recitato Orosmane,110 volli
acquistare una catena d’acciaio. Era nel periodo delle visite rituali all’inizio
di ogni anno e agghindato come si usava allora.111 Mi fermai davanti a un
negozio che mi sembrava ben fornito in quel genere. Entrando chiedo a una
donna, che stava al banco, le catene d’orologio. La donna sembra sorpresa
nell’ascoltarmi, mi guarda con aria stupita, resta immobile e mi scruta
senza rispondermi; ripeto la domanda con tono più forte; nessuna risposta.
Divenni impaziente e stavo per arrabbiarmi quando ruppe il silenzio
dicendo: «Ah, mio Dio, come sono sorpresa! Cosa! signora, chiederle le
catene che avete in vendita! Ah, signore! Scusatemi, ma avete una voce così
straordinaria che non riesco a dominare l’emozione che mi provoca. In
Larive interpreta Orosmane nella tragedia di Voltaire, Zaïre (13 agosto 1732), in modo
continuato dal 1775 al 1788.
111 L’anno teatrale coincideva con la ripresa degli spettacoli il lunedì successivo alla
Quasimodo (domenica in Albis) dopo il periodo di chiusura annuale di tre settimane
durante la quaresima e le festività pasquali.
110
54
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
verità, signora, se uno di noi due ha diritto a essere stupito, sono
certamente io, perché non vedo nulla di straordinario nella mia voce: siete
la prima persona a farmi questo singolare complimento. Signore, in nome
di Dio, ditemi chi siete e tutto ciò che ho è a vostra disposizione». Non
volendo cedere a quella indiscreta curiosità stavo per andarmene, quando
mi prese per il braccio, supplicandomi di nuovo, ma con tale insistenza che
non potetti più resistere.
Mi chiamo Larive, le risposi, e sono un attore tragico. Non appena sente il
mio nome, improvvisamente mi prende la testa fra le mani esclamando:
«Ah! disgraziato! siete voi ad aver assassinato Zaira». È impossibile
descrivere la mia sorpresa, non sapevo se dovevo arrabbiarmi oppure
ringraziarla. Nel dubbio fuggii e salii in vettura; la vidi ancora tendere le
braccia e ripetere di continuo: Ah, mio Dio! mio Dio! chi l’avrebbe pensato?
Esiste forse ancora nel dipartimento del Basso Reno una certa locanda dove
scommetto ci si ricordi ancora della mia voce. Ritornavo da Strasburgo nei
primi tempi della Rivoluzione. Dormii in un minuscolo paesello dove
trovai solo quella locanda, una delle peggiori dove mai sia entrato. La
camera da me occupata era al di sopra di uno stanzone, luogo di riunione
dei famigli. Un istante dopo essermi coricato, entrò un cappuccino, fu
ricevuto premurosamente, gli fu offerto da bere, cosa che non disdegnò di
rifiutare. Sentivo ciò che diceva attraverso uno sconnesso impiantito dove
una fessura lasciava penetrare la luce. Interrogavano il cappuccino su
quanto stava accadendo; rispondeva con tale insensatezza che ne fui
spazientito. Non riuscendo a dormire e estremamente infastidito dal suo
chiacchiericcio su Dio e su San Francesco, mi alzai piano piano, mi misi
sulla fessura dell’impiantito e declamai con tutta la mia possanza questi
due versi di Maometto, parodiando il secondo:
Andate, vile idolatra, nato per esserlo sempre,
Indegno Cappuccino, cercatevi un altro padrone.112
Non appena ebbi finito tutti scomparvero con la rapidità di un lampo.
L’indomani mattina la padrona di casa mi chiese se avessi sentito qualcosa;
No, le risposi, ho dormito benissimo. Mi guardò sospirando. Avete un’aria
triste, le dissi, è successo qualcosa di increscioso? Ah! signore, ieri sera il
reverendo padre cappuccino, nostro vicino, è venuto a trovarci e mentre
stava bevendo parlando con i nostri figli di religione abbiamo sentito una
voce terribile che sembrava uscire dall’inferno e che ha apostrofato il
reverendo padre in modo così spaventoso che è fuggito e non sappiamo
cosa gli sia accaduto.
Dal Mahomet, ou le Fanatisme di Voltaire: «Allez, vil idolâtre, et né pour toujours l’être, /
Indigne Capucin [Musulman], cherchez un autre maître» (battuta di Maometto a Séïde, atto
III, scena 6, vv. 879-880, dove la parola Cappuccino sostituisce la parola Musulmano).
112
55
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Abbiamo appena visto quale potenza possa avere una voce maschia,
reboante e sonora; ma se una voce così è adatta all’uomo che ha ricevuto
dalla natura il dono della forza, altrettanto sarebbe poco adatta a una
donna che deve piacere, soprattutto per la grazia e la dolcezza. In poche
parole nulla è meno consono alle donne di una voce maschile. Quando
sento a teatro un’attrice con questo difetto, mi ricordo sempre di quel cieco
che chiedeva l’elemosina a una signora che dandogliela gli parlò con voce
così aspra e forte che il cieco esclamò: Grazie, mio capitano.
56
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
CAPITOLO V
Della vista e dell’udito
L’occhio e l’orecchio sono le guide offerteci dalla natura; vigilano senza
sosta per la nostra difesa e la nostra sicurezza. Quanto colpisce gli occhi,
richiama l’orecchio, quanto colpisce l’orecchio richiama gli occhi. Sempre
vigili e in accordo precedono, per così dire, ogni sensazione; la nostra
sensibilità viene eccitata soprattutto grazie a loro. Quando sono uniti
sull’oggetto che ci affascina, i nostri organi e ogni nostra facoltà morale si
assommano e si concentrano e allora proviamo un godimento perfetto.
Gli occhi delegati per ricevere le impressioni, lo sono anche per trasmetterle
ancora più velocemente della voce. Per questo sul palcoscenico,
rappresentazione fedele della vita, devono essere sempre in gioco e niente è
più inopportuno né più spiacevole di un attore distratto. Se gli attori
sapessero il torto che fanno al loro talento con le loro continue distrazioni,
non li si vedrebbero, come spesso succede, portare vagamente sul pubblico
lo sguardo che mai dovrebbe superare il perimetro del palcoscenico. Gli
occhi, una volta persi in un oggetto estraneo a quello in cui l’attore deve
essere impegnato, attirano subito il suo pensiero, il talento lo segue e al
posto di un personaggio sensibile e riflessivo, non si vede che una statua
mobile, ma insignificante e inanimata.
Gli occhi, si dice solitamente, sono lo specchio dell’anima, cioè in altri
termini che lo sono del sentimento e del pensiero.
L’occhio timido o pudico evita fin da subito l’oggetto che lo colpisce o che
lo governa. Lo sguardo dell’uomo coraggioso e vero che si fissa su quello di
un uomo falso o vigliacco è sicuro di farglielo abbassare. L’occhio
osservatore pervade immediatamente ogni recesso del cuore: l’espressione
dello sguardo ha sfumature simili a quelle del carattere. La natura ha
fornito all’uomo questi due lumi non solo per guidare i suoi passi e
penetrare fin nel profondo di coloro sui quali si fissa, ma anche per farsi
leggere nei propri; dando allo sguardo dell’uomo un’espressione così
rapida e vera, sembra aver voluto bandire dalla terra la doppiezza e il
tradimento. Lo sguardo annuncia da subito il coraggio e la debolezza, la
franchezza o la falsità, la bontà o la cattiveria, l’amore o l’odio.
Il potere dello sguardo, così necessario da riconoscere nella vita, è di una
tale importanza a teatro che degli occhi brutti costituiscono uno dei difetti
naturali più incompatibili con l’arte attoriale. La vista bassa è tanto più
svantaggiata perché l’occhio non si fissa su niente e non ispira nulla. Mi ero
servito a lungo e con non poco successo dei miei occhi senza aver mai
considerato il potere di quest’organo: fu una scimmietta che avevo a
indurmi a riflettere su questo argomento. Era, come lo sono tutte, cattiva o
timida, aveva malmenato varie persone venute a trovarmi, tuttavia ero
stato sempre risparmiato e in genere non mordeva chi non aveva l’aria di
temerla; la sua prima mossa era di guardare intensamente tutti dritto negli
57
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
occhi. Tra i miei conoscenti c’era un incisore dallo sguardo freddo e ardito,
il giorno in cui venne da me la scimmietta aveva morso una donna; ne ero
rammaricato e ne parlai davanti a quell’artista che sembrò stupito
dall’audacia di un animale così piccolo. Volle vederlo: non gli nascosi il mio
timore che incorresse nella stessa sorte. Non ne tenne conto, affermando
che la mia scimmia non gli avrebbe fatto paura e che non avrebbe osato
morderlo. Volli esser presente all’incontro, la scimmia era nella sua
gabbietta, l’aprii: nell’uscirne scorge l’incisore, lo guarda facendo una
smorfia terribile. Anche lui, senza scomporsi la fissa con fermezza, la
scimmia pronta a slanciarsi tenta di nuovo l’effetto del suo piglio, ma
vedendo che lo guardo dell’avversario non perde né forza né espressività,
all’improvviso si ferma, sviando il suo; nello stesso momento riceve un
calcio e rientra ingloriosamente nella sua gabbia, la presi dicendo al suo
dominatore: la mia scimmia era un despota, l’avete appena resa schiava, ve
la regalo.
Qualche tempo dopo passai da lui e fui non poco sorpreso nel trovare la
scimmietta obbediente quanto era stata disobbediente con me. L’avete
insomma ben malmenata, gli dissi. No, mi rispose, l’ho resa docile solo
fissando i miei occhi nei suoi in modo minaccioso ogni qual volta voleva
fare il suo comodo.
Tutto ciò mi fece riflettere a lungo: da allora fui portato quasi
automaticamente a osservare gli occhi di chi frequentavo, studiandoli
attentamente mi convinsi sempre di più del potere che lo sguardo ha
sull’uomo; mi persuasi anche che gli occhi sono fra gli organi esterni quelli
che meno possono dissimulare il nostro pensiero; anche la persona più
sprovveduta se vuole fissarli nello sguardo di chi osserva sarà subito a
conoscenza del sentimento che lo anima. Se l’amore non avesse una benda
sugli occhi non ingannerebbe nessuno, sarebbe facile da prevedere, ma la
natura ha voluto che gli occhi degli amanti fossero nascosti da una nuvola
di cui la benda ne costituisce il simbolo. Le passioni sono cieche mentre
sarebbe necessario saper ben vedere. Man mano che si affievoliscono, gli
occhi si aprono, l’uomo riacquista l’equilibrio e la ragione lo riporta alla
verità.
L’animale più feroce si scaglia sulla sua vittima solo dopo aver visto negli
occhi il terrore che le incute; lo sguardo dell’uomo coraggioso ha un potere
che solo la morte può domare; il suo corpo soccombe alla forza, steso nella
polvere il suo occhio è ancora minaccioso e si spegne con lui. Ci sono mille
aneddoti che provano l’effetto prodotto dallo sguardo sullo spirito e
sull’anima. Eccone uno che, pur essendo estraneo al teatro, può tuttavia
esser usato in ciò che concerne sensazioni e impressioni fuggevoli.
58
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Durante la convalescenza del Delfino, padre di Luigi XVI, dopo una
pericolosa malattia,113 le Dames de la Halle andarono come si usava allora a
complimentarsi con lui.114 Luigi XV volle essere testimone della loro gioia e
sentire quanto sarebbe stato detto di ameno. Si era sistemato in disparte
nell’appartamento del figlio. Non appena quelle donne videro il Delfino, la
rappresentante gli disse: «Ah! Monsignore, quanto siamo felici di rivedervi!
Cosa ci sarebbe successo se foste morto! Tutto sarebbe andato perduto,
Monsignore, tutto sarebbe andato perduto».
A quelle parole gli occhi di una di loro incontrarono per caso quelli del re,
scorgendovi una sorta di turbamento. All’istante, senza perdere la
concentrazione, interrompendo l’allocutrice, esclamò: «Hai ragione,
comare, tutto sarebbe andato perduto perché il re suo padre, qui presente,
ne sarebbe morto di dolore!». Questa frase che nel suo genere ha qualcosa
di sublime, fu ispirata da un semplice sguardo.
Saper osservare gli sguardi e comprenderli è una parte essenziale dell’arte
che la maggioranza degli attori trascura. Ascoltare ne è un’altra di cui
parimenti si danno poco pensiero. Ignorano apparentemente che la
fisionomia deve essere sempre subordinata alle impressioni dello sguardo e
dell’udito. Anche il corpo deve assumere l’atteggiamento richiesto da
quelle impressioni; la posizione dell’uomo che guarda non deve essere la
stessa dell’uomo che ascolta: l’occhio e il corpo si fermano quando
l’orecchio vuole ascoltare.
Il sordo crede di ascoltare con gli occhi, il cieco di vedere con l’udito.
Molti attori hanno poi il difetto di rispondere senza aver ascoltato. L’ultimo
verso della loro battuta è il solo che li colpisca, si tratta allora di macchine
che esercitano un mestiere e purtroppo ci sono molte di queste macchine
che screditano questa bella arte.
Louis-Ferdinand de France, figlio di Luigi XV, chiamato il delfino Louis, (1729-1765); dal
matrimonio con Marie-Josèphe de Saxe, era nato, nel 1754, il futuro Luigi XVI.
114 Il comitato delle Dames de la Halle riuniva un numero scelto di venditrici delle diverse
corporazioni dei mercati generali di Parigi (pescivendole, erbivendole…) che godevano di
particolari privilegi corporativi come il diritto di occupare il palco reale della ComédieFrançaise per gli spettacoli che venivano dati gratis.
113
59
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
TERZO INCONTRO
CAPITOLO VI
Della sensibilità in genere e dei ricordi
Ho sentito dire a proposito di tale o tal altro attore che non lasciava nulla a
desiderare nei sentimenti eroici per quanto riguardava il coraggio e lo
sviluppo del carattere cavalleresco, ma che non aveva sensibilità: non sono
mai riuscito a capire un giudizio così assurdo. L’attore che esprime
perfettamente questi slanci dell’anima, che sa interpretare l’uomo insigne,
generoso e coraggioso, non può farlo senza avere una sensibilità raffinata.
Ogni passione ha un genere di sensibilità che gli è propria. La collera, la
paura, il furore e gli altri trasporti di questo tipo non possono essere ben
interpretati da un uomo insensibile; hanno, come la compassione, la
tenerezza e come anche l’amore, la loro sfumatura di sensibilità che varia
secondo le parti, le situazioni e le diverse circostanze della
rappresentazione teatrale. L’attore deve averle asservite tutte alla sua
volontà e se ne esiste una di cui non possa compenetrarsi, esaminatelo
attentamente quando dovrà esprimerne un’altra, malgrado le apparenze
seducenti vedrete che manca di verità. La sensibilità che si manifesta con le
lacrime è la più comune e l’ultimo degli uomini piange per una minima
contrarietà; questa sensibilità dipende spesso da una debolezza di carattere
e di costituzione fisica. La vera sensibilità, quella dell’anima, è rara quanto
preziosa, per suo tramite l’attore rende con scioltezza e senza sforzo i
sentimenti nobili, generosi e profondi, non appartiene mai a chi non ha la
vera dignità dell’uomo. Le lacrime non sempre costituiscono la prova di
una vera sensibilità. Cercherò di illuminare, su questo difficile punto, quelli
che ne sono ingannati ogni giorno.
Sembra che tutto sia finito quando si dice: ho visto scorrere le sue lacrime.
C’è nelle lacrime una differenza sensibile secondo la diversità delle cause
che le fanno versare. Il riflesso che le provoca in un individuo è lo stesso
che le trattiene in un altro; ce ne sono che scorrono, per così dire, solo sul
cuore senza mai risalire fino agli occhi: sono quelle delle anime forti: negli
uni le lacrime sono il primo effetto della sensibilità, negli altri ne sono
l’ultimo.
Ho conosciuto donne appassionate all’eccesso che non avevano una sola
sfumatura di sensibilità d’animo e che versavano un profluvio di lacrime
non appena la loro passione veniva avversata. In genere questo tipo di
donne piangono solo per se stesse e non hanno mai una lacrima per le
disgrazie che non le riguardano. Ne ho conosciute che piangevano al
minimo racconto toccante senza esser mai commosse e che passavano, da
un momento all’altro, dalla tristezza alla gioia senza che restasse la minima
traccia di tristezza nella gioia, né di gioia nella tristezza. Ne ho infine
conosciute di estremamente sensibili che, con il loro modo commovente e
60
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
ingenuo di esprimere il dolore, provocavano il pianto in chi aveva come
loro un’anima pura e sensibile: quei pianti scorrono senza fatica né
convulsioni, esprimono il dolore, quello che definiamo bel dolore. Sembra
allora che tutto pianga: i muscoli, i nervi, i tratti, la voce, eppure nulla è
esagerato, nulla è grottesco, ogni cosa conserva la bellezza che gli è propria
e gli occhi non essendo irritati da alcun movimento convulso, formano un
insieme che caratterizza il vero e bel dolore, quello che gli antichi
conoscevano così bene e da cui mai si dipartivano nelle produzioni delle
arti. Non c’è dolore dell’anima paragonabile a quello di Niobe: lo si legge
pienamente nei suoi tratti, senza che la bellezza ne venga alterata; la
dismisura del dolore morale e di quello fisico è scolpita nel volto del
Laocoonte, eppure nulla sfigura la sua imponente bellezza. Sono i due
modelli più perfetti che l’attore possa prefiggersi quando vuole esprimere il
dolore tragico e che sempre deve essere un dolore bello e nobile.
Il pianto non scorre mai con più dolcezza che a seguito di crisi violente:
quando viene suscitato dal ricordo malinconico di una pena che l’anima ha
a lungo sopportato, questo pianto procura un vero sollievo all’anima.
L’indignazione ha le sue lacrime, ma queste, provocate da una contrazione
dei nervi, sgorgano a intervalli. Anche la disperazione ha le sue che hanno
un certo rapporto con quelle dell’indignazione, ma sono più rare, più
amare, si fermano negli occhi o sulle gote. I moti della disperazione sono
troppo violenti per permettere alle lacrime di sfogarsi; sono convulsi e
provocano nel corpo una contrazione così forte che i muscoli e i nervi si
agitano contemporaneamente in senso opposto al loro movimento naturale.
Infine la gioia ha le sue lacrime che sono deliziose e luminose e scorrono
senza sforzo, abbelliscono chi le sparge: queste lacrime sono sovraccariche
di soavità, di letizia, di godimento e, simili a una dolce rugiada, sembrano
ravvivare le guance su cui le si vedono scendere.
Il terrore non ne ha, richiama le lacrime e il sangue verso il cuore; quando il
terrore è violento arresta le funzioni del cuore e dello spirito e coagula, per
così dire, i fluidi nel corpo di chi ne è colpito. Per l’uomo coraggioso nulla è
più difficile da esprimere del terrore, ma per quanto si sia impenetrabile,
sempre si sono presentate nella vita circostanze in cui lo si è incontrato, ed
è ricordando bene gli elementi che lo hanno caratterizzato che si può
arrivare a rappresentarlo fedelmente in scena quand’anche sia diventato
del tutto estraneo. Nella mia giovinezza (credo debba avvertirvi, Signori,
prima di dar inizio alla lettura di quest’aneddoto che, costretto per essere
veritiero a trarre gran parte degli esempi da me stesso, mi trovo
nell’assoluta necessità di citarmi sovente; il motivo che mi guida mi darà
forse diritto alla vostra indulgenza), nella mia giovinezza dunque tornavo
da La Rochelle a Parigi in una di quelle vecchie carrozze che, procedendo
faticosamente, facevano ogni giorno pochissima strada, stanco dei continui
scossoni che si avvertivano in quella scomoda vettura, preferii andare a
61
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
piedi. Giunsi di notte nella foresta di Orléans, avendo lasciato la carrozza a
una lega dietro di me: tutte le storie che mi erano state raccontate sui ladri
di quella foresta mi tornarono allora alla memoria, in breve la mia mente si
esaltò e temetti che accadesse una di quelle tristi avventure. Quel timore
s’impossessò talmente della mia immaginazione che il mio sguardo
inquieto vagava sulla strada lontano fin dove poteva in una notte
rischiarata dai pallidi raggi di una luna coperta dalle nuvole.
Improvvisamente credei di vedere sulla mia destra un uomo armato di
fucile puntato contro di me, mi fermo, sguaino la spada e gli grido di
lasciarmi libero il passo. Mi lancio verso di lui con la spada sguainata e mi
precipito sul selciato che ci divideva. Cado e la mia spada si spezza, un
sudore freddo mi copre il volto, non potei rialzarmi se non dopo aver
ripreso conoscenza. Guardandomi intorno non vedo che un tronco d’albero
spoglio cui non restava che un unico ramo che avevo scambiato per un
fucile. Tale era il mio terrore che, dopo aver cercato il cappello che mi era
caduto, provai un intenso dolore rimettendolo in testa, cosa che mi ha fatto
scoprire che i capelli possono drizzarsi. Il mio fisico si era alterato in un
istante al punto che avvertii a lungo dolore in tutto il corpo ed ebbi molta
difficoltà a camminare. Questa lezione di terrore non è andata persa per
me, e sovente l’ho riproposta in scena con successo. Dubito che senza
questa vicenda mi sarebbe stato possibile esprimere con così tanta verità il
terrore.
Non si può rendere esattamente una sensazione se non la si è provata di
persona. L’attore che vuole ricordarsi le emozioni suscitate in lui da un
movimento spontaneo dell’anima, può essere sicuro che sono ancora
impresse nel suo essere e che occorre solo un ricordo per rimettere in moto
i muscoli e le fibre che hanno tremato in tale o tal’altra circostanza. I ricordi
di un amore felice dispongono all’amore dilatando l’anima, quelli di un
dispiacere amoroso la stringono e l’attristano. La natura ci ha dato il
ricordo per dilatare la nostra esistenza sul passato, come noi la
prolunghiamo sull’avvenire con la speranza. Senza questi due benefici
della natura la vita intera si consumerebbe in un giorno perché ieri è
dimenticato e domani non è ancora nostro. Con i ricordi viviamo in un sol
giorno un secolo. I ricordi costituiscono la risorsa inesauribile dell’attore,
deve essere sempre con loro per disporne a piacimento quando vuole
suscitare in se stesso le emozioni da rappresentare, ma ci vuole abbastanza
tatto per attuarle al momento giusto e per non abusarne. Tutto in natura ha
una misura, chi piangesse sempre non farebbe piangere nessuno e la più
perfetta delle qualità drammatiche, se riproposta di continuo, apparirebbe
un difetto; non essendoci in natura, una ripetizione troppo frequente
allontanerebbe dalla verità.
È impossibile che la sensibilità di un individuo possa modellarsi su quella
di un altro. Quindi è solo nella propria mente, nelle sensazioni personali e
62
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
nei propri ricordi che l’attore deve cercare le grandi emozioni necessarie
alla tragedia. Bisogna guardare, ascoltare e osservare; il quadro fedele della
natura si offre a tutti gli occhi e s’incontra dappertutto: il dolore nasce con
noi, il ricordo del dolore è a un dipresso la sensazione di tutta la vita:
Il mortale più felice ha conosciuto la paura:
Ahimè! non c’è nessuno che non abbia pianto.115
L’uomo nasce col germe dell’immaginazione e delle passioni, ma come lui
deboli nell’infanzia, si formano e si sviluppano con l’età, l’intelletto e la
sensibilità. Se la passione e il talento nell’imitazione sono gli indizi più
sicuri del gusto e delle predisposizioni per il teatro, nessuno fu chiamato in
modo più perentorio di me. Durante l’infanzia le cerimonie religiose furono
le prime a colpire i miei occhi e volli diventare uomo di chiesa. Tenere un
turibolo mi sembrò qualcosa d’incantevole, non vedevo nulla di più
desiderabile che esser vestito come un prete, cantare, predicare. La mia
prima premura fu dunque di avere una cappella, di procurarmi i
paramenti, il turibolo, di predicare e cantare. Volli anche confessare, ma
non avendo potuto sentire quanto si diceva tra il penitente e il prete, andai
un giorno a mettermi in un angolo del confessionale per imparare a
confessare. Le mie idee sviluppandosi cambiarono genere; vidi delle
maschere e volli essere mascherato, vidi danzare e volli danzare, vidi
passare le truppe a suon di musica: tamburi e pifferi eccitarono in me una
nuova emulazione, volevo avere un fucile, una sciabola, insomma farmi
soldato.
La prima volta che assistetti a uno spettacolo provai un sussulto in tutto il
corpo e un’emozione così viva che da allora nulla ha potuto estinguerla; i
miei genitori se ne accorsero e non vollero lasciarmi andare a teatro, la mia
immaginazione irrequieta e curiosa crebbe ancor più e si diresse a quanto
mi circondava. Da quel momento la vita m’apparve come un segreto che mi
si voleva nascondere e che volevo fortemente scoprire negli occhi del
mondo. Giunto a Parigi con la mia famiglia, fui messo in collegio. Una
graziosa sedicenne abitava nella stessa casa del mio precettore. Un giorno
in cui lei scendeva le scale e io le salivo, un incidente la fece cadere: il grido
che le sfuggì mi fece volare da lei. Il disordine delle sue vesti ne suscitò un
altro in me. Il mio corpo fu scosso da un tremito generale: la tirai su e,
volendo sorreggerla, la strinsi contro di me; il dolce calore del suo cuore mi
pervase e m’infiammò così intensamente che mi sembrò uscire fuor di me
per confondere il mio essere col suo. Da quel momento non vedevo, non
Claude Guimond de La Touche, Iphigénie en Tauride, (4 giugno 1757) «Le plus heureux
mortel a connu les alarmes: / Hélas! il n’en est point qui n’ait versé des larmes», Pilade a
Ifigenia, atto II, scena 4.
115
63
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
cercavo che lei, i miei progressi furono rapidi; pura e ingenua come me,
fummo felici senza aver calcolato i mezzi per esserlo.
I genitori della fanciulla si accorsero presto che avevamo smesso di essere
bambini, la mia giovane innamorata sparì all’improvviso e per cancellarla
dal mio ricordo mi fu detto che era partita per la Normandia. Sapevo che la
sua famiglia era originaria di Honfleur, pensai che l’avessero portata lì.
Abbandono genitori e amici e mi avvio verso Honfleur. Arrivato in città,
con nessun’altra fortuna se non i miei sedici anni, non avevo calcolato i
mezzi per vivere che nella mia esaltazione. Non ero molto avanti negli
studi, sapevo solo leggere e scrivere. Non esitai nella scelta da fare e seduta
stante osai presentarmi come maestro di scuola. S’insinuò nel mio cuore,
che palpitava di piacere e di gioia, la speranza di aver notizie e di diventare
forse l’istitutore della mia giovane innamorata. Ma la mia speranza andò
presto delusa, vane furono le ricerche: colei che aveva acceso i primi ardori
dell’amore era sconosciuta a Honfleur e non vi era mai venuta.
Tuttavia eccomi maestro di scuola, la mia reputazione s’affermò
rapidamente, i miei princìpi apparvero tanto più sicuri in quanto osavo
ripetere con disinvoltura quanto mi aveva insegnato il mio maestro.
Ripeteva spesso che la maggior parte delle malattie di petto nascono dagli
sbagliati criteri dei maestri che trascurano di prevenire le giovanette del
pericolo cui si espongono con una errata postura per scrivere. C’erano a
Honfleur giovani e graziosi petti che si desiderava proteggere, li affidarono
alla mia sorveglianza e divenni l’istitutore della bella gioventù. Ero
divorato da un segreto languore, la vista di quelle graziose fanciulle che
avevo di continuo sotto gli occhi duplicava le mie pene e il rimpianto di
colei che avevo perduto. Obbligato a nascondere il mio segreto in fondo al
cuore, volgevo lo sguardo su quanto potesse distrarmi.
L’unico spettacolo che veramente m’interessasse era quello del mare:
riportava di continuo i vascelli dalle Indie, dall’America e da tutte le nostre
isole. Mi si crederà forse ancora ben lungi dal mio argomento con i miei
primi amori, la mia condizione di maestro di scuola e le mie fantasticherie
sul porto di Honfleur, eppure è tra quelle fantasticherie e nell’osservazione
dell’arrivo dei vascelli nel porto, che riflettei per la prima volta sulle più
vive emozioni dell’anima e appresi a conoscere le varie espressioni della
vera sensibilità. Mi sono addentrato nei minuziosi particolari che mi
riguardano solo per arrivare alle immagini commoventi che si
presentavano al mio sguardo. Là ho imparato che la madre che perde un
figlio è in genere più sensibile a questa perdita di quanto non lo sia il figlio
che perde la madre, che il dolore degli sposi che si amano teneramente è
meno vivo quando si separano della gioia che provano nel ritrovarsi. Al
momento della partenza dei vascelli la separazione strappava solo poche
lacrime, erano seguiti con lo sguardo e il dolore diminuiva nel cuore così
come l’immagine dei vascelli si perdeva all’orizzonte; ma al primo segnale
64
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
del loro rientro parenti e amici si recavano in massa in riva al mare per
rivedersi e ritrovarsi.
Leggevo e studiavo sui loro volti l’affetto più o meno grande che li
trascinava. L’emozione della madre si differenziava da quella della giovane
sposa, la tenera ansia dell’innamorata si manifestava con l’incarnato del
volto che si faceva più acceso all’avvicinarsi del vascello. Attracca, ognuno
cerca preoccupato il proprio caro. I primi che si riconoscono prorompono in
grida di gioia che si ripercuotono dal vascello al molo e dal molo al
vascello; le grida si moltiplicano e aumentano man mano che ci si ritrova; le
braccia si tendono le une verso le altre prima di potersi toccare, i piedi che
non possono ancora attraversare lo spazio che divide il vascello dalla terra
si muovono come per far scattare il corpo, il pallore dell’angoscia
s’impadronisce di quelle il cui sguardo non riesce a scoprire chi cerca;
rimangono immobili e come colpite da stupore. Infine ci si precipita
all’abbordaggio, le braccia della madre si aprono al figlio che la stringe
subito fra le sue: i loro baci sono accompagnati da lacrime di gioia. Il
giovane sposo si strugge d’ardore e di desiderio non appena ha raggiunto
la sposa, la strappa dal caos dello sbarco e con passo rapido e sicuro si
avvia verso casa. La giovane e schiva innamorata dà timidamente la mano
a chi cercava il suo cuore. Guarda, senza rendersene conto, con accresciuto
interesse, il corpo irrobustito dal tempo e dalle fatiche del mare; lui, meno
riservato, le dà senza esitare un bacio che accentua il colorito vivace e
luminoso di colei che lo riceve.
A questa scena d’amore e di gioia segue una scena straziante.
Improvvisamente risuonano grida di dolore, una donna che da tempo
cercava invano il marito apprende che non c’è più. Il pallore le copre il
volto, resta immobile, annientata, come colpita dal fulmine; mi avvicino,
cerco di rianimarla, alza gli occhi su di me e li riabbassa dolorosamente su
un bambinetto che non può ancora capire la perdita. Un momento dopo
sento alle mie spalle bestemmiare con terribile intensità, mi giro e vedo un
marinaio i cui occhi accesi sembrano minacciare cielo e terra: ha appena
saputo che la moglie infedele è andata via col suo seduttore e che per lui è
perduta per sempre. Pesta i piedi, incrocia le braccia e cammina
borbottando: i sospiri gli si affollano nel petto simili a un tuono che brontoli
gravemente in lontananza. Il volto è scuro e corrucciato, ogni sguardo è
come un lampo minaccioso che annuncia una terribile esplosione. Non una
lacrima gli scende dagli occhi, il primo effetto della collera, come del
terrore, è di richiamare il sangue al cuore, anche il pallore è comune a
entrambe le sensazioni: il terrore lo conserva, ma la collera, ritirando il
sangue, poi all’improvviso l’infiamma e lo fa salire alla testa con tanta
violenza da turbare la ragione: chi ne è colpito non è più in grado di sapere
ciò che dice né ciò che fa. La collera non ha lacrime, se ne avesse
dovrebbero essere lacrime di sangue. Le passioni violente sono in genere
65
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
assai simili nelle loro espressioni e si riconoscono a dei segnali più evidenti
di quelli che provengono da una sensibilità raffinata. Le prime parlano a
tutti e, per così dire, ad alta voce; le altre penetrano quasi
impercettibilmente e sono ben comprese solo da chi può provarle.
Ecco un racconto che lo dimostra. Quindici mesi dopo il mio arrivo a
Honfleur, avendo mio padre scoperto il mio nascondiglio, mi fece
imbarcare per Santo Domingo. Nel bastimento in cui ero partito c’era un
giovane mozzo di sette anni. Due giorni dopo la partenza ero sul ponte e
seppur circondato da alcuni marittimi non li sentivo né vedevo totalmente
preso dalla contemplazione del vasto e imponente spettacolo di un mare
immenso; il piccolo mozzo mi era accanto, gli sfuggì un sospiro, lo guardai
e ne vidi il volto rigato di lacrime. Gli chiesi la ragione di quel pianto. Ah!
signore, mi rispose, forse mai rivedrò la mia povera madre. Le lacrime
sgorgarono dai miei occhi, ebbene, fui l’unico a esser commosso e quelli che
ci attorniavano si misero a ridere. Per quanto allora oppresso dall’autorità
paterna, il mio cuore solo batté all’unisono col cuore di quel bravo figlio e
la mia sensibilità mi fece capire quanto doveva soffrire la sua.
Quel viaggio fu uno dei periodi della mia vita che mi ha fatto provare, in
diversi modi, le più forti sensazioni. La maggior parte di quelle che ho
portato sul palcoscenico sono dovute al ricordo di quanto ho sperimentato
nel mondo e varie circostanze di quel viaggio hanno sempre avuto la
priorità nei miei ricordi. Per esempio, l’attore che mai avesse conosciuto la
collera, non potrebbe, malgrado la maniera stupenda in cui è descritta
quella di Achille in Iphigénie, riuscire a esprimerla al meglio.116 Il ricordo di
quella che provai durante il viaggio mi ha forse da sola fornito i grandi
effetti che ho a volte creato in quella scena. Introduco ora quest’altro
aneddoto, visto che sto parlando di me.
In quell’angusto vascello eravamo otto passeggeri: era stato
approvvigionato per solo trenta giorni di traversata senza aver pensato ai
venti contrari e alle tempeste. Ne affrontammo talmente tante da restare in
mare per tre mesi: presto i viveri diminuirono al punto che fummo ridotti a
otto once di biscotti al giorno. I passeggeri, tutti di buon appetito come me,
si lagnavano del capitano, l’accusavano di essersi messo d’accordo con
l’armatore e di non aver preso che la metà dei viveri necessari alla nostra
sussistenza. Credendo che ci fossero delle farine nel carico, concepirono il
progetto di riunirsi per forzare il capitano a consegnarle. Fui messo a parte
del segreto e fui persino delegato a parlare a nome di tutti, acconsentii.
Dopo la consueta preghiera che riuniva l’equipaggio sul ponte, riferii al
capitano, senza mezzi termini, quanto mi avevano incaricato di dirgli.
Quell’uomo coraggioso e violento, indignato dai sospetti sollevati sulla sua
116 Racine, Ifigenia. La collera di Achille è descritta da Ulisse a Clitemnestra nella lunga tirata
del quinto atto (scena 6, vv. 1731-1794).
66
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
probità, andò su tutte le furie e mi accusò di voler istigare alla rivolta sul
suo vascello.
Interroga a turno i passeggeri per sapere chi sia d’accordo con me, in coro
rispondono che non hanno detto niente e che non si sono mai lamentati,
ogni volta che ognuno di loro aveva la bassezza di attribuire a me solo
quanto mi era stato da loro suggerito, mi sentivo impallidire.
L’indignazione che provavo si mutò in furore, un tremito generale
s’impadronì del mio corpo. Ero in uno stato di crisi tanto più violenta in
quanto mi era impossibile abbandonarmi alla vendetta (figlia prediletta
della collera). Il capitano, una volta terminato l’interrogatorio, si volse
verso di me dicendomi: Eccovi convinto, Signore, di essere l’unico autore di
un complotto formato per istigare alla ribellione, la legge mi autorizza a
farvi incatenare e a tenervi prigioniero fino al momento dell’arrivo, allora
potrò consegnarvi nelle mani della giustizia.
Non potendo vendicarmi e non avendo nulla da opporre a un uomo
sovrano a bordo, non risposi che dopo aver rivolto uno sguardo
d’indignazione sui vigliacchi che mi avevano procurato quella disgrazia.
Potete, Signore, dissi al capitano, fremendo di collera e alzando la voce via
via che parlavo, potete esercitare su di me ogni possibile violenza, sono
pronto a tendere le mani ai ferri di cui mi minacciate, ma un giorno avrò la
terra sotto i piedi e potrò vendicarmi dei vili furfanti che soli mi hanno
ispirato il discorso che vi oltraggia. Queste parole furono dette in modo
così energico e terribile che nessuno rispose né osò sostenere il mio
sguardo.
Il vero coraggio non perde mai i suoi diritti sulla gente ardimentosa. Il
capitano che ne aveva sovente dato prova, s’interessò improvvisamente a
me, mi fece scendere nel suo alloggio. Ignorandone lo scopo lo seguii senza
dir nulla e senza nulla temere; entrando prese una bottiglia d’acquavite, ne
riempì due bicchierini, me ne offrì uno e brindò con me senza complimenti,
poi mi prese la mano e vedendo l’emozione che provavo mi strinse contro
il suo petto abbracciandomi e mi disse: Siete mio amico e gli altri sono vili
furfanti. A quelle parole mi fu impossibile trattenere le lacrime, proruppero
tanto più abbondanti in quanto durante la crisi mi era stato impossibile
versarne una sola: non potrei definire né descrivere il movimento violento
che era affiorato in me per l’impossibilità di vendicarmi, ma ne ho
conservato il ricordo così attuale che mi è servito più di una volta per
riproporlo in scena, e quel ricordo mi è sempre stato utile per la collera di
Achille.
Per mia esperienza, sono convinto che solo i ricordi possono procurare
all’attore la mobilità con cui fare proprie, in modo intenso, le passioni che
non gli appartengono e grazie a essi può riprodurre quando vuole i moti
più terribili o quelli della più delicata sensibilità.
67
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Che l’attore che vuole recitare una parte in cui domina questa sensibilità,
richiami all’immaginazione quanto ha provato di più sensibile; che rievochi
quelle impressioni malinconiche, quegli accessi di una tristezza non priva
di dolcezza che spesso precede le grandi passioni e che a volte sopravvive
loro. Che cerchi nei grandi tragediografi se non può trovarli in se stesso; il
vero poeta crea un carattere secondo le inclinazioni dell’anima. Quando
Voltaire ideò Tancredi, era ben lontano dalle sensazioni che gli avevano
fatto concepire Maometto; in un certo senso era un altro uomo. Bisogna non
aver amato che una sola volta per ben sentire e ben recitare Tancredi, è una
delle parti che ha avuto maggior presa su di me. Le mie delicate emozioni
mi hanno sempre ricordato Tancredi; Tancredi mi ha sempre ricordato le
mie delicate emozioni. Com’ero felice quando recitavo questa parte così
interessante! Uscita per intero dal cuore di Voltaire, riempiva il mio: i
giorni in cui dovevo recitarla ero migliore, più amabile, più affettuoso; il
mio domestico diventava Aldamon e quando non avevo una Aménaïde, la
cercavo negli occhi di ogni donna.
Questa parte incantevole era quella che meglio mi si confaceva, mi ha
convinto che l’arte dispiegata da un grande talento per portare in scena un
carattere contrario al proprio, non può raggiungere la verità di un attore
seppur mediocre quando la sua parte ha un rapporto diretto con il carattere
che gli è stato elargito dalla natura.
68
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
QUARTO INCONTRO
CAPITOLO VII
Delle emozioni e delle sensazioni
Ho già detto il senso che do alla parola sensazioni.
Questo senso si allontana un po’ dalla precisione filosofica: è meramente
teatrale. Devo dire parimenti ciò che intendo con emozioni. Sono quei moti
imprevisti che si impadroniscono all’improvviso dell’anima, la trasportano
di colpo da una sensazione all’altra, precedono e annunciano l’effusione
della sensibilità: le emozioni, oserei dire, stanno alla sensibilità come il
brivido sta alla febbre. L’attore deve imparare a conoscerle bene e a ben
distinguerle.
Zaïre, voi piangete!117 Battuta che non può essere declamata bene se non con
una viva emozione. Orosmane folle d’amore e di gelosia è posseduto da
entrambi i sentimenti, il suo amore in tutto quanto precede è come avvolto
nella gelosia. Zaïre, voi piangete!
Mille cose estranee a questa espressione gli si affollano in mente. Volge lo
sguardo su Zaïre, vede che si scioglie in lacrime, avverte improvvisamente
un’emozione di amore intenerito, dimentica quanto ha detto e quanto stava
per dire, si getta ai suoi piedi e Zaïre, voi piangete! gli scaturisce per intero
dall’anima. L’amore riprende il suo potere, allontana dal cuore la gelosia e
lo abbandona senza riserve alle dolci effusioni della più intensa tenerezza.
L’emozione che trafigge il cuore di Orosmane deve cambiarlo
all’improvviso. Raggiante d’amore, pervaso da un’intensa sensibilità, ai
piedi di Zaïre dà libero sfogo all’eccesso del meraviglioso sentimento che
gli soffoca il cuore. Ho visto attori, sostenitori di un falso sistema di
naturalezza, che mai è esistito in natura, declamare Zaïre, voi piangete! come
se avessero detto: Avete perso il guanto, altri gridare come se avessero
detto: Mio Dio! state per cadere. Zaïre, voi piangete! in bocca a Orosmane che
la credeva infedele, equivale a: Zaïre, voi mi amate. Il pianto di Zaïre è per
lui ciò che una leggera rugiada è per la terra che cadendo lascia intravedere
un cielo terso, illuminato improvvisamente dai raggi di un nitido sole. Il
pianto di Zaïre deve dunque eccitare in Orosmane la deliziosa emozione di
un amore felice e allontanare dal cuore gli ingiuriosi sospetti che aveva
immaginato. È molto difficile passare repentinamente dai sospetti gelosi a
una fiducia estrema, può essere solo l’effetto di una improvvisa emozione
che s’impossessa di ogni nostra facoltà e sottomette i nostri sensi.
La battuta Zaïre, voi piangete! così sublime e così difficile da dire nel modo
giusto, costituisce un grande inconveniente per l’attore; tutti la conoscono e
l’aspettano; l’attore può allora avere l’emozione perfetta senza suscitarla
«Zaïre, vous pleurez!». Il celebre emistichio di Orosmane (atto IV, scena 2, v. 1154), è
seguito dopo la battuta di Zaïre dall’altrettanto celebre «Zaïre, vous m’aimez» (v. 1161).
117
69
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
nell’animo degli spettatori. Ma, mi si potrebbe obiettare, l’attore, così come
gli spettatori, sa che dirà quelle parole; certamente. L’attore prima di
entrare in scena sa già quanto deve dire, ma dal momento che entra nella
parte non sa più a ogni istante ciò che sta avvenendo, oppure non sa farsi
delle illusioni e quindi non può suscitarne. Se è compenetrato nella parte e
degno di recitarla, sarebbe realmente trascinato dalla gelosia e deciso a
lasciare Zaïre; quando improvvisamente ne scorge le lacrime, è veramente
colto di sorpresa e dalle idee rassicuranti suscitate da quella vista; la
sorpresa e l’afflusso di quelle idee devono inconsciamente suggerirgli il
tono con cui pronunciare quelle tre parole così giustamente celebri.
Ci sarete, figlia mia,118 è ancora una battuta che può essere resa solo con
profonda emozione, ma è più facile di: Zaïre, voi piangete! Questa proviene,
per così dire, all’improvviso dagli occhi al cuore di Orosmane, l’altra
giunge all’animo di Agamennone da un susseguirsi di domande che gli
pone di seguito Ifigenia e infine da quest’ultima così innocente e
commovente:
All’altare si vedrà la vostra felice famiglia?119
Questa domanda che ricorda ad Agamennone che la figlia deve esservi
immolata, gli dà la dolorosa emozione con la quale deve rispondere: Ci
sarete, figlia mia.
Per ben compenetrarsi in quell’emozione è necessario che l’attore sappia
ascoltare, ma è quanto i più trascurano d’imparare: il difetto comune degli
attori è di parlare senza ascoltare e di essere sensibili a ciò che dicono senza
preoccuparsi di quanto dicono gli altri; non dovrebbero mai dimenticare
che la parola, come ho già ripetuto, non è che l’eco del sentimento. Ora, in
una scena dialogata il sentimento nasce quasi sempre in uno degli
interlocutori, da quanto dice l’altro, altrimenti tutto appare freddo, arido e
nulla commuove.
Quanto ho appena affermato diventerà più chiaro se vi aggiungo, come già
mi è stato permesso di fare, un episodio della mia prima giovinezza che mi
ha fatto sentire il potere assoluto delle emozioni improvvise.
La necessità di conoscere e di provare è il primo sentimento che riceviamo
dalla natura. Nella felice età dell’innocenza, tutto interessa: gli occhi e
l’anima sono totalmente presi senza costrizioni né calcolo da quanto ci
emoziona: le paure e i piaceri sono tanto più intensi in quanto i sensi,
innocenti come le idee, hanno tutta la loro sensibilità. Benché fossi molto
giovane all’epoca di quella avventura a Honfleur che mi condusse in
America, non fu la prima, eccone una di un altro genere.
118
119
Racine, Iphigénie en Aulide, «Vous y serez, ma fille», atto II, scena 2, v. 578.
Ivi: «Verra-t-on à l’autel votre heureuse famille?», v. 577.
70
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
All’età di nove anni essendo stato redarguito da mio padre, scappai di casa,
da Decize dove vivevamo, per rifugiarmi dai religiosi di Sept-Fonds, nel
Bourbonnais.120 Era mia intenzione ritirarmi dal mondo e farmi monaco
della Trappa non appena raggiunta l’età opportuna. Nulla mi sembrava più
ragionevole di aspettarla in quella santa casa. Raccontai perciò una specie
di romanzo a quei bravi religiosi che li interessò a tal punto da offrirmi
asilo. Mi ricevettero con bontà e scrissero ai miei genitori che mi avevano
accolto per salvarmi dai pericoli cui ero esposto per la mia giovane età. La
sera, all’indomani del mio arrivo, fui condotto in chiesa per assistere a un
Salve. Entrando in quel vasto ambiente, di cui alla fioca luce del tramonto
non riuscivo a cogliere l’ampiezza, fui colto da un pio sentimento di cui
non sapevo rendermi conto. Assorto in quel sentimento, immerso in un
profondo silenzio fui commosso ancor più intensamente dal timbro di una
voce che nell’intonare il Salve mi sembrò provenire dal sottosuolo, ma
l’emozione si tramutò in terrore quando il mio udito fu colpito da
numerose voci sepolcrali che si aggiunsero improvvisamente alla prima;
tale fu il turbamento della mia candida immaginazione che credei di vedere
Dio in persona scendere in terra per chiedermi conto delle mie azioni. Così
forte fu la commozione provata che ancor oggi il ricordo è presente alla
mente. Da allora ho cercato di ritrovare quella prima emozione di terrore
religioso nelle parti di Amleto, di Ninias, di Edipo, ecc.121 Non mi ero
ancora ripreso quando l’indomani fui condotto nel luogo in cui i religiosi si
riuniscono per togliere, ciascuno dalla propria fossa, una palata di terra; li
osservavo con santo rispetto quando all’improvviso il mio sguardo fu
distolto dall’azione di un di loro che, nel camminare gli occhi bassi dietro a
un altro, spinse avanti la propria pala in modo da urtargli il piede; il
religioso colpito si girò senza dir nulla e guardò il vicino che vidi ridere di
gusto, nascondendosi sotto il cappuccio.
Tale ultima sensazione fece svanire il mio rispetto incondizionato per i
monaci.
All’età in cui il primo sviluppo comincia a eccitare in noi il fermento dei
sensi, il caos delle idee ci sommerge in una sorta di vaga malinconia che è
impossibile definire; a quell’età siamo capaci solo di sensazioni, si
succedono rapidamente senza fissarsi né nel cuore né nella mente. Solo
quando si è formato il sentimento, le nostre emozioni si prolungano, si
fanno più profonde e ci portano alla passione. Ma come definire perché tale
oggetto ci commuove, ci avvince e ci conquista più di un altro che pur lo
Antica provincia nel centro della Francia, sulla parte settentrionale del Massiccio
Centrale.
121 Larive aveva recitato nella parte di Amleto, per la prima volta nel 1787. Il testo di
Shakespeare era conosciuto nell’adattamento in versi di Jean-François Ducis (30 settembre
1769). Interpreta la parte di Ninias nella tragedia Sémiramis di Voltaire sporadicamente dal
1776 al 1792. Infine nell’Œdipe di Voltaire (18 novembre 1718) recita nel ruolo del titolo per
la prima volta nel 1775, riprendendolo anche successivamente.
120
71
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
supera in grazia e in bellezza? Credo che il motore sconosciuto che ci
domina e trascina scaturisca dai rapporti di maggiore o minore calore nel
sangue, di vivacità nello spirito e di delicatezza nella sensibilità. Le nostre
sensazioni e le nostre emozioni hanno ancora un rapporto diretto con la
temperatura dei luoghi dove viviamo. Il sangue e la bile vi sono
assoggettati come il mercurio nel barometro, a causa della loro azione
interna che sentiamo con maggior o minor vivacità, calore e sensibilità. Se il
tempo è opprimente e asfissiante, lo diventiamo anche noi e tutto in noi ne
soffre; se il tempo è sereno e trasparente le nostre sensazioni sono più
vivaci, più gioiose e l’immaginazione più dinamica.
I Provenzali sono in genere vivaci e collerici, gli Americani delle nostre
isole flemmatici e pigri, gli Olandesi ricevono quasi la stessa influenza
dell’umidità del clima, tranne che l’Olandese, più interessato
dell’Americano è più laborioso e più taciturno. Persino in Francia ogni città
ha un suo proprio carattere; ne distinguevo le sfumature recitando la
tragedia e sono rimasto convinto che in tutte le città principali ci sia una
differenza più o meno forte tra le emozioni e la sensibilità delle diverse
categorie del pubblico. Ho sempre creduto che tale differenza dipendesse
in parte dalla temperatura, dall’educazione, dai liquori, dagli alimenti e dai
climi. I venti vi contribuiscono in modo notevolissimo, alcuni assorbono le
forze al punto che non si riesce ad agire. Quello che i Tolosani chiamano
altano o marino,122 ha tale influenza sul corpo e sulla mente che quando
soffia è impossibile pensare e agire. L’ho provato nel recitare la tragedia in
modo tanto intenso che ero costretto, prima di entrare in scena, a battermi i
fianchi così come ci si percuote per riscaldarsi dal freddo; ero obbligato a
sforzare la voce e l’azione, altrimenti il pubblico e io saremmo rimasti quasi
in letargo.
Come un Provenzale non può avere le sensazioni di un Olandese, né
l’Americano quelle di un Parigino, così gli Ateniesi, i Romani, i Parti e gli
Egizi provavano emozioni differenti analoghe al clima, ai loro usi e
costumi.
L’attore deve compenetrarsi profondamente di ogni sfumatura inerente ai
diversi caratteri da impersonare: deve, innanzi tutto, imparare a conoscerli
bene. Anche gli individui che compongono il pubblico hanno ognuno un
proprio carattere e una propria sensibilità; questi piange quando un altro
prova una sorta di trasalimento, uno grida di piacere quando il vicino
sbigottito non può né parlare né agire. Solo il vero talento ha il privilegio di
ricondurre le diverse sensazioni a un centro comune; tale è la magia
dell’arte che è tenuta, tramite la verità, a riunire le sfumature in una sola:
allora il vero talento gode del suo trionfo.
L’attore non deve mai dimenticare che si fa interprete dei sentimenti
espressi dall’autore, deve sottostarvi arricchendoli con la propria arte: lo
122
È quello che gli Italiani chiamano scirocco; proviene dalle coste dell’Africa.
72
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
spirito e l’intuizione dell’autore devono essere la sua unica bussola, non
deve mai allontanarsene, perché nel momento in cui l’attore, non potendo
sollevarsi all’altezza del personaggio rappresentato, lo sminuisce o lo
modifica, viene rotta la catena che legava l’insieme dell’opera, non restano
più che arti disgiunte che da sublimi che erano in quell’insieme, appaiono
solo fredde e sconclusionate.
Se Orosmane non ha in grandiosità quanto è necessario per ispirare il
rispetto dovuto alla sua persona e alla sua dignità, se non ha una sensibilità
nobile e vera per entrare nel cuore degli spettatori, emozionarlo,
trascinarlo, sedurlo straziandolo, la costruzione eretta dall’autore crolla:
solo le parti deboli colpiscono gli occhi del pubblico e la tragedia, che al suo
apparire ha sollevato così tanta ammirazione e fatto scorrere tante lacrime,
ispira solo sensazioni evanescenti e diventa preda della critica.
Dopo Mlle Clairon, così sublime nella parte di Viriate, Sertorius è scomparso
dalle scene.123 Il pubblico giudica le opere secondo le sensazioni suscitate
dall’attore e se accade che quest’ultimo a forza d’intrighi usurpi una
reputazione immeritata, se osa interpretare i ruoli a modo suo, i giovani
spettatori non avendo più per giudicare i talenti che copie inconsistenti di
quelli dei quali si è rotto lo stampo, non potendo provare che sensazioni
fuggevoli, se la prendono più con le opere che con l’attore. Invece delle
emozioni struggenti che dovrebbero elettrizzarli, ridotti a controllare il loro
piacere, sono per sempre privati di quel santo entusiasmo che anima le
opere, rende immortali gli autori e offre agli attori, che ne sono stati i degni
interpreti, un posto accanto a loro.
Potrei citare molte tragedie mediocri il cui successo è stato dovuto al
talento degli attori che le avevano recitate e che poi sono state un fiasco per
l’inettitudine di chi ha tentato di riproporle. Le prime sensazioni suscitate
nel pubblico dal vero talento restano come una tradizione, ma spesso
questa si perde se i nuovi talenti non la sostengono, a volte può persino
costituirsi a loro svantaggio. Il pubblico rende l’attore responsabile delle
sensazioni che aveva provato; torna a teatro con quel ricordo, se non le
ritrova se ne allontana o manifesta il suo scontento con segnali ancor meno
equivoci.
Se i giovani che si indirizzano verso il teatro fossero profondamente
consapevoli della imprescindibile necessità di mantenere tutta la freschezza
delle loro sensazioni e quel sentimento raffinato e prezioso che solo
permette di provare emozioni profonde e di trasmetterle allo spettatore,
godrebbero di un successo solido e duraturo fondato su progressi sensibili
123 Sertorius, tragedia di Pierre Corneille (25 febbraio 1662, Théâtre du Marais). Nel ruolo di
Viriate, regina di Lusitania, il talento dell’interprete era tale che avrebbe stupito lo stesso
tragediografo; scrive il «Mercure de France»: «Mlle Clairon è sorprendente, e il genio di
Corneille è certamente analogo al carattere del suo animo. Allora si dimentica che è
un’attrice e si vede soltanto il personaggio eroico quale il grande Corneille doveva
rallegrarsi di aver concepito», settembre 1758, pp. 191-192.
73
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
e veri talenti; ma trascinati nel vortice di un mondo corrotto perdono presto
con la stanchezza le qualità primarie fornite dalla natura, la sensibilità, la
verità: senza di esse non c’è vero talento teatrale. Che non mi si parli di
sacrifici, di dolorose privazioni. Per diventare un grande attore si deve
essere inspirati da una passione travolgente per questa bella arte; bisogna
che ogni sensazione vi sia collegata, che nulla al mondo possa alterare o
distrarre il sentimento al quale l’attore consacra tutto se stesso; privazioni e
sacrifici non gli costano o piuttosto diventano per lui godimento, non cerca
altro riconoscimento della gloria.
Il mondo intero è il libro da cui l’attore deve attingere le proprie sensazioni,
nulla deve essergli indifferente, prima o poi potrà richiamare sulla scena i
dolori e i piaceri che ha provato. Ho avuto un qualche successo nelle parti
di Warwick e del conte di Essex;124 ma ho capito, dopo undici mesi di
prigione, che ero lontano dalle sensazioni profondamente dolorose che
dovevo dare a Warwick e al conte di Essex, quando sono nei ferri.125 Quelle
parti sempre presenti nella mia memoria durante la detenzione avevano
assunto un carattere malinconico che non avevo quando le recitavo e mi
rincresce di non aver potuto, dopo la liberazione, portare sul palcoscenico
quella sublime malinconia. Ogni età ha il proprio grado di intensità nelle
sensazioni come nello spirito e nel giudizio: sono più vivide in gioventù,
ma diventano poi più profonde grazie a una più ampia esperienza. L’attore
giovane può trovare in se stesso le emozioni di uno della sua età, ma può
In entrambe le tragedie: Le Comte de Warwick di Jean-François de La Harpe (7 novembre
1763) e Le Comte d’Essex di Thomas Corneille (gennaio 1678, Théâtre de l’Hôtel de
Bourgogne), Larive ha recitato nella parte del titolo per circa una decina di volte.
125 A seguito dello spettacolo Paméla ou la Vertu récompensée [Pamela o la Virtù ricompensata]
(1° agosto 1793) di François de Neufchâteau (aspramente criticato dai Giacobini perché vi
leggevano non tanto il successo della virtù quanto quello della nascita dato che il padre di
Pamela è un nobile) e delle intemperanze e dei tafferugli che ne seguirono, la Convenzione
ordinò la chiusura del teatro e l’arresto immediato dell’autore e degli attori. Larive, che al
momento dei fatti si trovava a Bordeaux per una serie di rappresentazioni, venne fermato il
13 settembre al suo rientro a Parigi e incarcerato. Liberato due giorni dopo in quanto gli fu
riconosciuto lo statuto particolare di libero attore, venne di nuovo arrestato su istanza dei
sanculotti e rinchiuso l’11 novembre prima a Sainte-Pélagie e poi trasferito a Port-Libre (3
gennaio 1794), prigione più vivibile rispetto alla precedente e dove ritrovò i suoi compagni. I
capi d’accusa formulati contro di lui erano passibili della pena di morte. Implacabile
accusatore nel processo istituito contro gli attori si era rivelato Collot d’Herbois che, prima
di diventare l’influente uomo politico della Rivoluzione, aveva tentato la strada del
palcoscenico. Il giudizio era stato fissato al 1° luglio 1794 e il destino dei prigionieri
sembrava ormai segnato. Il processo era stato però rinviato in quanto non si trovavano più
le prove a carico che sole avrebbero potuto consentire al pubblico accusatore, FouquierTinville, di pronunciare la condanna. L’intelligente astuzia di un ex-attore, CharlesHippolyte Labussière, impiegato presso la segreteria dell’accusatore, aveva permesso la
distruzione dei documenti. Nell’attesa di ricostruire i dossier, la macchina processuale
contro gli attori si era inceppata. Con l’arresto e l’esecuzione capitale di Robespierre il 9
termidoro (27 luglio 1794) cadde il regime del Terrore e finalmente le porte della prigione si
aprirono anche per gli attori.
124
74
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
immaginare quelle dell’uomo adulto solo studiandole negli altri. L’attore
più maturo ha maggior vero talento perché ha sperimentato personalmente
le diverse gradualità delle sensazioni, e se il fisico non perdesse in
proporzione ciò che guadagna la mente, diventerebbe perfetto alla fine
della carriera.
Fra le cause che influiscono sui vari gradi di forza delle emozioni e della
sensibilità, ho messo in conto gli alimenti e i liquori. A seguito di questa
osservazione gli attori devono sempre far attenzione alla salute, imporsi un
regime tale che possano disporre liberamente di loro stessi. Il mezzo più
sicuro è la sobrietà. Dovrebbero vagliare con attenzione la scelta degli
alimenti, questi formano le qualità della bile e senza la bile non esiste
passione.
Una singolare esperienza mi ha fatto capire fin dove può arrivare
l’influenza della sobrietà sulle sensazioni: forse le più forti che abbia
provato nella mia vita apparvero in un momento in cui mi nutrivo appena
per non morire; è all’epoca del mio viaggio a Santo Domingo quando
avevamo una razione giornaliera di solo otto once di biscotti. Mai ho avuto
l’immaginazione più vivida e attiva che in quella situazione, soprattutto nei
miei sogni: vi si svolgevano quasi sempre dei festini, le pietanze mi
sembravano così deliziose che non ho mai trovato nella realtà sapori tanto
squisiti.
Quando i sogni, cambiando natura, m’ispiravano un sentimento d’amore,
gli oggetti che veneravo erano di una bellezza sovrannaturale e i miei
piaceri così inebrianti che il risveglio mi gettava in una tristezza profonda.
Non poteva certo confortarmi ciò che avevo di continuo sotto gli occhi: lo
spettacolo di un mare sempre infuriato che sembrava a ogni istante volerci
inghiottire. Un giorno in cui mi trovavo in questo stato d’animo un
marinaio gridò all’improvviso: Terra! Come descrivere ciò che provai a
quella sola parola? La penna mi cade di mano per il delizioso ricordo che
riaffiora nel raccontarlo. Tale fu lo sconvolgimento del sangue che un
brivido di piacere mi attraversò il corpo, la mia voce non riusciva ad
articolar suono alcuno, mi spuntarono i lucciconi e l’intero equipaggio
provò la stessa emozione. All’istante mi gettai fra le braccia di coloro che
mi stavano attorno: amici, nemici tutti furono stretti sul mio cuore con puro
piacere, senza riuscire a capire, senza poter ancora definire la sorta di
sentimento che mi sommergeva; nell’entusiasmo strinsi persino l’albero del
vascello cui restai incollato per più di un minuto.
Da allora ho sempre pensato e ho sovente provato che la dieta, senza esser
spinta fino a tal punto, apporta all’anima e allo spirito una squisita
sensibilità che l’abuso di cibo distrugge. La natura, generosa e benefica,
sembra averci regalato il sonno per compensare le pene che proviamo da
svegli. Ne ho soprattutto riconosciuto il piacere nei momenti in cui, come
tanti altri, in prigionia, aspettavo la fine dei miei giorni. Avevamo allora
75
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
scarsissimo cibo e di pessima qualità tanto da non essere invogliati a
sovraccaricarne lo stomaco. Solo il sonno mi risarciva durante la notte delle
angosce diurne e tutti i miei compagni di disgrazia trovavano come me nel
sonno un sollievo ai loro mali. Da dove poteva scaturire questa calma in
una posizione così terribile? dalla sobrietà forzosa in cui vivevamo che
influisce non solo sul sonno; la chiarezza di pensiero, la vivacità delle
sensazioni, un’espressione pura e facile, ne sono le logiche conseguenze. Il
fisico avendo un rapporto diretto col morale, è quasi impossibile disporre
facilmente di quest’ultimo quando il primo è assorbito dalla quantità degli
alimenti e dalle loro qualità irritanti.
Ci sono cose che impressionano così fortemente da non poter più perderne
il ricordo. Recitando Montaigu in Roméo et Juliette mi ero fatto un’idea
terribile delle montagne degli Appennini, dove il personaggio era restato
nascosto per venti anni: tale era la mia espressione nel descriverle che esse
apparivano orribili sia al pubblico che a me.126 Avendo recitato la parte a
Marsiglia, un negoziante della città pensò d’inviarmi l’indomani sei
bottiglie di vino degli Appennini per riconciliarmi con quei luoghi che
descrivevo in modo così orribile. Confesso di non aver mai bevuto in vita
mia vino migliore e sono costretto a riconoscere, con vergogna, che da
allora non ho mai potuto più recitare la parte di Montaigu senza che il
ricordo di quel vino non si riaffacciasse nel momento in cui evocavo gli
Appennini e per quanto mi sforzassi non sono mai più riuscito a ritrovare
la mia prima espressione.
Se in gioventù non avessi provato quelle fortissime sensazioni
nell’ammirare la Venere che si trovava nel parco di Versailles127, non avrei
mai potuto concepire, come poi ho fatto, la parte di Pigmalione;128 ma
Jean-François Ducis aveva riscritto il testo shakespeariano: Romeo Montaigu, sotto falso
nome viene allevato come suo figlio da Capulet, mentre Montaigu padre allontanatosi da
Verona con gli altri quattro figli per sfuggire alla vendetta di Capulet, viene per suo ordine
fatto prigioniero e rinchiuso in una torre dove assiste impotente alla morte dei figli. Una
volta liberato si rifugia in un lungo esilio volontario tra i monti dell’Appennino. La tragedia
Romeo e Giulietta era andata in scena il 27 luglio 1772.
127 Le statue di Venere nel parco di Versailles sono almeno tre, si può pensare però che
Larive abbia in mente la Vénus Callypige di Jean-Jacques Clérion (1686), in quanto sembra
colta nell’atto di liberarsi dai veli.
128 La parte nella novità è quella di Pigmalione nella scène lyrique omonima di Jean-Jacques
Rousseau. Larive l’aveva già sostenuta a Lione riportando consensi unanimi; a Parigi va in
scena per la prima volta al Théâtre-Français il 30 ottobre 1775 con grande successo (12
repliche), il monologo costituirà uno dei suoi cavalli di battaglia e verrà riproposto fino al
1792 con notevole continuità. L’interpretazione di Larive costituisce una delle sue più
brillanti affermazioni, segnando una svolta decisiva nel suo ruolo in quanto gli autori
cominciano a guardare a lui come l’artista cui affidare le loro nuove creazioni. Il Pygmalion,
scène lyrique, in prosa, di Rousseau era stato pubblicato sul «Mercure de France» nel gennaio
1771 e rappresentato a marzo all’Opéra di Parigi insieme al Devin du village, con il cantante
Le Gros e Mlle d’Ervieux, cantante e ballerina. La pièce offre uno dei primi esempi di
melodramma in cui la musica introduce e annuncia la parola, ma la commistione di musica
126
76
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
quella statua, per quanto fredda per natura, aveva infiammato la mia
immaginazione giovanile per la bellezza delle forme e quella prima follia
dei sensi di un ragazzo, per me non è andata perduta poiché ho avuto
l’occasione di rievocarla in un’opera partorita dal delirio dei sensi: bisogna
averne la febbre per farla riuscire. Non sarebbe mai accettabile, malgrado il
calore della composizione, o piuttosto proprio a causa di quel calore, se
l’attore non avesse l’arte d’infiammare il pubblico prima d’intravedere
Galatea; il successo dipende, in gran parte, dal velo che copre la statua
durante la prima parte del melodramma. Se all’alzarsi del sipario Galatea
fosse visibile, mai Pigmalione avrebbe potuto farsi ascoltare, tanto l’arte
della parte dipende dal calore elettrico che l’attore fa passare nell’anima
dello spettatore prima di mostrargli Galatea! È necessario infine che la
magia dell’arte faccia di tutti gli spettatori dei Pigmalione, affinché
Pigmalione arrivi, senza che si ribellino, ad animare la statua e a diventarne
il felice amante. Ho sentito talmente il bisogno di essere fortemente
emozionato nell’iniziare la parte che non ho mai voluto recitarla, per
quanto faticoso fosse, che dopo una parte tragica.129
(l’ouverture era stata composta dallo stesso Rousseau, il resto delle sinfonie da Horace
Coignet) e di recitazione non fu da tutti apprezzata; nell’interpretazione di Larive le parole
non venivano cantate e la musica serviva a riempire gli intervalli tra le parti recitate. Tratto
dalle Metamorfosi di Ovidio (X, vv. 243-297) Rousseau apporta alcune varianti al testo latino:
tra le differenze più rilevanti, ricordiamo i cambiamenti di luogo: la scena si svolge a Tiro e
non a Cipro, la supplica agli dei si svolge nell’atelier di Pigmalione e non davanti agli altari
di Venere, la statua è scolpita nell’avorio e il nome di Galatea non compare in Ovidio. Sulla
riscrittura russoviana del mito, Cfr.: Anne Geisler-Szmulewicz, Le Mythe de Pygmalion au XIXe
siècle. Pour une approche de la coalescence des mythes, Paris, Champion, 1999, in particolare il
secondo capitolo: «Naissance du mythe de l’artiste. Le Pygmalion de Jean-Jacques
Rousseau», pp. 39-56.
129 La parte aveva suscitato la viva partecipazione di Larive per il crescendo di sentimenti e
passioni discordanti che attanagliano lo scultore, da un inizio di abbattimento e di
scoraggiamento al sentirsi poi pervaso da uno strano ardore. L’artista intuisce che l’unica
consolazione gli viene dalla statua di Galatea, il suo capolavoro, ai piedi della quale, dopo
aver sollevato il velo che la nascondeva, si prosterna. La perfezione raggiunta nell’opera
d’arte lo spinge, in una sorta di follia, ad andare oltre la materia e chiede alla statua
un’anima. Dal delirio della visione della statua che comincia ad animarsi, al dono di se
stesso a Galatea, ormai palpitante di vita, Larive sperimenta la metamorfosi della totale
dedizione dell’artista all’arte, in assoluta empatia con Rousseau.
77
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
QUINTO INCONTRO
CAPITOLO VIII
Sull’espressione visibile
Con espressione visibile intendo quella di cui gli occhi, i muscoli e i gesti
costituiscono le componenti. Tale espressione è lo specchio dell’anima: per
suo tramite si riconoscono i moti interiori di chi si osserva; senza il soccorso
della parola fa capire ciò che si prova. A volte le parole esprimono solo per
metà il pensiero: l’espressione visibile lo dilata all’infinito; senza di essa le
parole non sono che suoni, con lei una parola, che è solo parola, si fa cosa.
L’espressione visibile è così forte che può distruggere persino gli effetti
della parola e cambiare il sì in no e il no in sì. Esercita la sua forza
soprattutto in amore, è sempre lei a essere incaricata della prima
dichiarazione e solo allora l’amore si fa effettivamente eloquente.
Per quanto i gesti siano uno degli organi o degli agenti di questa
espressione, l’attore la perde se eccede nella molteplicità dei gesti:
l’espressione si riduce allora nell’impiego delle braccia, nella postura
mobile e sempre mutevole del corpo; mentre l’espressione dell’anima
risiede principalmente negli occhi e nei tratti del volto che restituiscono
inequivocabilmente e senza affettazione il pensiero e i sentimenti.
L’espressione dipinge ogni passione in quanto solo le passioni hanno
diritto a dirigere l’espressione visibile, a costringere l’anima a manifestarsi,
a propagarsi all’esterno. Che gli attori non si occupino dei gesti, della posa,
che non pensino a dare tale o tal altra fisionomia particolare al loro volto: la
mente preoccupata di dirigere l’espressione visibile, indebolisce
necessariamente il sentimento che solo deve guidarla. L’espressione visibile
è quindi l’interprete di tutte le passioni interiori e quando smette di essere
in accordo con quanto si vuole esprimere, in chi parla e agisce non c’è più
verità, anima o sentimento, è solo una fredda copia di ciò che ha visto o
sentito. Ma sarebbe fatica inutile insegnare a un attore il partito che può
trarre dall’espressione visibile; se la studiasse solo sul volto di chi vorrebbe
imitare, tale imitazione si ridurrebbe a fare delle smorfie ridicole; lo ripeto,
è solo nel sentimento che si trova il segreto della vera espressione. Ogni
passione fa muovere in noi questo o quel muscolo, lo tende con più o meno
forza in ragione di una maggiore o minore sensibilità.
L’espressione visibile assume diverse sfumature secondo lo stato,
l’educazione e le abitudini. L’espressione del popolo si manifesta mettendo
in tensione tutti i tratti del volto, alzando le spalle, mostrando i pugni,
gesticolando in modo volgare ed esagerato; quella dell’uomo dabbene, che
possiede un’anima elevata è nobile e disinvolta; esprime senza sforzo ciò
che prova. Il vero modo per adeguarsi all’espressione del volto è di provare
la parte senza fare alcun gesto, allora l’espressione si manifesta
involontariamente con la forza del sentimento che determina il movimento
78
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
dei muscoli, degli occhi, dei tratti. Un giorno volli raccontare a una cena
importante la storia di un gobbo. Tra i commensali ce n’era uno che non
avevo visto. L’espressione di coloro che mi ascoltavano bastò a impormi il
silenzio, arrossii fin nel bianco degli occhi e tale fu il mio imbarazzo che mi
fu impossibile articolare una sola parola. Poiché quell’aneddoto che volevo
allora raccontare mi torna in mente, l’introdurrò qui avendo un rapporto
con l’espressione visibile.
Armand, comico eccellente, era spesso criticato per la sua espressione da un
gobbetto, fratello di quel Procope che gestiva di fronte alla ComédieFrançaise un caffè allora celebre.130 Il Procope gobbo trovava l’espressione
di Armand troppo forzata, non so perché aveva entrata libera agli
spettacoli e abitualmente si metteva sulle panche che un tempo occupavano
i lati a destra e a sinistra della scena.131 Si trovava sempre lì, allo stesso
posto; era sempre lì, sotto gli occhi di Armand e spesso alzava le spalle
quando non era soddisfatto dalla sua espressione. Armand ne era talmente
spazientito che non era più padrone dell’espressione del volto quando lo
sguardo incrociava quello del gobbo e il suo gesto. Ecco ciò che ideò per
sbarazzarsene: attese la prima rappresentazione di una nuova pièce nella
quale doveva recitare, acquistò i trenta biglietti dei posti del palcoscenico e
andò ad appostarsi sul Pont-Neuf il giorno precedente la rappresentazione
e là fece la posta a tutti i gobbi che passavano. A ognuno offriva un
biglietto gratuito con la preghiera di contribuire al successo della pièce.
Dopo aver distribuito così i biglietti ebbe cura di trovarsi di buon’ora a
teatro e di piazzare, prima che si facesse luce, quindici gobbi sulle panche
di destra e altrettanti su quelle di sinistra. Il gobbo Procope era arrivato fra i
primi, Armand, senza esser riconosciuto, lo piazzò come gli altri e diede
ordine di non far vedere la ribalta se non al momento di alzare il sipario. Il
pubblico sorpreso nello scorgere tanti gobbi riuniti, esclamò quasi in coro:
Ah! quanti gobbi! quanti gobbi! I gobbi sorpresi nel sentirsi apostrofare si
girarono e mettendo tutte le loro gobbe in evidenza sembrarono ancor più
ridicoli, allora gli scrosci di risa partirono da ogni dove e le grida
raddoppiate di abbasso i gobbi!, li obbligarono a uscire tutti gli uni dopo gli
altri. Con questa burla Armand si sbarazzò per sempre delle critiche del
gobbo Procope che da allora non osò più presentarsi sul palco. Armand
non dovette più temere l’espressione delle sue spalle e poté forzare a
piacimento quella della recitazione.
François Armand Huguet, detto Armand (1699-1765), debuttò al Théâtre-Français nel
1723 e per circa quarant’anni reciterà nelle commedie con naturalezza e brio soprattutto le
parti di Scapino e Crispino. Il Caffè Procope, già in voga alla fine del Seicento, era uno dei
più frequentati da artisti, letterati e scrittori.
131 Le panche dei privilegiati che ingombravano i due lati del palcoscenico, poco funzionali
per la recitazione e limitative della gestualità degli attori, erano state abolite nel 1759 grazie
agli sforzi congiunti di attori e di autori, in primis Voltaire, e al sostegno economico del
conte di Lauraguais.
130
79
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Una giovane dama, parlando in società, volle dire che nel regno dei ciechi
quelli che hanno un sol occhio sono dei re. L’espressione di coloro che
l’ascoltavano le fece capire che era presente un uomo con un sol occhio.
Subito dopo aver proferito nel regno dei ciechi, si fermò e arrossì. Il cieco di
un occhio, galante quanto affabile, la cavò d’impaccio dicendole: Ebbene,
signora, perché fermarvi? Stavate per farmi re!
Alcune imperfezioni degli organi comportano, in qualche modo,
un’espressione che è loro peculiare. L’espressione dei balbuzienti è una
smorfia, gli sforzi che fanno per articolare decompongono i loro tratti. Ci
sono in certe commedie scene di balbuzienti che suscitano sempre il riso; a
volte accade che anche in società appaiano comici. Quando ero a Bruxelles,
un balbuziente volle comprare un calesse, il sellaio da cui si recò era
balbuziente come lui: lo straniero gli chiese a quanto gli avrebbe venduto il
ca-calesse. Il sellaio pensò di essere preso in giro: la sua espressione fu di
grande stizza e rispose balbettando ancora di più: vi venderò il mio cacalesse, tren-trenta lu-luigi. L’acquirente a sua volta credé che volesse
ridicolizzarlo, si mise in una collera terribile. Dal canto suo il sellaio
s’infuriò. I reciproci balbettii, le smorfie dei due interlocutori erano molto
risibili, ma la cosa sfiorò la tragedia se non fossero intervenute delle
persone che affermarono che entrambi avevano la stessa infermità; due
uomini dabbene si sarebbero forse sgozzati per la sola ragione che, senza
conoscersi, avevano entrambi lo stesso difetto.
Le persone che s’incontrano per la prima volta osservano subito e
reciprocamente i loro tratti e la loro espressione. Quella della cortesia
affettuosa ispira interesse e predispone all’affetto; l’espressione della voce e
il suo accento confermano o distruggono questa prima impressione.
L’attenzione di due persone che si parlano per la prima volta senza
conoscersi è tanto più coinvolgente che ci si ascolta tanto quanto si ascolta il
proprio interlocutore, ci si giudica contemporaneamente l’un l’altro e nel
lasciarsi ognuno resta con l’opinione che si è concepita dell’altro: la
sincerità attira la sincerità, il riserbo è sovente reciproco e in questo caso ci
si lega raramente.
Un giorno fui invitato a cena da una signora di grande nomea per il suo
spirito. Mi accorsi che voleva giudicarmi e sapere se fossi degno di
intrattenerla piacevolmente; all’inizio mi sentii a disagio, poi sorrisi a una
domanda che mi pose; me ne chiese il motivo, le risposi con naturalezza
che sorridevo per l’impegno da lei profuso per capire se fossi o no una
persona di spirito. La mia naturalezza la fece scoppiare a ridere, da quel
momento divenne affabile e sincera, la sua arguzia stimolò la mia come
succede con le persone timide il cui estro dipende sempre un po’ da quello
degli altri.
Il piacere della conversazione deriva molto spesso dall’espressione
dell’interlocutore: se l’espressione è indulgente abbiamo più sicurezza,
80
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
slancio e naturalezza; se è brusca e rigida involontariamente diventiamo
tristi e seri. Le donne oneste sono più indulgenti sulle battute un po’
piccanti di quelle che non lo sono. Quest’ultime hanno paura di essere
scoperte, la loro espressione è ben più severa e sovente assumono un
contegno serio per una cosa che fa ridere di cuore la donna che non ha
nulla da rimproverarsi. La maggior parte di queste osservazioni non
possono servire per la tragedia, ma possono essere spesso messe in pratica
nella commedia e persino nell’alto comico.
81
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
CAPITOLO IX
Dell’immaginazione
L’immaginazione, unita al giudizio e allo spirito giusto, è il più bel regalo
della natura e offre all’uomo quei mezzi sublimi che lo innalzano al disopra
dei suoi simili; ma l’immaginazione se diretta unicamente dalla foga del
sangue è più pericolosa che utile; gli errori portano l’uomo alla rovina, può
solo servire a distruggere chi non ha le qualità necessarie per governarla.
Lo fa divagare di progetto in progetto, senza direzione né programma né
ordine e presto o tardi lo trascina in un precipizio.
Ho sentito dire, nel parlare di alcune persone, che avevano immaginazione
o spirito, senza nessun’altra distinzione. Penso che questo modo di
esprimersi non spieghi nulla perché non discrimina lo spirito giusto da
quello falso, lo spirito brillante dal concreto, lo spirito forte dal debole e lo
spirito buono dal cattivo. Lo stesso vale per l’immaginazione che forse ha
più sfumature dello spirito. Tutte le passioni nascono nel cuore, ma solo
l’immaginazione accende i loro desideri e i loro progetti, da lei attingono il
loro linguaggio. Ci sono dunque, per così dire tante immaginazioni quante
umane passioni. Il cuore sente, lo spirito concepisce, l’immaginazione dà
vita. Senza immaginazione si vegeta, si è ridotti al solo istinto;
l’immaginazione eleva l’uomo unicamente quando è pura, vivace e saggia,
se è soltanto esaltata lo mette fuori strada e troppo spesso accanto al
sublime c’è la stravaganza. Gli attori necessitano di un’immaginazione forte
e mutevole, per suo tramite viaggiano nel tempo e in luoghi lontanissimi;
assumono tutti i caratteri, s’impregnano di tutte le sensazioni di cui è
suscettibile il cuore umano, provano ogni passione e s’innalzano fino alle
virtù sublimi che caratterizzano i grandi uomini.
Ognuno giudica col proprio spirito, con le proprie sensazioni e la propria
immaginazione; in genere ogni individuo crede che lo spirito, il giudizio e
l’immaginazione siano la regola e la guida di ciascuno di noi.
Sovente, dopo i primi incontri cui ho in precedenza accennato, allorché
ognuno si è sforzato di offrire l’opinione di sé più favorevole, ed entrambe
le parti hanno esaurito ogni risorsa dello spirito e della cortesia, ci si separa
con la promessa di rivedersi presto e ci si congratula reciprocamente della
fortuna di essersi conosciuti. Una volta separati, l’immaginazione riprende
i suoi diritti, si era entusiasmata favorevolmente, ma ora agisce in senso
contrario: ingrandisce e moltiplica i difetti che lo spirito aveva appena
intuiti e due individui che erano per così dire entusiasti l’uno dell’altro, si
raffreddano e si rivedono con eguale indifferenza. Il primo sentimento
dell’amore produce identico effetto fra i sessi sia al fisico che al morale.
L’immaginazione eccitata abbellisce dapprima gli oggetti: tutto incanta,
tutto inebria, ma ben presto attenuata lascia vedere le cose come sono
realmente. Il primo ardore del sentimento svanisce e subentra la tiepidezza.
82
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Potrei paragonare a queste frequenti vicissitudini ciò che accade
all’accoglimento delle opere presentate agli attori. La prima produzione di
un giovane autore è letta in presenza della compagnia, presto si sentono nei
corridoi elogi lusinghieri dell’opera e dell’autore. È un’opera sublime, si
esclama, nuova, straordinaria, ricca delle più grandi bellezze. Arriva il
giorno in cui si deve ascoltare e giudicare la nuova produzione: ci si
riunisce con la speranza di arricchirsi di un bel testo, di disporre di belle
parti. L’autore si presenta con aria affabile, sorride ai giudici, lo si scruta col
desiderio di trovare sulla sua fisionomia il presagio della bellezza della
pièce; se è favorito dalla natura, ci si predispone in suo favore; se ha l’aria
imponente, non si hanno dubbi sulla sua energia; se è magro e delicato si è
sicuri in anticipo che la pièce sarà ricca di spirito e di sensibilità. Se l’autore
è commosso nell’iniziare la lettura, l’interesse raddoppia, tutto quanto si
ascolta si abbellisce con l’immaginazione, alcune voci esclamano:
quest’opera è piena d’animo e di profonda sensibilità. L’immaginazione di
chi non è ispirato dal testo si entusiasma per l’emozione provata dagli
astanti, pensando di essere mal disposto, accentua l’attenzione e spesso,
commosso più da un lacrima che sfugge da un bell’occhio che da quanto
ascolta, finisce col credere l’opera eccellente. La pièce viene accettata
all’unanimità, si assegnano le parti e presto si sente dire dagli attori che
devono recitarvi che esse sono pessime e che non è quello il testo che hanno
ascoltato; è senza dubbio lo stesso testo ma il loro spirito meno esaltato
distrugge il prestigio delle bellezze chimeriche partorite solo
dall’immaginazione.
Ho visto sovente l’immaginazione del pubblico entusiasmarsi per un’opera
mediocre, l’ho visto applaudire con trasporto ciò che avrebbe fischiato a
oltranza in una pièce annunciata meno favorevolmente: le identiche cose
che assicuravano il successo di una pièce avrebbero deciso del fiasco di
un’altra. Alla prima rappresentazione del Misanthrope, il pubblico
predisposto in favore di Molière, applaudì con trasporto il famoso
sonetto.132 Ma in quella scena l’autore prova che il sonetto è pessimo. Il
pubblico indignato nel veder criticato il suo giudizio e vergognandosi della
giustezza della critica, cambiò atteggiamento e la sua immaginazione
diventata fredda gli fece ascoltare con indifferenza tutte le bellezze di
quella meravigliosa commedia. In genere è l’immaginazione a dettare le
decisioni esagerate e i giudizi d’entusiasmo.
Si mette in movimento solo per abbellire o imbruttire al massimo gli oggetti
da cui è colpita. Di un giovane attore o di una giovane attrice si sente dire
che sono perfetti od orribili, spesso non sono né l’una né l’altra cosa. Il
132 Il Misantropo di Molière andato in scena al Théâtre du Palais-Royal il 4 giugno 1666. Il
sonetto cui fa riferimento Larive è quello letto da Oronte (atto I, scena 2, vv. 315-332) che
Philinte loda sperticatamente e che invece Alceste giudica pessimo e demolisce frase dopo
frase.
83
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
tempo, lo spirito e il buon senso riportano tutto in equilibrio e ogni cosa,
tornata al suo valore, resta ciò che deve essere.
La prima volta che la mia immaginazione m’ispirò il desiderio di recitare la
tragedia, concepii nientedimeno la speranza di esser messo nel rango dei
primi attori, la mia audacia si spinse fino a persuadermi che solo i miei
difetti fisici avrebbero potuto fermare o limitare il mio percorso. Per non
aver dubbi al riguardo osai, al ritorno da Santo Domingo, andare a trovare
il celebre Lekain. Permeato da quanto mi aveva ispirato il suo talento, gli
dissi che ero Americano (non volendo essere riconosciuto nel caso in cui
non avesse giudicato in modo favorevole la mia vocazione); osai
aggiungere che ero trascinato da una nobile emulazione, che avevo
concepito il progetto di essere il suo sostituto alla Comédie-Française, che
mi aspettavo da lui un giudizio sincero sulle mie capacità fisiche e morali;
credevo di potergli affermare che se non avesse trovato in me nessun
difetto considerevole sarei pervenuto a essere il suo sostituto o che sarei
morto nello sforzo. Lekain sorrise malignamente e l’intenzione del sorriso
mi si stampò nella memoria e forse quel ricordo ha viepiù rafforzato la mia
emulazione. Mi disse che, occupato al momento, non poteva ascoltarmi e
m’indicò il giorno in cui avrebbe potuto giudicarmi. In quell’attesa non
dormii, fui preso solo dalla parte che volevo provare e che avrebbe deciso
del mio futuro. Ero determinato a far ricorso al suo giudizio, intuendo già
che accanto alla gloria che deriva dall’occupare il primo rango in questa
carriera, non si riscuote che vergogna e disprezzo nell’ultimo.
Arrivai da Lekain ben deciso a mettere in evidenza le mie capacità naturali
con tutte le fioriture di cui ero capace. Fui ricevuto con cortesia e non
volendo perdere il tempo che doveva dedicare all’audizione, mi chiese il
permesso di farsi pettinare durante l’ascolto. La proposta non mi piacque
molto, all’inizio mi bloccò, ma la mia immaginazione, infiammata dal
giudizio che avrebbe pronunciato su di me, prese il sopravvento e mi
abbandonai del tutto al mio calore naturale. Lekain senza interrompermi,
mi ascoltò dandomi le battute con garbo. Quando arrivai alla fine della
parte (era quella di Zamore)133 aspettai con un certo timore il giudizio che
avrebbe pronunciato. Mi disse: Signore, non vedo nulla che vi impedisca di
dedicarvi alla vostra nobile emulazione; è possibile che con l’amore che
avete per questa bella arte possiate essere un giorno il mio sostituto alla
Comédie-Française.
A quelle parole una gioia immensa s’impadronì di me, gli saltai al collo, lo
strinsi fra le braccia, affermando che sarei stato il suo sostituto o che sarai
morto per gli sforzi che avrei fatto per rendermene degno. Sorrise della mia
Personaggio di Alzire ou les Américains di Voltaire (27 gennaio 1736) [Alzire o gli
Americani], che Larive interpreterà con una certa continuità dal 1775 al 1786 e che fa parte
del suo repertorio fin dal primo debutto alla Comédie-Française.
133
84
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
irruenza, ma con un’espressione diversa dalla prima volta, mi augurò
buona fortuna e lo lasciai ebbro di piacere e di speranza.
Uscendo da lì andai a farmi scritturare da Mlle Montansier che, dopo avermi
fatto un’audizione, mi giudicò degno di guadagnare seicento libbre
l’anno.134 Non chiedevo di più e partii subito a piedi per unirmi alla sua
compagnia che era a Tours. Durante il percorso non feci che recitare versi
di tragedie, l’immaginazione mi trascinava già sulla scena francese, credevo
di sentire alla fine di ogni strofe che ripetevo ad alta voce gli applausi del
pubblico e l’approvazione degli intenditori. I miei compagni mi accolsero
molto bene e, non dubitando di nulla, chiesi di pronunciare, per mettermi
alla prova, il discorsetto d’apertura. Non riuscivo a immaginare la viva
emozione che avrei provato nell’apparire per la prima volta in pubblico,
entrai a passettini ravvicinati e trovai il percorso dalle quinte alla ribalta
lungo quanto quello da Parigi a Tours, alla fine arrivai, proferii alla meno
peggio il discorsetto che mi era stato affidato e mi allontanai di corsa al
suono di qualche applauso che mi inebriò di gioia. Una volta lanciato in
varie interpretazioni, la mia emulazione reduplicò, mi credei pronto, dopo
due anni d’esperienza, di presentarmi a Parigi. Mlle Clairon accettò di
dirigere i miei studi e mi fece debuttare con Zamore nel 1770.
Lekain era allora in viaggio. In capo a qualche mese, scelsi di tornare in
provincia per impegnarmi in nuovi studi. Quattro anni dopo fui richiamato
a Parigi dallo stesso Lekain che non sospettava che fossi l’Americano che
aveva accettato di ascoltare. Fui accolto dal pubblico con indulgenza e
entrai infine alla Comédie-Française, come sostituto di Lekain.
Felice per la mia buona stella, lo invitai una volta a cena; feci cadere, alla
fine del desinare, la conversazione sulla temerarietà dei debuttanti e sulla
loro sicurezza: gli chiesi se si ricordasse di un giovane Americano che era
andato a interpellarlo e che gli aveva confessato la pretesa di esserne il
sostituto. Dopo aver riflettuto un momento, Lekain mi disse: Ah! mi
ricordo, non ho visto nessuno di più folle di quel giovane: aveva veramente
in testa tutto l’entusiasmo della sua terra, doveva, diceva, o morire o essere
il mio sostituto, e poiché non lo è, non ho dubbi che sia morto.
Perdonatemi, gli risposi brindando con lui, ho tenuto parola, perché sono io
quell’Americano folle. Difficile esprimere la sua sorpresa, poco ci mancò
che il bicchiere gli cadesse di mano. Ci volle del tempo per riprendersi dalla
sorpresa e in seguito mi ha detto, più di una volta, che nulla l’aveva più
colpito.
Marguerite Brunot, detta Mlle Montansier (1730-1820), lascerà presto i suoi ruoli di
servetta per dedicarsi alla direzione di troupes teatrali sia in provincia che a Versailles
(Theâtre des Réservoirs, 1777) e a Parigi, prima al Theâtre de Beaujolais e poi in varie altre
sale in un’attività frenetica, resa possibile soprattutto dopo la proclamazione della libertà dei
teatri nel 1791. Infaticabile nella sua capacità organizzativa, seppe anche animare un salotto
aperto a scrittori, attori e personalità politiche.
134
85
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Ecco a cosa possono portare, nella carriera delle arti, un’immaginazione
fervida, una volontà costante e uno studio ostinato.
86
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
SESTO INCONTRO
CAPITOLO X
Dell’ispirazione
L’ispirazione è necessaria agli attori quanto ai poeti. Da lei provengono
quei movimenti spontanei dell’anima che suscitano l’ammirazione e
seducono totalmente gli spettatori. La più perfetta delle opere
drammatiche, Atalia, perderebbe parte delle sue bellezze se Joad non fosse
ispirato nel dire:
Cieli, ascoltate la mia voce; terra, porgi orecchio;
Non dir più, oh Giacobbe, che il tuo Signore sonnecchia;
Sparite, peccatori, il Signore si sveglia.
Come in vil piombo è cambiato l’oro puro?135
L’ispirazione di Joad divinizza questa magnifica scena o almeno le serba il
carattere divino impressovi da Racine. Se viene recitata senza ispirazione
non é più che una declamazione senza calore né vita. L’ispirazione deve
sempre animare il linguaggio degli innamorati; l’amore appassionato, il
vero amore comunica sempre in modo intenso. Il suo procedere è di fuoco:
ha un solo scopo; vi si precipita con la rapidità del lampo: brillante
attributo della gioventù, ne ha la vivacità, il fulgore e la fiamma. È il fuoco
sacro di cui bisogna, lo ripeto, preservare gelosamente la scaturigine,
bisogna alimentarlo con un sentimento squisito che permetta di apprezzare
i favori più delicati, che dia al minimo dolore un’espressione vera e
profonda e che tenga l’animo sempre aperto all’emozione e alla tenerezza.
Ciò che a teatro rende difficile la giusta estrinsecazione dell’amore è che
deve esser sempre accompagnato da grazia, da nobiltà, da un’espressione
nel contempo delicata e forte che giustifichi l’ardimento delle declamazioni,
l’audacia delle azioni, gli scarti e l’impeto di una passione ardente e
dispotica.
Ammetterò tuttavia che se l’amore ha un solo scopo, vi giunge per strade
diverse. Quella dei giovani innamorati alle prese con un primo amore è
gradevole e facile; quella delle passioni violente, che scoppiano solitamente
in età più adulta, è irta di spine, circondata da precipizi e quasi sempre
disorienta chi la sceglie: troppo spesso è accompagnato da forza e da
Athalie, l’ultima tragedia di Racine, scritta per le Demoiselles di Saint-Cyr e da loro
recitata il 5 gennaio 1691, sarà rappresentata alla Comédie-Française solo il 3 marzo 1716.
Particolarmente apprezzata da Larive tanto da iniziare il suo corso all’Athénée dall’analisi di
Athalie, vi reciterà nella parte di Abner. «Cieux, écoutez ma voix; Terre, prête l’oreille; / Ne
dis plus, ô Jacob, que ton Seigneur sommeille; / Pécheurs, disparaissez, le Seigneur se
réveille. / Comment en un plomb vil l’or pur s’est-il changé?» (atto III, scena 7, vv. 11391142).
135
87
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
violenza, non sa che tormentare e tormentarsi; è l’amore tiranno, un mostro
generato dal desiderio dei sensi che trascina con sé solo dolori e crimini.
L’attore che rappresenta queste terribili passioni, se vuole essere ispirato
nel modo giusto, deve far proprie tutte le circostanze marginali dell’azione
principale, quanto l’azione stessa. Chi impersona Vendôme nell’Adélaïde du
Guesclin, deve ricordarsi, prima di iniziare a recitare, la tenerezza che ha
provato nell’infanzia nei confronti di Nemours.136 Pervaso da questi cari
ricordi, gli sarà facile essere ispirato dagli stessi sentimenti nel momento in
cui riconosce il fratello e lo vede ferito. Se Vendôme pensa a Nemours, a
quel fratello che ha tanto amato, solo nel momento in cui lo vede, non avrà
la giusta ispirazione per dirgli:
Non sei più che mio fratello. Ah! momento pieno d’incanto
Ah! lasciami lavare il tuo sangue con le mie lacrime.137
Se coglie in modo giusto, in ogni sfumatura, il sentimento e la situazione
del personaggio che interpreta, di quelli che lo circondano e i diversi gradi
d’affetto e di odio che prova in particolare per ognuno, farà arrivare la sua
immaginazione al punto richiesto, sarà del tutto in armonia con se stesso, e
quando Nemours gli dirà, nel terzo atto:
Perché osate accusarlo di una scelta indegna?138
Vendôme sarà colpito come da un fulmine nello scoprire il rivale, e la sua
ispirazione sarà perfetta nel dire:
E perché, voi, mio fratello, osate scusarlo?139
È ancora necessario che, attraverso l’impeto d’ira e la sua estrema violenza,
ispiri un interessamento che lo faccia compiangere, che impedisca di
odiarlo e che il pubblico serbi la speranza di vederlo tornare in sé,
altrimenti viene meno ogni coinvolgimento nei suoi confronti, e in lui non
si ravvisa che un tiranno. Ladislas nel Venceslas di Rotrou, ha un carattere
pressoché simile: è fremente, furibondo, oserei persino pensare che
Vendôme sia nato da un ricordo di Ladislas: due versi della parte devono
bastare a far sentire all’attore tutto ciò che gli si chiede:
Morivo, ardevo, l’adoravo nell’anima;
Tragedia di Voltaire (18 gennaio 1734), Larive sarà Vendôme fin dagli inizi della sua
carriera teatrale.
137 «Tu n’es plus que mon frère. Ah! moment plein de charmes! / Ah! laisse-moi laver ton
sang avec mes larmes», atto II, scena 2, vv. 403-404.
138 «Pourquoi d’un choix indigne osez-vous l’accuser?», atto III, scena 3, v. 967.
139 Alla domanda di Nemours Vendôme risponde con un’altra domanda: «Et pourquoi,
vous, mon frère, osez-vous l’excuser?», Ivi, v. 968.
136
88
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
E il cielo ha fatto di me un essere di fuoco.140
Questa parte va annoverata fra quelle che possono servire da pietra di
paragone del talento di un attore; chi ha l’ispirazione giusta per provarne
ed esprimerne ogni bellezza, può recitare tutto con successo.141 Zamore,
parte difficilissima deve essere ispirata dal principio alla fine, ma il tono
dell’ispirazione deve variare con le motivazioni. Zamore è esaltato dalla
disperazione quando, schiavo e disarmato, invoca la vendetta contro
Gusman, questa «triste divinità dei mortali offesi»;142 lo è da un coraggio
feroce e incrollabile quando lascia Alzire per andare ad assassinare
Gusman; lo è dall’ammirazione di una virtù superiore quando dice:
Ah! la legge che ti obbliga a questo supremo sforzo,
Comincio a crederlo, è proprio la legge di un Dio.143
L’ispirazione appare nel sospendere all’improvviso il sentimento da cui si
era presi per abbandonarsi del tutto alla nuova idea che colpisce
repentinamente, come un lampo, l’immaginazione; allora i tratti del volto,
la postura del corpo, tutto assume una nuova direzione; l’essere nella sua
totalità si agita per sottostare al nuovo sentimento che lo anima e questa
agitazione è più o meno intensa secondo la natura e il grado d’ispirazione
da cui è suscitata. Alla ripresa della Veuve du Malabar, provavo per la prima
volta la parte del Generale francese:144 poco soddisfatto dal colpo di scena
finale che obbligava la Vedova a precipitarsi in una fossa in fiamme dalla
quale era tirata fuori dal Generale, senza provocare alcun effetto, mi sentii
Jean de Rotrou, Venceslas, (26 settembre 1680): «Je mourais, je brûlais, je l’adorais dans
l’âme; / Et le ciel a de moi fait un être de flamme» (atto II, scena 3, vv. 626-627, nella
versione originale al posto di ‘un être’ si legge ‘un sort tout’). La parte del principe Ladislas,
figlio di Venceslas re di Polonia, faceva parte del repertorio di Larive.
141 Larive esaminerà nel dettaglio e in progressione l’espressione dei diversi sentimenti che
agitano Ladislas: gelosia, amore, cieco impeto della passione e prostrazione finale, Cfr.:
Cours, 1810, I, pp. 138-183.
142 Nella già citata tragedia di Voltaire: Alzire ou les Américains: «triste divinité des mortels
offensés», atto II, scena 6.
143 Ivi: «Ah! la loi qui t’oblige à cet effort suprême, / Je commence à le croire, est la loi d’un
Dieu même», atto V, scena 7.
144 Antoine-Marin Lemierre: La Veuve du Malabar ou l’Empire des coutumes (30 luglio 1770) [La
Vedova del Malabar o l’impero dei costumi]. Fu un indiscutibile successo per Larive nella parte
di Montalban, il Generale francese: la pièce che al suo apparire aveva costituito un vero
tonfo, ora in parte rimaneggiata e con una realizzazione scenografica innovativa ottiene un
ottimo esito suggellato da trentadue repliche dalla prima del 29 aprile 1780 fino al 17
dicembre. Annota Grimm nella «Correspondance littéraire»: «Non c’è forse una parte in cui
Larive non abbia sviluppato una carattere più nobile e più impetuoso di quello del Generale
francese; ha colto perfettamente tutto ciò che lo caratterizza; gli ha dato la nobiltà e
l’entusiasmo cavalleresco che gli appartiene e il modo in cui ha reso l’ultimo colpo di scena,
che certamente non è di facile esecuzione, costituisce una ennesima prova dei progressi che
compie ogni giorno nella pratica scenica» (vol. XII, maggio 1780, pp. 395-396).
140
89
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
improvvisamente ispirato e dissi all’autore: Signore, voglio un rogo alto
cinque piedi, nel momento in cui sarà acceso da ogni lato e che la Vedova vi
salga, voglio lanciarmi tra le fiamme con in una mano la spada sguainata e
con l’altra trascinar via la Vedova. L’idea fece ridere gli astanti, non me ne
inquietai. Chiesi a Mlle Saint-Val, che recitava la parte della Vedova, se
avesse abbastanza fiducia in me per affidarsi interamente alla mia forza e al
mio coraggio, mi rispose cortesemente che acconsentiva. Feci costruire il
rogo e il colpo di scena produsse una sensazione così forte che recitammo
la pièce trenta volte di seguito con un’affluenza straordinaria.145
Ebbi di nuovo una sorta d’ispirazione nel mettere in atto la scena della
mela nel Guillaume Tell.146 L’autore mi disse che Lekain ne aveva trovato
l’esecuzione impossibile. Io la trovai semplicissima e immaginai che
nascondendo la freccia nel momento di tenderla, facendola sparire dietro di
me nelle quinte, proprio nell’istante in cui la mela attaccata a un filo doveva
cadere, l’azione avrebbe prodotto un effetto tanto più naturale che il
pubblico avrebbe fissato lo sguardo piuttosto sul bambino e sulla mela. La
cosa riuscì così perfettamente che varie persone mi chiesero come facessi
per colpire con così tanta abilità la mela. A Lione questo colpo di scena era
fatto con un fil di ferro teso da un lato all’altro del palcoscenico, la freccia lo
percorreva fino alla mela. Lo soppressi e feci a modo mio; provocò tanto
più effetto in quanto il pubblico aveva indovinato l’altro mezzo per la
lentezza con cui la freccia colpiva il bersaglio. Un giorno, sempre a Lione,
volendo eseguire il colpo di scena di Lyncée, nell’Hypermnestre147 (perché
sembra che queste peculiarità dovessero sempre prodursi con le pièces di
Lemierre), il mio piede s’impigliò nel mantello d’Hypermnestre, ella cadde;
nel tentativo di rialzarla scivolai e caddi su di lei: non era affatto tragico,
ma improvvisamente ebbi l’ispirazione di trar vantaggio da quella
situazione; coprii con un braccio il corpo d’Hypermnestre, con l’altro
armato di spada minacciai il tiranno; la postura del mio corpo fu così
maestosa che il pubblico pensò che l’avessi fatto appositamente e applaudì
con entusiasmo.
La stampa è unanime nel lodare la recitazione di Larive e forse è proprio la sua presenza
e la messa in scena à grand spectacle a decretare la fortuna della tragedia: «Sta di fatto che vi
si delineò straordinariamente, e il modo in cui strappò la vittima dal rogo gli valse
un’approvazione generale. Era ammirevole nell’urlare: Lanassa fra le fiamme!!… Era bello
d’amore e d’eroismo quando afferrava la vedova con l’aria di un’aquila che rapisce una
colomba», (Mémoires de Fleury…, cit., vol. I, p. 236).
146 Lemierre, Guglielmo Tell (17 dicembre 1766). La tragedia fischiata alla prima del 1766 e
ripresa due anni dopo senza successo, viene riproposta il 21 giugno 1786 con la speranza che
Larive le dia nuovo lustro, ma l’opera non avrà che cinque repliche, perché come affermano
i «Mémoires secrets» l’autore privilegia l’effetto scenico senza troppo curarsi dello stile (vol.
XXXII, 29 giugno 1786, p. 156). È solo la scena della mela che soddisfa l’esigenza del
pubblico avido della spettacolarità visiva del racconto, e che Larive ha ben colto.
147 Altra tragedia di Lemierre (31 agosto 1758). Fa parte del repertorio di Larive fin dal 1775,
ne porta in scena il personaggio con continuità fino al 1786.
145
90
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Racconto quanto mi è successo non tanto per vantarmi delle mie ispirazioni
quanto per provare ai giovani attori che devono essere totalmente
compenetrati nell’azione: l’attenzione sostenuta procura l’ispirazione e
l’ispirazione non può mancare di essere felice quando i pensieri dell’attore
sono fortemente fissati sull’oggetto che l’ha suscitata. Potrei citare storie in
cui l’ispirazione deriva da sfumature più delicate e procedere ad analisi più
profonde, ma i giovani attori non mi ascolterebbero con attenzione; ciò che
maggiormente desidero è persuaderli che quest’arte, se vogliono aver
successo, richiede che vi ci si dedichi con tutto se stessi. Una volta lanciati
sulla strada della verità, la loro sensibilità, la loro immaginazione e uno
studio assiduo fanno il resto. L’ispirazione può anche verificarsi nelle scene
di vita ordinaria, che possono essere più o meno felici. Ne ebbi una in
prigione che avrebbe potuto costarmi la testa se alcuni amici non mi
avessero impedito di seguirla. Era il giorno della festa dell’Eterno: credemmo
doverla celebrare in prigione, nei giorni di festa mi si facevano recitare dei
versi. Nell’istante in cui venivo vivamente sollecitato, sentimmo sparare il
cannone. Mi trovavo di umore malinconico come tanti altri, aspettavo ogni
giorno la fine della mia triste esistenza, ebbi l’idea di provocarla in modo
clamoroso. Mi slanciai per dire questi versi di Zamore:
Sento tuonare il bronzo di questo barbaro popolo:
Quale festa o quale crimine sta ora preparando?
Vediamo se almeno possiamo lasciare questi luoghi,
Se posso salvarvi o se dobbiamo perire.148
Nel momento in cui pronunciavo Sento tuonare il bronzo…, i miei sfortunati
amici, scorgendo in tutto il mio essere un movimento convulso, intuirono i
versi che avrei declamato, mi fermarono e m’imposero silenzio, affermando
che non solo sarei morto, ma che avrebbero sacrificato con me tutti quelli
che mi avessero ascoltato e che ne sarei stato la causa. Opponendosi alla
mia ispirazione, convengo che mi fecero un gran favore.
Eccone un’altra che potei realizzare e che ebbe esiti favorevoli.
Circa quattro anni fa mi trovavo ad Angers in occasione della celebrazione
di una pompa funebre per i ministri francesi assassinati a Rastatt.149
Invitato alla cerimonia dalla municipalità mi recai sul luogo indicato per il
raduno. Il corteo era composto da tutte le autorità costituite e da un gran
numero di cittadini. Ci recammo in pompa magna al Temple Décadaire;150
Alzire ou les Américains, atto II, scena 6: «J’entends l’airain tonner de ce peuple barbare: /
Quelle fête, ou quel crime est-ce donc qu’il prépare? / Voyons si de ces lieux on peut au
moins sortir; / Si je puis vous sauver, ou s’il nous faut périr», così termina il secondo atto.
149 Il 28 aprile 1799 i delegati francesi, che stavano lasciando la città dopo un Congresso
durato due anni senza approdare a un risultato, furono attaccati e uccisi da un contingente
di ussari austriaci.
150 Il calendario rivoluzionario adottato dalla Convention il 5 ottobre 1793 (resterà in vigore
fino al 1° gennaio 1806) imponeva una nuova denominazione dei mesi dovuta a Fabre
148
91
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
una folla immensa vi era concentrata. Il tempio era addobbato con cura,
accanto al cenotafio circondato da cipressi era stata predisposta una musica
lugubre e grandiosa.
Dopo che i militari, i giudici e le autorità ebbero preso posto, un cittadino
salì alla tribuna per pronunciare un discorso in correlazione con la
circostanza. La sua voce flebile non gli consentiva di essere udito da tutti e,
anch’io non potendolo sentire distintamente, provai una certa impazienza
che mi spinse a dire all’improvviso ai miei vicini: «Se fossi al suo posto mi
farei sentire meglio di lui». Ero emozionato e provai una specie di sussulto
e una involontaria agitazione.
Quando l’oratore ebbe finito, vidi il presidente della municipalità, seguito
da due guardie, venirmi incontro e dirmi: «Cittadino Larive, mi è stato
appena comunicato che avevate un discorso da pronunciare, sarete
accompagnato alla tribuna». Immaginate come mi sentii a quelle parole
vedendo gli sguardi volgersi verso di me e ripetere in un certo qual modo
l’invito appena formulato! Sorpreso dalla proposta e dal movimento
provocato nell’assemblea, non potei che salutare e seguire senza far parola
le guardie che mi accompagnavano. Mossi verso la tribuna senza sapere ciò
che avrei detto. Fu nel momento di salirvi che si presentò al mio ricordo
l’imprecazione di Edipo. Il rullo dei tamburi, gli occhi di quattromila
spettatori fissi su di me, la vista di quell’immensa cerchia, quell’insieme
turbò la mia anima. Stavo per cominciare quando mi accorsi che il primo
verso della tirata si rivolgeva agli Dei dei Tebani. Fui assai fortunato nel
riuscire a cambiare il verso prontamente; chiamai a raccolta tutte le mie
forze e pronunciai con voce veramente ispirata:
Dei dei repubblicani, Dei che ci esaudite,
Punite l’assassino, voi che lo conoscete:
Sole, nascondi ai suoi occhi il giorno che c’illumina;
Che odiato dai figli, esecrato dalla madre,
Errante, abbandonato, proscritto nell’universo,
Accentri su di lui tutti i mali degli Inferi;
E che il suo corpo insanguinato, privo di sepoltura,
Diventi la pastura dei voraci avvoltoi.151
d’Églantine e divideva il mese in tre decadi (mois décadaire); il decimo giorno (décadi)
veniva considerato festivo e una liturgia laica sostituiva quella religiosa che si svolgeva nel
Temple Décadaire, spesso una chiesa sconsacrata. Offriva occasione di commemorazioni e
celebrazioni patriottiche inneggianti ai valori repubblicani, alla nuova morale sociale,
all’Essere Supremo, alla Natura…
151 Voltaire, Œdipe (atto I, scena 3, vv. 257-264): «Dieux des Républicains [Et vous, dieux des
Thébains], dieux qui nous exaucez, / Punissez l’assassin, vous qui le connaissez. / Soleil,
cache à ses yeux le jour qui nous éclaire. / Qu’en horreur à ses fils, exécrable à sa mère, /
Errant, abandonné, proscrit dans l’univers, / Il rassemble sur lui tous les maux des Enfers, /
Et que son corps sanglant, privé de sépulture, / Des vautours dévorants devienne la
pâture».
92
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
A quest’ultimo verso il tempio echeggiò di applausi. Mi persi tra la folla, le
ginocchia tremanti non mi permisero di restare in piedi. Un’emozione così
violenta si era impossessata di me che io stesso stentavo a credere che da
semplice spettatore fossi diventato, in un istante, uno dei principali attori di
quell’augusta cerimonia.
93
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
CAPITOLO XI
Della seduzione
Molti giovani confondono a teatro l’amore vero con l’amore seduttore: è
importante distinguerli. Il primo trova fondamento nell’anima, il suo
andamento è tanto più puro che non utilizza né affettazione né
preziosismo. Sua unica eloquenza è la sensibilità: il vero amante gode del
pensiero e dello sguardo. Anima e sensi, fisico e morale, tutto si mescola e
si fonde in un unico sentimento. Il suo godimento è tanto più vivido che
solo le affettuosità dell’animo dirigono quelle dei sensi. Quando un
momento felice riunisce due innamorati infiammati da quel fuoco sacro
ignorato dall’amore seduttore, nulla eguaglia la loro ebbrezza. Colmi della
loro felicità, non possono immaginare né desiderare nulla di più grande; si
guardano, si ascoltano, quella felicità basta loro; sono circondati da un
santo rispetto, mai un favore è chiesto o rifiutato; tutto in loro si confonde,
il desiderio come l’abbandono. Anche nel godimento il pudore viene a
coprirli con le stesse ali di cui si serve per fuggire davanti ai sentimenti
impuri. A teatro l’amore dovrebbe essere espresso solo come un sentimento
eletto dell’anima che mai deve far sospettare i risvolti fisici. Ho detto in
precedenza: l’innocenza ha una propria voce che da lei scaturisce; aggiungo
che ha anche un contegno e uno sguardo sempre accompagnati dal pudore,
sempre da lui guidati e che non si trova più se scompare. Quanto dico ora
può aprire gli occhi di quelle attrici che credono di aver raggiunto la
perfezione ostentando ed elargendo le loro grazie infantili. A cosa può
servire per l’evoluzione dei costumi e per l’arte questo misero genere
corruttore in cui si esercitano quotidianamente delle giovanette che
assumono il ruolo delle innocenti quando hanno smesso di esserlo e che
sono condannate, per la maggior parte, a non concepire l’amore onesto
perché hanno conosciuto solo l’amore seduttore? Se le madri si sentissero in
dovere d’istruire le loro figliole fin dall’infanzia su quanto devono temere
dalla seduzione, ci sarebbero molto meno sedotte. Non sarebbe più sicuro
far conoscere i rischi quando si è ancora lontani dal precipizio piuttosto che
attendere l’istante in cui cuore e sensi sono già risvegliati dal desiderio?
«Non si può desiderare ciò che non si conosce», dice Zaïre;152 lo credo, ma
la giovanetta, il cui cuore comincia a palpitare, sospetta già delle differenze
e conosce presto un’attrattiva di cui approfitta l’abile seduttore. Gli omaggi
che le vengono presentati, il modo interessante con cui viene guardata, la
curiosità naturale al gentil sesso, tutto contribuisce a turbarla, niente
l’istruisce, niente può farle credere che la tenerezza che le manifestano
abbia come intento il disonore. Senza nulla sospettare lascia trapelare le sue
emozioni che il seduttore non è degno né di apprezzare né di sentire,
occupato unicamente a cogliere il frutto degli intrighi, il vuoto del suo
152
«On ne peut désirer ce qu’on ne connaît pas», atto I, scena 1, v. 19.
94
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
cuore è interessato solo ad assumere una sensibilità artificiosa di cui
dispone a volontà; sempre padrone di sé, delle sensazioni e dei sentimenti,
assume ogni forma per sorprendere la fiducia dell’oggetto perseguito; dal
momento che la possiede, osserva con freddezza la forza e la debolezza
della mente, del cuore e del carattere della sua vittima; va incontro a tutto
ciò che può piacerle, piange con lei se è triste, si rallegra della sua gaiezza,
il suo godimento consiste solo nel trionfo e nel lustro che ne scaturisce.
Si è vittime della seduzione solo se si è deboli di cuore e di carattere o se si
desidera essere adulate. Spesso le giovani lo sono per ignoranza, l’intero
edificio costruito per formare una donna onesta e sensibile crolla all’istante
perché non vi si sono fatte entrare le conoscenze che possono difendere
dalla seduzione; il male una volta compiuto non si riaggiusta più.
Una caduta comporta sempre un’altra caduta.153
Ben presto non restano più che piaceri fittizi che, di breve durata,
necessitano continuamente, per essere rinnovati, del cambiamento
d’oggetto e delle raffinatezze del vizio. Come, in mezzo a tale disordine,
riuscire a esprimere gli slanci ingenui e i sentimenti delicati di un amore
onesto? Sono le giovani attrici a doverlo rappresentare sul palcoscenico con
ogni fascino possibile; il segreto risiede nella loro condotta e nell’impegno
di non separarlo mai dalla delicata voluttà. Ma affinché tale riforma sia
completa bisogna chi vi collaborino anche i giovani attori, bisogna che
smettano di confondere il carattere del seduttore con quello del vero
innamorato, di scambiare l’espressione dei desideri con quella delle
passioni e di sostituire il delirio della mente o l’eccitazione dei sensi ai
delicati sentimenti del cuore. Il segreto per loro è identico, non cambia in
rapporto al sesso; consiste nella delicatezza naturale dei sentimenti e nella
regolarità dei costumi.
Che mi sia concesso di raccontare qui la breve avventura che ha
determinato la purezza dei miei e senza la quale, forse, avrei lasciato la mia
giovinezza in balia di quei falsi piaceri che lasciano il cuore freddo e vuoto
e appagano solo la puerile e colpevole vanità. Questa avventura non è
affatto lusinghiera per me, ma può illuminare i giovani che hanno quasi
sempre l’ambizione di fare nuove conquiste, quali che siano, e credono
doverle tutte ai privilegi accordati dalla natura.
Fiero dei miei successi dopo il debutto alla Comédie-Française, assai
vanitoso del mio aspetto giovanile, mi faceva piacere essere guardato e
fatto segno all’attenzione delle donne; dal momento che si degnavano di
«Dans le crime une fois il suffit qu’on débute / Une chute toujours entraîne une autre
chute», detto riportato da Marmontel, Cfr.: Œuvres posthumes de Marmontel, historiographe de
France, secrétaire perpétuel de l’Académie Française, imprimées sur le manuscrit autographe de
l’Auteur, Paris, chez Xhrouet, 1805, vol. VII («Logique», p. 168).
153
95
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
dirmi qualcosa di lusinghiero sul mio talento, avevo una piccola vanità di
credere di essere amato. Un mattino ricevetti un biglietto da parte di una
vera signora che m’invitava a recarmi il giorno stesso nel suo palazzo tra le
undici e mezzogiorno, ora alla quale non avrebbe ricevuto nessuno tranne me;
la vanità mi portò a credere di averle fatto girare la testa. L’immaginazione
me la rappresentava giovane, bella e soprattutto molto invaghita di me.
Ardevo dal desiderio di vedermi ai suoi piedi e di giurarle amore eterno.
Una dama di corte dal nome famoso, illeggiadrita dalle grazie che le
attribuivo, mi sembrava al di sopra di tutte le bellezze per le quali avevo
fino ad allora sospirato.
Mi abbigliai in modo assai ricercato e mi recai al palazzo indicatomi. Il
guardaportone, non appena pronunciato il mio nome, fece venire una
giovane cameriera che mi esaminò con un sorriso maligno e si offrì di
accompagnarmi dalla Signora. Attraversammo un appartamento grande e
magnifico. Il mio cuore palpitava di contentezza e di piacere. Arriviamo
nella stanzetta dove la Signora era intenta alla toilette; la cameriera vi entra
da sola per annunciarmi. «Fate passare nel mio salottino, rispose la Signora,
e dite al guardaportone che non ci sono per nessuno». Eccomi introdotto
nel delizioso boudoir. Languidamente seduto su un’ottomana, mi perdo
nelle più piacevoli riflessioni: essere l’amante prediletto di una vera
Signora, imparare da lei come si fa l’amore a corte: tutto ciò m’inebriava e
mi faceva desiderare con impazienza il momento di trovarmi fra le sue
braccia. Non l’avevo ancora vista, ma la voce mi era sembrata nobile e
seducente, questa donna, dicevo tra me, ha l’accento della voluttà. Ah!
sento che solo lei potrà insegnarmi a conoscere il nobile piacere, il solo
degno di me, il solo che ormai vorrò assaporare. Ma bisogna essere
prudenti e non dire nulla prima che abbia confessato il sentimento che
prova per me.
Sento un leggero trapestio, il mio cuore palpita, si apre una porta, mi alzo e
vedo entrare la mia vera Signora. Immaginatevi la mia sorpresa quando
invece della Venere o dell’Ebe che mi aspettavo, non trovo che una donna
di una quarantina d’anni, assai brutta, avendo di gradevole solo le braccia,
le mani e gli occhi. Il mio cuore si agghiaccia e non riesco ad articolare che
qualche parola dignitosa sull’invito che mi valeva l’onore di vederla.
«Sedetevi, Signore, mi disse in modo serio, devo farvi una confidenza di
cui, spero capirete il valore. Sono informata dei vostri costumi e della
vostra onestà: visto tutto il bene che mi è stato detto su di voi non ho dubbi
sulla vostra discrezione». Mentre mi parlava teneva la mano davanti alla
bocca lasciandomi o piuttosto facendomi vedere il profilo del braccio che
era veramente bello. La rassicuro, un po’ rattristato, della mia discrezione e
l’ascolto: «Signore, mi dice con tono molto grave, ho la disgrazia di avere
da tempo una cattiva salute, il mio medico ha esaurito senza successo ogni
ausilio della sua arte, è filosofo e uomo di mondo, non ha esitato a
96
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
confessarmi che la mia salute si era deteriorata all’epoca in cui mio marito
aveva cominciato a trascurarmi. Non è necessario che vi dica il consiglio
che ha accompagnato tale affermazione; ho provato, come ve ne rendete
conto, tutta la ripugnanza che una donna come me deve avere in simile
circostanza; ma insomma bisogna star bene: è una triste sorte dover soffrire
sempre. La voglia di distrarmi mi portò l’altro giorno alla ComédieFrançaise. La vostra bella voce, la vostra nobile figura, la vostra salute
smagliante, tutto in voi m’ispirò un reale interesse: siete giovane, è compito
di una donna sensibile e onesta sottrarvi ai pericoli che incombono sulla
vostra inesperienza; credo di avere quanto è necessario per istruirvi. Il mio
medico, che era con me, mi parlò molto bene di voi e ha finito per farmi
decidere in vostro favore».
Non è facile dire come mi sentii dopo un simile discorso. L’indignazione
s’impossessò di me e mi sentii molto umiliato di essere venuto da questa
donna solo come un rimedio ai suoi mali; ci misi del tempo a rimettermi
dalla sorpresa: il suo silenzio mi avvertiva che dovevo rispondere. Le dissi:
«Sono estremamente colpito, Signora, dalla preferenza che avete voluto
accordarmi per il recupero della vostra salute; ho solo un vivissimo
rimpianto, quello di non poter soddisfare le vostre aspettative; Melpomene,
Talia e una donna che amo impegnano ogni mia possibilità. Quel poco che
resta sarebbe un rimedio troppo blando per osare offrirvelo. Ma avete,
Signora, un modo ben più sicuro e più semplice. Un gran numero di questi
giovani montanari che la miseria e la speranza di guadagnarsi da vivere
attirano ogni anno a Parigi, attorniano il vostro palazzo; il loro vestiario è
poco costoso e si offrono a buon mercato». A queste parole la mia vera
Signora indignata si alza e mi dice rossa, più di collera che di pudore, che
non si sarebbe mai aspettata da parte mia una tale impertinenza, né io,
Signora, le risposi, l’indecenza della vostra proposta. Subito raggiunsi le
scale e scomparvi.
Restai così addolorato da questa triste avventura che non osai vantarmene
con nessuno e da allora ho sempre diffidato di quelle donne alle quali non
costa nulla né il primo passo né il primo approccio e che le si trova del tutto
disposte a risparmiarvi l’imbarazzo di una dichiarazione. Ogni volta che ne
ho vista una pronta a darsi da fare con me, mi è tornata in mente la
prescrizione del medico; mi sembrava che pensassero a me solo perché
dovevano ristabilire la loro salute.
I giovani attori hanno un’enorme necessità di conservare i loro mezzi fisici,
da loro dipende quel vigore elettrico che si comunica e convince. L’attore
accorto e che dispone dei propri mezzi, è forte senza essere forzato,
esprime senza fatica ciò che vuole. Chi gode oltre le proprie possibilità ha
un bel fare, il suo animo è usato come i suoi sensi, non desta negli spettatori
che un sentimento artificioso, quello da lui percepito; per dirla in breve
97
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
nelle sue proprie impressioni come in quelle che suscita resta sempre al di
qua dell’obiettivo da raggiungere.
Ritorniamo al seduttore, non si può recitare bene questo ruolo se non dopo
aver fatto proprie tutte le sfumature che ne compongono il vero carattere,
contrario, in ogni punto, alla sincerità e alla buona fede.
L’attore non deve dimenticare che se nel corso di una parte di questo tipo ci
sono momenti lusinghieri per l’amor proprio, non è così alla fine. Il
seduttore non appena è scoperto raccoglie solo l’odio delle vittime e il
disprezzo degli spettatori: se non raggiunge questo intento, non è un vero
seduttore.
L’attrice che rappresenta l’oggetto della seduzione deve ricordarsi anche
che può essere vulnerabile solo per un sentimento irresistibile nei confronti
di chi vuole avere la meglio su di lei o per una sensibilità ingenua che
suscita interesse in suo favore nel momento stesso in cui soccombe.
98
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
SETTIMO INCONTRO
CAPITOLO XII
Della nobiltà e della dignità
Queste due qualità, o piuttosto queste due sfumature che concorrono a
formarne una, sono di assoluta necessità nella tragedia. Senza di esse è
impossibile impressionare il pubblico e convincerlo che sono Agamennone,
Mitridate, Fedra o Semiramide che gli si fanno vedere e ascoltare.154 Non
dipendono esclusivamente dalla bellezza dei tratti o dalle perfezioni delle
forme; ho visto uomini molto belli non avere né nobiltà né dignità; ho visto
donne prestanti e ben fatte avere un’aria dozzinale; ho visto uomini bassi e
brutti apparire ciononostante nobili e solenni; donne altrettanto
svantaggiate dalla natura risultare eleganti e maestose.155 La nobiltà e la
dignità dipendono piuttosto dall’elevatezza dell’anima e da una certa stima
di se stessi che dalla regolarità dei tratti e della corporatura. Chi ha dignità
nell’animo ha certamente una dignità fisica purché, almeno, non abbia
alcuna deformità. L’anima comanda a tutto l’insieme e gli dà il tono,
quando s’innalza al di sopra dei meschini interessi e delle limitate passioni,
si manifesta nel fisico intero: gli occhi, i gesti, gli atteggiamenti essendo
interpreti dell’anima, danno al corpo, se animata da grandi sentimenti, un
aspetto imponente che ispira rispetto, avvince lo spettatore e fa scomparire
l’attore nel personaggio rappresentato.
Vorrei esortare gli attori a forgiare in tempo il loro spirito con lo studio e la
contemplazione dei grand’uomini che lo sono diventati con l’amore per la
gloria e si sono elevati al di sopra degli altri a opera di queste virtù
fondamentali che comportano ammirazione e rispetto. Vorrei che non
recitassero mai una parte eroica senza aver cercato nella storia tutto ciò che
può informarli sul carattere, le virtù e le azioni dell’eroe. Anche in società
coglieranno facilmente i frutti che derivano dalla stima di sé, diventeranno
compiti affinché gli altri lo siano con loro, eviteranno di essere confidenziali
perché sapranno, secondo l’antico proverbio, che confidenza fa perder
riverenza;156 saranno rispettosi con le donne perché capiranno che il
rispetto che si porta al sesso attira benevolenza e stima. La modestia
interessa, la vanità indispone; l’una richiama l’umanità, l’altra provoca
l’odio. L’uomo modesto corre un solo pericolo, quello di passare per
timido; il presuntuoso sarà fortunato se sarà giudicato soltanto ridicolo.
Accenno ai due personaggi maschili di Racine, il primo dell’Iphigénie, il secondo della
tragedia eponima Mithridate (Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, gennaio 1673).
155 Topos ricorrente negli scritti del tempo di attori sgraziati, come Lekain, e di attrici
fisicamente poco avvincenti che erano del tutto trasformati nel loro incedere sul
palcoscenico.
156 «Familiarité engendre mépris».
154
99
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
L’amor proprio ferito non perdona mai. Non dimentichiamo questo detto
che appartiene a tutti, che è fra le verità assodate e che lo spirito dovrebbe
sempre tener presente. L’uomo più fatuo può incontrare un uomo fatuo
quanto lui e quindi cosa diventerà? Gli attori, soprattutto, devono tener
presente che quanto più sono in prima linea per la fama dei successi che
vengono loro riconosciuti, tanto più devono evitare di abbandonarsi a un
sentimento d’orgoglio che può fuorviarli perché è facile che ne siano
inebriati.
Ancor giovane e avendo fatto qualche economia, mi recai da un notaio
ricco e pieno di sé, mi presentai da lui con l’educazione e il riserbo che mi
erano abituali. Quest’uomo m’invitò a sedere in modo scioccante: Sedete,
mio caro Larive, mi disse con disinvoltura. Gli espressi l’intenzione che
avevo d’investire del denaro in un vitalizio. Fate bene, caro amico, mi
rispose, per fortuna non avete figli. Dite per disgrazia, Signore, replicai. In
fede mia, riprese con tono ancor più disinvolto, trovo che è una fortuna per
voi di non averne, perché nella vostra posizione che ne avreste fatto?
Indignato da quelle parole, lo guardai fisso e gli risposi: Signore, ne avrei
fatto dei notai. Quell’uomo fino a quel momento così a suo agio con me, si
trovò talmente stupido che non seppe cosa rispondere e da quel momento
fu tanto educato quanto poco lo era stato in precedenza.
In un periodo in cui si era immaginato di trasportare le immondizie di
Parigi nell’Île des Cygnes, ne fui informato fra i primi e temetti di essere
disturbato al Gros-Caillou dove all’epoca abitavo.157 Mi decisi a
presentarmi dal principe di Condé che poteva esserne disturbato quanto
me. Il principe era a Chantilly, mi rivolsi a un segretario che conoscevo che
si offrì di accompagnarmi da M. Michel, l’amministratore del principe: lo
seguii. Dopo aver attraversato un grande e vasto appartamento, arriviamo
in una stanza dove si trovava M. Michel: lo saluto, il segretario mi presenta
e annuncia il motivo della mia visita; quell’ometto in piedi davanti al
camino mi guarda senza rispondere al mio saluto e mi dice: Ebbene,
Signore, ripetetemi tutto, di che si tratta? Mi girai verso il segretario e gli
dissi in modo solenne: ho forse l’onore di parlare con sua signoria? No,
rispose sorpreso, sono M. Michel. M. Michel, ripetei, scriverete al vostro
padrone che si vuole impiantare all’Île des Cygnes, una cosa molto
incomoda per lui e che mi sono presentato per avere l’onore di avvertirlo.
Quell’ometto del tutto sconcertato non seppe cosa rispondermi, volle
balbettare qualche parola che non persi tempo ad ascoltare e trovai
divertente farmi riaccompagnare da lui fino all’ultima anticamera.
Il quartiere del Gros-Caillou sulla riva sinistra della Senna e dove Larive abitava dal 1781,
rue Saint-Dominique, era prospiciente all’Île des Cygnes, così denominata perché Luigi XIV
vi aveva fatto installare una colonia di cigni provenienti dalla Danimarca e dalla Svezia.
L’isola che si estendeva tra gli attuali ponti degli Invalidi e di Iena, oggi non esiste più in
quanto fu ricollegata nel 1820 alla terra ferma.
157
100
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Nei primi tempi quando mi recavo a recitare a corte,158 credei di trovare nei
grandi del regno i modelli per antonomasia di nobiltà e di dignità; li
seguivo con lo sguardo, li ascoltavo con la più scrupolosa attenzione;
supponevo che un personaggio di spicco non dovesse turbarsi se non per
cause gravissime. In questa disposizione di spirito vidi un giorno entrare
nel grande teatro di Versailles il maresciallo di D…; sembrava molto
turbato e esclamava, camminando a grandi passi: Ma come fare? che
accadrà? è un’insolenza veramente criminale; ci vendicheremo in modo
clamoroso. Io che arrivavo a corte per la terza volta e che non ero al
corrente di nulla, eccomi molto spaventato; penso che sia accaduta una
grande disgrazia, che i ministri, che la stessa maestà regale sia stata
insultata: tutto tremebondo mi avvicino al maresciallo e gli chiedo di che
cosa si tratti. Allora non siete informato, risponde, cosa accade? non
sappiamo come finiremo. Il mio spavento raddoppia e lo supplico di farmi
conoscere quell’evento increscioso. Audinot, mi dice, con le imprecazioni
che gli erano abituali, non vuole prestarci il suo tamburo per simulare il
tuono. Questa sera abbiamo bisogno di un tuono e non l’abbiamo! Mi ci
volle tutto il rispetto dovuto al rango di un maresciallo di Francia per non
scoppiare a ridere; ma non potei fare a meno di pensare che non era in quel
contesto che avrei trovato i modelli giusti per rappresentare gli eroi.
Volendo nondimeno scegliere i miei in natura, non perdevo occasione per
studiare il gran mondo e fui sempre attento a restare al mio posto per non
essere mai obbligato a indietreggiare d’un passo. Da questo studio trassi
utili risultati, non solo per la mia arte ma per la mia esperienza nel modo di
vivere. Appresi che c’è tutto da guadagnare per chi sa osservare le
conversazioni e che in genere è proprio di una mente vivace far valere lo
spirito di quelli che non ne hanno. Appresi che nelle posizioni più brillanti,
l’uomo davvero filosofo è al disopra di quanto riguarda vanità e fortuna;
cerca solo in se stesso la propria considerazione, disdegna elogi e
adulazione, non è sensibile ad alcuna piaggeria e, simile all’oro puro che si
libera nel crogiolo dagli altri metalli eterogenei, allontana da sé ciò che gli è
estraneo. Appresi che l’uomo che eccelle in un genere non può essere negli
altri che un uomo ordinario; che uno sciocco crede sempre che ciò che
ascolta valga meno di quanto pensi; che una mente ottusa non riconosce
mai un torto ed è impossibile convincerla di aver pensato male o agito
La compagnia del Théâtre-Français era tenuta a recitare a corte (i così detti voyages à la
cour) nei teatri delle regge di Fontainebleau, di Versailles o di Choisy secondo gli
spostamenti del re, in genere da novembre ad aprile secondo scadenze ben precise e con un
repertorio richiesto che non sempre corrispondeva a quello presente nello stesso momento
sul palcoscenico parigino. In linea di principio il martedì era consacrato alla tragedia, il
mercoledì all’opera, il giovedì alla commedia, il venerdì all’opéra-comique. Il numero
complessivo annuo dei voyages era superiore alla quarantina e variava a seconda delle
stagioni teatrali, comportava un dispendio notevole di energie e un costo di gestione
particolarmente oneroso.
158
101
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
male. Appresi che coloro che hanno la capacità di ammassare una grande
fortuna raramente ne fanno un uso nobile e generoso e che infine non
sempre basta esser investiti di dignità per avere dignità né di essere nobile
per agire e pensare con nobiltà.
L’attore tragico deve sforzarsi di acquisire nobiltà e dignità personali, anzi
di svilupparle, perché forse sono le cose più difficili da fingere e non c’è
altro modo di migliorare il proprio tono e le proprie maniere se non
nobilitando i propri sentimenti. Che mi sia concesso di citare qui una lettera
di Mlle Clairon: la celebre attrice acconsentì a formare la mia educazione
teatrale e mostrò nei miei confronti il più vivo interesse dirigendo il mio
talento e le mie sensazioni. Un giorno renderò pubblica questa
corrispondenza. Mlle Clairon col suo talento ispirava a teatro la più viva
ammirazione e imponeva rispetto a chi la circondava. Pensando di non
saper parlare quanto lei di nobiltà e dignità non posso far altro che lasciarla
parlare personalmente. Ecco la lettera che mi scrisse a questo proposito a
Bruxelles, dove recitavo nel 1771.159
«Sono molto lieta che sua signoria, il duca di Arenberg, vi permetta di
fargli la corte, quando arrivava e Parigi e io recitavo veniva a trovarmi nel
mio camerino e mi trattava con grande generosità. Dicono che sia altero,
ma l’ho sempre trovato solenne ed è una grande differenza; imparatela, è
utile per il vostro mestiere; la fierezza nasce sempre da un vizio del cuore e
della mente; la dignità dalla nobiltà d’animo. La prima attira quasi sempre
l’odio, la seconda impone rispetto; l’una porta al disprezzo dei nostri simili,
l’altra riconduce all’umanità; all’uomo altero accordiamo solo quanto non
possiamo rifiutare al suo rango, l’entità dei nostri riguardi è commisurata
solo al suo potere. La natura ha fatto tutti gli uomini uguali, il caso li ha resi
nobili o plebei; avvalersi del caso è tirannia o grettezza, lo si giustifica solo
forzando gli uomini ad ammettere che si è veramente degni mediante le
virtù… Ma basta su quest’argomento, sforzatevi nella parte del Glorioso di
far valere questa mia breve descrizione; siccome il personaggio è giovane e
che alla fine si pente, bisogna far sentire le due sfumature di cui vi ho
appena parlato; è altero con Pasquin, Lisette, La Fleur e Lisimon in tutto il
resto deve essere solenne.160 Mi chiederete forse come far sentire questa
differenza, con un nonnulla, o quasi nulla: finché sarete glorioso non
Il progetto di Larive di editare la corrispondenza di Mlle Clairon non ebbe seguito. Sarà
invece pubblicata su «Le Coureur des spectacles» dal 6 luglio 1846; la corrispondenza che
faceva parte della collezione di autografi di Dubrunfaut, apparve per la prima volta in
extenso a cura di Charles Maurice, direttore del quotidiano, nella rubrica «Récoltes» (qui,
martedì 7 luglio 1846).
160 Nella commedia di Philippe Nericault Destouches, Le Glorieux (18 gennaio 1732), Larive
reciterà nella parte del conte di Tufière, il Glorioso del titolo, anche all’inizio della sua
carriera teatrale alla Comédie-Française tra il 1775 e il 1778. I personaggi citati sono
rispettivamente il cameriere del conte, la cameriera d’Isabelle, il lacchè del conte e il ricco
borghese nobilitato, padre d’Isabelle e di cui è innamorato.
159
102
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
dovete aver niente di condiscendente, di affabile nel volto,
nell’atteggiamento e nella voce, valutate il vostro entourage come fango,
parlate con tono breve, brusco con gravità e misura; che la vostra risata sia
amara e sprezzante e quando avrete bisogno di essere solenne, mantenendo
l’aria il più possibile nobile, ingentilite il vostro atteggiamento, il vostro
viso e il vostro tono; il vostro entourage, per quanto a voi inferiore, è
formato da uomini, conquistateli quanto può permetterlo il vostro
carattere; come ci è dato, dobbiamo fatalmente seguirlo».
La decenza e il pudore sono sodali della dignità e del vero amore. Un
amante virtuoso, quando osa infine dichiararsi, cerca con il più gran riserbo
la propria sorte negli occhi dell’innamorata; tanto la sua dichiarazione
desta interesse quando si rivolge a un oggetto degno e casto, tanto è
ridicola se l’oggetto amato è sembrato persuaso fin dalla prima parola.
Una vecchia attrice, nel dare lezione a una giovanetta, volendo suscitare in
lei moti di dignità, di tenerezza e di disperazione, le chiese cosa avrebbe
fatto se fosse stata abbandonata dall’innamorato più caro. La giovane
allieva rispose che ne avrebbe preso un altro; andatevene, le disse, non siete
degna né di intendere né di recitare la tragedia.161
Sventurate quelle che si lasciano andare a una vita depravata, smorzando le
incantevoli sensazioni che danno fascino agli animi nobili e sensibili!
Ridatemi i miei desideri, diceva Mme Deshoulières, vi ridarò i vostri
piaceri.162 Sì, la dignità e la virtù sono tanto più necessarie per gli attori che
è impossibile raffigurarle se non le si prova. Per esprimere adeguatamente
tutte le passioni è necessaria una squisita sensibilità che la natura è ben
lungi dall’elargire a tutti; neanche si può essere buon giudice di una
passione che non si avverte. Bisogna essere sensibili per conoscere bene
ogni sfumatura della sensibilità; grave, coraggioso, nobile, generoso e
riguardoso per apprezzare e rappresentare nel modo giusto queste rare
qualità. È molto facile per un uomo virtuoso imitare i vizi di quanto non sia
a un essere depravato rappresentare bene le pure virtù che richiedono in un
certo senso un’anima nuova e un carattere vergine.
L’aneddoto figurava già in Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, A Paris, chez Vincent,
M.DCC.XLIX; Cfr.: la traduzione a cura di Edoardo Giovanni Carlotti, L’Attore, pubblicata in
AAR, anno II, n° 4, novembre 2012, cap. IV, p. 304.
162 Mme Deshoulières (Antoinette du Ligier de la Garde), 1637-1694, legata ai circoli letterari e
all’alta società parigina, fu autrice di raccolte poetiche (idilli, egloghe, elegie, canzoni)
all’epoca molto apprezzate.
161
103
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
CAPITOLO XIII
Del coraggio
Il coraggio dipende da una qualità del sangue che si rafforza, che si può
anche ottenere con l’educazione o con essa deteriorarsi; chi si diverte a
spaventare i bambini è tanto più colpevole in quanto può soffocare in loro
questa preziosa qualità. Il sangue, raffreddato dalla paura, ostruito nella
circolazione, comprime i moti del cuore e ne rallenta lo slancio. Chi è nato
coraggioso può esserlo per tutta la vita con diverse sfumature perché si
ritrova in ogni qualità e anche in ogni passione dell’anima. Il vero coraggio
ha sempre per compagne la generosità, la grandezza d’animo, l’umanità:
l’uomo può essere coraggioso solo per onore, basta il rispetto che ha di se
stesso per fargli respingere, col coraggio, ciò che potrebbe umiliarlo. Un
altro è coraggioso fino alla temerarietà, fino a quel punto di esagerazione
che si chiama spavalderia, perché ha di suo un sangue selvaggio e bollente
che circola con così tanta violenza che la minima contrarietà lo mette fuori
di sé: questo tipo di coraggio, quasi sempre accompagnato dalla brutalità, è
tanto più pericoloso per la società in quanto può esporre le persone più
tranquille a scene spiacevoli quando meno se lo aspettano. Ci sono, al
contrario, persone che hanno appena il coraggio bastante per salvarle dal
disonore; questa tipologia di coraggiosi è un po’ come quei devoti che
amano Dio solo perché hanno paura del diavolo. Il vero coraggioso può
infondere coraggio anche a chi non ne ha: ciò dipende dal sapere eccitare
l’immaginazione, esaltare la mente, riscaldare il sangue che finisce per
infiammarsi. Questi uomini diventano all’improvviso capaci di tutte le
azioni eroiche, ma passato quel momento, una volta calmati, sono proprio
loro a esserne sorpresi e cercano la forza irresistibile che ha potuto
trascinarli così lontano dalle loro abitudini naturali. L’attore deve studiare,
in ogni personaggio, tutte le sfumature che ne compongono il carattere
primitivo; a queste sfumature deve subordinare non solo la dizione, ma la
forza più o meno grande e la fermezza nei gesti, nello sguardo e nel
contegno: l’audace non ha lo sguardo di un uomo timoroso e timido, non
ne ha i gesti né il tono né l’espressione; è altrettanto deciso nell’incedere che
nei movimenti del capo, tutto il suo insieme sprigiona un’energia austera;
parla e agisce con sicurezza senza ostentazione né cedimenti: il pubblico
deve intuire, prima che parli, ciò che è capace di fare e l’interesse che può
ispirare il personaggio rappresentato dipende molto da quanto suscita
nell’entrare in scena.
L’uomo coraggioso, persino nelle sue debolezze, ha sempre la dignità che si
confà al vero coraggio e mai si permette quelle insulsaggini femminili che
sviliscono il nostro sesso e lo privano di dignità. Bisogna che l’uomo parli e
agisca da uomo, alle donne che sono degne di riguardo per le loro qualità
stimabili piacciono in genere le persone coraggiose e scelgono come amici
quelli che uniscono a una modestia cortese un vero coraggio.
104
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Molti attori credono che tenendosi impettiti, alzando il capo con insolenza e
mostrando i pugni, di esprimere il coraggio: si sbagliano di grosso. La sede
del vero coraggio, come della nobiltà, è nell’animo, non richiede gesto
alcuno. Ho visto persone dall’aria intrepida pronte a sfidare tutto e tutti
fino al momento in cui arrivavano sul terreno del duello e che al momento
decisivo diventavano vigliacchi tanto quanto prima si erano mostrati
insolenti. Ho trovato uomini esili che pur privi di spirito e di bella presenza
erano di un coraggio a tutta prova. Questa dote dipende dal sangue, dai
princìpi di onore, dalle abitudini della gioventù, è di ogni età; la forza
d’animo e di giudizio, il rispetto di se stessi appartengono ai veri
coraggiosi.
La foga della gioventù non sempre permette di distinguere il genere di
offesa che esige una vendetta sanguinosa. Molti giovani si confondono su
questo punto: in età più matura si sbaglia meno, soprattutto quando si è
data buona prova di sé.
Alla Comédie-Française, un uomo sulla cinquantina era sistemato in platea
sul primo banco del parterre. La sua enorme parrucca ostacolava la vista di
un giovane sventato che si trovava dietro di lui; dopo aver fatto molte
battute che trovarono l’approvazione del parterre, il giovane si azzardò a
tirare un ricciolo della parrucca. L’uomo anziano la rimise tranquillamente
a posto senza voltare la testa e senza dir nulla: l’insolenza di quel tipo
spiritoso, incoraggiata dal silenzio, reduplicò al punto che l’uomo
rispettabile che ne era vittima, prese la parrucca e se la mise in tasca. A quel
gesto le risa aumentarono, allora si girò freddamente e disse al giovane:
Signore, sono restato dieci anni alla Bastiglia per aver ucciso un cicisbeo
come voi e non valete la pena che rischi di tornarvi. A quelle parole
pronunciate signorilmente e a sangue freddo, il giovane restò confuso e
sconcertato e non osò rispondere: coloro che avevano riso finirono per
ammirare e rispettare il brav’uomo che avevano offeso. In generale i
giovani non hanno un’idea giusta del vero coraggio, la minima cosa che
urta la loro vanità appare come una grave offesa che va lavata col sangue.
Ho avuto la disgrazia, in gioventù, di macchiarmi di quel torto con un
uomo che godeva della stima generale. Mi permetto di raccontare quella
avventura solo perché fu di dominio pubblico e soprattutto perché
l’epilogo onora un insigne letterato.
Nel 1771, al mio primo ingresso al Théâtre-Français, de Belloy aveva dato
lettura presso Mlle Clairon della sua tragedia Pierre le Cruel:163 mi aveva
pregato di parteciparvi per farmi conoscere la tragedia e la parte che mi
avrebbe assegnato. Ma quando fu il momento di iniziare le prove e di
Pierre Laurent Buirette detto Dormont de Belloy (1727-1775), per l’esito favorevole della
sua tragedia patriottica Le Siège de Calais [L’Assedio di Calais] fu eletto nel 1770 all’Académie
française. Pietro il crudele sarà allestito alla Comédie-Française il 20 maggio 1772; Larive
sosterrà poi con successo la parte di Édouard ventidue volte tra il 1780 e il 1791.
163
105
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
distribuire le parti, non ebbi quella che mi aveva promesso, seppi che era
stata affidata a un mio cadetto.164 Divenni furioso e mi sentii disonorato,
volli provare all’autore di Gaston et Bayard che avevo nell’animo il coraggio
dei suoi eroi;165 ero persuaso che l’uomo che descriveva così bene i
coraggiosi doveva esserlo per antonomasia e mi ripromettevo uno scandalo
clamoroso. Sollecito un passaporto per l’estero, vendo una parte del
mobilio per raccogliere i cinquanta luigi di cui avevo bisogno. Attuate
queste disposizioni vado a cercare de Belloy a teatro, lo prendo in disparte
e gli propongo di sfidarci a duello come se gli proponessi una passeggiata.
Aggiungo che ho badato a tutto, che ho un passaporto e cinquanta luigi che
conto mettere da parte per servire a chi sopravvivrà di noi due. Non
dubitavo che la mia proposta sarebbe stata accettata, immaginando che
colui che aveva mostrato in scena uomini così sensibili alle questioni
d’onore avrebbe dovuto essere onoratissimo di battersi con me. In tutto ciò
non avevo considerato né la differenza d’età né la stima dovuta a un
letterato che aveva nei miei confronti l’unico torto di essersi lasciato
sedurre affidando a un altro la parte che mi aveva promesso.
De Belloy, che non si aspettava una simile proposta, apparve estremamente
sorpreso e restò per un po’ senza rispondere, dopo essersi ripreso mi disse
che aveva una madre e che non avendo potuto, come me, sistemare le sue
faccende desiderava averne il tempo, mi sembrò ovvio e gli accordai
generosamente due giorni. De Belloy avvertì il ridicolo di un duello con
uno sventato della mia età, approfittò di questo tempo e il giorno in cui
contavo sull’onore di battermi con lui, ricevetti l’ordine di lasciare
immediatamente la Francia e fui obbligato a recarmi a Bruxelles dove fui
esiliato per quattro mesi; infine Mlle Clairon ottenne che fossi richiamato. Al
ritorno fui convocato dal luogotenente di polizia che esigette la mia parola
d’onore di non parlare a de Belloy e di evitare persino d’incontrarlo.
Sono così denominati in termine teatrale, relativamente a ogni attore, quelli che sono entrati dopo
di lui nella professione; quelli che l’hanno preceduto sono i suoi «aînés» [maggiori].
165 Larive aveva partecipato alla prima rappresentazione della tragedia di Dormont de
Belloy, Gaston et Bayard (24 aprile 1771) nel ruolo di Rovere, duca d’Urbino, accanto a Lekain
che sosteneva la parte del chevalier Bayard, parte che sarà poi nel repertorio del Nostro a
partire dal 1777. L’opera fu accolta con interesse dal pubblico ed ebbe dodici repliche, essa
ha il merito, secondo Charles Collé, presente alla prima, di portare in scena un evento
riguardante la storia nazionale sulla scia dell’Adélaïde du Guesclin di Voltaire e di
rappresentarlo con naturalezza e con la necessaria verità dei fatti narrati, Journal et Mémoires
de Charles Collé sur les hommes de lettres, les ouvrages dramatiques et les événements les plus
mémorables du règne de Louis XV (1748-1772), Paris, Didot,1868, 3 voll. (vol. III, p. 315). Il
pubblico accoglierà con favore anche altre tragedie di de Belloy che figureranno
successivamente nel repertorio di Larive, quali Gabrielle de Vergy, Le Siège de Calais e Pierre le
Cruel, rappresentate con continuità fino al 1791.
164
106
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
De Belloy essendo poi venuto a conoscenza del mio successo a Lione, dove
mi ero recato da Parigi dopo il mio ritorno da Bruxelles,166 ebbe qualche
rimpianto di esser stato in gran parte causa del mio primo ritiro dal
Théâtre-Français, me lo trasmise con la lettera che qui trascrivo:
Parigi, 11 settembre 1774
Si è temuto, Signore, che mi sarei servito del credito che posso avere presso il
duca di Duras per impedire il vostro ritorno in città. Secondo ciò che mi ha
detto qualche giorno fa sull’argomento M. d’Hannetaire,167 ho pensato che il
mezzo migliore per allontanare ogni sospetto era di sollecitare personalmente
al Duca l’ordine di debutto che desiderate; l’ho richiesto ieri e l’ho ottenuto;168
guardatevi dall’essermene grato, siamo entrambi in un rapporto tale che fra
noi non ci può essere né favore né riconoscenza. Vigilerò affinché l’ordine sia
spedito il più presto possibile, il viaggio vi sarà pagato, secondo il vostro
desiderio; il duca di Duras me l’ha promesso.
De Belloy
Quando ricevetti questa lettera avevo avuto il tempo di avvertire la
ridicolaggine della mia condotta, serbai il rimpianto di aver offeso un uomo
a cui dovevo ammirazione, avevo piacere di ritornare per rimediare ai miei
torti, ma la morte strappò alla Francia quest’autore stimabile prima del mio
ritorno a Parigi.169
Nel 1773 Larive lascia il Théâtre de la Monnaie di Bruxelles e viene ingaggiato a Lione;
con lui parte anche Eugénie d’Hannetaire che finirà per sposare (il permesso del padre viene
accordato il 30 gennaio 1775).
167 Larive aveva lavorato per due anni a Bruxelles nel teatro diretto fin dal 1755 da JeanNicolas Servandoni d’Hannetaire (1719-1780). Prima attore alla Comédie-Française poi a
Bruxelles come direttore del teatro della città dove era stato invitato dal maresciallo di Saxe
ad assumerne l’incarico, d’Hannetaire era l’autore di un trattato all’epoca assai celebrato:
Observations sur l’art du Comédien, Et sur d’autres objets concernant cette profession en général.
Avec quelques Extraits de différens Auteurs & des Remarques analogues au même sujet: ouvrage
destiné à des jeunes acteurs et actrices. Par le Sieur D∗∗∗, Ancien Comédien, Paris, Société
Typographique, 17742. È interessante notare che la troupe, nella stagione teatrale 1772-1773,
conta fra i primi attori molti futuri sociétaires della Comédie-Française; oltre a Larive, infatti,
figurano a vari intervalli Grandmesnil, Dazincourt e Florence.
168 L’ordine di ripresentarsi a teatro reca la data del 15 gennaio 1775. Il secondo debutto di
Larive avviene il 29 aprile successivo nella parte di Oreste nell’Iphigénie en Tauride di
Guimond de La Touche.
169 De Belloy era morto il 5 marzo 1775.
166
107
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
OTTAVO INCONTRO
CAPITOLO XIV
Della verità
La verità ha un impero che non le può in alcun modo essere sottratto; è
fonte o compagna di ogni virtù; offre a chi procede con lei sui tortuosi
sentieri della vita un vantaggio inapprezzabile: si rappresenta in ogni
tratto, l’annuncia il suo occhio sincero, i muscoli del viso mai contratti dalla
menzogna offrono alla fisionomia la pura calma della rettitudine che fa
amare e credere a quanto dice. La sua mente è sempre in accordo col cuore,
persuade facilmente: tutto è semplice nell’espressione, nei gesti e nello
sguardo. L’attore la cui arte è in certo qual modo una continua menzogna
deve amare e cercare sempre la verità, è lei che il pubblico, almeno quello
formato dalle persone colte, sembra soprattutto prediligere. Meno la si
incontra in società più sembriamo cercarla avidamente nelle
rappresentazioni teatrali. La verità parla al cuore e all’anima; la menzogna
seduce la mente, ma non convince. L’arte imita i fiori, la vista può
ingannarsi per un istante, ma il tatto e l’odorato vengono in suo aiuto e
l’illusione una volta dileguata non torna più. La menzogna impiega ogni
risorsa dell’arte per imitare la verità, ma non può sostenere lo sguardo
osservatore che la persegue e la scopre. I colori che l’arte presta al viso non
avranno mai il puro fulgore della semplice natura.
Tutti gli sforzi impiegati per rimediare all’irreparabile oltraggio degli anni
sono senza successo; s’inganna solo per un momento un difetto nella
corporatura, nascosto dall’arte; disturba l’insieme della persona e si fa
sentire, per così dire, nei gesti e nel modo di essere. Ciò che comprime il
corpo ostacola la voce e la snatura; e l’attore così oppresso non può
permettersi quell’abbandono talmente necessario per esprimere le passioni,
facendo intuire, proprio con i suoi sforzi, i difetti che vuole nascondere.
Divina verità, il tuo impero dovrebbe estendersi all’intero globo! Tu sola
dovresti governare l’universo! La tua forza, la tua energia, la tua
persuasione, che fanno impallidire la menzogna, dovrebbero bandirla per
sempre. Ti si ama e ti si teme. Vorremmo trovarti negli uomini, ma sembra
che siano ridotti a nasconderti, a rinchiuderti in loro. Eviti le città, il sereno
soggiorno della campagna ti possiede ancora in tutta la sua purezza. Io, tuo
fedele amante, stanco di cercarti invano tra gli uomini, vivo con te nei
boschi dove il cuore e gli occhi godono liberamente delle tue bellezze,
perché la natura è sincera. Che l’interroghi, l’esamini nella sua produzione,
la foglia di un albero mi dice il suo nome e le sue qualità; il sapore di un
frutto avverte il mio palato e lo informa senza ingannarlo; e per conoscere
un fiore senza nominarlo, mi basta respirarne il profumo e ammirarne lo
splendore. Con la natura il mio spirito non è mai preoccupato di scoprire la
verità: si offre spontaneamente ai miei occhi e al mio cuore. Felice e sereno
108
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
assaporo l’incanto di una vita pura mai turbata dal rimorso: il canto degli
uccelli che mi circondano è sempre sincero, l’udito m’insegna a riconoscerli
senza difficoltà. Distinguo, al primo gorgheggio l’usignolo dalla capinera, il
ciuffolotto dal fanello e il lieve tordo dal pesante corvo: non rischio mai di
confondere l’uccello da preda con l’innocente tortora.
La verità mi circonda, mi segue, m’incanta continuamente nel mio delizioso
rifugio;170 solo con me stesso senza calcolo né costrizioni godo di una
felicità che mai menzogna o adulazione avranno il diritto di turbare; i miei
passi non si perdono sulle tracce dei malvagi; la natura provvidenziale mi
riempie di favori: gli alberi che ho piantato mi crescono sotto gli occhi e si
premurano di testimoniare la loro riconoscenza offrendomi i loro frutti…
Ma dove mi fanno smarrire queste seducenti fantasticherie? Quale il
rapporto tra il mio rifugio campestre e la tragedia di cui devo parlare? Il
mio proposito è di contribuire a creare attori e non agricoltori o pastori. La
verità dei campi non ha nessun rapporto con quella delle passioni.
Lasciamo il mio giardino dove non avrei dovuto addentrarmi e torniamo al
teatro e in società che ne è la vera scuola.
Il pubblico, sempre esigente e che ha diritto di esserlo, vuole sempre la
verità. Se l’impressione prodotta dall’arte è troppo forte, essa urta,
scoraggia e l’effetto viene meno; lo scopo della tragedia è di commuovere e
di suscitare nell’animo emozioni vere. Lo scopo è raggiunto quando lo
spettatore è talmente commosso che dimentica se stesso, preso interamente
dall’azione rappresentata e si crede trasportato ad Atene o a Roma con la
magia del talento e la verità della recitazione. Senza verità nulla
commuove, nulla interessa, nulla può fare illusione. Il mezzo più sicuro per
raggiungere la verità a teatro è ancora nella vita privata dell’attore, se vuole
bandire la menzogna, essere sempre vero in società, lo sarà senza sforzo in
scena. Ma per essere accettata in società, la verità ha bisogno di alcune
precauzioni che solo possono essere apprese dall’uso; dovrebbe risplendere
in ugual maniera per tutti gli uomini: se ciascuno la volesse per sé
avremmo orrore della menzogna, l’adulazione sarebbe bandita dalla terra e
gli uomini non sarebbero mai ingannati. Ho dovuto il mio scarso talento
solo alle verità che mi sono state dette, ne ho talmente avvertito il
vantaggio che la sollecitavo continuamente, se a volte è dura, è sempre
utile. Simile al sole, illumina e purifica le nebbie in cui la vanità ci avvolge.
Nel 1792 Larive aveva acquistato nel luogo detto «Les Brosses» un bosco ceduo, bene
nazionale appartenuto ai Mathurins di Montmorency, aumentando così la superficie dei
terreni da lui posseduti nella circoscrizione di Pontoise dall’inizio del 1791 e già proprietà
dei canonici della Sainte-Chapelle di Vincennes. Montlignon, situato ai bordi della foresta di
Montmorency, nella vallata di Eaubonne, costituirà il Buen Retiro di Larive probabilmente
già a partire dal 1794. Circondata da un grande parco, la costruzione, posta in una
situazione elevata, ricalca l’aspetto delle dimore signorili di fine Settecento; era stata
successivamente abbellita da un laghetto artificiale con ponticelli e cascatelle (Cfr.: Mme Jean
Delbée, Histoire de Montlignon, Paris, Société Française d’Impression, 1914).
170
109
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Fin dall’infanzia l’ho scelta per guida nei miei studi e in ogni azione della
mia vita. Non nascondo il numero di nemici che mi ha procurato né
rimpiango nessuno di quelli che ho allontanato da me, non erano fatti per
essere miei amici. La vera amicizia è come la probità, trae origine dalla
verità; entrambe sono sorelle.
L’uomo vero ha, nello sguardo e nella parola, un abbandono senza
reticenze che l’uomo falso non può imitare; il primo parla e ascolta solo col
cuore, il secondo solo con la mente: le risposte della mente sono lente e
spesso oscure, quelle del cuore chiare quanto rapide. La verità non piace
soprattutto perché è rara, se diventasse più comune quelli che meno
l’amano sarebbero obbligati a perdonarla.
La vostra pièce non è bella, dicevo un giorno a un autore che mi chiedeva la
verità, cadrà platealmente, si trascinerà per cinque o sei rappresentazioni.
Se ne fossi convinto, mi rispose stizzito, darei subito alle fiamme il mio
manoscritto. La pièce ebbe il destino che avevo annunciato, da allora
l’autore non mi ha più parlato, è anzi diventato un nemico. Ho conosciuto
autori così persuasi della bontà delle loro opere che preferivano credere che
il pubblico fosse privo di gusto e di buon senso piuttosto che i loro testi
senza merito. Questo mi ricorda ciò che successe con l’autore di Les
Arsacides, tragedia in sei atti, che fu recitata nel 1775.171 La pièce era
scadente. Avevo una parte lunga e molto ingrata, era la prima che mi era
affidata in un’opera inedita. I miei compagni non avevano sul testo
un’opinione migliore della mia e si permettevano, alle prove, di ridere alle
spalle della pièce e dell’autore: questi m’intrigò per il suo aspetto onesto,
l’età avanzata e la cieca fiducia nel suo lavoro. Non ebbi timore di parlargli
apertamente e gli dissi ingenuamente:
«Signore avete un’aria rispettabile e vedo con apprensione che la vostra
pièce vi procurerà un gran dolore. I miei compagni non osano dirvelo, ma
io che sono più sincero vi prevengo che è impossibile che possa avere
successo e oso pregarvi, in nome della vostra età e della mia giovinezza, di
ritirarla prima di un tonfo: non può che fare gran torto a entrambi, a voi
come autore e a me come attore: è la vostra prima pièce ad andare in scena
ed è la prima parte che creo; la nostra gloria come la nostra vergogna sono
comuni e cadremo entrambi in modo umiliante». A questo discorso, privo
d’artificio, l’autore si tolse gli occhiali e mi disse freddamente: «Signore,
siete giovane e non ancora in grado di apprezzare tutte le bellezze della
mia tragedia: non eravate ancora nato che la mia fama già correva tra i veri
intenditori e gli uomini di gusto. Sappiate che non mi si può fare
un’osservazione alla quale non possa rispondere, aprendo un tiretto dove ci
sono tutte; la vostra parte vi coprirà di gloria e dovete esser felice della
Nella tragedia Gli Arsacidi di Peyraud de Beaussol (26 luglio 1775) Larive recita nella sua
prima creazione originale nella parte di Tigrane, principe dei re d’Armenia; dopo la replica
del 29 viene ritirata dalle scene.
171
110
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
fiducia che vi ho testimoniato nell’affidarvela». Si rimise gli occhiali e la
prova continuò. La pièce fu recitata al suono dei fischi tranne una sola
scena che ricevé molti applausi; per farla breve, continuò tra burrasche e
frastuono e arrivò alla fine solo grazie a un gran sipario che doveva aprirsi
alla fine del sesto atto e che stuzzicò la curiosità del pubblico.
L’autore era così persuaso del merito della sua pièce che ci costrinse a
recitarla una seconda volta dicendo che un’opera di tale importanza non
poteva essere veramente recepita che alla ventesima rappresentazione.
Spaventati da questa minaccia decidemmo di ritirarla, dandogli cinquanta
luigi.
Erano trascorsi fra i dodici e i quattordici anni senza che sentissi parlare di
lui e della sua pièce, quando un mattino vidi arrivare a casa mia un uomo
alto e vecchissimo che non riconobbi. Mi annunciò che doveva parlarmi di
un affare molto importante. Gli offrii da sedere e accettò. Ne ho bisogno,
disse, vengo a piedi dalla rue des Postes dove vivo ritirato dal mondo. Ho
saputo per caso che il Théâtre-Français è in cattive acque in mancanza di
novità degne di attirare il pubblico. Ho trovato il mezzo di farvi
guadagnare cinquantamila scudi in poco tempo. Signore, gli dissi, ci fareste
onore e piacere. Lo credo bene, mi rispose, prestatemi attenzione e sarete
convinto della verità che vi dico. Ascolto. Signore, sono Peyraud de
Beaussol, autore della tragedia degli Arsacidi, in cui avevate recitato una
parte che ha fatto la vostra reputazione. La mia pièce non è restata nel
repertorio per mancanza di sviluppo, ho scritto un settimo atto che era
necessario alla sua perfezione. Portate questa notizia ai vostri colleghi,
saranno, credo, incantati quanto sorpresi del felice soccorso che ho il
piacere di procurar loro. Lo ringraziai molto e lo riaccompagnai,
assicurandolo della mia riconoscenza e di quella dei miei compagni, non
osando né potendo dire di più a un vecchio al quale restava ancora una
chimera da accarezzare. Quegli anni in più mi avevano insegnato che se
non si deve mai alterare la verità, non è sempre opportuno proclamarla.
111
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
CAPITOLO XV
Del cuore buono e del cuore malvagio e delle sfumature di entrambi
Il cuore è la sorgente di tutte le affezioni morali. Da lui provengono le
grandi virtù e i grandi vizi. Gli attori devono essenzialmente sforzarsi di
conoscere, di penetrarne i segreti, di distinguere le sfumature che
diversificano tra loro i cuori quanto le fisionomie.
Il migliore fra tutti è colui che è sempre sensibile agli altri e che trova solo
nel bene un incentivo alla sua attività. La sua felicità consiste in quella che
procura: felice con chi è felice, con gli sventurati lo diventa per la
compassione affettuosa. Per quanti siano i privilegi che un uomo dotato di
buon cuore abbia dalla fortuna non può goderne se non condividendoli; il
piacere che irradia attorno a sé lo rende più ricco per ciò che dona piuttosto
che per ciò che gli rimane.
Ben diverso è il cuore dell’egoista. Sì, l’egoista si rallegra delle disgrazie che
non gli capitano; s’intristisce per una felicità che non gli appartiene,
riferisce tutto a se stesso. Se compie una buona azione calcola solo l’onore
che deve procurargli, se regala qualche cosa è perché è convinto che questa
cosa è per lui inutile e che non può trarne vantaggio se non regalandola.
L’individuo suscettibile ha un cuore inquieto: continuamente attento a
quanto si dice, crede sempre che si parli di lui, diventa ridicolo proprio per
paura di esserlo. Le cose più semplici, sviscerate dalla sua immaginazione,
gli appaiono gravi e serie: dappertutto vede cattive intenzioni, non
riconosce le persone ottuse e pensa che esistano solo spiriti furbi.
Il cuore più pericoloso è quello incapace di un affetto profondo: sempre
passivo, è tanto più da temere che cede in egual misura a qualsiasi
impressione e non si fissa su nessuna. Amico di tutti senza esserlo di
nessuno sembra credere a quanto si dice, ma di fatto non presta né
attenzione né fiducia a nulla. Fa tanto più male perché pensa che le sue
azioni non siano più sensibili agli altri di quanto non lo sono a se stesso.
L’attore deve sforzarsi di conoscere tutte queste sfumature e di
approfondirle, non solo nelle parti che gli sono affidate, ma anche in quelle
presenti nella pièce in cui recita. Solo questo studio può dare intensità al
suo talento: deve essere quello di tutta la vita: da esso dipende la verità
senza la quale, lo ripeto, non esiste talento drammatico.
L’attore, perennemente osservatore, deve cogliere i caratteri dappertutto e
trarli dalla natura stessa.
A volte basta una sola parola per scoprirli malgrado il triplice involucro di
cui si ammantano. Nei primi anni della mia presenza alla ComédieFrançaise, fui invitato a cena da un gran signore che mi trattò con bontà.
Tutto da lui mi sembrò effondere lusso e abbondanza. Alla fine della cena
scomparve e tornò poco dopo con in mano un pacchettino. Tenete, mio caro
Larive, disse offrendomelo, ne trarrete vantaggio. Gettai lo sguardo sul
pacchetto e mi accorsi che si trattava di spezzoni di ricamo. Non osando
112
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
rifiutare li accettai per pura educazione. Ritornando a casa, esaminai il
ricamo e lo trovai in così cattivo stato che non avrei esitato a gettarlo nel
fuoco se non avessi temuto di apparire poco riconoscente per il regalo e di
far dispiacere all’autore. Presi una decisione migliore, incaricai il mio
ricamatore di servirsene su un abito e di fare ciò che era necessario per
renderlo elegante e piacente: spendendo parecchi soldi, la cosa riuscì a
meraviglia. Quando un giorno quel signore mi fece l’onore di venire da me,
pensai doverlo a mia volta ossequiare per il suo ricamo. Senza parlarne gli
presentai l’abito e lo pregai di dirmi cosa ne pensasse. Gli sembrò
incantevole, elegantissimo e del gusto più squisito. Siccome non cessava nei
complimenti, come, gli dissi, Signore, non riconoscete il ricamo che mi
avete regalato! Sorpreso da quanto sente, riporta lo sguardo sull’abito
esclamando: «Eh! mi avevano detto che non se ne poteva far niente!». Feci
un gesto che non gli sfuggì. Riprese immediatamente un sorriso affabile e
mi disse che era felice che ne avessi tratto un così buon partito, ma credei
più alla prima reazione che alle sue ultime parole e al suo sorriso.
Se avessi dovuto recitare il Faux Généreux dopo questa scena, gli avrei dato,
ne sono sicuro, un grado di verità che non avrei potuto raggiungere in
precedenza.172
Gli attori devono insomma osservare di continuo e cercare di cogliere tutti i
caratteri, tutte le sfumature che distinguono il vero e il falso, i cuori buoni e
i cattivi; una parola, uno sguardo, il movimento dei muscoli, tutto è
interessante: bisogna studiare e conoscere ogni cosa. Questo studio è
necessario a tutti gli uomini, ma ancora più essenziale a coloro i quali per
condizione sono deputati a presentare l’uomo all’uomo. Lo spirito buono
nasce da un cuore buono, da uno cattivo provengono i difetti e i vizi. Cuore
e spirito hanno, come il corpo, la loro infanzia; l’educazione dell’uno si
compie con quella dell’altro, il corpo e lo spirito invecchiano, solo il cuore
no.
172
Il Falso generoso, commedia in versi di Antoine Bret (18 gennaio 1758).
113
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
NONO INCONTRO
CAPITOLO XVI
Della gelosia
La gelosia è una febbre ardente che divora il cuore, sconvolge mente e
corpo, è la malattia in assoluto più funesta, trascina a ogni eccesso e
disturba talmente l’organizzazione fisica e morale che ogni cosa appare
nell’immaginazione di chi ne è colpito in modo opposto alla verità.
L’occhio vede fantasmi senza realtà, l’udito sente cose che non vengono
dette; il geloso non riposa mai, il sonno lo fugge, è avvolto in una tetra
malinconia: insopportabile a quanto lo circonda, lo diventa a se stesso; tutte
le virtù lo abbandonano, solo le furie lo ispirano, finisce per detestare la
persona che adorava, e la società e la solitudine e la vita.
L’attore che non ha mai provato la gelosia potrà difficilmente esprimerla in
modo veritiero, deve allora studiarla attentamente negli altri. I sintomi non
sono ambigui: si rivela nella voce, nello sguardo, nei muscoli, nello
sconvolgimento delle idee; nasce con noi, cresce, si sviluppa con i nostri
gusti, si combina con le altre passioni e per una particolare fatalità non può
essere corretta con l’educazione. Né la mente né il buon senso fanno presa
su di lei; assorbe tutte le sensazioni e tutte le facoltà dell’uomo. Anche gli
animali vi si abbandonano con tanta violenza che sono portati ad
autodistruggersi ed è quasi la sola passione che li renda crudeli quanto noi
verso la propria specie.
C’è una gelosia gentile che non presenta nessuno di questi orribili caratteri,
non tormenta l’oggetto amato, ma si limita a vigilare perennemente su di
lui con amabilità e delicatezza; essa deriva dalla mancanza di fiducia in se
stessi, rende più affettuosi e a volte più premurosi. La fiducia e la stima
bastano per guarire quanto ci potrebbe essere di sgradevole nella gelosia di
questa natura.
Non è soltanto in amore che la gelosia esercita il suo impero; tutti gli
uomini che hanno l’animo nobile e che la natura ha creato perché abbiano
successo in qualsiasi professione, portano innata nel cuore una gelosia
nobile che si chiama allora emulazione. C’è invece una gelosia bassa e
degradante che appartiene ai malnati e male educati e che fa loro vedere
con dolore negli altri tutto ciò che non hanno: questa bassa gelosia, che
viene chiamata più comunemente invidia, è inutile da conoscere per l’attore
tragico.
In genere la gelosia assume il carattere dell’individuo che ne è colpito: chi è
nato crudele avrà una gelosia atroce e suscettibile dei più grandi timori;
Atreo ne è la prova.173
173 Nella tragedia di Crébillon, Atrée et Thyeste (14 marzo 1707), Atreo, per vendicarsi del
fratello Tieste, gli uccide il figlio e gli porge da bere una coppa col suo sangue.
114
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Se Tito è geloso, Tito è innamorato.174
Questo verso prova che non c’è amore senza gelosia. Orosmane è geloso al
punto d’immolare Zaïre. Solo un eccesso d’amore può scusare lo
smarrimento che lo porta a commettere quel crimine. Ci si ricorda che è
stato oggetto di una pubblica controversia;175 alcuni lettori hanno accusato
Orosmane, ma alcune lettrici lo hanno difeso. Il delirio di
un’immaginazione sconvolta dall’amore geloso può infatti scusare un
crimine a teatro.
Fayel in Gabrielle de Vergy osa presentare alla sua vittima il cuore di Coucy,
appena immolato alla sua gelosia.176 Quando me ne fu affidata la parte, mi
fece orrore e non vidi dapprima che la catastrofe e considerai Fayel come
un tiranno abominevole che il pubblico mai avrebbe potuto accettare, ma
studiando i dettagli della parte capii con quale arte era stata indotta e
motivata la sua orribile vendetta. Fayel ama la moglie fino all’idolatria:
come sposo ha il diritto di non accettare presso di lei nessuno dei rivali e
quindi quello di essere indignato nel trovare in casa propria l’innamorato
amato dalla moglie. Cerchiamo di essere, dissi fra me, il marito più
innamorato e più amorevole, cerchiamo di esprimere quest’amore con ogni
attrattiva, facciamo in modo che il pubblico possa compatirmi e interessarsi
alla mia situazione; allora vedrà Coucy come un giovane imprudente che
viene a turbare la felicità di uno sposo sensibile, di uno sposo unicamente
assorbito nel fare quanto suggerito dalla tenerezza per piacere all’oggetto
della sua passione. Questo mezzo mi è riuscito, solo lui ha potuto far
sopportare l’orribile scioglimento. La disperazione di Fayel alla fine della
pièce, la verità dei rimorsi l’hanno fatto compatire in ragione della forza del
sentimento sviluppato nel corso della pièce; e quello che più mi persuade
sull’esattezza delle mie osservazioni su questa parte, è che la tragedia ebbe
allora un gran successo e un lungo periodo di rappresentazioni177 e che
essendo in seguito riproposta a teatro, è stata vista con orrore, forse per
colpa degli attori che hanno recitato Fayel come un tiranno feroce e che si
sono preoccupati più di mostrare un marito duro e despota che si vendica,
«Si Titus est jaloux, Titus est amoureux», ultimo verso della tirata di Berenice che chiude
il secondo atto (scena 5, v. 666) dalla tragedia di Bérénice [Berenice] di Racine, Théâtre de
l’Hôtel de Bourgogne, 21 novembre 1670.
175 Nel «Journal de Paris», circa quindici anni fa.
176 Tragedia di Dormont de Belloy (12 luglio 1777), la scena del quinto atto aveva provocato
una sensazione orribile, Gabrielle quando prende in mano la coppa fatale in cui crede di
trovare il veleno vi scorge invece il cuore insanguinato dell’amante.
177 Le dodici repliche del 1777 erano state seguite da una grande affluenza di pubblico
attratto dalla terribilità dello scioglimento che costituiva nel suo orrore una sorta di
richiamo; la stampa dell’epoca se ne fece l’eco; piaceva anche la suggestione del
«dénouement en action», tanto più incisivo rispetto agli immancabili récits.
174
115
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
piuttosto che un marito affettuoso, innamorato, profondamente sensibile,
trascinato dalla disperazione nel furore di un amore offeso.
La cosa più preziosa da osservare a teatro è la verità dei caratteri; è la verità
a inquadrare, in un certo senso, le opere, che ne trasmette e distribuisce
l’interesse nelle giuste proporzioni, che valorizza ogni parte in se stessa o in
opposizione con le altre. Non appena gli attori se ne allontanano, il
pubblico tradito da loro si smarrisce con loro e, invece di vedere una bella
rappresentazione nel suo insieme, non vede che un solo aspetto dell’intera
pièce. Oserei sostenere che l’arte si è persa da quando sono state
dimenticate le passate tradizioni. L’antica Comédie-Française era così
severa su questo punto importante che la compagnia nel suo insieme
redarguiva severamente chi si allontanava dalla strada tracciata dagli
autori. Si potrebbe aggiungere, è vero, che le opere che non appartengono
ai nostri grandi maestri sono ben lontane da quell’intensità di concezione
che scandagliava ogni carattere e dava a tutti una coloritura così marcata
che mai si sarebbe potuto confondere un personaggio con un altro. Per
limitarmi alla passione che costituisce l’argomento di questo capitolo, la
gelosia di Tancredi e quella di Orosmane sono ben differenti benché siano
entrambi gelosi. Quella di Tancredi è velata da una sensibilità malinconica
che gli attira tutti i cuori e lo fa compatire tanto quanto è amato; quella di
Orosmane conserva le tracce del carattere di un despota che non è abituato
alla sventura, che si sovviene a ogni istante della sua possanza pur
rinunciandoci per piacere e ha avuto il merito di innalzare fino a lui una
schiava. Colto d’indignazione quando si crede ingannato, la sua gelosia è
costituita da sensibilità, orgoglio e furore; può abbandonarsi a scoppi che
sarebbero deprecabili in Tancredi. Ecco quanto gli attori dovrebbero
osservare piuttosto che abbandonarsi in tutte le parti di geloso alla stessa
gelosia e allo stesso furore.
116
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
CAPITOLO XVII
Dell’imitazione servile, dell’affettazione e della maniera
Il gusto dell’imitazione è innato nell’uomo, costituisce la prima inclinazione
che appare in lui fin dalla più tenera infanzia. Prima di articolare le parole,
il bambino imita le grida degli animali che conosce, via via che avanza in
età copia quanto lo circonda, camminando, salutando, nel modo di porsi e
di parlare, il giovane imita l’uomo fatto. Non c’è nessuno che non voglia
imitare il talento che più predilige, fare ciò che si è visto fare è la prima
scuola in tutte le arti, tutto s’impara all’inizio con l’imitazione, soltanto i
grandi talenti sanno liberarsene, ma è permesso unicamente a quelli che
hanno il genio della loro arte di arrivarci con successo e siccome questo
genio è rarissimo ci sono pochissimi artisti che si lanciano in modo felice
fuori dalla strada comune.
La cosa più spiacevole per i talenti è che ognuno si crede in diritto di
giudicarli e siccome pochissimi fra questi pretesi giudici sanno distinguere
il vero bello, l’artista più perfetto viene a lungo criticato prima di godere
della gloria: lo è, e dagli ignoranti e dagli intenditori, perché la critica nasce
proprio con il progredire del talento. Si desidera in ragione della
sensazione che si prova. E perché una cosa è bella la si vuole perfetta, la
minima mancanza colpisce tanto più l’osservatore se è circondata da
bellezze. L’artista che ogni giorno fa un passo verso la perfezione, non ci
può arrivare se non con molto impegno, riflessione e tempo. Ma il pubblico
frettoloso vuol godere in quel momento: decide, condanna e l’artista, che si
era lusingato di soddisfarlo, è a volte scoraggiato dalla critica. Se lo
sconforto s’impossessa di lui, tutto è perso, il talento svanisce.
Gli artisti devono imparare a difendersi da queste amarezze e custodire in
loro quella nobile emulazione permessa a chi sente ciò che vale. Tanto è
dannoso lo stupido orgoglio, quanto è necessaria l’autostima, e quando si
ha la fortuna di sentirsi ben inspirato, bisogna calpestare le vecchie pratiche
e le usanze abituali che sono destinate a quelli che la natura condanna a
una mediocrità insanabile.
L’imitazione servile è più comune a teatro che in qualsiasi altra arte. Si è
impressionati dagli effetti di un grande talento: è stato applaudito in questo
e quel punto, lo si vuole essere parimenti; ci si sforza di cogliere le sue
intonazioni e ci si crede eredi del suo talento nel prenderne le inflessioni e i
gesti. Quest’errore costituisce la perdita di molti giovani destinati a riuscire
per se stessi se non si fossero imposti questa imitazione servile. Si vede che
tutto il loro lavoro consiste nell’ascoltarsi e che sono soddisfatti quando la
loro memoria fedele rende alle loro orecchie i suoni che hanno registrato.
Una cosa assai divertente mi nauseò dell’imitazione quando cominciai a
recitare. A Tours, l’attore che interpretava le prime parti aveva un bel fisico
e un volto seducente, si muoveva sul palcoscenico con estrema
disinvoltura, si concedeva familiarità che con altri non avrebbero avuto
117
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
successo, per esempio lanciava il cappello dalla mano destra sotto il braccio
sinistro con tanta abilità che il cappello si trovava sotto il suo braccio come
se fosse sparito. Mi sembrò una cosa suggestiva, anch’io volli lanciare il
mio cappello sotto il braccio, trascorsi un giorno intero a questo bel
esercizio. Quando credei di essere sicuro del fatto mio, volli cogliere il
frutto del mio studio. Lui recitava l’Uomo del giorno e io il Marchese.178 In
una scena in cui eravamo insieme lanciò il cappello sotto il braccio,
pronunciando il secondo di questi due versi:
Da nessuna impressione il suo animo è emozionato,
E presto sposerò una bella statua.179
Mi sembrò il
rispondendogli:
momento
favorevole
per
lanciare
anche
il
mio,
Il tempo e le vostre lezioni le insegneranno a pensare.180
Ma lo feci con tale veemenza che il cappello, passandomi sotto il braccio
andò a cadere dietro le quinte. Il pubblico scoppiò a ridere e il mio modello
e io restammo molto imbarazzati, io per aver mancato il colpo, lui per l’idea
che lo avessi preso in giro. Si sbagliava, ma il pubblico, che fino ad allora
aveva applaudito la sparizione del cappello, non poté più vederla senza
ridere e l’autore di quel gioco di destrezza fu costretto a sopprimerlo. Da
quel momento non mi azzardai più a copiare nessuno e riconobbi che se
una cosa va bene per uno non è detto che vada bene per un altro. La natura
vuole che ciascuno si serva dei mezzi che gli sono stati dati. L’imitazione
dell’accento, della dizione, del gesto, dell’atteggiamento corporeo distrugge
il vero talento. Esorto tutti i giovani attori a guardarsene e ad avversare
quella facilità naturale all’imitazione, caratteristica della loro età.
Talora i grandi attori imitano in un certo senso se stessi. Nel vederli solo
una volta in una parte si riconoscono ovunque le stesse intonazioni, la
stessa azione muta, gli stessi gesti. Hanno preso loro stessi per modello,
hanno per così dire fissato l’ispirazione a forza d’arte. Tutti sono d’accordo
nel dire che Mlle Dangeville era la servetta più perfetta e più vivace mai
vista, ebbene, ciò che faceva una volta in una parte, lo faceva ogni volta alla
stessa maniera, al medesimo momento ed era sempre perfettamente
piacevole, la grazia, la naturalezza e la finezza della sua recitazione
Les Dehors trompeurs ou l’Homme du jour, commedia in cinque atti, in versi, di Louis de
Boissy (18 febbraio 1740) [Gli esteriori ingannevoli o l’uomo del giorno].
179 Battuta del Barone: «D’aucune impression son âme n’est émue, / Et je vais épouser une
belle statue», atto I, scena 7.
180 Battuta in risposta del Marchese: «Le temps et vos leçons l’apprendront à penser», Ivi.
178
118
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
apparivano al pubblico sempre nuove.181 Sembrava aver riunito ogni
perfezione e averle distribuite nelle parti del suo ruolo in modo che,
cambiandole, si trasformava di continuo e recitando la stessa si
rassomigliava sempre, e cioè ritrovava sempre, a piacere le stesse
perfezioni e gli stessi abbellimenti. Bisogna ammettere che il genere comico
ha più sfumature e più varietà del tragico. Checché si dica, è più facile
essere piacevole che veramente perentorio e patetico. I muscoli che servono
per esprimere la gaiezza sono flessibili, si muovono più facilmente di quelli
delle passioni tragiche che si mettono in moto solo quando l’anima ha
ricevuto emozioni profonde. Per piacere non bisogna neanche contare
troppo sul fascino ricevuto dalla natura, non bisogna soprattutto lasciar
trapelare che vi si fa affidamento. Non appena il pubblico scopre in un
attore questa certezza, gli contesta ogni privilegio e gli toglie il consenso.
Dalla preoccupazione sui propri mezzi naturali scaturiscono la maniera e
l’affettazione, queste li corrompono e li alterano, imbruttirebbero il più bel
volto e renderebbero insopportabili i doni più preziosi.
L’affettazione e la maniera, avendo solitamente una sede particolare nei
tratti o nell’atteggiamento del corpo, disturbano talmente l’insieme che
nulla va d’accordo in chi vuole così forzare la natura. Se avete gli occhi
grandi e se volete farli apparire ancora più grandi fingendo di spalancarli,
togliete loro espressione e grazia; diventano duri e stravolti. Non è
sforzandosi di tenersi dritti che si appare più alti, la rigidità toglie al corpo
quei movimenti aggraziati e semplici che caratterizzano la vera nobiltà, e
come dice Rousseau non c’è grazia senza spontaneità.182 Un pittore nel ritrarre
una donna che si sforzava di contrarre la bocca per farla apparire molto
piccola, fece bene a dirle: «Non datevi pena, Signora, se solo lo desiderate
non ve la farò proprio». Mi ricordo di aver recitato con una giovane attrice
che, per nascondere la sua estrema pinguedine, si era talmente stretta che,
volendo congiungere le mani in uno dei momenti più patetici della pièce,
nelle vesti avvenne uno strano scompiglio; la scena da tragica si fece
all’istante una delle più risibili. Ne restai sconcertato e tale fu la confusione
della giovane attrice che fummo obbligati a sospendere la pièce.
Nel momento in cui il pubblico avvinto è concentrato nell’azione, il minimo
incidente di questo tipo può distruggere l’illusione che prova. Quest’effetto
è reso tanto più forte in quanto imprevisto ed estraneo a quanto avviene.
Una Galatea, nel Pygmalion in cui recitavo con lei, starnutì nel momento più
critico della scena: fu impossibile continuare e la pièce non fu portata a
termine.
181 Marie-Anne Botot, detta Mlle Dangeville (1714-1796), figlia d’arte, aveva debuttato alla
Comédie-Française a soli quindici anni ed era stata ammessa nel ruolo delle servette nel
marzo 1730. Ammirata da Voltaire e da Garrick reciterà con successo fino al 1763 anche in
ruoli dal registro drammatico.
182 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation [Emilio o Dell’educazione] 1762, libro V: «La
grâce ne va point sans l’aisance».
119
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Ma si tratta di incidenti, e devo esortare il giovani allievi di Talia e di
Melpomene a correggersi dei loro difetti o a non contrarne. Li invito
soprattutto a non imitare quegli attori che si tormentano e che restano
senza fiato per trascinare lo spettatore a furia di convulsioni e sforzi. Più ci
si stanca, più si stancano gli altri. Ciò che proviene dalla testa impressiona
solo la testa, ciò che proviene dal cuore va diritto al cuore. Immedesimatevi
in ciò che dite, esprimetevi senza sforzi, il pubblico si delizierà senza pena e
avrete, con meno della metà di fatica, un successo doppio.
120
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
DECIMO INCONTRO
CAPITOLO XVIII
Delle sfumature e delle opposizioni
Per rendere fedelmente i grandi caratteri come quelli di Augusto, di
Mitridate, ecc., li si devono studiare, intuire e non sbagliarsi sulle
sfumature che li contraddistinguono. Augusto in Cinna è nel novero di quei
caratteri per eccellenza che hanno rimosso qualsiasi passione e offrono,
sotto ogni aspetto, solo la vera grandezza d’animo.183 Mitridate deve essere
incluso tra quelli che riferiscono tutto a loro stessi e che non sanno amare
od odiare se non in ragione del loro interesse personale.
Sfumature molto evidenti distinguono Fedra da Semiramide sebbene la
loro situazione sembri offrire alcune analogie: un’attrice deve guardarsi dal
confonderle. Fedra, entrando in scena, arde d’amore ma senza rimpianti e
senza crimine; il potere di Venere onnipotente l’attira verso Ippolito. Lo
sposo è da tempo assente e dubita che sia ancora in vita, la passione che
prova ha dunque una specie di scusa: soffre, geme, non è criminale. È,
come ha scritto Boileau:
Il dolore virtuoso
Di Fedra, suo malgrado perfida, incestuosa.184
Solo nell’istante in cui il suo amore ha perso ogni illusione e speranza,
Enone la trascina nel crimine.185 Morendo colpevole, ispira ancora interesse
per la verità dei rimorsi e della confessione e per l’dea di un potere
superiore, della fatalità che suo malgrado l’ha travolta. Semiramide invece,
colpevole della morte dello sposo, criminale per il suo debole nei confronti
di Assur, deve mostrare, comparendo in scena, una fisionomia ben
differente: deve esservi espresso il rimorso, il suo carattere politico serve
solo da copertura ai tormenti che prova, una tinta cupa deve oscurare
persino i bagliori di speranza che concepisce.
Fedra presa totalmente dal sentimento che la domina, lascia andare le sue
espressioni e la sua anima senza alcun ritegno; Semiramide, perseguitata
Pierre Corneille, Cinna ou la Clémence d’Auguste, Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, 1640.
Nella sua carriera Larive ha interpretato il personaggio di Cinna, mai Augusto.
184 Nicolas Boileau-Despréaux: «La douleur vertueuse / De Phèdre, malgré soi perfide,
incestueuse», Épîtres, VII.
185 Larive accenna alla terza scena del terzo atto, dove Enone, nutrice e confidente di Fedra,
di fronte al suo smarrimento nell’apprendere che Teseo non è morto, le suggerisce di
imputare a Ippolito il crimine di cui lei dovrebbe esser giustamente accusata.
183
121
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
dall’ombra di Ninus,186 è di continuo agitata da mille pensieri che si
osteggiano e che è obbligata a nascondere.
Racine nel Mithridate ha voluto dare a Farnace un’aria di famiglia, ma ha
avuto l’abilità di farlo scomparire nel momento in cui smette di dominarsi
davanti al padre: si riconosce nella passione di Farnace, nel carattere
intraprendente e irruente, il degno figlio di Mitridate.187 Era impossibile che
questi due personaggi si sopportassero senza nuocersi vicendevolmente.
Xipharès, al contrario, per la sua dolcezza e la sua tenerezza presenta un
perfetto contrasto con la passione gelosa e crudele di Mitridate.
In Adélaïde du Guesclin, Coucy parlando di Vendôme dice nel primo atto:
È nato violento, ancorché magnanimo,
Sensibile ma collerico, eppur capace di un crimine.188
Vendôme nel secondo atto dice di Coucy:
Se avessi come voi questo coraggio tranquillo
Così freddo nel pericolo, così calmo nella tempesta!189
Ecco due caratteri ben delineati e ben opposti, ma se per farsi applaudire o
per ignoranza Coucy mette nella sua parte il calore e l’impeto che solo
Vendôme deve avere, a quest’ultimo non resta più che un’espressione
esagerata se vuole gareggiare in forza contro Coucy, o non è più Vendôme
se vuole opporre il ragionamento alla forza.
Tutti i grandi drammaturghi hanno avvertito la necessità delle opposizioni
e siccome è impossibile sostenere contemporaneamente in scena due
caratteri simili, hanno, come l’autore di Rhadamiste, forzato uno dei due a
reprimersi davanti all’altro: Rhadamiste parla a Pharsamane solo in una
concione e lo rivede al momento del pentimento e della sua morte.190
L’apparizione dell’ombra di Ninus (atto III, scena 6) aveva creato non pochi problemi alla
prima rappresentazione.
187 Larive sosterrà la parte di Farnace fra il 1778 e il 1782. Nella tragedia raciniana nella quale
il tema della passione amorosa si oppone ai disegni della politica, il carattere di Farnace
fiero e dispotico ha tanto più rilievo in quanto è messo in opposizione a quello del fratello
Xipharès, virtuoso e sensibile, sottomesso al volere paterno. Secondo Larive: «Quando
questa tragedia è recitata con grande accordo e se gli attori rispettano i limiti prescritti
dall’autore, produce una forte sensazione», Cours, 1810, vol. II, p.188.
188 Adélaïde du Guesclin di Voltaire (18 gennaio 1734): «Il est né violent, non moins que
magnanime, / Tendre, mais emporté, mais capable d’un crime», battuta di Coucy ad
Adélaïde (atto I, scena 1, vv. 27-28). Larive ha impersonato per la prima volta il duca di
Vendôme il 10 luglio 1775.
189 Ivi. «Que n’ai-je, comme vous, ce tranquille courage / Si froid dans le danger, si calme
dans l’orage!» (atto II, scena 1, vv. 339-340).
190 Prosper Jolyot de Crébillon, Rhadamiste et Zénobie (23 gennaio 1711). Larive ha recitato la
parte di Rhadamiste a partire dal 1775; fa riferimento rispettivamente al II atto, scena 2 e al
V atto, scena 5.
186
122
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Ifigenia nell’incedere, negli sguardi, nei gesti, nel dolore, nella gioia, non
deve avere nulla in comune con Eriphile: una passione delicata, casta e
pura riempie il suo cuore, una passione violenta e gelosa tormenta Eriphile;
la prima deve dunque avere in candore, pudore e nobiltà tutto ciò che
appartiene al sangue da cui discende.191 Non si deve contare su due o tre
intonazioni toccanti per rappresentare Ifigenia, c’è una grande differenza
fra il suo dolore e quello di una fanciulla di oscure origini. Racine, almeno,
ha fatto questa differenza e tuttavia sembra sfuggire alla maggior parte
delle nostre giovani attrici.
Un tempo i critici erano molto esigenti su quanto concerne la vera dignità,
oggi temono di parlare un linguaggio che non sarebbe più compreso o sono
stati loro stessi corrotti da ciò che vedono abitualmente.
Se ogni attore sapesse immedesimarsi scrupolosamente nel carattere
specifico della propria parte, ne scaturirebbe un insieme che darebbe a tutti
i componenti della compagnia un valore reciproco e il pubblico competente
avrebbe maggior piacere nell’ascoltare attori mediocri così in accordo che
attori di grandi doti che hanno la pretesa di voler riunire tutte le passioni in
una parte in cui generalmente non devono esprimerne che solo una. Quelli
che non riescono a dare a ogni parte un carattere particolare si creano in
genere gesti e dizione che servono per tutte, trovano più facile di dare al
personaggio la loro statura e il loro sembiante piuttosto che assumere
l’atteggiamento e la fisionomia delle grandi figure che interpretano. Racine
non ha voluto fare di Oreste un personaggio riflessivo, lo ha voluto furioso
e il furore non permette di ragionare dato che è l’effetto della follia.192
Oreste deve dunque abbandonarsi al disordine dei sensi con tutte le sue
forze e la sua energia, senza però ferire la dignità del sangue di
Agamennone. La qualità assolutamente essenziale per la tragedia è, come
ho già detto, la dignità: senza di essa nulla è tragico.
La tragedia esige sempre nobiltà nell’espressione e nel contegno, ma
permette che l’attore cambi contegno ed espressione a seconda della
maggiore o minore elevatezza nei caratteri. Sarebbe ridicolo dare al vecchio
Orazio la dignità che appartiene ad Agamennone. Il primo è un semplice
cittadino di Roma, colmo d’onore e d’amore per la patria che deve e può
esprimersi con calore ed energia, ma con una verità semplice e franca che
Larive ha già accennato in precedenza ai personaggi della tragedia raciniana: Ifigenia è
figlia di Agamennone e Clitemnestra, Eriphile di Elena e Teseo.
192 Larive evoca il personaggio di Oreste, figlio di Agamennone, nell’Andromaque di Racine.
Nella sua interpretazione appare anche una vena profondamente malinconica. Oreste,
vittima della passione, della gelosia e della disperazione, dimentico persino del proprio
onore tanto da assassinare Pirro, è trascinato da una fatalità che secondo Larive «nulla può
vincere e la cui forza non conosce freni. Questa continua cecità che lo porta a sacrificare tutto
per una donna che non l’ama che lo rende spergiuro e assassino per piacerle, questo infelice
destino che ne fa un oggetto d’orrore persino per colei che gli ha ordinato il crimine: tutto
imprime a questo carattere una malinconia profonda e toccante», Cours, 1810, vol. II, p. 62.
191
123
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
nulla lo obbliga a reprimere in presenza dei figli. Agamennone deve avere,
persino con la famiglia tutta la dignità del re dei re. È necessario che il viso
e il contegno ne attestino l’abitudine al rispetto che gli è dovuto, e al
comando.
Il giovane Achille deve avere l’energia e la dignità che si addicono al figlio
di una dea. Il giovane Rodrigo (nel Cid) è coraggioso, impetuoso come
Achille, ma c’è una grande differenza fra questi due eroi. La loquacità
veemente di Rodrigo nella narrazione e nell’apostrofe «Fatevi avanti
Navarresi, Mori e Castigliani, ecc.» sarebbe biasimevole in Achille.193
Rodrigo cerca la gloria, Achille ne ha già l’abitudine.
Non ignoro che ci vuole un gran talento per cogliere queste sfumature,
sono necessarie inoltre le conoscenze acquisite e un’elevatezza d’animo e di
princìpi che non è da tutti. Direi di più: è quasi impossibile recitare queste
parti nell’età indicata dall’autore, non basta un volto giovane e la grazia
naturale per interpretarle in modo giusto e purtroppo nel momento in cui
un assiduo lavoro e una lunga esperienza ci hanno fornito ogni mezzo
necessario per renderle alla perfezione, il pubblico spesso meno
suggestionato dal cambiamento del nostro fisico che dal numero di anni
che ha visto passare da quando le recitiamo, ci avverte di lasciarle.
Pierre Corneille, Le Cid (Théâtre du Marais, fine novembre 1636). «Paraissez, Navarrois,
Mores et Castillans», atto V, scena 1, v. 1559.
193
124
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
CAPITOLO XIX
Della dizione semplice e della declamazione; di alcune amarezze legate
all’arte drammatica
Molte persone sollevano il problema di sapere se la tragedia deve essere o
parlata o declamata. Assomiglia molto a quest’altro problema, della
tragedia in versi e della tragedia in prosa.194 È certo che Corneille, Racine e
Voltaire non hanno fatto versi così belli perché siano ridotti al tono della
prosa. I bei versi smettono di esserlo quando una dizione troppo familiare
ne fa scomparire le bellezze, ma c’è una declamazione epica e lirica che si
avvicina alla natura quando vi si avvicinano gli stessi personaggi tragici. La
natura tragica è in parte ideale, anche il linguaggio deve esserlo. Dare ad
Agamennone, a Joad, a Fedra, a Merope la locuzione di uomini e donne
ordinari significa travestire questi grandi personaggi in borghesi di
quartiere; significa con una malintesa imitazione, oserei dire colpevole,
della natura comune distruggere quella natura ideale raffigurata dall’arte
della tragedia, e alterare quella bella lingua poetica che è costata lunghe
veglie ai poeti che la parlavano al meglio. Parlare con nobiltà ed elevatezza
senza enfasi né volgarità è il sublime dell’arte. La parlata nobile è
l’espressione del sentimento e dell’eroismo: la declamazione vuota e
ampollosa costituisce una ridondanza di tono che occulta la verità che
invece del verso non fa risuonare che parole e rime. Accanto al sublime c’è
la stravaganza, un semitono in più o in meno può rendere triviale ciò che,
senza questo difetto di sfumatura, sarebbe perfetto. Il tatto raffinato e
delicato dell’attore deve indicargli fin dove può spingersi senza ferire la
nobiltà e la dignità tragiche. Ci sono ancora molti conoscitori che hanno
visto Melpomene nei suoi più bei giorni e che non hanno dimenticato con
quale sublime semplicità Mlle Dumesnil parlava in questa bella scena della
rivelazione nell’Œdipe:
Sappiate, sappiate in questo estremo periglio
Quello che avrei voluto nascondere a me stessa.195
Già all’inizio del secolo una diatriba aveva opposto Houdar de La Motte, autore di una
tragedia su Edipo in prosa e successivamente messa in versi (rappresentata nel 1726), a
Voltaire. L’accademico sosteneva, in modo assai innovativo, la forma prosastica della
tragedia rivendicando tale possibilità in nome della verosimiglianza e della naturalezza,
Voltaire legato all’armonia del verso per tradizione poetica asseriva che la prosa non può
sostenere la tensione richiesta dalla tragedia e che «la schiavitù della rima» appariva come
una necessità estetica.
195 In questa scena dell’Œdipe di Voltaire Giocasta svela a Edipo quanto le era stato
vaticinato dall’oracolo al momento della nascita del figlio di Laio: «Apprenez, apprenez,
dans ce péril extrême, / Ce que j’aurais voulu me cacher à moi-même» (atto IV, scena 1, vv.
963-964).
194
125
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Neppure si è dimenticato con quale maestosa nobiltà, Mlle Clairon parlava
in Sertorius dicendo:
Voi mi amate, Perpenna, Sertorio lo dice.196
Il disprezzo che mostrava, accompagnato da un sorriso sdegnoso,
trascinava il pubblico. Ci sono mille bellezze di questo genere che sarebbe
troppo lungo citare e che non mancavano mai il loro effetto. Ho detto che la
dizione tragica doveva solitamente allontanarsi dalla declamazione epica e
lirica: eppure bisogna che qualche volta vi si avvicini nei casi in cui il poeta
stesso si è avvicinato nello stile all’uno e all’altro di questi due generi.
Biasimerei l’attore che non declamasse i versi che hanno più enfasi che
sentimento, come questi di Zamore:
Dalla plaga infuocata e dal centro del mondo
L’astro del giorno ha visto la mia corsa vagabonda.197
Ci sono molte circostanze in cui ci vuole una magia di dizione che si
avvicini più alla declamazione che a quella parlata nobile, ma semplice,
linguaggio abituale dei personaggi tragici. L’arringa di un ambasciatore,
quelle che sono indirizzate a tutto un popolo esigono necessariamente una
qualche declamazione, senza arrivare tuttavia fino al ‘cantato’; ma deve
dare alla dizione una dignità maschia, imponente e sostenuta. Deve
elevarsi ancor più in certe narrazioni poetiche come nel récit di Teramene o
in brani interamente lirici come la profezia di Joad.198 Solo al talento spetta
sentire quale sia, al riguardo, la misura adatta.
Un carattere sincero ed evoluto deve avere una dizione più rapida di un
grave politico. È impossibile che quella di Bayard convenga a Rhadamiste,
ecc., ecc. Spetta ancora al talento e al gusto essere sensibili alla parola di
valore di ogni verso e di dare questo valore ai bei versi e ai bei pensieri in
modo da fissare l’attenzione del pubblico sulle cose e non sulle parole, di
sorvolare su quelle che sono fredde e insignificanti, come ne sfuggono a
volte ai più grandi geni e come se ne permettono così sovente agli scrittori
di secondo ordine. Una dizione grave, pesante e uniforme soffoca le
bellezze più emozionanti e ne distrugge l’effetto. Mi ricordo di aver sentito
dire di seguito, a un attore che recitava il vecchio Orazio:
Che morisse
Nel Sertorio di Pierre Corneille, all’inizio della scena IV del 2 atto, v. 679: «Vous m’aimez,
Perpenna, Sertorius le dit».
197 Voltaire, Alzire: «De la zône brûlante et du milieu du monde, / L’astre du jour a vu ma
course vagabonde» (atto II, scena 1).
198 Rispettivamente in Phèdre e in Athalie.
196
126
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
O che allora fosse soccorso da una bella disperazione.199
Aveva abituato il pubblico ad applaudire solo alla fine del secondo verso.
Fui indignato che nella patria di Corneille si osasse sfigurarlo così. Recitai
la parte per rendere quel sublime che morisse in tutta la sua purezza. Il
pubblico sorpreso nel vedermi portare l’espressione sul solo che morisse, ne
avvertì la bellezza un secondo dopo, ma la sentì con una sorta d’ebbrezza e
gli rese, con lunghi applausi, il meritato omaggio. Ma il successo di questa
celebre espressione non sempre dipende da chi la dice, è il modo vero di
chiedere al vecchio Orazio
Cosa volevate che facesse contro tre?
che decide la perfezione più o meno accentuata della risposta. Se questa
battuta è pronunciata lentamente e come l’ho qualche volta sentita su tre
toni diversi, è impossibile che il che morisse non perda tutto il suo effetto; ciò
prova che il talento è necessario anche nelle parti secondarie. Una cosa
importantissima a teatro, a cui molti attori prestano poca attenzione, è il
modo di inspirare; da ciò dipende in larga parte la bellezza della dizione.
Molti attori inspirano con tanta precipitazione che non riescono a evitare
un singulto spiacevole per loro e per il pubblico che soffre per lo sforzo che
sembrano fare. È facile evitare questo difetto lasciandosi il tempo di
inspirare studiando con attenzione la forza e l’estensione del fiato,
risparmiando i propri mezzi, non sforzando mai la voce al punto di non
riuscire più a controllarla. Si è sempre forti, per quanto si possa apparire
deboli, quando si sanno economizzare le proprie forze.
Le si devono adoperare principalmente, come ho detto, sulle parole di
valore di ogni verso, risparmiandole sulle cose che richiedono solo verità e
semplicità. So che spesso l’attore si lascia trasportare da certe ispirazioni
che lo trascinano così lontano che non riuscirebbe a continuare e a finire sul
tono scelto. In questo caso se il tono è vero e giusto il pubblico, senza
saperlo, viene in suo aiuto, l’applauso che riceve si prolunga quanto la
sensazione prodotta: ha così il tempo di respirare e di riprendere forza.
Lekain, che ben conosceva il pubblico e di cui era sicuro, i giorni in cui era
in salute sapeva ciò che poteva permettersi e mai dubitava dell’applauso
necessario alla pausa; ma quando stava meno bene e non sentiva lo spirito
e la sensibilità a sua disposizione, rallentava la dizione e si lasciava andare
molto meno. In quei giorni il pubblico non diceva: Lekain ha recitato male,
diceva che Lekain era malato e non si aveva l’impudenza, l’indomani, di
travisarlo e di ingiuriarlo sui giornali. Ma chi, meno fortunato di lui, è
Pierre Corneille, Les Horaces (Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, 1640): «Qu’il moûrut, /
Ou qu’un beau désespoir alors le secourût», (atto III, scena 6, vv. 1021-1022). È la risposta
del vecchio Orazio alla domanda di Julie, poi citata da Larive, che gli aveva chiesto: «Que
vouliez-vous qu’il fît contre trois?» (v. 1021).
199
127
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
obbligato a lottare costantemente contro l’intrigo e la malafede dei nemici
non ha la stessa fiducia. Per nuocere all’attore che si osteggia e per
disturbarlo nei suoi più bei momenti ci sono mille modi che la parte sana
del pubblico non immagina neanche; il loro successo, non temo dirlo, rende
la più bella delle arti il più vile dei mestieri. È persino impossibile che colui
che ha l’animo abbastanza fiero da disdegnare le risorse derivanti dalla
bassa compiacenza e l’intrigo, e tutti quei mezzucci che creano in un giorno
piccole reputazioni, non sia esposto a ogni genere di amarezze.
Nella nostra condizione abbiamo bisogno di una grande fiducia, direi di
più, se abbiamo la modestia necessaria al vero talento, ne abbiamo anche il
nobile orgoglio. Se non serbassimo la speranza di piacere e anche quella di
suscitare una vera ammirazione, saremmo presto scoraggiati. Gli applausi
del pubblico sono un introito quotidiano di cui abbiamo ben più bisogno di
quello degli ingressi perché siamo ben consapevoli che la nostra gloria è,
per così dire, in denaro contante, e dal momento in cui il sipario è abbassato
il ricordo dei nostri talenti si oscura come il teatro stesso quando si spegne
la ribalta. È perciò impossibile raggiungere la perfezione quando,
circondato da gente mal intenzionata, l’attore è criticato nei suoi momenti
più belli e spesso destinato a raccogliere, come prezzo degli sforzi e del
sudore, unicamente la fatica della parte.
L’attore che va dritto all’anima dello spettatore trova generalmente meno
indulgenza di chi ne occupa solo la mente, lo spettatore appassionato
perdona raramente l’emozione che prova se incompleta: diventa tanto più
esigente in quanto, suscitata da un vero movimento di sensibilità, la sua
fibra più tesa è allora più sensibile; il minimo tono forzato o falso la ferisce,
distrugge l’illusione e ogni incanto scompare.
L’abuso che più nuoce all’insieme delle rappresentazioni e che
recentemente si è diffuso alla Comédie-Française è legato alla pretesa dei
giovani attori che non ritengono degno di loro recitare, sotto i vecchi, parti
di secondo piano.
Ancora ci si ricorda che all’antica Comédie-Française i giovani talenti si
sentivano onorati di contribuire al successo delle pièces, nell’ambire
recitare accanto ai Lekain, Dumesnil, Clairon. Mlle Clairon ha fatto
conoscere le bellezze della parte di Eriphile che prima di lei era stata
sempre giudicata brutta e provò in quella di Costanza della tragedia d’Inès
che non esiste parte ingrata per chi ha un vero talento.200 Molé stesso ha
sviluppato l’attrattiva della sua arte in parti che prima di lui non
presentavano alcun interesse e hanno perduto la loro nuova rinomanza nel
perdere colui che le aveva create.201 L’attore che il pubblico ascolta
Antoine Houdar de La Motte, Inès de Castro (6 aprile 1723), Costanza è la figlia della
regina del Portogallo promessa sposa a Don Pedro.
201 François-René Molé (1734-1802) attore della Comédie-Française dal 1761, recitava con
altrettanto successo nei ruoli tragici e comici; durante la sua carriera aveva creato più di
200
128
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
freddamente e al quale presta poca attenzione contribuisce spesso al
successo delle parti brillanti; quando una semplicità discreta fa risaltare,
con un’opposizione ben marcata, tutte le bellezze di queste parti
importanti.
Uno studio approfondito dell’arte da me esercitata per più di trent’anni in
tutte le città dove ci sia un teatro, ha dovuto insegnarmi a conoscere lo
spirito degli spettatori e degli attori. È difficilissimo trovare in questi ultimi
l’accordo necessario al talento, tutti sono mossi da passioni diverse, da una
esaltazione abituale e un’immaginazione sempre mutevole, che ci fa di
continuo lasciare il nostro carattere per assumere quello delle diverse
interpretazioni. Di conseguenza è quasi impossibile che non ci sia tra gli
attori uno scontro continuo d’opinioni e di idee che li allontanano e li
ravvicinano secondo il loro particolare interesse.202 I giovani attori, che per
loro fortuna non possono misurare la distanza che li separa dalla
perfezione, credono al minimo applauso di averla raggiunta e pensano già
di lasciare dietro di sé quelli che da lungo tempo hanno meditato sulla loro
arte consacrandole le loro veglie e subendo le prove necessarie per arrivare
alla meta agognata. Questi veterani che conoscono i pericoli, mostrando
minor sicurezza ed esaltazione, sanno confinarsi scrupolosamente nelle
loro parti e non si preoccupano di raccogliere gli applausi calcolati che
potrebbero derivare da successi effimeri e prestabiliti. Sono profondamente
convinti che non ci sarebbe né merito né gloria ad acquisire particolari
talenti con studi lunghi e faticosi, se questi talenti fossero immediatamente
a disposizione di debuttanti incapaci di riflessione e privi d’esperienza.
La cieca fiducia della gioventù è perdonabile quando non si accompagna
alla perfidia e si serve solo di mezzi leciti. Mi ricordo di aver anche osato
paragonarmi ai grandi talenti e di aver immaginato che il mio valore e il
mio giovane aspetto potessero pormi di colpo accanto ai grandi maestri; ero
tanto più disposto a convincermene essendo in quell’età in cui si crede
facilmente in ciò che lusinga.
Ho dovuto lottare contro un gran numero di ostacoli e malgrado
l’accoglienza lusinghiera ricevuta dal pubblico al mio debutto fui presto
convinto che in questa carriera tempestosa non bisogna mai contare sul
successo del giorno precedente per quello dell’indomani. Il pubblico mi
aspettava, non solo nelle caratterizzazioni felici in cui ne avevo già ottenuto
centoventi nuove interpretazioni; era stato il primo conte d’Almaviva nel Mariage de Figaro
di Beaumarchais. I rapporti con Larive erano stati a volte piuttosto conflittuali.
202 Non si potrebbe attribuire a questa stessa esaltazione e a questa mobilità d’immaginazione, la
facilità con cui si accettano molte pièces mediocri o scadenti? Questa opinione mi aveva fatto decidere,
da più di vent’anni, di astenermi dal partecipare alle letture.
Ho sempre pensato che fosse impossibile giudicare in modo giusto una pièce dopo una sola lettura;
credo che gli attori, dopo averla ascoltata dovrebbero rileggere ciascuno in privato e poi riunirsi per
giudicarla e non ammettere al giudizio che coloro i quali hanno acquisito, per lunga esperienza, il
diritto di valutare un’opera.
129
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
il suffragio, ma anche in tutte le bellezze consacrate dal grande talento di
Lekain. Questi, più fortunato di me era subentrato a un talento mediocre.
Dufresne, malgrado il suo bel fisico, non suscitava alcuna emozione nelle
parti che richiedevano l’enfasi delle grandi passioni, cantava e declamava
interrottamente.203
L’animo sensibile e ardente di Lekain fece ben presto dimenticare Dufresne,
ma il mio compito fu tanto più difficile perché comparvi sulla scena
proprio nel momento in cui Lekain aveva trionfato sui suoi nemici e
godeva di una gloria immensa. Sentii presto la necessità di andare a dare
libero corso ai miei mezzi in provincia dove non dovevo sostituire quel
grande artista che, avendo una costituzione diversa dalla mia, si era creato
un genere appropriato al suo morale e al suo fisico. La natura, se mi si
permette di dirlo, mi ha concesso in potenzialità ciò che aveva dato a
Lekain in emozioni concentrate, i suoi scoppi erano tanto più tragici che la
sua anima, più difficile a commuoversi, si dispiegava con tutta la sua forza
nelle scene patetiche o di furore. Un grande impegno, una mente colta, il
vivo interesse che gli mostrava Voltaire, la fortuna inestimabile di aver
creato una parte dei bei personaggi di questo grand’uomo, i talenti
superiori che gli erano propri, un pubblico composto da una gioventù colta,
appassionata e sensibile che sapeva restituire all’animo dell’attore le
sensazioni che riceveva, infine venti anni di carriera gli avevano fatto
conoscere ogni segreto di quest’arte difficile. Mi accorsi che nel cercare di
imitarlo, sforzandomi di ottenere dalla mia voce quegli spasimi che
elettrizzavano il pubblico, mi era impossibile esprimere come lui ciò che
non apparteneva che a lui, non potendo imitare le sue intonazioni se non
ostentando una voce che non era la mia, sarei stato condannato a essere
solo un doppio freddo e monotono.204 Il pubblico, giustamente
condizionato dal grande talento di Lekain, non mi avrebbe in seguito
perdonato di osare servirmi dei miei mezzi e di recitare secondo la mia
sensibilità, un suo leggero malcontento sarebbe stato per me una condanna
a morte ed ero grandemente addolorato al minimo segno di
disapprovazione. Questa stessa sensibilità, necessaria al vero talento, non
potevo dismetterla con il costume di Achille o di Orosmane, mi seguiva
Quinault cadet Abraham Alexis, detto Quinault Dufresne (1693-1767) debuttò alla
Comédie-Française nel 1712, esageratamente fatuo per il suo aspetto fisico molto attraente e
una bella voce, malgrado il successo per una dizione lineare e misurata, finì per stancare il
pubblico con il suo fare altero e sprezzante, aveva lasciato il palcoscenico nel 1741.
204 Certamente Larive aveva sensibilità, grande intuito e una sostenuta attenzione a quanto
lo riguardava. Grimm in un articolo redatto al momento della seconda prova dell’attore alla
Comédie-Française, nell’affermare che egli offre maggiori garanzie per il futuro rispetto ad
altri che si sono proposti, scrive: «Ha soprattutto il vantaggio di non essere una brutta copia
dello stupefacente originale che sembra così difficile da raggiungere e che sarebbe senz’altro
infelice se lo si imitasse in modo mediocre», «Correspondance littéraire», vol. XI, aprile 1775,
p. 72.
203
130
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
dietro il sipario e il teatro mi ha sempre lasciato, persino dopo i più brillanti
successi, preoccupazioni e timori che si sono ripresentati ogni qualvolta mi
sono affidato al pubblico.
La gelosia, flagello deplorevole di tutte le società, è più viva a teatro che
altrove, sentivo quanto avrei potuto e vedevo con dolore che non osavo
esprimere nulla a modo mio. Quando mi decisi a lasciare Parigi, mi accorsi
con grande gioia che la cabala, l’intrigo e la gelosia non mi avevano seguito
e le diverse approvazioni, che ho avuto la gioia di ottenere, mi hanno
provato che ciò che è vero lo è dappertutto e che coloro che sanno sentire
sono i veri intenditori. Non penso affatto, come molti affermano, che i
talenti si perdano in provincia, sembra, a sentirli, che solo Parigi abbia il
privilegio di plasmarli e di preservarli. Quelli che pensano così
dimenticano che proprio in provincia è nata la maggior parte dei talenti di
cui gode Parigi e che di frequente quelli che si erano formati solo a Parigi,
fieri dei loro successi nella capitale, perdono molto del loro lustro in
provincia dove il pubblico, meno esaltato e più riflessivo, apprezza i talenti
per ciò che valgono. Là, più felice che a Parigi, trovavo nella buona volontà
dei miei compagni i mezzi per recitare fruttuosamente tutte le mie parti e
per offrire al pubblico in sei mesi più spettacoli di quanti non ne
rappresentavo in sei anni a Parigi. A Parigi mi è stato impossibile far
riproporre Mithridate, Venceslas e qualche altra tragedia che ho il grande
rimpianto di non aver potuto recitare.205
Larive aveva recitato nelle due tragedie rispettivamente nelle parti di Farnace fino al 1782
e di Ladislas fino al 1788.
205
131
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
UNDICESIMO INCONTRO
CAPITOLO XX
Di alcune circostanze favorevoli o sfavorevoli al talento e al successo
Quando giunsi a Lione, splendente di giovinezza e di salute, inebriato dai
miei primi successi, ricco di tutta la fiducia derivante da un’età in cui non si
dubita di nulla, credevo nel diritto di rivaleggiare persino con Lekain, la cui
reputazione riempiva la Francia.206 Quell’attore arrivò proprio nel
momento in cui gli spettatori mi tributavano corone e applausi. La sua
comparsa mi mise di cattivo umore. Fu accolto dal pubblico come meritava
che lo fosse e il cattivo umore aumentò. Nel corso delle rappresentazioni mi
fu proposto di recitare con lui. Non ritenni degna di me una parte di
secondo piano e rifiutai la proposta. I miei amici mi fecero capire il ridicolo
della mia condotta, cedetti e credei lusingare Lekain proponendogli di
ritardare di qualche giorno la rappresentazione di Adélaïde du Guesclin in
cui contavo recitare la parte di Nemours.207 Lekain poco colpito dalla mia
proposta mi disse freddamente che non poteva cambiare la
programmazione degli spettacoli. Offeso dal rifiuto trascorsi la notte a
ripetere la parte, la pièce si recitava l’indomani. Entrai in scena al secondo
atto, il pubblico che non se lo aspettava mi ricevé con gli applausi tributati
solo a Lekain. Questi apparve sorpreso, mi sembrò anzi che mi credesse
degno della sua collera perché da quel momento la sua anima e la sua
energia crebbero a tal punto che ne fui elettrizzato. Gli spettatori trascinati,
fremevano di piacere nell’ascoltarlo e dopo averlo applaudito
fragorosamente, prestandomi di nuovo tutta la loro attenzione sembravano
voler far passare nella mia anima quella di Lekain. Mi riesce difficile
descrivere ciò che provai: la mia emozione si fece così vivida e così vera che
le mie espressioni e i miei movimenti sembravano esser dettati proprio
dalla natura. Lekain superò se stesso, il pubblico richiese a gran voce una
seconda esibizione. Si pensò di raddoppiare il costo dei posti, Lekain
confessò di esser stato troppo contento di sé da voler correre il rischio di
Larive è a Lione, seconda città del regno, nel 1767 e recita sotto la direzione di Mme
Lobreau che forma anche altri attori che entreranno alla Comédie-Française come Fleury e
Mlle Sainval (Cfr.: Emmanuel Vingtrinier, Le Théâtre à Lyon au XVIIIe siècle, Lyon, Meton
Libraire-Éditeur, 1879, p. 39).
207 Nella tragedia, che si svolge all’epoca della guerra dei Cento Anni, Voltaire mette in
scena l’antagonismo fra due fratelli: il duca di Vendôme e il duca di Nemours. Sui loro
caratteri opposti già si era soffermato Larive (v. supra): il loro conflitto è in parte politico (il
duca di Vendôme ha tradito il re di Francia ed è alleato con gli Inglesi, mentre Nemours è
rimasto fedele a Carlo VII), ma anche passionale: entrambi amano la nipote del conestabile,
Adélaïde du Guesclin. Nell’incontro, che avviene durante l’assedio di Lille, Nemours appare
ferito e prigioniero del fratello (atto II, scena 2) al quale rimprovera la fellonia, mentre nel
terzo atto (scena 3) gli si rivela come rivale in amore, sicché Vendôme lo condanna a morte.
Alla fine prevale il sentimento della fratellanza e in Vendôme interviene il perdono.
206
132
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
esserlo meno una seconda volta. A Lione ci si ricorda ancora dell’effetto
prodotto da quella rappresentazione memorabile.208
Neanche si è dimenticata a Parigi l’impressione che provocò poi una recita
di Brutus nella quale Lekain impersonava Arons, Brizard Bruto e io Tito.209
Fui talmente pieno d’ammirazione per il grande talento di Lekain che mi
affrettai immediatamente a rimediare ai miei torti nei suoi confronti,
testimoniandogli il mio rammarico e il mio rispetto. Ne fu grandemente
colpito e da allora ebbe per me una vera amicizia. Fu lui a scegliermi come
sostituto e d’intesa con de Belloy contribuì in maggior misura a farmi
tornare a Parigi.
Nell’intimità che si creò tra noi, non mi nascose le angustie e i fastidi che
l’avevano tormentato perché non è mai impunemente che si ottiene
l’ammirazione dei propri simili. La natura non permette che colui che
sembra felice agli occhi di tutti lo sia ai propri e quella sensibilità che
procura sprazzi di felicità inestimabile, ce li fa spesso pagare con lunghi e
angosciosi dolori. Oso credere che non sarà privo d’interesse leggere la
lettera che ricevei da Lekain due anni prima della sua morte, prova che ha
dovuto soffrire molto da quel momento fino a quello in cui ha cessato di
vivere.
Parigi, 15 novembre 1776
Vi prevengo, con rammarico, caro collega, che la necessità di vegliare alla
guarigione della mia cattiva salute mi porrà nell’impossibilità di recitare la
prossima settimana sia a corte che in città. Corro il grave pericolo di una nuova
infiammazione ai reni e per prevenirla ho bisogno di un regime severo e di un
lungo riposo.
Avverto, amico mio, che sarà presto il momento di ritirarmi e di lasciarvi la
guida del regno, che possiate mettere un po’ più d’ordine nei vostri piccoli
stati di quanto non mi sia stato possibile attuare!
Vi abbraccio con tutto il cuore congiuntamente alla vostra gentile sposa.
Lekain
L’emozione che provo nel copiare questa lettera mi ricorda il vivo dolore
che mi pervase vedendo scendere nella tomba colui che aveva mantenuto
così a lungo il diritto di elettrizzare gli animi più freddi e di emozionare i
La versione dell’evento che ne dà Jean-Nicolas Bouilly è leggermente diversa e si rifà al
racconto di un vecchio artista, Dumanoir, testimone oculare della rappresentazione. Larive
entra in scena per sostituire l’attore indisposto e Lekain pensando che sia stato fatto di
proposito recita con grande «alterigia e fierezza», anche perché il testo si presta allo scontro
Vendôme/Nemours. L’applauso incondizionato del pubblico per Lekain costituì «una
terribile lezione per il giovane presuntuoso che ne fu atterrito» anche se poi Lekain cercò di
attenuare il contrasto dando un’intonazione del tutto particolare al verso «chi sa rispettare il
valor di un nemico», Soixante ans du Théâtre-Français…, cit., p. 21.
209 Voltaire, Brutus, (11 dicembre 1730). Jean-Baptiste Britard, detto Brizard (1721-1791) era
sociétaire dal 1758, stimato da Diderot per l’interpretazione del suo Le Père de famille [Il Padre
di famiglia], 18 febbraio 1761. Tito era il figlio del console Bruto e Arons l’ambasciatore di
Porsenna.
208
133
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
cuori più insensibili. Fu almeno assai fortunato da dare, prima di morire,
nuove prove del suo grande talento nella bella parte di Vendôme, l’ultima
nella quale si sia prodotto e che recitò con l’energia di un giovane altero
quanto appassionato.210
Sono stati pubblicati i Mémoires di Lekain e mi è molto dispiaciuto che non
vi sia riferito un episodio che fa onore al suo spirito quanto alla sua
sagacia.211 Credo che sarà cosa gradita riportarlo qui.
Un autore che era andato incontro a degli insuccessi nella sua produzione
drammatica poco tempo prima della rappresentazione de Le Siège de
Calais,212 trovandosi nel foyer della Comédie-Française il giorno del debutto
della tragedia, pensò di poter stroncare la pièce e il suo successo. Lekain era
presente e sembrava indignato dalle critiche dell’autore fischiato che, senza
mezzi termini, manifestava la propria rabbia dicendo ad alta voce che la
pièce era esecrabile e il pubblico senza gusto né discernimento. Lekain si
credé in diritto di muovere alcuni rilievi al critico che si esasperò al punto
di dire che nel Le Siège de Calais non c’era neanche un verso da citare.
Lekain gli fece notare con discrezione la sua ingiustizia rispondendogli che
ce n’erano di molto belli. Citatemene uno, aggiunse il critico, e rinuncio alla
condanna. Lekain indignato avanzò verso di lui dicendo:
Voi foste infelice e siete crudele!213
Quel verso che ricordò all’autore il tonfo della sua tragedia, lo obbligò a
ritirarsi senza replicare e la presenza di spirito di Lekain ottenne i sentiti
applausi degli astanti.
Aveva recitato nell’Adélaïde du Guesclin il 24 gennaio, si era ammalato il 27; l’8 febbraio
1778 Lekain era morto improvvisamente a soli quarantanove anni per una «febbre
infiammatoria e un’ulcera nei reni» (Registre des feux, 13010, Bibliothèque-Musée de la
Comédie-Française, Paris). La sua scomparsa costituisce un gravissimo impoverimento per
la scena teatrale parigina.
211 Mémoires de Henri Louis Lekain, publiés par son fils aîné, Paris, chez Colnet, an IX, 1801. In
un passo di queste Memorie, Larive avrà certo trovato l’eco delle proprie riflessioni; scrive
Lekain: «L’anima è il primo elemento dell’attore, l’intelligenza il secondo, la verità e la
passione dell’elocuzione il terzo, la grazia e l’atteggiamento del corpo il quarto. Ben
conoscere le proprie parti, studiare la prosodia, non perdere mai di vista la natura semplice,
nobile e commovente, pensare che l’intelligenza si acquisisce tramite sagge riflessioni e il
talento con un lavoro accanito, mostrare sempre il personaggio, servirsi del pittoresco con
precauzione, essere vero tanto nella dizione del dettaglio quanto nei grandi moti della
passione; vedere la propria arte in grande; non far percepire troppo di frequente le proprie
reticenze, mostrare sempre la nobiltà, persino attraverso la leggerezza; evitare una dizione a
scatti, non piangere, cosa che è l’effetto di un’anima investita e concentrata sul dolore;
portare un’attenzione continua alla scena, identificarsi col proprio personaggio» (Mémoires
de Henri Louis Lekain…, cit., pp. 173-174).
212 L’Assedio di Calais di de Belloy (13 febbraio 1765).
213 Ivi: «Vous fûtes malheureux, et vous êtes cruel!». Aurèle al padre Eustache de SaintPierre, atto V, scena 7.
210
134
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
S’intuisce, con quanto precede, l’influenza che gli attori hanno gli uni sugli
altri, quella che hanno sul pubblico e quella che a sua volta il pubblico
esercita su di loro. Quando tutti questi effetti si sovrappongono le
rappresentazioni raggiungono un grado di energia e di verità di cui si
conserva a lungo il ricordo.
Pongo nel novero di queste rappresentazioni quella che recitai nel 1780 a La
Rochelle, la mia città natia. Me ne ero allontanato nell’infanzia e vi
ritornavo allora per la prima volta, dopo un’assenza di venti anni. Avevo
scelto per il debutto la mia pièce favorita, Tancrède. Al mio ingresso in
scena, già commosso dall’interessamento del pubblico e dall’accoglienza
affettuosa, nel momento in cui declamai i primi due versi della mia parte:
A tutti i cuori bennati quanto è cara la patria!
Con quale entusiasmo rivedo questo luogo!214
lacrime di commozione apparvero negli occhi degli spettatori e nei miei, fui
fortunato del fatto che gli applausi si prolungarono abbastanza per darmi il
tempo di riprendermi. L’emozione deliziosa che sentivo aveva del tutto
turbato la mia memoria, non sapevo più una parola di ciò che dovevo dire;
solo dopo esser tornato in me, mi fu possibile continuare e il mio cuore era
talmente oppresso che non potei che balbettare i versi successivi. È forse in
quel periodo che fui più intensamente emozionato a teatro. La mia illusione
arrivò al culmine, mi parve di essere fra i miei congiunti più cari e i miei
migliori amici.
A volte gli effetti prodotti dal pubblico sull’attore sensibile sono
straordinari tanto sul fisico quanto sul morale. In una delle mie prime
tournée a Nantes, dopo una parte violenta, recitai Pygmalion; mi accorsi a
sipario alzato che era stata malamente posizionata una pesante e indecente
statua di sei piedi proprio di fronte a Galatea. Infastidito da quel colosso
osai andarlo a prendere per spostarlo in fondo al palcoscenico: avvertii una
qualche resistenza, varie voci si alzarono, sentivo ripetere: «Non ce la farà»,
una voce armoniosa e sensibile colpì il mio udito nell’esclamare con
un’emozione e un interesse che mi impressionarono: «Ah! mio Dio! si farà
male». Quelle parole mi rinvigorirono talmente che arrivai, sotto lo scroscio
degli applausi, a trasportare quel colosso. Finita la rappresentazione
quattro uomini che avevano collocato la statua non vollero credere che mi
fosse stato possibile smuoverla. Cercai invano di provarglielo ma,
malgrado tutti i miei sforzi, mi fu impossibile di farle fare il minimo
spostamento.
Dipende dunque in gran parte dal pubblico e dallo stato d’animo che
dimostra infervorare e formare gli attori, è quasi sempre giusto quando
«A tous les cœurs bien nés que la patrie est chère! / Qu’avec ravissement je revois ce
séjour!», atto III, scena 1.
214
135
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
abbandonato alle proprie sensazioni non si lascia influenzare da cabale e
complotti, purtroppo in quest’ultimo caso assume, senza accorgersene, le
disposizioni che gli vengono comunicate e una parola di critica, sfuggita
accanto allo spettatore meglio disposto, può raffreddarlo all’istante. Gli
attori, che sanno di aver talento e che si abbandonano interamente al
pubblico senza suscitare gli applausi con amici indiscreti o biglietti di
favore, devono esser sicuri di arrivare presto o tardi al successo, il pubblico
imparziale non si sbaglia mai. Quando gli applausi sono dovuti solo alle
impressioni che prova sono utili allo sviluppo degli attori che ne
costituiscono l’oggetto, ma quando vengono provocati li ingannano e li
portano fuori strada, li mettono nell’impossibilità di distinguere gli elogi
meritati da quelli che non lo sono. L’attore così forviato è condannato a una
mediocrità incurabile. Ciò che è vero è bello, lo è sempre, ciò che non lo è,
malgrado i tentativi di complotto presto o tardi scompare. La Fedra di
Pradon, portata alle stelle è dimenticata, quella di Racine, che si osò
criticare in modo oltraggioso, è e sarà in ogni tempo uno dei capolavori
dello spirito umano e l’onore della scena francese.215
Il plauso più lusinghiero non sempre si manifesta con il fragore dei
battimani e le grida di bravo. Ma l’attore non si lasci trarre in inganno: è più
difficile ottenere un profondo silenzio e un’attenzione sostenuta che gli
applausi e chi possiede l’arte di sedurre l’uditorio è ben più sicuro di
raggiungere il cuore di chi si abbandona ai grandi scoppi.216 Ho sempre
notato che il pubblico applaudiva più energicamente i sentimenti eroici
piuttosto che quelli patetici e commoventi; quando è veramente commosso
non pensa ad applaudire.
Ho già esposto le varie cause che rendono il pubblico disponibile o severo,
a volte persino ingiusto. Tutti coloro i quali hanno onorato la scena con il
loro talento gli sono diventati cari dopo averne subito i capricci, ma è
sempre disposto a compensare l’attore ingiustamente ferito.
Jacques Pradon (1632-1698) aveva presentato il 3 gennaio 1677 la sua tragedia Phèdre et
Hippolyte al Théâtre Guénégaud ottenendo un notevole successo (25 rappresentazioni in tre
mesi). Una cabala era stata montata nell’intento di screditare e di far concorrenza alla Phèdre
di Racine andata in scena il primo gennaio al Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, cabala
sostenuta dalla duchessa di Bouillon, dal duca di Nevers e da Mme Deshoulières; grazie a
intrighi e biglietti di favore Pradon era arrivato a un successo che poi si rivelò effimero,
l’affaire aveva suscitato vive polemiche tra i letterati del tempo cui prese parte, in difesa di
Racine anche Boileau. È incredibile che nel secolo della raffinatezza e del buongusto, scrive
Larive nel suo Cours, «un partito invidioso fosse abbastanza potente da dare il doppio
scandalo del successo di una banalità e del fiasco di un capolavoro» (1810, I, p. 184).
216 A proposito di una rappresentazione in cui Larive interpreta Tancredi, il critico del
«Journal de Paris», recensendo lo spettacolo, evidenzia la sua maestria soprattutto nella
scena con Aménaïde del quarto atto: «Gli accenti della voce erano dolorosi e patetici. Non ha
mai gettato un grido e ha fatto piangere. Che mi permetta di dirgli che quel silenzio teso
durante il quale si teme di applaudire il verso appena sentito per paura di perdere quello
che segue, è più lusinghiero per l’amor proprio di un attore degli applausi strappati da
scoppi di voce e grida forzate», sabato 23 giugno 1781, p. 703.
215
136
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Alla prima rappresentazione di una Médée di Clément, recitavo un triste
Giasone.217 Sapevo che Medea doveva, dopo la mia scena, lamentarsi del
modo freddo con cui le avevo parlato, di conseguenza pensai dover
rispondere a tutto ciò che mi diceva d’impetuoso e di appassionato con un
sangue freddo glaciale. Il pubblico spazientito nel trovarmi così freddo me
ne testimoniò lo scontento, accompagnando la mia uscita con un mormorio
molto marcato, ma quando ebbe inteso Medea lamentarsi della mia
freddezza si affrettò ad applaudire per correggere l’ingiustizia.
Una difficoltà indissociabile dalla nostra condizione è quella che dipende,
come già detto, dalle spaccature che spesso esistono fra gli attori nel
momento stesso in cui sono obbligati di raffigurare o l’amore più
appassionato o l’intesa più forte. Mi ricordo a tal proposito ciò che mi
accadde a Bordeaux.
Avevo fatto le prove con una giovane e graziosa Zaïre. Il giorno della
rappresentazione quale fu il mio stupore nel veder apparire in scena una
donna alta, né giovane né vivace, che aveva rivendicato il suo diritto di
anzianità per sostituire la mia giovane Zaïre. Gli attori non avevano osato
preavvertirmi, sicuri che non avrei acconsentito a recitare con quella donna,
diventai furioso, ma dopo aver sbollito la collera, essendo arrivata la scena
in cui dovevo entrare e recitata la battuta, dovetti cominciare ad amare
l’oggetto della mia avversione. Ecco una delle leggi più gravose di questa
difficile condizione: bisognerebbe che l’attore ne fosse pervaso al punto di
dimenticare ogni passione personale per assumere unicamente quelle
richieste dall’arte, bisognerebbe infine che si spogliasse di ciò che gli è
proprio per darsi totalmente al personaggio rappresentato.
Mi si dirà, forse, come potete essere veritiero esprimendo a una persona
sentimenti del tutto contrari a quelli che vi suscita? Ammetterò che ciò è
molto difficile, si può forse credere che sia più facile adottare il carattere e i
nobili sentimenti di tanti eroi? L’attore non è né Achille né Mitridate né
Oreste e tuttavia deve cogliere le loro passioni e assumerne la dignità.
Sarebbe dunque necessario, per raggiungere il sublime, che l’attore avesse
abbastanza padronanza dei propri sensi per assoggettarli in tutto e per
tutto al genio dell’autore, alle circostanze delle pièces e alle convenzioni
della scena; bisognerebbe infine che avesse l’arte di trascendere se stesso, di
essere o di credere di essere il personaggio che recita e di confondere le
proprie sensazioni nelle sue. Sovente, è vero, l’io dell’attore trionfa su
quello del personaggio quando è particolarmente e profondamente
coinvolto. In questo caso, se è abbastanza fortunato perché la parte abbia
Pierre Clément (1707-1767), Medea, tragedia in tre atti, in versi, 20 febbraio 1779. L’opera
non ebbe alcun seguito: l’autore travisando il carattere di Medea, non più maga pericolosa
ma amante sensibile e appassionata, le fa comunque commettere l’orrore dell’infanticidio
che nel contesto emotivo piuttosto edulcorato finisce per far ridere gli spettatori; Larive fu
comunque applaudito per alcuni bei versi dell’imprecazione di Giasone nel terzo atto. Cfr.:
«Correspondance littéraire», vol. XII, febbraio 1779, p. 219.
217
137
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
un rapporto diretto col sentimento che lo domina, sarà sublime; se questo
sentimento è contrario alla parte ogni illusione andrà distrutta e non resterà
tutt’al più che l’apparenza fisica del personaggio. Credo poter citare come
esempio di quest’ultimo caso ciò che mi è successo personalmente. Fu dopo
aver recitato una quarantina di volte e con successo a Parigi la difficilissima
parte di Orosmane e dopo esser stato in varie occasioni richiamato dal
pubblico (favore allora rarissimo) per ricevere le testimonianze più
lusinghiere del suo compiacimento, fui trattato in questa stessa parte col
massimo rigore.218 Avevo presentato al pubblico una giovane attrice che
cinque volte di seguito aveva ottenuto un certo successo nella parte di
Zaïre; dopo questo inizio se ne presentò un’altra e per provare che valeva
più della prima;219 furono prenotati venti palchi che si ebbe cura di riempire
di gente fidata che, nel dar risalto al merito della nuova attrice, non
tralasciò di dire di me, parlando occasionalmente alla mia allieva, quanto
potesse pensare di più sfavorevole sulla mia persona e sul mio talento.
Poiché si è sempre portati a credere più al male che al bene, fui accolto con
un’indifferenza alla quale non ero aduso. Entrando in scena l’accoglienza
poco lusinghiera mi raffreddò e si manifestò qualche nota di dissenso;
allora m’indignai meno per altro contro i miei persecutori quanto contro
quelli che permettevano che mi si perseguitasse, la mia voce si alterò e
anziché trovare nel mio animo quella squisita sensibilità così necessaria per
tratteggiare l’amore appassionato di Orosmane, non trovai che rabbia e
furore. Ci si può immaginare che in tale stato d’animo mi fosse impossibile
recitare al meglio, ciò non sarebbe successo se avessi avuto abbastanza
controllo di me per lasciarmi andare e non essere che Orosmane, anziché
Larive, o se tutti quelli che, da più di quindici anni mi testimoniavano con
applausi continuati il loro gradimento, non avessero trovato qualche
piacere segreto nel vedermi umiliare.220 Fu a quell’epoca che lasciai
La parte di Orosmane era collaudatissima e aveva seguito tutto il percorso scenico di
Larive dal lontano 1771, tanto che l’attore la sentiva totalmente sua per una sorta di osmosi.
Già nel capitolo IV aveva ricordato la reazione della negoziante nell’udire la sua voce.
Orosmane metteva poi in evidenza il fascino fisico dell’interprete. Scrive Fleury nelle sue
Memorie: «Orosmane era una parte molto vantaggiosa per Larive. Oltre al calore della
recitazione, quell’attore era il più bel ornamento possibile per il teatro: l’abito turco e il
turbante col piumetto mettevano ancor più in valore tutto il lusso e il bel insieme delle sue
qualità d’attore; si vedeva realmente in lui lo scita orientale del poeta» (Mémoires de Fleury…,
cit., vol. II, p. 16).
219 Il 27 maggio 1788 a Mlle Fleury, allieva di Larive, subentra Mlle Desgarcins, giovanissima
protetta di Molé, la cui naturalezza recitativa era certamente in contrasto con quella più
ampollosa ed enfatica di Larive.
220 Il critico Le Vacher de Charnois fa riferimento all’accaduto negli stessi termini: «Quel
giorno piacque meno del solito, ebbe spesso il dispiacere di sentire levarsi dei mormorii tali
da affliggere un attore abituato a essere accolto con onore e applaudito calorosamente. La
recitazione risentì del turbamento prodotto e lo scontento del pubblico si fece sentire ancora
di più in proporzione al fatto che l’attore diventava poco convincente e più estraneo alla sua
parte. L’accaduto ha talmente desolato M. Larive che si è rammaricato che da tempo si
218
138
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
definitivamente la Comédie-Française alla quale da allora non fui più
legato dal titolo di sociétaire, senza nessuna intenzione di vendicarmi dei
miei nemici, dissi a me stesso ciò che Clitandre dice ne La Coquette corrigée:
Lo scalpore è per il vanesio, la lamentela per lo sciocco.
Il perfetto gentiluomo ingannato se ne va e non dice parola.221
Ho citato circostanze deleterie allo sviluppo del talento, citerò un episodio
che proverà quanto il mio ebbe ad avvantaggiarsi in una circostanza più
felice.
Dieci anni dopo, vivamente sollecitato dai miei vecchi compagni e su
richiesta unanime del pubblico, mi decisi a tornare in scena. Per il rientro
scelsi la parte di Edipo: mi ricorderò sempre con gratitudine gli applausi
che mi furono tributati ancor prima di apparire sul palcoscenico; la
memoria dei dispiaceri provati nel lasciare, paragonata all’entusiasmo che
il pubblico mi testimoniava universalmente, provocò nel mio animo
emozioni così intense e profonde che mi credei veramente il figlio e il
successore di Laio.222 Ero talmente compenetrato e mi lasciai andare con
tale abbandono a questa parte terribile che il mio io fu del tutto sostituito
da quello di Edipo. Quel giorno fu uno dei più radiosi della mia vita. La
felicità dipende meno da noi quanto dalle passioni o dalle illusioni
piacevoli che si impossessano di noi, perché non siamo mai più infelici che
nell’istante in cui, privi di passioni e d’illusioni, riportiamo le nostre idee su
noi stessi, così come sentiamo il pericolo di cessare d’esistere solo nel
momento in cui ci occupiamo tristemente della nostra esistenza. Il fisico
cercava di scoraggiarlo e ha dato le dimissioni» (Costumes et annales des grands théâtres de
Paris. Accompagnés de notices intéressantes et curieuses. Ouvrage périodique avec privilège du Roi,
vol. V, n° XII, 1788, p. 96).
221 Jean-Baptiste Sauvé, detto La Noue, La Civetta punita (23 febbraio 1756): «Le bruit est pour
le fat, la plainte est pour le sot, / L’honnête homme trompé s’éloigne et ne dit mot» (atto I,
scena 3). Larive aveva sostenuto la parte di Clitandre all’inizio della sua carriera, negli anni
1775-1777, quando la commedia faceva ancora parte del suo repertorio.
222 Lo spettacolo della tragedia di Voltaire si tenne il 4 maggio 1790, l’affluenza del pubblico
fu notevolissima; la presenza di Larive scatenò un entusiasmo irrefrenabile. La
«Correspondance littéraire» afferma che persino per il Charles IX di Marie-Joseph Chénier (4
novembre 1789) non si era visto un concorso così straordinario e che la parte di Edipo,
particolarmente congeniale all’attore, ne metteva in mostra tutta la sensibilità interpretativa.
Il suo talento viene percepito dai presenti con la stessa intensità che per il passato. Colpisce
la sua padronanza scenica, la sensibilità della voce, l’ascendente sugli spettatori e le
sfumature negli slanci della passione e nei momenti di meditata partecipazione (vol. XVI,
giugno 1790, p. 27). Di esaltazione generale riferisce il «Moniteur universel»: «Mai questo
attore ha riunito in una sola parte un così gran numero di quelle bellezze supreme che
annunciano il talento vero e consumato. Una dizione pura, una nobiltà fiera e seducente,
una conoscenza ragionata degli effetti, tutte le risorse dell’animo, del patetico,
dell’intelligenza, l’impiego di forme felici negli atteggiamenti del corpo e quell’arte difficile
di passare da un sentimento a un altro, da un tono rapido e elevato a uno più semplice e più
moderato, senza nulla precipitare» (n° 126, giovedì 6 maggio 1790).
139
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
influisce talmente sul morale che, in caso di cattiva salute, a volte è
impossibile superare il timor panico che s’impossessa di noi. Quattro anni
fa ne provai un effetto molto particolare.
Mlle Raucourt mi pregò di dare per lei all’Odéon, una rappresentazione di
questa stessa tragedia di Edipo.223 Nell’intervallo tra il giorno in cui glielo
avevo promesso e quello della rappresentazione, mi ammalai. Facendo
affidamento sul mio coraggio, in mancanza di salute, non osai proporle di
posticipare di qualche giorno. La sala era interamente prenotata e, per un
effetto bizzarro della malattia che mi portava a credere che ne sarei morto,
temetti di farle perdere un incasso considerevole. Arrivai a teatro verso le
quattro. La moltitudine eccezionale che gremiva la piazza e i dintorni del
teatro mi procurò un’emozione vivissima, giunsi infine attraverso una folla
immensa al camerino che mi era assegnato; mi sedetti pallido e tremante
sul divano. Uno dei direttori dell’Odéon che era presente mi disse: «Ahimè!
La povera Joly vi si è seduta una sola volta; è morta da poco e voi ne
occupate il camerino».224 Per natura non sono né influenzabile né
pusillanime, ma mi fu impossibile di non credere che stesse per arrivare la
mia ultima ora.
Si dice che c’è un Dio per i bambini, non dipese che da me, quel giorno, di
essere convinto che ne esistesse uno per gli attori. Nello stato di debolezza
in cui mi trovavo, non riuscii a capire dove trovassi la forza necessaria per
quella parte violenta; fui molto applaudito senza tuttavia poter nascondere
che ero lungi dal renderla così bene come la volta precedente.
Poiché ho parlato degli effetti che favoriscono od ostacolano gli attori, non
posso resistere al desiderio di raccontare ciò che mi è successo, in questo
genere, al mio ultimo passaggio a Bordeaux. Vi trovai un’artista così
mediocre e così collerica che era impossibile parlarle e risponderle senza
una discordanza sgradevole tanto per me quanto per il pubblico. Osai
esprimerle il mio scontento, ne fu irritatissima e si mise a detestarmi con
tutte le sue forze: ciononostante dovevo recitare con lei. In quel difficile
contesto le feci recitare la parte di Cassandra in Venceslas. Si sa che
Cassandra aborre Ladislas e gli parla solo per subissarlo di rimproveri e
d’ingiurie: la cosa riuscì alla perfezione; l’attrice, che prima era impossibile
ascoltare senza irritazione, fu talmente ispirata e gioì talmente
nell’ingiuriarmi che, dimenticando ogni affettazione, per la prima volta in
Françoise-Marie-Antoinette-Josèphe Saucerotte, detta Mlle Raucourt (1756-1815), allieva di
Brizard, aveva debuttato giovanissima alla Comédie-Française nel 1772 con notevole
successo, ma la sua vita sregolata l’aveva allontanata dalle scene per un certo periodo.
Aveva spesso recitato con Larive e, dopo la prigionia durante il Terrore, inaugurò insieme a
lui la Salle Louvois nel dicembre 1796. Si tratta dell’ultimo spettacolo del Théâtre de l’Odéon
dove l’attrice aveva trasferito la compagnia nel gennaio 1798 dopo che il Théâtre-Français de
la rue de Louvois era stato chiuso (rappresentazione data «au bénéfice» dell’attrice).
224 Marie-Elisabeth Jolly, detta Mlle Joly, allieva di Préville, recitò nel ruolo delle servette,
morì prematuramente nel 1798.
223
140
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
vita sua divenne naturale. Fui contentissimo di aver trovato l’unico mezzo
per scoprirle del talento.
In questo capitolo e in qualche altro, ho dato un resoconto delle mie
sensazioni solo per dimostrare nel contempo al pubblico e agli attori il loro
potere; ma avrei bisogno di espressioni identiche a quelle sensazioni per
descrivere convenientemente a entrambi quegli slanci sublimi che suscitano
la verità quando nulla si oppone al loro empito. Posso solo asserire che non
ho mai potuto far passare nell’anima degli spettatori sentimenti che non
avessi provato: l’amore che ho avuto per quest’arte divina è sempre stato
fondato sulle splendide sensazioni che mi suscitava. Provavo piacere a
ritrovare e ad alimentare in me quel delirio stupendo che sembrava
innalzarmi al disopra dei comuni mortali, lo ritrovavo nell’oggetto dei miei
affetti solo per riproporlo in scena dove, ricevendo nuovi stimoli,
m’infervoravo ancor di più. Parlo solo a voi anime sensibili che mai avete
svilito questo dono prezioso, questa eletta sensibilità il cui fascino è nella
natura e nella verità, voi soltanto potete capirmi.
141
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
ULTIMO INCONTRO
CAPITOLO XXI
Cause dello scadimento dei talenti; sale di spettacolo, ecc.
Non c’è nessuno che non si accorga dello scadimento in cui oggi si trova
l’arte drammatica, nessuno che non cerchi di rendersene conto e che non si
chieda da dove nasca la difficoltà di trovare dei successori a coloro che
hanno dato lustro alla scena francese.225 Questa difficoltà ha evidentemente
origine e nel sentimento scoraggiante degli affanni, degli studi e delle
contrarietà di cui questa difficile carriera è disseminata e nella nefasta
facilità con cui la gioventù riesce a conseguire effimeri successi e un
avanzamento nei nostri piccoli teatri.
Un’altra causa, che non ha meno contribuito ad alterare gli effetti di una
pura dizione, dipende dalla smisurata grandezza delle nostre nuove sale, al
loro genere di costruzione.226
La perfezione del talento degli attori risiede nella verità; la verità vuole solo
mezzi naturali e si smette di essere veri quando si è obbligati a ricorrere a
mezzi artificiali o forzati.
La natura inesauribile diversifica voci e sembianze, non offre a tutti gli
stessi mezzi; ora succede spesso che degli attori ai quali ha rifiutato
privilegi che accorda ad altri, credano sostituirli costituendosi voci
d’imitazione e fittizie: perdono così, invece, l’accento dell’anima che solo
può pervadere e avvincere quella degli spettatori.
Il primo desiderio dell’attore è di piacere e di essere applaudito. Se la
grandezza della sala non gli consente di animare e d’infiammare il pubblico
nei dettagli che esigono solo l’accento del sentimento e la semplice verità, fa
allora ricorso alle intonazioni forti che gli sono riuscite meglio, le ripropone
di continuo e così cade in una monotonia che diventa presto fastidiosa e
insostenibile. Non essendo più in grado di abbandonarsi alle piacevoli
emozioni che prova, sempre in guardia contro la debolezza dei suoi mezzi
quando è veramente emozionato è obbligato a ricordarsi che tremila
Larive volutamente ignora la presenza saliente di François Joseph Talma (nato nel 1763,
aveva debuttato alla Comédie-Française nel 1787) che, negli anni in cui il Nostro scrive,
dopo il grande successo nella parte di Charles IX nella tragedia di Marie-Joseph Chénier
(Charles IX ou l’École des rois, 4 novembre 1789) aveva raggiunto un enorme prestigio in un
articolato e vasto repertorio che era già stato in parte di Larive.
226 Larive accenna molto probabilmente alla nuova sala dell’Odéon dove la ComédieFrançaise si era trasferita nel 1782. Era il primo teatro costruito espressamente per gli attori,
progettato da Marie-Joseph Peyre e Charles de Wailly, i lavori erano iniziati nel 1779
sull’area dell’Hôtel de Condé, nei pressi del Lussemburgo. L’innovazione più rilevante è che
il parterre (platea), che ora viene denominato parquet, comporta solo posti a sedere; il teatro
poteva ospitare circa millenovecento spettatori. Fin dall’inizio si erano paventati problemi di
acustica come si evince dalla lettura delle pubblicazioni del tempo, spesso molto critiche
anche sulla struttura interna della sala.
225
142
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
persone che vogliono sentirlo non gli sarebbero grati di un sospiro se non
giungesse fino a loro.
Quando l’attore sacrifica l’accento naturale e sentimentale della voce tutto è
perduto per il talento.
La vecchia sala del faubourg Saint-Germain è quella in cui Talia e
Melpomene avevano costituito il loro impero e dove si è visto il loro più bel
regno, là si sono formate le Dumesnil, le Clairon, le Gaussin, le Dangeville,
i Baron, i Dufresne, i Lekain, i Brizard, i Préville, i Molé.227 Quella sala
aveva le proporzioni giuste e favorevoli agli accenti della voce e quegli
accenti non perdevano nulla della loro attrattiva nelle intonazioni, anche le
più delicate e le più semplici. Gli spettatori vi godevano senza sforzi e
senza tensioni. Il teatro, più facile da illuminare, permetteva di vedere tutto
e l’azione muta non andava persa come succede oggi. Il celebre Lekain era
così persuaso che una sala troppo grande fosse deleteria per il talento e la
verità che non volle acconsentire a recitare in quella delle Tuileries se non a
condizione che il fondo fosse ravvicinato: fu fatto senza tener conto della
perdita di quaranta o cinquantamila libbre d’incasso annui e tuttavia quella
sala era metà meno grande di quelle che ci sono oggi.228
Conosco ciò che si dice sull’immensità dei teatri presso gli antichi, ma il
loro sistema drammaturgico sembra esser stato del tutto diverso dal nostro.
Avevano per aumentare la statura, enfatizzare i tratti e rafforzare la voce
dei segreti che sono andati persi e che forse non dobbiamo rimpiangere.
Non ignoro neanche che in Italia ci sono molte sale immense nelle quali si
sente persino un sospiro, ma l’arte di costruirle con tale perfezione non è
ancora giunta fino a noi.
Le esibizioni da me realizzate, in più di una cinquantina di teatri dove ho
recitato durante diverse tournée, mi hanno dimostrato che quelli che hanno
le giuste proporzioni sono i soli nei quali l’attore possa apparire per ciò che
è.229 Potevo abbandonarmi senza sforzo né fatica ai miei mezzi naturali,
Nella gloriosa sala della rue des Fossés Saint-Germain-des-Prés (oggi rue de l’Ancienne
Comédie), inaugurata nel lontano agosto 1689 si erano succeduti i più grandi interpreti del
tempo cui accenna Larive. Gli attori avevano acquistato il Jeu de Paume de l’Étoile e due
fabbricati contigui poi in parte abbattuti, il progetto di ricostruzione era stato affidato a
François d’Orbay, la sala aveva una capienza di circa duemila posti.
228 Nel 1770 gli attori avevano dovuto lasciare la sala des Fossés Saint-Germain, ormai
fatiscente, e nell’attesa della costruzione di un nuovo teatro, che si protrae per più di dieci
anni, si erano dovuti adattare nella sede temporanea delle Tuileries. Costruito tra il 1660 e il
1662 da Louis Le Vau e Carlo Vigarani per i grandi spettacoli à machines era uno spazio
immenso con la capacità virtuale di seimila posti, destinato in prevalenza agli spettacoli
dell’Académie Royale de Musique; malgrado gli adattamenti escogitati dall’architetto
Germain Soufflot (1713-1780), per renderlo più fruibile, non offriva un’acustica del tutto
adeguata (circa milleottocento posti).
229 Rientrava nelle consuetudini della Comédie che gli attori avessero diritto ad allontanarsi
da Parigi per recitare in provincia. È soprattutto negli anni Ottanta che Larive compie molte
fortunate tournée e non solo in Francia, ma anche in Svizzera e in Belgio, se ne hanno echi a
227
143
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
potevo avvincere gli spettatori e disporre a mio piacimento di ogni loro
sensazione; per ottenere quel successo, bisogna che un gesto, uno sguardo
possano essere colti senza essere forzati, che la voce abbandonandosi,
concentrandosi e spegnendosi quasi sia ancora sentita e che la mimica,
premonitrice delle espressioni dell’anima, sia vista in egual misura da tutti
gli spettatori. L’azione muta sostiene l’interesse della rappresentazione e
contribuisce di più all’insieme.
A causa del difetto di proporzione che regna nelle nostre nuove sale, è
impossibile che gli attori possano soddisfare allo stesso tempo quelli che
sono troppo vicini al palcoscenico e quelli che ne sono troppo lontani,
devono inevitabilmente sembrare troppo forzati per gli uni e troppo deboli
per gli altri.
Marmontel nelle sue osservazioni sull’arte della declamazione ha detto che
era necessario che la pronuncia fosse più marcata che in società dove la
comunicazione avviene più da vicino, ma sempre nelle proporzioni della
prospettiva e cioè in modo che l’espressione della voce fosse ridotta a un
grado naturale quando arriva all’orecchio degli spettatori.230 Marmontel ha
ragione per la pronuncia e l’articolazione delle parole e delle sillabe, ma
non per l’emissione e l’espressione della voce. Se è forzata nell’uscire dalla
bocca dell’attore, è impossibile che arrivi in modo naturale all’orecchio
degli spettatori, deve allora perdere necessariamente il suo accento e il suo
vellutato e non può giungere che dura e secca fino a quelli che sono più
distanti. Se invece l’attore, senza riguardo per le proporzioni negative della
sala trascura di forzare la voce, allora non arriva ai posti lontani che debole
e inespressiva.
A questi inconvenienti comuni, il Théâtre de la République ne aggiunge
altri che sono peculiari alla sua costruzione.231 Le colonne e i tramezzi che
dividono i palchi ostacolano talmente la voce che il pubblico che li occupa
non sente nulla di quanto viene detto in scena e non si crede obbligato a
controllarsi più che a casa propria. Gli spettatori che vogliono ascoltare non
hanno più la facilità di testimoniare il loro malcontento a chi turba il loro
piacere e, da questi movimenti contrari, risulta un brusio sordo che nuoce a
tutti i begli effetti dello spettacolo. L’attore che ne è infastidito, a volte non
sentendo neanche se stesso, non è padrone di prendere la voce nel tono che
gli è naturale.
Nantes (1780), a La Rochelle, a Ginevra (1784), a Lille (1784 e 1785), a Bordeaux (1785) e a
Marsiglia (1787).
230 Marmontel, Déclamation théâtrale, articolo dell’Encyclopédie, ed. 1754, vol. IV.
231 Gli attori dell’antica Comédie-Française si dividono nel 1791 in due compagnie connotate
da opposte vedute politiche: Il Théâtre-Français o Théâtre de la République, Rue de
Richelieu (attuale sede della Comédie-Française) e il Théâtre de la Nation (attuale Odéon). Il
Théâtre-Français realizzato fra il 1786 e il 1790 dall’architetto Victor Louis per il teatro delle
Variétés amusantes, viene ribattezzato Théâtre de la République il 30 settembre 1792 (già
Théâtre de la Liberté et de l’Égalité); aveva una capienza di milleseicento posti.
144
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Diciamolo francamente, uno spettacolo così solenne come la tragedia è
fuori posto nel quartiere più rumoroso di Parigi dove sono riuniti tutti i
generi di piaceri.232 Desidererei che Melpomene non si trovasse sulla strada
degli sfaccendati che vanno a teatro più per gli spettatori che per lo
spettacolo. Il faubourg Saint-Germain, la sua antica sede, era il quartiere
che più le si addiceva. L’università le forniva i suoi innamorati fedeli; da
quando li ha perduti non ne ha più che di volubili.
Uno dei privilegi che più contribuiscono al perfezionamento dei talenti
dipendeva dal vivo interesse manifestato dalle persone raffinate e dai veri
intenditori. Erano più numerosi in una piccola sala di quanto non lo siano
oggi in una grande, potevano darvi il tono, sostenere gli attori nelle loro
capacità naturali, consigliare i giovani talenti quando si allontanavano dal
carattere della loro parte, ecc., ecc.233 Questo mezzo di perfezione non esiste
più dopo le perdite irrimediabili fatte dalle arti e dopo che tanti motivi
diversi hanno turbato e disperso gli appassionati che esistono ancora.
Anche l’orario del pranzo si è troppo ravvicinato a quello degli spettacoli.
Non è alzandosi da tavola che ci si può facilmente immedesimare in una
situazione tragica; alla fine di un banchetto si è più disposti all’allegria che
alla tristezza. Credo che oggi la tragedia ci guadagnerebbe se si abolissero
le pièces brevi e se si iniziasse un’ora dopo: una parte del pubblico, che
entra tra il primo e il secondo atto, avrebbe il tempo di arrivare per
l’esposizione, godrebbe di più e gli attori non sarebbero disturbati dal
rumore di quelli che entrano dopo l’inizio della rappresentazione.
Ancora altre cause concorrono alla nostra decadenza teatrale, esistono negli
attori stessi più che nelle sale e nel pubblico. Ne ho parlato in altri capitoli
ed è inutile ripetermi.
Il Palais-Royal, alle cui gallerie è addossato il Teatro, era diventato il cuore pulsante della
capitale. Lo spazio attorno al giardino centrale era stato riorganizzato dal duca Louis
Philippe d’Orléans, il futuro Philippe Égalité, che tra il 1781 e il 1784 aveva fatto costruire
unità abitative e negozi di vario genere. Luogo di incontri tra i più frequentati di Parigi, oltre
a un florido commercio, ospitava club privati, case da gioco e di piacere.
233 Due anni dopo la situazione non è affatto migliorata malgrado il «delirio universale» per
il teatro, il pubblico, costituito per lo più da soldati, studentelli, operai, impiegati statali,
nuovi ricchi, non ha le necessarie competenze di giudizio: «Questi spettatori, parimenti
estranei alle conoscenze preliminari che il gusto per il teatro necessita e suppone, ignorando
persino i primi elementi della grammatica e della versificazione, non sanno distinguere la
prosa dal verso, il comico dalla farsa, l’ampollosità dal sublime, il patetico dal lacrimevole»,
Cfr.: «Le Censeur dramatique ou Journal des principaux théâtres de Paris et des
départemens», par une Société de Gens-de-lettres; rédigé par A. B. L. Grimod de La
Reynière, M.DCC.XCVII, 4 voll., vol. I, p. 6.
232
145
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
CAPITOLO XXII
Della critica, della necessità e dei mezzi per salvare i teatri
La critica è facile e l’arte è difficile.234
E se mi si concede di azzardare di sfuggita una parola sull’abuso che alcuni
giornalisti fanno della libertà di scrivere, dirò che la portano a una
esagerazione che può trovare scuse solo nella necessità di riempire ogni
settimana i loro fogli.
Eh! perché non hanno sotto gli occhi questi versi di M. Vigée?235
C’è una critica benevola, garbata,
Direi persino affabile nella sua severità
Che sempre sceglie per guida la verità.
Di uno scritto valuta la forza e la debolezza,
E si duole in segreto del difetto che la colpisce.
Biasimando con misura, approvando senza esagerazione
Spiana al giovane l’accesso al Parnaso,
Avverte lo scrittore maturato dagli anni
Che è tempo di realizzare i suoi alti destini;
Al vecchio, la cui penna divaga quasi a caso,
Consiglia di ritirarsi prima che sia troppo tardi;
Non è asservita ad alcun partito, non vende alcun suffragio
Non vede mai l’autore, solo la sua opera;
E con una giusta considerazione, per correggerlo meglio,
Rifiuta la battuta che potrebbe addolorarlo.
Ma ce n’è un’altra, emula dell’invidia,
Destouches, Le Glorieux, atto II, scena 5: «La Critique est aisée, et l’art est difficile».
Louis Jean-Baptiste Étienne Vigée (1758-1820), autore di brevi commedie, poesie e articoli
giornalistici. I versi qui riportati che fanno parte di un poema intitolato «Encore une visite»
figurano in varie raccolte, cito in particolare, Poésies de L. J.-B. E. Vigée, 5ème édition, corrigée et
augmentée de pièces inédites, Paris, Delaunay, 1813, pp. 44-45. «Il est une critique obligeante,
polie, / Je dirais même affable en sa sévérité, / Qui pour guide toujours choisit la vérité, /
Balance d’un écrit la force et la faiblesse, / Et gémit en secret du défaut qui la blesse. /
Blâmant avec réserve, approuvant sans effort, / Du Parnasse au jeune homme elle aplanit
l’abord, / Avertit l’écrivain mûri par les années, / Qu’il est tempos d’accomplir ses hautes
destinées; / Au vieillard, dont la plume erre presque au hasard, / Conseille la retraite avant
qu’il soit trop tard; / Ne sert à aucun parti, ne vend aucun suffrage, / Ne voit jamais
l’auteur, ne voit que son ouvrage; / Et par un juste égard, pour le mieux corriger, / Se refuse
au bon mot qui pourrait l’affliger. / Mais il en est une autre, émule de l’envie, / Qui
condamne à plaisir, à plaisir humilie; / Et s’aveuglant soi-même en sa malignité, / Ne veut
voir qu’un défaut où brille une beauté. / Celle-ci, de nos jours, par malheur trop commune,
/ S’attache à tous les noms dont l’éclat l’importune; / Dès qu’un jeune talent croit pouvoir
se montrer, / Se fait un jeu cruel de le désespérer; / Aux talents reconnus, dont s’illustre
notre âge, / Prodigue, au lieu d’encens, et le blâme et l’outrage, / Met son bonheur à nuire
et sa gloire à blesser, / Sourit d’avance au trait que sa main va lancer: / Tantôt, pour égayer
ses injures banales, / Emprunte les rebus, les quolibets des halles; / Tantôt, pour satisfaire à
ses fougueux transports, / Jusque dans leurs tombeaux court insulter les morts; / De
lauriers déchirés jour et nuit s’environne, / Offense tout le monde et n’éclaire personne».
234
235
146
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
Che condanna e umilia senza averne motivo;
E rendendosi cieca nella sua malignità,
Non vuol vedere che un difetto là dove brilla una bellezza.
Sfortunatamente troppo conosciuta ai giorni nostri
Si appiglia a tutti i nomi la cui fama l’infastidisce.
Non appena un giovane talento crede potersi mostrare,
Si fa un gioco crudele di fargli perdere la speranza;
Ai talenti riconosciuti che danno lustro al nostro tempo
Prodiga, invece dell’incenso, e il biasimo e l’oltraggio,
È felice di nuocere e si gloria di ferire,
Sorride in anticipo allo strale che la sua mano lancerà,
Talvolta, per ravvivare le sue banali ingiurie,
Prende in prestito le battute e i sarcasmi dei facchini,
Talaltra, per soddisfare i suoi empiti focosi,
Corre a insultare i morti fin nella loro tomba;
Notte e giorno si circonda di allori strappati,
Offende tutti e non fa brillare nessuno.
In questi versi il poeta indica ai giornalisti il loro dovere. Stabilisce una
giustissima distinzione tra la critica che vuole, che può essere utile, e quella
che ha il solo scopo di nuocere e di scoraggiare; quanto dice in relazione
alla letteratura può essere applicato a tutte le arti. Nondimeno renderò la
giustizia che è loro dovuta al novero dei giornalisti che hanno meritato la
pubblica stima; questi non vendono né le loro critiche né i loro elogi,
sempre giusti estimatori dei talenti pur facendo notare i difetti di un artista
ne parlano con riguardo, senza bisogno di denigrare continuamente gli uni
per mettere in valore gli altri e senza dipartirsi dalla giusta misura che
distribuisce a ciascuno quanto gli appartiene. Sanno che la critica che si
esercita sugli attori deve avere come unico scopo di far luce sui loro difetti,
senza mescolare alle censure sarcasmi insultanti e calunnie, né scoraggiare
con una severità eccessiva, bensì accendere in loro quella lodevole
emulazione che li sostiene nelle fatiche dando loro la speranza di
raggiungere la perfezione. Questi uomini onesti e giusti rispettano
bastantemente i giudizi del pubblico e non si permettono di snaturare
l’indomani quanto emesso il giorno precedente: sanno che è impossibile
esser ogni giorno uguali a se stessi nell’arte che esercitano e che esige
continuamente da noi ciò che non sempre da noi dipende: perché sarebbe
necessario che ogni giorno, a tale ora, a tale momento, potessimo avere in
salute, in forza, in semplicità, in energia e in esaltazione tutto quanto serve
per esprimere in un’ora ciò che un autore non ha potuto concepire che
dopo lunghe riflessioni e molto tempo. L’autore ha in più il vantaggio di
poter sopprimere e cancellare ciò che non approva, ma per noi che
dobbiamo all’alzarsi del sipario dare una nuova vita all’opera, infiammare
gli spettatori distratti, essere sicuri di esprimere tutto nel modo giusto
poiché un’espressione, un gesto una volta osati non possono più essere né
corretti né trattenuti, è fisicamente impossibile poter essere ogni giorno
sempre allo stesso livello.
147
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Chi è sempre adeguato non può mai superarsi, ci sarebbe nella sua
recitazione qualcosa di uguale e di monotono che resterebbe al di sotto
nelle situazioni solenni e forti. Voltaire stesso era così compenetrato da
questa verità che credeva, quando recitava le sue tragedie nel teatro di
Ferney, doversi vestire fin dal mattino col costume necessario alla parte che
avrebbe interpretato la sera; non temeva di ammettere che aveva bisogno
del costume per immedesimarsi del tutto nel personaggio che avrebbe
rappresentato. Non posso scrivere qui il nome di questo grand’uomo senza
ricordare l’interesse che portava alla difficile arte dell’attore e la sua
particolare indulgenza nei miei confronti. Mi aveva visto interpretare
Zamore quindici giorni prima della sua morte ed ebbe la bontà di
testimoniarmi la sua soddisfazione.236 Incoraggiato da questa
ragguardevole approvazione, pensai di dover andare a pregarlo, otto giorni
dopo, di ascoltarmi nella prova di una parte; lo trovai molto prostrato, mi
disse vedendomi entrare: «Ah! amico mio, non posso più occuparmi delle
cose di questo mondo, sto morendo. Eh!, Signore, gli risposi dispiaciuto,
sono vivamente afflitto dallo stato in cui vi vedo! Domani devo interpretare
Tito e, pensando di trovarvi in buona salute, avevo osato sperare che vi
sareste degnato di ascoltare la mia prova».237
All’improvviso fissa su di me i suoi occhi d’aquila: il suo volto e i suoi
movimenti riprendono vigore. Mi dice, alzando le mani col gesto teatrale
che gli era consueto: «Come, amico mio! Domani recitate Tito; ah! in questo
caso non c’è morte che tenga, bisogna che ve lo faccia provare».
Immediatamente si alza dalla poltrona, va a cercare il testo nel volume
delle sue opere e mi fa provare con tanto interesse che sorrideva con bontà
quando era contento e si arrabbiava seriamente se qualche cosa non gli
andava a genio, e allora in quel fervore, sconcertato o piuttosto stordito dal
frastuono, osai dirgli: «Ma, Signore, se gridate così contro di me, non
Voltaire muore il 30 maggio 1778. Era tornato a Parigi agli inizi di febbraio dopo un esilio
di ventisette anni, ma in condizioni fisiche assai critiche. Malgrado la sua debolezza aveva
assistito il 30 marzo alla rappresentazione della sua Irène; alla fine dello spettacolo il busto di
Voltaire, opera di Jean-Baptiste Lemoyne del 1744 regalata dallo scultore Jean-Jacques
Caffieri alla Comédie, venne posto su in piedistallo al centro della scena e incoronato da
tutti gli attori che recano fiori e ghirlande. Per lo spettacolo di riapertura della ComédieFrançaise, il 27 aprile, era stata riproposta la tragedia Alzire con Larive interprete del
sovrano Zamore, era la prima volta che si cimentava con questo personaggio dopo la morte
di Lekain. Il recensore del «Journal de Paris» sottolineava quanto fosse una delle parti «tra le
più forti e le più difficili e in cui i grandi talenti dell’attore che rimpiangiamo si
manifestavano al meglio. Benché la memoria ne sia ancora recente, l’interpretazione del
sieur de Larive è molto piaciuta e ha ricevuto da parte di M. de Voltaire i complimenti più
lusinghieri» (1778, p. 108).
237 Il Brutus di Voltaire andrà in scena il 4 maggio.
236
148
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
riuscirò a recitare». Mi rispose, gridando ancor più forte: «Non grido contro
di voi, amico mio, grido per voi».238
Lo riconosco, gli attori non hanno più oggi simili incoraggiamenti, al
contrario le ostilità sembrano moltiplicarsi intorno a loro. Per finire credo
dunque doverli esortare ad armarsi soprattutto di coraggio e di costanza e a
disdegnare gli intrighi. Il tempo che si trascorre a guardare dietro e accanto
a sé è del tutto perso; lo scopo che ci si propone di raggiungere sembra
allontanarsi ogni giorno e vi si arriva solo in fine corsa. Non ho sempre
pensato così, ma oggi che la mia carriera è compiuta credo dover fare
osservare ai miei compagni che non sono che i depositari dei capolavori di
cui la nazione si onora e che non hanno il diritto di privare questa nazione
sensibile del diletto di ammirarli. Il solo piacere di far rinascere molte opere
del tutto dimenticate, mi aveva spinto a prolungare la mia carriera
teatrale;239 ma contrariato di continuo da perfide intenzioni, stanco da
trentatré anni di attività, provato infine da pene d’amore e da dispiaceri
cocenti, non vedo oggi altra speranza, per la mia mente attiva, che quella di
coltivare i tesori che la natura benefica offre a tutti gli uomini, almeno a
quelli che come me, senza ambizioni né rimpianti, sanno apprezzare le
delizie di un modesto e piacevole ritiro.
Felice chi, appagato della propria umile fortuna,
Libero dal giogo superbo in cui fui vincolato,
Vive nello stato oscuro dove gli dei l’hanno nascosto!240
Larive, oltre alle nove tragedie citate nel Cours (ricordo, per ordine alfabetico: Adélaïde du
Guesclin, Alzire ou les Américains, Brutus, Mahomet ou le Fanatisme, Œdipe, L’Orphelin de la
Chine, Sémiramis, Tancrède e Zaïre), ha anche recitato nelle seguenti pièces di Voltaire (tra
parentesi il personaggio da lui interpretato e la data della prima rappresentazione):
L’Écossaise ou le Café, commedia (Lord Murray, 5 ottobre 1777), L’Enfant prodigue ou l’Ecole de
la jeunesse, commedia (Euphémon fils, 26 agosto 1777), Mérope (Égisthe, 4 novembre 1778),
La Mort de César (Brutus, 21 febbraio 1783), Nanine ou le Préjugé vaincu, commedia (comte
d’Olban, 27 ottobre 1776), Olympie (Cassandre, roi de Macédoine, 20 ottobre 1781), Oreste
(Pilade, 17 dicembre 1776), Rome sauvée (Catilina, 10 luglio 1779).
239 Il suo ritorno in scena nel maggio 1790 al Théâtre de la Nation (così era stato rinominato il
Théâtre-Français nel dicembre 1789) avviene dopo lunghe trattative condotte con molto
circospezione da alcuni sociétaires della Comédie-Française che, non vedendo di buon occhio
le novità che voleva imporre Talma e la sua fulminea ascesa, si trovavano nella necessità di
avere a disposizione un attore in grado di contrastarlo. Era stato concordato che avrebbe
recitato solo una volta a settimana per ragioni di salute e mai in parti nuove, che avrebbe
proposto un suo repertorio e che sarebbe stato retribuito unicamente per le prestazioni
effettuate (compenso fisso di cinquecento libbre) senza partecipare ad alcun beneficio, libero
di potersi ritirare dalle scene in qualsiasi momento. Il suo addio definitivo, dopo incresciosi
episodi d’incomprensione da parte degli attori e del pubblico, avvenne nel maggio 1801.
Quel giorno, il 25 fiorile, interpretava il personaggio di Oreste nell’Andromaque di Racine.
240 Racine, Iphigénie: «Heureux qui, satisfait de son humble fortune, / Libre du joug superbe
où je fus attaché, / Vit dans l’état obscur où les Dieux l’ont caché!», battuta di Agamennone
all’inizio della tragedia (atto I, scena 1, vv. 10-13).
238
149
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Che mi sia ancora permesso, senza troppo abusare della pazienza dei miei
lettori, di sviluppare le mie idee sui mezzi per far rapidamente rinascere
attori degni di onorare la scena. Nelle comuni professioni della vita ognuno
ha il diritto di consultare le proprie preferenze e le proprie inclinazioni e la
società non ha quello di chieder conto a un individuo di ciò che fa quando
la professione che esercita non può recar torto che a lui; ma se questa
professione interessa l’intera società non dovrebbe essergli permesso di
sceglierla senza il suo consenso. Desidererei dunque che fosse possibile
stabilire una specie di commissione, composta da artisti e da cultori
ragguardevoli per il loro gusto, per la purezza dei loro costumi e per le
conoscenze acquisite, che fosse incaricata di ammettere o di respingere tutti
quelli che si consacrano al teatro, dopo aver giudicato le loro attitudini. Mi
si potrà obiettare, forse, che i talenti ci sono sempre stati senza adoperare i
mezzi da me proposti. Risponderò che all’epoca in cui abbiamo avuto la
maggior presenza di attori d’ingegno, i teatri e i generi non erano così
numerosi come lo sono oggi241 e che a quell’epoca il gran numero di novità
degne dell’ammirazione pubblica obbligava gli attori a studi approfonditi e
a conoscenze che la maggior parte di loro hanno potuto tralasciare di
acquisire utilizzando il proprio talento nelle rappresentazioni di novità di
tutt’altro genere. I drammi hanno iniziato questa decadenza, le mostruosità
tragiche le hanno dato il colpo di grazia: da quel momento si sono viste
avventurarsi nella carriera teatrale persone la cui recitazione consiste
essenzialmente in esagerazioni e smorfie. Spesso inoltre hanno avuto la
ridicola pretesa di formare degli allievi e persino allievi in ogni genere, il
male si è allora allargato quasi illimitatamente. Chi non ha nessuna delle
qualità richieste per essere la voce dei nostri capolavori disturba,
svilendola, l’armonia della rappresentazione, ne distrugge l’illusione, ne
disgusta il pubblico e provoca pregiudizio tanto alla memoria degli autori
che hanno immortalato la nostra scena quanto agli artisti e ai direttori. Ho
sempre sentito dire che noi stessi non ci conosciamo, ora chi non si conosce
non deve avere il diritto di disporre della società disponendo di se stesso.
Il teatro è la scuola dei costumi e anche delle passioni, di frequente è alla
rappresentazione di una bella tragedia che una giovane e onesta persona
emette il suo primo sospiro, là avverte il bisogno di amare la tenera
apprensione che la tormenta per la prima volta, non la lascia più finché non
si è fissata su un oggetto. Si deve dunque fare attenzione a che le passioni
siano espresse con adeguata verità né di conseguenza essere troppo severi
sulla scelta dei soggetti che possono ispirare, in modo più o meno puro e
casto, sentimenti da cui dipende la felicità o l’infelicità della gioventù. Lo
scopo precipuo delle rappresentazioni drammatiche deve essere di far
Già alla fine dell’Ancien Régime, ma poi soprattutto con la Rivoluzione, i palcoscenici
parigini si erano moltiplicati a dismisura e diversificati i generi teatrali.
241
150
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
amare la virtù nel descriverne i vantaggi e di far detestare il vizio
mostrandolo in tutto il suo orrore.
Il teatro influisce grandemente sui caratteri che molto spesso cominciano a
svilupparsi proprio da qui. Il giovane ancora troppo timido per confessare
a se stesso gusti e inclinazioni, comincia a sentire e a riconoscersi alle
rappresentazioni delle nostre tragedie, cerca nelle diverse passioni che vede
esternate quelle più simili alle sue passioni nascenti.
I primi slanci d’amore per la patria si manifestano con le tragedie romane
di Corneille, con Orosmane impara ad amare, con Achille avverte la
necessità della gloria, con Augusto apprende a perdonare e con Burro
conosce la virtù austera. Se gli attori incaricati d’interpretare quei grandi
caratteri che devono arrecare profonde impressioni nel cuore sensibile della
gioventù non ne provano il sentimento, se ne indeboliscono l’eloquenza
travolgente, se tolgono loro, per mancanza di talento e ancor più per
freddezza d’animo o mediocrità di spirito, il nobile impero della virtù, non
lo faranno amare; se non sanno rappresentare il vizio in tutto il suo orrore il
giovane dimenticherà forse i princìpi di Burro per non ricordarsi che della
crudeltà di Nerone e delle perfidie di Narciso.242
Ah! se avessi un’eloquenza pari alla sensibilità che provo! riuscirei a
persuadere di ciò che esprimo solo in modo sommesso e avrei la speranza
di essere utile nel contribuire a moralizzare i nostri teatri e a ricondurre per
loro tramite alcuni di questi uomini, che si sono smarriti lungi dagli affetti
della natura e della società ben ordinata, a quello stato naturale e sociale
che ci dà per i nostri simili i generosi sentimenti per i quali l’uomo è legato
all’uomo. Non ne esiste neanche uno, per quanto fiero sia diventato, che,
tornato per qualche momento in se stesso, non pianga sullo stato di
stordimento in cui è sprofondato. Si sono degradati così dopo aver esaurito
gli influssi positivi che la natura distribuisce a tutti equamente; è allora che
non hanno trovato per il loro cuore disincantato altro alimento se non una
miserevole depravazione e altra risorsa contro la noia se non lo sconcerto
del crimine. Lo zelo del governo nell’incoraggiare le arti ci dà infine la
speranza consolatoria di vederle ben presto rifiorire. Chi è giunto, con
instancabile energia, a riportare ovunque l’ordine dove regnava l’anarchia,
sentirà, meglio di ogni altro, che una delle più belle ricchezze della nazione
è costituita dai capolavori creati da Racine, Corneille, Voltaire, ecc., ecc.; che
le rappresentazioni di questi capolavori possono, meglio dei discorsi dei
moralisti, frugare nel cuore dell’uomo e sviluppare e concentrare in lui ogni
risorsa dell’animo; non ce n’è uno che non possa contribuire alla felicità del
proprio paese, della famiglia, della società quando queste risorse sono
Accenno ai personaggi del Britannicus [Britannico] di Racine, Théâtre de l’Hôtel de
Bourgogne, 13 dicembre 1669. Larive aveva recitato nella parte di Nerone tra il 1775 e il
1785.
242
151
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
messe in moto dalla rappresentazione fedele delle nobili passioni espresse
con energia e verità.
L’uomo che è stato colpito dalla grandezza d’animo di Augusto uscendo da
una rappresentazione di Cinna smette di odiare il proprio nemico, persino
colui che avrebbe voluto uccidere recandosi a teatro lo abbraccerebbe
volentieri se lo incontrasse uscendo da quello spettacolo sublime. La donna
pregna della grandezza d’animo di Paolina in Polyeucte, accompagnata a
questa rappresentazione dall’amante che vuol renderla infedele, ritira, con
severità, uscendo, la mano che entrando aveva porto con affetto.243 La
giovane e pudica persona che ha visto recitare Œdipe chez Admète,
profondamente colpita dalle virtù di Antigone, raddoppia affetto e
tenerezza per i genitori;244 il giovane che ha visto Les Horaces si appassiona
con ardore alla gloria del proprio paese.
A tanti felici effetti si potrebbe ancora aggiungere l’inestimabile vantaggio
offerto ai giovani letterati dalle ricchezze e dalla perfezione della nostra
bella poesia. Possono vedervi che i nostri grandi autori hanno saputo
sormontare tutte le difficoltà addotte dalla mediocrità e persino troppo
spesso amplificate, per farsene una scusa. Malgrado il rigore dei nostri
princìpi che obbligano alla tirannia della rima, hanno saputo, senza alterare
la forza e la dignità del loro pensiero, redigere i loro versi in modo che ogni
parola esprima una cosa, un sentimento o un’idea e sempre con eleganza
quanto con grazia ed energia. I poeti drammatici Inglesi, Italiani e Tedeschi
non hanno le stesse limitazioni e tuttavia sono ben lungi dal raggiungere la
stessa perfezione.
Credo aver detto abbastanza per provare l’utilità degli spettacoli, sarebbe
un compito superiore alle mie forze risalire alle origini dei nostri teatri e
mostrare l’influenza che i loro capolavori hanno avuto sugli sviluppi della
nostra lingua e su questa affabile gentilezza che caratterizza i Francesi, ma
non credo sbagliare nel considerarli come una delle cause principali della
nostra civiltà e della nostra gloria letteraria. Forse senza i nostri teatri non
avremmo mai avuto, anche in altri generi, dei Racine, dei Corneille, dei
Voltaire, né dei Molière; l’emulazione nasce dai successi e dagli applausi, e
se la religione ci ha dato i Bourdaloue, i Bossuet, i Massillon, ecc., ecc., li
dobbiamo forse solo al piacere che trovavano nel recitare in pubblico le loro
eloquenti opere, a essere testimoni delle profonde emozioni che
comunicavano a un numeroso uditorio e delle lacrime che facevano
spargere.245 Ci piace vedere, non solo in modo speculativo e in prospettiva,
Pierre Corneille, Polyeucte, martyr [Poliuto martire], Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, 16401641.
244 Jean-François Ducis, Edipo da Admeto, 4 dicembre 1778; Larive aveva recitato, alla
creazione della tragedia, la parte di Admeto.
245 Louis Bourdaloue (1632-1704), Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) e Jean-Baptiste
Massillon (1663-1742) illustri predicatori molto seguiti anche dalla corte e autori di celebri
Orazioni funebri e Sermoni.
243
152
Jean Mauduit-Larive, Corso di declamazione diviso in dodici incontri
ma in azione e movimento, tutto ciò che scaturisce dalla nostra
immaginazione; è nel parlare, nell’agire e nel mettere in moto il proprio
coraggio e la propria energia che l’uomo s’innalza al disopra dell’uomo o
piuttosto a tutta l’elevatezza alla quale è chiamato dalla sua natura.
153
AAR Anno VI, numero 11 – Maggio 2016
Signori,
Questo incontro sarà l’ultimo del Corso che ho creduto poter inaugurare,
non so quali siano le intenzioni che mi siano state ascritte, ma ecco i miei
motivi. Dopo una lunga consuetudine con la scena, dopo molteplici saggi e
posso dirlo, dopo incoraggiamenti lusinghieri, nel ritiro che mi ero creato,
lo sguardo errabondo sulle opere immortali dei Corneille, dei Racine, dei
Voltaire e sui ritratti dei Baron, dei Lekain, delle Dumesnil e delle Clairon,
felice e triste a volte dei miei svaghi, riportavo la vista su quel palcoscenico
dove avevo tante volte provato la compiacenza del pubblico benevolo e
dicevo tra me: Tutti i miei sforzi sono perduti per me, se non lascio sulla
carta almeno qualche traccia delle sensazioni che ho provato e che ho
cercato di far provare agli altri, e allora ho preso la penna. Non volevo
essere autore: per esserlo bisogna unire a un’imponente erudizione tutte le
grazie dell’artificio, e ogni volta che volevo avere dello spirito, sentivo che
avevo solo animo: ma infine bisognava sapere se il mio animo non fosse a
volte ingannato nelle sue emozioni o se la mia arte le avesse fedelmente
espresse, e di conseguenza, prima di pubblicare la mia opera ho voluto
sondare il gusto di un uditorio selezionato, ho quindi annunciato un Corso
di Declamazione. Quale non è stata la mia felicità, Signori, quando ho
constatato il vostro interessamento? Una piacevole illusione, lo confesso, ha
dissipato i miei timori, ha cancellato il pericolo di un’impresa che poteva
avere un risultato infelice: selvaggio abitatore dei boschi, rientravo in una
lizza dove da tempo non ero più apparso. Tra voi, Signori, ho ritrovato
quell’amabile benevolenza che fa amare tutto, che rende tutto piacevole e
che mi farà mettere nel novero dei giorni più fortunati quelli in cui la mia
anima ha potuto manifestarsi liberamente e senza timore nella vostra. Mi
sono visto come un amico (perdonate, Signori, alla riconoscenza, questo
paragone di cui gode il mio cuore); sì, mi sono guardato come un amico
che, lontano dai suoi per una tempesta, si ritrovava con loro in un’isola
fortunata: ma stiamo per separarci, il solo ricordo della vostra indulgente
bontà mi seguirà nel mio ritiro, allieterà il mio tempo libero, diletterà il mio
cuore riconoscente col puro piacere da me provato… Ma come osar parlare
di piacere nel momento di separarci? Risparmiatemi, Signori,
dall’aggiungere altro.
FINE
154