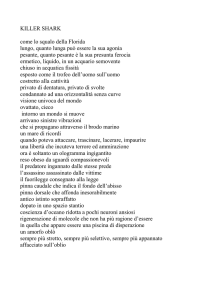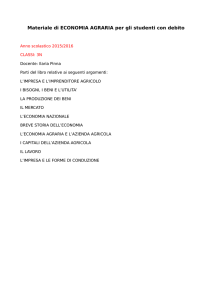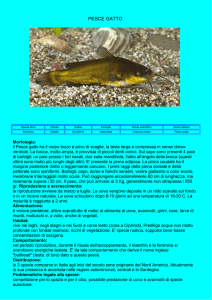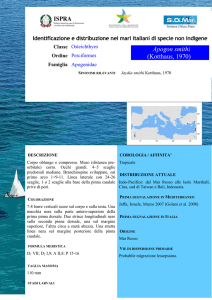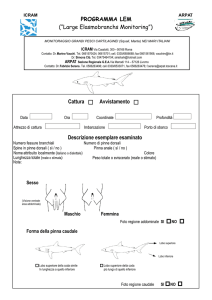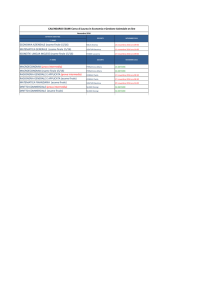Franco Pinna. Fotografie 1944-1977, in “Ossimori”, 8, 1996, pp. 114-117
[recensione a Franco Pinna. Fotografie 1944-1977, Milano, Motta, 1996].
_______________________________________________________________
Franco Pinna. Fotografie 1944 - 1977
a cura di Giuseppe Pinna, Maria Stefania Bruno, Claudio Domini, Giorgio Olmoti
con testi di Annamaria Greci, Giuseppe Pinna, Wladimiro Settimelli, Lello Mazzacane,
Franco Cagnetta, Giovanni Berlinguer e Piero Della Seta, Antonello Ricci, Franco
Lefèvre, Renzo Renzi
Milano, Motta, 1996, 320 pp., 260 ill.
In una elegante edizione tipografica per i tipi dell’Editore Federico Motta, è
uscito il volume Franco Pinna. Fotografie 1944 - 1977, che costituisce il catalogo della
mostra antologica dedicata all’opera di Franco Pinna, intitolata «Da De Martino a
Fellini: Franco Pinna. Fotografie 1944 - 1977». La mostra, allestita dalla società
Alfomega Produzioni Culturali, è stata finora ospitata a Siena, Napoli, Sassari, mentre
diverse altre sedi in Italia e all’estero sono previste per il triennio 1996-98.
Nel volume, che appare del tutto indipendente dalla mostra, 260 immagini fotografiche (204 B/N, 56 colore), di cui alcune già edite, altre inedite, testimoniano in
modo inequivocabile la centralità della produzione di Franco Pinna nella storia della
cultura fotografica italiana. L’opera è introdotta dalla testimonianza di Annamaria
Greci, la sua compagna di vita, che, nonostante l’ultima volontà del marito
(“Distruggete tutto l’archivio, grazie”), ha conservato, tenacemente, ostinatamente e
consapevolmente tutti i materiali fotografici, per consegnarli alla società e alla storia.
Seguono il saggio introduttivo di Giuseppe Pinna (la cui omonimia con il fotografo è
puramente casuale) e altri sette scritti, di studiosi di storia della fotografia, fotogiornalismo, cinema, etno-antropologia.
Purtroppo il volume, realizzato dalla stessa società Alfomega, appare fortemente
penalizzato da una cura non all’altezza del compito, a cui si aggiunge una qualità della
stampa fotografica inferiore ai consueti standards dell’Editore Motta.
Le immagini sono ripartite in sei sezioni in base a criteri disomogenei, non
esplicitati nel volume: cronologico nella prima (L’occhio, la vita, la storia), tematico
nelle successive (Roma, Sud, Sardegna, Itinerari emiliani), tecnico nell’ultima
(Colore). A causa di tale impostazione la prima sezione comprende fotografie che dal
punto di vista del contenuto dovrebbero venire ridistribuite in Roma, Sud, Sardegna,
Itinerari emiliani e la cui mescolanza fra loro e con immagini relative ad altri diversi
contesti crea notevoli salti di lettura. Non si capisce, ad esempio, perché una scena
R.Tucci
relativa alla terapia coreutico-musicale del tarantismo sia collocata accanto alla fuga
prospettica di una linea elettrica (n. 38-39); oppure perché le sequenza degli zingari e
delle prostitute del Mandrione (n. 22-23 e 24-27) siano poste nella prima sezione,
lasciando Roma piuttosto scarna e privata delle immagini forse più significative. Inoltre,
ciò che è ancora più grave, le originali serie fotografiche di Franco Pinna appaiono così
frazionate in modo tale che la continuità delle sequenze stesse ne risulta violata. Ciò, ad
esempio, è osservabile nel «Ciclo coreutico di Maria di Nardò» (I/39, III/26-27), o in
«Il gioco della falce» (I/41, III/31-33), o ancora in «Stintino» (I/44, IV/24-27), dove, in
particolare, la frattura fra la prima e l’ultima foto - sicuramente due scatti molto
ravvicinati - appare di particolare evidenza. Anche la collocazione dei saggi di
Mazzacane, Ricci, Lefèvre, Renzi all’interno delle sezioni fotografiche contribuisce a
generare confusione ed equivoci sul contenuto dei saggi stessi, come è il caso, ad
esempio, di quello di Mazzacane, Pinna e De Martino: una vicenda complessa, che
appare nella sezione Roma.
Tutte le fotografie, corredate da brevi didascalie in calce e da schede esplicative
riunite in fondo al volume, sono rinumerate da uno in ogni sezione e ciò ne rende
disagevole la consultazione quando ad esse rinviano i testi. Singolare è inoltre il fatto
che nei testi i riferimenti alle immagini vengono sempre effettuati citando la scheda e
non la fotografia: trattandosi di un corpus fotografico, ci si aspetterebbe il contrario.
Sia il saggio di Giuseppe Pinna, “Biografia mia: 27 anni di fotogiornalismo”.
Franco Pinna, l’immagine ritrovata, sia i testi delle schede sono inficiati da
imprecisioni, errori e opinabili prese di posizione che dimostrano come i curatori non
siano stati in grado di affrontare un così articolato e complesso corpus di immagini,
soprattutto per quel che attiene quella importante vicenda dell’antropologia italiana, che
vide Franco Pinna lavorare accanto a Ernesto de Martino e Diego Carpitella: vicenda
che peraltro, opportunamente, assume nell’intero volume una collocazione centrale.
D’altra parte, dalla scheda distribuita durante la mostra, si apprende che
Alfomega Produzioni Culturali è una giovane società di storici dell’arte, estranei, per
preparazione, alle tematiche antropologiche. Ciononostante, i curatori, non hanno
ritenuto di avvalersi della consulenza di esperti e hanno preferito affrontare in prima
persona tali tematiche, per di più con una notevole dose di presunzione, demolendo i
precedenti apporti di qualificati studiosi e mettendo in dubbio la validità del metodo
scientifico che viene praticato in sede accademica. Nel fascicolo che accompagna la
mostra, a cura di Giuseppe Pinna, si legge che «l’attività di Alfomega vuole
costantemente far capo ad un nuovo modo di concepire le attività culturali,
intenzionalmente lontano dalle complicate modalità, dai tempi lunghi e talvolta dai
2
R.Tucci
risultati mediocri delle istituzioni accademiche, sempre più in difficoltà nel supplire al
compito [...]».
Il saggio di Giuseppe Pinna prende avvio in tono acremente polemico: «Credo di
non far torto a nessuno nell’affermare che su Franco Pinnna [...] si sia scritto finora
poco e poco bene, anche quando con poco bene non si voglia dire necessariamente
male». E prosegue prendendo in considerazione soprattutto il noto scritto di Diego
Carpitella, Franco Pinna e la fotografia etnografica in Italia, pubblicato come
introduzione a Viaggio nelle terre del silenzio. Reportage dal profondo Sud 1950-1959
(Milano 1980), per concludere che «la maggior parte della letteratura critica riguardante
Pinna [...] può essere considerata di carattere testimoniale, come se chi lo avesse
conosciuto da vicino si fosse sentito spontaneamente in obbligo di perpetuarne l’alto
esempio umano e professionale». Subito dopo, accennando a «primi gravi equivoci»,
afferma che «questa letteratura ha finito per vestire un ruolo ordinatorio e classificatorio
nei confronti della produzione fotografica di Pinna; dunque un ruolo di natura più propriamente scientifica, che ne fossero coscienti o meno coloro che in esso sono rimasti
invischiati».
Ora, già queste prime categoriche osservazioni appaiono totalmente confuse e
contraddittorie. Infatti, un intervento di tipo «ordinatorio e classificatorio» non
costituisce di per sé analisi scientifica, anche se, naturalmente, per essere attendibile,
deve venire condotto con metodo scientifico. Ma, l’approccio «testimoniale» e l’azione
«ordinatoria» non esauriscono tutti i possibili livelli di studio e di analisi di un corpus
fotografico, tutt’altro: vi è infatti un terzo livello, che è quello propriamente scientifico,
teso a fornire un’interpretazione delle immagini dal punto di vista dei fondamenti
epistemologici della disciplina a cui le immagini stesse rinviano. In questo senso il
saggio di Lello Mazzacane, nel volume, e prima ancora, le osservazioni di Francesco
Faeta nel suo Ernesto de Martino e l’antropologia visiva. Appunti per la definizione di
un percorso critico, in «Ossimori» 7-1995 (già in La cinematografia demartiniana, una
prima selezione, a cura di E. de Simoni, L. di Gianni, V. Padiglione, Roma-Napoli
1995) suggeriscono un livello analitico che utilizza categorie antropologiche legate allo
sguardo e alla visualità. Ma lo stesso Carpitella, nel saggio già ricordato aveva inquadrato la produzione di Franco Pinna da un punto di vista storico-culturale, offrendo
un quadro delle dinamiche ideologiche e delle tensioni intellettuali che hanno caratterizzato una larga parte della società italiana negli anni ‘50. E’ una scrittura che, se
si vuole, può anche assumere valore «testimoniale», ma che è essenzialmente
finalizzata a contestualizzare e storicizzare l’esperienza di Franco Pinna e a valorizzarla
proprio in quanto storicizzabile.
3
R.Tucci
Tuttavia, in un inarrestabile crescendo, Giuseppe Pinna rincara la dose e parla di
«possibili “disastri” che si possono combinare in simili casi qualora non si vanti
un’adatta consapevolezza metodologica, magari confidando ciecamente sulla memoria
altrui o sull’intuito personale». Addebita a chi si è occupato di Franco Pinna di averlo
fatto creando «danni» e «disastri», diffondendo un «opinionismo» [sic!] «letteralmente
privo di fondamento», generando un «patrimonio di (dis)conoscenze», provocando
«handicap», praticando «velleitarismo»: tutto ciò per concludere, in totale avallo di se
stesso, che i primi risultati della ricerca da lui condotta «saranno, con buona pace di chi
mi ha preceduto ed in attesa di nuovi arricchimenti o perfezionamenti, i nuovi, veri
fondamenti sui quali potremo finalmente basare una conoscenza credibile di Franco
Pinna».
Ancor più negativo è l’atteggiamento di Giuseppe Pinna nei confronti di Ernesto
de Martino, disinvoltamente definito «il “tiranno” De Martino», «l’altezzoso professore
partenopeo»: un atteggiamento privo di alcun reale riscontro critico. Nel suo scritto il
lavoro demartiniano appare totalmente frainteso. Le informazioni su di esso sono errate,
confuse, approssimative, contraddette dagli stessi saggi presenti nel volume, soprattutto
quello, già ricordato, di Lello Mazzacane e quello di Antonello Ricci, Lo sguardo sui
suoni: il fotografo e la musica popolare.
Sembra che Giuseppe Pinna, al fine di legittimare la propria posizione, intenda
proporre (ma a chi? e con quali strumenti?) una revisione di quella importante pagina
della storia della cultura italiana che ha visto come protagonisti, nei loro rispettivi
ambiti, uomini come Ernesto de Martino, Diego Carpitella, Franco Pinna, tutti ormai
scomparsi, che sicuramente non hanno avuto il dovuto riconoscimento da parte della
società italiana e il cui riflesso è tutto sommato rimasto confinato nei vari campi in cui
hanno operato. Ma ha senso rivalutare l’opera dell’uno svalutando quella dell’altro?
E su quale base Giuseppe Pinna intenderebbe operare tale revisione, onde correggere i presunti «disastri» e «danni» di chi lo ha preceduto? Sulla base di una
ricostruzione filologica delle fonti, a cui, in passato, sarebbe stata posta scarsa
attenzione: «oltre tre quarti delle didascalie che hanno accompagnato le fotografie del
sardo dopo la sua morte sono risultate imprecise o totalmente erronee». Dunque un
obiettivo già in partenza piuttosto ridotto. Inoltre, nonostante Giuseppe Pinna e i suoi
collaboratori di Alfomega dichiarino di aver consultato «più di 200.000 immagini tra
vari archivi fotografici», circa 500 pubblicazioni illustrate», «supporti bibliografici» e
«numerose testimonianze», non si può dire che essi siano esenti dai difetti che loro
stessi attribuisono ad altri. Infatti non poche sono le imprecisioni, gli errori, le inadeguatezze di carattere documentario, storico, teorico, in ambito etno-antropologico, che
4
R.Tucci
si incontrano nel suo testo e nelle schede e che dimostrano quanto sarebbe stata necessaria una rigorosa consulenza di esperti.
Giuseppe Pinna definisce Vittoria de Palma un’antropologa anziché un’assistente
sociale; assegna erroneamente a Cesare Zavattini il ruolo di accompagnatore e a
Benedetto Benedetti il ruolo di fotografo nel sopralluogo che de Martino effettuò nel
Materano fra il 1951 e il 1952, laddove in realtà fu Arturo Zavattini a prendervi parte in
qualità di fotografo (a lui si deve la documentazione visiva) e Benedetti non fotografò
in quanto non era fotografo; assegna a Franco Cagnetta il ruolo di «iniziatore degli studi
di antropologia culturale in Italia», ignorando sia la reale fisionomia e funzione di
quello studioso nel contesto italiano, sia che l’antropologia culturale italiana si inscrive
in una cronologia decisamente anteriore; tratta la ricerca di storie di vita, cara a Franco
Pinna, come se fosse una peculiarità del fotografo e non già un più ampio filone che va
da Rocco Scotellaro allo stesso de Martino e oltre (si pensi a Gianni Bosio, per non fare
che un nome). Definizioni demartinane quali «ciclo coreutico di Maria di Nardò»,
«gioco della falce», sono assunte e utilizzate didascalicamente, senza citarne la fonte
(«la celebre», «il cosiddetto»); quest’ultimo poi è definito un «curioso rito propiziatorio». Perfino le scelte lessicali o le perifrasi usate mal si adattano ad avallare un’operazione innestata su giudizi tanto intransigenti: si parla, con sinistra coincidenza con un
lessico politico-televisivo, di «squadra» per indicare le équipe interdisciplinari di de
Martino, si parla di «tour» per indicare le spedizioni etnografiche dello stesso.
Nelle schede si ritrova il medesimo linguaggio, farcito da analoghe espressioni:
«la “premiata ditta” De Martino-Di Palma-Carpitella», «la trasferta lucana», «l’impresa
di San Giorgio Lucano», «il binomio De Martino-Pinna», «il solito Carpitella». Viene
fatto largo uso di appunti e note dello stesso Franco Pinna tratti dalle carte private del
fotografo e, a volte, utilizzati in modo disinvolto. Spesso, infatti appaiono con evidenza
come estemporanei appunti di taccuino, troppo personali e troppo poco elaborati per
potersi offrire a una lettura pubblica, a cui non erano evidentemente destinati. Questa
utilizzazione indiscriminata degli appunti lasciati da Pinna, unitamente alla non
sufficiente conoscenza delle problematiche etno-antropologiche, fa compiere ai
compilatori delle schede banalizzazioni ed errori, spesso proprio là dove le interpretazioni demartiniane sono maggiormente consolidate. Così, nella serie «Il gioco della
falce», l’interpretazione del capro delle schede n. I/41 e n. III/31-33 («i mietitori
svolgono il loro lavoro simulando una caccia ad un simbolico “capro”, predatore di
grano, e quindi nemico atavico delle genti contadine») appare del tutto arbitraria.
Nella serie del «cosiddetto Ciclo coreutico di Maria di Nardò», è erronea la ricostruzione del rito in due supposte parti, secondo cui: «La prima parte del ciclo, la più
pagana, si svolge in un interno domestico di Nardò, concludendosi poi con la
5
R.Tucci
“liberazione” della trance nella cappella di San Paolo della vicina Galatina». Il
compilatore della scheda n. I/39 non conosce il significato della terapia coreuticomusicale e il suo ruolo liberatorio e si contraddice riportando, nella scheda n. III/28,
proprio un passo di Carpitella, in cui viene detto chiaramente qual è il significato della
ripetizione del rito a Galatina.
Il commento alla fotografia «Funerali di un bambino», nella scheda n. III/4, («La
presenza del fotografo, maldestra parodia dell’“invisibilità” predicata da CartierBresson, ha modificato radicalmente il carattere luttuoso dell’evento, trasformando il
funerale in un divertito corteo dal vivace sapore locale. De Martino la pubblicò
ugualmente, forse per sottolineare lo straniamento dei lucani dagli eventi funebri»)
appare del tutto inadeguato a comprendere la situazione rappresentata nella fotografia e
deriva dalla non conoscenza dell’orizzonte mitico-rituale tipico della cultura contadina
del Sud Italia: un funerale di un bambino molto piccolo, la cui bara viene trasportata da
bambini, gli unici peraltro - e neanche tutti - a manifestare uno sguardo divertito dalla
presenza del fotografo. Non solo il corteo non appare come «un divertito corteo dal
vivace sapore locale», né vi si individua un presunto «straniamento dei lucani dagli
eventi funebri», ma chi conosce intimamente il Sud e le fini analisi demartiniane
sull’universo infantile nel Mezzogiorno contadino, vi ritrova una serie di elementi che
portano a un’altra lettura dell’immagine: la morte dei bambini piccoli non assimilata a
quella degli adulti e la particolare collocazione che gli stessi bambini assumono fra il
mondo dei vivi e quello dei morti.
Infine, qualificando la presenza di Franco Pinna come «maldestra parodia
dell’“invisibilità” predicata da Cartier-Bresson», si va a inficiare finanche la validità
stessa del fotografo, in una sorta di furore “antropofago” che non risparmia nemmeno
colui il quale si vorrebbe valorizzare. Anche qui prendendo un abbaglio. Franco Pinna
non ha mai perseguito «l’invisibilità», tutt’altro: nelle sue immagini egli appare
inequivocabilmente e consapevolmente all’interno dell’evento osservato, in stretta
relazione con esso e con le persone che lo animano.
Dunque proprio quelli che Giuseppe Pinna definisce i «nuovi, veri fondamenti sui
quali potremo finalmente basare una conoscenza credibile di Franco Pinna» appaiono
come ulteriori elementi da revisionare: ciò di fatto vanifica un’iniziativa che avrebbe
potuto essere fruttuosa se collocata nelle giuste mani. Si ha l’impressione che la foga
polemica contro l’antropologia italiana derivi dalla necessità di auto-legittimazione non
soltanto per il volume appena curato, ma anche per future iniziative relative all’archivio
Pinna. Al termine del suo saggio Giuseppe Pinna annuncia, con lessico demartiniano,
una «specifica diramazione della ricerca in corso» che dovrebbe portare alla
pubblicazione del materiale sardo di Franco Pinna, con il non originale titolo di L’isola
6
R.Tucci
del rimorso: una idea già suggerita da Carpitella proprio nel suo contestato saggio.
Inoltre, nella scheda che accompagna la mostra, viene avanzato il progetto di una
«Fondazione intitolata a Franco Pinna, che in futuro possa occupasi di allocare e
catalogare in maniera definitiva l’archivio del fotografo, in modo che possa essere
conservato in maniera corretta ed essere valorizzato in quanto patrimonio storicoartistico».
Allora, si tratta di stabilire se il corpus fotografico di Franco Pinna debba «essere
valorizzato in quanto patrimonio storico-artistico», escludendo, o meglio “riplasmando”
nel modo che si è visto, il contenuto antropologico, oppure se debba venire assunto, in
una prospettiva pluridisciplinare, da esperti, restituendo alle fotografie etnografiche
quello spessore culturale che soltanto un’analisi competente e approfondita è in grado di
dare.
Roberta Tucci
7