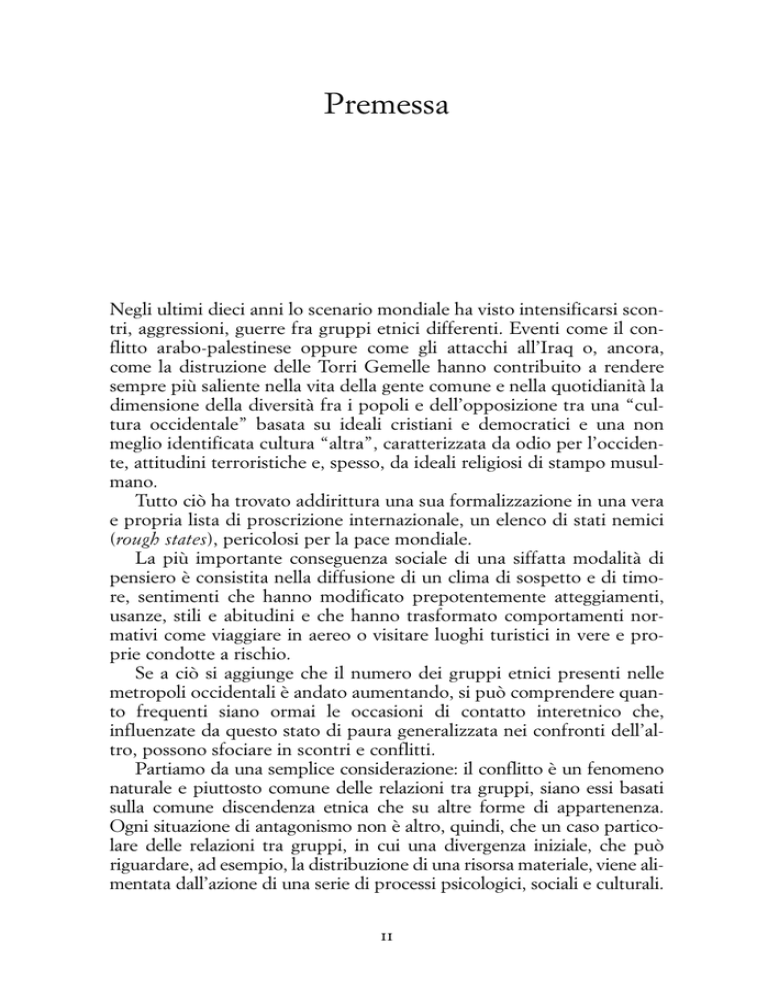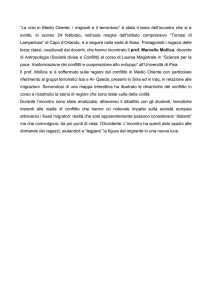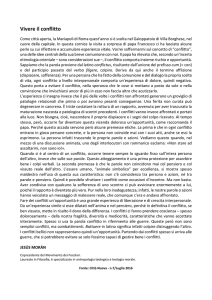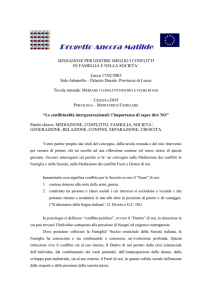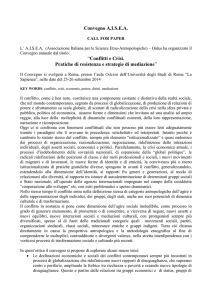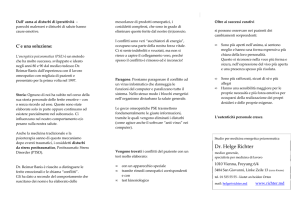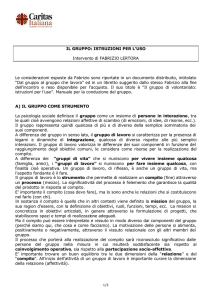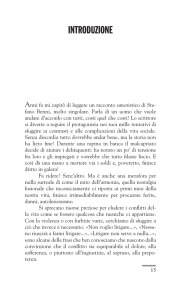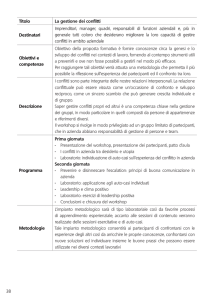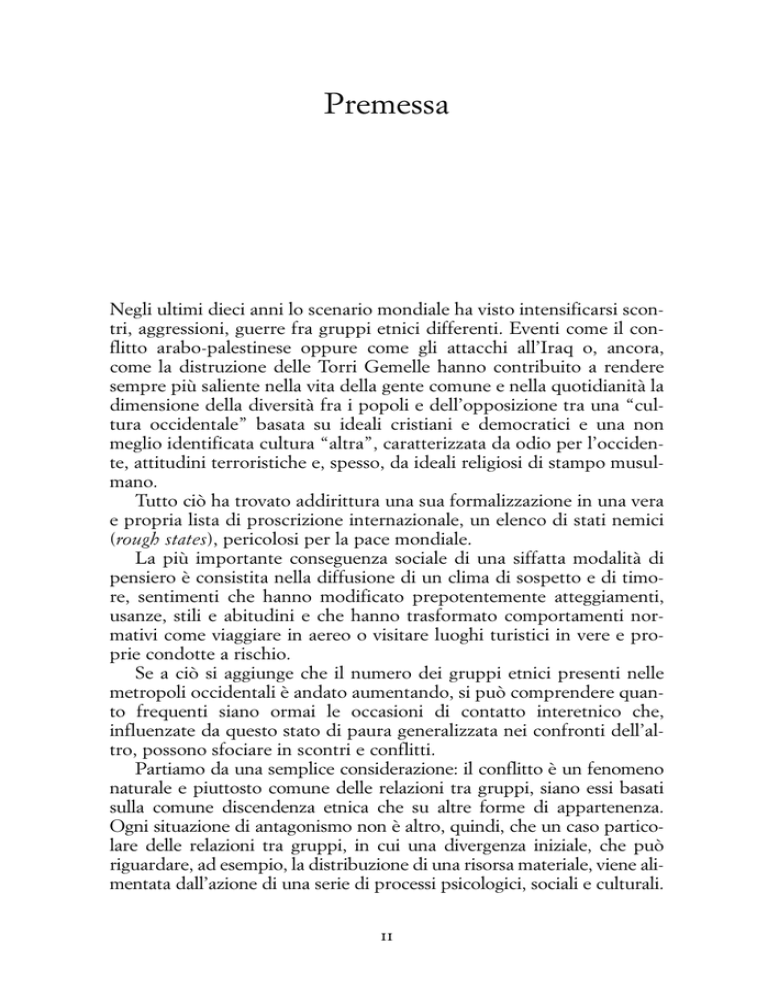
Premessa
Negli ultimi dieci anni lo scenario mondiale ha visto intensificarsi scontri, aggressioni, guerre fra gruppi etnici differenti. Eventi come il conflitto arabo-palestinese oppure come gli attacchi all’Iraq o, ancora,
come la distruzione delle Torri Gemelle hanno contribuito a rendere
sempre più saliente nella vita della gente comune e nella quotidianità la
dimensione della diversità fra i popoli e dell’opposizione tra una “cultura occidentale” basata su ideali cristiani e democratici e una non
meglio identificata cultura “altra”, caratterizzata da odio per l’occidente, attitudini terroristiche e, spesso, da ideali religiosi di stampo musulmano.
Tutto ciò ha trovato addirittura una sua formalizzazione in una vera
e propria lista di proscrizione internazionale, un elenco di stati nemici
(rough states), pericolosi per la pace mondiale.
La più importante conseguenza sociale di una siffatta modalità di
pensiero è consistita nella diffusione di un clima di sospetto e di timore, sentimenti che hanno modificato prepotentemente atteggiamenti,
usanze, stili e abitudini e che hanno trasformato comportamenti normativi come viaggiare in aereo o visitare luoghi turistici in vere e proprie condotte a rischio.
Se a ciò si aggiunge che il numero dei gruppi etnici presenti nelle
metropoli occidentali è andato aumentando, si può comprendere quanto frequenti siano ormai le occasioni di contatto interetnico che,
influenzate da questo stato di paura generalizzata nei confronti dell’altro, possono sfociare in scontri e conflitti.
Partiamo da una semplice considerazione: il conflitto è un fenomeno
naturale e piuttosto comune delle relazioni tra gruppi, siano essi basati
sulla comune discendenza etnica che su altre forme di appartenenza.
Ogni situazione di antagonismo non è altro, quindi, che un caso particolare delle relazioni tra gruppi, in cui una divergenza iniziale, che può
riguardare, ad esempio, la distribuzione di una risorsa materiale, viene alimentata dall’azione di una serie di processi psicologici, sociali e culturali.
PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERETNICHE
Se il conflitto è un fenomeno così frequente, esso diventa ancora
più probabile quanto più le parti in gioco si percepiscono come differenti. Secondo una credenza del pensare comune, infatti, sembra naturale che due persone (o due gruppi) diverse per qualche attributo si
scontrino, perché è proprio alla loro diversità che si deve far risalire o
imputare la difficoltà di comunicazione reciproca e il raggiungimento
di modalità relazionali positive. Quando questa diversità, poi, è legata
all’appartenenza etnica, coinvolge variabili che vanno dalla lingua parlata alla religione praticata, dallo stile di vita al sistema di valori adottato. In questo contesto, le differenze percepite tra le parti si moltiplicano e ciò rende ancora più probabile la nascita e l’alimentarsi di
incomprensioni e scontri.
Non dovrebbe, perciò, stupire se, nella realtà odierna, gli scontri tra
gruppi etnici si configurano come eventi altamente probabili e difficilmente evitabili.
Piuttosto che sulla constatazione di dati di fatto, l’interesse dovrebbe spostarsi sul modo in cui è possibile affrontare e gestire situazioni
simili. I conflitti hanno un enorme potenziale distruttivo, poiché portano verso guerre sanguinose o verso l’annientamento di interi popoli,
ma, allo stesso tempo, essi contengono potenzialità nascoste: ogni conflitto può diventare un occasione di crescita per le parti implicate, un
momento per negoziare e contrattare nuove forme di relazione che
prendano il posto delle precedenti, disfunzionali. In altre parole, non
esistono conflitti in assoluto negativi o positivi, sono le modalità con cui
vengono affrontati a esserlo.
Generalmente, nella nostra cultura, il conflitto è vissuto come un
evento infausto, da evitare e sopprimere repentinamente, attraverso
l’uso della forza o dell’autorità giudiziaria. Ad esempio per molte persone è naturale pensare che per risolvere una controversia si debba far
ricorso a un tribunale oppure che per sedare uno scontro ci si debba
rivolgere alle forze dell’ordine. È come se si ritenesse che le parti non
posseggano gli strumenti necessari per arrivare a un accordo costruttivo e che solo una decisione imposta da terzi possa mettere fine alla contesa.
Questo atteggiamento si riflette ovviamente anche sul modo di
intervenire nelle situazioni di conflitto etnico che sorgono sia a livello
internazionale sia a quello nazionale. Se si analizzano le politiche degli
ultimi anni verso il fenomeno dei conflitti etnici le modalità più utilizzate sembrano essere di due tipi.
A livello internazionale la strategia più comune ormai sembra essere
quella della “guerra preventiva” (pre-emptive war), cioè un intervento
armato che ha lo scopo di prevenire i danni che uno Stato (o un grup
PREMESSA
po etnico) potrebbe arrecare ad un altro Stato (o gruppo etnico). Un
esempio recente è costituito dal conflitto promosso da Stati Uniti e
Gran Bretagna contro l’Iraq oppure dai diversi episodi di attacchi armati contro palestinesi da parte dell’esercito israeliano.
A livello nazionale, invece, la strategia più utilizzata sembra essere
quella del “blocco delle frontiere”, di un maggiore controllo delle entrate di cittadini immigrati nel nostro paese, seguendo il principio che
minore è il numero di cittadini italiani di etnia differente, minore sarà il
pericolo di scontri etnici.
Ma queste strategie sono realmente efficaci per fronteggiare il
rischio di insorgenza di conflitti etnici?
La risposta, a nostro avviso, è negativa. L’aspetto che accomuna tutti
e due i metodi è il ricorso alla forza e al potere, che nel primo caso è rappresentato da eserciti nazionali mentre nel secondo riguarda l’utilizzo di
operatori delle forze dell’ordine per disciplinare i confini e per controllare l’eventuale presenza all’interno del territorio italiano di clandestini
da espellere. In questi casi, paradossalmente, si cerca di affrontare qualcosa di potenzialmente violento e dannoso – come un possibile conflitto – esclusivamente attraverso l’utilizzo della forza e della coercizione e
ciò implica l’enorme rischio di irrigidire i rapporti con la controparte,
di creare un’intensificazione delle ostilità reciproche e di distruggere
ogni possibile forma di comunicazione.
Come notato precedentemente, non sembra essere questa la strada
corretta per una gestione costruttiva dei conflitti tra gruppi etnici. La
pace non può essere imposta ma deve essere realizzata attraverso il confronto e lo scambio tra i contendenti. Emerge la necessità di identificare modalità alternative per la gestione di tali situazioni che siano basate
sull’utilizzo della comunicazione e del dialogo piuttosto che sull’uso
della coercizione; solo in questa maniera le parti possono essere avviate
verso un processo di ricerca di soluzioni durature che consentano di
migliorare la qualità delle loro relazioni e prevenire l’insorgenza di futuri scontri. Uno sforzo ulteriore, inoltre, dovrebbe essere diretto a mettere a punto metodologie di intervento efficaci sia a livello nazionale sia
internazionale.
È proprio da queste considerazioni che nasce il presente volume,
con lo scopo di proporre un modello di intervento per la gestione dei
conflitti etnici che sorgono nei grandi centri cittadini degli Stati di
nuova immigrazione, come l’Italia. In questa ottica, esso si configura
come un tentativo di sistematizzare e raccogliere la letteratura psicosociale di riferimento, partendo dall’analisi dei processi psicologici alla
base dei fenomeni di antagonismo etnico per arrivare alla considerazione delle strategie operative più efficaci.
PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERETNICHE
In cartolare, nel CAP. verrà introdotto l’oggetto di analisi del volume attraverso una definizione dei conflitti etnici nelle loro linee generali; particolare l’attenzione sarà rivolta ai “conflitti etnici metropolitani”,
che si manifestano all’interno delle grandi città multietniche e rappresentano la forma più diffusa di antagonismo etnico in Italia.
Il CAP. prenderà in considerazione il fenomeno del conflitto tra
gruppi attraverso l’analisi della letteratura psicologica. In particolare,
verranno analizzate le principali spiegazioni fornite dalla psicologia
sociale: dalla teoria del conflitto realistico di Sherif alla teoria dell’identità sociale di Tajfel. Infine, sarà delineato il panorama scientifico attuale, i modelli teorici dominanti e le revisioni che le diverse concettualizzazioni hanno subito negli anni più recenti.
Il CAP. continuerà l’analisi dei fattori psicologici alla base dei conflitti etnici, utilizzando come punto di riferimento l’insieme di ricerche
sulla socializzazione etnica che studiano come i bambini immigrati sviluppano le modalità di integrazione/interazione con gli altri gruppi etnici, sia maggioritari che minoritari, presenti nelle società di immigrazione. Inoltre, verrà presentata una rassegna delle ricerche sull’argomento
effettuate in Italia.
Il CAP. cercherà di individuare possibili strategie costruttive di soluzione dei conflitti tra gruppi. A questo proposito sarà passata in rassegna
la letteratura sulla negoziazione e sulla mediazione, che offre una serie di
tattiche e strategie per la risoluzione delle situazioni conflittuali.
Il CAP. , infine, si focalizzerà sui metodi e le strategie utilizzate per
la mediazione dei conflitti etnici. Verranno presentati alcuni metodi di
risoluzione dei conflitti, come la tecnica degli obiettivi superordinati, la
decategorizzazione e il metodo elaborato dalla School for Peace di Neve
Shalom/Wahat al Salam, una struttura di formazione israeliana che si
occupa di organizzare interventi di mediazione tra arabi ed ebrei.
Inoltre, saranno presentate alcune possibili applicazioni di questi
modelli di intervento al contesto italiano, attraverso l’ausilio di un esempio concernente un progetto di un corso di formazione sulla mediazione dei conflitti etnici rivolto ad agenti delle forze dell’ordine.