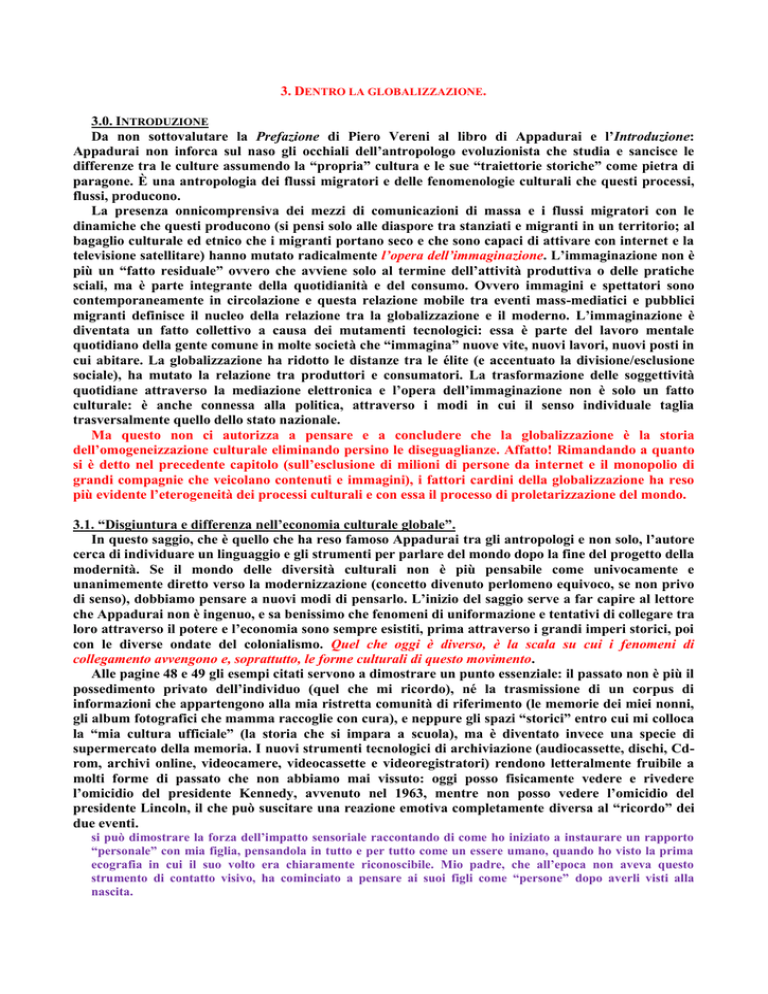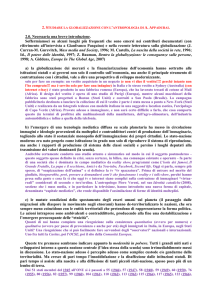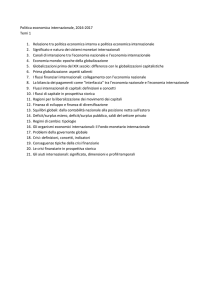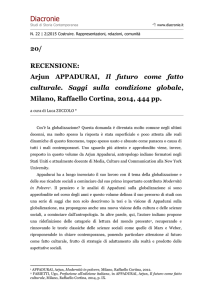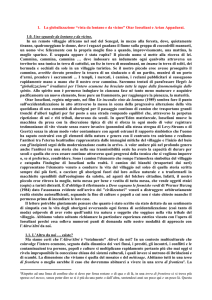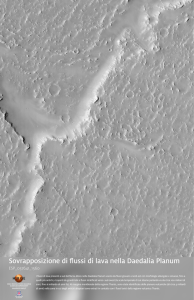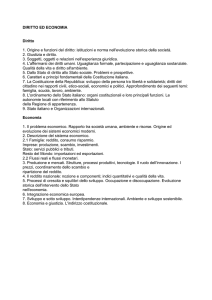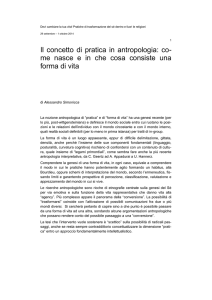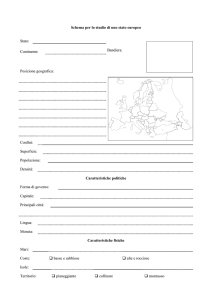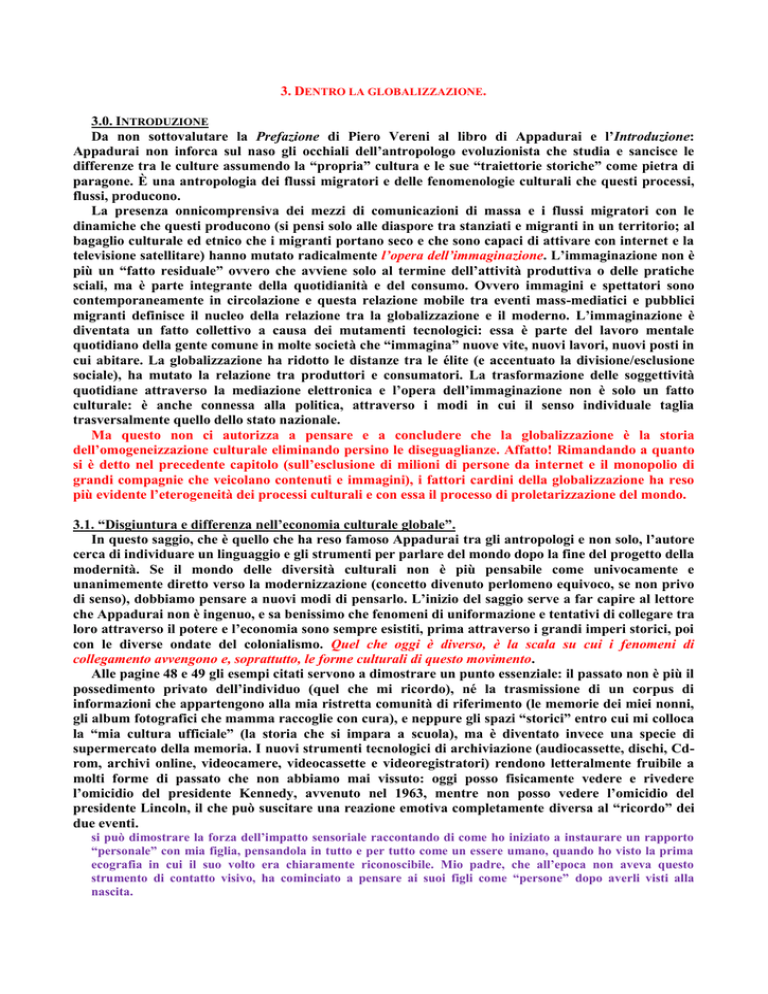
3. DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE.
3.0. INTRODUZIONE
Da non sottovalutare la Prefazione di Piero Vereni al libro di Appadurai e l’Introduzione:
Appadurai non inforca sul naso gli occhiali dell’antropologo evoluzionista che studia e sancisce le
differenze tra le culture assumendo la “propria” cultura e le sue “traiettorie storiche” come pietra di
paragone. È una antropologia dei flussi migratori e delle fenomenologie culturali che questi processi,
flussi, producono.
La presenza onnicomprensiva dei mezzi di comunicazioni di massa e i flussi migratori con le
dinamiche che questi producono (si pensi solo alle diaspore tra stanziati e migranti in un territorio; al
bagaglio culturale ed etnico che i migranti portano seco e che sono capaci di attivare con internet e la
televisione satellitare) hanno mutato radicalmente l’opera dell’immaginazione. L’immaginazione non è
più un “fatto residuale” ovvero che avviene solo al termine dell’attività produttiva o delle pratiche
sciali, ma è parte integrante della quotidianità e del consumo. Ovvero immagini e spettatori sono
contemporaneamente in circolazione e questa relazione mobile tra eventi mass-mediatici e pubblici
migranti definisce il nucleo della relazione tra la globalizzazione e il moderno. L’immaginazione è
diventata un fatto collettivo a causa dei mutamenti tecnologici: essa è parte del lavoro mentale
quotidiano della gente comune in molte società che “immagina” nuove vite, nuovi lavori, nuovi posti in
cui abitare. La globalizzazione ha ridotto le distanze tra le élite (e accentuato la divisione/esclusione
sociale), ha mutato la relazione tra produttori e consumatori. La trasformazione delle soggettività
quotidiane attraverso la mediazione elettronica e l’opera dell’immaginazione non è solo un fatto
culturale: è anche connessa alla politica, attraverso i modi in cui il senso individuale taglia
trasversalmente quello dello stato nazionale.
Ma questo non ci autorizza a pensare e a concludere che la globalizzazione è la storia
dell’omogeneizzazione culturale eliminando persino le diseguaglianze. Affatto! Rimandando a quanto
si è detto nel precedente capitolo (sull’esclusione di milioni di persone da internet e il monopolio di
grandi compagnie che veicolano contenuti e immagini), i fattori cardini della globalizzazione ha reso
più evidente l’eterogeneità dei processi culturali e con essa il processo di proletarizzazione del mondo.
3.1. “Disgiuntura e differenza nell’economia culturale globale”.
In questo saggio, che è quello che ha reso famoso Appadurai tra gli antropologi e non solo, l’autore
cerca di individuare un linguaggio e gli strumenti per parlare del mondo dopo la fine del progetto della
modernità. Se il mondo delle diversità culturali non è più pensabile come univocamente e
unanimemente diretto verso la modernizzazione (concetto divenuto perlomeno equivoco, se non privo
di senso), dobbiamo pensare a nuovi modi di pensarlo. L’inizio del saggio serve a far capire al lettore
che Appadurai non è ingenuo, e sa benissimo che fenomeni di uniformazione e tentativi di collegare tra
loro attraverso il potere e l’economia sono sempre esistiti, prima attraverso i grandi imperi storici, poi
con le diverse ondate del colonialismo. Quel che oggi è diverso, è la scala su cui i fenomeni di
collegamento avvengono e, soprattutto, le forme culturali di questo movimento.
Alle pagine 48 e 49 gli esempi citati servono a dimostrare un punto essenziale: il passato non è più il
possedimento privato dell’individuo (quel che mi ricordo), né la trasmissione di un corpus di
informazioni che appartengono alla mia ristretta comunità di riferimento (le memorie dei miei nonni,
gli album fotografici che mamma raccoglie con cura), e neppure gli spazi “storici” entro cui mi colloca
la “mia cultura ufficiale” (la storia che si impara a scuola), ma è diventato invece una specie di
supermercato della memoria. I nuovi strumenti tecnologici di archiviazione (audiocassette, dischi, Cdrom, archivi online, videocamere, videocassette e videoregistratori) rendono letteralmente fruibile a
molti forme di passato che non abbiamo mai vissuto: oggi posso fisicamente vedere e rivedere
l’omicidio del presidente Kennedy, avvenuto nel 1963, mentre non posso vedere l’omicidio del
presidente Lincoln, il che può suscitare una reazione emotiva completamente diversa al “ricordo” dei
due eventi.
si può dimostrare la forza dell’impatto sensoriale raccontando di come ho iniziato a instaurare un rapporto
“personale” con mia figlia, pensandola in tutto e per tutto come un essere umano, quando ho visto la prima
ecografia in cui il suo volto era chiaramente riconoscibile. Mio padre, che all’epoca non aveva questo
strumento di contatto visivo, ha cominciato a pensare ai suoi figli come “persone” dopo averli visti alla
nascita.
Oggi, dice quindi Appadurai, posso “ricordare” cose che non solo non ho mai vissuto, ma che non
fanno neppure parte di una qualche “storia collettiva” della comunità cui sento di appartenere. Questa
liberazione della memoria dalle linee della storia rende definitivamente impossibile concepire “gli
Altri” entro quel paradigma evoluzionista di cui abbiamo accennato, per cui il sud e l’est del mondo
occidentale vengono pensati come “il nostro passato”.
Questo fatto nuovo si può descrivere come un aspetto particolarmente evidente di un fenomeno più
generale, che possiamo definire l’affrancamento dell’immaginazione, cioè la liberazione della fantasia
umana dalle pastoie del pensiero nazionale. L’immaginazione diventa pratica sociale, anzi campo
organizzato di pratiche sociali e non più fantasia, via di fuga, passatempo per le élite. Questo ci
costringe, come analisti della realtà sociale, a modificare il nostro giudizio dell’immaginazione come
qualcosa di fondamentalmente negativo, che ostacola la comprensione della “realtà reale” o che al
massimo è ininfluente per comprenderne la sua composizione effettiva (è il vecchio modello
materialista e razionalista che ha dato forma e sostanza all’empirismo da cui nascono le scienze sociali
come l’antropologia).
Appadurai ci invita a considerare l’immaginazione non un elemento fuorviante, e neppure un
ingrediente opzionale della vita sociale, ma una sua componente essenziale: è la nostra capacità di
immaginare la realtà nella quale siamo immersi che letteralmente crea quella realtà. Il problema
centrale delle interazioni globali moderne è la tensione tra omogeneizzazione culturale (da sempre
entità di piccola scala temono di essere assorbite culturalmente da entità più grandi, specialmente da
quelle che sono più vicine) ed eterogeneizzazione culturale. Questa complessità ha a che fare con
alcune disgiuntore tra economia, politica e cultura. Quasi per dimostrare che prende sul serio quel che
ci chiede di fare (di immaginare l’immaginazione come parte integrante della realtà nella quale gli
uomini vivono) Appadurai comincia a immaginare nuove parole che ci permettano di capire meglio il
mondo in cui siamo.
Queste parole indicano le 5 dimensioni dei flussi culturali globali e sono: etnorama (il flusso degli
uomini, il panorama di persone, turisti, immigrati, rifugiati, lavoratori che si muovono costantemente
e mai come oggi influenzano le politiche nazionali), tecnorama (il flusso della tecnologia, la rapidità con
cui questa si muove attraverso confini sempre meno definibili), finanziorama (il flusso del denaro, in
tutte le sue forme; panorama misterioso, rapido e difficile da seguire, che muove megadenaro ad una
velocità incredibile), mediorama (il flusso delle immagini veicolate dai mezzi di comunicazione di
massa e individuali), e ideorama (il flusso delle idee e delle ideologie, spesso legate alla politica).
Ognuno di questi flussi è un panorama, declinato dalle contingenze storiche, linguistiche, politiche di
diversi tipi di attori (uomini, stati, comunità). Come indicano le insistenti parentesi, si tratta
sostanzialmente di flussi, che possiamo immaginare come diverse correnti di un unico mare: come
possiamo individuare la corrente del Golfo nell’Atlantico, così possiamo pensare che il mondo attuale
sia percorso da diversi flussi, di persone, macchine, soldi, immagini e idee. Il suffisso -orama (da
panorama) sta a indicare che, diversamente che per i flussi del mare, non abbiamo una terraferma da
cui guardare a quei flussi, ma vi siamo perennemente immersi anche noi. Immaginate allora di essere
dentro quel mare e di guardare a quei diversi flussi che passano: ovunque voi siate, non potrete fare a
meno di guardare ai flussi dal vostro punto di vista (per cui una corrente è più vicina, magari ci siete
proprio immersi, mentre un’altra la vedete solo da lontano, un’altra passa sopra di voi, e un’altra
ancora vi sembra invisibile).
Appadurai insiste su un punto fondamentale: questi flussi sono disgiunti, cioè si muovono a velocità
relative diverse, verso direzioni diverse, ma ognuno è soggetto all’influenza dell’altro. Stabilire quali
siano gli specifici rapporti di forza tra i diversi flussi è una questione empirica che va risolta caso per
caso: non possiamo sapere in anticipo se un mediorama influenzerà un tecnorama, o l’inverso, o
ancora se i due saranno determinati da un finanziorama. La ragione principale di questo è
l’indebolimento dello stato nazionale come “contenitore” che cercava o fingeva di poter controllare i
diversi livelli della vita sociale.
Tutto questo si può leggere alla luce di un’altra parola chiave, deterritorializzazione. Il concetto di
flusso implica movimento, e il movimento stride con la nostra idea consolidata che l’appartenenza sia
locale o localizzabile. I diversi -orami non sono più individuabili in senso spaziale, ma vanno percorsi
nel loro divenire e nelle loro complicate interazioni. La d. è una delle forze centrali del mondo
moderno: crea nuovi mercati per il cinema che sono chiamati a riprodurre determinati modelli locali
in sistemi globali, per le agenzie di viaggio che prosperano sul bisogno di tenere un contatto con la
terra di origine. Di fronte a questo movimento, Appadurai ci informa su un’importante conseguenza:
gli stati, lungi dall’accettare passivamente il loro indebolimento, sembrano spingere ancora di più
verso l’uniformazione e l’omogeneizzazione (cioè cercano ancora di più di impossessarsi della nazione,
cioè di fare in modo che il loro confine coincida con quello della nazione, da cui pulizie etniche,
espulsioni, tentativi di assimilazione) mentre, viceversa, le popolazioni in movimento (gli etnorami)
pretendono spesso di “mangiarsi” lo stato, richiedendo diritti nei paesi in cui si muovono suscitando
risentimenti e ulteriori reazioni omogeneizzanti. In più, il flusso degli ideorami (le idee di democrazia,
autodeterminazione, diritti umani) fa sì che molte minoranze agiscano consapevolmente in modo
politico, rivendicando l’indipendenza politica e la necessità di un loro stato. “L’etnicità come
primordialismo diffuso” di cui si parlerà in seguito è una conseguenza di questi flussi. Un po’ come ci
aveva insegnato Geertz, il contatto con il diverso (migrante o ospitante) irrigidisce le differenze, e un
po’ (come insiste Appadurai) il flusso degli ideorami e dei mediorami rende plausibile un uso politico
della differenza culturale su scala planetaria.
Sugli effetti della globalizzazione nella produzione delle merci e del consumo, Appadurai riprende
una vecchia terminologia marxista (feticismo delle merci) per parlare di due forme nuove di feticismo:
il f. della produzione, per cui gli stati si illudono di poter controllare il livello locale dei tecnorami e dei
finaziorami, mentre sono essi stessi parte di questi flussi (è, insomma, l’illusione degli stati di poter
gestire un’economia ancora “nazionale”) e il f. del consumatore, per cui ci si illude che il consumatore
sia un attore sociale (possa cioè fare delle scelte), mentre in realtà il suo margine di scelta è
ridottissimo dalle determinazioni dei diversi flussi.
Nella globalizzazione risulta palese la contraddizione dell’Illuminismo, che voleva
contemporaneamente riconoscere l’eguaglianza di tutti gli uomini e la specifica differenza delle diverse
culture. Sta dicendo che la globalizzazione ha un aspetto positivo in quanto rende disponibili nuove
informazioni e nuova tecnologia per nuovi gruppi sociali, ma è anche un male perché stimola un iperparticolarismo culturale e tendenzialmente isolazionista. Tanto per non perdere il vizio, Appadurai ci
ricorda che le questioni sono spesso più complicate di come vorrebbero farci credere i nostri tentativi
di inquadrarle entro schemi semplici, lineari, di causa-effetto.
Il capitolo si chiude con una questione importante. Come sia possibile riprodurre e trasmettere le
culture entro questo sistema di flussi. Com’è ovvio, le culture per poter sopravvivere devono essere in
grado di trasmettersi alle nuove generazioni (se di colpo tutti gli italiani decidessero di parlare
francese, fra un’ottantina di anni al massimo l’italiano sarebbe scomparso). La famiglia (sede
dell’inculturazione primaria) è il centro dove si condensano proprio le tensioni contraddittorie dei
diversi flussi, per cui genitori e figli possono essere inseriti in flussi mediatici profondamente diversi
(pensate a quello che guardate voi in televisione, e quello che guardano i vostri genitori o i vostri
nonni) che si intrecciano con ideorami spesso conflittuali (un figlio no global con un padre di Forza
Italia), flussi che si intersecano con tecnorami divergenti (spedire gli sms sembra essere una questione
riservata a chi ha meno di 45 anni). Insomma, oggi diventa più complicato capire come fare per
trasmettere il sapere e il fare delle culture e le sofferenze della riproduzione gravano per lo più sulle
donne, da un lato forzate ad entrare nel mondo del lavoro attraverso nuove modalità e dall’altro
responsabili del mantenimento dell’eredità familiare.
3.2. “Etnorami globali: appunti e questioni per un’antropologia transnazionale”.
Nel 20° secolo si è verificato il mutamento della riproduzione sociale, territoriale e culturale
dell’identità di gruppo: dato che i gruppi migrano, si riaggregano in nuovi territori, ridisegnano le loro
storie e i loro progetti etnici, il prefisso etno- dell’etnografia assume una connotazione instabile e
spaesata. I gruppi non sono più strettamente territorializzati, confinati spazialmente, inconsapevoli
della loro storia, per questo Appadurai vuole riconsiderare alcune delle convenzioni dell’antropologia
culturale.
Se le considerazioni di cui sopra sono riferite all’etnografia e all’antropologia, sulle quali Appadurai sta
modificando la struttura teorica e la metodologia, non si può non cogliere la rilevanza della dinamica dei
flussi per una qualsiasi teoria dell’educazione: come possiamo delineare e realizzare nuove pratiche
comunicative e relazionali nelle differenze culturali? Differenze non solo legate alla natura delle etnie
(concetto messo in discussione dallo stesso Appadurai) ma appunto al loro movimento che comporta un
mescolamento? Il sapere pedagogico occidentale ha promosso da decenni (agli inizi degli anni Ottanta del
secolo scorso) l’educazione interculturale come una nuova modalità nell’attività del formare. Tuttavia, anche
questa opzione del discorso pedagogico sta rilevando tutti i suoi limiti (le cronache sui conflitti tra stanziati e
migranti sono una prova evidente della mancata accoglienza e integrazione) in quanto essa presuppone la
sovrapposizione della cultura del paese di accoglienza sulla cultura del paese di provenienza.
Ci sono state diverse strategie retoriche che le culture applicano per farci sentire a casa nel mondo e
Appadurai chiama queste forme retoriche “realismi”. Nel pensiero scientifico occidentale i diversi
realismi che hanno dominato non sembrano reggere più (cioè: ci siamo accorti che sono strategie
retoriche). Alcuni di questi realismi sono quello evoluzionista o modernista (tutto il mondo sta andando
nella stessa direzione); quello individualista (poco a poco, gli uomini diventano “individui”, razionali
ed economici); quello della “gabbia d’acciaio”, concetto elaborato dalla “Scuola di Francorte”) per cui
gli uomini sono costretti proprio dalla modernità a subire forme di dominio sempre maggiori, fino ad
arrivare all’oppressione totale, che è perfetta in quanto ha annullato la nostra consapevolezza di essere
oppressi; quello marxista.
Tutte queste “grandi narrazioni” non servono più a capire dove siamo, e quindi dobbiamo
rivolgerci ad altri tipi di analisi. Se ogni luogo è un punto in cui convergono i diversi -orami, “essere
stati lì” non serve a nulla, come prova della nostra conoscenza, se non siamo stati in grado di guardare
ai diversi flussi e al modo in cui si intersecavano in quel punto. Non è più in questione la natura
dell’antropologia, ma la natura letteraria della vita reale.
Chiarito questo aspetto, Appadurai passa a presentare tre esempi che, ciascuno a suo modo, ci
fanno vedere come i flussi si incrocino anche in località ben determinate, e anzi “creino” le località nel
loro intersecarsi. Il primo esempio è autobiografico:
il paradosso transnazionale: la moglie di Appadurai si reca a Madurai da Philadelphia per
incontrare un sacerdote di un tempio nonché suo amico con cui aveva compiuto una serie di ricerche, e
scopre che questi è a Houston, per assistere la comunità indiana d’oltremare nella delicata politica di
riproduzione culturale. È la globalizzazione dell’induismo: il tempio non più come centro di attrazione
culturale, ma dotato di una sua forza di espansione nel mondo;
il secondo letterario: il brano di Julio Cortàzar che racconta di un’invenzione pazzesca, un nuovo
sport, il nuoto in una piscina di gofio che è la farina di ceci: è l’esasperazione dell’internazionalismo
dello sport che esalta la performance anche con l’uso di steroidi che finisce con bizzarre realtà tecniche
che possono anche portare alla morte – l’abuso fisico per ottenere il risultato.
il terzo cinematografico documentaristico (quindi anche etnografico): il documentario-etnodramma
India Cabaret di Mira Nair; è un esempio di deterritorializzazione non globale, ma più limitata.
Il senso degli esempi è riassunto con queste parole di Appadurai: «molte vite sono oggi
inestricabilmente legate a rappresentazioni, e quindi abbiamo bisogno di incorporare nelle nostre
etnografie la complessità delle rappresentazioni espressive (film, romanzi, resoconti di viaggio), non solo
come appendici tecniche, ma come fonti primarie con cui costruire e interrogare le nostre stesse
rappresentazioni».
3.3. “Consumo, durata e storia”.
Il consumo secondo l’economia neoclassica costituisce la fine del percorso per beni e servizi, il
termine della loro vita sociale. Il consumo però è anche ripetizione e abitudine, anzi tende all’abitudine
attraverso la ripetizione. Ci sono anche segnali di consumo che in realtà riproducono modelli di
scambio di doni (Mauss) su una base di periodicità. Le periodicità di consumo organizzate socialmente
sono costitutive del significato sociale dei riti di passaggio; è il consumo che in molti casi determina tali
periodicità e quindi il tempo, e non si limita a rifletterlo (l’anticipazione e pianificazione dei regali di
Natale). Le periodicità del consumo sono però da considerarsi all’interno di momenti storici più
lunghi, ma questi modelli di lunga durata per essere compresi adeguatamente devono essere valutati in
prima istanza a livello locale. Il mutamento di lungo termine del consumo, infatti, non è ovunque
rapido alla stessa maniera e la questione della sua rapidità e della sua intensità è di particolare
interesse.
Il consumo crea il tempo ed è responsabile della sua mercificazione: la rivoluzione dei consumi ha
trasformato il lavoro in merce e il tempo lavorato; il tempo è oggi un’entità salariabile. La quantità di
tempo di cui ognuno ha il controllo (tempo libero) diventa un indicatore di status. Il consumo oggi è la
pratica sociale attraverso cui le persone sono inserite nella fantasia: nostalgia e fantasia tramite il
consumo vengono combinate in un mondo di oggetti mercificati. Oggi siamo in una “rivoluzione del
consumo”: il consumo è diventato l’attività principale della società tardo-industriale.
3.4. “Giocare con la modernità: la decolonizzazione del cricket indiano”.
Saggio semplice che si può riassumere nella sua struttura: l’ideologia del cricket in Inghilterra; la
penetrazione del cricket in India e le sue ragioni colonizzanti; gli attori dell’indigenizzazione dello
sport: principi, professionisti inglesi e australiani, sponsor commerciali; rapporto tra cricket, squadre
su base religiosa e nazionalismo indiano; l’uso dei media: tv, radio e linguaggio, stampa specializzata e
biografie dei campioni come collage della modernità.
Qui ci limitiamo a indicare i punti sui quali vorrei che rifletteste autonomamente (cercando magari ulteriori
contesti di applicazione):
1. rapporto tra sport e appartenenza collettiva (nazionalismo o altro) … e basterebbe indicare il film InvictusL’invincibile un film del 2009 di Clint Eastwood basato su una storia vera (il rugby come prodotto dei bianchi
zuavi, che poi diventa fattore di coesione popolare nella Republica Sudafricaa) ;
2. rapporto tra sport e media come esempio di intreccio tra mediorama e ideorama, che si rinforzano.
Per un ex-colonia la decolonizzazione non è solo uno smantellamento di abitudini, ma un dialogo
con il passato coloniale e mentre l’Inghilterra si è progressivamente snaturata man mano che perdeva
il suo impero, alcuni aspetti del suo retaggio si sono radicati nelle colonie. Il cricket si presenta come
forma culturale “dura” e quindi resistente alla trasformazione sociale; in realtà è diventato
profondamente indigenizzato al punto che l’India soffre di una vera e propria febbre da cricket.
Questo perché, secondo Appadurai, l’indigenizzazione di uno sport come il cricket avviene lungo molte
dimensioni: dal modo in cui lo sport è gestito, dal retroterra sociale dei giocatori, dalla dialettica tra
spirito di squadra e sentimento nazionale, dal modo in cui viene costituito un vivaio di giocatori a cui
attingere per perpetuare lo sport, dal contributo dei media e della pubblicità. Il cricket è parte di una
storia più vasta che racconta la costituzione di un tessuto culturale postcoloniale e globale per gli sport
di squadra. Il cricket è riuscito meglio di ogni altra cosa ad instillare e comunicare i valori delle classi
vittoriane in Inghilterra; era un’attività maschile ed esprimeva i codici che ci si aspettava possedessero
gli uomini: spirito sportivo e cavalleresco, controllo assoluto delle emozioni, subordinazione dei
sentimenti e degli interessi personali a quelli del gruppo, fedeltà assoluta alla squadra. Ma oltre che
strumento di socializzazione della classe dominante vittoriana, il cricket si rivelò anche strumento di
mobilità sociale per coloro che, pur provenendo da classi inferiori, erano molto dotati nello sport. In
campo la divisione di classe era momentaneamente sospesa. In India, inglesi ed indiani mai giocavano
insieme, ma il cricket divenne uno strumento informale della politica culturale statale, grazie
soprattutto ad esponenti dell’amministrazione che considerarono questo sport come il mezzo più
efficace per trasmettere alla colonia gli ideali vittoriani di forza di carattere e vigoria fisica. E
soprattutto tra il 1870 e il 1930, giocare a cricket per gli indiani volle dire entrare in contatto con il
misterioso mondo degli inglesi. Successivamente principi indiani si resero responsabili della diffusione
del c. chiamando giocatori professionisti dall’Inghilterra e dall’Australia per allenare le squadre locali,
organizzando tornei, impiantando campi da gioco, importando materiale ed ospitando le squadre
inglesi. Inoltre fornirono supporto diretto e indiretto a ottimi giocatori di umili origini. Quello che
avvenne dunque non fu una semplice riproduzione di uno sport, ma l’entrata in contatto di gerarchie
inglesi e indiane produsse un gruppo di indiani di estrazione medio-bassa che si sentivano allo stesso
tempo dei veri giocatori di cricket e dei veri indiani.
Il dominio del c. sui media si è avuto con l’avvento della televisione, che ha consacrato il c. come
perfetto sport televisivo e i giocatori come divi. La televisione ha rafforzato la passione nazionale per il
c. coltivata dalla radio e ha aperto le porte ai giornali specializzati, ai libri sull’argomento, all’accesso
fattivo del grande pubblico al gioco. Una volta che il c. può essere visto, ascoltato e letto si crea in tutta
l’India un pubblico competente che comprende sempre di più l’inglese e che da spettatore di un gioco
diventa protagonista del fenomeno d’indigenizzazione.
3.5. “Il numero nell’immaginazione coloniale”.
Questo capitolo potrebbe benissimo essere letto “sugli usi e gli abusi della quantificazione”.
Introdotta dallo stato britannico ma che è ancora in vigore presso le scienze amministrativistiche che
non sono affatto neutrali.
Appadurai mette in atto una nuova prospettiva per una critica del dominio coloniale europeo:
ritiene che lo stato coloniale britannico abbia impiegato la quantificazione nel suo governo del
subcontinente indiano in un modo diverso da quello utilizzato dalla sua controparte domestica nel 18°
secolo. È stato scritto molto sull’ossessione dello stato britannico in India per la classificazione della
popolazione indiana e molti storici hanno indicato che le classificazioni coloniali avevano l’effetto di
disporre le pratiche indigene verso nuove direzioni, modificando l’identità di gruppo. Poca attenzione
è stata però ricolta ai numeri, alla misurazione e alla quantificazione di questa impresa. La quantità di
statistiche che venivano prodotte, infatti, dava a coloro che le redigevano e a coloro che le visionavano
l’idea di una realtà indigena controllabile. La nuova élite coloniale alfabetizzata riteneva che la
quantificazione fosse socialmente utile, in realtà fu uno degli elementi che determinò il sorgere delle
idee nazionaliste e il progressivo declino del dominio coloniale. In quel periodo in Gran Bretagna
vigeva la convinzione che uno stato potente non potesse sopravvivere senza fare dell’enumerazione una
tecnica cardine del controllo sociale; di certo l’applicazione dei censimenti in India fu molto diversa
nelle sue motivazioni da quella fatta in patria (gli indigeni erano visti come una popolazione
problematica nel suo insieme). Il numero era anche uno strumento per disciplinare l’enorme apparato
burocratico dello stato. Più problematico si rivelò l’avvio di una politica catastale per classificare il
territorio, perché gli iniziali interessi erariali si andarono ad intrecciare con quelli di natura geografica
e topografica.
Questi documenti erano anche strumenti di educazione per i misuratori indigeni: “la terra va governata, la
terra va insegnata”.
Le pratiche di conteggio ebbero un’altra grande conseguenza: sciolsero i gruppi sociali dalle
complesse e localizzate strutture di gruppo e pratiche agrarie in cui erano inseriti. La diversità delle
caste, delle sette, delle tribù e degli altri raggruppamenti venne ricondotta in un panorama categoriale
più vasto slegato dalla specificità del terreno agricolo. Anche se la storia del censimento pan-indiano
mostra che in pratica c’erano molte difficoltà a costruire una griglia pan-indiana di caste dotate di un
nome e quantificate. Certo è che tutto questo determinò quello che venne definito “l’approccio per
comunità” che ebbe la sua manifestazione più drammatica nella costituzione di elettorati separati per
indù e musulmani, ma che non fu ristretto a questi 2 gruppi religiosi. Oggi la democrazia indiana è
ancora negativamente influenzata dall’idea dei votanti divisi in blocchi piuttosto che di individui
padroni del proprio voto. Altri regimi possono aver avuto degli interessi numerici e degli interessi
classificatori, ma queste 2 sfere rimasero sempre separate; nello stato coloniale, invece, queste 2 sfere
si fusero e l’enumerazione delle comunità umane divenne lo scopo politico principale.
3.6. “Sopravvivere al primordialismo”.
Lo scopo del saggio è dimostrare che i conflitti “etnici” che dalla fine degli anni Ottanta sembrano
attraversare il mondo con frequenza sempre più allarmante non sono il “riemergere” di odi congelati,
ma sono invece la risposta alle politiche uniformanti dello stato, a volte come reazione, a volte proprio
come assecondamento di quelle politiche. Le nuove etnicità delineano una matrice composta da: 1)
ampiezza della dimensione; 2) ambizione nazionalista; 3) uso della violenza. L’etnicismo è quindi la
reazione a una pressione esterna, dovuta alle condizioni globali e al tentativo degli stati di realizzare il
progetto originario dell’unità nazionale. Non parliamo quindi di esplosioni etniche, ma d’implosioni.
Per primordialismo alcuni antropologi (pochi) e molti analisti politici intendono la resistenza alla
modernizzazione che si espleta per privilegiare in modo irragionevole o irrazionale i legami
primordiali delle piccole comunità di appartenenza.
Il loro ragionamento può essere così sintetizzato: tutti gli uomini sono stati primordialisti, ma per fortuna
abbiamo inventato la democrazia liberale o il socialismo, o un’altra versione della modernità come processo
inevitabile, e quindi noi siamo sfuggiti alle maglie mortali di quei legami fatti di faide, sangue e occhio per
occhio, mentre loro sono ancora intrappolati nel loro sistema di relazioni primordiali. Ergo, siamo autorizzati
ad “esportare la democrazia” oppure a sottomettere gli “uomini primordiali”.
Questa proposta interpretativa non tiene conto però del fatto che paradossalmente gli stati nati
dalla decolonizzazione hanno manifestato i segni più evidenti di pratiche violente ed etnocidi proprio
mentre mettevano a punto il loro progetto di modernizzazione, assumendo tutte le istituzioni tipiche di
un “moderno” stato nazionale. Detto altrimenti, quella che a noi potrebbe sembrare la cura del male si
è rivelata esserne una causa, o almeno un fattore di complicazione. Il caso degli eserciti e delle forze di
polizia (che in uno stato moderno dovrebbero costituire l’incarnazione della legalità in quanto
espressione del monopolio dell’uso della forza da parte dello stato per fini benefici) è esemplare: invece
di garantire l’ordine sociale e evitare l’esplosione della violenza politica ed etnica, molte volte le forze
dell’ordine nei nuovi stati sono state lo strumento principale di terribili pratiche di violenza.
Sono vittime del primordialismo quelle entità politiche che non hanno avuto abbastanza tempo per
adattarsi alle pratiche legali della modernità, che insomma hanno mal digerito la lezione liberale e
pacifica della democrazia, reagendo a volte in modo irragionevole (dimensione storica). Ma questo non
spiega casi come l’Irlanda, i Paesi Baschi, e non spiega poi com’è possibile che stati per lungo tempo
pacifici e pienamente in grado di maneggiare gli strumenti istituzionali della modernità, dopo molti
decenni di pace siano letteralmente esplosi (vedi la Jugoslavia, cui di certo non mancava una
tradizione antica di pratica statale). Neppure le democrazie più stabili (Francia, Germania, USA)
sembrano immuni al tarlo del primordialismo.
Per Appadurai la violenza etnica non è il ritorno di pratiche ataviche, il riemergere di emozioni
primitive perché primordiali, ma è invece la risposta moderna alla crisi attuale delle appartenenze:
sottratti al controllo imbrigliante dello stato accentratore e politicamente omogeneizzante, i flussi
discussi nei capitoli precedente implodono sui corpi delle persone, insegnando loro le forme dell’odio e
dell’appartenenza originariamente sorte entro lo stato, ma ormai prive del contenitore che le aveva
generate e che riusciva (internamente) a contenerle, per spingerle invece verso l’esterno (il nemico
oltre confine). Una volta che lo stato non riesce più – sotto la spinta della globalizzazione delle idee,
delle merci e delle persone – a contenere quei modelli di appartenenza pura sotto il suo controllo,
quegli stessi modelli possono essere rivendicati blandamente come richiesta di diritti, oppure essere
urlati in faccia agli altri come volontà di distruzione di tutto ciò che non somiglia loro, fosse anche solo
il vicino di casa. L’alternativa all’approccio primordialista è data dal modello d’implosione etnica.
Seguendo l’approccio di Rosenau, Appadurai sostiene che non è possibile descrivere le dinamiche del
mondo contemporaneo senza tenere conto che ci sono 2 sistemi nell’odierna politica mondiale: quello
multicentrico e quello statocentrico, e l’interazione turbolenta di questi 2 sistemi determina la
struttura della società. Rosenau descrive gli eventi di questi sistemi come delle “cascate”, sequenze di
azioni che prendono slancio, si bloccano, invertono il loro corso, e dove la politica globale è
strettamente legata alla micro politica delle strade. L’attuale violenza estrema tra gruppi etnici poggia
su un sentimento di profondo tradimento, tradimento rispetto all’identità di gruppo; la rabbia che si
promana da questa idea di tradimento può facilmente espandersi a masse d’individui che non
conoscono il responsabile, ma animano questa rabbia. Il culturalismo è potenzialmente incline alla
violenza, soprattutto in una fase storica in cui lo spazio culturale a disposizione dello stato è soggetto
all’influenza dei flussi migratori e della comunicazione di massa.
3.7. “Il patriottismo e i suoi futuri”.
Per pure ragioni di tempo, voglio provare a veicolare l’idea di fondo e la ragione che mi ha spinto a
includerlo nei capitoli del programma. Per tutto questo corso, abbiamo ragionato cercando di vedere
come le appartenenze non siano un dato di fatto naturale: come impariamo la playstation o a
truccarci, così impariamo a sentirci a casa nella comunità che consideriamo nostra. Questo lavoro di
riflessione sulla costruzione delle appartenenze si è accompagnato allo studio di come quelle vecchie
costruzioni oggi siano profondamente in crisi rendendo instabile e friabile il terreno su cui poggiano
tutte le appartenenze (“il mondo si è messo in movimento”).
Siamo quindi passati attraverso questo corso cercando di capire che le identità collettive sono una
costruzione, e che questa costruzione sembra oggi potentemente “decostruita” nella sua stabilità dal
processo della globalizzazione. Ma questo lavoro di consapevolezza e decostruzione non è sufficiente,
perché la natura sociale dell’uomo lo porta inevitabilmente a considerarsi parte di qualche gruppo.
Come possiamo ancora pensare di appartenere a qualche comunità, nelle condizioni attuali? È questa
la domanda che Appadurai si pone in questo capitolo. La sua proposta fondamentale è quella di
separare il trattino che unisce il totem politico dello stato-nazione, per far sì che il nostro senso di
appartenenza non sia limitato ai nostri doveri civici, e neppure coincida ossessivamente con essi.
Elaborando il concetto di transnazione, Appadurai vuole suggerirci che il nostro senso di appartenenza
può riuscire a travalicare i confini e che gli stati devono fare di tutto (se vogliono sopravvivere come entità
morali, oltre che politiche) per assecondare questo movimento di liberazione.
3.8. “La produzione della località”.
L’intento di Appadurai è comprendere il significato della località in una situazione in cui lo stato
nazionale è di fronte a forme specifiche di destabilizzazione transnazionale. Uno dei luoghi comuni
della teoria sociale sulla località, vede quest’ultima come oggetto in pericolo nelle società moderne e
allo stesso tempo come dato di fatto e fine a sé stessa. Diversi studi (Malinovsky, van Gennep, Frazer)
hanno invece dimostrato che le società di piccola scala non tendono a considerare la località come un
dato di fatto, ma partono dal presupposto che la località sia un bene effimero che va prodotto e
mantenuto con costanza. Alla luce del concetto di località e di vicinato, Appadurai ritiene che debba
essere rivista l’intera etnografia, la qual cosa avrebbe 3 vantaggi: 1) l’etnografia si trasformerebbe da
storia dei vicinati a storia delle tecniche di produzione della località; 2) farebbe riconsiderare l’enorme
categorizzazione fatta degli indigeni da parte di antropologi, intellettuali, missionari, etnologi; 3) la
nuova etnografia, quella che si concentra sulle località appunto, darebbe un enorme contributo
all’etnografia stessa.
Nell’attuale mondo i media elettronici stanno trasformando i rapporti tra informazione e
mediazione, e gli stati nazionali si battono per tenere il controllo sulle loro popolazioni contro una
miriade di movimenti subnazionali. Produrre località è un compito sempre più difficile: lo stato
nazionale basa la sua legittimità sul controllo di un territorio confinato, all’interno del quale controlla
i cittadini, definisce i capitali e le strutture, e costruisce il popolo. Ma da una parte vuole creare uno
spazio piatto, omogeneo, facile da sorvegliare e dall’altra crea luoghi e spazi distinti e divisi, adibiti
alla sicurezza, al controllo, alla disciplina. Gli stati non riescono, per quanto ci provino, a penetrare la
vita quotidiana dei cittadini e lo dimostrano le economie sommerse, le polizie private, i nazionalismi
secessionisti. I singoli stati, inoltre, si comportano diversamente rispetto a forme culturali di
riferimento diverse e questo crea discontinuità tra stati contigui.
La località per lo stato è il luogo della memoria, per le celebrazioni, le commemorazioni, la
produzione di cittadini e tutto ciò che è a beneficio del modello nazionale; il vicinato, invece, che
dovrebbe riprodurre docili cittadini nazionali, produce soggetti locali autonomi e sono una fonte
d’insicurezza per lo stato nazionale. Allo stesso tempo i vicinati sono una riserva dove attingere per la
produzione di lavoratori, insegnanti, soldati, tecnici e agricoltori. Inoltre è natura della vita locale
svilupparsi anche in opposizione ad altri vicinati, creando alterità che minano alla base il progetto
nazionale di costruzione del cittadino disciplinato.
Ci sono una serie di pratiche messe in atto dallo stato che minano se stesso o gli stati vicini o che
quantomeno rendono difficile perseguire l’obiettivo del controllo all’interno dei confini: la repressione
verso gruppi considerati disturbanti (i profughi) crea un movimento degli stessi che li spinge verso
altri paesi, allargando la situazione di disordine e instabilità; la povertà o la repressione di un paese
può spingere le persone a sperare in una vita migliore e in nuove possibilità economiche da un’altra
parte; alcune categorie di lavoratori (come i soldati dell’ONU o gli ingegneri petroliferi) sono
perennemente in movimento; carestie e siccità nei paesi africani creano migrazioni imponenti; infine
l’industria del tempo libero. Costituire un vicinato in questa realtà è un’attività problematica. Una
variante estrema di questo problema è costituita dai campi profughi semi-permanenti palestinesi, dove
il vicinato è prodotto dal contesto e non viceversa e dove si concretizza l’esempio più lampante delle
situazioni d’incertezza, povertà, spaesamento in cui la località può essere prodotta.
C’è poi il ruolo dei media nel creare nuovi tipi di disgiuntura tra vicinati spaziali e virtuali. I nuovi
mezzi di comunicazione, spesso diffusi anche in ambienti poverissimi della popolazione, eludono il
controllo degli stati nazionali con il loro potenziale comunicativo transnazionale, e creano inedite
connessioni tra produzioni e pubblici, locali e nazionali, stanziali e diasporici. Gli stessi leader
sfruttano questi mezzi per comunicare rapidamente con realtà locali e nazionali. E poi c’è internet,
una comunità elettronica che consente il dibattito, il dialogo e la costruzione di relazioni tra individui
separati sul piano territoriale ma uniti in una comunità d’immaginazione e d’interessi: è il vicinato
virtuale, non più legato al territorio e al passaporto, ma al possesso di sw e hd. Questi vicinati virtuali
pur non basandosi su un rapporto face to face, sono in grado di mobilitare veramente le persone oltre
che le idee e di spingerle all’azione comune, faccia a faccia.
I 3 elementi che più influenzano la produzione della località – lo stato nazionale, i flussi diasporici,
le comunità elettroniche e virtuali – si articolano tra loro in forme variabili. La località sorge sempre
dalle pratiche dei soggetti locali in specifici vicinati e la possibilità che diventi una struttura di
sentimento è variabile e indeterminata. Le popolazioni spaesate, deterritorializzate e in movimento che
costituiscono gli etnorami moderni sono impegnate nella costruzione della località, in quanto struttura
di sentimento, dovendo spesso far fronte all’erosione, alla dispersione e all’implosione dei vicinati
come formazioni sociali coerenti.
Cosa pensare di fronte all’ingegneria finanziaria che scommette sui disastri attraverso i cat bond, le
“obbligazioni catastrofe”? La risposta di Appadurai sta nell’«etica della possibilità», ovvero in quei
modi di pensare, sentire e agire che ampliano gli orizzonti della speranza, espandono il campo
dell’immaginazione, generano maggiore equità, allargano gli spazi di una cittadinanza informata,
creativa e critica. Da parte sua l’antropologia – e non solo, perché secondo l’autore la ricerca tout court
dovrebbe essere riconosciuta alla stregua di un diritto umano – deve disporsi a rilevare e interpretare
le «idee di vita buona» che animano e orientano gli individui e le società, e la capacità di aspirare,
ovvero la «capacità di navigazione» grazie alla quale le componenti più svantaggiate delle società
fanno fronte alle logiche dell’emergenza e della catastrofe con quella “disciplina della pazienza” che sa
convertire «l’aspettare che» in «aspettare di»: la chiave di volta, secondo Appadurai, per «strategie
fondate sulla speranza»1.
Riflessioni/sollecitazioni/esercitazioni.
1. Appadurai fa riferimento al film-documentario di Mira Nair, India Cabaret e della stessa regista
si può vedere Salaam Bombay. Dopo la visione, si desidera un commento.
2. Riflettere e approfondire questi concetti chiave dell’opera di Appadurai:
a. Immaginazione.
b. Stato-nazione.
c. Culturalismo.
d. Deterritorializzazione.
e. Indigenizzazione.
f. Identità.
g. Etnicità.
3. Cosa si intende per etica della probabilità e per etica della possibilità?
4. Come si potrebbe progettare e realizzare un programma didattico nella scuola secondaria (e in
università)? Quali potrebbero essere secondo voi le discipline nell’era della globalizzazione? Se
pensate adesso alla storia o alla filosofia, cosa secondo voi andrebbe riformato nel programma (e nei
manuali)?
Ivi, “Sopravvivere al primordialismo”; “Il patriottismo e i suoi futuri”.
1