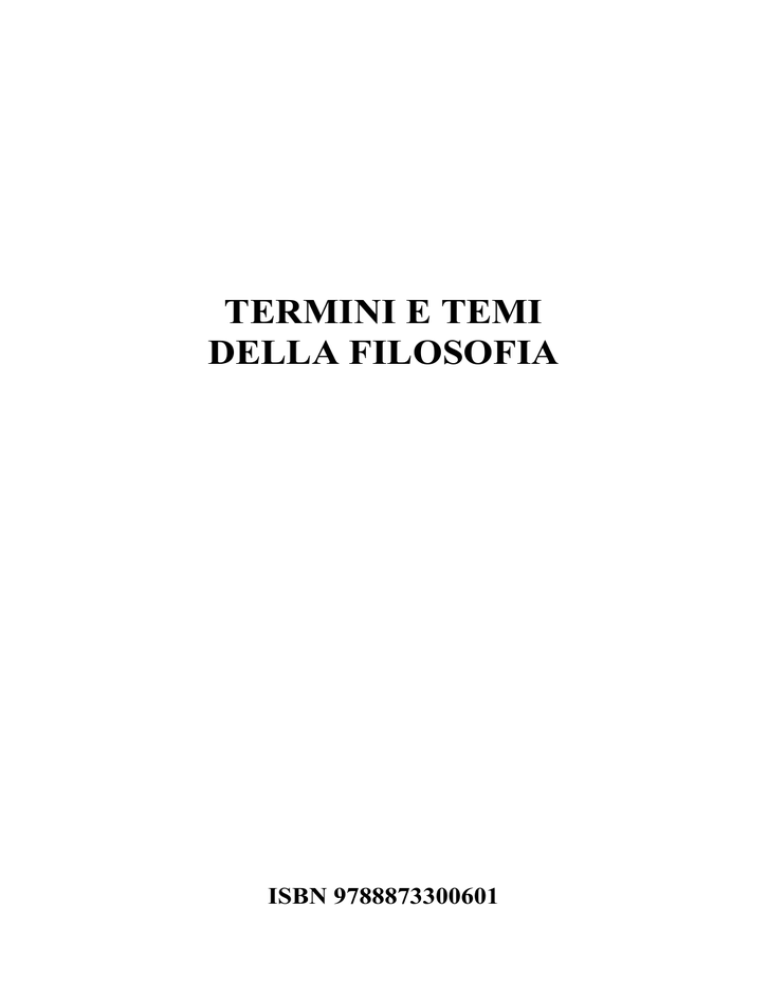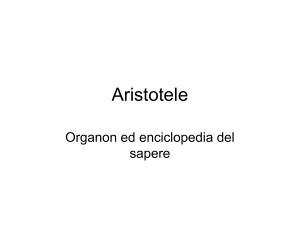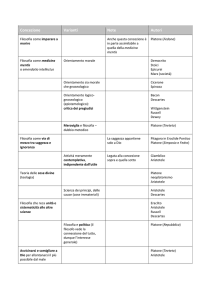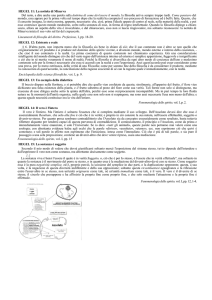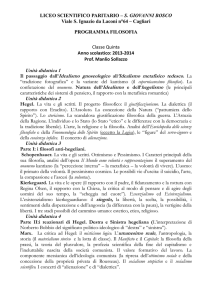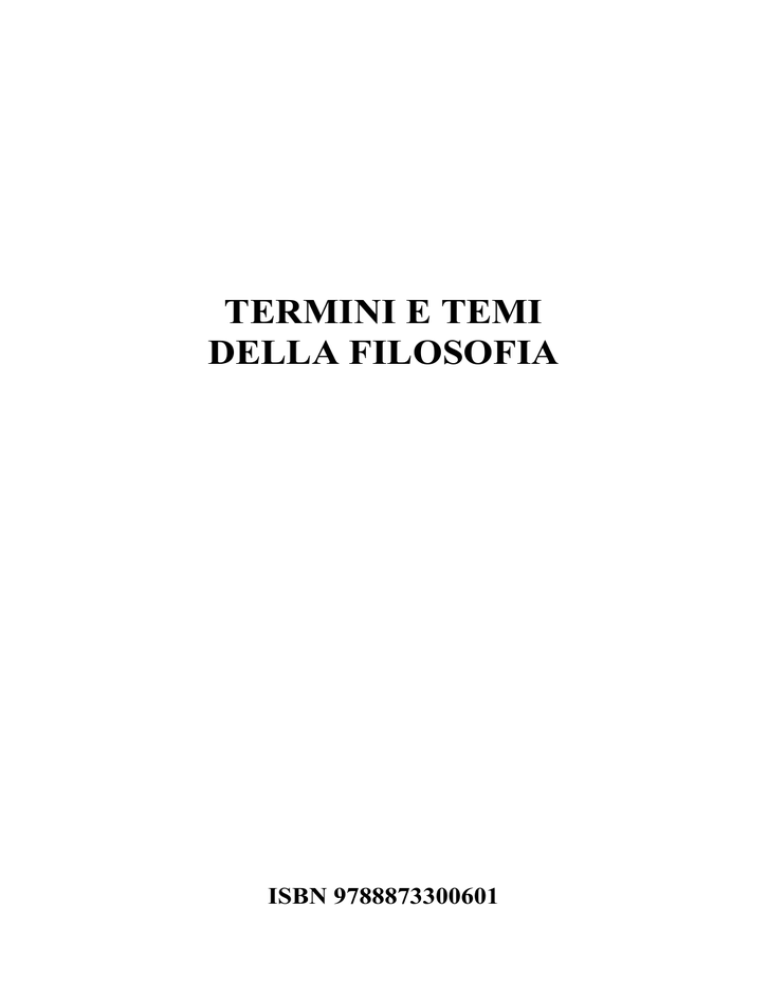
TERMINI E TEMI
DELLA FILOSOFIA
ISBN 9788873300601
I termini filosofici qui proposti sono una selezione di un lavoro più ampio, in via di
compilazione. Sono stati scelti per fare da supporto ai vari volumi della sezione
filosofica, sia il manuale Dai presofisti ai postmoderni, sia l’antologia tematica
Interroghiamo i filosofi, sia i classici e le antologie tematiche della collana La ricerca.
Costituiscono infatti di per sé proposte di percorsi, corredati da adeguate indicazioni
bibliografiche.
Per altri approfondimenti, si possono ricercare i termini proposti anche in Internet,
prendendo come punto di inizio e di riferimento il Portale di Filosofia.
2
A
ADAEQUATIO REI ET INTELLECTUS
È la tradizionale definizione latina di verità, formulata dalla Scolastica medioevale secondo
l’orientamento del realismo gnoseologico. È presente in particolare negli scritti di
Tommaso d’Aquino. Essa ripropone ciò che la filosofia classica antica aveva sempre
sostenuto, confermando una convinzione del senso comune: la verità consiste nella
corrispondenza (adaequatio) tra ciò che si pensa (e si dice) e la realtà oggettiva intenzionata
dalla mente (→ Intenzionalità). Propriamente la gnoseologia greca parlava di “somiglianza”
(ὁμοίωσις, homóiosis), intendendo il processo conoscitivo come un’assimilazione, cioè un
farsi simile del soggetto all’oggetto. Pertanto, parafrasandola, la formula “adaequatio rei et
intellectus” va intesa come un “adeguare la mente alla realtà” (intellectum rei adaequare).
→ Assimilazione cognitiva; Verità; Realismo
La “rivoluzione copernicana” di Immanuel Kant inverte la disposizione di questo
rapporto, intendendolo come un adeguamento della realtà alla mente (rem intellectui
adaequare), nel senso che è la realtà a conformarsi alle nostre strutture mentali (forme).
L’inevitabile esito fenomenistico di tale impostazione non dà luogo alle conseguenze
relativistiche degli scettici, perché assicura una conoscenza dotata di universalità e
necessità e, in questo senso, “oggettiva”. → “Rivoluzione copernicana”; Fenomeno;
Oggettività; Oggetto
Occorre anche aggiungere che nell’interpretazione tomistica la formula qui considerata è
anche intesa nel senso dell’esemplarismo d’impostazione platonica, secondo il quale la
verità consiste primariamente e ontologicamente nell’adeguarsi della realtà creata alle idee
presenti nell’intelletto divino, dalle quali dipendono. → Esemplarismo
AGNOSTICISMO
Questo termine, derivato dal greco ἄγνωστος (ágnostos), che significa “ignoto”, fu coniato
dal naturalista Thomas Henri Huxley (1825-1895), per designare l’atteggiamento di chi non
intende pronunciarsi di fronte a problemi scientificamente insolubili. Fu poi felicemente
accolto dai filosofi, che solitamente lo usano per caratterizzare la condizione mentale di chi
ritiene che la ragione umana non possa conoscere e quindi non sia in grado di dimostrare
verità d’ordine metafisico, in particolare l’esistenza di Dio. L’agnostico, tuttavia, non è
ateo, perché è semplicemente convinto che la condizione umana sia insuperabilmente
problematica e quindi non si possa dir nulla di un’ipotetica realtà divina.
Talora
l’agnosticismo è la manifestazione di un più generale scetticismo (→ Scetticismo) o può
persino esprimere un pratico indifferentismo. A questo riguardo si può considerare
significativo il caso occorso all’apostolo Paolo in un’Atene scaltrita dalla presenza delle
filosofie più diverse e propensa ad un atteggiamento generalmente critico e scettico.
Percorrendola, vi aveva scorto un altare dedicato “al dio ignoto” ἄγνωστω θεῶ (ágnosto
theô). Agli incuriositi interlocutori, che aveva trovato davanti all’Areopago, pensò di poter
suggerire il nome del Dio di Gesù Cristo, in cui credeva. Fu grande, tuttavia, la sua
3
disillusione nel constatare che alcuni lo deridevano e altri più benevolmente dicevano: ‘Ti
sentiremo su questo un’altra volta’”5.
Nella filosofia antica una netta posizione agnostica era stata quella di Protagora, che così
si era espresso: “Riguardo agli dei, non ho la possibilità di accertare né che sono, né che
non sono, opponendosi a ciò molte cose: l’oscurità dell’argomento e la brevità della vita
umana”6.
Particolarmente problematica, poi, fu la posizione di Immanuel Kant, che professò un
esplicito agnosticismo in ambito teoretico nei riguardi delle tradizionali verità metafisiche,
ritenendo peraltro di poterlo superare mediante una postulazione di tipo etico. →
Fenomenismo; Dio (La questione della dimostrabilità dell’esistenza di Dio: La critica di
Immanuel Kant)
ALIENAZIONE
Nel linguaggio giuridico questo termine, che deriva dal latino alius (altro), designa la
cessione e il trasferimento ad altri di un bene o di un diritto. Nella storia della filosofia
risulta interessante l’uso che ne hanno fatto in particolare Rousseau, Hegel, Feuerbach e
Marx. La concezione dialettica dell’alienazione, propria di Hegel e Marx, fa sì che essa sia
considerata un’esperienza soltanto immediatamente negativa, perché il suo superamento
comporta un esito finale positivo: essa fa provvisoriamente perdere al soggetto considerato
(l’Idea per Hegel, il proletariato nella società capitalistica per Marx) l’originaria identità,
allo scopo di fargliela poi ritrovare in una condizione ontologicamente ed esistenzialmente
superiore. → Dialettica; Aufhebung
J.J. Rousseau: è inammissibile che l’uomo alieni politicamente se stesso
J.J. Rousseau affronta la questione politica servendosi del generale paradigma disposto dal
pensiero giusnaturalistico, secondo il quale vanno innanzitutto riconosciuti come universali
e inalienabili, in quanto naturali, i diritti soggettivi alla vita e alla tutela della propria
incolumità, alla libertà e al godimento dei propri beni. Allo scopo di assicurarne a tutti la
fruizione, lo Stato va pensato come un’organizzazione volontaria del potere, realizzata
mediante un patto originario, che la costituisce come legittima sulla base del consenso e
della delega dei poteri. Nel Contratto sociale, infatti, il filosofo ginevrino afferma: “Dato
che nessun uomo ha per natura autorità sul suo simile e che la forza non crea alcun diritto,
restano solo gli accordi quale base di qualunque autorità legittima in mezzo agli uomini”. Si
potrebbe allora pensare che ciascuno, avendo un diritto naturale su se stesso, possa alienarsi
a qualcun altro, ma egli osserva che in questo rilievo c’è dell’equivoco. “Alienare”, infatti,
“può significare sia donare che vendere”. Ora, la cessione di sé e dei propri beni al despota
sembrerebbe aver come contropartita per i sudditi la tranquillità civile; ma, a ben vedere,
che cosa davvero “vi guadagnano essi, se le guerre che la sua ambizione attira su di loro, se
la sua insaziabile avidità, se le vessazioni dei suoi ministri li rendono molto più desolati di
quanto potrebbero essere per i loro contrasti? Che vi guadagnano, se proprio questa
tranquillità è una delle loro miserie? Anche nelle prigioni si vive tranquilli, e ciò dovrebbe
essere sufficiente perché ci si trovi bene?” Un’ipotetica “alienazione” di sé e della propria
originaria libertà è “una cosa assurda e inconcepibile: un tale atto è illegittimo e nullo, per il
solo fatto che chi lo compie non è nel pieno possesso delle sue facoltà mentali”. In senso
generale occorre far valere il principio secondo il quale “rinunciare alla propria libertà vuol
5
6
Atti degli apostoli, 17, 16-33
I Presocratici, Vol. 2, “B. Frammenti”, 4, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1975, p. 894
4
dire rinunciare alla propria qualità di uomo, ai diritti dell’umanità e anche ai propri doveri”.
In base a queste premesse, per la stessa ragione per cui non è alienabile la libertà
dell’uomo, “la sovranità, altro non essendo che l’esercizio della volontà generale, non può
mai essere alienata”. Gli uomini possono conseguire la propria realizzazione politica
soltanto nella democrazia diretta, perché “il corpo sociale”, di cui la volontà generale è
espressione, “non può essere rappresentato che da se stesso”7. → Politiche (Teorie
politiche)
G.W.F. Hegel: l’Idea alienata (“fuori di sé”) è la natura. La “coscienza infelice”.
Per Hegel l’alienazione è la condizione dell’“Idea fuori di sé” nella realtà materiale del
mondo fisico, nella quale l’Idea appare come “la negazione di sé stessa”, perché
“l’esteriorità costituisce la determinazione, nella quale essa è come natura”8 (→ Idea).
Pertanto nella natura l’Idea è “alienata”, cioè inconsapevole di sé, estraniata rispetto alla
sua originaria idealità. La natura è di per sé una contraddizione non risolta: in quanto è
espressione dell’Idea, è divina, ma, per il modo estraniato (inconsapevole) in cui la esprime,
è Idea decaduta. Non a caso gli antichi consideravano la materia come non ens. Il recupero
dialettico dall’alienazione fa acquisire all’Idea un livello superiore a quello originario e
astratto della semplice condizione logica (l’“Idea in sé”). Questo livello superiore è lo
Spirito (l’“Idea che ritorna a sé”), che si specifica con l’emergere della coscienza
nell’ambito del mondo umano.
Nella filosofia hegeliana, poi, l’alienazione riguarda non soltanto la generale condizione
pre-umana della natura, ma la coscienza stessa. Anche la coscienza, infatti, matura
attraverso un processo dialettico di dis-alienazione, che nella Fenomenologia dello Spirito
Hegel analizza mediante le note “figure” dell’autocoscienza, in particolare le figure della
“signoria e servitù” e della “coscienza infelice” (→ Autocoscienza, Le figure hegeliane
dell’autocoscienza). Soprattutto questa figura nel contesto della filosofia hegeliana non solo
intende rappresentare direttamente ed esplicitamente la specifica esperienza religiosa
dell’ebraismo e del cristianesimo medioevale, ma può essere anche plausibilmente assunta
con un significato più generale. Infatti, la coscienza è infelice o alienata, perché considera
le cose ancora come indipendenti dalla sua propria essenza e quindi estranee. Il
superamento di questa alienazione può avvenire soltanto attraverso la scoperta, che la
coscienza, in quanto autocoscienza, fa della propria infinità e assolutezza creatrice, che
integra in sé tutta la realtà finita. → Idealismo
L. Feuerbach: la religione è l’ autocoscienza alienata dell’uomo
Con il termine “alienazione” Feuerbach designa la condizione di autoestraneazione della
coscienza umana, che è reperibile nell’esperienza religiosa. Egli descrive la religione come
“la prima, ma indiretta autocoscienza dell’uomo”, perché in Dio sono presenti gli stessi
predicati che competono all’uomo. La religione, infatti, “precede sempre la filosofia, nella
storia dell’umanità così come nella storia dei singoli individui. L’uomo sposta il suo essere
fuori di sé prima di trovarlo in sé”. In questo senso “la religione è l’infanzia dell’umanità”.
Essa, tuttavia, è un’infanzia alienata: proiettando illusoriamente l’essenza umana e le sue
caratteristiche specifiche (ragione, volontà e cuore) in un essere fantastico “considerato
come un altro essere”, noi riponiamo in Dio quanto togliamo a noi stessi, al punto che
“l’uomo deve essere un nulla, perché Dio sia tutto”9. Conseguentemente l’ateismo si
7
J.J. Rousseau, Il contratto sociale, I, 4 e II, 1, trad. di G. Barni, Rizzoli, 1974, pp. 42-43 e p. 56
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, a cura di B. Croce, Laterza, 1973, vol. I, § 247, p. 205
9
L. Feuerbach, L’essenza del cristianesimo, a cura di A. Banfi, Feltrinelli, 1971, p. 35 e p. 47
8
5
prospetta come un dovere morale, se davvero vogliamo realizzare la nostra essenza nella
sua autenticità e autonomia.
Feuerbach accomuna nella sua critica il tradizionale pensiero teologico e la filosofia
“speculativa” dell’idealismo. Sostiene, infatti, che “la filosofia di Hegel è l’ultimo rifugio,
l’ultimo puntello razionale della teologia”10, perché è essa stessa una “teologia mascherata”,
cioè razionalizzata. Sia nella teologia che nel pensiero hegeliano è individuabile lo stesso
errore di considerare come predicati dell’infinito le manifestazioni della realtà finita. Sia
l’una che l’altro chiamano concreto ciò che è astratto e ideale. Pertanto il loro svolgimento
speculativo è un cammino alla rovescia: ciò che nell’effettività dell’esperienza sensibile è
soggetto diventa predicato e viceversa, ossia il pensiero, che è una manifestazione
dell’essere, diventà una realtà in sé sussistente, della quale l’essere è considerato
un’espressione derivata e secondaria. Per ritrovare la verità, occorre quindi invertire la
visione capovolta e “rimettere la realtà sui piedi”, mentre invece la teologia e la filosofia
speculativa la fanno poggiare sulla testa, nel senso che la natura per la prima è creata da
Dio e per la seconda è derivata dal movimento dialettico dell’Idea. Il disvelamento del
“misticismo” religioso e speculativo fa sì che il soggetto che crea l’oggetto “a sua
immagine e somiglianza”, non sia più Dio, ma l’uomo.
K. Marx: l’alienazione del proletariato è il prodotto storico del capitalismo
Marx si avvale del termine “alienazione” in una celebre analisi dei Manoscritti economicofilosofici del 1844, con la quale descrive la “disumanizzazione” a cui è ridotto l’operaio,
ossia il lavoratore dipendente della moderna fabbrica, “proletario” perché è ricco solo di
prole11. Marx la considera sotto i seguenti quattro aspetti:
Il proletario subisce l’alienazione di ciò che produce, perché il prodotto della sua forzalavoro non gli appartiene, ma, in quanto capitale, assume di fronte a lui l’aspetto di una
potenza estranea e dominatrice.
Il proletario si percepisce estraneo al suo stesso lavoro, che avverte come una
condizione forzata e costrittiva, asservita a interessi non suoi e a lui ostili (il profitto
del capitalista). Così egli si sente “bestia” in quell’attività che dovrebbe realizzarlo
come uomo, se derivasse da una creatività libera e consapevole; invece
paradossalmente si sente uomo quando fa la bestia, quando mangia, beve, procrea, cioè
quando vive bestialmente attività che sarebbero “anche funzioni schiettamente umane”,
se fossero inserite in un contesto umanamente dignitoso.
Perciò il proletario si vede estraneo al suo stesso Wesen, cioè all’“essenza” umana, che
lo vorrebbe creativo, libero e capace di un lavoro universale. Infatti, diversamente
dall’animale che “produce in modo unilaterale”, ossia “unicamente ciò che gli occorre
immediatamente per sé o per i suoi nati” su sollecitazione degli impulsi fisiologici,
l’uomo secondo la sua essenza “produce veramente soltanto quando è libero dal
bisogno fisico”, perché “si pone liberamente di fronte al suo prodotto […] e si guarda
quindi in un mondo da esso creato”, in particolare quando agisce esteticamente e crea
“secondo le leggi della bellezza”. L’animale produce solo se stesso, mentre l’uomo può
ricreare l’intera natura, suo “corpo inorganico”.
Inoltre risultano deteriorate le relazioni sociali; in particolare il proletario vive in una
condizione di conflittualità con il capitalista che lo sfrutta.
10
L. Feuerbach, Tesi preliminari per la riforma della filosofia, in Scritti filosofici, a cura di C. Cesa, Laterza,
1976, p. 192
11
K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Einaudi, 1980, pp. 69-86
6
L’alienazione è un prodotto storico del capitalismo: da un lato “la proprietà privata appare
come il fondamento, la causa del lavoro alienato”, perché chi è privo dei mezzi di
produzione (il capitale) è costretto a dipendere da chi invece ne è proprietario; dall’altro
“essa ne è piuttosto la conseguenza; [...] Successivamente questo rapporto si converte in
un’azione reciproca”12. L’emancipazione potrà avvenire solo con l’appropriazione
comunitaria degli strumenti di produzione e più in generale con la socializzazione
dell’economia e con il comunismo. L’alienazione e l’emancipazione da essa non sono
condizioni semplicemente naturali, ma storiche, perché è nella storia che l’uomo si realizza
attraverso conflitti e contraddizioni. → Comunismo
AMORE
È un termine che si presta a vari significati, perché può esprimere relazioni affettive molto
diverse. Il greco antico dispone di due termini, che sono normalmente tradotti con la stessa
parola “amore”, ma indirizzano a due differenti percorsi tematici: ἔρως e ἀγάπη (éros e
agápe). Preferibilmente il primo designa l’affezione che spinge al possesso dell’oggetto che
la suscita, il secondo esprime la tendenza a sentire come propria la condizione altrui e la
disponibilità a corrispondere ai suoi bisogni.
Il tema dell’“éros” in Platone
Il tema dell’éros è particolarmente importante nella filosofia di Platone. Nel Simposio e nel
Fedro egli lo connette al tema della bellezza. Nel primo Éros (Amore) è rappresentato
come un demone, che “sta in mezzo fra il dio e il mortale” e consente tra loro la
comunicazione. È figlio di Πενία (Penía = povertà, mancanza, bisogno) e di Πόροσ (Póros
= risorsa, espediente, mezzo, astuzia); perciò da un lato “è molto lontano dall’essere
delicato e bello, come pensano in molti, ma anzi è duro, squallido, scalzo, peregrino, uso a
dormire nudo e frusto per terra”, dall’altro è “coraggioso, audace e risoluto, cacciatore
tremendo, sempre a escogitar machiavelli d’ogni tipo […]; ciò che acquista sempre gli
scorre via dalle mani, così che Amore non è mai né povero né ricco”; inoltre “anche fra
sapienza e ignoranza si trova a mezza strada”, quindi è “filosofo”, cioè ama la sapienza,
perché non la possiede, ma aspira ad essa, così come ama la bellezza, perché desidera
venirne in possesso. Inoltre, l’amore e la filosofia tendono al bene e al bello secondo una
prospettiva d’immortalità, perché “è naturale che si ami l’immortalità insieme al bene se è
vero che l’amore è amore di possedere il bene per sempre”. Già nell’attrazione fisica, che
aspira a procreare mediante il contatto con colui che è bello, è presente l’aspirazione a
sopravvivere, perché “ciò che invecchia e se ne va, lascia al suo posto un’altra esistenza
giovane, identica a quella di prima”. Ad un livello superiore anche le anime colte e belle in
reciproco contatto per una “più intima comunione e più salda amicizia di quella che viene
dai figli” aspirano ad esprimere la propria fecondità spirituale mediante opere che
“garantiscono loro fama e memoria immortale”.
L’iniziazione ai misteri d’amore, alla quale Diotima, profetessa e sacerdotessa di
Mantinea, aveva invitato Socrate e che questi ripropone ai suoi interlocutori, prospetta i vari
gradi nei quali la bellezza è presente nella realtà ed è l’oggetto dell’aspirazione degli
uomini, “cominciando dalle bellezze di questo mondo, in vista di quella ultima bellezza”,
per la quale è bello tutto ciò che è bello: i corpi belli, le anime belle, le leggi e le istituzioni
belle, le scienze belle. Essa è “bellezza eterna, che non nasce e non muore, non s’accresce
12
K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., pp. 82-83
7
né diminuisce, che non è bella per un verso e brutta per un altro, né ora sì e ora no, [...] né
bella per alcuni, ma brutta per altri”18.
La rappresentazione platonica dell’amore per la bellezza è svolta con ulteriore notevole
efficacia nel mito escatologico del Fedro, nel quale è collegato alla teoria della
reminiscenza. L’anima dell’uomo, che vive nell’oblio dentro un corpo, mediante la filosofia
tende a recuperare l’originaria unione con il mondo degli dei. Colui che così si dispone,
“alla vista della bellezza terrena, riandando col ricordo alla bellezza vera, mette le ali”, vive
un autentico processo di interiore trasformazione: “si allontana dalle faccende umane e si
volge al divino”; perdendo l’ordinario contatto con la vita dei più, “è accusato dal volgo di
essere fuori di sé, ma il volgo non sa che egli è posseduto dalla divinità”. L’idea della
bellezza è più vivacemente riflessa di tutte le altre idee nella nostra esperienza: tra le
essenze essa è “la più percepibile dai sensi e la più amabile di tutte”, è tale da coinvolgere
tutto l’uomo e tutta l’anima nelle sue diverse parti in una tensione che eccede la
compostezza di una vita tranquilla: nell’amore si realizza uno stato di “delirio”,
“rapimento”, “estasi”, “smarrimento”, che comporta un vero “patimento dell’anima”. Il
susseguirsi concitato dei termini, a cui Platone fa ricorso, rappresenta un’efficace
sintomatologia del mal d’amore; essa è data dalla registrazione di varie reazioni
psicofisiche, che non dipendono dalla nostra volontà: “rabbrividire”, “accendersi di calore”,
“palpitare”, essere sottoposti alle “trafitture” e agli “assilli” del desiderio amoroso, che ci
sommerge nella sua onda, “smaniare” e subire gli “affanni” per l’oggetto amato19.
L’éros è considerato dal grande filosofo ateniese come una delle quattro forme di “delirio
(μανία, manía) divino”, che l’uomo vive quando è posseduto da un’energia superiore che lo
invade, tanto da essere messo fuori senno. Esse sono: la mania profetica, o mantica, dovuta
all’ispirazione di Apollo; la mania mistica o dionisiaca, che attraverso iniziazioni
misteriche cerca la purificazione dai mali; la mania dei poeti, ispirati dalle Muse; infine,
come forma “più alta”, c’è il delirio d’amore, che dipende da Afrodite e da Eros20. Spetta
alla nostra parte razionale, come ad un coscienzioso auriga, tenere sotto controllo il carro
della nostra anima, che è soggetto al traino indisciplinato di un indomito cavallo nero,
propenso ad accondiscendere ai propri impulsi istintivi. Essa può farsi forte della memoria
della bellezza assoluta e perfetta, contemplata nel mondo divino, per imporre all’anima la
temperanza e dirigere il desiderio verso i valori più alti, in attesa di ritornare nel mondo da
cui è caduta. La filosofia è nostalgia di quella bellezza.
L’amore cristiano è “agápe”
La designazione dell’amore come ἀγάπη (agápe), termine che ordinariamente è tradotto in
latino con caritas, è soprattutto biblica. L’amore realizza compiutamente la vita etica del
credente, perché riassume “tutta la Legge e i Profeti”. Il suo oggetto è apparentemente
duplice: (“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima” e “Amerai il
prossimo tuo come te stesso”), ma, nella radice teologica che lo motiva e nella fede che lo
sostanzia, è unico: “In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. […] Dio è
18
Platone, Simposio, 201 d - 212 c, trad. di P. Pucci, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1971,
vol. 3, pp. 188-201
19
Platone, Fedro, 249 d; 250 d; 251 a - 252 b, trad. di P. Pucci, in Opere complete, cit., vol. 3, pp. 250 ss.
20
Platone, Fedro, 265 b, cit., pp. 269-270
8
amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui” 21. Pertanto l’incarnazione di
Dio è il vertice della historia salutis (storia della salvezza), perché rivela la misura infinita
della sua condiscendenza verso l’uomo e della grazia (χάρις, cháris), con la quale fa dono
di sé agli uomini, perché essi stessi, a loro volta, facciano altrettanto verso i loro simili.
Dell’amore Paolo tesse l’elogio in un famoso inno, nel quale evidenzia come suoi tratti
salienti la pazienza, la benignità, l’attenzione disinteressata al bene altrui, l’incapacità di
godere dell’ingiustizia, e lo segnala come la condizione definitiva ed eterna: “La carità non
avrà mai fine. […] Queste le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di
tutte più grande è la carità”22.
Éros e pietà nel pensiero di A. Schopenhauer
Per Arthur Schopenhauer l’origine metafisica dell’universale dissidio, della conflittualità di
interessi ed egoismi reciprocamente ostili e dell’odio che intercorre tra gli uomini consiste
nell’individuarsi dell’unica e irrazionale Volontà in una pluralità indefinita di esseri. Anche
là dove si offre l’incanto di un possibile incontro tra due esseri determinato dall’éros,
questo svela ben presto il proprio inganno: l’individuo è strumento e vittima della specie e
la natura, che vuol solo la perpetuazione della vita, si fa beffe di lui, illudendolo, perché ciò
a cui essa mira è solo la perpetuazione della specie. Con questo tipo di amore si realizza
l’incontro di due infelicità per generarne una terza.
Possiamo trovare pensieri simili in Giacomo Leopardi, per esempio nel Canto notturno di
un pastore errante dell’Asia (versi 39-44).
Un diverso atteggiamento verso il prossimo è dato, secondo Schopenhauer, dalla pietà,
che è autentico amore disinteressato, carità e compassione, le quali ci rendono capaci di far
nostra la sofferenza degli altri. E tuttavia “compatire” è pur sempre “patire”. Pertanto,
nemmeno l’etica è un rimedio risolutivo al male di vivere. Lo è solo l’ascesi radicale, il cui
esito finale è il distacco dalle seduzioni sensibili e la soppressione della volontà di vivere.
ANGOSCIA
Questo termine, così come il corrispondente tedesco e danese angst, deriva dal latino
angustia, che a sua volta rinvia al verbo angere (stringere). Nel suo significato originario
designa una condizione di soffocante ristrettezza e oppressione, che genera affanno e
inquietudine.
L’esistenzialismo, sulle tracce di Kierkegaard, ha prestato un’attenzione particolare
all’angoscia, individuando in essa una peculiare situazione emotiva, che rivela la specificità
dell’esistenza umana. Rimane, tuttavia, paradigmatica la descrizione che ne aveva già fatto
Hegel nella dialettica dell’Autocoscienza.
G.W.F. Hegel: la funzione dialettica dell’angoscia nel processo di emancipazione
dell’Autocoscienza
Nel rappresentare la vicenda dialettica della “signoria e servitù”, una delle più note figure
dell’Autocoscienza, nella Fenomenologia dello Spirito G.W.F. Hegel considera l’angoscia
(Angst) come un’importante esperienza attraversata dalle singole autocoscienze in reciproco
conflitto, in cui ognuna intende affermare se stessa sull’altra (→ Autocoscienza). È una
“lotta per la vita e per la morte”, alla quale si sentono obbligate, perché “debbono, nell’altro
21
Matteo, 22, 37-40; 1 Giovanni, 4, 8-16, in La Bibbia di Gerusalemme, versione della Conferenza episcopale
italiana, EDB-Borla, 1974
22
S. Paolo, 1 Corinti, 13, 4-13, in La Bibbia di Gerusalemme, cit.
9
e in se stesse, elevare a verità la certezza loro di esser per sé. E soltanto mettendo in gioco
la vita si conserva la libertà, si dà la prova che all’autocoscienza essenza non è l’essere, non
il modo immediato, nel quale l’autocoscienza sorge, non l’esser calato di essa
nell’espansione della vita”. Per voler affermare la propria indipendenza, ogni autocoscienza
si trova nella condizione di rischiare la vita. Di fronte alla morte, “signora assoluta”, essa
“non è stata in ansia per questa o quella cosa e neppure durante questo o quell’istante, bensì
per l’intiera sua essenza”. Quando ha provato una tale situazione, può dire che “ha tremato
nel profondo di sé, e ciò che in essa v’era di fisso ha vacillato”33. Nella storia emerge come
signore ed è riconosciuto come tale chi mette coraggiosamente a repentaglio la vita; si trova
invece a dover subire la sorte del servo chi, per aver salva la vita, ritiene di preferire la
perdita della propria autonomia.
Questa figura hegeliana dell’Autocoscienza è stata apprezzata non soltanto dal pensiero
marxista, che nell’inversione dei ruoli tra servo e signore ha visto l’anticipazione storica di
quella che avverrà, mediante la rivoluzione sociale, tra il proletariato industriale e la
borghesia capitalistica (→ Comunismo), ma anche dalle analisi fenomenologiche prodotte
dalle filosofie dell’esistenza. Gli autori che qui consideriamo sono Kierkegaard, Heidegger
e Sartre (→ Esistenzialismo).
Sören Kierkegaard: l’angoscia è costitutivamente connessa all’esistenza
A tale tema S. Kierkegaard dedica un intero scritto: Il concetto dell’angoscia (1844), nel
quale esplicita gli aspetti della precarietà rischiosa e dell’insuccesso, che caratterizzano
costitutivamente l’esistenza. L’“esistenza” riguarda propriamente l’uomo, che ha l’essere in
forma contingente e finita. Egli, infatti, non sussiste in sé, ma “ex-sistit”, “deriva da” altro,
cioè da colui che lo crea; invece propriamente “Dio non esiste, Egli è eterno”34. La
condizione ontologica originaria e permanente dell’esistenza è, pertanto, la possibilità.
Nulla, che ci riguardi, è scontato, perché “nella possibilità tutto è ugualmente possibile”,
soprattutto l’infelicità del nostro destino eterno, ascrivibile alla nostra libertà: “il lato
terribile, la perdizione, l’annientamento abitano porta a porta con ciascuno di noi”35. In
particolare, poi, ognuno porta la responsabilità di se stesso. La scelta costituisce
l’individuo, che non è mai un dato. Essa è ineludibile, perché anche rinunciare a scegliere è
una scelta. Pertanto l’esistenza, affidata a se stessa, appare indeterminata nei suoi esiti ed è
esposta al sentimento dell’angoscia. Questa non è la paura di un pericolo che riusciamo a
configurare e perciò possiamo tentar di controllare, ma è un turbamento inquietante e totale,
che “abita porta a porta” con noi: è la “vertigine” della libertà, perché “chi volge gli occhi
al fondo di un abisso, è preso dalla vertigine. [...] In questa vertigine la libertà cade”36.
Kierkegaard ne evidenzia con fine sensibilità le manifestazioni in Adamo. Il divieto divino
“rende inquieto Adamo perché sveglia in lui la possibilità della libertà [...] la possibilità
angosciante di potere. Cosa sia ciò ch’egli può, egli non ne ha idea alcuna; altrimenti si
presupporrebbe [...] la differenza tra il bene e il male”. L’angoscia non appartiene
all’animale, ma all’uomo; si distingue dal semplice timore, che “si riferisce a qualcosa di
determinato”, perché, all’opposto, “il nulla genera l’angoscia”: essa “è la realtà della libertà
come possibilità per la possibilità”37.
33
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, a cura di E. De Negri, La Nuova Italia, 1976, pp. 157 e 161-162
S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica, parte II, c. 3, § 2, in Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni,
1972, p. 441
35
S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, a cura di C. Fabro, Sansoni,1953, pp. 194-5
36
ivi, p. 74
37
ivi, p. 54 e p. 51
34
10
È nell’esperienza dolorosa di essa che si è rivelata anche l’umanità di Gesù Cristo:
“Quello che fai, fallo presto”, egli dice a Giuda che si dispone a tradirlo, palesando così
l’insostenibile angoscia per ciò che può accadere. Queste parole sembrano a Kierkegaard
ancor più forti della stessa “terribile espressione” sulla croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?”38
Martin Heidegger: “L’Essere-per-la-morte è essenzialmente angoscia”
Anche M. Heidegger, ispirandosi a Kierkegaard, si avvale della nozione dell’angoscia, per
caratterizzare in generale l’esistenza e in particolare la condizione mortale di fronte alla
quale l’esistenza, vissuta autenticamente, si trova. L’Esserci (Dasein), cioè l’essere-nelmondo che ciascuno di noi è, non è il padrone dell’essere e nel pensiero della morte,
nell’anticipazione di essa, che non consiste nel realizzarla con il suicidio, ha modo di
viverla come sua possibilità più propria e permanente e non come un semplice fatto tra gli
altri. Tale “decisione anticipatrice” genera la situazione emotiva dell’angoscia, che, come
già Kierkegaard aveva evidenziato, non è la paura di qualcosa di determinato, ma è
l’esperienza del nulla. Ecco alcune parole di Heidegger a questo riguardo: “La situazione
emotiva che può tener aperta la costante e radicale minaccia incombente sul se-Stesso,
minaccia che proviene dal più proprio e isolato essere dell’Esserci, è l’angoscia. In essa
l’Esserci si trova di fronte al nulla della possibile impossibilità della propria esistenza.
L’angoscia si angoscia per il poter-essere dell’ente così costituito e ne apre in tal modo la
possibilità estrema. Poiché l’anticipazione isola totalmente l’Esserci e in questo isolamento
fa sì che esso divenga certo della totalità del suo poter-essere, la situazione emotiva
fondamentale dell’angoscia appartiene a questa autocomprensione dell’Esserci nel suo
fondamento stesso. L’Essere-per-la-morte è essenzialmente angoscia”39. La piena e
consapevole accettazione del nulla da cui proveniamo e del nulla verso cui andiamo è ciò
che ci consente di guardare alla finitezza costitutiva dell’esistenza e di sfuggire
all’anonimato del vivere inautentico; infatti è di me che si tratta quando penso alla mia
morte. La coscienza del morire e la disponibilità ad accettare il proprio destino fondano
l’autenticità del vivere. L’uomo che vive autenticamente non ha alcunché di eccezionale: da
un lato prosegue la vita ordinaria e comune del suo tempo e del suo popolo, dall’altro,
tuttavia, mediante l’esperienza anticipatrice della propria morte vive con il distacco di chi
ha compreso il nulla dell’esistenza e dei suoi progetti.
Jean-Paul Sartre: l’angoscia è strettamente connessa alla libertà
J.-P. Sartre riprende a sua volta il tema dell’angoscia, collegandolo alla strutturale
condizione di libertà dell’esistenza. Egli osserva che la nostra coscienza esprime un potere
di annullamento della situazione che le è data, quando fa uso della libertà, mediante la
quale, progettando se stessa, “ha da essere ciò che è”40. La libertà che la costituisce è
intenzionalità che si sottrae al dato e s’impegna in una prospettiva di sempre nuove
possibilità, in cui è possibile che i progetti assunti varino di fronte a nuove scelte.
Originariamente l’uomo è nulla; a lui spetta realizzarsi in una qualche direzione, perchè “la
libertà umana precede l’essenza dell’uomo e la rende possibile, l’essenza dell’essere umano
è in sospeso nella sua libertà”. In tale analisi Sartre si rifà direttamente a Kierkegaard:
mentre “la paura è paura degli esseri del mondo, l’angoscia è angoscia di fronte a me
38
ivi, p. 193
M. Heidegger, Essere e tempo, § 53, trad. it. di P. Chiodi, Longanesi, 1970, p. 400
40
J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, Il Saggiatore, 1975, trad. it. di G. Del Bo, p. 32
39
11
stesso” e io “mi angoscio proprio perché i miei comportamenti non sono che possibili”41.
L’angoscia è la coscienza della libertà, è l’esperienza radicale del nulla. → Libertà
ANTROPOLOGIA
“Antropologia” è un termine di origine greca, composto da ἄνθρωπος (ánthropos, uomo) e
da λογία, terminazione astratta derivante dal tema della parola λόγος (discorso). Esso
perciò significa letteralmente “studio dell’uomo”. Data la pluralità delle prospettive e degli
aspetti secondo i quali possiamo considerare l’essere umano, non c’è una sola, ma ci sono
necessariamente più antropologie. Accanto ad un’antropologia fisica, che colloca l’uomo
nell’ambito della zoologia, e ad un’antropologia culturale, che intende rilevare e comparare
la varietà delle culture espresse dai diversi gruppi umani, si può legittimamente parlare
anche di un’“antropologia filosofica”, come espressamente intese fare in tempi ancora
relativamente recenti Max Scheler. L’uso del termine “antropologia” nell’ambito della
filosofia sembra risalire al XVIII secolo. Una delle prime applicazioni fu sicuramente
quella fatta da Immanuel Kant nell’ultima opera da lui pubblicata: L’antropologia dal
punto di vista pragmatico (1798), in cui raccolse materiale d’insegnamento universitario
sugli argomenti filosofici che più gli erano cari e che considerava importanti. Se con la
parola “antropologia” designava uno specifico studio riguardante l’uomo, “ordinato in
maniera sistematica”, con l’aggettivo “pragmatico” intendeva riproporre il progetto
filosofico dell’Illuminismo, consistente nel determinare ciò che l’uomo può e deve fare di
sé come essere libero e responsabile, che si distingue specificamente dagli altri enti per la
sua capacità di progredire mediante l’educazione.
Nella filosofia occidentale la problematica antropologica è antica ed è sorretta dalla
consapevolezza che del sapere l’uomo è insieme il soggetto promotore e l’oggetto
preminente. Se ai primordi storici la questione dominante della ricerca fu quella della
phýsis e dell’ordine razionale che la può configurare come un “cosmo”, già con i sofisti e
con Socrate ci fu una svolta teoretica, che mise al centro del proprio interesse l’uomo e la
sua formazione (παιδεία, paidéia). In particolare, per Socrate l’ideale educativo andava
posto nella cura dell’anima, attivando in ognuno innanzitutto un impegno di conoscenza,
che gli sembrava corrispondere all’invito contenuto nelle parole incise sul frontone del
tempio di Delfi: “Conosci te stesso”. Perciò il filosofo ateniese affermava: “Se
conosceremo noi stessi, conosceremo forse la cura che dobbiamo prenderci di noi, se no,
non la conosceremo mai”73. → Paidéia
Lungo i secoli presso i vari autori e nei diversi movimenti o scuole emersero molteplici e
opposte concezioni antropologiche: dualistiche o unitarie; ilemorfiche o riduttivamente
materialistiche; naturalistiche o orientate in senso trascendentistico; individualistiche o
impegnate a far valere la socialità umana; personalistiche o propense a integrare l’uomo in
strutture generali dominanti.
Per la tematizzazione di questi vari profili si possono considerare varie voci; in
particolare si rinvia a → Anima; Corpo; Persona.
Nel Novecento Max Scheler (1874-1928) s’impegnò a tematizzare in forma sistematica una
“antropologia filosofica” d’impostazione personalistica (→ Persona). Ciò avvenne
espressamente nei suoi ultimi scritti. Di lui citiamo in particolare La posizione dell’uomo
41
ivi, pp. 62, 67 e 69
Platone, Alcibiade primo, 129 a, trad. di P. Pucci, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1971,
vol. 4, p. 46
73
12
nel cosmo (1927). L’uomo, egli dice, in quanto essere vivente, è caratterizzato
dall’“impulso” (Drang) e, in quanto persona, dallo “spirito” (Geist). Entrambi questi aspetti
lo qualificano essenzialmente. Lo spirito, infatti, ha bisogno dell’impulso irrazionale per
dotarsi di vitalità e di energia creativa, alle quali a sua volta dà una direzione e un senso,
disciplinandole e, diversamente dagli altri animali, negando alla loro forza prorompente il
suo assenso. L’animale è garantito dalle sicurezze che gli offre l’istinto e non può evitare di
corrispondere alle sollecitazioni e pressioni dell’ambiente, alle quali, invece, l’uomo può
resistere, “de-realizzandolo”, cioè prendendone le distanze, e orientando in senso spirituale
l’impulso vitale, così come avviene nel processo di “sublimazione” descritto da Freud (→
Sublimazione). In quanto persona, l’uomo è affidato alla libera responsabilità di se stesso.
A questo riguardo, ecco una significativa affermazione del filosofo tedesco: “L’uomo è
l’essere vivente che, in virtù del suo spirito, è in grado di comportarsi in maniera
essenzialmente ascetica nei confronti della sua vita, che lo soggioga con la violenza
dell’angoscia; può soffocare e reprimere i propri impulsi tendenziali, vale a dire rifiutare
loro il nutrimento delle rappresentazioni percettive e delle immagini. Paragonato
all’animale che dice sempre ‘sì’ alla realtà effettiva – anche quando l’aborrisce e fugge l’uomo è ‘colui che sa dir di no’, l’‘asceta della vita’, l’eterno protestatore contro quanto è
soltanto realtà. […] L’uomo è l’eterno ‘Faust’, la bestia cupidissima rerum novarum [la
bestia più cupida delle novità], mai paga della realtà circostante, sempre avida di infrangere
i limiti del suo essere ‘ora-qui-così’, sempre desiderosa di trascendere la realtà circostante e
con essa anche i limiti della propria realtà personale presente”74.
ARTE
Per molto tempo le arti (in greco τέχναι, téchnai) non furono soprattutto e solo “le arti
belle”, ma le tecniche, perché ad esse era primariamente attribuita una funzione produttiva
di oggetti utili, cioè destinati a soddisfare le molteplici esigenze della vita. Consistevano nei
diversi mestieri e professioni, per esercitare i quali in forme ottimali occorrevano perizia e
conoscenza. La produzione (ποίησις, póiesis) dei più diversi oggetti richiede capacità
creativa, che a sua volta è connessa alla potenza e all’efficacia dell’immaginazione, cioè
della facoltà rappresentativa (εἰκασία, eikasía). → Immaginazione
Nella filosofia antica e medioevale la bellezza (in latino pulchrum) era considerata un
aspetto costitutivo dell’essere, legato a quegli attributi del bonum e del verum, che la
Scolastica denominerà trascendentali (→ Trascendentale; Bellezza). Perciò la base
giustificativa che la riguarda rinvia ai fondamenti ontologici della realtà. Alla fine dell’età
moderna, invece, l’attenzione fu rivolta alla fruizione soggettiva della bellezza, in maniera
tale da trasformare la questione dell’arte nella questione “estetica” (→ Estetica).
Platone
La questione dell’arte nel pensiero di Platone è complessa. Egli ne parla nella Repubblica in
rapporto ai temi più generali della conoscenza e dell’educazione di coloro che dovrebbero
governare la città. A questo riguardo il suo giudizio appare alquanto severo: poiché si
compiace di pure immagini, l’arte è lontana di tre gradi dall’essere vero e perfetto; infatti
l’immagine (in greco εἰκών, eikón) imita l’oggetto sensibile, il quale a sua volta imita
l’idea. Perciò l’eikasía, cioè la facoltà rappresentativa, va considerata come il livello
teoretico inferiore.
74
M. Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo, trad. di R. Padellaro, Fabbri, 1970, pp. 194-195
13
Platone, inoltre, giudica l’arte pericolosa, perché si rivolge alla parte inferiore dell’anima,
della quale solletica gli impulsi. Così, per esempio, egli si esprime: “La pittura (e, in
genere, l’arte imitativa) elabora la propria opera lontano dalla verità. Essa è in intima
relazione, compagna e amica di quel nostro interiore elemento che sta lontano
dall’intelligenza, senza alcuna meta sana né vera”110. Anche dei poemi di Omero, il divino
tra i poeti, vanno censurate le parti non educative, per esempio quelle in cui rappresenta in
maniera disdicevole gli dei, “non perché non siano poetiche e non offrano dilettevole
ascolto ai più, ma perché quanto più sono poetiche, tanto meno le devono udire fanciulli e
uomini che hanno da essere liberi”111. L’arte non può pretendere alcuna autonomia, perché
il suo valore è strumentale: dipende soltanto dalla capacità di servire la verità e il bene. A
questo scopo va rilevato che per il filosofo ateniese la politica stessa va pensata come
un’arte e precisamente come “l᾿arte regia” (ἡ βασιλική τέχνη, e basiliké téchne), la quale
comporta la responsabilità di organizzare e dirigere l’uso di altre arti, quali la strategia, che
abilita a condurre efficacemente una guerra, la giurisprudenza e la retorica. Infatti,
l’acquisizione di queste tecniche fa sì che si sappia semplicemente come è possibile
realizzare determinate cose, ma non se sia necessario farle né a quale scopo vadano fatte112.
Nel Filebo, poi, Platone riconosce come propri gli elementi essenziali di un’estetica che
erano già presenti nella tradizione ellenica e saranno poi ripetutamente ribaditi nel corso dei
secoli come tipici del classicismo, in particolare il senso della misura e i valori della
simmetria e della proporzione, nei quali egli coglie bellezza e verità. Era una convinzione
antica che la mancanza di “misura” rovina ogni cosa e che “la misura e la simmetria senza
dubbio risultano dovunque bellezza e virtù”. Con affermazioni ancor più impegnative egli
osserva che “ad esse viene mescolata, nella fusione di cui parliamo, la verità” e che “la
potenza del bene […] s’è rifugiata nella natura del bello”, perché è il bello che ce lo rivela.
Il bene, infatti, è caratterizzato dalla corretta combinazione di “bellezza, proporzione e
verità”113 (→ Bellezza). Pertanto, volendo descrivere la genesi del mondo, Platone non
trova nulla di meglio che rappresentarla come un’eccellente produzione artistica. Il divino
demiurgo la realizzò agendo sull’informe materia, modellandola secondo un progetto con il
quale rivela intelligenza e bontà. Tutto ciò spiega perché la condizione del mondo in cui
siamo sia “mista”; la creazione, infatti, derivò da “una combinazione della necessità e
dell’intelligenza: l’intelligenza dominò la necessità, col persuaderla di rivolgere al bene la
più parte delle cose che si generavano”114. La perfezione dell’essere rimase nella sua
originaria trascendenza e tuttavia la forma, che l’artefice volle dare alla materia, l’attinse da
quel mondo ideale, per farne partecipe questo mondo sensibile, il quale perciò lo imita.
Riecheggiando gli antichi miti della creazione del mondo dal caos originario, Platone così
descrive l’operazione divina: “Dio volendo che tutte le cose fossero buone e, per quant’era
possibile, nessuna cattiva, prese quanto c’era di visibile che non stava quieto, ma si agitava
sregolatamente e disordinatamente, e lo ridusse dal disordine all’ordine, giudicando questo
del tutto migliore di quello. Ora né fu mai, né è lecito all’ottimo di far altro se non la cosa
più bella”115.
110
Platone, La Repubblica, X, 603 a-b, trad. di F. Sartori, in Opere complete, vol. 6, Laterza, 1971, p. 333
ivi, III, 387 b, cit., p 104
112
Platone, Politico, 304 a, trad. di A. Zadro, in Opere complete, cit., vol. 2, p. 327
113
Platone, Filebo, 64 b-66 d, trad. di A. Zadro, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1971, vol.
3, pp.141-144
114
Platone, Timeo, 48 a, trad. di C. Giarratano, in Opere complete, cit., vol. 6, p. 400
115
ivi, 30 a, cit., p. 377
111
14
Aristotele
Aristotele vede nell’arte (téchne) l’espressione positiva delle capacità produttive dell’uomo,
che tramite essa realizza anche se stesso; perciò l’arte è virtù (ἀρετή, areté). Egli la colloca
tra le virtù dianoetiche, perché rivela in chi la possiede un livello di conoscenza superiore a
quella che dà la semplice consuetudine o routine degli empirici. L’arte è il prodotto della
competenza di un professionista, che è in grado di indurre norme generali da ciò che
osserva e fa ed è consapevole della sicura efficacia della sue conoscenze. Aristotele,
dunque, afferma che “gli uomini acquistano scienza e arte attraverso l’esperienza”,
sedimentando e accumulando nella memoria ciò che vanno apprendendo. In particolare,
“l’arte si genera quando, da molte osservazioni di esperienza, si forma un giudizio generale
ed unico riferibile a tutti i casi simili. […] Orbene, ai fini dell’attività pratica, […] gli
empirici riescono anche meglio di coloro che posseggono la teoria senza la pratica. E la
ragione sta in questo: l’esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l’arte è conoscenza
degli universali; ora tutte le azioni e le produzioni riguardano il particolare […] E tuttavia,
noi riteniamo che il sapere e l’intendere siano propri più all’arte che all’esperienza, e
giudichiamo coloro che posseggono l’arte più sapienti di coloro che posseggono la sola
esperienza, […] perché i primi sanno la causa, mentre gli altri non la sanno. Gli empirici
sanno il puro dato di fatto, ma non il perché di esso; invece gli altri conoscono il perché e
la causa”116. È evidente che Aristotele stabilisce una gerarchia nel processo della
conoscenza: al livello inferiore, ma necessario per sviluppare anche gli altri, sta
l’esperienza (ἐμπειρία, empeiría); poi c’è l’arte (téchne), che ha scopi produttivi e
utilitaristici; infine al livello più alto c’è la scienza (ἐπιστήμη, epistéme), il cui scopo è il
sapere stesso, puro e disinteressato.
In generale l’arte imita la natura: si appropria dei suoi principi, per proseguirne
liberamente l’attività creatrice e realizzare ciò che essa non prevede di fare. Infatti “alcune
cose che la natura non sa fare l’arte le fa; altre invece le imita”117. L’imitazione, di cui qui si
parla, non è la passiva ripetizione di ciò che è già fatto, ma la produzione in base a principi
e a concetti universali appresi dalla natura, che rappresentano la realtà nella sua essenza più
vera.
Aristotele dedica un’opera specifica all’arte drammatica, che tanta importanza aveva nella
vita delle póleis greche. Si tratta della Poetica, di cui possediamo il primo libro, che
riguarda la tragedia. Un secondo libro, che riguardava la commedia, è andato perduto. Nel
Medioevo l’opera aristotelica fu pressoché sconosciuta e divenne oggetto di notevole
interesse nell’età moderna.
Della tragedia La Poetica dice che è “mimesi di un’azione seria e compiuta in se stessa,
[...] in forma drammatica e non narrativa; la quale, mediante una serie di casi che suscitano
pietà e terrore, ha per effetto di sollevare e purificare l’animo da siffatte passioni”. Più in
generale, dell’imitazione poetica Aristotele mette in risalto sia la funzione conoscitiva che
la funzione creativa. Infatti “ufficio del poeta non è il descriver cose realmente accadute,
bensì quali possono in date condizioni accadere: cioè cose le quali siano possibili secondo
le leggi della verisimiglianza o della necessità”. La differenza dallo storico non è data dallo
scrivere in versi, ma dal fatto che “lo storico descrive fatti realmente accaduti, il poeta fatti
che possono accadere. Perciò la poesia è qualche cosa di più filosofico e di più elevato della
storia; la poesia tende piuttosto a rappresentare l’universale, la storia il particolare”118.
116
Aristotele, La metafisica, A 1, 981 a, a cura di G. Reale, Loffredo, 1968, vol. I, p. 104
Aristotele, Fisica, B 8, 199, a 15-16, trad. di A. Russo, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973, vol. 3
118
Aristotele, Poetica, 6, 1449 b 24-28; 9, 1451 b 4-6, trad. di M. Valgimigli, in Opere, cit., vol. 10, p. 203 e p.
211
117
15
Inoltre, non sempre abbiamo tutti gli elementi per una soddisfacente comprensione della
storia, mentre la poesia produce un insieme di azioni e fatti interconnessi in un processo
unitario, che ha un inizio, uno sviluppo e una fine. La rappresentazione poetica è
verosimile: non si accontenta della contingenza di ciò che avviene, che per vari aspetti può
essere effetto del caso, ma consente di conoscere l’uomo e il suo mondo più perfettamente e
con un’ampiezza che va oltre i nudi dati di fatto del resoconto storico. Così, per esempio,
ciò che la tragedia mette in scena ci riguarda tutti, perché descrive la condizione umana
nella sua universalità, nella quale ci possiamo riconoscere. La poesia, perciò, è “più
filosofica della storia”, nel senso che essa fa sì che le azioni e gli eventi non rimangano
fortuiti e inspiegabili, perché conferisce all’insieme un ordine razionalmente interpretato. In
tal modo Aristotele rovescia il giudizio negativo che della tragedia aveva dato Platone. Essa
non alimenta affatto la nostra passionalità, ma realizza il salutare beneficio di renderci
padroni di noi stessi di fronte al destino, mediante la “catarsi” o purificazione dell’anima
dall’emotività che ci potrebbe travolgere, se non fosse sottoposta al controllo della ragione
(→ Catarsi).
Riflettendo su queste considerazioni di Aristotele, in particolare sull’arte intesa come
“trasfigurazione in forma”, e tenendo ben presente che la nozione di “forma” è
fondamentale in tutta l’estetica classica e classicistica, il filosofo tedesco Hans Georg
Gadamer da buon ermeneuta osserva che “la forma è tale in quanto si presenta come una
totalità dotata di senso”. Mentre il mondo in cui abitualmente viviamo è contrassegnato da
incoerenza e imperfezione, il mondo dell’arte realizza una compiutezza e un ordine, che
trova in se stesso “un significato conchiuso”. La produzione artistica, tuttavia, consegue la
sua perfezione solo nell’essere effettivamente “rappresentata”, interpretata e fruita, perché
“ogni ripetizione è originaria quanto l’opera stessa”119. → Ermeneutica
L’apporto del pensiero cristiano
La concezione mimetica dell’arte è propria di tutta la tradizione classica, alla quale il
pensiero cristiano apporta due specifici elementi importanti che la fondano e la giustificano
ulteriormente: la dottrina della creazione, secondo la quale Dio creò gli uomini “a sua
immagine e somiglianza”, e la fede nell’incarnazione del Verbo divino, che “si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi”120.
Storicamente è opportuno ricordare che, per conseguire stabilmente la propria posizione
dottrinaria, la cristianità orientale antica dovette superare la lunga e aspra crisi
dell’iconoclastia. Con il secondo concilio di Nicea del 787 il cristianesimo si confermò
come religione dell’immagine, distinguendosi dall’ebraismo e dall’islamismo, che invece
vietano severamente la raffigurazione artistica dell’uomo, per il rischio che ciò incentivi
l’idolatria.
Possiamo citare Dante come autorevole testimone della teoria estetica medioevale e della
sintesi che essa realizza degli elementi fondamentali della tradizione, sia classica che
cristiana: l’arte è imitazione della natura e la natura è creazione del divino artefice. Secondo
quest’ottica l’uomo con la propria attività produttiva non fa che proseguire l’azione
creatrice di Dio. I versi, che qui riportiamo, intendono parafrasare i testi di Aristotele su
riportati: “Filosofia […] a chi la ‘ntende, / nota non pur in una sola parte, / come natura lo
suo corso prende / dal divino intelletto e da su arte; / e se tu ben la tua Fisica note, / tu
119
H.G. Gadamer, Verità e metodo, a cura di G. Vattimo, Bompiani, 1988, pp. 142-153
Genesi, 1, 26-27; Giovanni, 1, 14. Nonostante la solenne affermazione della Genesi, la legge mosaica (Esodo,
20, 4) proibisce la produzione di immagini, per evitare il pericolo dell’idolatria.
120
16
troverai, non dopo molte carte, / che l’arte vostra quella, quanto pote, / segue, come ‘l
maestro fa il discente; / sì che vostr’arte a Dio quasi è nepote”121.
La pervasività della fede religiosa fa sì che l’uomo medioevale consideri ovvio
interpretare tutta l’attività culturale come un “itinerarium mentis in Deum”, un percorso
della mente verso Dio, secondo le parole del francescano Bonaventura di Bagnoregio (XIII
secolo). Lungo questo percorso è possibile scorgere in tutte le creature le tracce del creatore
(vestigia) e nell’uomo la sua immagine (imago). Se poi interviene l’elevazione per grazia
ad una condizione di soprannaturale vicinanza a Dio, l’uomo riflette una diretta somiglianza
(similitudo) con lui. Ovunque nel mondo siano presenti verità, bontà e bellezza, Dio rivela
se stesso. Attraverso l’arte il simbolismo religioso alimenta nei secoli l’educazione alla
bellezza. → Simbolo
La funzione educativa e civilizzatrice dell’arte. Giambattista Vico
Nel Rinascimento si assiste ad un recupero e ad una valorizzazione non solo della cultura
greco-romana, ma dei modelli artistici di quel lontano passato, di cui si assumono i criteri
estetici, considerandoli perennemente validi. È il cosiddetto classicismo, i cui canoni
dominano per secoli nella cultura europea. La tradizione rinascimentale fa sì che il valore
dell’arte sia ormai riconosciuto come fondamentale nella formazione umana.
Nell’ambito della filosofia ciò risulta confermato in particolare dalle riflessioni prodotte
nel XVIII secolo da Giambattista Vico, per il quale anche la sensibilità artistica e in
particolare la percezione poetica del mondo contribuiscono decisamente al processo storico
di civilizzazione dell’umanità. Questo avviene principalmente nella fase adolescenziale
della storia dei popoli, essendo essa caratterizzata da un vigoroso sviluppo della fantasia. È
quella l’età degli eroi, nei cui modelli gli aristocratici, che dominano le città, amano
riconoscersi, proponendo alla pubblica esaltazione le virtù della magnanimità, della forza e
del coraggio. È quello anche il tempo favorevole alla poesia, nella quale si esprime una
sapienza che educa il sentimento e l’azione. Questa sapienza poetica non è un abbellimento
fantastico di concetti già presenti in forma razionale, perché in essa si esprimono in forma
originaria gli “universali fantastici”. Ecco come ne parla Vico: “I primi uomini, come
fanciulli del genere umano, non essendo capaci di formar i generi intelligibili delle cose,
ebbero naturale necessità di fingersi i caratteri poetici, che sono generi o universali
fantastici”122, come, per esempio, la raffigurazione simbolica della forza e del valore in
Achille o quella dell’ingegno in Ulisse. Quel mondo poetico delle origini è mirabilmente
rappresentato dai poemi omerici, ai quali Vico dedica tutto il terzo libro della Scienza
nuova, anticipando la soluzione, che successivamente sarà data dai filologi di professione,
della “questione omerica”: l’Iliade e l’Odissea non sono ascrivibili ad un singolo poeta,
perché furono la produzione di tutto un popolo.
Come abbiamo già detto, alla fine dell’età moderna, in particolare con Immanuel Kant, la
tradizionale questione filosofica dell’arte o diventa questione estetica oppure con la
questione estetica è obbligata a confrontarsi. Per questo proseguimento di questa
problematica si invia alla voce → Estetica
ASTRAZIONE
Secondo Aristotele l’intelletto interviene per mezzo dell’astrazione (in greco ἀφαίρεσις,
apháiresis) sui dati sensibili predisposti dai sensi e dall’immaginazione, nel senso che esso
121
122
D. Alighieri, Inferno, XI, 97-105
G.B. Vico, La scienza nuova, a cura di P. Rossi, Rizzoli, 1963, I, II (Degnità XLIX), p. 127
17
tralascia gli aspetti accidentali, contingenti e particolari delle cose, ossia la condizione
materiale della loro individualità (→ Sìnolo), e mediante l’intuizione della loro essenza dà
luogo a rappresentazioni concettuali, che sono, in quanto tali, universali (→ Concetto;
Universali, il problema degli). L’astrazione si configura, perciò, come il processo stesso
dell’induzione (ἐπαγωγή, epagoghé): coglie con un’intuizione intellettiva “l’unità al di là
della molteplicità”, cioè rende mentalmente universale l’essenza di una cosa (ciò che è “uno
e identico in tutti gli oggetti molteplici”), potendola così applicare, come concetto e come
“principio della scienza”, alla pluralità delle sostanze individuali, nelle quali noi la
riconosciamo ontologicamente presente138. Aristotele afferma altrove: “È nelle forme
sensibili che esistono gli intelligibili […] Per questo chi non avesse sensazione alcuna, non
apprenderebbe né comprenderebbe niente, e quando l’uomo pensa una cosa, di necessità
pensa una qualche immagine”139. Questa gnoseologia anti-innatistica, che per la conoscenza
ritiene preventivamente necessaria l’esperienza, sarà sintetizzata nel noto detto medioevale:
“Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu” (nell’intelletto non c’e nulla, che
prima non sia stato nel senso).
Dell’ineludibilità dell’apporto sensoriale già prima di Aristotele era ben consapevole
Democrito, che pur ne afferma l’insufficienza. Egli, infatti, dopo aver svalutato i dati
qualitativi immediati dell’esperienza, che attribuiva all’illusorietà soggettiva dell’opinione
(“opinione è il colore, opinione il dolce, opinione l’amaro, verità gli atomi e il vuoto” →
Qualità e quantità: La questione moderna delle qualità “primarie” e “secondarie” dei
corpi), metteva in guardia la ragione contro l’opposta tentazione di ritenersi autosufficiente.
In una sua rappresentazione animata di un breve e ideale dialogo i sensi si rivolgono ad essa
con queste parole: “O misera ragione, tu, che attingi da noi tutte le tue prove, tenti di
abbattere noi? Il tuo successo significherebbe la tua rovina”140.
Anche gli empiristi sono convinti che la nostra mente senza esperienza è tamquam tabula
rasa, ma respingono come metafisica l’interpretazione aristotelica, che lega l’astrazione ad
un’essenza inverificabile. Essi, invece, intendono l’astrazione come una semplice
generalizzazione (→ Generalizzazione), con la quale noi eliminiamo mentalmente le
condizioni concrete spazio-temporali dagli oggetti particolari dell’esperienza, per
conservare ciò che li fa simili e applicarlo poi a tutti i singoli casi. Lo stesso John Locke,
che pur distingue le essenze “reali” da quelle “nominali”, ritiene che esse, anche nella
supposizione che siano effettivamente qualcosa, siano inconoscibili. In quanto sono
singolarmente designate con un termine unitario, sono comunque sempre essenze
“nominali”: queste denominazioni corrispondono per convenzione linguistica a idee
generali, che produciamo per astrazione. Se gli oggetti del nostro pensiero non sono realtà
naturali, ma nostre costruzioni mentali, come avviene in matematica, l’essenza nominale
coincide con quella reale.
Pertanto, a proposito dei termini generali o astratti, gli empiristi professano una posizione
nominalistica (→ Universali, il problema degli), perché le esperienze sono sempre
particolari, ma nel linguaggio ricorrono termini comuni, con i quali intendiamo riferirci a
ciò che rende simili i singoli enti. La funzione economica del linguaggio fa sì che un
termine possa fungere da segno riassuntivo di un’intera classe di enti particolari, cioè sia un
semplice segno nominale che li rappresenta.
138
Aristotele, Secondi analitici, II (B), 19, 100 a 1-9, trad. di G. Colli, in Opere, Laterza, 1973, vol. 1, p. 372
Aristotele, Dell’anima, III (), 8, 432 a 13, trad. di R. Laurenti, in Opere, Laterza, 1973, vol. 4, p. 182
140
I Presocratici, Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1975, “Frammenti”, 125, vol. II,
p. 775
139
18
ATEISMO
Questo termine designa la posizione di chi nega l’esistenza di Dio. Talora è stato anche
applicato alle concezioni panteistiche, perché, identificando il divino con la natura,
misconoscono la specificità di Dio. In questo senso l’accusa di ateismo fu rivolta, per
esempio, a Spinoza con l’evidente scopo di salvaguardare la fede tradizionale contro un
pensiero considerato particolarmente insidioso, perché pretendeva espressamente
d’imperniarsi totalmente su Dio, sostanza unica del mondo.
L’ateismo nel mondo antico
Per il lontano passato sono rare le attestazioni di esplicita professione di ateismo. Tra le
cause possiamo indicare anche il sussistere di una generale condizione culturale e politica
d’intolleranza. L’ateismo, infatti, era ritenuto una minaccia per la stabilità dell’ordine etico
e sociale. Pertanto appariva ovvia l’affermazione biblica che soltanto un insensato può dire:
“Dio non è” (“Dixit insipiens in corde suo: non est Deus”141). Non a caso anche oggi in
questo senso si sente ripetere la nota affermazione di Dostoevskij: “Se Dio non c’è, tutto è
permesso”.
Nell’antichità greca soltanto il naturalismo di Democrito si espresse nella forma di un
integrale ateismo. Con esplicito orgoglio questo filosofo cercava di convincere che la
conoscenza delle vere cause dei fenomeni naturali può liberare gli uomini dalle paure che
nascono dall’ignoranza. Dalla dottrina democritea Epicuro riprese poi la critica alla
religione, ma non propriamente l’ateismo. La sua filosofia, infatti, ammetteva l’esistenza
degli dei, ma affermava che essi non godono di alcuna trascendenza rispetto alla natura
della quale fanno parte, anche se sono immortali, perché di continuo si rigenerano mediante
un afflusso costante di atomi nuovi. Non sono, però, in rapporto con l’uomo e non
intervengono nelle faccende umane; quindi non ha senso temerli né tributare loro un culto.
Gli dei possono solo essere indicati come perfetti modelli di vita, che li rende degni di
ammirazione.
Di Epicuro, poi, vanno ricordate le obiezioni alla fede nella provvidenza divina, che
sempre hanno messo a dura prova la tradizionale teodicea. → Teodicea
Nella tradizione filosofica successiva operò una vera e propria damnatio memoriae nei
riguardi di questi autori. Forse non è casuale che già Platone nei suoi Dialoghi non nomini
mai Democrito, se è vero che egli desiderava bruciare i suoi scritti, secondo una
testimonianza che ci è riferita da Diogene Laerzio142. Il filosofo ateniese era stato
particolarmente severo nel denunciare l’ateismo come una grave causa di immoralità
sociale. Così si continuò a pensare per molti secoli, perfino da parte di chi, come John
Locke, ancora alla fine del diciassettesimo secolo, intendeva diffondere il riconoscimento
del diritto di tolleranza. Locke, infatti, escluse da questo diritto gli atei, perché “per un ateo
né la parola data, né i patti, né i giuramenti, che sono i vincoli della società umana, possono
essere stabili o sacri”143.
L’ateismo nell’età moderna
Nell’età moderna, tuttavia, si era andata diffondendo una critica corrosiva verso il
tradizionale pensiero metafisico, che presso i cosiddetti libertini si presentava in forme per
141
Salmo 52,1
Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, X, 40
143
La “Lettera sulla tolleranza” di Locke e il problema della tolleranza nella filosofia del seicento, trad. di D.
Marconi, a cura di R. Cortese, Paravia, 1994, p. 81
142
19
lo più scettiche, ma talora anche esplicitamente atee (→ Libertini). Culturalmente essi si
rifacevano alla tradizione del naturalismo rinascimentale. Tra i loro temi più ricorrenti
ricordiamo la polemica contro l’inganno della religione, che si avvalse in particolare della
circolazione di un anonimo trattatello medioevale, De tribus impostoribus, sui tre
impostori, cioè Mosè, Gesù e Maometto, la cui dottrina era accusata di aver irretito la gente
nella superstizione, approfittando del naturale timore a cui è esposto l’animo umano e
giustificando, quindi, l’uso che del potere fanno le autorità costituite. Una simile
insinuazione non era nuova; essa era stata anticamente mossa da alcuni sofisti greci, in
particolare da Crizia. Va, peraltro, rilevato che l’ossessiva e drastica azione inquisitoriale
dell’età moderna fece sì che il libertinismo assumesse spesso modi cauti e mascherati nel
proporre le sue tesi.
Le critiche contro la metafisica divennero sempre più esplicite durante l’Illuminismo e le
concezioni teologiche si attestarono per lo più su posizioni deistiche o agnostiche. Le
dichiarazioni di ateismo erano ancora rare e potevano corrispondere alle convinzioni
espresse dai francesi D’Holbach e La Mettrie o all’ un atteggiamento sempre più
problematico manifestato da Denis Diderot. In Gran Bretagna si dimostrò cauto anche
David Hume. Egli infatti non pubblicò i suoi Dialoghi sulla religione naturale, che
uscirono postumi.
L’ateismo di L. Feuerbach e K. Marx
Nell’Ottocento l’ateismo prese piede soprattutto tra i rappresentanti della sinistra hegeliana.
Fu sostenuto in particolare da Ludwig Feuerbach e Karl Marx.
Il concetto centrale della critica feuerbachiana fu quello di “alienazione”, secondo il quale
la religione è la proiezione illusoria dell’essenza umana e delle sue caratteristiche
specifiche (ragione, volontà e cuore) in un essere fantastico, “considerato come un altro
essere”. Pertanto, se la religione ci induce a riporre in Dio quanto togliamo a noi stessi, al
punto che “l’uomo deve essere un nulla, perché Dio sia tutto”144, l’ateismo si prospetta
come un dovere morale, perché l’uomo si realizzi in autenticità e autonomia.
Note sono, poi, le parole del giovane Marx: “La religione è il gemito della creatura
oppressa, l’animo di un mondo senza cuore”, ma in sé è un rimedio fallace, consolazione
illusoria e “oppio per il popolo”; è un sintomo che tradisce “condizioni che hanno bisogno
di illusioni”; perciò “la critica della religione è la critica della valle di lacrime di cui la
religione è l’aureola sacra”145. Il senso di queste affermazioni è che l’alienazione religiosa
dipende da un’alienazione ancor più radicale, prodotta dalle concrete condizioni storiche in
cui si svolge il lavoro dipendente in una società capitalistica, divisa in classi contrapposte.
Riscattato dalle sue servitù, l’uomo non può più avvertire il bisogno di Dio.
Una puntuale argomentazione critica contro la concezione metafisica dell’esistenza Marx
la svolse nei Manoscritti del ’44. Al fittizio interlocutore, con il quale si confronta e che
vorrebbe risalire la serie causale degli eventi naturali legati al divenire, in quel “progresso
che mi spinge sempre più indietro sino a farmi domandare chi ha generato il primo uomo e
in generale la natura”, Marx ribatte: “la tua domanda è essa stessa un prodotto
dell’astrazione. [...] Fai astrazione dall’uomo e dalla natura. Tu li poni come non esistenti,
eppure vuoi che te li provi come esistenti”. Coerenza vorrebbe, aggiunge, che dovrebbe
pensarsi come non esistente anche chi pone la domanda, perché anch’egli è parte della
natura e perciò non dovrebbe né pensare né interrogare. Appare, pertanto, improponibile la
L. Feurbach, L’essenza del cristianesimo, a cura di A. Banfi, Feltrinelli, 1971, p. 47
K. Marx, Annali franco-tedeschi (precisamente in Per la critica della filosofia del diritto di Hegel.
Introduzione), in Scritti politici giovanili, a cura di L. Firpo, Einaudi, 1950, p. 395
144
145
20
questione, perché procede “da un punto di vista, a cui non posso rispondere perché è
assurdo”. Per riscattarla razionalmente, suggerisce di considerare anche il “movimento
circolare” del processo causale, in base al quale l’uomo e la natura riproducono se stessi,
rimanendo sempre soggetti; diversamente “il problema di un essere estraneo, di un essere
superiore alla natura e all’uomo” comporta “l’ammissione dell’inessenzialità della natura e
dell’uomo”. Con un esplicito richiamo alla dimensione storica Marx intende superare
l’insufficiente naturalismo feuerbachiano e afferma: “Tutta la cosiddetta storia del mondo
non è altro che la generazione dell’uomo mediante il lavoro umano, null’altro che il
divenire della natura per l’uomo”146. Peraltro egli ritiene che per il problema della religione
la soluzione rappresentata dall’ateismo sia ormai insufficiente e, in quanto tale, si prospetti
come destinata ad essere superata dalla dialettica storica: “L’ateismo, in quanto negazione
di questa inessenzialità, non ha più alcun senso; infatti l’ateismo è, sì, una negazione di Dio
e pone attraverso questa negazione l’esistenza dell’uomo, ma il socialismo in quanto tale
non ha più bisogno di questa mediazione. […] Esso è l’autocoscienza positiva dell’uomo,
non più mediata dalla soppressione della religione. […] Il comunismo è, in quanto
negazione della negazione, affermazione”147.
L’ateismo positivistico
Un orientamento ateo o almeno agnostico è strettamente connesso alla critica
d’insensatezza che l’epistemologia del Positivismo e poi del Neopositivismo hanno rivolto
alla metafisica. L’esclusione della metafisica dall’ambito della vera conoscenza è
determinata dalla convinzione della sua insensatezza: “Ogni proposizione che non è
strettamente riducibile alla semplice enunciazione di un fatto, particolare o generale, non
può presentare nessun senso reale e intelligibile”148. L’umanità, a somiglianza di quanto
avviene nello sviluppo dell’individuo, consegue storicamente la propria maturità, cioè lo
stadio positivo della scienza, attraverso il superamento dello stadio teologico e dello stadio
metafisico: nel primo domina la fantasia, che offre una spiegazione fittizia dei fenomeni
naturali, facendo intervenire agenti soprannaturali; nel secondo subentra la ragione, che
tuttavia individua solo cause astratte (le “essenze”). → Positivismo; Neopositivismo
L’ateismo di Friedrich Nietzsche
Dobbiamo poi ricordare l’offensiva antimetafisica di Friedrich Nietzsche, efficacemente
sintetizzata nella nota pagina della Gaia scienza dall’annuncio della morte di Dio, la cui
ingombrante presenza ha finora reso impossibile l’affermazione di una libera e creativa
umanità. Nietzsche, peraltro, osserva che l’eliminazione di Dio e dei presunti valori
metafisici lascia la sensazione di un enorme vuoto, un senso di smarrimento, vero e proprio
sgomento del nulla (nichilismo): “Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito
nulla? [...] Non è troppo grande per noi la grandezza di questa azione? Non dobbiamo
anche noi diventare dei, per apparire almeno degni di essa?”149. È il presagio dell’übermensch (l’oltre-uomo), cioè di un’umanità superiore, rinnovata e potenziata per i tempi che
verranno. Una volta che il mondo si sarà liberato dagli dei, all’uomo sarà data l’opportunità
di realizzare un nuovo atteggiamento, non più metafisico né religioso né improntato alla
vecchia morale, e di avviare la “trasvalutazione dei valori”, ossia la libera reinterpretazione
della vita e del mondo.
146
K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Einaudi, 1980, pp. 124-125
ivi, pp. 125-126
A. Comte, Discorso sullo spirito positivo, a cura di A. Negri, Laterza, 1985, p. 15
149
F. Nietzsche, La gaia scienza, in Opere complete, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, vol.V/2, 1965,
125, p. 129
147
148
21
L’umanismo ateo di Jean-Paul Sartre
J.-P. Sartre ha espresso la convinzione di pensare in maniera più radicale e coerente dei
filosofi atei del XVIII secolo, dai quali “la nozione di Dio viene eliminata, non così però
l’idea che l’essenza preceda l’esistenza”, convinzione fondamentale di tutta la tradizione
metafisica. In realtà, egli osserva, “non c’è una natura umana, poiché non c’è un Dio che la
concepisca”150. Trovarsi affidati soltanto a se stessi nell’assenza di un Dio “è molto
scomodo”: “L’uomo è ‘abbandonato’ perché non trova né in sé né fuori di sé possibilità
d’ancorarsi”. E aggiunge: “Non abbiamo né davanti a noi né dietro di noi, nel luminoso
regno dei valori, giustificazioni o scuse. Siamo soli [...] L’uomo è condannato a essere
libero, [...] senza appoggio né aiuto, è condannato in ogni momento a inventare l’uomo” 151.
Il riconoscimento della libertà come condizione costitutiva della coscienza non è
compatibile con l’esistenza di Dio, perché, se Dio fosse, l’uomo sarebbe da lui vincolato, la
sua essenza sarebbe da lui predeterminata. Secondo l’umanismo esistenzialista “non c’è
altro universo che quello umano, l’universo della soggettività umana. [...] non c’è altro
legislatore” che l’uomo152. Nel drastico dualismo, che l’ontologia sartriana pone in termini
di inconciliabile alterità tra l’“in sé” (il mondo) e il “per-sé” (la coscienza umana), cioè tra
l’essere e il nulla, “l’uomo è fondamentalmente desiderio di essere”153, perché vuole
sfuggire alla contingenza ed “essere il proprio fondamento”. Il suo progetto fondamentale è
di essere “l’in-sé-per-sé”, l’Ens causa sui della tradizione metafisica; in altri termini
“l’uomo è desiderio di essere Dio, l’essere che progetta di essere Dio”154: una pretesa
assurda destinata allo scacco. → Assurdo; Disperazione
Ateismo e secolarizzazione
Nel processo di secolarizzazione della società contemporanea è constatabile per lo più un
ateismo pratico o un diffuso agnosticismo, che tuttavia convivono con vistosi fenomeni di
ripresa del sentimento religioso.
Nell’ambito del cristianesimo protestante del Novecento c’è stato chi ha tentato di
considerare l’ateismo non come un fenomeno necessariamente e soltanto negativo, ma
come un’opportunità offerta a chi intenda rifiutare la concezione banalizzata di un “Dio
tappabuchi”, come l’ha qualificato Dietrich Bonhoeffer, cioè di un idolo di cui possiamo
disporre nei confronti delle difficoltà quotidiane155. Secondo questo pastore e teologo
luterano tedesco, appartenente al movimento di resistenza antinazista della “chiesa
confessante” e vittima della tremenda repressione del regime, a tale concezione occorre
sostituire un’interpretazione più seria e impegnativa della fede cristiana. Consapevole di
vivere in un mondo ormai “adulto”, che sente di dover affrontare i problemi da solo, senza
più un “tutore” che provveda miracolisticamente per lui, Bonhoeffer ha fatto propria la
distinzione di Karl Barth, che aveva opposto la fede cristiana e la theologia crucis al
comune fenomeno mondano della religione. Su questa base si è dimostrato convinto che
“non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo etsi Deus
J.-P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, trad. it. di G. Mursia Re, Il Saggiatore, 1978, pp. 47-48
ivi, pp. 63-64
152
ivi, pp. 107-109
153
J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, trad. it. di G. Del Bo, Il Saggiatore, 1975, p. 678
154
ivi, p. 680
155
D. Bonhoeffer potrebbe essersi ispirato a queste parole di F. Nietzsche: “Lo spirito di questi redentori era fatto
di buchi; ma in ogni buco essi avevano ficcato la loro illusione, il loro tappabuchi da loro chiamato Dio” (Così
parlò Zarathustra, Opere complete, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, vol. VI/1, 1973, pp. 109-110).
150
151
22
non daretur”, cioè come se Dio non ci fosse156. → Secolarizzazione; Razionalizzazione e
disincantamento
A sua volta, invece, Martin Buber, confrontandosi con il fenomeno dell’ateismo moderno,
ne L’eclissi di Dio (1952) ha osservato che Dio non è affatto “morto”, ma si è solo
momentaneamente “eclissato”, perché tra l’Altissimo, il cui nome è stato ripetutamente e in
varie maniere deturpato dagli uomini, e noi si è interposto qualcosa che ce lo rende
irriconoscibile. Lo scritto di Buber termina con una prospettiva di speranza, perché l’eclissi
non è un’estinzione e Dio, che permane nonostante tutto nella sua luminosità, potrebbe
quanto prima tornare a brillare anche ai nostri occhi.
156
D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, traduz. di S. Bologna, Bompiani, 1969, p. 264
23
B
BIOETICA
È un termine composto di derivazione greca (βίος: vita e ἐθική: etica o morale), introdotto
da alcuni decenni per designare l’insieme dei problemi d’ordine etico, che, soprattutto a
causa degli importanti sviluppi scientifici e tecnologici degli ultimi decenni, sono emersi in
ambito biologico e medico. Infatti la scienza empirica e l’efficacia delle applicazioni
operative della tecnica consentono sempre più di metter mano ai processi spontanei della
natura. Le possibilità d’intervento riguardano in particolare sia l’inizio che la fine della vita
di un individuo umano.
Nel primo caso ci si confronta con le potenzialità dell’ingegneria genica, con le diverse
modalità di fecondazione artificiale (in vivo o in vitro, cioè realizzata direttamente nel
corpo della donna o predisposta in laboratorio), con il possibile trattamento dell’embrione
nelle sue varie fasi evolutive e talora con l’impedimento stesso del suo sviluppo (aborto).
Soprattutto in riferimento a questa decisione estrema è inevitabile interrogarsi
sull’eventuale identità personale dell’embrione. La persona, cioè l’“individuo razionale”,
c’è già fin dal concepimento, come ritiene il pensiero cattolico moderno (→ Persona;
Animazione umana), o per un certo tempo, magari breve, essa ancora non c’è? Chi sostiene
la plausibilità di questa tesi solitamente mette l’interlocutore di fronte a due rilievi: nei
primi quattordici giorni, cioè nella cosiddetta fase preembrionale, non può ancora esserci
l’individualità, perché perdura la possibilità di una divisione gemellare; inoltre, fino a
quando non si è formata la corteccia cerebrale, manca il necessario presupposto organico
della razionalità.
A questo riguardo si può rilevare una particolare causa di perplessità e disagio. La morte
di un individuo, convenzionalmente indicata dalla comunità scientifica e generalmente
accolta dalle pubbliche istituzioni, nonché dal pensiero cattolico ufficiale, è fatta coincidere
con la cessazione di ogni attività cerebrale. Ora, non si capisce perché l’assenza di questa
attività all’origine del percorso generativo non sia altrettanto generalmente invocata come
criterio per affermare che la singola persona non c’è ancora.
La determinazione stessa della fine della vita risulta spesso problematica in riferimento ai
diversi possibili livelli di attività cerebrale e del sistema nervoso, comportanti la presenza
della coscienza o la sua sospensione, che può essere a sua volta momentanea o irreversibile,
pur sussistendo una funzionalità di tipo vegetativo.
Dunque, anche di fronte alla prospettiva della morte si pongono difficili interrogativi,
dalla soluzione dei quali dipendono decisioni importanti e talora urgenti, quali la
legittimazione di un eventuale espianto di organi da trapiantare su altri viventi, la
sospensione delle terapie che possono protrarre, anche in condizioni esistenzialmente molto
penose, le funzioni vitali elementari oltre i limiti che la natura, lasciata a se stessa,
imporrebbe.
La questione bioetica verte in generale sui criteri stessi in base ai quali si giudicano le
possibilità di intervenire sul vivente. Essa è così formulabile: ci si deve attenere al principio
della sacralità e intangibilità della vita o a quello della sua qualità? Le due posizioni
implicano una diversa considerazione sia della natura che della plausibilità dell’azione
umana, volta eventualmente a correggerla e a modificarla. → Etica
24
C
CASO
Questo termine deriva dal latino casus (caduta), che a sua volta rinvia al verbo cado
(cadere, accadere). Il caso, infatti, è ciò che accade inaspettatamente o accidentalmente; di
esso, infatti, si dice che sarebbe potuto non accadere e non è il risultato di una volontà
intenzionale. È quanto intende anche Aristotele con i termini di “accidente” (τὸ
συμβεβηκός, tò symbebekós) e di “fortuito” (τὸ αὐτόματον, tò autómaton), riferiti a ciò che
non accade sempre né per lo più, ma solo talvolta13. → Accidente
La casualità degli eventi, apportatrice imprevedibile di possibili vantaggi o danni, era
denominata dagli antichi con termine greco τύχη (týche) e con termine latino fortuna. Così
essi designavano ciò che noi chiamiamo “sorte”. → Fato, Destino, Fortuna
Le varie definizioni del termine “caso” sono sostanzialmente riconducibili a due diverse
interpretazioni: una considera la casualità come un dato oggettivo, riguardante eventi non
collegabili a specifiche cause; l’altra, invece, la identifica con l’ignoranza delle cause,
facendola dipendere da una semplice condizione soggettiva, e non preclude quindi una
concezione deterministica del mondo.
La concezione filosofica che fa derivare l’ordine del mondo dalle combinazioni casuali
degli elementi e degli eventi è detta “casualismo”.
La concezione epicurea
Epicuro propone per primo esplicitamente la tesi di una casualità oggettiva. Egli aderisce
all’atomismo democriteo, ma, rispetto a Democrito, che con i suoi atomi, infiniti di numero
e in movimento vorticoso ed eterno, riconduceva la formazione dei mondi e il continuo
generarsi delle cose alle leggi del moto, nel senso che, dato un certo impulso causale
secondo una certa misura e una certa direzione, l’effetto risulta necessariamente
determinato (determinismo meccanicistico), Epicuro apporta una sostanziale modifica,
facendo dipendere il movimento dal peso. Ciò lo induce ad introdurre un’inspiegabile e
casuale “deviazione” (παρέγκλισις, parénclisis) degli atomi in caduta verticale, per poter
dar conto della loro aggregazione. Lucrezio la descrive come “exiguum clinamen
principiorum” (leggera tendenza a deviare degli elementi originari). La sua importanza nel
sistema teorico epicureo è ancor più rilevata dal fatto che è essa “a consentire che la mente
stessa in tutti i suoi atti non sia sottoposta ad un’intima necessità e non si senta
passivamente costretta soltanto a subire”14, cioè a dar conto della libertà umana. Una tale tesi
lascia interdetti, perché c’è una distanza enorme tra un evento fortuito, cioè razionalmente
non determinato né spiegabile, e un evento che deriva dall’intenzione di un ente
intelligente, che vuol conseguire autonomamente un proprio fine.
13
14
Aristotele, Fisica, B 6, 197 a 36 ss.
Lucrezio, De rerum natura, II, vv. 251-293
25
Anche di Democrito si dice che “il mondo a caso pone” e “dal caso deriva il vortice e il
movimento che separò gli elementi e ordinò nella sua forma presente l’universo”15; tuttavia
qui il caso e la necessità non sono in contraddizione tra loro, perché il caso esprime
l’assenza di finalismo e di provvidenzialità nella natura, ma non la deroga al rigoroso
determinismo meccanicistico. Infatti “Democrito, lasciate da parte le cause finali, riconduce
alla necessità [meccanica] tutte le operazioni della natura”16.
La teorizzazione di Jacques Monod
Jacques Monod nell’esergo con cui dà inizio al saggio Il caso e la necessità (1970)
ripropone la convinzione antica di Democrito: “Tutto ciò che esiste nell’universo è frutto
del caso e della necessità”. L’inevitabile prospettiva che essa induce è che “fra tutti i
concetti di natura scientifica, quello del caso distrugge più degli altri ogni antropocentrismo
ed è il più intuitivamente inaccettabile da parte di quegli esseri profondamente teleonomici
che siamo noi”17, cioè tendenzialmente portati al finalismo. Ciò nonostante, Monod afferma
che contro le illusioni occorre inesorabilmente far valere un’“etica della conoscenza”18,
rispettosa della verità oggettiva. Avvalendosi della propria competenza scientifica in ambito
biologico egli rileva l’importanza delle mutazioni che intervengono nel codice genetico:
nella loro accidentalità esse sono la sola fonte di ogni novità evolutiva (→ Evoluzionismo);
e tuttavia, “una volta inscritto nella struttura del DNA, l’avvenimento singolare, e in quanto
tale essenzialmente imprevedibile, verrà automaticamente e fedelmente replicato e tradotto,
cioè contemporaneamente moltiplicato e trasposto in milioni o miliardi di esemplari. Uscito
dall’ambito del puro caso, esso entra in quello della necessità, delle più inesorabili
determinazioni”19.
A proposito della parola “caso” Monod osserva che essa viene impiegata con significati
diversi. Infatti l’uso che si fa del calcolo delle probabilità per prevedere l’esito di una
partita nel gioco dei dadi o della roulette intende riferirsi ad una “indeterminazione
puramente operativa, ma non essenziale”, tipica di quei giochi meccanici nei quali è
impossibile imprimere e dirigere con sufficiente precisione un movimento. In altre
situazioni, invece, il concetto di caso è usato con un significato “essenziale” e non soltanto
operativo, come avviene “nelle cosiddette ‘coincidenze assolute’, che risultano
dall’intersezione di due sequenze causali totalmente indipendenti l’una dall’altra”. A questo
riguardo Monod fa il banale esempio del dottor Dupont, che è chiamato per la visita di un
ammalato e viene colpito mortalmente dal martello che sfugge alla presa di uno stagnino
che sta riparando il tetto di una casa vicina a quella a cui è diretto. Considerando la
biologia, egli osserva che “esiste un’indipendenza totale anche tra gli avvenimenti che
possono provocare, o permettere, un errore nella replicazione del messaggio genetico e le
conseguenze funzionali di tale errore”. Inoltre “esiste, in scala microscopica, una fonte di
indeterminazione ancora più radicale, innestata sulla struttura quantistica della materia
stessa”. Ora, indipendentemente dalla questione delle diverse interpretazioni che la teoria
dei quanti può prevedere (Einstein, per esempio, non ammetteva che “Dio giochi ai dadi” e
c’è chi ha voluto vedere nel principio di indeterminazione di Heisenberg solo un concetto
operativo e non essenziale), è inevitabile ammettere l’esistenza di una casualità essenziale e
non semplicemente operativa nelle “coincidenze assolute”, “a meno di non voler tornare
15
Dante Alighieri, Inferno, IV, 136; Aristotele, in I Presocratici, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1975, vol. 2,
vol. 2, p. 695
16
Aristotele, in I Presocratici, cit., p. 694
17
J. Monod, Il caso e la necessità, trad. it. di A. Busi, A Mondadori (Oscar), 1976, p. 113
18
ivi, pp. 168-170
19
ivi, p. 118
26
all’universo di Laplace dal quale il caso veniva escluso per definizione”20. →
Meccanicismo
C’è chi ha visto nella teoria di Monod l’espressione di un rigido riduzionismo, che
sembrerebbe evidenziarsi sia nell’“assoluto determinismo” delle leggi chimico-fisiche della
biologia molecolare sia nell’“indeterminismo altrettanto assoluto” del caso; in particolare il
ricorso al caso è sembrato “un modo per mascherare una incapacità esplicativa”21. Si è
obiettato, infatti, che anche il caso si presta a previsioni statistiche e la sua
razionalizzazione in termini di leggi probabilistiche consente di parlare anche in relazione
ad esso di determinismo. → Riduzionismo
Si può comunque osservare che la questione del “caso” nelle riflessioni di Monod assume
una radicalità “metafisica” nel momento in cui egli propende a interpretare la casualità
come una condizione originaria dell’essere. Comprensibilmente, perciò, di fronte
all’altissima improbabilità con la quale i calcoli solitamente ci configurano un’ipotetica
origine casuale della vita, si sostiene che ci sia ancora qualcosa che non conosciamo e che
nella spiegazione degli eventi rinvii non al fortuito, ma a leggi naturali.
Le concezioni irrazionalistiche di A. Schopenhauer e F. Nietzsche
A sostenere che il caso domini il mondo sono in generale le teorie irrazionalistiche. Citiamo
in particolare Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Per Schopenhauer la sostanza
delle cose è la Volontà, che egli interpreta come puro impulso irrazionale e inconscio, il
quale non ha altra finalità che non sia la cieca riaffermazione di sé. Sulle sue tracce procede
Nietzsche, per il quale il mondo “danza sui piedi del caso”22, è caotico e disarmonico,
contraddittorio e crudele, non sostenuto da alcuna logica provvidenziale né da alcuna
prospettiva consolatoria. Ecco, per esempio, come in questo aforisma parafrasa il prologo
del vangelo di Giovanni: “Historia in nuce. La parodia più seria che io abbia mai sentito è
questa: ‘in principio era l’assurdo, e l’assurdo era, al cospetto di Dio!, e Dio era
l’assurdo’”23.
Le critiche delle filosofie razionalistiche e provvidenzialistiche
Ad escludere il caso dagli accadimenti del mondo e dalle vicende della storia umana o a
ridurne l’importanza provvidero nel corso dei secoli le varie metafisiche razionalistiche e
provvidenzialistiche, per le quali nella realtà è presente, o in forma palese o in maniera
nascosta, una trama razionale; perciò tutto è “giustificato” nell’ordine universale. Questa
convinzione fu propria già di Eraclito e poi di Platone e di Aristotele, dello stoicismo, della
teologia cristiana, delle filosofie di Spinoza, Leibniz, Vico, Hegel. → Razionalismo;
Finalismo; Provvidenza; Entelechìa
Lungo una diversa tradizione epistemologica, più direttamente collegata ai progressi della
meccanica moderna, si andò configurando una rigorosa concezione deterministica del
mondo, solitamente denominata “meccanicismo”, che possiamo veder rappresentata nella
sua fase più matura da Pierre-Simon de Laplace (→ Meccanicismo). Anch’essa esclude il
caso. A renderla problematica intervennero le novità della fisica del Novecento e, in
particolare, la formulazione del principio d’indeterminaziome. → Indeterminazione,
Principio di; Indeterminismo
20
ivi, pp. 114-116
B. Fantini, La nuova biologia, in Storia del pensiero filosofico e scientifico di L. Geymonat, vol. 7, Garzanti,
1976, p. 508
22
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, vol. VI/1, 1973, p. 201
23
F. Nietzsche, Umano, troppo umano, Adelphi, vol. IV/2, 1965, p. 18
21
27
CAUSALITÀ, Principio di
Con il termine “causalità” s’intende genericamente la relazione che connette la causa al suo
effetto. Il principio di causalità afferma che nulla avviene a caso, ma che ogni evento è
l’effetto di una causa che l’ha prodotto (→ Causa; Caso); perciò ha un profilo decisamente
metafisico, perché la necessità ontologica che esso implica riguarda l’universale condizione
del divenire nel mondo: concretamente esprime la ricorrente esigenza razionale di legare
l’attuarsi delle potenzialità, che il divenire rivela, non al nulla assoluto, da cui niente può
venire, ma a qualcosa che è già in atto. → Divenire; Atto e potenza
Nella tradizione filosofica a questo principio è attribuito un valore fondamentale. Già
Aristotele fa leva su di esso, per dimostrare l’esistenza di una causa prima incausata, che
denomina Motore immobile e Atto puro, e che tuttavia configura come causa finale, pur
essendo, quella enunciata dal principio che stiamo trattando, per lo più intesa come
efficiente. Egli ritiene, infatti, che altrimenti il Motore immobile sarebbe inevitabilmente
coinvolto nel movimento stesso della natura, cioè nella sua potenzialità e imperfezione. A
parte ciò, sia nella Metafisica che nella Fisica Aristotele deduce dall’analisi del divenire
presente nel mondo la necessità di un principio immobile, al quale poter connettere ogni
movimento, indipendentemente dal numero di rinvii che può esigere la serie delle
trasmissioni da ciò che è mosso a ciò che muove. Egli afferma perentoriamente: “Tutto ciò
che si muove è necessariamente mosso da qualcosa” (Ἅπαν τὸ κινούμενον ἀναγκη ὐπό
τινος κινεῖσθαι), che Tommaso d’Aquino tradurrà: “Omne quod movetur ab alio movetur”
(tutto ciò che si muove è mosso da altro), e spiegherà in questi termini: “È impossibile che
sotto lo stesso rapporto e nello stesso modo un ente sia insieme movente e mosso, cioè che
muova se stesso”, nel senso che “non è possibile che la medesima cosa sia insieme in atto e
potenza secondo il medesimo aspetto, ma solo secondo aspetti diversi”27. In tal modo
Tommaso riconduce il principio di causalità al principio di non contraddizione. Quindi in
ogni ordine di realtà, in cui si dà movimento, c’è un primo motore immobile, e non è il tutto
a muovere se stesso, ad essere motore e mosso. Anche nei viventi, che sono definiti come
gli enti che muovono se stessi, c’è il principio agente (l’anima) e ciò che è mosso (il corpo).
→ Vita
È opportuno precisare che questa formulazione del principio “Omne quod movetur ab alio
movetur”, pur riguardando immediatamente il movimento locale, va intesa in senso
metafisico generale: essa vuol dar conto di tutto ciò che diviene, cioè passa dalla potenza
all’atto, assumendo una forma e venendo all’essere.
Per determinare rigorosamente la contingenza del mondo e la sua condizione creaturale,
Tommaso d’Aquino ritiene opportuno sviluppare ulteriormente l’analisi ontologica di
Aristotele. A tale scopo e ispirandosi al filosofo arabo Avicenna, negli enti finiti rileva la
presenza di una distinzione reale tra essentia e actus essendi (o esistenza). → Esistenza;
Divenire; Contingenza; Creazione; Dio (La questione della dimostrabilità dell’esistenza di
Dio)
Al di là dell’applicazione metafisica appena richiamata, anche la tradizionale cosmologia
meccanicistica, in forma più o meno esplicita, si avvale necessariamente del principio di
causalità, al quale aggiunge il principio del determinismo naturale, secondo cui nel mondo a
determinate cause inevitabilmente corrispondono determinati effetti, dai quali pertanto è
27
Aristotele, Fisica, VII (H), 1, 241 b 24, trad. di A. Russo, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973, vol.
3, p. 167; Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 2, art. 3 c
28
possibile all’inverso risalire alle cause. La regolare connessione causale tra i fenomeni è
giustificata in base al principio dell’uniformità della natura, secondo il quale cause simili in
condizioni simili producono effetti simili. → Determinismo; Meccanicismo
L’efficacia causale nella spiegazione degli eventi è stata resa evidente dagli scolastici
medioevali mediante la formulazione di tre corollari del principio di causa: “posita causa,
ponitur effectus” (posta la causa, è posto l’effetto), “sublata causa, tollitur effectus” (tolta la
causa, è tolto l’effetto), “variante causa, variatur effectus” (variando la causa, varia
l’effetto). Le stesse tabulae induttive del metodo baconiano di ricerca empirica non sono
che un’applicazione operativa e sistematica di questi corollari. → Metodo sperimentale,
Formazione del
Diversamente dalla tradizione, nella quale aveva dominato una concezione realistica del
principio di causa, David Hume introduce un’interpretazione soggettivistica. La sua analisi,
peraltro, non distingue, ma sostanzialmente identifica i due principi che abbiamo appena
considerato, cioè il principio di causalità e il principio del determinismo causale. Da che
cosa nasce, egli si chiede, la nostra convinzione riguardante la regolarità della natura?
Perché ci prospettiamo gli eventi futuri in conformità a quelli passati? Per Hume non è la
ragione che ci induce a ciò; è invece un’inclinazione istintiva che ci porta a crederlo. A sua
volta questa credenza (belief) è determinata dall’“abitudine” (custom) prodotta in noi
dall’esperienza, cioè dall’aver osservato che le cose si sono svolte finora in una certa
maniera. Pertanto, l’inferenza induttiva non ha né un fondamento logico né un fondamento
empirico, ma psicologico: è la nostra mente che trasforma un semplice post hoc in un
propter hoc, ossia la successione in un processo causale. → Credenza; Induzione
L’impostazione scettica del pensiero humeano appare fortemente aporetica; ci possiamo,
infatti, chiedere: con la sua indagine non intende egli stesso, nelle spiegazioni che dà,
avvalersi teoreticamente della relazione causale?
Immanuel Kant non condivide il soggettivismo psicologistico di Hume. Ad esso, tuttavia,
oppone non il realismo tradizionale, ma un’epistemologia di tipo “trascendentale”, secondo
la quale il principio di causa è un giudizio sintetico a priori. → Realismo; “Rivoluzione
copernicana”; Sintetici a priori, Giudizi
CONTRATTUALISMO
È la concezione tipica del pensiero giusnaturalistico, secondo la quale la società politica o
Stato non è naturale, ma è un prodotto dell’“arte”, cioè un’organizzazione volontaria e
artificiale del potere, realizzata mediante un patto o contratto originario, che la costituisce
come legittima sulla base del consenso e della delega dei poteri, allo scopo di assicurare a
tutti il godimento dei diritti naturali o, almeno, nella concezione politica di Thomas
Hobbes, del bene primario della vita.
I giusnaturalisti distinguono il pactum unionis, che costitutisce l’unione, cioè la società
politica, e porta al superamento dello stato naturale, e il pactum subjectionis, che è il
bilaterale impegno dei governati e dei governanti al rispetto delle regole concordate per
l’esercizio del potere pubblico. Hobbes non fa sua questa distinzione. Per lui il patto è
unico, nel senso che gli individui riconoscono insieme la necessità di rinunciare alla propria
volontà egoistica e l’obbligo di accettare un’autorità sovrana che assicuri la pace generale.
Il potere va ceduto allo Stato in maniera assoluta, totale e irrevocabile. Invece,
l’interpretazione liberale del patto, data per esempio da John Locke, comporta che una sua
trasgressione sostanziale da parte di chi governa legittimi la resistenza ed eventualmente la
29
rivoluzione di chi è governato. Le posizioni dei due filosofi inglesi riflettono
significativamente lo svolgersi degli eventi drammatici dell’Inghilterra del secolo XVII.
I teorici del contrattualismo non sempre intendono riferirsi ad una stipulazione del patto
storicamente effettiva. Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, per esempio, la
considerano piuttosto un modello teorico, utile a comprendere il senso della convivenza
politica. → Giusnaturalismo; Positivismo giuridico; Politica (Teorie politiche), §§ 8 e 9
(Concezione contrattualistica dello Stato)
CONVENZIONALISMO
È un termine usato nell’ambito del dibattito epistemologico ed è spesso associato al termine
“strumentalismo”, per designare l’orientamento di chi considera le teorie scientifiche come
strumenti liberamente scelti e concordati all’interno della comunità scientifica sulla base
della loro utilità ed efficacia ad interpretare i dati sperimentali, ad organizzare la ricerca e a
sistemarne i risultati. Le teorie, quindi, non sono propriamente né vere né false, ma solo
comode, funzionali e operativamente opportune o inidonee.
Come esempi ragguardevoli di un convenzionalismo complesso e problematico possiamo
menzionare le posizioni dei francesi Henri Poincaré (1854-1912) e Pierre Duhem (18611916), direttamente impegnati nell’attività scientifica e interessati alla riflessione
epistemologica.
A giudizio di entrambi le teorie scientifiche sono strumenti di organizzazione
dell’esperienza. Questa non ci potrà mai obbligare in maniera definitiva a preferire un certo
modello interpretativo rispetto ad altri. La scelta avviene sulla base di motivi di opportunità,
di semplicità, addirittura estetici e potrà sempre essere rivista e mutata. Non c’è la teoria
assolutamente vera; i modelli svolgono una funzione euristica, cioè sono ipotesi funzionali
alla ricerca empirica e i responsi dell’esperienza possono sempre essere compatibili con una
pluralità di schemi teorici. Secondo Poincaré, tuttavia, lo scienziato non “crea” il fatto
oggetto di studio, come invece affermava, estremizzando, Edouard Le Roy, ma lo traduce
in un linguaggio comodo. I fatti in sé sono “bruti”, grezzi; è lo scienziato che li fa diventare
fatti scientifici, inserendoli in una certa teoria.
In particolare, poi, nell’ambito della geometria, ormai ampiamente sviluppata in direzioni
non euclidee, Poincaré sostiene che gli assiomi sono “definizioni mascherate”, semplici
convenzioni liberamente scelte e, esplicitamente o tacitamente, stipulate da coloro che nella
comunità scientifica ne fanno uso. E aggiunge: “La nostra scelta, tra tutte le convenzioni
possibili, è guidata dai fatti sperimentali; ma resta libera ed è limitata solo dalla necessità di
evitare ogni contraddizione”. Perciò la domanda quale sia la geometria “più vera” è
insensata; “tanto varrebbe domandare se il sistema metrico è vero e le antiche misure false;
se le coordinate cartesiane sono vere e le coordinate polari false. Una geometria non può
essere più vera di un’altra, può soltanto essere più comoda”98. → Geometrie non euclidee
A sua volta Duhem, contro l’induttivismo, sostiene il carattere ipotetico-deduttivo del
metodo scientifico: prima sono poste liberamente in via ipotetica le costruzioni teoriche,
elaborate tramite sistemi di equazioni, poi esse sono interpretate fisicamente e rese
suscettibili di controllo empirico; tuttavia, anche se questo risulta positivo, non è affatto
accertata la “verità” delle ipotesi, perchè i risultati esperienziali sono compatibili con una
pluralità di teorie.
Duhem suffraga la propria concezione epistemologica anche con l’indagine storiografica,
per esempio a proposito della censura ecclesiastica contro la posizione galileiana (in
98
H. Poincaré, La scienza e l’ipotesi, a cura di F. Albergamo, La Nuova Italia, 1950, p. 58
30
Salvare i fenomeni, 1908): poiché la teoria copernicana e la teoria tolemaica hanno solo il
valore strumentale d’interpretare l’esperienza e di darle un ordine razionale, la verità non
consisteva semplicemente nel dire che in realtà è la terra a muoversi attorno al sole;
pertanto aveva ragione il cardinale Roberto Bellarmino, nell’adottare la tradizionale
distinzione tra astronomia matematica e astronomia fisica, a sostenere che si potesse
accettare la teoria copernicana solo come ipotesi.
La concezione che Duhem ha della ricerca scientifica è consapevolmente complessa e
problematica. Egli considera del tutto inadeguato, semplicistico e ingenuo il modello
metodologico baconiano dell’esperimento cruciale (experimentum crucis), che
consentirebbe di escludere in un confronto decisivo tra due ipotesi una delle due, pensando
che l’altra sia senz’altro vera (→ Metodo sperimentale, Formazione del). Innanzitutto in
una spiegazione scientifica non è pensabile che si diano soltanto due ipotesi, perché è
sempre possibile supporne qualche altra. Inoltre un’ipotesi non è mai isolata, ma s’inserisce
in un contesto teorico complessivo, in cui intervengono varie altre ipotesi accessorie e
ausiliarie, assunte più o meno consapevolmente ed esplicitamente. L’eventuale
contestazione sperimentale dell’ipotesi, che è oggetto d’interesse, mette perciò in
discussione direttamente o indirettamente tutto un insieme teorico. È, questa, la cosiddetta
teoria dei “controlli olistici”, denominata anche “tesi Duhem-Quine”, perché è stata
successivamente ripresa e confermata dal logico Willard Quine (1908-2000).
A giudizio di Karl R. Popper (1902-1994) lo strumentalismo è inevitabilmente connesso ad
un sostanziale relativismo scettico, che non ci consente di disporre di alcun criterio per
valutare la validità teoretica delle nostre tesi. Pertanto egli opta per un “realismo” critico e
problematico, ossia per una concezione della verità intesa come corrispondenza tra le
proposizioni e i fatti (l’adaequatio rei et intellectus della tradizione), assunta, tuttavia, come
un ideale regolativo mai compiutamente raggiungibile, ossia come verosimiglianza.
Diversamente da Duhem, Popper prende posizione a favore di Galilei contro lo
strumentalismo, perché la storia dimostra che la scienza realizza effettive scoperte e
migliori conoscenze: “L’asserzione che la terra sia immobile e che il cielo stellato vi ruoti
intorno è più lontana dalla verità di quella che la terra ruoti intorno al proprio asse; che sia,
cioè, il sole ad essere immobile e che la terra e gli altri pianeti si muovano intorno al sole in
orbite circolari (come proposero Copernico e Galileo). L’asserzione, dovuta a Keplero, che
i pianeti non si muovono in cerchi, ma in ellissi (non molto allungate) con il sole nel loro
fuoco comune (e con il sole immobile, o in rotazione intorno al proprio asse), è un’ulteriore
approssimazione alla verità”99. → Strumentalismo; Realismo; Verosimiglianza
CRITERIO DI VERITÀ
Questo termine deriva direttamente dal greco κριτήριον (kritérion), che si rifà al tema del
verbo κρίνω (kríno), il cui significato è: distinguo, giudico. In generale designa ogni norma
di giudizio e di valutazione. In senso specifico, nell’ambito della filosofia, si riferisce a ciò
che consente di discernere il vero dal falso.
Nel dibattito gnoseologico delle scuole ellenistiche, in particolare dello stoicismo, erano
denominati “criteri” le regole che consentivano di determinare la validità veritativa delle
teorie e dei discorsi. Come la dottrina epicurea del canone (→ Canone), anche la logica
stoica indicava l’origine prima e ineludibile della conoscenza nelle sensazioni, alle quali è
vincolata la formazione delle prolessi e delle nozioni comuni (→ Prolessi). Gli stoici, però,
99
K.R. Popper, Poscritto alla Logica della scoperta scientifica, , vol. I: Il realismo e lo scopo della scienza, trad.
di M. Benzi e S. Mancini, Il Saggiatore, 1984, p. 24
31
rilevavano che non tutte le rappresentazioni hanno la stessa evidenza. Soltanto quando
questa appare non problematica, noi ci sentiamo nella condizione di dare il nostro assenso;
in questo caso siamo di fronte alla rappresentazione “catalettica”, con la quale il nostro
intelletto ritiene di “comprendere” l’oggetto, cioè di averne il possesso conoscitivo, come
avviene quando stringiamo in pugno qualcosa, secondo l’efficace immagine usata da
Zenone di Cizio, stando alla testimonianza di Cicerone195. → Catalettica, rappresentazione
Il problema di come ci si debba regolare, per distinguere il vero dal falso e dar certezza
alla nostra conoscenza, da sempre ha interessato il pensiero filosofico, ma è diventato
centrale ed ha acquisito sistematicità nell’età moderna, a partire dalla questione cartesiana
del metodo e dal suo momento iniziale, costituito dal “dubbio metodico” (→ Metodo;
Dubbio). Renato Cartesio assunse come impegno programmatico di applicazione metodica
la regola dell’evidenza: “non accettare mai per vera nessuna cosa che non conoscessi con
evidenza esser tale: [...] cioè non comprendere nei miei giudizi se non ciò che si fosse
presentato alla mia mente con tale chiarezza e distinzione da non aver nessun motivo di
metterlo in dubbio”196. La conquista del “punto d’Archimede” della sua filosofia, cioè la
certezza del “cogito, ergo sum”, non fece che ribadire in lui questa certezza: “Avendo
notato che nella proposizione ‘io penso dunque sono’ ciò che mi fa certo che non mi
inganno consiste soltanto nel fatto che intendo con gran chiarezza che per pensare bisogna
essere, pensai di poter assumere come regola generale che son tutte vere le nozioni che
concepiamo in modo del tutto chiaro e distinto”197. In tal modo egli tradusse l’evidenza nel
possesso di idee chiare e distinte, e la ripropose con maggior vigore di quanto non fosse
stato fatto nel passato come l’autentico e ineludibile criterio di verità, la solida base a cui
poter applicare le altre regole metodiche, in particolare l’analisi e successivamente la
sintesi. Si può inoltre rilevare che questo criterio, nell’uso che Cartesio ne fece, ebbe
un’esplicita caratterizzazione matematistica, avendo egli considerato la scienza matematica
come il modello di tutto il sapere, pensato nella forma di una mathesis universalis (→
Matematismo). La concezione cartesiana delle idee pose, peraltro, le premesse di una
gnoseologia fenomenistica, che caratterizzerà buona parte della filosofia moderna (→
Fenomenismo). Infatti, l’assoluta certezza della sussistenza di un mondo oggettivo Cartesio
l’acquisì per via metafisica, affidandosi alla perfetta veracità divina. Questo è
sostanzialmente il ragionamento cartesiano: poiché siamo generalmente portati a credere
che le sensazioni derivino da cose esterne a noi, se così non fosse, dovremmo assurdamente
pensare che Dio c’inganna.
Baruch Spinosa riconfermò a sua volta il matematismo cartesiano, applicandolo con
estremo rigore, preoccupandosi anche di precisare che la verità non ha bisogno di criteri
estrinseci per farsi riconoscere, perché “come la luce manifesta se stessa e le tenebre, così la
verità è norma di sé e del falso” (“Sicut lux seipsam et tenebras manifestat, veritas norma
sui et falsi est”)198. Che cos’è, infatti, la verità, secondo l’originaria dizione greca ἀλήθεια
(alétheia), se non il “rivelarsi” dell’essere o la sua intrinseca evidenza?
Il fondamentale criterio veritativo, che emerge storicamente nel pensiero dei vari autori, a
partire dall’assiomaticità dei primi principi (principio di non contraddizione e principio del
terzo escluso) esaminati da Aristotele fino alla “riduzione fenomenologica” e
195
Cicerone, Academica priora, II, 144, in Stoici antichi, a cura di M. Isnardi Parente, UTET, 1989, vol. I, p. 152
Discorso sul metodo, trad. di E. Lojacono per conto dell’editrice UTET, in Il “discorso sul metodo” di Cartesio
e il problema del metodo nel XVII secolo, a cura di G. Brianese, Paravia, 1993, p. 57
197
R. Cartesio, Discorso sul metodo, cit., p. 74
198
B. Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrato, II, Scolio della prop. 43
196
32
all’“intuizione eidetica” considerate da Edmund Husserl (→ Fenomenologia), è alla fin fine
questo. → Evidenza e certezza; Verità
Nell’ambito delle scienze empiriche il positivismo e il neopositivismo hanno stabilito un
“criterio di significanza”, facendolo coincidere con il principio di verificazione. →
Verificazione, Principio di
33
D
DEMOCRAZIA
Il termine di origine greca, che letteralmente significa “potere del popolo”, oggi ha in sé
un’ovvia connotazione positiva, ma così non era nel mondo antico.
Il modello politico democratico, preferibilmente denominato ἱσονομία (isonomía), cioè
uguaglianza di fronte alla legge, fu considerato da Pericle e Protagora la condizione più
confacente ad assicurare la realizzazione storica della giustizia e del progresso. Non
condivisero questa convinzione né Platone, per il quale nella democrazia imperversa una
sfrenata libertà, cioè la “licenza di fare ciò che si vuole”16, né Aristotele, che considerava la
democrazia come il governo della moltitudine economicamente più povera, in opposizione
ostile verso gli altri. Invece, secondo lo Stagirita, il modello positivo è rappresentato dalla
“politìa”, in greco πολιτεία (politéia), che significa letteralmente “governo della città”. Essa
corrisponde al governo di molti per il bene comune; e i molti in questo caso sono i cittadini
delle classi medie, i quali “non bramano le altrui cose, come i poveri, né gli altri le loro,
come fanno appunto i poveri dei beni dei ricchi”17. Nel trattato sulla Politica Aristotele
applica ai gruppi sociali le distinzioni e le qualificazioni usate per l’individuo nell’ambito
dei comportamenti etici, per cui la classe individuata in posizione mediana tra gli estremi
della massa più misera e dell’élite più ricca è indicata come la più adeguata ad un corretto
governo dello Stato, perché dà maggiori garanzie di equilibrio, di ordine e di equità. La
μεσότης (mesótes), cioè la “medietà”, è la condizione generale della virtù. → Mesótes
La nostra attuale democrazia è una realizzazione storicamente recente, connessa alla
formazione della moderna società di massa, che, a sua volta, è il prodotto della rivoluzione
industriale. A voler considerare anche solo le condizioni geografiche e demografiche degli
stati odierni, la realtà ci appare ben diversa da quella delle πόλεις (póleis) greche, che
potevano anche consentire una partecipazione diretta del popolo alla gestione politica
nell’ἀγορά (agorá), cioè nell’assemblea convocata nella piazza pubblica. Oggi tale
partecipazione avviene in poche occasioni, comunque importanti e decisive (elezioni,
referendum), perché la gestione ordinaria del potere è realizzata attraverso i rappresentanti,
che agiscono “senza vincolo di mandato”18, nel senso che il rapporto con gli elettori non si
traduce in forme imperative per gli eletti, ma rimane semplicemente fiduciario. Il potere
degli eletti è un potere delegato.
La democrazia è una forma di governo che si fonda sui principi etico-giuridici della
naturale uguaglianza degli uomini e della sovranità popolare. La sua realizzazione storica è
intrecciata a quella del liberalismo moderno, che l’ha preceduta e il cui principio
fondamentale consiste nella limitazione del potere politico. Il potere, infatti, secondo il
pensiero liberale, è legittimato da un patto costituente, che ad esso attribuisce la funzione di
garantire gli universali diritti originari e inalienabili degli individui, già teorizzati dalle
moderne teorie giusnaturalistiche. Sembrerebbe che questo universalismo giuridico, così
16
Platone, La Repubblica, VIII, 557 b, trad. di F. Sartori, in Opere complete, cit., vol. 6, p. 283
Aristotele, Politica, IV () 11, 1295 b 30-32, trad. di R. Laurenti, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza,
1973, vol. 9 p.136
18
Art. 67 della costituzione italiana
17
34
come la concezione contrattualistica dello Stato, dovesse di per sé caratterizzare il
liberalismo come una teoria intrinsecamente democratica; invece, la concreta applicazione
storica che ne è stata fatta ha per lungo tempo vanificato questo profilo ideale,
subordinando il diritto elettorale ai criteri del sesso (maschile), del censo (il riconoscimento
in base alla propria contribuzione fiscale, rapportata al patrimonio e al reddito) e
dell’istruzione. Pertanto l’effettiva democratizzazione della politica, avvenuta tra
l’Ottocento e il Novecento, è consistita nel realizzare l’originaria ispirazione universalistica
del liberalismo, integrato tuttavia da un nuovo ed esplicito impegno di solidarietà sociale.
Essa si è svolta attraverso tensioni e lotte, dovute soprattutto ai movimenti e alle
organizzazioni popolari, in particolare di orientamento socialista, che esigevano il rispetto
di elementari diritti di giustizia, perché l’uguaglianza non fosse soltanto formale, cioè
giuridica e politica, ma anche sostanziale, cioè riguardasse le condizioni economiche e
sociali. Ciò ha determinato un concreto arricchimento della stessa nozione di democrazia,
che l’evoluzione storica occidentale, soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, ha
cercato di attuare secondo il modello del welfare state, espressione che solitamente è
tradotta in italiano con “stato del benessere” o “stato sociale”. È quanto ha inteso
prescrivere la nostra stessa costituzione repubblicana tra i suoi principi fondamentali: “Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge […]. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”19. → Politica;
Liberalismo; Eguaglianza
DETERMINISMO
Questo termine designa ogni concezione della realtà, che stabilisce una connessione causale
necessaria tra gli eventi. → Determinazione
Occorre distinguere il principio metafisico di causalità, secondo il quale tutto ciò che
accade ha una causa e nulla è a caso (→ Causalità, Principio di ), dal determinismo causale,
secondo cui a determinate cause inevitabilmente corrispondono determinati effetti, dai quali
pertanto è possibile all’inverso risalire ad esse. Il determinismo riguarda la natura, nella
quale tutto si svolge secondo regolarità costanti e generali (le cosiddette leggi). La
ricorrente connessione causale tra i fenomeni è tradizionalmente giustificata con il principio
di uniformità della natura, secondo il quale cause simili in condizioni simili producono
effetti simili. A questo proposito, particolarmente efficace è la sentenza di John Stuart Mill:
“È una legge che ogni cosa abbia una legge”. Quindi la conoscenza delle leggi naturali
consente la prevedibilità degli eventi. A tale riguardo Mill afferma: “Noi crediamo che lo
stato dell’intiero universo in un istante qualsiasi sia la conseguenza dello stato in cui si
trovava nell’istante precedente; cosicché, chi conoscesse tutti gli agenti che esistono al
momento attuale, la loro collocazione nello spazio e tutte le loro proprietà – in altre parole
le leggi della loro azione – potrebbe prevedere tutta quanta la storia successiva
dell’universo”22. La tradizionale concezione deterministica del mondo fu elaborata sia
anticamente che nell’età moderna in base alle leggi del movimento, ossia in forma
meccanicistica. → Meccanicismo
Anche nei sistemi metafisici che implicano uno svolgimento totalizzante dell’essere, per cui
nulla può essere diversamente da com’è, è individuabile un rigido determinismo, che può
19
22
Art. 3 della costituzione italiana
J. Stuart Mill, Sistema di logica deduttiva e induttiva, Utet, 1988, vol. I, libro III, cap. V, p. 482
35
svolgersi o in forma deduttiva (come avviene nel sistema spinoziano) o in forma dialettica
(come avviene nel sistema hegeliano). Baruch Spinoza, infatti, ha inteso derivare con
metodo geometrico (ordine geometrico), tutta la complessa articolazione del reale da verità
prime (assiomi e definizioni) riguardanti la sostanza (→ Deduzione; Matematismo). La
causalità, che emerge nel suo sistema, non è transitiva, perché gli effetti non sono al di fuori
della causa, ma immanenti ad essa. Ora, poiché egli parte dall’affermazione che Dio è
l’unica e infinita sostanza, che si dispiega nei suoi infiniti attributi e modi, la conseguenza è
che essa tutto include in sé, secondo un rigoroso monismo. → Sostanza; Modi
La stessa struttura monistica, per cui “Dio è la causa immanente e non già transitiva di
tutte le cose”23, è presente anche nel sistema hegeliano, che tuttavia si sviluppa con un
procedimento formale non deduttivo, ma dialettico. → Dialettica
DIALETTICA
Il termine “dialettica” percorre con un uso non univoco tutta la storia della filosofia, fin
dalle sue lontane origini, nelle quali designava direttamente l’arte del discorso e del
ragionamento. “Dialettica” (διαλεκτική, dialektiké) è un aggettivo sostantivato, che
sottintende la parola τέχνη (téchne). Esso designa letteralmente “l’arte del discorso”.
La dialettica nel pensiero antico
Non a caso G.W.F. Hegel ha visto una prefigurazione della propria concezione dialettica
del reale già nell’antica teoria eraclitea, secondo la quale il lógos governa con la sua legge
un mondo in perpetuo divenire, assicurando un ordine armonico mediante la mobile
opposizione dei contrari. → Lógos
Con Zenone nella scuola eleatica la dialettica consiste nell’arte della confutazione. →
Confutazione
I sofisti e Socrate l’assumono in questo senso, ma inserendola nella più ampia e consueta
dimensione del dialogo. Si può, per inciso, osservare che i due termini “dialettica” e
“dialogo” hanno la stessa derivazione etimologica, che evidenzia il trascorrere del discorso
attraverso le parole. In entrambi, infatti, è rilevante il confronto oppositivo tra gli
interlocutori, che rivela la positiva fecondità della negazione nel progressivo emergere della
verità. → Dialogo socratico
Sulla base della testimonianza platonica dobbiamo, peraltro, rilevare che diverso è
l’animo con il quale i sofisti e Socrate affrontano e alimentano l’interlocuzione: nei primi
non è presente l’appassionata ricerca della verità che troviamo nel secondo e la dialettica
tende a diventare retorica, attenendosi al semplice criterio della verosimiglianza e mirando
soltanto a persuadere l’interlocutore. → Retorica
La dialettica platonica
Anche per Platone, discepolo di Socrate, la filosofia fa tutt’uno con la dialettica. Egli la
identifica con l’impegnativo percorso della ricerca, la quale, portandoci oltre l’ambito della
phýsis, ci consente di accedere alla verità. È convinto che il mondo sensibile non abbia in sé
la spiegazione dei problemi che suscita; perciò, diversamente dalla precedente indagine
“fisica” della filosofia, intende “mutare modo di navigazione”25, puntando la direzione
B. Spinoza, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, I, prop. 18, trad. di Sossio Giametta, Boringhieri,
1971
25
Platone, Fedone, 99 d, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, cit., vol. 1, pp. 165.
23
36
dell’intelletto verso la verità immutabile e trascendente delle idee. In questo senso ciò che
Platone chiama “dialettica” sarà poi più comunemente denominato “metafisica”. →
Metafisica
Platone traduce operativamente la dialettica sia nell’analisi delle idee, considerate nelle
loro logiche articolazioni, sia, all’opposto, nella sintesi delle idee più limitate in quelle più
generali. L’essere, infatti, non ha la rigida unità con la quale l’aveva pensato Parmenide, ma
si struttura come un complesso sistema, che consente all’abile dialettico di evidenziare per
un verso l’unità del molteplice, sia del molteplice presente nel mondo empirico sia del
molteplice del mondo ideale, e in senso opposto l’articolazione e la divisione delle idee
generali nelle idee specifiche, così come soltanto ad un esperto macellaio è dato di poter
smembrare un organismo animale “seguendo le nervature naturali, guardandosi dal
lacerarne alcuna parte”26. Il sistema può essere trascorso sia verso l’alto, in un movimento
che unifica, sia verso il basso, in un movimento che divide. → Idea; Diáiresis
L’argomentazione dialettica secondo Aristotele
Aristotele interpreta la dialettica in due maniere: come metodo della confutazione
(élenchos) di una determinata tesi, di cui intende dimostrare la contraddittorietà (→
Confutazione), e come tecnica dell’argomentazione non rigorosa né scientifica, ma
semplicemente probabile. In questo secondo senso essa coincide sostanzialmente con l’arte
retorica. Perciò nei Topici e nella Retorica Aristotele considera anche il sillogismo
dialettico, distinguendolo da quello apodittico, proprio della logica, perché esso “conclude
da elementi fondati sull’opinione”27. → Retorica
L’argomentazione dialettica nella tradizione e nella filosofia di Kant
Nella tradizione medioevale e moderna l’accezione prevalente del termine “dialettica” sarà
quella data da Aristotele. Anche Kant l’assume nella sua Critica della ragion pura, dove
designa la dialettica come “logica dell’apparenza”, individuandone la specifica
applicazione nella metafisica. Di questa, infatti, nella Dialettica trascendentale egli intende
evidenziare gli insidiosi ragionamenti e criticare le illusorie e fallaci pretese dimostrative,
riguardanti ciò che trascende l’esperienza. → Metafisica
La dialettica hegeliana
L’idealismo romantico rovescia la posizione kantiana: dalla critica della metafisica passa
alla sua celebrazione; in tal modo la filosofia da teoria del finito si capovolge in una
teorizzazione dell’infinito (→ Idealismo). Specialmente il pensiero hegeliano si presenta
come una superba organizzazione totalizzante del sapere, giustificata da una concezione
intrinsecamente unitaria e finalistica del reale, pensato come l’infinito-tutto, che si esplicita
nell’interdipendenza dialettica dei suoi aspetti finiti. Con Hegel, perciò, ci troviamo di
fronte ai fasti di una grandiosa metafisica dell’immanenza. A suo giudizio, la metafisica
tradizionale pensa, in maniera del tutto scorretta, il finito come una realtà ontologicamente
autonoma, posta accanto all’infinito; pensato adeguatamente, invece, il finito tende
necessariamente a “superare se stesso”, a negarsi e a risolversi nella realtà infinita, nella
quale soltanto s’invera, cioè trova la propria verità. Il processo, mediante il quale ciò
avviene, è appunto la dialettica.
Per Hegel è dialettico sia lo sviluppo ontologico della realtà che il logico articolarsi del
pensiero, perché logica e ontologia fanno un tutt’uno: “ciò che è razionale è reale e ciò che
26
Platone, Fedro, 265 e, cit., p. 270
Aristotele, Topici, I (A), 1, 100 a 30, in Opere, vol. 2, trad. di G. Colli, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973,
p. 5
27
37
è reale è razionale”28. Egli riafferma così l’identità anticamente proclamata da Parmenide:
“È la stessa cosa pensare ed essere” (→ Essere); la dialettica, infatti, riguarda non solo
l’essere, ma anche il pensiero, che ne rivela l’intima razionalità. Non a caso Hegel
denomina Idea la realtà. Egli, tuttavia, diversamente da Parmenide, la considera in divenire,
riproponendo così l’universale divenire delle cose, di cui aveva parlato Eraclito (→
Divenire). Perciò con il termine “dialettica” Hegel intende innanzitutto e in senso generale
caratterizzare la realtà e la conoscenza nella forma del divenire, perché sia l’una che l’altra
si danno compiutamente solo in termini processuali e non in maniera immediata.
Concretamente, poi, questo divenire si svolge secondo un ritmo triadico di progressiva
realizzazione e progressivo inveramento. I tre momenti che lo scandiscono sono denominati
scolasticamente con i termini di “tesi”, “antitesi”, “sintesi”29, ma Hegel preferisce indicarli
rispettivamente come momento “astratto o intellettuale”, momento “dialettico o negativorazionale” e momento “speculativo o positivo-razionale”. Il momento propriamente
dialettico è il secondo, per la funzione “negativa”, di opposizione e contraddizione, che
esso esprime. Le singole determinazioni della realtà, astrattamente considerate, ossia
scollegate dalla totalità di cui fanno parte e in cui hanno senso, risultano statiche, unilaterali
e insufficienti. In riferimento ad esse vale il principio di identità e di non contraddizione (A
è A). Spetta alla razionalità dialettica metterle in movimento, perché la contraddizione ne
evidenzia le relazioni di interdipendenza. Questo era già stato indicato dalla sentenza
spinoziana, che Hegel cita: “Omnis determinatio est negatio”, nel senso che, per dire ciò
che una cosa è, occorre anche rilevare ciò che essa non è. La negazione dialettica è una
“negazione determinata”, perché non è finalizzata semplicemente ad eliminare la tesi, ma
“ha un contenuto positivo”, cioè “un nuovo concetto, che è superiore e più ricco che non il
precedente. [Infatti...] è l’unità di quel concetto e del suo opposto”; in altri termini “quello
che si contraddice non si risolve nello zero, nel nulla astratto, ma solo nella negazione del
suo contenuto particolare”30. Infine il movimento dialettico s’invera, cioè trova la sua
verità, nel momento “speculativo o positivo-razionale”: in esso è data l’unità delle
determinazioni opposte. È il momento del “superamento” (Aufhebung), che esprime
insieme le azioni del “togliere” (l’opposizione fra tesi e antitesi) e del “conservare” (la
verità compiuta della tesi e dell’antitesi, il loro inveramento); in esso, attraverso la
negazione della negazione, si riafferma la positività di una nuova tesi ad un livello più
avanzato e ontologicamente più perfetto della processualità del reale.
Osserviamo che è stata rimproverata a Hegel una certa “disinvoltura” nell’uso delle
“antitesi” dialettiche: talvolta esse sono vere e proprie contraddizioni delle tesi (negano ciò
che le tesi affermano), altre volte sono semplicemente affermazioni contrarie (tesi e antitesi
non possono essere entrambe vere, ma potrebbero essere entrambe false), altre volte ancora
le antitesi sono solo diverse rispetto alle tesi, in altri casi ne individuano semplicemente
alcuni limiti o si riferiscono a termini correlativi.
28
G.W.F. Hegel, Prefazione ai Lineamenti della filosofia del diritto, trad. it. di F. Messineo, Laterza, 1974, p. 16
Ai tre momenti del processo dialettico (tesi, antitesi e sintesi) corrispondono rispettivamente particolari
espressioni pronominali (“in sé”, “per sé” e “in sé - per sé”), di cui Hegel si avvale tuttavia in maniera non univoca
e il cui significato va perciò determinato in rapporto al contesto in cui si trovano. In generale è qualificato come
“in sé” ciò che è immediato, implicito e non sviluppato nelle sue possibili relazioni dialettiche, perciò è
inconsapevole e astratto; all’opposto, “per sé” è ciò che risulta come mediato, esplicito, consapevole e concreto.
30
G.W.F. Hegel, Scienza della logica, a cura di A. Moni e C. Cesa, Laterza, 1974, I, p. 36. La citazione di
Spinoza, attinta dalle Epistulae, L, è presente nella stessa Scienza della logica, I, qui menzionata, p. 108.
29
38
La dialettica nel materialismo storico di Marx
Un’importante applicazione innovativa della dialettica hegeliana all’interpretazione della
storia è presente nel materialismo storico di Karl Marx, la cui incidenza sulla cultura
dell’Ottocento e del Novecento è stata notevole. Si rinvia per questo alla voce →
Materialismo storico
Benedetto Croce e la riforma della dialettica hegeliana
Ad un secolo di distanza dal grande maestro tedesco Benedetto Croce propone una riforma
della dialettica hegeliana, in particolare nello scritto: Ciò che è vivo e ciò che è morto della
filosofia di Hegel (1906). Egli è sospinto a ciò soprattutto dalla preoccupazione di
salvaguardare, nell’ambito delle attività spirituali, l’autonomia dell’arte, che con Hegel era
sembrata andare incontro ad un processo di dissoluzione: inserita nella filosofia della storia,
essa sembrava destinata ad appartenere al passato come un momento ormai superato
dell’esperienza umana (teoria della “morte dell’arte” → Estetica). Pertanto, la novità
crociana è data dalla “dialettica dei distinti”. Per Croce, infatti, l’opposizione dialettica (o
“dialettica degli opposti”), ci può essere solo nell’ambito di ciascun grado, o forma della
realtà (bello e brutto nell’arte, vero e falso nella filosofia, utile e inutile nell’economia, bene
e male nell’etica). Quindi la filosofia non può “superare” dialetticamente l’arte,
dichiarandone la morte, ossia inverandola ad un livello superiore, e l’arte permane come
forma autonoma della vita spirituale: essa è “intuizione lirica”, sintesi a priori fra un
contenuto di carattere sentimentale e una forma di carattere intuitivo. L’insieme delle
diverse forme dell’attività spirituale con le loro distinte espressioni realizza l’unità dello
spirito, che in tutte continuamente e variamente vive e si arricchisce, passando dall’una
all’altra e realizzando la “circolarità dello spirito”.
DIO
A) La nozione di Dio nella tradizione teologica occidentale
Data la varietà delle concezioni riguardanti l’essere assoluto, dovremmo parlare del
“divino”, più che di Dio. Volendo, in particolare, riferirci alla concezione teologica del
cristianesimo, che ha assimilato e usato la concettualizzazione approntata dalla filosofia
classica, potremmo dire che Dio va inteso come l’essere assoluto e supremo, sussistente in
sé ed eterno, dotato di una personalità che trascende il mondo, di cui è il creatore e al cui
ordine misteriosamente provvede, garantendo per gli uomini il trionfo finale della giustizia.
Si considerino le seguenti voci tematiche, che a questa sono variamente connesse: →
Assoluto; Infinito; Teismo; Deismo; Panteismo; Ateismo; Agnosticismo; Religione;
Antropomorfismo; Metafisica; Teologia; Teologia apofatica; Mistero; Creazione;
Provvidenza.
Il pensiero filosofico delle origini
Il pensiero filosofico occidentale delle origini esprime generalmente una forma di
naturalismo panteistico, nel senso che la natura è considerata l’orizzonte unico e
onnicomprensivo dell’essere e il divino non è esterno ad essa, non la trascende, ma le è
immanente e fa tutt’uno con l’elemento dinamico che le dà la vita. Anche Senofane di
Colofone (VI secolo a. C.), che promuove un’efficace critica del tradizionale
antropomorfismo religioso, suggerisce la concezione di una divinità onnipotente e
onnipresente, che tutto il mondo pervade, identificandosi con esso.
Un segno di svolta sembra darla Anassagora. Nel descrivere la formazione delle cose, egli
non si accontenta di indicare cause meccaniche, ma introduce una mente divina ordinatrice,
39
un’Intelligenza (Νοῦς, Noûs). La novità colpisce favorevolmente il giovane Socrate, che in
un primo momento s’illude di poter individuare in essa la soluzione dei suoi problemi; poi
invece constata che anche Anassagora non se ne avvale in maniera significativa (→
Fisiologi).
Socrate
Socrate rivela una sensibilità nuova riguardo alla questione religiosa. Accuse giudiziarie,
che sono destinate a procurargli la condanna a morte, gli imputano la responsabilità di aver
corrotto la gioventù e di non riconoscere gli dei della città. Esse, tuttavia, appaiono
semplicemente pretestuose di fronte al suo costante ed effettivo impegno a educare i
giovani alla virtù e a vivere la propria esistenza in un atteggiamento di pietà e obbedienza
agli dei, tanto che egli si sente di dover opporre a chi le sostiene e lo sollecita a smettere di
filosofare un fermo: “Obbedirò piuttosto al dio che a voi”. Nonostante la sostanziale
ignoranza nella quale tutti siamo, egli è convinto che la divinità è garante della giustizia;
perciò afferma: “A uomo dabbene non è possibile intervenga male veruno, né in vita né in
morte; e tutto ciò che interviene è ordinato dalla benevolenza degli dei”. E poi prosegue di
fronte a coloro che hanno voluto la sua condanna: “Anche quello che capita a me ora non è
opera del caso; [...] ecco che è l’ora di andare: io a morire, e voi a vivere. Chi di noi due
vada verso il meglio è oscuro a tutti fuori che a Dio”37.
Platone
Platone ha una concezione piuttosto estesa del “divino”. La condizione divina non compete
soltanto ad un’entità personale: divino è il mondo ideale; divino è l’originario stato
dell’anima, che da quel mondo proviene e ad esso desidera ritornare; divino è il Demiurgo
che plasma il mondo naturale, modellandolo sulle forme del mondo ideale; divina è
soprattutto l’eterna idea di Bene, che nella Repubblica38 è metaforicamente raffigurato dal
sole, “un dio la cui luce permette alla nostra vista di vedere nel miglior modo e alle cose
visibili di farsi vedere”. Platone così ne parla: “Ciò che nel mondo intelligibile il bene è
rispetto all’intelletto e agli oggetti intelligibili, nel mondo visibile è il sole rispetto alla vista
e agli oggetti visibili”; infatti come dal sole dipende la visione, così dal bene dipendono il
senso e l’intelligibilità del mondo in cui siamo. L’idea di Bene, poi, non è solo “causa della
scienza e della verità”, ma anche “causa di tutto ciò che è retto e bello” e, più in generale,
causa creatrice di tutto ciò che è; perciò “gli oggetti conoscibili non solo ricevono dal bene
la proprietà di essere conosciuti, ma ne ottengono ancora l’esistenza e l’essenza, anche se il
bene non è essenza, ma qualcosa che per dignità e potenza trascende l’essenza”.
Del divino Demiurgo, artefice del mondo, Platone parla nel Timeo. La teoria platonica
della formazione del mondo è chiaramente finalistica: le cose non provengono dalla
combinazione casuale e meccanica di elementi materiali, ma da un’iniziativa intenzionale e
benevola. L’intelligenza divina, infatti, riuscì ad imporsi sull’informe presupposto
materiale, ordinandolo verso scopi positivi.
C’è un ordine universale, soggetto al giudizio giusto e provvidente della divinità. Nessuno
può presumere di sottrarsi alla “giustizia degli dei”. A ciascuno va ricordato questo
avvertimento: essa “non ti trascurerà mai, nemmeno se tu fossi così piccolo da immergerti
nelle profondità della terra, nemmeno se tu diventassi così grande da volare fino al cielo. Tu
37
Platone, Apologia di Socrate, 19-20; 41 d - 42 a, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, cit., vol. 1, p. 54 e
pp. 72-73
38
Platone, La Repubblica, VI, 508a-509 b; VII, 517 c, cit., pp. 231 s e p. 240
40
agli dei pagherai la tua pena”39. Gli dei non sono ingiusti né si lasciano corrompere. Platone
è severo nel considerare l’ateismo una grave causa di immoralità sociale. A suo giudizio le
leggi devono prevedere che chi non si lascia persuadere dalle pazienti esortazioni né è
disposto a farsi correggere dal carcere merita la pena della morte.
Aristotele
La teologia aristotelica ha intenti cosmologici: del Motore Immobile o Atto puro Aristotele
parla come della causa prima, che può spiegare il divenire universale del mondo. Essa,
tuttavia, non è una causa efficiente, che sarebbe inevitabilmente coinvolta nel movimento
stesso della natura, cioè nella sua potenzialità e imperfezione. Il principio divino, dovendo
muovere senza essere mosso, agisce come causa finale: “muove come oggetto di amore [ὡς
ἐρώμενον κινεῖ, hos erómenon kinéi]”40. Essendo perfetta, “l’essenza prima non ha
materia”41, che è la condizione originaria della potenzialità degli enti naturali. La sua natura beata
è quella dell’“Intelligenza divina”, per la quale sarebbe indegno rivolgere la propria
attenzione a qualcosa d’inferiore a sé e darsi cura del mondo e degli uomini; essa “pensa se
stessa e il suo pensiero è pensiero di pensiero [νόησις νοήσεως, nóesis noéseos]”42.
Dunque, non è un dio provvidente. Aristotele, peraltro, lo descrive con vero entusiasmo. “Il
suo modo di vivere”, egli dice, “è il più eccellente: è quel modo di vivere che a noi è
concesso solo per breve tempo. E in quello stato Egli è sempre. [...] Ora, il pensiero che è
pensiero per sé, ha come oggetto ciò che è di per sé più eccellente [...] Ed Egli è anche Vita,
perché l’attività dell’intelligenza è vita, ed Egli è appunto quell’attività. E la sua attività,
che sussiste di per sé, è vita ottima ed eterna. Diciamo, infatti, che Dio è vivente, eterno ed
ottimo”43. Altrove, poi, precisa ulteriormente: “Noi immaginiamo che gli dei siano
sommamente beati e felici” e che l’attività più consona alla loro natura sia la
contemplazione; “quindi anche tra le attività umane quella che è più congenere a questa,
sarà quella più capace di render felici. […] Per gli dei tutta la vita è beata, e per gli uomini
lo è in quanto vi è in essi un’attività simile a quella […] Per quanto dunque s’estende la
speculazione, di tanto s’estende anche la felicità”. E quale può essere l’espressione più alta
dell’attività teoretica, cioè della filosofia, se non “la contemplazione di dio”?44
Plotino
Plotino ha una rigorosa consapevolezza della trascendenza del principio assoluto
dell’essere, cioè, religiosamente parlando, del mistero divino. L’ispirazione mistica
alimenta tutta la sua riflessione, accompagnandola fino all’esito finale dell’estasi. Egli
denomina il principio con l’appellativo di “Uno”, ma ritiene di doverlo sottrarre ad ogni
definizione, perché l’eventuale tentativo di configurarne l’identità, cioè di dire che cos’è, lo
sminuirebbe come ente tra gli enti. Poiché è al di là di ogni possibile determinazione
predicativa, l’Uno va qualificato come ἄπειρον (ápeiron), cioè infinito. In questo caso
l’infinità della potenza (δύναμις, dýnamis), di cui parla Plotino, non è più la potenzialità
indefinita della materia, di cui aveva parlato Aristotele, ma indica il massimo positivo della
39
Platone, Leggi, X, 905 a, trad. di A. Zadro, in Opere complete, cit., vol. 7, p. 352
Aristotele, La metafisica, , 7, 1072 a 25-26 e 1072 b 3, a cura di G. Reale, Loffredo, 1968, vol. II, p. 242
41
ivi, , 8, 1074 a 31-38, cit., II, p. 248
42
ivi, , 9, 1074 b 33-34, cit., II, p. 250
43
ivi, , 7, 1072 b 14-29, II, pp. 243 s.
44
Aristotele, Etica nicomachea, X (K), 8, 1178 b 8, 23-30, trad. di A. Plebe, in Opere, a cura di G. Giannantoni,
Laterza, 1973, vol. 7, p. 267;
Etica Eudemia, VIII (Θ), 3, 1249 b,17, trad. di A. Plebe, in Opere, cit., vol. 8, p. 192
40
41
forza creatrice, che si è soliti riconoscere a Dio. L’Uno “è senza forma, non è essenza”, “è
al di là dell’essere” e al di là del pensiero, è “l’Ineffabile” (ἄρρητος, árretos). Tutti i nomi,
ai quali tentiamo di ricorrere, si rivelano inadeguati e “anche questo nostro nome ‘Uno’ non
ha altro valore che di ‘soppressione’ relativamente al molteplice [...] Che se l’Uno - nome e
cosa significata - avesse un valore positivo, esso riuscirebbe in fin dei conti assai meno
chiaro che se non gli si desse nome alcuno”45. Considerata l’enorme influenza che Plotino
avrà sul pensiero filosofico e teologico dei secoli successivi, possiamo dire che qui siamo
all’origine della teologia “apofatica” o “negativa”, di cui si avvarrà tutta la tradizione
mistica occidentale.
La consapevolezza della trascendenza dell’Uno sembra obbligare al silenzio; tuttavia
Plotino accetta il rischio di incorrere nella contraddizione, parlandone e attribuendogli
qualificazioni positive, come la denominazione platonica di Bene, ma precisa che
propriamente l’Uno non ha bisogno di nulla, è al di là di ogni aspirazione, perciò “è superBene; e non è bene per se stesso ma è bene per gli altri esseri che eventualmente siano in
grado di parteciparne”46.
A proposito dell’Uno, poi, Plotino pone paradossalmente la questione metafisica estrema,
riguardante la sua origine. Del principio egli parla come di una realtà originariamente
dinamica, cosicché “la sua attività, cioè quella che potrebbe dirsi la sua vita, non può affatto
venir riportata al suo cosiddetto essere; ma il suo cosiddetto essere è congiunto e quasi
connaturato sin dall’eternità con la sua attività”47. L’Uno è causa sui, si pone eternamente
da sé: “come Egli volle, così anche è. [...] Egli è in tutto e per tutto padrone di sé, poiché fa
rientrare anche l’essere nel suo libero arbitrio. [...] Egli è il Creatore di se stesso: poiché se
la volontà promana da Lui ed è, per così dire, la sua opera, se però essa s’identifica con la
sua esistenza, allora Egli ha chiamato se stesso all’esistenza; [...] egli non è quello che
capitò a caso, ma quello che Egli stesso volle”48 (→ Autoctisi; Causa sui).
La teologia cristiana
Per la teologia cristiana Dio è certamente l’essere assoluto e supremo, trascendente il
mondo e suo creatore e signore, sussistente in sé, quindi necessario ed eterno, dotato di
personalità, garante dell’ordine universale e della definitiva giustizia tra gli uomini; tuttavia
il cristianesimo ritiene di essere innanzitutto non una dottrina, ma un evento di salvezza,
che s’incentra sul mistero dell’incarnazione divina, rappresentata storicamente da Gesù
Cristo, il cui “vangelo” è letteralmente la “buona notizia” di una salvezza connessa alla sua
morte e alla fede nella sua risurrezione e annunciata agli uomini. Gesù Cristo è indicato
come “il primogenito di coloro che risuscitano dai morti”, perché, afferma recisamente
Paolo di Tarso, “se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è
risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono
morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per
questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini”49. Dai testi sacri Gesù Cristo è
presentato come il Lógos eterno, la divina Parola per mezzo della quale Dio si è rivelato
agli uomini, prendendo parte alla loro storia e manifestando nei loro riguardi una
“scandalosa” condiscendenza mediante l’incarnazione: vero “svuotamento” (κένωσις,
kénosis) della dignità divina, come afferma il secondo capitolo della lettera di San Paolo ai
45
Plotino, Enneadi, V, 5, VI, a cura di V. Cilento, Laterza, 1973, vol. III / 1, pp. 66 s.
Plotino, Enneadi, V, 5, XIII; VI, 9, VI, cit., vol. III / 1, pp. 76 e 429
47
Plotino, Enneadi, VI, 8, VII, cit., vol. III / 1, p. 393
48
Plotino, Enneadi, VI, 8, XIII, cit., vol. III / 1, pp. 402-404
49
San Paolo, Lettera ai Colossesi, 1, 18 e Prima lettera ai Corinti, 15, 16-19, nella versione della Conferenza
episcopale italiana, disponibile in particolare ne La Bibbia di Gerusalemme, EDB-Borla, 1974
46
42
Filippesi. Ciò che il mistero cristiano intende rivelare è l’amore di Dio, che Giovanni indica
ai credenti come il fondamento dell’etica cristiana: “In questo sta l’amore: non siamo stati
noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di
espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci
gli uni gli altri. […] Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui”50.
L’enunciazione del messaggio (κήρυγμα, kérygma), la successiva riflessione dei credenti
e poi la chiarificazione ed elaborazione concettuale prodotta dalla teologia sono state via
via fissate ufficialmente nei dogmi dalla sanzione impegnativa dell’autorità ecclesiastica.
Tra le principali verità, che così faticosamente sono state definite, vanno ricordate quelle
riguardanti Dio stesso, di cui la Chiesa proclama l’unità della natura e la trinità delle
persone (→ Persona). → Cristianesimo e filosofia
Nonostante tutto questo intervento riflessivo della mente, Dio rimane comunque avvolto
nel suo mistero, cioè Deus absconditus51, e tutta la dottrina che lo riguarda è, in ultima
istanza, affidata alla fede. Da Agostino a Tommaso d’Aquino, passando per Dionigi
l’Areopagita, si rinnova la salda convinzione che una corretta teologia comporta la
consapevolezza della trascendenza divina. La cautela “apofatica” non impedisce, però, a
Tommaso d’Aquino di elaborare una ben dosata ed equilibrata teoria degli attributi divini,
che consente anche una teologia affermativa o “katafatica”. A questo scopo precisa con
nitidezza i fondamentali criteri epistemologici dell’analogia. → Teologia apofatica;
Analogia; Attributo.
B) La questione della dimostrabilità dell’esistenza di Dio
Secondo le parole di San Paolo, Dio stesso provvede a far sì che i popoli lo cerchino, in
modo tale che “arrivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano da
ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo”. Ad una mente pura e non
ottenebrata da comportamenti perversi è “manifesto” che “dalla creazione del mondo in poi
le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui
compiute, come la sua eterna potenza e divinità”52. Perciò il cristiano sa con ovvietà che
Dio esiste, perché soltanto un insensato può dire: “Dio non è”53.
La teologia cristiana afferma che le dimostrazioni della sua esistenza non sono destinate a
suscitare la fede, ma a giustificarla razionalmente davanti agli uomini, che sono enti
intelligenti e come tali, ossia consapevolmente, sono invitati a credere. Per Anselmo
d’Aosta, che si rifaceva ad Agostino, la nostra è essenzialmente una “fides quaerens
intellectum” (una fede che chiede di capire). → Fede e fideismo.
Il pensiero agostiniano e la secolare tradizione che ad esso si richiama (→ Agostinismo)
hanno una particolare predilezione sia per l’argomento delle verità eterne che per
l’argomento eudemonologico. Il primo afferma l’esistenza di Dio sulla base di quelle verità
immutabili, il cui fondamento non può che essere Dio stesso, non dipendendo esse dal
nostro arbitrio. Esso comprende in sé anche il cosiddetto argomento deontologico (dal
greco δέον, déon, che significa dovere), fondato sul riconoscimento di una legge morale, di
cui non siamo noi gli autori, ma che ci s’impone necessariamente ed è incisa nella nostra
coscienza (→ Verità eterne). L’argomento eudemonologico postula l’esistenza di Dio sulla
50
Prima lettera di Giovanni, 4, 8-16
Isaia, 45,15
Atti degli apostoli, 17, 27-28; Lettera ai Romani, 1, 20, da La Bibbia di Gerusalemme, EDB-Borla, 1974
53
Secondo il Salmo 52, 1, frequentemente citato dai teologi medioevali: “Dixit insipiens in corde suo: non est
Deus”.
51
52
43
base del nostro innato desiderio di una felicità infinita: l’oggetto presupposto da una tale
aspirazione e ad essa corrispondente è necessariamente Dio (→ Eudemonismo)54.
La prova a priori di Anselmo d’Aosta: il cosiddetto “argomento ontologico”
Anselmo d’Aosta (XI secolo), oltre a più consuete dimostrazioni dell’esistenza di Dio, nel
Proslogion elabora quella che secoli dopo Kant denominerà “ontologica”, perché deriva
dall’analisi del concetto stesso di Dio, inteso come Ens realissimum, cioè l’essere
ontologicamente perfetto, o, per usare le parole dello stesso Anselmo, “qualcosa di cui non
si può pensare nulla di più grande” (aliquid quo nihil maius cogitari potest). Secondo
l’argomentazione anselmiana, svolta nel Proslogiom, non possiamo ritenere che l’essere
perfetto sia solo nella nostra mente che lo pensa e non nella realtà. Ciò sarebbe assurdo,
perché, se così fosse, quel che pensiamo non sarebbe più l’essere supremo, ma si
rivelerebbe inferiore all’essere che, oltre che nella mente, fosse anche nella realtà. Per
evitare la contraddizione è necessario appunto affermare che ciò di cui non si può pensare
nulla di più grande è, oltre che nel pensiero, anche nella realtà.
La prova ontologica sarà variamente riproposta da altri filosofi, quali Cartesio, Spinoza (→
Sostanza; Causa sui), Leibniz e sarà difesa da Hegel contro le contestazioni kantiane. Per
Hegel, infatti, l’esistenza è una determinazione logica dell’“essenza”, che a sua volta e
fondamentalmente ne è la ragion d’essere. In particolare, riferendosi all’assoluto, egli
afferma: “Nell’ordinaria maniera di sillogizzare sembra che fondamento dell’assoluto sia
l’essere del finito: poiché v’è un finito, v’è l’assoluto. La verità invece è che perché il finito
è l’opposizione contraddicentesi in se stessa, perché esso non è, per questo l’assoluto è”55.
Tommaso d’Aquino, invece, esclude che l’esistenza di Dio sia evidente per noi e che la sua
dimostrazione possa essere derivata dalla semplice riflessione svolta sul concetto
dell’essere supremo. Infatti “questa proposizione: ‘Dio è, in quanto in sé è’, di per se stessa
è evidente, perché il predicato è identico al soggetto, nel senso che Dio è il suo essere”,
come si è soliti definirlo; tuttavia, concretamente, stando alla nostra effettiva esperienza,
“non sappiamo che cosa sia Dio”. Perciò “la proposizione, chiara di per sé, non lo è per noi,
ma è necessario dimostrarla per mezzo di quel che ci è più noto, [...] cioè per mezzo degli
effetti” della sua creazione, così come si dispiega davanti ai nostri occhi nel mondo56. La
dimostrazione non può essere svolta a priori, ma a posteriori, perché non abbiamo alcuna
conoscenza innata di Dio. → A priori / a posteriori
Le “quinque viae” di Tommaso d’Aquino
Con le “cinque vie” Tommaso ripropone le principali argomentazioni a posteriori
provenienti dalla tradizione filosofica57.
54
Si veda, per esempio, il cap. 23 del libro X delle Confessioni.
G.W.F. Hegel, Scienza della logica, a cura di A. Moni e C. Cesa, Laterza, 1974, II, p. 495
56
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 2, art. 1 c
57
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 2, art. 3 c
È stato opportunamente osservato che queste dimostrazioni, pur provenendo, almeno in parte, dall’antica
tradizione greca, nell’ottica di un cristiano concludono sempre, anche se implicitamente, con la dimostrazione di
un Dio creatore. In particolare Étienne Gilson, riferendosi alla prima prova, innanzitutto ricorda che in natura “il
moto è all’origine della generazione degli esseri e per conseguenza la causa del moto generatore è la causa degli
esseri generati”; poi rileva che, a differenza di Aristotele, per il quale “tutto è ‘dato’, e il Primo Motore, e i motori
intermediari, e il moto, e gli esseri che questo moto genera”, Tommaso d’Aquino ha ben presente il fondamento
originario della loro diversa condizione ontologica. Egli, infatti, nella Summa contra Gentiles (II, 6) afferma
esplicitamente: “Poiché noi vediamo un gran numero di esseri venire all’esistenza in conseguenza del moto del
cielo, e poiché Dio è stato dimostrato come motore primo in quest’ordine di moti, bisogna che Dio sia per tutti
55
44
La prima via, ex motu, è ritenuta “manifestior”, cioè più evidente delle altre, perché
parte dal movimento, che caratterizza universalmente la natura in maniera palese a
chiunque. Essa si rifà ovviamente all’uso che già Aristotele ne aveva fatto, per risalire al
Motore immobile, da cui il movimento originariamente parte. La prova s’impernia sulla
rilevazione che “tutto ciò che si muove è mosso da altro” (Omne quod movetur ab alio
movetur). A questo riguardo Tommaso osserva infatti che “è impossibile che sotto lo
stesso rapporto e nella stesso modo un ente sia insieme movente e mosso, cioè che si
muova da sé e passi da se stesso dalla potenza all’atto”. Orbene, nel rinvio da ciò che è
mosso a ciò che muove non ha senso un processo all’infinito, perché con ciò non si fa
che spostare in avanti l’individuazione necessaria di un motore primo, del quale
sinteticamente Tommaso dice: “et hoc omnes intelligunt Deum” (e tutti comprendono
che questo è Dio). → Divenire
La seconda via, ex causa, parte dalla constatazione che nel mondo c’è un ordine di
cause efficienti e di relativi effetti. Anch’essa s’ispira ad Aristotele e ripete lo schema
della prima prova: innanzitutto, una qualsiasi cosa in natura non può produrre se stessa,
ma la sua esistenza è l’effetto di una precedente causa; inoltre, non ha senso procedere
all’infinito nell’individuazione della serie delle cause, perché senza la causa prima e
incausata tutta la serie risulta non giustificata. → Causalità, Principio di
La terza via, ex possibili et necessario, s’ispira sia ad Aristotele sia ad Avicenna.
Tommaso osserva che gli enti del mondo non esistono necessariamente, perché nascono
e muoiono. Ora, è impossibile che tutti gli esseri esistenti siano contingenti, perché “se
ciò fosse vero, non ci sarebbe nulla nemmeno ora: perché ciò che non è, non comincia
ad essere se non in virtù di qualcosa che è”; perciò gli enti contingenti devono aver
avuto inizio da un essere che esiste di per sé, cioè necessariamente. → Contingenza.
La quarta via, ex gradibus, procede dai gradi di perfezione presenti nelle cose: più o
meno di bontà, di verità, di nobiltà. Ora, “il più e il meno si dicono di cose diverse a
seconda che si avvicinino in diversa misura ad un massimo” di bontà, di verità, di
nobiltà e “di conseguenza a ciò che è essere in grado supremo”. Tommaso osserva che
“ciò che è massimo in un genere è causa di tutto ciò che fa parte di quel genere; [...]
Dunque c’è qualcosa che nei riguardi di tutti gli enti è causa dell’essere, della bontà,
della verità e di qualsiasi perfezione: noi lo chiamiamo Dio”.
Questa prova deriva dalla tradizione platonica, in particolare dalla teoria della
“partecipazione”, che Tommaso interpreta nel senso della creazione: le creature,
partecipando dell’essere, partecipano della perfezione stessa di Dio, non nel senso di
aver parte della sua essenza, che rimane nella sua assoluta trascendenza, ma nel senso di
ricevere una condizione ontologica imperfetta e finita, che comporta una somiglianza
con lui. → Partecipazione
La quinta via, ex gubernatione rerum, parte dalla considerazione dell’ordine presente
nelle cose. È la prova teleologica, che ha origini antiche. Essa fa leva sull’osservazione
che “alcuni enti privi di conoscenza, cioè i corpi naturali, operano per un fine [...] così
da conseguire ciò che è ottimo; è perciò evidente che pervengono al fine non a caso, ma
intenzionalmente. Ora gli enti che sono privi di conoscenza, non tendono al fine se non
sono diretti da uno che ha conoscenza e intelligenza, com’è diretta una freccia da parte
dell’arciere. Dunque c’è un essere intelligente dal quale tutti gli enti naturali sono
ordinati ad un fine: noi lo chiamiamo Dio”. → Finalismo
quegli esseri la causa delle loro esistenza” (É. Gilson, Lo spirito della filosofia medioevale, Morcelliana, 1964, p.
95).
45
I rilievi critici di Blaise Pascal sulla teologia razionale
Nel secolo XVII gli strumenti logici e le argomentazioni razionali appaiono a Blaise Pascal
inefficaci a persuadere gli scettici (i “pirroniani”); tant’è che se ne avvalgono sia i non
credenti sia coloro che ritengono di poter costruire una religione naturale (→ Deismo). Dal
momento che il razionalismo a lui contemporaneo si caratterizza prevalentemente in senso
cartesiano, egli ha modo di rivolgere la sua critica a Cartesio in questi termini: “Non posso
perdonare a Descartes. Avrebbe pur voluto, in tutta la sua filosofia, poter fare a meno di
Dio; ma non ha potuto esimersi dal fargli dare un colpetto per mettere in movimento il
mondo: dopo di che, non sa che farsi di lui”. L’astratta razionalità non è in grado di
alimentare nell’uomo l’esperienza religiosa. Perciò, afferma Pascal, “non prenderò qui a
dimostrare con prove naturali l’esistenza di Dio o la Trinità o l’immortalità dell’anima, né
altre cose della stessa specie: non solo perché non mi sento abbastanza forte da trovare nella
natura di che convincere atei induriti, ma anche perché senza Gesù Cristo tale conoscenza è
inutile e sterile. [...] Il Dio dei Cristiani non è semplicemente un Dio autore delle verità
matematiche e dell’ordine cosmico: come quello dei pagani e degli epicurei. [...] Il Dio di
Abramo, il Dio d’Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei cristiani, è un Dio di amore e di
consolazione: un Dio che riempie l’anima e il cuore di coloro che possiede; un Dio che fa
loro sentire interiormente la loro miseria e la propria misericordia infinita”.
L’insoddisfazione data da una teologia solo razionale è tale che Pascal dichiara: “Il deismo
è tanto lontano dalla religione cristiana quasi quanto l’ateismo”. E, per suffragare le ragioni
di credibilità del cristianesimo, egli si affida ad una facoltà diversa dalla ragione astratta: il
“cuore”, l’esprit de finesse, cioè l’intuizione e il sentimento. E dichiara: “Il cuore, e non la
ragione, sente Dio. Ecco cos’è la fede: Dio sensibile al cuore, e non alla ragione”58. Siamo
di fronte ad un’esplicita manifestazione di misticismo e fideismo. L’argomento,
retoricamente suggestivo, da lui proposto è quello della “scommessa” (pari). →
Misticismo; Fede e fideismo
Le argomentazioni scettiche di David Hume
L’indisponibilità verso il pensiero metafisico fa sì che David Hume manifesti una netta
opposizione teoretica al pensiero religioso e al suo presupposto fondamentale, che è il
riconoscimento dell’esistenza di Dio. Per lui l’esistenza è connessa necessariamente
all’esperienza, cioè è una questione di fatto, empiricamente constatabile e non può essere
oggetto di dimostrazione logica, la quale si basa sul principio di non contraddizione. Per
dire la cosa nei termini della tradizione scolastica, l’esistenza non è dimostrabile a priori,
contrariamente a quanto hanno pensato Descartes, Spinoza e Leibniz. Nei Dialoghi sulla
religione naturale Hume così afferma: “Qualunque cosa concepiamo esistente possiamo
anche concepirla come non-esistente. Non c’è essere, quindi, la cui non-esistenza implichi
contraddizione. Di conseguenza non c’è un Essere la cui esistenza sia dimostrabile”, così da
dover percepire che “la sua non esistenza è impossibile tanto quanto che due più due non fa
quattro”. Perciò “le parole esistenza necessaria non hanno senso, o, ciò che è la stessa cosa,
non ne hanno uno coerente”59. → Essere; Esistenza; Necessità; Contingenza
L’inferenza che fa leva sui dati empirici è soltanto di tipo induttivo, congetturale e
probabilistico, ed è in grado di accreditarsi soltanto nell’ambito dell’esperienza. Su questa
base Hume ritiene di poter vanificare anche i ragionamenti dei quali pretendono di avvalersi
le tradizionali prove a posteriori dell’esistenza di Dio. Egli osserva che il linguaggio
religioso manifesta la naturale tendenza a parlare di Dio secondo criteri e forme umane.
58
59
B. Pascal, Pensieri, 51, 114, 148, trad. di P. Serini, Oscar Classici, A. Mondadori, 1976
D. Hume, Dialoghi sulla religione naturale, a cura di A. Attanasio, Einaudi, 1997, Parte IX, pp. 173-175
46
L’antropomorfismo porta a concepire il mondo come il prodotto artificiale di un artigiano o
di un architetto. Così, per esempio, sembrano pensarla anche i deisti moderni. “Guardate il
mondo che ci circonda.”, essi dicono, “Contemplate l’insieme e ciascuna parte. Non
troverete altro che una grande macchina, suddivisa in un infinito numero di macchine più
piccole, […che] si adattano l’un l’altra con una accuratezza che suscita l’ammirazione di
tutti coloro che le contemplano”. Essi ripropongono il tradizionale argomento dell’ordine
universale e del suo intrinseco finalismo: “Il preciso adeguamento dei mezzi ai fini,
riscontrabile sempre in natura, somiglia esattamente, anche se di molto superiore, alle
produzioni della inventiva, del progetto, del pensiero, della saggezza e dell’intelligenza
umane. E quindi, poiché gli effetti si somigliano l’un l’altro, siamo portati a inferire, sulla
base di tutte le regole dell’analogia, che anche le cause si assomiglino, e che l’Autore della
natura sia in qualche modo simile alla mente dell’uomo, sebbene in possesso di facoltà più
ampie, proporzionate alla grandezza dell’opera che ha realizzato”60. Diversamente dai
deisti, tuttavia, Hume si avvale delle regole dell’analogia, che egli desume dalla pratica di
coloro che usano il metodo sperimentale, contro le presunte prove a posteriori. Quelle
regole consistono nell’esigenza di riferirsi all’esperienza ripetuta e uniforme dei rapporti
causali che intervengono tra gli eventi del mondo. A questo riguardo egli afferma: “Quando
due species di oggetti sono sempre stati osservati congiunti insieme, posso inferire, per
consuetudine, l’esistenza dell’uno, ogni qualvolta vedo l’esistenza dell’altro. Questa la
chiamo una argomentazione d’esperienza. Ma può essere difficile spiegare come questo
tipo di argomentazione possa applicarsi là dove gli oggetti, come nel caso presente [ossia
l’origine del mondo], siano unici, individuali”. Pertanto al teista, che pretende di
argomentare a favore di un Dio creatore del mondo, obietta: “Si sono mai formati dei
mondi sotto i vostri occhi? E avete mai avuto il piacere di osservare l’intero sviluppo del
fenomeno, dalla prima apparizione dell’ordine fino alla sua estinzione finale? Se così,
allora citate la vostra esperienza e esponete la vostra teoria”61.
Hume, poi, mette in questione la presunta maggiore plausibilità che ci sarebbe nel
concepire la natura come un manufatto (“un orologio o un telaio per la tessitura”) piuttosto
che come un essere vivente, a proposito del quale risulterebbe invece pertinente “inferire
che la causa del mondo sia qualcosa di simile, o di analogo, alla generazione o
vegetazione”62. Gli interessa soprattutto contestare il bisogno di spiegare il mondo con la
vana complicazione di un rinvio causale ad una mente al di là di esso: “Se il mondo
materiale poggia su un mondo ideale ad esso simile, il mondo ideale deve poggiare su
qualche altro, e così di seguito, senza fine. Sarebbe meglio, quindi, non guardare mai al di
là del presente mondo materiale. Se supponiamo che esso contiene in sé il principio del suo
ordine, noi in realtà stiamo asserendo che esso è Dio”63. E poi “perché dovremmo pensare
che l’ordine è più essenziale al pensiero che alla materia? […] Sarebbe quindi saggio
limitare tutte le nostre ricerche al mondo presente, senza guardare oltre. Nessuna
soddisfazione si potrà mai ottenere da speculazioni che così tanto eccedono i limiti ristretti
dell’intelletto umano”64. Dunque, un dio trascendente il mondo, da cui il mondo
dipenderebbe, non è necessario. E si potrebbe perfino tentare un’ipotesi cosmogonica che
“non appare del tutto assurda e improbabile”, secondo la quale la materia è affidata ad “una
forza cieca e non guidata”, tale per cui “l’universo procede, per molte età, in una continua
successione di caos e disordine”, ma poi si assesta in un certo ordine, “in modo da non
60
ivi, Parte II, pp. 45-47
ivi, Parte II, p. 65 e p. 69
ivi, Parte VII, p. 139
63
ivi, Parte IV, p. 99
64
ivi, Parte IV,, p. 101
61
62
47
perdere il suo moto e la sua forza attiva”, che lo mantiene “in perpetuo cambiamento”.
Questo, afferma il nostro autore, “è proprio il caso dell’universo attuale”65.
Rileviamo infine che Hume ripropone gli antichi interrogativi epicurei riguardanti la
compatibilità di una divinità buona e potente con un mondo imperfetto, nel quale
l’esistenza degli uomini è messa a dura prova dall’insidia del male: “Le vecchie domande
di Epicuro sono ancora senza risposta. [La divinità] vuole prevenire il male, ma non ne è
capace? Allora è impotente. Ne è capace ma non vuole? Allora è malvagia. Ne è capace e lo
vuole? E allora da dove proviene il male?”66. Di fronte all’ineludibile realtà del mondo
possiamo soltanto dire che “la fonte originaria di tutte le cose è del tutto indifferente […] e
non ha maggior riguardo verso il bene rispetto al male”67.
Al di là di ogni possibile critica di tipo teoretico alla religione, lo studio humiano dei
fenomeni religiosi è comunque motivato da un oggettivo interesse, perché la religiosità è
un’importante manifestazione della natura umana. È questo il senso del titolo di un suo
scritto: Storia naturale della religione. La religione ci fa conoscere l’uomo, perché rivela le
speranze e i timori che incessantemente lo agitano. Questi pensieri non sono del tutto nuovi;
riecheggiano idee dell’epicureismo antico. È tipica, invece, della cultura illuministica la
sensibilità verso la questione dell’intolleranza e del fanatismo. Secondo Hume
l’intolleranza e il fanatismo si manifestano soprattutto nelle religioni monoteistiche, ma
sono sostanzialmente estranei al politeismo.
La critica epistemologica di Immanuel Kant
Immanuel Kant svolge la sua critica alla “teologia razionale” e alle tradizionali
dimostrazioni dell’esistenza di Dio nella Critica della ragion pura, in particolare
nell’ambito della Dialettica trascendentale. Egli rileva innanzitutto che la nozione di Dio
corrisponde all’ideale della ragion pura, cioè al modello supremo di ogni perfezione
ontologica (Ens realissimum). Procede poi riassumendo le tradizionali prove dell’esistenza
di Dio in tre tipi e criticandone l’illusoria pretesa dimostrativa, cioè evidenziandone la
fallacia dialettica (→ Dialettica).
La prova ontologica, sostenuta da Anselmo d’Aosta e poi da Cartesio, gli appare
fondamentale e ad essa riconduce anche le altre due. Essa ambisce a dedurre l’esistenza
stessa di Dio dal suo concetto di ente perfettissimo, che la include come suo primo
essenziale attributo. Come prova Kant la giudica impossibile e contraddittoria:
impossibile, perché pretende di ricavare una realtà effettiva da una semplice idea;
contraddittoria, perché implica preventivamente nell’idea dell’essere supremo
un’esistenza che si dovrebbe invece dimostrare. L’esistenza non è una proprietà logica,
ma un dato che si può soltanto constatare facendone esperienza. Infatti, sotto l’aspetto
del contenuto concettuale cento talleri reali non sono niente di più e di diverso da cento
talleri possibili.68
La prova cosmologica intende riassumere diverse prove tradizionali, ben rappresentate
dalle prime quattro delle “cinque vie” di Tommaso d’Aquino. Essa si basa sulla
distinzione ontologica tra “contingente” e “necessario” e afferma che, se qualcosa
esiste, qualcosa esiste necessariamente. Avvalendosi del principio di causa e partendo
dall’esperienza della serie causale degli enti contingenti, i quali fanno dipendere di volta
in volta da altri la loro esistenza, avanza la pretesa di trascendere l’esperienza con il
65
ivi, Parte VIII, pp. 157-161
ivi, Parte X, p. 197
ivi, Parte XI, p. 235
68
I. Kant, Critica della ragion pura, parte II, Dialettica trascendentale, libro II, cap. III, sez. IV, a cura di G.
Gentile e G. Lombardo-Radice, riveduta da V. Mathieu, Laterza, 1971, pp. 471-472
66
67
48
rinvio ad una prima causa assoluta, ad un ente incausato e necessario, ossia l’essere la
cui essenza implica l’esistenza. La critica kantiana da un lato rileva che il rapporto
causale è una modalità trascendentale (categoria e relativo principio), con cui il soggetto
pensante connette tra loro i fenomeni, e quindi non può essere utilizzato per una realtà
che oltrepassa l’esperienza; dall’altro sostiene che questa prova riproduce in termini
rovesciati l’argomento ontologico. Questo, infatti, afferma che nel concetto dell’essere
perfettissimo è compresa anche l’esistenza necessaria; la prova cosmologica, invece,
intende dimostrare che l’analisi dell’esperienza causale porta a concludere che
l’esistenza necessaria compete all’essere perfettissimo. Essa fa un uso indebito dei
concetti, dai quali pretende di far disinvoltamente scaturire delle esistenze.69
La prova fisico-teologica, cioè teleologica, fa riferimento all’ordine del mondo per
derivarlo da un’Intelligenza che l’ha predisposto e creato. È la prova per la quale Kant
dimostra maggior simpatia e della quale dice che “merita d’esser sempre menzionata
con rispetto. Essa è la più antica, la più chiara e la più adatta alla comune ragione
umana. Essa ravviva lo studio della natura, […] porta fini e scopi dove la nostra
osservazione da sé non li avrebbe scoperti, e amplia le nostre conoscenze della natura
col filo conduttore di una particolare unità, il cui principio è fuori della natura”70. Questa
prova corrisponde all’argomento fondamentale del deismo illuministico, secondo il
quale l’immanente razionalità della gran macchina del mondo, paragonata ad un
complesso orologio, è necessariamente garantita da un Supremo Orologiaio. Kant
obietta che l’ordine della natura potrebbe trovare la sua spiegazione nella natura stessa e
nelle leggi in essa immanenti. Inoltre rileva che la pretesa che la causa ordinatrice si
identifichi con la causa creatrice fa sì che l’argomento teleologico ritorni alla prova
cosmologica, la quale rinvia a sua volta a quella ontologica.
In ambito teoretico Kant non è ateo, ma agnostico, perché è convinto che la ragione umana
non possa dimostrare né l’esistenza di Dio né la sua non esistenza. Nell’ambito della ragion
pratica, invece, egli postula la sua esistenza come una delle condizioni necessarie perché
abbiano senso la legge morale e il destino etico dell’uomo. La postulazione dell’esistenza di
Dio, inteso come l’essere perfetto e onnipotente, capace di piegare la natura alle esigenze
della moralità, ossia di far corrispondere la felicità al merito, è sostenuta da una “fede
razionale”, cioè da “un bisogno” ineludibile, che ci fa dire che “è moralmente necessario
ammettere l’esistenza di Dio71. → Fede e fideismo (La fede postulatoria di Immanuel Kant)
DIRITTO, Filosofia del
La filosofia del diritto tratta dei principi giustificativi del diritto.
Il termine “diritto”, usato come aggettivo, qualifica letteralmente tutto ciò che procede in
linea retta e si oppone a ciò che è “storto”; usato come sostantivo, designa l’insieme dei
comportamenti codificati come corretti da norme o leggi, stabilite dall’autorità legittima
nell’ambito di una comunità (→ Legge). L’uso sostantivale deriva dalla voce del latino
medioevale: directum. Il latino classico, invece, si avvaleva del termine ius-iuris, che
etimologicamente sembra doversi connettere al participio passato del verbo iubeo, cioè
iussum, intendendo designare ciò che è stato comandato. Da ius deriva l’italiano “giure” e
69
ivi, cap. III, sez. V, pp. 477-478
ivi, cap. III, sez. VI, pp. 488-489
71
I. Kant, Critica della ragion pratica, Parte I, Libro II, Cap. II, 5, a cura di F. Capra, ed. rivista da E.
Garin,Laterza, 1971, pp. 152-153
70
49
le parole composte come “giusnaturalismo” (teoria del diritto naturale) e “giurisprudenza”
(la scienza del diritto).
Il diritto ha a che vedere con la “giustizia”, che è la condizione d’ordine necessaria perché
una comunità sussista e funzioni adeguatamente in rapporto ai propri fini (→ Giustizia).
Quindi l’oggetto della legge è ciò che è denominato ius non solo in quanto è iussum
(comandato), ma in quanto è iustum (giusto). A questo riguardo, tuttavia, si possono
distinguere due fondamentali impostazioni teoriche: quella del giusnaturalismo e quella del
positivismo giuridico o giuspositivismo (→ Giusnaturalismo; Positivismo giuridico). La
prima sostiene che sia giustificabile come oggetto del comando ciò che di per sé è giusto
(iussum quia iustum, cioè prescritto perché è giusto); la seconda, al contrario, sostiene che
sia competenza esclusiva di chi detiene la sovranità stabilire che cos’è giusto o ingiusto
(iustum quia iussum, cioè giusto perché è prescritto).
Fin dall’antichità il pensiero giusnaturalistico sottrasse la regolamentazione dei rapporti
umani all’arbitrio, per affidarla a dei principi assoluti e universali di razionalità e giustizia,
colti in ciò che è specifico della natura umana. A questo livello la legge si propone di far
emergere quel che è giusto per natura (φύσει δίκαιον, phýsei díkaion, secondo la dizione
greca), accreditandosi sulla base di una sostanziale dimensione etica, dal cui incondizionato
valore deduce l’obbligatorietà dell’ordine giuridico e la conseguente plausibilità del diritto
positivo, ossia del diritto effettivamente e storicamente vigente in una società. Tuttavia, ciò
non significa che il diritto s’identifichi con la morale; infatti, mentre questa riguarda
intrinsecamente l’intenzione dell’animo umano e la sua rettitudine, la funzione del diritto
consiste nel garantire la “legalità”, cioè la conformità pubblica ed esterna alla legge, come
in particolare ha ben rilevato Immanuel Kant (→ Etica).
Il positivismo giuridico, invece, vuol distinguere nettamente il diritto dall’etica,
analizzandolo non sulla base di “giudizi di valore”, che presumono di dire che cos’è giusto
o ingiusto in assoluto, ma sulla base di “giudizi di fatto”, cioè in maniera puramente
descrittiva, per evidenziare come esso funziona in una comunità. Secondo questa
impostazione, le condizioni di validità del diritto coincidono con le condizioni della sua
effettività.
Indipendentemente dall’uno o dall’altro di questi due diversi orientamenti, la concreta
esperienza giuridica porta a distinguere la legge (lex) dal diritto (ius), in particolare quando
una determinata disposizione, decisa da chi ne ha l’autorità (per esempio, un’assemblea
parlamentare), è avvertita come arbitraria e contrastante con le norme o i principi
fondamentali codificati ad un più alto livello, ad esempio dalla carta costituzionale o dalle
convenzioni che impegnano in ambito internazionale, alla cui tutela hanno il compito di
provvedere specifiche istituzioni giudiziarie di controllo, rispettivamente la corte
costituzionale o la corte competente nell’ordine sovranazionale, alle quali si accede proprio
per garantire il diritto, che è messo in discussione dalla legge contestata.
DOVERE
Il dovere si identifica con la necessità deontica (dal greco τὸ δέοn, tó déon: “il dovere”),
ossia con l’obbligatorieta imposta da una norma etica o giuridica ad una volontà libera. →
Necessità
Socrate
Nella riflessione della filosofia occidentale la coscienza del dovere emerge storicamente
come un elemento fondamentale della questione morale già con Socrate. Ce ne dà conto la
testimonianza da lui resa davanti ai suoi accusatori nella prospettiva di un’imminente
50
condanna a morte. Le accuse giudiziarie gli imputano la responsabilità di corrompere i
giovani e di non riconoscere gli dei della città. Esse appaiono semplicemente pretestuose di
fronte al suo costante ed effettivo impegno pedagogico, che comprende l’esigenza di
favorire la pietà e l’obbedienza nei riguardi degli dei, tanto che egli si sente di dover
opporre a chi le sostiene e lo sollecita a smettere di filosofare un fermo: “Obbedirò piuttosto
al dio che a voi”90. La missione, alla quale si sente vincolato, gli ha creato molte inimicizie
e difficoltà, al punto da fargli dire: “Vivo in estrema miseria per questo mio servigio del
dio”91; ma sa che ne va della sua propria dignità, perché, prosegue, “dove uno abbia
collocato se stesso, reputando quello essere il suo luogo più onorevole, o vi sia stato
collocato da chi comanda, quivi, io credo, deve rimanere, e quivi affrontare i pericoli, e
della morte non fare calcolo, né d’altro male veruno, più che della viltà e della vergogna.
[…] Sarebbe una assai singolare e strana condotta la mia se, […] qui, ordinandomi il dio,
almeno come ho potuto intendere e interpretare io quest’ordine, che dovessi vivere
filosofando e adoprandomi di conoscere me stesso e gli altri, qui, dico, per paura della
morte e d’altro simile male, avessi disertato il posto che il dio mi aveva assegnato”92.
Pertanto, questa lucida consapevolezza gli fa dire che “della morte [...] non me ne importa
proprio un bel niente; ma di non commettere ingiustizia o empietà, questo m’importa sopra
tutto”93.
Socrate non accetta nemmeno le esortazioni degli amici, di Critone in particolare, che lo
vorrebbero indurre a fuggire davanti alla morte. Accondiscendere a ciò significherebbe per
lui il misconoscimento del proprio onore di fronte alla città di Atene e a Dio. Perciò
immagina che, nell’ipotetica eventualità della sua fuga, le leggi della città gli parlino e gli
chiedano ragione di quel che va facendo: “Socrate, che cosa hai in mente di fare? non
mediti forse, con codesta azione a cui ti accingi, di distruggere noi, cioè le Leggi, e con noi
tutta insieme la città, per quanto sta in te? o credi possa vivere tuttavia e non essere
sovvertita da cima a fondo quella città in cui le sentenze pronunciate non hanno valore, e
anzi, da privati cittadini, sono fatte vane e distrutte?”94. Le leggi gli ricordano che è da esse
e dall’ordine con il quale hanno regolato la vita della città, e quindi anche l’unione tra i suoi
genitori, che egli ha ricevuto una pubblica identità e un’educazione, tanto che può ben
considerarsi loro figlio. E lo incalzano: “Sei così sapiente da avere dimenticato che più
della madre e più del padre [...] è da onorare la patria? E che la patria si deve rispettare [...]
e che, o si deve persuaderla o s’ha da fare ciò che ella ordina di fare, e soffrire se ella ci
ordina di soffrire, con cuore silenzioso e tranquillo, [...] e non bisogna abbandonare il
proprio posto [...] Se a taluno queste leggi non piacciono è libero di prendere seco le cose
sue e di andarsene dove vuole”95. Ma egli non si è mai allontanato da Atene e ha dimostrato
di essere da sempre legato alla sua città e alla disciplina delle sue regole. Perciò le sue
interlocutrici aggiungono: “T’era lecito nel corso stesso del processo, condannarti da te
all’esilio, se volevi; e ciò che mediti ora di fare contro il consenso della città, potevi allora
farlo col suo consenso. [...] E ora dunque tu te ne vai [...], se così risolvi, ingiustamente
offeso, è vero, ma non da noi offeso, dalle leggi, bensì dagli uomini [...] ricambiando
ingiustizia per ingiustizia e male per male, venendo meno ai patti e agli accordi che avevi
90
Platone, Apologia di Socrate, 29 d, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni e altri,
Laterza, 1971, vol. 1, p. 54
91
ivi, 23 c, p. 45
92
ivi, 28, d-e – 29 a, pp. 52-53.
93
ivi, 32 c-d, cit., p. 59
94
Platone, Critone, 50 b, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, vol. 1, cit., p. 88
95
ivi, 51 a-b, d, p. 90
51
con noi”96. E a Critone, che non ha più nulla da aggiungergli per convincerlo ad andarsene
da Atene, dice: “E allora lascia, o Critone; e andiamo per questa via; ché questa è la via per
cui ci conduce Iddio”97.
Nella morale socratica il richiamo alla trascendenza non contrasta con la convinzione
eudemonistica che “necessariamente beato e felice è chi agisce bene, mentre infelice è il
malvagio in quanto agisce male”98. Importante, poi, non è “vivere il più a lungo possibile”,
ma vivere bene, e “di questi due mali - commettere e subire ingiustizia - [...] maggiore è
commetterla”99.
La teoria stoica
Un apporto decisivo alla teorizzazione sistematica del dovere lo danno gli stoici in un’ottica
immanentistica. Solitamente si dice che con essi nella morale fa la sua apparizione, esplicita
e teoricamente impegnativa, la nozione del “dovere”; più correttamente si dovrebbe dire
che il termine greco τὸ καθῆκον (tò kathékon), che ricorre nella loro dottrina, significa “ciò
che conviene” alla natura di un determinato ente, il quale, di volta in volta, può essere
l’uomo, ma anche una pianta o un animale, come già Zenone aveva rilevato, secondo
quanto ci dice Diogene Laerzio100, il quale aggiunge che per gli stoici “dovere è l’azione
che, una volta compiuta, ha in sé una giustificazione razionale. [...] Esso è un atto proprio
della costituzione secondo natura”. Pertanto tò kathékon è ciò che è conforme a natura,
adeguandosi alla quale ci si realizza. → Stoicismo
Per gli stoici il fondamento normativo universale dell’agire è la natura, ed esso è
variamente configurato in relazione ai diversi enti e alle loro diverse fasi di sviluppo. Ne è
buon testimone Seneca, il quale osserva che si è generalmente convinti che “ogni animale si
adegua innanzitutto alla condizione costitutiva del suo essere (primum constitutioni suae
conciliari); ora, poiché la natura dell’uomo è razionale, egli si conforma a se stesso non in
quanto animale, ma in quanto razionale”; in particolare, “ad ogni età corrisponde una
condizione diversamente determinata per il bambino, per il fanciullo e per il vecchio”
(unicuique aetati sua constitutio est, alia infanti, alia puero, alia seni)101. Sia l’istinto che la
ragione assicurano rispettivamente all’animale e all’uomo l’autoconservazione mediante la
“tendenza ad appropriarsi” (in greco οἰκείωσις, oikéiosis, in latino conciliatio) di quanto
naturalmente all’uno e all’altro serve o, al contrario, ad evitare tutto ciò che è percepito
come dannoso. Quindi il principio fondamentale dell’etica stoica è “vivere secondo natura”,
attenendosi alla legge universale del Lógos divino, che è presente in tutte le cose.
Un’informazione di Cicerone precisa che “il dovere perfetto possiamo chiamarlo retto
(perfectum officium rectum vocemus), poiché i Greci lo chiamano κατόρθωμα
(katórthoma), ed invece chiamano καθῆκον (kathékon) il dovere comune”102.
L’originaria dottrina stoica era intransigente e sosteneva posizioni estreme. Per essa
soltanto il saggio, che conosce l’ordine del mondo, è in grado di praticare il bene, cioè di
realizzare la virtù nella sua forma eminente, e non ha propriamente bisogno di precetti,
perché è in perfetta sintonia con il Lógos, la cui presenza riconosce in sé. Egli sa che al di
fuori dell’ordine cosmico, da sempre preordinato, è vano attendersi qualcosa o nutrire
96
ivi, 52 c, 54 c, pp. 92 e 94
ivi, 54 d-e, p. 95
98
Platone, Gorgia, 507 c, trad. di F. Adorno, in Opere complete, cit., vol. 5, p. 228
99
ivi, 511 b, p. 233; 509 c, p. 231
100
Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VII, 107, in Stoici antichi, cit., vol. II, p. 1152
101
Seneca, Lettere a Lucilio, CXXI, 14-15
102
Cicerone, De officiis, I, 3
97
52
timori. Le cose che solitamente sono apprezzate dagli uomini, e perciò sono considerate
“valori” (→ Valore), come la vita, la salute, la bellezza, la ricchezza e gli onori, gli sono
indifferenti.
Questi rilievi ci permettono di capire in che senso gli stoici tendono a riservare il
semplice dovere (kathékon o officium), distinto dal katórthoma, agli uomini comuni. Infatti,
come ci documenta ulteriormente Cicerone, che a questo riguardo rivela una sensibilità più
concreta rispetto all’estremismo originario della scuola stoica, “anche se diciamo che è
bene solo ciò che è moralmente pregevole, tuttavia adempiere il dovere corrisponde alle
esigenze della nostra natura, dal momento che non mettiamo il dovere né tra i beni né tra i
mali (cum, quod honestum sit, id solum bonum esse dicamus, consentaneum tamen est fungi
officio, cum id officium nec in bonis ponamus nec in malis)”. E in ciò, egli aggiunge, va
riconosciuto che c’è “qualcosa di ragionevole e tale da poter essere giustificato” (aliquid
probabile, et quidem ita, ut eius ratio reddi possit)103.
Il pensiero cristiano
La nozione del dovere diventa ovvia nell’ambito del pensiero cristiano, che riassume “tutta
la legge e i profeti”, cioè la vita morale e religiosa, nei due comandamenti: “Amerai il
Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente” e
“Amerai il prossimo tuo come te stesso”104. Tuttavia, nello stesso tempo in cui pone questi
precetti alla base del vivere cristiano, il Vangelo si preoccupa di impedire che la morale
decada a legalismo, essendo il suo scopo fondamentale il bene dell’uomo: “Il sabato è stato
fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato”105.
Occorre, peraltro, aggiungere che il cristianesimo si propone innanzitutto come
un’esperienza di salvezza, nella quale l’iniziativa non è affidata all’impotente volontà
umana, dal momento che “tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono
giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo
Gesù”; e “indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio”106 (→ Libero
arbitrio). Ciò che il mistero cristiano intende rivelare è l’amore di Dio, che si esprime come
gratuita iniziativa redentrice. Giovanni indica esplicitamente in esso il fondamento
dell’etica cristiana: “In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che
ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. […] Dio è
amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui”107. → Cristianesimo e filosofia
Immanuel Kant
La più nota teorizzazione filosofica del dovere etico ci è data da Immanuel Kant nella
Critica della ragion pratica. Egli distingue la legge morale dagli imperativi ipotetici,
condizionati e relativi, cioè subordinati al conseguimento di determinati scopi, quali sono le
“regole dell’abilità” e i “consigli della prudenza”, la cui formulazione è così configurabile:
“Se vuoi raggiungere questo obiettivo, agisci in questa maniera”. La legge morale, invece,
si esprime nella forma di un imperativo categorico, cioè assoluto e valido di per sé, che
ogni uomo può constatare presente nella sua coscienza come un “fatto”, di cui è
assolutamente certo e che non c’è bisogno di dimostrare. Con immediata evidenza esso
implica come suo presupposto il postulato della libertà: “Devi, dunque puoi”; infatti, perché
103
Cicerone, De finibus bonorum et malorum, III, 58
Matteo, 22, 37-40
Marco, 2, 27
106
Romani, 3, 21-24
107
1 Giovanni, 4, 8-16
104
105
53
l’imperativo abbia senso, in ambito etico l’uomo deve riuscire a sottrarsi al determinismo
naturale (→ Causa noúmenon). La convinzione che ha a questo riguardo, Kant la manifesta
nel noto inno al dovere: “Dovere! nome sublime e grande, che non contieni niente di
piacevole che implichi lusinga, ma chiedi la sottomissione; che, tuttavia, non minacci niente
da cui nasca nell’animo naturale ripugnanza e spavento che muova la volontà, ma esponi
soltanto una legge che da sé trova adito nell’animo e anche contro la volontà si attira
venerazione”108. Proseguendo, poi, si chiede quale sia l’origine di quel “valore, che è il solo
che gli uomini si possono dare da se stessi”, e risponde con queste parole: “Non può essere
se non ciò che innalza l’uomo sopra se stesso (come parte del mondo sensibile) [...] Non è
altro che la personalità, cioè la libertà e l’indipendenza dal meccanismo di tutta la
natura”109.
L’imperativo categorico, secondo Kant, è unico, perché la morale non può risolversi in un
insieme di precetti particolari, in una casistica preconfezionata di situazioni, anche se
ovviamente il comportamento etico si realizza nella concretezza delle varie esperienze,
nelle quali incorriamo. Caratteristica essenziale della legge morale è, infatti, la sua
“formalità”, che prescrive in maniera universalmente valida “come” agire. Così la morale
kantiana rovescia l’ordine in cui solitamente sono disposti il bene e la legge: non è il bene
che precede e configura la legge, ma viceversa è la legge nella sua formalità che determina
quel che è bene. Ciò può apparire sorprendente, al punto che Kant stesso lo designa un
“paradosso”110.
L’imperativo categorico è un criterio regolativo pratico, che impegna chiunque; pertanto
non è una semplice “massima” soggettiva. Nella Fondazione della metafisica dei costumi
(1785) Kant ne dà tre formulazioni, di cui nella Critica della ragion pratica (1788)
mantiene soltanto la prima. Esse riguardano l’universalità della legge morale, la dignità
umana considerata come fine e mai come mezzo, l’autonomia della volontà razionale
dell’uomo. In quest’ordine testualmente le citiamo:
“Opera in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere in ogni tempo
come principio di una legislazione universale”111;
“Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro,
sempre come fine e mai semplicemente come mezzo”112;
Agisci in modo tale che “la volontà possa considerare se stessa come legislatrice in
senso universale”113.
Kant insiste sull’insufficienza di tutte le morali “eteronome”, che derivano cioè la loro
imperatività da fonti diverse dalla volontà razionale. Esse non possono pretendere di avere
una validità universale, perché fanno riferimento a qualcosa che non è in grado di imporsi
uniformemente a tutti. È il caso, per esempio, della morale teologica, valida solo per chi
crede. Perciò la razionalità è la sola condizione universale e necessaria dell’etica; non lo è
invece il sentimento (per esempio, la simpatia di cui parlano gli empiristi), che è troppo
fragile e soggettivo. Gli imperativi delle morali eteronome, derivati o dalla volontà divina o
dal sentimento o dalla ricerca della felicità (eudemonismo), del piacere (edonismo),
dell’utile (utilitarismo), sono ipotetici, cioè condizionati da finalità esterne alla pura e
108
I. Kant, Critica della ragion pratica, Parte I, Libro I, Cap. III, a cura di F. Capra, ed. rivista da E. Garin,Laterza,
1971, p. 106
109
ibidem
110
I. Kant, Critica della ragion pratica, Parte I, Libro I, Cap. II, cit., p. 78
111
I. Kant, Critica della ragion pratica, Parte I, Libro I, Cap. I, § 7, cit., p. 39
112
I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, 1990, B 66-67
113
ivi, BA 76
54
autonoma razionalità dell’uomo. L’uomo, in quanto essere razionale, è il legislatore di se
stesso. → Autonomia / Eteronomia
Max Scheler
Nell’ambito della scuola fenomenologica del Novecento Max Scheler è interessato alla
problematica dei valori e soltanto sulla base di questi ritiene che si possa parlare di
coscienza del dovere. Egli critica l’etica formale di Kant, perché gli sembra astratta e vuota.
A suo giudizio essa potrebbe essere espressa con un “devi, perché devi”, arbitrario e
incapace di giustificarsi; perciò le contrappone un’etica “materiale”. Nell’opera più
importante a ciò dedicata, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori (1916),
sostiene che il vero fondamento della morale non è il vacuo concetto di dovere, ma quei
contenuti concreti che sono i “valori”, rispetto ai quali ha senso il dovere. Non è il soggetto
umano a stabilirli, perché da lui non dipendono; egli può soltanto riconoscerli e apprenderli
attraverso un’“esperienza emozionale pura”, cioè mediante il sentimento, che è
caratterizzato da un’intrinseca intenzionalità, così come avviene per tutti gli atti della
coscienza. I valori sono oggettivi, assoluti ed eterni; la loro origine è in Dio e all’uomo si
rivelano come essenze. I valori si manifestano secondo una disposizione gerarchica, che li
distingue, oltre che in positivi e negativi, in inferiori e superiori. La scala axiologica
indicata da Scheler li ordina in questa serie: sensibili, vitali, spirituali e religiosi. Non vi
figurano i valori morali, perché il valore morale, in base al quale giudichiamo buono o
cattivo un comportamento, non ha un proprio contenuto autonomo, ma presuppone gli altri
vari valori e i loro gerarchici rapporti, in riferimento ai quali si dispongono
responsabilmente il volere e l’agire, che determinano così la propria moralità. → Valori;
Coscienza; Etica
55
E
EGUAGLIANZA
In senso matematico e in senso logico l’eguaglianza tra due o più entità è data dalla loro
reciproca sostituibilità, senza che ciò comporti mutamento.
In senso etico l’eguaglianza è considerata da Aristotele come la caratteristica essenziale
della giustizia. Egli la individua innanzitutto nella posizione intermedia tra l’eccesso e il
difetto, indicandola come il criterio generale dell’eticità e qualificandola come “l’eguale”
(τὸ ἴσον, tò íson), cioè il punto equidistante tra gli estremi, e poi nelle due specificazioni
particolari della giustizia distributiva, che corrisponde i compensi proporzionalmente ai
meriti, e della giustizia commutativa, che regola impersonalmente i contratti e gli scambi
secondo un’eguaglianza aritmetica. → Giustizia; Mesótes
L’eguaglianza è il fondamento e lo scopo della democrazia moderna (→ Democrazia).
Può essere considerata come un fatto e come un valore: come un fatto, perché pone in
rilievo ciò che accomuna tutti gli uomini, appartenendo essi ad un’unica specie, vincolata
ad uno stesso destino; come un valore, perché è indicata come un positivo impegno da
realizzare, pur essendo problematico determinare le condizioni concrete della sua
attuazione. L’esigenza etica e politica dell’eguaglianza non s’identifica affatto con la
prospettiva del conformismo, che ne è invece la contraffazione, essendo propria della
condizione umana l’individualità dei caratteri e la personalità di tutto ciò che ci distingue.
Una formulazione ben bilanciata nel rappresentare le varie istanze, sollevate dalla
questione che ci sta interessando, è data dall’art. 3 della nostra Costituzione repubblicana:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.
L’eguaglianza davanti alla legge è solitamente designata come giuridico-politica. Essa
attua ciò che letteralmente già auspicavano i greci dell’età classica con l’“isonomia”
(ἰσονομία). La moderna democrazia avverte come profondamente ingiuste le
discriminazioni giuridiche.
L’eguaglianza sociale, poi, implica il riconoscimento della pari dignità di tutti, in quanto
uomini, indipendentemente dalle loro diverse condizioni di cultura, lavoro e reddito.
Il secondo comma dell’articolo citato della costituzione tiene compresenti la libertà e
l’eguaglianza nelle loro reciproche implicazioni. È giustizia ed eguaglianza riconoscere e
garantire che a ciascuno, nello sviluppo della sua personalità, spetti ciò che gli si deve in
base ai meriti. Tuttavia, per rendere effettivo tale scopo, è compito di una comunità
democratica rimuovere gli ostacoli che impediscono agli individui, in misure e forme
diverse, di realizzare le loro potenzialità. Il principio d’eguaglianza, infatti, non impone di
dare a tutti l’eguale, ma a ciascuno ciò di cui ha bisogno.
56
EMPIRIOCRITICISMO
È il termine con il quale il tedesco Richard Avenarius (1843-1896), nel contesto della
cultura positivistica dominante nel secondo Ottocento, denominò il progetto di
riconsiderare criticamente l’esperienza (Critica dell’esperienza pura, 1890). Egli intendeva
liberarla dalle tradizionali sovrastrutture artificiose e dogmatiche del pensiero metafisico,
che la configurano impropriamente in forma dualistica, opponendo tra loro un soggetto e un
oggetto, un ambito psichico e uno fisico, e pertanto non consentono di coglierla
adeguatamente nella sua originaria unità. Con questo proposito egli pensava di adeguarsi
all’universale principio regolativo dei fenomeni naturali, da lui denominato “principio del
minimo sforzo”, secondo il quale la natura è sempre e ovunque semplice e omogenea. →
Economia, Principio di
Il progetto di Avenarius coincise in maniera indipendente con alcune posizioni
dell’epistemologia fenomenistica di Ernst Mach. → Fenomenismo
EMPIRISMO
È un termine che deriva dalla parola greca ἐμπειρία (empeiría), che significa esperienza.
Nel linguaggio comune indica per lo più un modo di fare non rigoroso, che procede
approssimativamente e per tentativi. In filosofia, invece, designa sia un atteggiamento
teoretico che generalmente privilegia le informazioni accessibili mediante i sensi, cioè i dati
empirici e i riscontri sperimentali, sia una tradizione filosofica che si sviluppò dalla fine del
Medioevo in poi soprattutto in Inghilterra e si impegnò a favorire un generale progresso
della vita civile.
Una plurisecolare presenza storica
Nell’antichità un orientamento tendenzialmente empiristico può essere colto già nel
movimento dei sofisti. Un empirismo più sistematico fu poi presente nello scetticismo
ellenistico. Non a caso Sesto Empirico (II-III secolo d. C.), la fonte più importante della
nostra conoscenza sullo scetticismo antico, ebbe l’appellativo di “empirico”. Apparteneva,
infatti, a quella scuola di medicina, per la quale nella pratica terapeutica occorre regolarsi
sulla base delle sicure indicazioni provenienti dall’esperienza e dai risultati già comprovati.
Tuttavia in un ambito filosofico più generale egli affermava che lo scettico non dogmatizza
e non dà l’assenso a ciò che non appare evidente, ma intende attenersi semplicemente ai
“fenomeni”, cioè alla realtà “quale appare” ai nostri sensi. Questo esito “fenomenistico” si
riproporrà nell’empirismo moderno.
Nel XIV secolo Guglielmo d’Ockham indicò nell’esperienza l’ambito originario e
intrascendibile della conoscenza certa e valida, in cui i dati intuitivi costituiscono il
fondamento di ogni vero sapere e il criterio di riferimento delle sue possibilità. Egli
espresse l’esigenza metodologica di sfrondare la ricerca da ingiustificabili pretese e da
inutili complicazioni logiche, per ricondurla appunto alle condizioni empiriche nelle quali è
obbligata a svolgersi. A questo scopo si avvalse del “principio di economia”, generalmente
conosciuto come il “rasoio di Ockham”: “Non sunt multiplicanda entia praeter
necessitatem” (non vanno moltiplicati gli enti oltre il necessario). → Economia, Principio
di
All’inizio del XVII secolo con Francesco Bacone assistiamo alla costruzione di un
empirismo consono alle esigenze della moderna scienza sperimentale, alla quale egli intese
contribuire mediante il rinnovamento della logica induttiva e l’organizzazione del metodo
sperimentale. → Induzione; Metodo sperimentale
57
L’empirismo si sviluppò nella forma più sistematica nel XVIII secolo con John Locke e
David Hume. Essi ebbero come proprio specifico impegno la questione gnoseologica, che
affrontarono problematizzando (Locke) o rifiutando (Hume) la tradizionale metafisica.
Inoltre l’empirismo britannico fu una componente essenziale del rinnovamento della
cultura europea prodotto dall’Illuminismo. Per dare il senso di questa affermazione,
ricordiamo che teoreticamente Hume svegliò Kant dal “sonno dogmatico” e in ambito
politico Locke espose i fondamentali criteri giustificativi di un uso liberale del potere e
dello spirito di tolleranza nella vita pubblica. → Illuminismo; Liberalismo; Tolleranza
Lo spirito dell’empirismo illuministico proseguì poi nel positivismo del XIX secolo,
favorendo le nuove prospettive di progresso aperte dalla rivoluzione industriale e lo
sviluppo delle riforme politiche e sociali. L’esponente più significativo fu John Stuart Mill,
che operò sia in ambito teoretico con una risistemazione dell’epistemologia sia in ambito
etico e politico, in cui rielaborò le tesi dell’utilitarismo di Jeremy Bentham e di suo padre
James Mill, e sostenne le esigenze di un liberalismo progressivo e democratico con i saggi
On liberty e The subjection of women. → Utilitarismo; Politica (Teorie politiche).
Nel Novecento nuovi orientamenti si ricollegarono alla tradizione dell’empirismo. Essi
sono il neoempirismo logico o neopositivismo (→ Neopositivismo) e, nell’ambito del
pragmatismo, l’“empirismo radicale” di William James (1842-1910) e lo strumentalismo di
John Dewey (→ Pragmatismo; Strumentalismo).
William James, in particolare, qualifica come radicale il proprio empirismo, perché
intende cogliere nell’“esperienza pura” la base unitaria e dinamica del reale, antecedente la
distinzione dualistica tra soggetto e oggetto. Questo dualismo, a suo giudizio, non ha nulla
di originario, ma è una configurazione derivata e secondaria, che dipende dalle diverse e
dinamiche relazioni prospettiche che la vita suscita. Nel fluire continuo dell’esperienza il
soggetto e l’oggetto sono semplici virtualità, che mutano a seconda del punto di vista di
volta in volta assunto, per cui ciò che prima era soggetto può successivamente diventare
oggetto e viceversa. La corrente (stream) dell’esperienza pura di James richiama in qualche
modo sia il fenomenismo di Avenarius e Mach, rispetto al quale, tuttavia, manifesta
incontrollate tendenze metafisiche, sia soprattutto il vitalismo di Henri Bergson e la sua
concezione dell’élan vital e della durée.
Le tesi principali della gnoseologia empiristica
Sul piano teoretico le tesi principali dell’empirismo classico sono: il rifiuto dell’innatismo,
una gnoseologia nominalistica e un fenomenismo tendenzialmente solipsistico e scettico.
Il rifiuto dell’innatismo è determinato dalla convinzione che tutto ciò che la nostra
mente elabora deriva dall’esperienza, secondo la tradizionale sentenza: Nihil est in
intellectu quod prius non fuerit in sensu (→ Esperienza; Innatismo). L’empirismo di
Locke, in particolare, ritiene inconcepibile che la mente possa avere una conoscenza
senza esserne consapevole. Egli, infatti, fa coincidere il sapere con la coscienza che si
ha dei suoi contenuti. La sua argomentazione critica nei riguardi dell’innatismo si
richiama all’ovvia e irrefutabile esperienza del mondo umano, che non consente affatto
di rilevare un universale consenso sui principi della logica, della religione e della
morale, perché le idee a questo riguardo variano molto presso i diversi popoli,
attestando spesso giudizi opposti e contrastanti. Quindi non possono essere innati. I
principi della logica risultano sconosciuti ed estranei a coloro che non li hanno appresi
o non sono in grado di avvalersene. Generalmente, poi, gli uomini sono portati ad
58
illudersi sulle convinzioni che hanno assimilato fin da piccoli e paiono loro tanto
naturali, da considerarle innate.
Anche Mill si dichiara convinto che tutte le nostre conoscenze sono di natura
empirica e che le formulazioni teoriche che le esprimono sono il prodotto di
generalizzazioni induttive. Lo stesso principio di non contraddizione è originato
dall’incompatibilità psicologica tra i due stati mentali del consentire e del dissentire e
dalla generalizzazione di quei dati elementari, reciprocamente contrastanti, che sono,
per esempio, la luce e il buio, il movimento e la quiete, il suono e il silenzio. La nostra
conoscenza ha alla sua base solo l’esperienza e questa può assumere come riferimento
di convalida soltanto se stessa.
L’adesione al nominalismo gnoseologico deriva dalla convinzione che la conoscenza
non ci dà accesso a presunte essenze delle cose, essendo i concetti pure espressioni
verbali, che corrispondono alla funzione economica e pragmaticamente utile di
sintetizzare in senso generale la pluralità delle singole esperienze. → Nominalismo;
Universali, Il problema degli
In particolare l’idea complessa di sostanza, che dalla tradizione filosofica è stata
considerata tanto importante, è il risultato di una sintesi mentale di aspetti particolari,
che l’esperienza ci presenta normalmente connessi; la sua identità unitaria è solo un
nome, che designa un aggregato di idee semplici. → Sostanza (La problematizzazione
dell’empirismo)
Anche lo spazio e il tempo sono puri nomi, che denominano rappresentazioni
derivate da generalizzazioni dell’esperienza (→ Spazio; Tempo).
La gnoseologia empiristica è tendenzialmente fenomenistica. In senso rigoroso il
fenomenismo, a cui l’empirismo giunge, sostiene che la realtà, di cui possiamo
fondatamente parlare, si riduce alle rappresentazioni che ce ne dà la nostra mente, ossia
che l’esperienza consiste in ciò che appare. Essa, infatti, non ci mette direttamente di
fronte a cose o a sostanze indipendenti e oggettive, ma ai loro fenomeni. L’essere si
riduce al suo essere percepito da un soggetto spirituale (“Esse est percipi”), secondo
George Berkeley. Questo esito della gnoseologia empiristica è solo apparentemente
paradossale, essendo effettivamente coerente rispetto alle premesse assunte dalla
gnoseologia moderna. → Fenomenismo (Gli inevitabili esiti fenomenistici e scettici
dell’empirismo moderno); Immaterialismo
Le conclusioni a cui giunge Hume sono invece sostanzialmente scettiche: l’io non è
in grado di uscire dallo scenario della propria coscienza, è confinato in se stesso, perciò
non ha la possibilità di accertarsi dell’oggettiva sussistenza di un mondo esterno. →
Solipsismo
Nell’Ottocento una forma critica di fenomenismo è rappresentata dall’epistemologia
di Ernst Mach e di Richard Avenarius. → Empiriocriticismo
EPISTEMOLOGIA
È un termine che deriva dalla composizione di parole greche: ἐπιστήμη (epistéme) e λογία
(loghía), forma astratta di λόγος (lógos). Letteralmente significa “discorso sulla scienza”. È
usato per lo più come equivalente di “filosofia della scienza”.
L’epistemologia problematizza le pretese di validità della teoresi scientifica e determina
le condizioni metodologiche generali della conoscenza e quelle specifiche delle varie
discipline.
59
L’impostazione dell’epistemologia moderna fu data da Immanuel Kant, quando
nell’introduzione alla Critica della ragion pura pose la domanda: “come” sono possibili la
matematica e la fisica? Di esse, infatti, intese analizzare preliminarmente le “condizioni di
possibilità”, perché non fossero esercitate acriticamente. → Scienza
ESISTENZA
Originariamente il significato di questo termine ne restringeva l’applicazione alle creature,
il cui essere ex-sistit, “deriva da” altro, cioè da Dio, il quale propriamente non esiste, perché
è eterno. Tuttavia esso fu usato sempre più indiscriminatamente in riferimento sia alle
creature che al creatore.
La tematizzazione di Tommaso d’Aquino
La determinazione di un ente mediante l’essenza ad Aristotele sembrava sufficiente, perché
per lui la forma era già esistenza in atto. Nella sua filosofia l’eternità della natura non
costituiva una difficoltà né egli si era mai posto il problema di un suo inizio assoluto come
creazione, ex nihilo sui et subiecti, cioè dal nulla non solo di ogni forma, ma anche della
sua base materiale47. Per Tommaso d’Aquino, invece, proprio per determinare la condizione
creaturale del mondo è opportuna e necessaria la distinzione tra essentia e actus essendi (o
esistenza), a cui, infatti, ricorre ispirandosi ad Avicenna, del quale tuttavia non accetta la
convinzione che il mondo creato sia una manifestazione necessaria ed eterna di Dio48. Da
un lato tutti gli enti naturali sono sostanze composte di materia e forma, perché tutta la
natura nel suo divenire è un perenne determinarsi di forme dal sostrato indeterminato della
materia, e così la materia e la forma, quali principi metafisici costitutivi degli enti naturali,
corrispondono rispettivamente alla potenza e all’atto riguardo alla loro essenza; dall’altro,
tuttavia, l’essenza non è di per sé data come effettivamente esistente, perché è solo
possibile (→ Contingenza). Tutti gli enti finiti, materiali e spirituali (gli angeli), sono
composti di una loro essenza e dell’esistenza: in essi l’essenza e l’esistenza (actus essendi)
corrispondono rispettivamente alla potenza e all’atto in rapporto all’effettività dell’essere.
Ogni essenza può essere pensata senza che si sappia se essa esiste o non esiste; in
particolare “posso comprendere che cosa è l’uomo o la fenice, e tuttavia non sapere se
esistano in natura; è dunque evidente che l’essere è cosa diversa dall’essenza o quiddità.
Farebbe eccezione una realtà la cui quiddità [= essenza] fosse il suo stesso essere e questa
realtà non può essere che una sola e la prima, [...] una realtà che sia soltanto essere,
cosicché l’essere stesso sia sussistente”, cioè Dio49. Dio è necessariamente ed eternamente
in virtù di ciò che è: in lui essenza ed esistenza coincidono. Egli è “a se” e “per se”, ossia
l’essere assoluto che sussiste in sé e non deve ad altri il suo essere, è Ipsum esse subsistens,
tanto che Tommaso ama interpretare in questo senso il nome con il quale Dio si è rivelato a
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 44, art. 2; q. 47, art, 1
Nell’ambito dell’insegnamento medioevale dell’Europa cristiana il primo che formula in maniera precisa questa
importante distinzione, di per sé implicita nella dottrina della creazione, è Guglielmo d’Auvergne (1180-1249),
teologo e poi vescovo di Parigi. Egli così afferma: “Quoniam autem ens potentiale est non ens per essentiam, tunc
ipsum et eius esse quod non est ei per essentiam duo sunt revera, et alterum accidit alteri, nec cadit in rationem
nec quidditatem ipsius. Ens igitur secundum hunc modum compositum est et resolubile in suam possibilitatem et
suum esse” (La citazione è presente in É. Gilson, Lo spirito della filosofia medioevale, Morcelliana, 1963, nota 3,
p. 102. Possiamo così tradurla: “Poiché per essenza l’ente potenziale è non ente, allora esso e il suo essere, che non
gli appartiene per essenza, sono in realtà due ed ha l’essere non per ciò che esso propriamente è. Pertanto l’ente è
composto e in esso si possono distinguere la sua potenzialità e la sua esistenza effettiva”).
49
Tommaso d’Aquino, L’ente e l’essenza, c. IV, in “L’ente e l’essenza” di Tommaso d’Aquino e il rapporto federagione nella scolastica, trad. di A. Bettini,a cura di G. Galeazzi, Paravia, 1991, p. 80
47
48
60
Mosè: “Dominus respondit: Ego sum qui sum. Sic dices filiis Israël: Qui est misit me ad vos
(Exod., III, 13-14)”: Dio dice di sé: Io sono colui che sono; Colui che è mi ha mandato a
voi”50. Ogni altra realtà, invece, è creata, cioè ha l’essere come qualcosa di derivato da una
causa. A questo riguardo nel De aeternitate mundi contra murmurantes Tommaso afferma:
“Esse non habet creatura nisi ab alio. Sibi relicta, in se considerata nihil est. Unde prius
naturaliter inest sibi nihil quam esse” (La creatura non ha l’essere se non da altro. Lasciata
a sé e considerata in sé, è nulla. Perciò per natura le è proprio prima il nulla dell’essere)51.
→ Ente
L’analisi di Søren Kierkegaard
A tematizzare ulteriormente la pregnanza del termine “esistenza” intervengono Søren
Kierkegaard e poi sulle sue tracce gli autori dell’esistenzialismo (→ Esistenzialismo).
Contro il dominio della logica speculativa hegeliana il filosofo danese fa dell’esistenza la
concreta condizione ontologica dell’uomo, inteso non genericamente, ma nella sua assoluta
singolarità. Infatti, considerandolo come un essere generico o una specie, Hegel gli ha tolto
la peculiarità distintiva, perché nel mondo animale la specie è la realtà più importante e
determinante, e in funzione di essa gli individui vivono e muoiono, ma solo nel genere
umano, grazie al Cristianesimo, “il Singolo è più alto del genere”52. Nell’idealismo
hegeliano l’esistenza è semplicemente una determinazione logica dell’“essenza”, che ne è il
fondamento e la ragion d’essere. In tal modo, rileva Kierkegaard, Hegel “opera sempre con
il ‘concetto’ di esistenza. Ma il concetto di esistenza è un’idealità”53, ossia un’astrattezza,
che consiste in una pura e integrale trasposizione speculativa della realtà nella dimensione
logica, cosicché “pensare l’esistenza in abstracto e sub specie aeterni è sopprimerla nella
sua essenza”54.
Inoltre Hegel misconosce la realtà finita, perché nel suo sistema dialettico la risolve nello
stesso Infinito. Per Kierkegaard, invece, c’è una differenza di assoluta trascendenza, un
abisso, tra l’umano e il divino, che solo Dio nella sua imperscrutabile gratuità creatrice e
salvifica può superare, mentre invece l’uomo è consegnato al silenzio (→ Teologia
apofatica). Di per sé l’approccio razionale all’Assoluto è destinato alla sconfitta, perché non
può che svolgersi in maniera paradossale, cioè all’insegna della contraddizione, la quale,
diversamente da quanto aveva sostenuto Hegel, non è riscattabile da alcuna mediazione
dialettica.
Fondamentale e strutturale determinazione dell’esistenza secondo Kierkegaard è la
possibilità. Essa è caratterizzata dall’angoscia e dalla disperazione. → Possibilità;
Angoscia; Disperazione
L’analisi di Martin Heidegger
La riscoperta teologica e filosofica di Kierkegaard dopo la prima guerra mondiale (si parla
a questo riguardo di una Kierkegaard-Renaissance) contribuisce in misura importante a
risvegliare nel Novecento la problematica sull’esistenza. In particolare l’analisi
dell’esistenza costituisce per Martin Heidegger l’avvio di una lunga meditazione
ontologica, che lo intratterrà tutta la vita. Diversamente da quanto avverrà negli anni
Tommaso d’Aquino, Contra Gentiles, l. I, c. 22; v. Summa theologiae, I, q. 2, art. 3
Tommaso d’Aquino, De aeternitate mundi contra murmurantes, cap. 7, in Opuscula philosophica, Marietti,
1954, p. 106
52
S. Kierkegaard, Diario, II, a cura di C. Fabro, Morcelliana, 1963, p. 33
53
S. Kierkegaard, Diario, I, a cura di C. Fabro, Morcelliana, 1962, p. 1008
54
S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica, in Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni, 1972, parte II, c. 3, §
1, p. 427
50
51
61
successivi alla “svolta” (Kehre), che determinerà nel suo pensiero un drastico
rovesciamento di prospettiva, in virtù del quale riserverà all’Essere l’iniziativa della propria
autorivelazione, nella prima grande opera Essere e tempo (1927) l’impresa analitica è
invece affidata all’uomo, unico tra tutti gli enti a potersi interrogare sull’essere. L’uomo è
designato come “Esserci” (Dasein), perché la condizione originaria che lo caratterizza è il
suo “essere-nel-mondo”. Per lui il mondo non è la semplice somma degli enti, ma è
l’orizzonte in cui gli enti appaiono; non è una cosa già data, a lui esterna e contrapposta,
perché esso non si dà senza l’uomo, che è appunto “essere-nel-mondo”. A sua volta l’uomo,
in quanto “Esserci”, si rapporta costitutivamente al “mondo”. Il “mondo”, perciò, è un
aspetto fondamentale dell’“Esserci” e l’“essere-nel-mondo” è il primo tra gli “esistenziali”,
aggettivo sostantivato con cui Heidegger denomina i caratteri strutturali dell’Esserci,
distinguendoli dalle “categorie”, che sono genericamente riferibili agli altri enti. Inoltre,
l’essere-nel-mondo dell’Esserci, come è già sempre un “essere presso le cose”, così è
anche, altrettanto costitutivamente, un “essere con gli altri” (Mitsein), per cui il mondo di
ognuno è il “mondo comune”. A differenza delle cose che sono ciò che sono, cioè semplici
presenze, l’uomo non è una realtà fissa e predeterminata, ma è esistenza, che, come aveva
già vigorosamente evidenziato Kierkegaard, è intrinsecamente caratterizzata da una
condizione di possibilità. L’ex-sistere dell’Esserci letteralmente è uno “star fuori” o al di là,
in vista di possibili trascendimenti della realtà data. Il termine “trascendenza” in Heidegger
si collega strettamente a quello di “possibilità”. La “cura” (parola di derivazione latina,
resa con il tedesco “Sorge” e presente nelle usuali espressioni: “prendersi cura delle cose” e
“aver cura degli altri”) può sintetizzare la condizione più generale e costitutiva
dell’esistenza, come lascia trasparire una citazione dello scrittore Igino (I secolo dopo
Cristo): “Cura enim quia prima finxit, teneat quamdiu vixerit” (poiché fu la Cura che per
prima diede forma all’uomo, essa lo impegni finché vive)55. “Gettato nel mondo”, l’esserci
fa del mondo l’ambito dei suoi progetti. → Cura
Altri spunti tematici, riguardanti i vari aspetti dell’esistenza, sono dati dai diversi autori del
cosiddetto esistenzialismo. → Esistenzialismo
ESPERIMENTO
È l’esperienza scientificamente controllata, consistente nella riproduzione artificiale di un
fenomeno in condizioni opportune, ossia metodicamente predisposte e strutturate, per
osservarne, identificarne e registrarne le effettive modalità di svolgimento e testare la
validità delle ipotesi che lo spiegano. → Metodo sperimentale, Formazione del
ESTETICA
Il termine “estetica” deriva dal greco αἴσθησις (áisthesis), che significa “sensazione”. Fu
introdotto nel XVIII secolo dal tedesco Alexander G. Baumgarten per designare quella
parte della gnoseologia che riguarda la conoscenza sensibile e, in senso più specifico e
nuovo, la teoria che ha per oggetto la bellezza e l’arte che la produce. Immanuel Kant
adottò il termine in entrambi i significati, rispettivamente nella Critica della ragion pura
(→ Estetica trascendentale) e nella Critica del Giudizio. A prevalere poi nell’uso fu il
secondo. Oggi, pertanto, l’estetica è strettamente connessa alla produzione artistica e alla
sua fruizione. Storicamente, però, e per molto tempo le arti (in greco τέχναι, téchnai:
55
M Heidegger, Essere e tempo, § 42, trad it. di P. Chiodi, Longanesi, 1970, p. 306
62
tecniche) non furono soprattutto e solo “le arti belle”. Alle arti infatti era primariamente
attribuita la funzione produttiva di oggetti utili, cioè destinati a soddisfare le molteplici
esigenze della vita. “Arte” era sinonimo di mestiere e professione. Per esercitarla in forme
ottimali erano necessarie la perizia e la conoscenza (→ Arte). Inoltre, occorre osservare
che, secondo la filosofia classica, della bellezza è possibile dare una giustificazione
metafisica, considerandola un aspetto costitutivo dell’essere, che i medioevali,
denominandolo pulchrum, talora qualificarono come un suo attributo trascendentale,
associandolo al bonum (→ Trascendentale). Con la svolta soggettivistica della filosofia
moderna, invece, emerge in primo piano la funzione fondamentale della coscienza, alla cui
sensibilità è affidato il giudizio “estetico”.
Immanuel Kant: i sentimenti del bello e del sublime attestano in noi la presenza di una
spirituale libertà
Kant affronta la questione estetica nella Critica del Giudizio (1790). Nella precedente
Critica della ragion pratica (1788) aveva sostenuto che la nostra destinazione etica ci
obbliga a postulare la libertà come la condizione essenziale per elevarci al di sopra del
determinismo naturale; ora intende dimostrare che questa libertà e la connessa capacità di
interpretare finalisticamente gli eventi si manifestano anche nell’ambito della natura e nelle
produzioni dell’arte, ma in forma extrateoretica, tramite il sentimento. Il sentimento è la
facoltà intuitiva che ci consente di esprimere giudizi di diverso genere rispetto a quelli
“determinanti”, con i quali l’intelletto inquadra e unifica mediante le categorie i contenuti
empirici offerti dai sensi. I “giudizi riflettenti” sono appunto gli apprezzamenti con i quali il
sentimento configura, secondo prospettive finalistiche ed esigenze di armonia, ciò che
l’intelletto ha già determinato mediante le categorie, corrispondendo così ad altre istanze
del nostro spirito. Due sono le specifiche forme del giudizio riflettente: il giudizio
“estetico” e il giudizio “teleologico”.
Kant chiama “gusto” la capacità di giudicare esteticamente e “genio” la capacità naturale
di creare la bellezza. A questo proposito afferma: “Il genio è la disposizione innata
dell’animo (ingenium), mediante la quale la natura dà la regola all’arte. [...] È il talento di
produrre ciò di cui non si può dare nessuna precisa regola; [...] di conseguenza, l’originalità
dev’essere la sua prima caratteristica. [...] I prodotti del genio devono essere anche modelli,
cioè esemplari; quindi, senza essere essi stessi frutto di imitazione, devono servire a tale
scopo per gli altri, cioè come misura e regola di giudizio. Il genio stesso non sa descrivere o
mostrare in modo scientifico come esso realizzi i propri prodotti, ma dà la regola in quanto
natura”106.
Questi concetti avranno sviluppi importanti durante il Romanticismo.
I caratteri del piacere estetico secondo Kant sono i seguenti107.
È disinteressato, perché deriva dal compiacimento sentimentale per l’immagine
dell’oggetto. È, inoltre, indipendente da ogni considerazione utilitaristica e non va
confuso con una sensazione edonistica.
È caratterizzato dall’esigenza di un consenso universale, perché chi dice che una cosa è
bella, si attende da tutti gli altri il medesimo giudizio; tuttavia non si può dimostrare
questa necessità attraverso ragionamenti, perché in questo caso saremmo di fronte ad un
giudizio logico e non estetico. Poiché non è argomentabile razionalmente, il giudizio
estetico si esprime nella forma di una tautologia: è bello perché è bello. Infatti è bello
ciò che piace “senza concetti”.
106
107
Critica del Giudizio, a cura di A. Bosi, UTET, 1993, pp. 280-81
Sono esposti nell’“Analitica del bello” .
63
È suscitato dalla rappresentazione di una finalità complessiva, non da uno scopo
concettualmente determinato, perché il bello ci dà un’impressione d’ordine e di
armonia, la quale tuttavia, se è analizzata, non lascia scorgere alcuna finalità
razionalmente definibile. È vero che Kant nel descrivere le diverse espressioni
dell’esperienza estetica distingue, accanto ad una bellezza “libera” da determinazioni
concettuali (ad esempio, un arabesco oppure un brano musicale non condizionato da
supporti testuali), una bellezza “aderente”, che noi colleghiamo funzionalmente ad
esigenze concettuali, per esempio a ciò che pensiamo di un uomo, di un cavallo, di un
edificio, ma è alla bellezza libera che più propriamente si addicono le caratteristiche
estetiche indicate dall’analisi kantiana.
L’armonia, che costituisce la “forma” dell’oggetto bello, non è una qualità della cosa
stessa, ma un sentimento interiore che il soggetto inconsapevolmente proietta
sull’oggetto. Le rappresentazioni estetiche sono create liberamente dalla facoltà
dell’immaginazione, che agisce disinteressatamente e si sottrae alla visione
meccanicistica dell’intelletto. Esse dimostrano la capacità dell’io di affermarsi al di là di
ogni limite oggettivo e tuttavia possono accordarsi con l’intelletto. Il piacere estetico
nasce dal “libero gioco” delle due facoltà108, ossia dal rapporto mediante il quale
spontaneamente si accordano e armonizzano, corrispondendo alle attese del soggetto.
Mentre il “bello” risiede nella contemplazione della forma dell’oggetto e quindi è connesso
alla sua limitatezza, il sentimento del “sublime” si ha, invece, dinanzi a ciò che è sentito
come illimitato per grandezza (sublime matematico) o per potenza (sublime dinamico).
Esso consiste in un sentimento del contrasto, non dell’armonia. Anche il sublime, tuttavia,
non è nelle cose, ma nell’uomo, il quale da un lato si sente piccolo e schiacciato dal mondo,
ma dall’altro scopre di essere superiore: quasi in un’illusione egli attribuisce alla natura
quell’infinità che propriamente è in lui, essere razionale, la cui destinazione morale supera
incommensurabilmente la realtà sensibile. L’esistenza della bellezza è per noi un segno che
esiste una dimensione di spirituale libertà oltre il determinismo della natura. → Sublime
L’estetica nel Romanticismo: J.C.F. Schiller, F.W.J. Schelling, A. Schopenhauer
Nel Romanticismo il sentimento estetico è considerato un’esperienza privilegiata rispetto a
qualsiasi altra, addirittura la più consona a conseguire la stessa verità filosofica. A questo
riguardo è significativo il diffuso consenso che i romantici esprimono nei riguardi della
Critica del Giudizio di Kant, mentre all’opposto essi sentono culturalmente lontana la
Critica della ragion pura.
Si consideri innanzitutto l’importanza del tema schilleriano dell’“educazione estetica”,
finalizzata a conciliare nell’uomo le due tendenze che in lui convivono, cioè l’impulso
sensibile e la razionalità, reciprocamente opposte, ma complementari. L’“anima bella”,
secondo Johann C.F. Schiller, è caratterizzata da un forte sentimento morale, che esalta la
“dignità” della legge, ma in un perfetto e spontaneo equilibrio con la “grazia”, ossia con lo
sviluppo armonico di tutte le facoltà umane. Nel lontano passato l’uomo si esprimeva
mediante una poesia “ingenua”, che segnalava, con immediata oggettività, un rapporto
armonico con la natura. Oggi questo è concesso solo raramente e in misura precaria; il
rapporto con la natura è solitamente indiretto, mediato dal sentimento e dalla soggettività109.
Kant ne parla nella “Deduzione dei giudizi estetici puri”, dove giustifica la pretesa del giudizio estetico a valere
universalmente, connettendola alla condizione a priori del sentimento, che accomuna tutti gli uomini.
109
Può essere utile ricordare che in una nota analisi fatta da Giacomo Leopardi si ritrova una simile distinzione tra
la poesia degli antichi (frutto dell’“immaginazione”) e la poesia dei moderni (in cui interviene la riflessione e il
“sentimento”).
108
64
Questa concezione estetica ha portato Schiller a vedere la storia stessa della civiltà come un
passaggio dalla poesia “ingenua” degli antichi alla poesia “sentimentale” dei moderni.
Caratteristica negativa della civiltà moderna è, infatti, la scissione dell’uomo in se stesso e
nella società, prodotta dalla progressiva divisione del lavoro: le specializzazioni del sapere
e dell’agire da un lato hanno generato un incremento della produttività e dell’efficienza
della specie umana, dall’altro però hanno anche creato le condizioni storiche per un
inaridimento e un impoverimento delle persone. Singole abilità vengono esaltate in maniera
unilaterale, ma a scapito di tutte le altre potenzialità, che sono destinate all’atrofia. Se la
società fa del ruolo professionale la misura dell’uomo, se in uno dei suoi cittadini valorizza
la sola memoria, in un altro l’intelligenza analitica, in un terzo l’abilità meccanica, cioè se
si vuole che tutta la cura sia rivolta ad un’unica facoltà, dalla quale ci si attende onore e
ricompensa, ci si può meravigliare che le altre facoltà dell’animo vengano trascurate?
Scrive, fra l’altro, Schiller: “Il vanto di raffinatezza e di cultura, che a buon diritto noi
facciamo valere nei riguardi di ogni altra natura semplice, non ci può valere nei confronti
della natura greca, che si appropriò di tutti i fascini dell’arte e di tutta la dignità della
sapienza, senza tuttavia esserne la vittima come la nostra. I greci non solo ci superano per
una semplicità che è estranea al nostro tempo; [...] I greci, se avessero voluto progredire
verso un più alto perfezionamento, avrebbero dovuto come noi rinunciare alla totalità del
loro essere. [...] Per quanto questo separato [= specialistico] perfezionamento delle facoltà
umane possa essere vantaggioso per la totalità del mondo, non si può negare che gli
individui che vi sono soggetti soffrono della maledizione di questo scopo mondiale. [...] La
forte tensione di singole facoltà spirituali può sì produrre uomini straordinari, ma solo
l’armonica temperanza di tutto può dare uomini felici e perfetti”110. A questo riguardo non
si può non rilevare l’affinità tematica del classicismo schilleriano con la prospettiva
marxiana di un possibile umanismo integrale nella futura società comunista (→
Comunismo).
L’“idealismo estetico” di Friedrich W.J. Schelling teorizza l’arte come la forma autentica di
rivelazione dell’Assoluto, che è identità indifferenziata di natura e spirito. L’arte, infatti, è
l’attività capace di armonizzare la natura e lo spirito. Essa è nello stesso tempo produzione
inconsapevole e spontanea, e professionalmente cosciente. Il vero artista è il “genio”, che
quando opera è soggetto ad una forza che lo ispira e lo entusiasma, ma è pure
accompagnato dall’attenzione meditata e riflessiva, dalla competenza tecnica necessaria e
dall’assimilazione delle regole operative a cui deve attenersi. L’artista e il poeta umano con
le loro particolari produzioni fanno ciò che l’Assoluto realizza con la sua attività cosmica,
riproponendo nella creazione estetica il mistero della creazione del mondo. La creazione
artistica mette in contatto diretto con l’essenza del reale. Rispetto ad essa la riflessione
filosofica interviene faticosamente in seconda istanza, perché “la visione che il filosofo si fa
artificialmente della natura è per l’arte la visione originaria e naturale”111.
Arthur Schopenhauer indica nella musica una vera e propria “metafisica in suoni”, perché
nella sua asemanticità essa esprime l’irrazionale sostanza del mondo. A tutte le arti, anche
se in diversa misura, va riconosciuta una funzione catartica, che allevia la condizione
dolorosa della nostra esistenza.
Georg W.F. Hegel e Benedetto Croce: la questione della “morte” dell’arte
J.C.F. Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, trad. it. di A. Sbisà, La Nuova Italia, 1970, pp. 1626, passim
111
F.W.J. Schelling, Sistema dell’idealismo trascendentale, in L. Pareyson, Schelling. Presentazione e antologia,
Marietti, 1975, p. 258
110
65
Georg W.F. Hegel intende distinguersi per vari aspetti dai romantici, suoi contemporanei.
In particolare non ritiene che l’arte sia l’espressione suprema dell’attività spirituale. Questo
primato spetta solo alla filosofia, la quale conosce l’assoluto nella forma adeguata del puro
concetto. L’arte, invece, lo conosce nella forma dell’intuizione sensibile, nella quale allo
spirito è dato di vivere con immediatezza la propria fusione con la natura. L’opera artistica
dà forma sensibile ad un contenuto spirituale. In essa, perciò, si assiste alla
spiritualizzazione della natura e alla naturalizzazione dello spirito.
L’arte vive e muta nei secoli, perché è un prodotto storico, che si sviluppa dialetticamente
nella successione di tre modi tipici di produzione: l’arte simbolica, l’arte classica, l’arte
romantica.
L’arte simbolica è caratterizzata da uno squilibrio tra il contenuto spirituale e la forma
sensibile, nel senso che questa è alquanto rudimentale e quello non riesce ancora a pensarsi
con sufficiente autonomia, cioè a sottrarsi all’immediata connessione con le immagini.
L’arte classica, invece, è in grado di realizzare un equilibrio armonico tra il contenuto e la
forma e di conseguire così la perfezione, cioè il risultato massimo che l’arte può dare,
perché l’arte è strutturalmente legata all’elemento sensibile. A questo riguardo Hegel
osserva che “presso i Greci l’arte fu la forma più alta in cui il popolo si rappresentò gli dei e
si diede una coscienza della verità”112.
L’arte romantica, infine, è determinata dalla consapevolezza che qualsiasi forma sensibile
è insufficiente a manifestare l’interiorità spirituale ed è perciò caratterizzata da un nuovo
squilibrio tra il contenuto spirituale e la forma sensibile. È il momento della crisi e della
“morte” dell’arte, come poi si dirà, perché ci si rende conto sempre più che la vita spirituale
richiede altre forme espressive più adeguate. Si ammira ancora l’arte e la si pratica, ma la
coscienza che essa possa essere la più alta espressione dello spirito non ci appartiene più.
Ormai l’arte “ha cessato di essere il bisogno supremo dello spirito”113.
Poiché non troverà convincente nella teoria hegeliana soprattutto questa concezione
dell’arte, Benedetto Croce, nel riproporre l’idealismo alla cultura italiana del primo
Novecento, sosterrà la “dialettica dei distinti”. Per lui, infatti, l’opposizione dialettica,
contrariamente a Hegel, è presente solo nell’ambito di ciascun grado, o forma, della realtà
(bello e brutto nell’arte, vero e falso nella filosofia, utile e inutile nell’economia, bene e
male nell’etica); perciò, la filosofia non può pretendere di “superare” dialetticamente l’arte,
dichiarandone la morte, ossia inverandola ad un livello superiore, e l’arte permane come
forma autonoma della vita spirituale: essa è “intuizione lirica”, sintesi a priori fra un
contenuto di carattere sentimentale e una forma di carattere intuitivo. L’insieme delle
diverse forme dell’attività spirituale con le loro distinte espressioni realizza l’unità dello
spirito, che in tutte continuamente e variamente vive e si arricchisce, passando dall’una
all’altra: è la “circolarità dello spirito”.
Nell’estetica crociana è stata rilevata la seguente contraddizione: da un lato, secondo la
tipica tradizione del classicismo, essa enfatizza la nozione di forma, dall’altro, invece,
trascura proprio quegli aspetti formali (le distinzioni dei generi letterari, le tecniche, i
momenti più direttamente operativi ed espressivi dell’attività artistica) che interessano le
analisi più innovative del primo Novecento. Il lavoro della critica, così com’è proposto
dall’estetica crociana, appare alquanto precario, riducendosi a distinguere in un’opera tra
“poesia e non poesia” (la cosiddetta “critica delle forbici”); esso non consente una più
robusta elaborazione discorsiva, che si dimostri in grado di cogliere la totalità dell’opera
d’arte e di apprezzarla nella complessità delle sue varie componenti. L’impostazione
112
113
G.W.F. Hegel, Estetica, a cura di N. Merker e N. Vaccaro, Einaudi, 1976, p. 120
G.W.F. Hegel, Estetica, cit., p. 121
66
crociana appare chiaramente insoddisfacente nei riguardi di quegli autori (per esempio
Dante, Leopardi, Manzoni, Pirandello), nei quali il momento artistico è indissolubilmente
legato a quello meditativo e concettuale. Se l’arte è intuizione pura, alla quale risulta
estraneo ogni contenuto intellettivo o morale, il compito del critico consisterà soltanto nel
rivivere dentro di sé con congenialità impressionistica l’intuizione dell’autore che interessa.
Paradossalmente da un lato il gusto estetico classicheggiante e l’apprezzamento per le
produzioni equilibrate e prive di asprezze impediscono a Croce di comprendere molta arte
contemporanea, contrassegnata da “laceranti inquietudini”, dall’altro però “la concezione
dell’arte come folgorazione, come operazione alogica, la ricerca del frammento poetico,
l’identificazione fra intuizione ed espressione”, tipiche del primo Novecento, trovano
“suggestioni e giustificazioni proprio nella sua estetica”114.
Umberto Eco, poi, critica come aporetica e contraddittoria l’identificazione crociana fra
intuizione ed espressione: “Imbarazzante è il discorso che Croce inizia nel capitolo sesto
dell’Estetica, dedicato all’attività teoretica e alla pratica, dove si enuncia l’incredibile
proposizione che l’intuizione-espressione dell’arte si esaurisce nell’elaborazione interna,
mentre la sua estrinsecazione tecnico-materiale, nel marmo, sulla tela, in suoni vocali
emessi, è del tutto accessoria e inessenziale, soltanto finalizzata alla ‘conservazione e
riproduzione’ dell’originario lampo interiore. Ma come? Forse che non sta parlando lo
stesso autore che cento pagine prima aveva detto che ‘si ode spesso taluni asserire di avere
in mente molti e importanti pensieri, ma di non riuscire ad esprimerli’, mentre ‘se li
avessero davvero, li avrebbero coniati in tante belle parole sonanti’? Certo, Croce può dirci
che il concretare in suoni quei pensieri è solo una necessità empirica, una trovata
stenografica, diciamo a futura memoria, per avvertire lui, o altro giudice, che quei pensieri
c’erano davvero [...]. Il fatto è che quello che Croce dice non corrisponde a quello della
pratica di altri artisti, che hanno fatto schizzi su schizzi alla ricerca dell’immagine
definitiva, o si sono affannati con squadra e compasso per realizzare il punto di fuga
perfetto”115.
Friedrich Nietzsche: l’arte è a servizio della vita
L’arte è un oggetto frequente delle considerazioni di Friedrich Nietzsche. Fin dalla prima
opera da lui pubblicata (La nascita della tragedia dallo spirito della musica, 1872) egli
ritiene che solo “la conoscenza tragica” sia adeguata al mondo di cui siamo parte; essa,
però, “per poter essere sopportata, ha bisogno dell’arte come protezione e rimedio”116. A
questo proposito guarda alla tragedia classica greca (quella di Eschilo e di Sofocle) come ad
un ben riuscito prodigio artistico, che ha combinato in un felice equilibrio l’elemento
dionisiaco, ossia l’istintività e l’inquieta oscurità delle pulsioni primitive, con la sua
trasfigurazione e sublimazione razionale, ossia l’elemento apollineo, espressione di
luminosa serenità e formale compostezza. Nietzsche intende l’arte come una forma di vita,
apprezzabile in quanto è in grado di potenziare la vita stessa; non le riconosce, quindi,
quell’autosufficienza e autonomia pretesa dall’estetismo ed espressa dalla famosa formula
di Theophile Gauthier: “l’art pour l’art”; sarebbe come “un verme che si morde la coda”. E
s’interroga: “Il più profondo istinto dell’artista tende all’arte o non piuttosto al senso
dell’arte, alla vita? a una desiderabilità della vita? - L’arte è il grande stimolante alla vita:
come si potrebbe concepirla come priva di un fine, di una meta, come ‘l’art pour l’art?’”117
114
S. Guglielmino, Guida al Novecento, Principato, 1986, p. 25
U. Eco, Croce, l’intuizione e il guazzabuglio, in Kant e l’ornitorinco, Bompiani, 1997, pp. 382-383
F. Nietzsce, La nascita della tragedia, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, vol. III/1, 1972, pp. 102-103
117
F. Nietzsce, Crepuscolo degli idoli, cit., “Scorribande di un inattuale”, § 24, a cura di G. Colli e M. Montinari,
Adelphi, vol. VI/3, 1970, p. 125
115
116
67
Essa non può mai smarrire il legame con la radice “dionisiaca” della condizione umana,
cioè con la realtà delle pulsioni vitali, dei desideri e dei sentimenti.
Henri Bergson: intuizione estetica e intuizione vitale
Secondo Henri Bergson nell’arte è possibile prefigurare l’esperienza metafisica del mondo.
Egli, infatti, è convinto che soltanto l’intuizione ci consente di comprendere la vita, così
come ci consente di realizzare l’esperienza artistica. Con l’intuizione “ci si situa all’interno
d’un oggetto per identificarsi con ciò che esso ha di unico e quindi di inesprimibile”. È ben
diversa la maniera di comprendere il personaggio di un romanzo mediante l’intelligenza
analitica, che ci fa soltanto “girare attorno all’oggetto”, dall’intuizione, che invece ci
permette di immedesimarci in esso. Perciò “lo scrittore potrà moltiplicare i tratti del suo
carattere, far parlare e agire il suo eroe quanto vuole: ma tutto ciò non potrà mai eguagliare
il sentimento semplice e indivisibile che avvertirei se coincidessi per un solo istante col
personaggio stesso. In tal caso mi apparirebbero come derivanti spontaneamente dalla loro
sorgente le sue azioni, i gesti e le parole”118. Similmente nell’esperienza metafisica si
ricerca il contatto “simpatetico” e amoroso con l’energia creatrice che fa evolvere il mondo,
cioè con l’essere assoluto, nel quale misticamente ci si immedesima.
M. Heidegger e H.G. Gadamer: il carattere veritativo dell’“esperienza estetica”
Secondo Martin Heidegger l’arte è uno degli ambiti privilegiati in cui si rivela e “si
storicizza la verità”119. Ad essa ha rivolto un’attenzione particolare nel saggio L’origine
dell’opera d’arte, presente in Sentieri interrotti. In contrasto con le tradizionali e diffuse
considerazioni estetizzanti e soggettivistiche egli afferma che “la storia dell’essenza
dell’arte occidentale non va intesa a partire dalla bellezza per sé presa, più di quanto vada
intesa a partire dall’esperienza vissuta”. Invece, “ponendosi in opera, la verità appare.
L’apparire, in quanto apparire di questo essere-in-opera e in quanto opera, è la bellezza. Il
bello rientra pertanto nel farsi evento nella verità. Non è quindi qualcosa di relativo al
piacere, quale suo semplice oggetto. Il bello riposa, sì, nella forma, ma solo perché la forma
prende luce dall’essere come ‘entità’ dell’ente”120.
Heidegger ricorre ad alcune esemplificazioni: il paio di scarpe da contadino di un famoso
quadro di Van Gogh e lo scenario del tempio greco che si erge nel mezzo di una valle
dirupata. Nel quadro prende concreta forma e si fa conoscere l’intensa vita del contadino;
nella presenza del tempio, con la statua del Dio che esso racchiude, si dispiega lo spazio
sacro di un popolo storico, con tutti i suoi interni rapporti, in cui “nascita e morte, infelicità
e fortuna, vittoria e sconfitta, sopravvivenza e rovina delineano la forma e il corso
dell’essere umano nel suo destino”121. La funzione rivelativa dell’arte ne evidenzia l’intima
essenza. Infatti, “ogni arte, in quanto lascia che si storicizzi l’avvento della verità dell’ente
come tale, è nella sua essenza Poesia. [...] Il linguaggio, nominando l’ente, per la prima
volta lo fa accedere alla parola e all’apparizione. [...] L’essenza dell’arte è la Poesia: Ma
l’essenza della Poesia è la instaurazione della verità”122. Ciò che di volta in volta appare è
un mondo storico. Esso si costruisce a partire da quel fondo di risorse, da cui l’opera
artistica attinge i materiali occorrenti e che “i Greci chiamarono originariamente ‘phýsis’.
H. Bergson, Introduzione alla metafisica, in L’“Introduzione alla metafisica”, di Bergson. Scienze e filosofia
nel pensiero del ‘900, , a cura di G. Penati, Paravia, 1994, pp. 32-33
119
M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, 1973, p.
42
120
ivi, p. 64
121
ivi, p. 27
122
ivi, pp. 56-58 passim
118
68
[...] Noi la chiamiamo la Terra”123: è la natura, che nella varietà dei mondi storici prende
forma. Pertanto “Mondo e Terra sono essenzialmente diversi l’uno dall’altro e tuttavia mai
separati. Il Mondo si fonda sulla Terra e la Terra sorge attraverso il Mondo”124.
Nell’operare artistico l’Essere fa emergere e apre “mondi” umani125, cioè totalità dotate di
senso, nel cui ambito intercorrono i rimandi tra gli elementi e tra le parti che le
compongono. L’opera d’arte è mediatrice tra “Terra” e “Mondo”126: i loro reciproci rapporti
appaiono conflittuali nella fatica che l’opera, “attizzatrice della lotta”127, richiede, per
consentire alla “Terra” e al “Mondo” “l’autoaffermazione”128; tuttavia essi sono anche
complementari, perché la valorizzazione della “Terra” e del “Mondo” può realizzarsi solo
se essi non si separano.
Heidegger osserva che nel greco antico la parola téchne (arte, tecnica) indicava ancora
quel dis-velamento del senso delle cose, che avveniva nel processo stesso della loro
produzione, la quale assecondava l’opera della natura. In quanto creazione e produzione
(póiesis), essa apparteneva all’ambito della verità, nella quale l’essere si rivela.
Etimologicamente la “pro-duzione” era “dis-velamento”. Ora invece la tecnica moderna
vede l’esclusiva e totale iniziativa dell’uomo di fronte all’ente, ormai ridotto a un “fondo”
di risorse disponibili all’illimitato sfruttamento di una pretesa dominatrice. Il dominio del
mondo mediante la tecnica è il trionfo del “nichilismo”, ossia lo smarrimento e l’oblio
dell’essere. → Tecnica
La filosofia di Hans Georg Gadamer, in particolare con l’opera Verità e metodo (1960),
prosegue lungo le tracce di Heidegger a considerare il carattere veritativo dell’“esperienza
estetica”. Nella prospettiva di costituire l’ermeneutica come una vera e propria ontologia,
Gadamer affronta innanzitutto l’analisi dell’esperienza artistica, ritenendola una tipica
esperienza di verità irriducibile ai criteri metodologici dell’epistemologia moderna, per la
quale un “soggetto” s’impegna ad indagare un “oggetto” che gli sta di fronte in maniera
tecnica, neutrale, cioè senza esserne esistenzialmente coinvolto. Egli critica l’illusoria
“coscienza estetica” dei moderni, che a partire dalla Critica del Giudizio di Kant, si è
andata configurando, sulla base del sentimento, come un mondo di “apparenze”, privo di
ogni valore “veritativo” e antitetico alla realtà della conoscenza e della scienza, che
compete invece alla ragione teoretica. In tal modo la “coscienza estetica” pensa di poter
scindere “la qualità estetica di un’opera da tutti i momenti contenutistici”, che possono, per
esempio, esigere da noi un coinvolgimento sul piano morale o su quello religioso; ma così
“si prescinde da tutto ciò in cui un’opera si radica come nel suo originario contesto
vitale”129 e si dissolve l’unità dell’oggetto artistico nella frammentazione degli Erlebnisse,
cioè dei vari momenti dell’“esperienza vissuta” (le crociane “intuizioni liriche”, si potrebbe
dire), sopprimendo “l’unità dell’opera, l’identità dell’artista con se stesso e l’identità
dell’interprete o del fruitore”130. Per Gadamer, al contrario, “l’arte è conoscenza”. Pertanto,
alla cosiddetta “coscienza estetica” contrappone l’“esperienza estetica”, che non è una fuga
onirica dal mondo da parte di un artista bohémien, sradicato o outsider, ma è un’esperienza
rivelativa dell’essere.
123
ivi, pp. 27-28
ivi, p. 34
125
ivi, pp. 30-31
126
Tra “natura” e “cultura”, potremmo dire con termini per noi più consueti.
127
M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, cit., p. 34
128
ivi, p. 42
129
H.G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. a cura di G. Vattimo, Bompiani, 1988, pp. 114-115
130
ivi, pp. 125-126
124
69
Egli in particolare si richiama alla poetica aristotelica e al suo concetto di mímesis, che è
un’attiva rappresentazione dell’essenza e “lascia da parte tutto ciò che è accidentale”, per
far emergere un senso delle cose esemplarmente potenziato rispetto all’ordinaria esperienza
quotidiana. Non per nulla per il filosofo greco la poesia è “più filosofica” della storia,
perché, diversamente da questa, che è rivolta al particolare, esprime piuttosto l’universale;
suo oggetto è il “verosimile”, perché rappresenta ciò che “perlopiù” accade131.
L’esperienza estetica è autentica esperienza di verità solo in quanto è un “evento”, che
riguarda innanzitutto l’opera stessa: chi la esegue e interpreta ne è coinvolto e vi partecipa.
Perciò “l’esperienza dell’arte è un modo di conoscenza sui generis, [...] ma tuttavia pur
sempre conoscenza, cioè partecipazione di verità”; è “un’esperienza che modifica realmente
chi la fa [...] L’esperienza implica un comprendere, ed è quindi essa stessa un fenomeno
ermeneutico”132. Come l’essenza del gioco sta nel giocare, così l’essenza dell’arte sta
nell’essere giocata, cioè eseguita e interpretata. L’opera si dà concretamente solo nelle sue
interpretazioni, che per essa non sono accidentali, ma essenziali, in quanto solo per mezzo
di esse il gioco dell’arte vive nel tempo. Quindi “l’estetica deve risolversi
nell’ermeneutica”133. Alla fruizione dell’opera d’arte, infatti, è connesso il problema più
generale dell’interpretazione, la quale richiede di evidenziare nel presente il significato di
quel che ci è trasmesso dal passato. → Ermeneutica
ETICA
È la trascrizione sostantivata dell’aggettivo greco femminile ἐθική (ethiké), che deriva dal
sostantivo ἔθος (éthos), il cui significato è: “comportamento”, “abitudine”, “modo di fare”.
I due termini greci corrispondono rispettivamente all’aggettivo moralis e al sostantivo mosmoris della lingua latina. Nell’uso linguistico della filosofia soltanto Hegel, come avremo
modo di vedere, ha ritenuto opportuno distinguere l’oggetto dell’etica dall’oggetto della
morale.
Nell’enciclopedia filosofica di Aristotele l’etica o morale costituisce, insieme alla
politica, l’ambito della “filosofia pratica”, che considera l’uomo sia nel suo agire privato
che nel suo comportamento sociale. Essa non è una scienza teoretica e al suo oggetto, cioè
il comportamento umano, si addice in generale un metodo non rigoroso, ma
“approssimativo”, e ciò che è opportuno e conveniente, in particolare la determinazione
effettiva del “giusto mezzo” (→ Mesótes), va stabilito in relazione alla varietà dei soggetti e
delle circostanze in cui questi vengono a trovarsi149.
L’etica, inoltre, non è una disciplina semplicemente descrittiva, ma valutativa, cioè non si
fonda su “giudizi di fatto”, ma su “giudizi di valore” o axiologici, che si traducono in
norme, la cui forma è quella prescrittiva del dovere. Il concetto di dovere implica
necessariamente in colui che agisce una condizione di libertà e conseguentemente la
personale responsabilità delle azioni compiute.
Tra i concetti e i temi implicati dall’etica citiamo: → Valori; Bene; Virtù; Saggezza;
Giustizia; Dovere; Legge; Coscienza; Libertà; Volontà.
Per la filosofia greca ed ellenistica l’etica è esercizio di virtù ed è orientata in senso
eudemonistico
131
ivi, pp. 146-147
ivi, pp. 128 e 131
133
ivi, p. 202
149
Aristotele, Etica Nicomachea, A 3, 1094 b – 1095 a; B 6, 1106, a 26 – b 7; B 6 1106 b 18-28
132
70
La questione dell’etica nel dibattito filosofico greco inizia pubblicamente ad emergere nel
momento in cui si mette in discussione il tradizionale convincimento di una società
aristocratica che l’ἀρετή (areté), cioè la virtù, e l’onorabilità derivano dall’esser nati da
ἄριστοι (áristoi), letteralmente, “i migliori”. La nuova παιδεία (paidéia), ossia la
formazione corrispondente ad una società che tende a farsi sempre più democratica, lega
invece l’areté e l’onorabilità al merito personale. → Paidéia
I sofisti si propongono come maestri di virtù. Essi insegnano che l’areté consiste nel far
valere la propria efficienza in vista di un successo sociale. In particolare l’abilità retorica,
espressa nell’ἀγορά (agorá) democratica, può assicurare una condizione di vantaggio nelle
pubbliche relazioni e nel confronto politico.
Socrate si distingue da essi per un diverso ordine di valori, che si concentrano nel
“prendersi cura dell’anima” e nel “conoscere se stessi”150, come già invitava a fare il dio di
Delfi, Apollo. L’anima è il centro di riferimento della responsabilità morale e ad essa è
affidata la conoscenza del bene, la basilare virtù dalla quale sono generate tutte le altre.
L’ottimismo socratico traspare dalla convinzione che inevitabilmente fa il bene colui che lo
conosce. → Intellettualismo
Il bene non è il piacere. Soltanto la giustizia (δικαιοσύνη, dikaiosýne) e la σωφροσύνη
(sofrosýne), che è insieme la saggia percezione dei propri limiti e il senso della misura,
conferiscono all’anima ordine, armonia e salute: sono esse il suo bene e da esse dipende il
suo benessere (εὐδαιμονία, eudaimonía). L’ordine etico rivela un’anima assennata “e
un’anima assennata è un’anima buona”, che “tutto quello che fa lo fa bene, virtuosamente”
e “necessariamente beato e felice è chi agisce bene, mentre infelice è il malvagio in quanto
agisce male”. Importante, poi, non è “vivere il più a lungo possibile”, ma vivere bene, e “di
questi due mali - commettere e subire ingiustizia - [...] maggiore è commetterla” 151. →
Eudemonismo
I valori a cui pensa Socrate risaltano soprattutto nelle parole di autodifesa da lui rivolte ai
suoi accusatori: “Della morte [...] non me ne importa proprio un bel niente; ma di non
commettere ingiustizia o empietà, questo m’importa sopra tutto”152. Perciò, alle
sollecitazioni dei suoi interlocutori a non infastidirli con le sue obiezioni risponde:
“Obbedirò piuttosto al dio che a voi; e finché io abbia respiro, e finché io ne sia capace, non
cesserò mai di filosofare e di esortarvi e ammonirvi [...] così: [...] non ti vergogni a darti
pensiero delle ricchezze per ammassarne quante più puoi, e della fama e degli onori; e
invece della intelligenza e della verità e della tua anima, perché diventi quanto è possibile
ottima, non ti dai affatto né pensiero né cura? [...] non dalle ricchezze nasce virtù, ma dalla
virtù nascono ricchezze e tutte le altre cose che sono beni per gli uomini”153.
L’eudemonismo convive anche con il dualismo ascetico e con la prospettiva metafisica del
destino umano, che caratterizzano la dottrina di Platone: l’immortalità dell’anima e il suo
assoggettamento ad un giudizio escatologico, che ne deciderà il destino di beatitudine o di
condanna, integrano esplicitamente le convinzioni socratiche.
150
Platone, Apologia, 30 b, cit, p. 55; Lachete, 185 e, trad. di P. Pucci, in Opere complete, cit., vol. 4, p. 165; v.
Fedone, 82 d, cit., p. 140;
Platone, Alcibiade primo, 129 a, trad. di P. Pucci, in Opere complete, cit., 1971, vol. 4, p. 46.
151
Platone, Gorgia, 507 a-c, 511 b, 509 c, trad. di F. Adorno, in Opere complete, cit., vol. 5, pp. 228, 233, 231
152
Platone, Apologia di Socrate, 32 c-d, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, vol.
1, Laterza, 1971, p. 59
153
Platone, Apologia di Socrate, 29 d-e, 30 b, cit., pp. 54 s.
71
L’eudemonismo lo si ritrova anche nell’impostazione teleologica della filosofia di
Aristotele, che identifica il bene supremo dell’uomo non con una realtà trascendente, alla
maniera di Platone, ma con l’attuazione perfetta di ciò che è peculiare della sua natura
razionale, cioè con la “virtù” (areté). Il “naturalismo” aristotelico, tuttavia, è aperto alla
trascendenza di Dio, alla beatitudine del quale il vero filosofo si ispira mediante la virtù
della sapienza. → Virtù; Sapienza
Aristotele, poi, supera decisamente l’intellettualismo socratico con un’analisi concreta e
puntuale dell’atto volitivo. → Volontà
Eudemonistiche sono pure le filosofie dell’età ellenistica, in particolare lo stoicismo e
l’epicureismo.
Lo stoicismo connette la beatitudine al principio del vivere secondo natura. La stessa
natura razionale induce l’uomo a conformarsi al proprio destino, ossia a ciò che il Lógos
universale ha previsto; ciò consente al saggio di poter conseguire il dominio totale sulla sua
emotività, cioè l’apatia. → Apatia
Nell’epicureismo l’eudaimonía è identificata con l’ἡδονή (hedoné), cioè con il piacere,
considerato, tuttavia, non indiscriminatamente, ma in base a quei criteri di saggezza, che
consigliano equilibrio e tranquillità dell’animo. È il piacere detto “catastematico”, cioè
quieto (ἡ ἡδονή καταστηματική, hedoné katastematiké).
L’etica cristiana
Secondo la dottrina cristiana l’uomo non ha più una competenza primaria sull’etica, perché
a causa del peccato non è in grado di assicurare autonomamente la realizzazione del proprio
bene. A questo riguardo San Paolo afferma perentoriamente che nessuno, né gentili né
ebrei, può presumere alcunché: “Tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio.
Infatti in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui, perché
per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. Ora invece, indipendentemente
dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio […] per mezzo della fede in Gesù Cristo, per
tutti quelli che credono. E non c’è distinzione: tutti hanno peccato e sono privi della gloria
di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per sua grazia, in virtù della redenzione realizzata
da Cristo Gesù”154. Pertanto l’uomo può essere giusto soltanto in virtù della grazia e la
morale si inscrive nell’ambito della fede e dipende dall’iniziativa salvifica di Dio, che la
teologia chiama tradizionalmente “grazia”.
L’etica cristiana intende orientare l’agire umano alla realizzazione dell’amore o carità
(ἀγάπη, agápe), nel quale si riassumono “tutta la Legge e i Profeti”155. Il Vangelo si
premura, inoltre, di richiamare all’essenzialità dell’agire morale, che consiste nella retta
intenzione del “cuore” (→ Coscienza) e rifiuta il misero legalismo e l’astratta ritualità,
come ci ricordano rispettivamente questi versetti di Marco: “Tutto ciò che entra nell’uomo
dal di fuori non può contaminarlo […invece] dal cuore degli uomini escono le intenzioni
cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia,
invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e
contaminano l’uomo”. E ancora: “Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il
sabato”156.
Confrontandosi con le dottrine etiche delle filosofie antiche, la teologia cristiana,
soprattutto nel Medioevo integra nel suo pensiero alcuni loro elementi essenziali, tra i quali,
154
San Paolo, Lettera ai Romani, 3, 19-24, da La Bibbia di Gerusalemme, EDB-Borla, 1974
Matteo, 22, 40, da La Bibbia di Gerusalemme, cit.
156
Marco, 7, 18-23; 2, 27, da La Bibbia di Gerusalemme, cit.
155
72
in particolare, l’analisi psicologica del comportamento umano e l’analisi delle virtù. →
Virtù
B. Spinoza: “Ethica more geometrico demonstrata”
Nell’età moderna c’è chi, come Baruch Spinoza, elabora un’etica more geometrico
demonstrata (dimostrata con metodo geometrico), come dice il titolo della sua opera
maggiore, uscita postuma nel 1677. Egli, infatti, intende porsi in sintonia con un
orientamento epistemologico che considera con ammirazione il rigore della geometria e
desidera vederlo applicato ad ogni disciplina, quindi anche all’etica. Spinoza rifiuta la
consueta interpretazione umanistica della natura, che incentra sull’uomo e sulle sue
aspettative l’ordine del mondo. A suo giudizio l’ordine è già da sempre determinato in
forma assoluta dall’identità della natura con Dio e ad esso la corretta ragione suggerisce di
attenersi. Quest’ordine è indifferente agli usuali giudizi di valore, che pretendono di
stabilire pregiudizialmente il bene e il male. Spinoza, perciò, vuol trattare “della natura e
delle forze degli affetti, e del potere della mente di dominarli, con lo stesso metodo
[matematico ...] come se fosse questione di linee, superfici o corpi”157.
Il geometrismo etico s’impone come l’espressione di un rigoroso razionalismo, il cui
scopo è di sottrarre l’uomo all’emotività e di impegnarlo a “non deridere, non compiangere
né disprezzare, ma capire le azioni umane” (humanas actiones non ridere, non lugere neque
detestari, sed intelligere)158, perché solo la loro corretta conoscenza razionale ci permette di
realizzare la condizione di un’effettiva libertà. Infatti il libero arbitrio, com’è
ordinariamente inteso, è un’illusione, perché non ci si può sottrarre al determinismo
universale, che riguarda anche le nostre passioni. A questo proposito l’orientamento
spinoziano sembra coincidere con l’indicazione data dall’antica etica stoica, secondo la
quale l’unico modo per non ridursi in schiavitù consiste nel comprendere l’intima ragione
dell’universale necessità e adeguarsi ad essa, come già diceva il greco Cleante, le cui parole
sono così tradotte da Seneca: “Ducunt volentem fata, nolentem trahunt”(il destino guida
colui che l’asseconda, trascina invece colui che si oppone). La nostra mente può conseguire
la perfetta beatitudine quando è in grado di guardare alla natura e a se stessa, che ne è parte,
sub specie aeternitatis, cioè nell’ottica di ciò che è eterno. → Libero arbitrio; Passione
La morale fondata sul sentimento: A. Shaftesbury, F. Hutcheson, A. Smith, D. Hume
La filosofia britannica del XVIII secolo tende ad attribuire al sentimento un ruolo
fondamentale nell’assicurare rapporti umani moralmente positivi.
L’inglese Anthony Ashley Cooper, conte di Shaftesbury (1671-1713), nel Saggio sulla
virtù e il merito (1699) nega che l’uomo sia naturalmente portato al solo egoismo, come
invece aveva pensato Hobbes; è convinto, invece, che egli dispone di un naturale “senso
morale”, che lo inclina ad avvertire intuitivamente ciò che è bene o male, cioè ad essere in
immediata sintonia con il primo e a provare ripugnanza per il secondo. Il senso morale si
rivela assai simile al senso estetico, con il quale percepiamo spontaneamente la positività di
ciò che è bello e la negatività di ciò che è disarmonico. Nei rapporti con gli altri, poi, la
moralità dell’agire deve molto al sentimento della simpatia, che ci porta a socializzare con
essi. → Senso morale
B. Spinoza, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, prefazione alla terza parte, trad. di Sossio Giametta,
Boringhieri, 1971
158
B. Spinoza, Tractatus politicus, I
157
73
Gli scozzesi Francis Hutcheson e Adam Smith sono in sintonia con la posizione di
Shaftesbury. Sia l’uno che l’altro ne ripropongono il sostanziale ottimismo.
Francis Hutcheson (1694-1747) ritiene, per es. nel Saggio sull’origine delle nostre idee
della bellezza e della virtù (1725), che con il suo innato senso morale l’uomo sia in grado di
corrispondere all’ordine che Dio ha immesso nel cosmo e sia disinteressatamente incline ad
atteggiarsi con benevolenza verso i suoi simili.
Anche Adam Smith (1723-1790) rivela un orientamento fondamentalmente ottimista, che
lo porta ad individuare nella “simpatia” un importante fattore di socializzazione. Egli,
inoltre, è convinto che le fiduciose aspettative degli individui, che operano in una libera
società, dispongano positivamente i vicendevoli rapporti e siano effettivamente cause
importanti del progresso economico e morale. In particolare, come Smith sostiene sia nella
Teoria dei sentimenti morali (1759) sia soprattutto nel capolavoro Ricerche sopra la natura
e le cause della ricchezza delle nazioni (1776), la libera iniziativa e il libero confronto
nell’ambito di un mercato non più irretito dalle soffocanti regolamentazioni della tradizione
inducono tutti a dare il meglio di sé, realizzando così la ricchezza dei popoli. In maniera
apparentemente paradossale l’interesse dei singoli, che solitamente è qualificato come
egoismo, non porta al disordine, ma ad un incremento del benessere generale, determinando
un contesto di sociale armonia, che sembra assicurata da una provvidenziale “mano
invisibile”159.
A sua volta anche lo scozzese David Hume (1711-1776) fonda la morale sul sentimento,
mediante il quale esprimiamo valutazioni di approvazione o riprovazione nei riguardi delle
azioni umane. Il sentimento morale è una forma di piacere disinteressato; infatti possiamo
apprezzare anche l’agire virtuoso di un nemico. Esso si rivela affine al gusto estetico ed
apre ad una prospettiva eudemonistica. A questo proposito, per esempio, nella Ricerca sui
principi della morale Hume afferma: “Poiché la virtù è un fine, ed è desiderabile per se
stessa, senza ricompensa e rimunerazione, soltanto per la soddisfazione che reca, è
necessario che ci sia qualche sentimento che la raggiunga, qualche gusto o sensazione
interna […] Così risultano accertati i confini precisi ed i compiti della ragione e del gusto.
La prima ci dà la conoscenza del vero e del falso; il secondo ci dà il sentimento del bello e
del brutto, del vizio e della virtù. […] Il gusto, poiché dà piacere o dolore, e fonda così la
felicità o l’infelicità, diviene un movente per l’azione ed è la fonte prima o il primo impulso
a desiderare e a volere”160.
Nel sentimento, poi, va riconosciuto il fondamento della socievolezza. Non possiamo,
infatti, restare indifferenti alla condizione di benessere o di infelicità dei nostri simili,
perché sentiamo che da essa dipende anche la nostra. Con ciò Hume non intende affatto
affermare che le norme etiche siano semplici travestimenti dell’egoismo; al contrario esse
derivano dalla “simpatia”, per mezzo della quale avvertiamo come nostre le gioie e le
sofferenze degli altri.
Questa positiva combinazione di interesse individuale e interesse sociale è un aspetto
essenziale anche dell’etica utilitaristica, che sarà poi propugnata dagli inglesi Jeremy
Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836) e dal figlio di costui John Stuart Mill
(1806-1873). Rileviamo, peraltro, che la prima formulazione del principio dell’utilitarismo,
alla quale si rifà Bentham, è di Cesare Beccaria; essa indica il fine di ogni attività morale e
159
A. Smith, Teoria dei sentimenti morali, in F. Ranchetti (a cura di), La formazione della scienza economica,
Quesnay, Smith, Say, Loescher, 1977, p. 124
160
D. Hume, Ricerca sui principi della morale, Appendice I, in Opere filosofiche, a cura di E. Lecaldano, Laterza,
1987, vol. II, p. 310
74
sociale nella “maggior felicità possibile del maggior numero possibile di individui”. →
Utilitarismo
Immanuel Kant: la formalità della legge morale
Una concezione etica rigorosamente antieudemonistica e antiutilitaristica è quella di
Immanuel Kant. Un fondamentale e coerente razionalismo presiede alla morale da lui
elaborata. Esso assegna all’autonomia della ragione umana la determinazione
dell’imperativo categorico (→ Autonomia; Dovere). Secondo Kant ciò che è essenziale
della legge morale è la sua formalità, che poi coincide con la sua universalità. Kant così la
formula: “Opera in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere in ogni
tempo come principio di una legislazione universale”161. Questa indicazione di universalità
è il generale criterio direttivo di “come” dobbiamo agire, nel senso che siamo tenuti a
comportarci così come si deve comportare ogni uomo nella nostra stessa situazione. La
morale, perciò, non è un insieme di precetti particolari, non si risolve in una “casistica”
preconfezionata di situazioni, anche se ovviamente il comportamento etico si realizza nella
concretezza delle varie condizioni empiriche dell’esistenza. Kant rovescia l’ordine in cui
solitamente sono disposti il bene e la legge: non è il bene che precede e configura la legge,
ma, viceversa, è la legge nella sua formalità che determina ciò che è bene.
Un ulteriore aspetto qualificante della morale kantiana è il suo “rigorismo”: essa propone
“il dovere per il dovere” e non riconosce come fattori di moralità le emozioni e i sentimenti.
Tra i sentimenti soltanto il “rispetto” per la santità della legge morale ha una rilevanza
etica, perché rivela il positivo influsso della ragione sulle spontanee inclinazioni della
nostra soggettività.
Kant, poi, distingue la “moralità” dalla “legalità”: questa è la semplice conformità
esteriore alla legge, quella invece è collegata all’intenzione ed è perciò una convinta
adesione della volontà alla legge (la cosiddetta “buona volontà”).
Il comportamento morale, su cui si fonda la dignità umana, non dipende dal sapere. Più
che per il scienza, l’uomo vale per il modo con cui agisce. È rimasta famosa questa
confessione personale del filosofo tedesco: “Io sono uno studioso e sento tutta la sete di
conoscere che può sentire un uomo. Vi fu un tempo in cui io credetti che ciò costituisse
tutto il valore dell’umanità. Allora io disprezzavo il popolo che è ignorante. È Rousseau che
mi ha disingannato. Quella superiorità illusoria è svanita; ho imparato che la scienza di per
sé è inutile, se non serve a valorizzare l’umanità”162. Perciò Kant afferma decisamente il
primato della ragion pratica sulla ragione teoretica. Questo primato è ulteriormente
confermato dal fatto che la ragion pratica, mediante la “fede razionale” che è in grado di
indurre in noi, ci consente di accedere in maniera postulatoria alle verità metafisiche. →
Fede e fideismo
L’idealismo etico di J.G.Fichte
Sulle tracce di Kant anche Johann Gottlieb Fichte vuol affermare il primato dell’etica, che
intende come l’espressione stessa della libertà dello spirito in opposizione al decadimento
che interviene quando, dipendendo dalle cose, ci si atteggia in maniera naturalistica e
dogmatica. La premessa metafisica di questo primato risiede nell’Io assoluto, che non va
pensato come una sostanza, ma come un’attività autocreatrice, la quale “pone” se stessa
prima di creare il mondo (il non-io). → Causa sui
161
I. Kant, Critica della ragion pratica, Parte I, Libro I, Cap. I, § 7, a cura di F. Capra, ed. rivista da E. Garin,
Laterza, 1971, p. 39
162
Citato da L. Geymonat in Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. III, Garzanti, 1971, p. 608.
75
Nell’interpretazione dialettica della filosofia fichtiana la realtà oggettiva (il non-io)
costituisce il momento negativo di opposizione all’impegno e allo sforzo volitivo dei
singoli io empirici, che tuttavia necessitano delle difficoltà e degli ostacoli per affermare e
realizzare la propria libertà. Non a caso, quindi, l’idealismo fichtiano è qualificato sia come
“soggettivo”, per l’insistenza con la quale rimarca la radicale preminenza del soggetto, sia
come “etico”, per la tensione morale che all’io è richiesta per affermare la propria attività e
autonomia. → Idealismo
G.W.F. Hegel: l’etica è superiore alla morale
Georg W.F. Hegel considera la morale kantiana del tutto insufficiente alla realizzazione
pratica dello Spirito; essa, infatti, propone il bene in termini ideali, come un dover-essere
legato alle intenzioni soggettive, cioè astrattamente, nel senso che la positività ideale
rimane permanentemente inattuata. Dalla morale, che esprime l’intenzionalità impotente del
soggetto, Hegel distingue l’etica, ossia la realizzazione effettiva del bene nelle condizioni
storico-sociali nelle quali concretamente si vive e che sono la famiglia, la società civile e
soprattutto lo Stato. L’eticità è la concreta moralità sociale, perché compone in una
superiore sintesi le unilateralità astratte del diritto, che in nome della legalità si accontenta
di assicurare un semplice ordine esterno, e della morale, la quale sembra soddisfarsi della
sola interiorità e dell’intenzione. → Idealismo
Friedrich Nietzsche: il superamento del nichilismo e la trasvalutazione dei valori
Tra il XIX secolo e XX il secolo l’attenzione della filosofia si concentra sempre più sulla
questione dei valori (→ Valore). In nome dei valori vitali, della libera autoaffermazione
dell’uomo e nella prospettiva dell’über-mensch Friedrich Nietzsche applica l’analisi
“genealogica” (in particolare nella Genealogia della morale, 1887) alla morale cristiana, di
cui intende smontare la pretesa di indicare valori trascendenti e assoluti. A suo giudizio essa
alimenta nei suoi seguaci “l’istinto del gregge”, cioè la presenza passivamente interiorizzata
di un volere autoritario. Valorizzando gli atteggiamenti di umiltà e abnegazione, si dimostra
una morale di schiavi: incapaci di esprimere la forza, la fierezza, il coraggio, la salute e la
gioia, i deboli e gli sconfitti della vita sanno solo esprimere invidia e risentimento, cioè
l’odio dell’impotenza, e interpretano come disvalori gli autentici valori vitali di una morale
creativa e libera (la morale dei signori). Ingenerando sensi di colpa nei riguardi dei
comportamenti naturali, il cristianesimo reprime gli istinti. Questi, tuttavia, quando
vengono distolti dalla loro destinazione più propria, non si annullano, ma si ritorcono
contro l’uomo, facendone un essere tormentato163. In aspra opposizione a questo destino
nichilistico (→ Nichilismo) occorre avviare la “trasvalutazione dei valori”, ossia la
reinterpretazione attiva e libera della vita e del mondo. Questo è davvero un compito
immane, al quale può far fronte soltanto l’über-mensch, ossia un’umanità rinnovata e
potenziata.
Max Weber: l’etica della convinzione e l’etica della responsabilità
Max Weber, diversamente da Wilhelm Windelband e Heinrich Rickert, rappresentanti della
cosiddetta “Scuola del Baden”, non considera i valori in maniera platonica come realtà
sovrastoriche, trascendenti e assolute (→ Valore); constata, invece, nel mondo umano un
irriducibile pluralismo etico, un “politeismo dei valori”, che rende relativi alle particolari
situazioni i giudizi e le valutazioni.
163
Questa interpretazione “genealogica” di Nietzsche anticipa per vari aspetti l’analisi psicoanalitica di Freud.
76
Egli è particolarmente interessato alla questione dell’etica politica, di cui considera
insieme la plausibilità e l’efficacia. A questo riguardo distingue l’“etica della convinzione”
dall’“etica della responsabilità”. La prima, in nome di una presunta purezza dei principi,
non intende tener conto né dei mezzi né delle conseguenze dell’agire; la seconda, invece,
induce a valutare l’efficacia dei mezzi e a farsi carico delle conseguenze delle proprie
azioni. In prima istanza Weber sembra propendere per questa, perché corrisponde al criterio
tipicamente moderno dell’“agire razionale rispetto allo scopo”; tuttavia egli pensa che la
contrapposizione tra le due non sia assoluta, com’è possibile constatare in queste sue
affermazioni: “Si rimane profondamente colpiti quando un uomo maturo, il quale senta
realmente e con tutta l’anima la responsabilità per le conseguenze e agisca secondo l’etica
della responsabilità, dice a un certo punto: ‘Non posso far diversamente, da qui non mi
muovo’ [...] Pertanto l’etica della convinzione e quella della responsabilità non sono
assolutamente antitetiche ma si completano a vicenda e solo congiunte formano il vero
uomo, quello che può avere la ‘vocazione alla politica’ [...] La politica consiste in un lento
e tenace superamento di dure difficoltà, da compiersi con passione e discernimento al
tempo stesso”164. Così considerata, la “professione” (Beruf) del politico tende ad assumere
un profilo “tragico” e il vero politico diventa un “eroe”, perché si fa consapevolmente
carico del male che le sue decisioni possono comportare. Per Weber, infatti, anche nel
moderno Stato razionale la politica comporta necessariamente l’esigenza di misurarsi con
l’efficacia della forza e della potenza e, se “i grandi modelli di carità e di bontà, siano essi
nati a Nazareth o ad Assisi o nei palazzi reali indiani, non si sono serviti del mezzo politico
della violenza”, ciò è dipeso dal fatto che “il loro regno ‘non era di questo mondo’”165.
Max Scheler: l’etica consiste nel conformare il volere e l’agire alla gerarchia dei valori
Nell’ambito della fenomenologia del Novecento Max Scheler (1874-1928) critica l’etica
formale di Kant come una morale vuota, che potrebbe essere espressa con un “devi, perché
devi”, arbitrario e incapace di giustificarsi. Ad essa contrappone un’etica “materiale”, i cui
contenuti concreti sono i “valori”, che non è il soggetto umano a stabilire, perché da lui non
dipendono; egli può soltanto riconoscerli e apprenderli. Essi, infatti, sono oggettivi, assoluti
ed eterni; la loro origine è in Dio e all’uomo si rivelano come essenze. L’uomo li
“apprende” non con l’ordinaria sensibilità empirica né con la ragione teoretica, ma
attraverso un’“esperienza emozionale pura”, cioè mediante i sentimenti, che, come tutti gli
atti della coscienza, sono caratterizzati da un’intrinseca intenzionalità. La condizione
originaria e specifica, che distingue l’uomo dagli altri enti della natura, è data dallo
“spirito” (Geist). Lo spirito non è solo intelletto, ma anche volizione e sentimento.
I valori si manifestano secondo una disposizione gerarchica, che li distingue, oltre che in
positivi e negativi, in inferiori e superiori. La scala axiologica indicata da Scheler li ordina
in questa serie: i valori sensibili, in base ai quali si contrappone il piacevole allo spiacevole;
i valori vitali, che riguardano ciò che favorisce o compromette l’efficienza biologica e si
esprimono secondo la polarità “nobile/volgare”; i valori spirituali, che possono essere
estetici, conoscitivi, giuridici, in virtù dei quali si giudica qualcosa secondo il criterio
bello/brutto, vero/falso, giusto/ingiusto; i valori religiosi, che comportano l’opposizione di
sacro/profano. Come non si possono considerare i valori dei semplici oggetti di desideri
soggettivi, così sono anche i loro rapporti gerarchici: oggettivi e assoluti. Il loro ordine è
rivelato dall’atto puro del preferire. Questo non va confuso con la scelta, che eventualmente
164
M. Weber, Il lavoro intellettuale come professione - La politica come professione, trad. di A. Giolitti, Einaudi,
1971, p. 119
165
ivi, p. 116
77
lo segue. Il valore morale, in base al quale giudichiamo buono o cattivo un comportamento,
non ha un proprio contenuto autonomo, ma presuppone i vari valori e i loro gerarchici
rapporti, in riferimento ai quali si dispongono responsabilmente il volere e l’agire, che
determinano così la propria moralità.
Hans Jonas: l’etica della responsabilità di fronte al sopravanzamento del potere della
tecnica
Sulle orme di Weber, Hans Jonas ripropone alla riflessione filosofica “il principio
responsabilità”, da far valere con la necessità urgenza nell’attuale tempo storico. L’umanità
contemporanea, tecnologicamente potente, sembra ormai diventata un “Prometeo
scatenato”, non sufficientemente consapevole delle conseguenze che l’attendono e che essa
stessa ha determinato, costruendo la civiltà in cui vive. A poter salvare l’uomo c’è soltanto
la sua responsabilità morale di fronte al futuro. Pertanto, a questo riguardo Jonas scrive:
“Pur non essendo certo un fenomeno nuovo in ambito morale, la responsabilità non ha mai
avuto un tale oggetto e finora anche la teoria etica se ne è occupata poco. Sia il sapere che il
potere erano troppo limitati per includere il futuro più lontano nelle previsioni e addirittura
il globo terrestre nella coscienza della propria causalità. Anziché interrogarsi oziosamente
sulle remote conseguenze in un destino ignoto, l’etica si è concentrata sulla qualità morale
dell’atto momentaneo stesso, nel quale il diritto del prossimo che condivide la nostra sorte
ha da essere rispettato. Nel segno della tecnologia, però, l’etica ha a che vedere con azioni
(sia pure non più del soggetto singolo) che hanno una portata causale senza eguali,
accompagnate da una conoscenza del futuro che, per quanto incompleta, va egualmente al
di là di ogni sapere precedente. A ciò si aggiunge la scala delle conseguenze a lungo
termine e spesso anche la loro irreversibilità. Tutto ciò pone la responsabilità al centro
dell’etica, con orizzonti temporali e spaziali corrispondenti appunto a quelli delle azioni”166.
→ Tecnica
EVIDENZA E CERTEZZA
Il termine “evidenza” designa etimologicamente la condizione di “piena visibilità” di
qualcosa, che va ovviamente intesa in senso metaforico in riferimento agli “occhi” della
mente.
La nozione di evidenza comporta due aspetti inscindibilmente interconnessi: il primo è
dato dalla chiarezza con la quale un oggetto si rivela, distinguendosi dagli altri; il secondo
consiste nella necessaria implicazione di un soggetto (la coscienza), al quale quell’oggetto
nitidamente appare e che, perciò, non può non dare il suo assenso, dichiarandosene certo. In
questo senso la certezza è la naturale conseguenza dell’evidenza: è lo stato di soggettiva
convinzione, in virtù del quale dichiariamo qualcosa dell’oggetto, che si palesa nella sua
verità. → Criterio di verità
Il criterio veritativo dell’evidenza nella filosofia antica
Nella filosofia antica l’evidenza caratterizza intrinsecamente già le idee platoniche. La
parola italiana “idea” corrisponde direttamente al termine greco ἰδέα (idéa) e al suo
equivalente εἶδος (eîdos): entrambi derivano dalla radice dello stesso verbo ἰδεῖν (ideîn),
che significa “vedere” e designano “ciò che si vede” di una cosa, cioè la “forma”, la quale
tuttavia non è il suo aspetto superficiale offerto ai sensi, ma la sua realtà più fondamentale e
H. Jonas, Prefazione a Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P. Portinaro,
Einaudi, 1990, p. XXVIII
166
78
vera, che solo l’intelletto può scorgere. L’idea platonica, perciò, designa in senso
ontologico la natura essenziale di un ente.
L’evidenza è di per sé e originariamente criterio e garanzia di verità e di certezza. Ancor
prima di Platone, Parmenide aveva parlato dell’intima connessione tra l’ἀλήθεια, cioè la
verità, intesa come l’oggettiva trasparenza dell’essere, e la νόησις (nóesis), cioè l’attività
pensante che le aderisce, identificandosi con essa: “È la stessa cosa pensare e pensare che è:
/ perché senza l’essere, in ciò che è detto, non troverai il pensare”186. In greco il termine
ἀλήθεια designa etimologicamente il rivelarsi di una cosa, che ormai non si sottrae più alla
nostra vista. A tale riguardo si veda la voce → Verità
Aristotele, poi, rileva in particolare l’evidenza di quei principi che chiama “assiomi”. Essi
sono enunciati non dimostrati, ma accolti comunque immediatamente come veri in virtù
della loro intrinseca auto-evidenza, perché “elementi veri e primi sono quelli che traggono
la loro credibilità non da altri elementi, ma da se stessi: di fronte ai principi delle scienze
non bisogna infatti cercare ulteriormente il perché, e occorre invece che ogni principio sia
per se stesso degno di fede”187. In greco la parola “assioma” (aksíoma) significa
letteralmente “ciò che è degno di considerazione”, “ciò che è ritenuto giusto e valido”. →
Assioma
L’evidenza, come norma o criterio di verità, è al centro anche dell’analisi gnoseologica
dell’epicureismo e dello stoicismo.
Secondo gli epicurei, per accertare la verità o l’errore delle opinioni, occorre riportarsi
all’esperienza diretta delle cose, alla loro evidenza sensibile. → Canonica
A loro volta gli stoici individuano nella rappresentazione “catalettica” la condizione non
problematica, perché evidente, alla quale ci sentiamo di dare il nostro assenso. Per mezzo di
essa il nostro intelletto ritiene di “comprendere” l’oggetto, come se lo tenesse in pugno.
Secondo quanto dice Cicerone, lo stoico Zenone la raffigurava con il gesto della mano che
si chiude in una presa progressiva: “Mostrando all’interlocutore in faccia la mano aperta
con le dita tese, diceva: ‘la rappresentazione è così’. Poi, contraendo un poco le dita:
‘l’assenso è così’. Stretta poi la mano a pugno, diceva: ‘questa è la comprensione’ e proprio
da questo paragone fu indotto a dare a questa un nome che prima non esisteva: κατάληψις
(katálepsis), che significa “presa”. Accostata poi alla destra la sinistra, e con questa
afferrato fortemente e compresso ad arte il pugno chiuso, diceva che quella era la scienza, e
che era cosa tale che nessuno, fuorché il sapiente, poteva rendersene padrone”188. →
Catalettica, rappresentazione
La regola metodica dell’evidenza nella filosofia cartesiana
Nell’età moderna Renato Cartesio indica nel criterio dell’evidenza la regola prima di un
metodo rigoroso, che occorre universalmente applicare all’uso della nostra ragione. Così lo
formula, impegnandosi personalmente a rispettarlo: “Non accettare mai per vera nessuna
cosa che non conoscessi con evidenza esser tale: [...] cioè non comprendere nei miei giudizi
se non ciò che si fosse presentato alla mia mente con tale chiarezza e distinzione da non
Parmenide, “Frammenti”, DK B 8, vv. 38-40, da I Presocratici, Testimonianze e frammenti, a cura di G.
Giannantoni, Laterza, 1975, vol. I, p. 276
187
Aristotele, Topici, I (A), 1, 100 b 18-21, trad. di G. Colli, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973,
vol. 2, p. 5
188
Cicerone, Academica priora, II, 144, in Stoici antichi, a cura di M. Isnardi Parente, UTET, 1989, vol. I, p. 152
186
79
aver nessun motivo di metterlo in dubbio”189. Delle quattro regole metodiche, da lui date,
questa è la fondamentale, nel senso che le altre conseguono da essa necessariamente. Infatti
soltanto di un’idea evidente, cioè chiara e distinta, è possibile fare l’analisi, ricondurre poi
all’inverso, mediante la sintesi, i vari aspetti o elementi all’unità originaria, e poter infine
rassicurarci, in una revisione generale, di non aver tralasciato nulla nei nostri ragionamenti.
→ Cartesianesimo; Metodo
La regola dell’evidenza sottende il riferimento ineludibile ad un soggetto pensante, al
quale qualcosa risulta evidente; in essa, perciò, è già implicita la connessione con il punto
d’Archimede di tutto il sistema cartesiano, cioè con la sua verità prima: la consapevolezza
indubitabile della mia esistenza in quanto penso (cogito, ergo sum). A sua volta, poi, e
all’inverso, la verità indubitabile del “cogito” si presta all’attenzione di Cartesio come il
fondamentale riferimento giustificativo della validità della prima regola metodica. Così egli
ne dà conto: “Avendo notato che nella proposizione io penso dunque sono ciò che mi fa
certo che non mi inganno consiste soltanto nel fatto che intendo con gran chiarezza che per
pensare bisogna essere, pensai di poter assumere come regola generale che son tutte vere le
nozioni che concepiamo in modo del tutto chiaro e distinto”190.
Cartesio, inoltre, chiama in causa la stessa veracità divina per fondare metafisicamente
ancora una volta, insieme a tutta la nostra conoscenza, la validità stessa del criterio
veritativo dell’evidenza. Nel Discorso sul metodo lo esprime in questi termini: “Quella
stessa affermazione che poc’anzi ho assunto come regola, cioè che son vere tutte le cose
che concepiamo in modo del tutto chiaro e distinto, è certa solo in quanto Dio è o esiste ed
è un essere perfetto e tutto quanto è in noi viene da lui”191. Al di là della possibile
obiezione, avanzata già da Antoine Arnauld, che il complesso ragionamento cartesiano
comporti una circolarità viziosa, nel senso che la nozione chiara e distinta di un Dio
perfetto e veritiero è invocata a garantire la validità della prima regola metodica, dopo che
di essa ci si è avvalsi per dimostrare la sua esistenza, nelle parole di Cartesio si può anche
cogliere un’implicita concezione volontaristica, secondo la quale la verità e la sua evidenza
dipendono da quanto ha disposto l’assoluta volontà divina. → Volontarismo
Dopo Cartesio questo appello teologico non avrà più grande importanza e il criterio
dell’evidenza, sia nella considerazione di David Hume che in quella di Immanuel Kant,
tornerà a garantirsi da sé in riferimento alle verità logiche o analitiche, fondate sul principio
di non contraddizione. → Analitici / sintetici, giudizi
E. Husserl: intuizione eidetica e rifiuto dello psicologismo
Nel Novecento Edmund Husserl vuol riprendere da Cartesio il tema del cogito e
riconsiderare, sulla base dell’intenzionalità della coscienza, la funzione fenomenologica
della filosofia, alla quale assegna appunto il compito di descrivere i fenomeni, ossia ciò che
con rigorosa obiettività si manifesta all’intuizione della coscienza: sia i dati particolari che
emergono nel vissuto, riferiti a determinati oggetti, sia le essenze ideali o concetti
universali, che la coscienza coglie mediante un’“intuizione eidetica” (= visione delle idee).
Nei riguardi di questa coscienza, intenzionalmente orientata alle essenze ideali, egli
rivendica l’evidenza apodittica, che considera propria del sapere scientifico. A tale scopo
critica lo psicologismo, ossia l’orientamento tipico dell’empirismo, in particolare di John
Stuart Mill, che lui stesso aveva condiviso in una sua giovanile ricerca rivolta alla
conoscenza matematica (Filosofia dell’aritmetica, 1891), nella quale connetteva i concetti
R. Cartesio, Discorso sul metodo, Parte seconda, trad. di E. Lojacono per conto dell’editrice UTET, in Il
“discorso sul metodo” di Cartesio e il problema del metodo nel XVII secolo, cit., p. 57
190
R. Cartesio, Discorso sul metodo, cit., Parte quarta, p. 74
191
R. Cartesio, Discorso sul metodo, cit., Parte quarta, p. 79
189
80
di tutto, parte, unità, pluralità e numero ad elementari operazioni della mente. A
convincerlo a mutare atteggiamento teoretico erano stati anche gli appunti critici del
logicista Friedrich Frege (→ Matematica, Filosofia della). In seguito a questa esperienza
Husserl distingue ormai nettamente l’atto psichico del pensare dai contenuti intenzionati dal
soggetto pensante, ma teoreticamente valutabili soltanto nella loro oggettività ideale e in
rapporto alla loro natura logica di concetti “in sé”, proposizioni “in sé”, ragionamenti “in
sé”, indipendentemente dal fatto di essere pensati da qualcuno. Quindi invita ad applicare
criticamente, contro il dogmatismo della coscienza ingenua, il metodo dell’epoché, e
assicurare così la funzionalità di una coscienza “trascendentale”, capace di intuire i suoi
oggetti in una forma universale. → Fenomenologia; Epoché; Psicologismo
L’evidenza è un criterio logico o psicologico?
In ambito logico-matematico l’interpretazione convenzionalistica delle geometrie non
euclidee induce, diversamente dall’intuizionismo assolutistico e pretenziosamente
apodittico della fenomenologia husserliana, ad una rimozione del tradizionale criterio
dell’evidenza, che era stata posta fin dall’antichità alla base dell’assiomatizzazione della
geometria euclidea. Ormai l’evidenza è considerata non più un criterio logico, ma soltanto
psicologico del processo dimostrativo, e la nozione di assioma è del tutto equiparata a
quella di postulato, perché è fatta consistere in un enunciato che di per sé non è né vero né
falso, ma è assunto convenzionalmente come “ipotesi”, e la cui scelta è ritenuta del tutto
libera, alla sola condizione che il sistema logico che ne deriva sia coerente, cioè non
contraddittorio. Pertanto ognuna delle possibili geometrie è un “sistema ipotetico
(assiomatico)-deduttivo” (David Hilbert). → Geometrie non euclidee; Assioma
81
F
FALSIFICABILITÀ
Contro l’epistemologia positivistica Karl R. Popper ritenne che le teorie scientifiche, che si
sottopongono al vaglio del metodo sperimentale, non siano affatto verificabili, ossia accertabili
come vere in maniera definitiva, ma soltanto falsificabili. Egli considerò la falsificabilità
una loro condizione specifica, indicandola come il fondamentale “criterio di
demarcazione”, che le distingue dalle teorie non scientifiche, in particolare quelle
metafisiche.
La tradizione positivistica affidava la verifica delle teorie all’applicazione del metodo
induttivo. La critica popperiana, pertanto, si appuntò sull’induzione allo scopo di
evidenziarne l’irrimediabile precarietà logica, nel senso che, per garantire la verifica di una
teoria empirica, occorrerebbe un numero infinito di conferme, che non è possibile
realizzare; invece, per una sua eventuale falsificazione, è sufficiente un solo fatto negativo
che la smentisca. È un’evidente asimmetria logica che obbliga ad invertire la direzione
della ricerca: non si procede dai fatti alle teorie, ma dalle teorie (ipotesi) al loro controllo
mediante i fatti. Secondo Popper, poi, la nostra stessa mente non procede in maniera
induttiva, ma per congetture e confutazioni, cioè con un metodo ipotetico-deduttivo. →
Induzione; Metodo ipotetico-deduttivo
Popper riconobbe, peraltro, che dal punto di vista metodologico nessuna smentita può
essere a sua volta considerata come definitiva; infatti, in coerenza con l’ammissione della
falsificabilità delle teorie scientifiche, bisogna essere disponibili ad accettare anche la
falsificabilità delle falsificazioni; e non si può nemmeno negare che una teoria,
eventualmente confutata dall’esperienza, possa utilmente essere ancora applicata, finché
non si sia in possesso di una migliore.
Popper sostenne con vigore che la falsificabilità empirica non è un criterio di significanza
delle proposizioni, perciò non è possibile usarla per determinare la loro sensatezza (in
quanto falsificabili) o insensatezza (in quanto non falsificabili); essa è solo un “criterio di
demarcazione” tra le teorie scientifiche e le teorie metafisiche. Le teorie metafisiche, infatti,
non sono di per sé prive di senso e non esprimono, come riteneva Rudolf Carnap, puri stati
emotivi e sentimentali; sono invece teorie razionali, empiricamente non falsificabili, ma che
si possono capire, criticare e discutere.
FEDE E FIDEISMO
Il termine “fede” designa una ferma convinzione soggettiva, a ingenerare la quale non
intervengono processi logici o accertamenti empirici, direttamente e oggettivamente
controllabili, ma il fatto che essa si configura in armonia con la complessiva esperienza
personale e corrisponde alla fondamentale esigenza esistenziale di dare un senso accettabile
alla vita e di prefigurarne un destino soddisfacente. Per lo più si riserva la parola “fede” alle
convinzioni specificamente religiose, che presuppongono una disponibilità filosofica alla
dimensione metafisica.
In senso più generico nella quotidianità della vita l’atteggiamento del “credere” riguarda,
invece, più banalmente le ordinarie opinioni e conoscenze probabili; a questo proposito si
usa solitamente il termine “credenza”. → Credenza
82
Sia nella fede che nella credenza l’accettazione di una determinata tesi avviene
nell’impossibilità di un suo diretto controllo empirico o razionale, per cui ci si affida, oltre
che alla ragionevolezza del proprio orientamento esistenziale, all’altrui competenza o
testimonianza, che si ritengono meritevoli di fiducia. Tutta la conoscenza storica è di questo
genere, così come la religione ebraico-cristiana si regge sul credito concesso a coloro che
sono ritenuti testimoni di una rivelazione storica di Dio. Alla problematica della fede sono
interessate sia la filosofia che le varie teologie religiose.
Con il termine di “fideismo” s’intende designare una “fede cieca”, cioè una fede che
prescinde dalla ragione o è addirittura in contrasto con essa.
Fede e mito nella filosofia di Platone
Nella riflessione filosofica la fede ha una significativa presenza già con Platone, che ne
parla in particolare nel mito della caverna. Egli individua nella πίστις (pístis), cioè nella
credenza, il momento più elevato della δόξα (dóxa), cioè dell’opinione, che distingue
dall’ἐπιστήμη (epistéme), cioè dalla scienza. La pístis è la conoscenza adeguata al mondo
del divenire ed è collocata ad un livello superiore rispetto all’εἰκασία (eikasía), cioè
all’immaginazione, perché i suoi oggetti sono direttamente gli enti di questo mondo, non le
loro rappresentazioni. L’ambiguità ontologica dei suoi oggetti si riflette su di essa,
caratterizzandola come una conoscenza “intermedia” tra la verità e l’illusione. La pístis,
perciò, può decadere al livello dell’ordinaria e ottusa persuasione di chi ritiene che il mondo
della natura sia tutta la realtà, ma può anche diventare la disposizione di chi, consapevole
dei limiti connessi alla presente condizione dell’uomo, si rende disponibile ad una ricerca
metafisica, il cui esito sarà comunque la rivelazione di una verità imperfetta e indiretta, cioè
inevitabilmente mediata dal linguaggio allusivo e figurato del mito. Finché vive nell’ambito
di questo mondo, l’uomo è in una condizione intermedia tra l’ignoranza e la conoscenza.
Pertanto la “fede” non è mai superabile, ma accompagna sempre la tensione conoscitiva di
grado più elevato, cioè la dialettica intellettiva, che ci consente di svolgere un movimento
logico ascensivo e discensivo nel complesso sistema delle idee (→ Dialettica). È, questo,
un compito rigoroso e arduo, che, tuttavia, non può mai pretendere di poter conseguire un
sapere esaustivo e definitivo. Quando produce lo sforzo più intenso per andar oltre la φύσις
(phýsis), cioè oltre la dimensione empirica, l’intelligenza è inevitabilmente sollecitata ad
accompagnarsi o a cedere il posto alla fede (pístis), cioè alla condizione esistenziale e
teoretica di chi è consapevole di essere in un qualche rapporto con la verità, che non può
comunque razionalmente dominare, ma soltanto indirettamente evocare mediante il mito.
I miti hanno una presenza importante nella filosofia di Platone, che ne avverte la
necessità, ma li usa criticamente, sempre attento a non trascurare il controllo che su di essi
esercita il λόγος (lógos), cioè la razionalità. Nel Fedone, per esempio, a proposito della
rappresentazione del destino delle anime dopo la morte afferma: “Certo, ostinarsi a
sostenere che le cose siano proprio così come io le ho descritte, non si addice a un uomo
che abbia senno; ma che sia così o poco diverso di così delle anime nostre [...], sostener
questo mi pare si addica, e anche metta conto di avventurarsi a crederlo. E la ventura è
bella”14. Nel Gorgia, poi, Socrate teme che il sofista Callicle possa considerare il suo “bel
discorso” sul giudizio delle anime oltre la morte risibile come uno “di quei miti che narrano
le vecchie, e non t’invita a pensare”; egli, invece, lo ritiene “un ragionamento”, che
desidera esporre “quasi fosse una verità”; “ha fede che sia vero” ed è convinto che non
irrigidisca il pensiero, ma lo solleciti a interrogarsi, perciò è anche disponibile ad
14
Platone, Fedone, 114 d, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, cit., vol. 1, p. 185
83
abbandonarlo, “se, poi, cercando, trovassimo qualche cosa di meglio e di più vero”15. La
sua non è l’opinione presuntuosa di chi si lega all’esperienza sensibile e crede che le cose
abbiano in se stesse la spiegazione di ciò che sono, ma è fede che indaga ed è consapevole
di non poter garantire da ogni ambiguità e incertezza l’assenso al proprio oggetto, perciò si
orienta verso una realtà trascendente, che possa soddisfare le esigenze ineludibili della
razionalità e della giustizia. → Mito e filosofia
Fede e ragione a confronto nel cristianesimo
Nella storia del cristianesimo fin dall’origine è posta la questione della ragionevolezza della
fede, con esiti non univoci, anzi talora decisamente contrastanti.
Già San Paolo nel corso dei suoi viaggi si vede obbligato a confrontarsi con la filosofia.
Ad Atene, dopo aver tentato con abile retorica di accattivarsi l’attenzione e la benevolenza
degli astanti, propone loro di rivelare quel “Dio ignoto” al quale qualcuno aveva dedicato
un altare, ma la delusione per dover constatare la loro indisponibilità lo induce a mutare
strategia e a denunciare l’effettivo contrasto esistente tra la filosofia dei pagani e la fede
cristiana. Così la evidenzia nella Prima lettera ai Corinti: “Poiché nel disegno sapiente di
Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i
credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i Giudei chiedono segni e i Greci
cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i
pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo, potenza
di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò
che è debolezza di Dio è più forte degli uomini”16.
Tra i Padri della Chiesa Giustino (II sec.) assume un atteggiamento di disponibilità a
riconoscere gli elementi validi e veritieri della filosofia, che egli interpreta come “semi del
Lógos” divino, di cui, tuttavia, a suo giudizio i credenti in Cristo possono rivendicare la
proprietà. Infatti afferma: essi “appartengono a noi cristiani”17, perché ciò che hanno
insegnato i Profeti e Cristo è “la sola filosofia sicura ed utile”18. Tertulliano (II-III sec.) poi
ostenta un profilo d’intransigenza ostile, perché vede nella filosofia solo una causa di
sviamento; egli è convinto che “le eresie in sostanza sono eccitate dalla filosofia”19. È
proverbiale il detto a lui attribuito, che non figura letteralmente nei suoi scritti, ma
corrisponde al suo pensiero: credo quia absurdum (credo perché è assurdo). A suo giudizio
la verità cristiana contrasta con la verità razionale. Addirittura si compiace di prestare fede
a cose che dai più sono ritenute incredibili e indegne della divinità: “Qualunque cosa sia
indegna di Dio mi va bene: sono salvo se non provo imbarazzo riguardo al mio Signore”
(quodcumque Deo indignum est mihi expedit: salvus sum si non confundar de domino meo).
In particolare, a proposito del nucleo fondamentale del κέρυγμα (kérygma) cristiano, cioè
dell’annuncio che proclama: “È morto il figlio di Dio” e “dopo essere stato sepolto, è
risorto”, non esita, con franca impudenza e felice stoltezza (bene impudentem et feliciter
stultum), ad esprimere la sua adesione di fede, affermando della morte del figlio di Dio: “È
assolutamente credibile, perché è sconveniente”, e della risurrezione dalla morte: “È certa
15
Platone, Gorgia, 523 a, 524 b, 527 a, trad. di F. Adorno, in Opere complete, Laterza, 1971, vol. 5, pp. 249, 251,
254 s.
16
Prima lettera ai Corinti 1, 21-25. La narrazione del viaggio di San Paolo ad Atene è presente negli Atti degli
apostoli (17, 16-33).
17
Giustino, Seconda apologia, cc. 8 e 13, in G. Bosio, Iniziazione ai Padri, SEI, 1966, vol. I, p. 159-161
18
Giustino, Dialogo con Trifone, 8, in G. Bosio, Iniziazione ai Padri, cit., vol. I, p. 144
19
Tertulliano, De praescriptione haereticorum, I, 7,3, in G. Bosio, Iniziazione ai Padri, cit., vol. I, p. 345
84
perché è impossibile” (mortuus est Dei filius: prorsus credibile est, quia ineptum est; et
sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile)20.
La sintesi agostiniana
Tra il credere e l’intelligere, secondo Sant’Agostino, si può svolgere una circolarità
virtuosa, che realizza l’incremento sia della fede che dell’intelligenza. Egli insiste sulla fede
come dono di Dio, perché tutto il percorso della salvezza, a partire dal suo stesso inizio,
deriva dalla grazia divina. Così invita il cristiano: “crede ut intelligas” (credi, se vuoi
capire), perché la fede è il presupposto e la condizione della possibilità d’intendere, e
“l’intelligenza è il compenso della fede” (intellectus merces est fidei)21. È valido tuttavia
anche il principio inverso: “intellige ut credas”, perché, per credere, occorre comprendere il
senso di ciò che si crede e assentire, ossia disporre il pensiero ad aderirvi (“credere est cum
assensione cogitare”); appare ovvio, infatti, che “nessuno crede [alcunché] se prima non ha
pensato che esso esige di essere creduto” (Nullus quippe credit nisi prius cogitaverit esse
credendum)22. La fede illumina e sostiene l’intelligenza, che a sua volta ne esplicita le
ragioni. Questo intende esprimere la celebre affermazione: “fides quaerit, intellectus
invenit” (la fede cerca, l’intelletto trova), alla quale Agostino aggiunge: “et rursus
intellectus eum quem invenit adhuc quaerit” (e di nuovo l’intelletto domanda di colui che
ha trovato), perché la vita è una continua ricerca23. Agostino non riconosce come validi gli
atteggiamenti opposti ed estremi del razionalismo e del fideismo. Esclude ovviamente il
primo, che non lascia spazio alla fede e pretende di ricondurre tutto il conoscibile alla sola
indagine razionale; non ritiene però adeguato alla dignità umana il secondo, perché la
rivelazione divina si attende da noi non un assenso cieco, ma la chiarificazione realizzata
dalla mente, che a sua volta è purificata dalla fede ed è illuminata dal Lógos divino.
Pertanto afferma: “Lontano da noi il credere che la fede impedisca di trovare o cercare la
spiegazione razionale di quanto crediamo, dal momento che non potremmo neppure credere
se non avessimo un’anima razionale”24.
Il dibattito medioevale
La questione della ragionevolezza della fede (rationabile obsequium) diventa centrale nel
dibattito teologico medioevale. Sant’Agostino ha un forte seguito. Anselmo d’Aosta, per
esempio, afferma che lo stesso “sacro testo c’invita ad investigare le ragioni della fede,
quando dice: ‘se non crederete, non comprenderete’25 [...] Ritengo che, tra la fede e la
visione, sta in mezzo l’intelligenza che abbiamo in questa vita [...] quantunque uomo di
troppo piccol sapere, mi sforzo d’innalzarmi un poco a capire la ragionevolezza di quella
verità che crediamo”26. “Fides quaerens intellectum” (la fede che chiede di capire) è il
programma di Anselmo e di tutta la teologia medioevale, anche di quei dialettici che
esprimono una maggiore autonomia rispetto alle tradizionali auctoritates. Abelardo, per
esempio, nel suo Sic et non applica il metodo dialettico del confronto tra tesi opposte
(videtur quod sic..., sed contra...), proponendo così un modello per la costruzione della
quaestio nell’insegnamento delle scholae. Egli non vuole screditare la fede; il suo scopo è
20
Tertulliano, De carne Christi, V, 3-4
Sant’Agostino, Tractatus in Ioannis evangelium, 29, 6
Sant’Agostino, De praedestinatione sanctorum, 2, 5
23
Sant’Agostino, De Trinitate, XV, 2, 2
24
Sant’Agostino, Lettera 120, I, 3, in Nuova Biblioteca Agostiniana, Opere di Sant’Agostino, vol. XXI/2, a cura di
L. Carrozzi, cit., 1969, p. 1191
25
Isaia, 7, 9
26
Anselmo d’Aosta, Cur Deus homo, citazione derivata da: “L’ente e l’essenza” di Tommaso d’Aquino e il
rapporto fede-ragione nella scolastica, trad. di A. Bettini, a cura di G. Galeazzi, Paravia, 1991, p.104
21
22
85
di far intervenire più decisamente l’analisi e l’argomentazione razionale nei riguardi di
questioni che non appaiono già concluse sul piano dottrinale e sulle quali le autorità stesse
dei Padri della Chiesa e i pronunciamenti conciliari sono in contrasto tra loro. Dimostra
come sia umanamente insostenibile l’atteggiamento fideistico di chi non intende valutare la
credibilità di coloro che sono proposti come auctoritates, autorità alle quali prestar fede:
“Se la fede non deve essere affatto discussa dalla ragione, affinché non perda di merito, e se
non bisogna sottoporre a un giudizio critico che cosa sia opportuno credere e che cosa non
lo sia, ma bisogna subito aderire a tutto ciò che viene predicato, non importa più nulla
replicare, qualunque errore la predica diffonda”. Il giudizio razionale è inevitabile, se
vogliamo aver rispetto della nostra specifica natura. Perciò “ciascuno decide secondo la
propria ragione e sceglie da solo quali autorità seguire. Si dovrebbero altrimenti accettare
indifferentemente le dottrine contenute nei libri religiosi di tutti i popoli, se la ragione, che è
ad esse naturalmente anteriore, non le sottoponesse prima al proprio giudizio”27.
La sintesi di Tommaso d’Aquino
Nell’affrontare la questione della fede Tommaso d’Aquino rivela un grande equilibrio. Egli
vuole evitare il rischio del razionalismo, che riduce la plausibilità della fede ad un’evidenza
dimostrativa. A questo scopo osserva che “la correttezza del giudizio” non deriva soltanto
dal “perfetto uso della ragione”, che non è alla portata di tutti, ma può realizzarsi anche “in
virtù di una connaturalità” (propter connaturalitatem quamdam), la quale consiste nella
spontanea disposizione a comprendere “le realtà divine” e dipende dal dono divino della
sapienza. Egli, però, sa anche che la fede non può ridursi a fideismo, perché è ragionevole e
non cieca e si esprime sulla base di evidenze per le quali il credente vede che ciò che gli si
chiede di credere merita di essere creduto (“qui credit non crederet nisi videret ea esse
credenda propter evidentiam signorum”)28. Pertanto, per pronunciare un consapevole atto
di fede in Dio, occorre confrontarsi con i praeambula fidei, cioè con le premesse razionali
alla fede, in particolare con la dimostrazione dell’esistenza di Dio29. Infatti, come sarebbe
possibile credere alla rivelazione di un essere del quale non si ammettesse l’esistenza?.
Anche Tommaso, come i pensatori di tradizione agostiniana, è convinto della
conciliabilità tra la ragione umana e la fede, ma ritiene di dover evidenziare l’autonomia
della prima, perché anche la fede corrisponda maggiormente alla specificità dell’uomo. In
questo senso il servizio che la ragione filosofica, in quanto ancilla theologiae, offre alla
verità divina, non costituisce per essa un’umiliazione, perché non la mortifica. La fede va
pensata in armonia con la ragione, del cui corretto uso è garante. Tommaso non aderisce
alla teoria averroista della doppia verità, perché la verità è unica. Così si esprime nel
Commento al De Trinitate di Boezio: “È impossibile che le cose che ci sono attraverso la
fede tramandate divinamente siano contrarie a quelle che ci sono date per natura [mediante
il lume della mente, cioè attraverso la filosofia]. In questo caso occorrerebbe che o le une o
le altre fossero false; poiché sia le une sia le altre ci vengono da Dio, Dio sarebbe per noi
l’autore della falsità: il che è impossibile”. E prosegue: “Se nei detti dei filosofi si trova
qualcosa di contrario alla fede, questo qualcosa non appartiene alla filosofia, ma è un abuso
Abelardo, dal Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano, citazione derivata da: “L’ente e l’essenza” di
Tommaso d’Aquino e il rapporto fede-ragione nella scolastica, trad. di A. Bettini, a cura di G. Galeazzi, Paravia,
1991, pp. 116-118
28
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 45, art. 2 c; II-II, q. 1, art. 4 ad secundum
29
Tommaso d’Aquino, Expositio in Boëthium, De Trinitate, a. 3, trad. ital. in N. Abbagnano, Filosofi antichi e
nuovi, Paravia, 1989, pp. 74-75
27
86
della filosofia per difetto di ragione”. Qualora ciò avvenga, la ragione è sollecitata dalla
fede a riesaminare i propri procedimenti e a correggersi30. → Doppia verità
A proposito della fede, poi, Tommaso dà prova di una particolare finezza analitica e
psicologica. Nell’art. 1 (quid sit credere: che cos’è credere) della XIV quaestio disputata
distingue la fede da varie altre condizioni teoretiche: dal dubbio, nel quale l’animo “fluttua”
indeciso tra due tesi contraddittorie; dall’opinione, nella quale si propende per una tesi, ma
non si esclude totalmente l’altra; dalla conoscenza certa che ci è data nell’intuizione
intellettiva (percezione immediata dei principi, in particolare degli assiomi) e nella scienza
(conoscenza mediata o discorsiva delle dimostrazioni), nelle quali l’adesione ad una tesi è
totale. Egli osserva, poi, che la fede esige l’assenso ad una tesi; questo assenso, tuttavia,
non è determinato dalla nostra attività pensante, ma dalla volontà, perché si dà credito a
quel che una certa persona dice e sostiene. Nella fede l’intelletto “rimane inquieto”: non
ancora soddisfatto, continua a cercare e a pensare, benché l’assenso dato sia fermissimo
(eius motus nondum est quietatus, sed adhuc habet cogitationem et inquisitionem de his
quae credit, quamvis firmissime eis assentiat). Commentando una citazione di San Paolo
(“In captivitatem redigentes omnem intellectum”31), nella quale l’apostolo parla
dell’assoggettamento dell’intelligenza umana alla scienza di Dio, Tommaso ne accoglie la
suggestiva metafora: “L’intelletto di colui che crede è fatto prigioniero, perché è tenuto
dentro confini altrui” (intellectus credentis dicitur esse captivatus, quia tenetur terminis
alienis, et non propriis)32.
Il suggestioni di Blaise Pascal
Un approccio fortemente paradossale alla questione della fede è quello di Blaise Pascal.
Egli s’impegna in un’apologia del cristianesimo, ma la realizza nelle forme di un
misticismo tendenzialmente fideistico, che arriva a sollecitare l’opzione religiosa con
l’argomento della scommessa (pari), come se si trattasse di un azzardo con il quale si ha
tutto da guadagnare, cioè Dio, e nulla da perdere, se non la miserevole condizione della
nostra esistenza. Pascal intende persuadere l’interlocutore scettico che gli conviene puntare,
nell’incertezza razionale in cui si trova, sull’esistenza di Dio. Possiamo vedere in questa
proposta un atto provocatorio e ad effetto, connesso anche con l’interesse da lui dimostrato
per il gioco d’azzardo e il calcolo delle probabilità. Per interpretarla adeguatamente, è
comunque decisivo il fatto che egli non trova convincente l’applicazione della ragione alla
fede né sente congeniale la necessità di rappresentare Dio come il fondamento metafisico
delle verità matematiche e il garante del moto universale. Citiamo alcuni passaggi del noto
argomento: “Dio esiste o no? [...] La ragione qui non può determinare nulla”, cioè, non può
dimostrare né l’esistenza né la non esistenza di Dio. Qui non si tratta di decidere se Dio
esiste o no, ma se si vuole scegliere di vivere come se Dio ci fosse o no. “Che cosa
scegliete, dunque? Poiché scegliere bisogna”; infatti, anche non scegliere è comunque una
scelta: “non è una cosa che dipenda dal vostro volere, ci siete impegnato (vous êtes
embarqué)”. Pensare di rimanere scetticamente in una posizione di “sospensione”
dell’assenso (la cosiddetta epoché) è un’illusione. Pertanto “pesiamo il guadagno e la
perdita, nel caso che scommettiate in favore dell’esistenza di Dio. Valutiamo questi due
casi: se vincete, guadagnate tutto; se perdete, non perdete nulla. Scommettete, dunque,
senza esitare, che egli esiste. [...] qui c’è effettivamente un’infinità di vita infinitamente
beata da guadagnare, una probabilità di vincita contro un numero finito di probabilità di
Tommaso d’Aquino, Expositio in Boëthium, De Trinitate, a. 3, cit.
San Paolo, II Lettera ai Corinti, 10, 5
32
Tommaso d’Aquino, Quaestiones disputatae, Quaestio XIV: De fide, art. 1
30
31
87
perdita, e quel che rischiate è qualcosa di finito. Questo tronca ogni incertezza”. Egli,
inoltre, suggerisce all’interlocutore il “metodo” efficace di fare ogni cosa come se si
credesse, prendendo l’acqua benedetta, facendo dire messe, ecc., perché, egli dice, “in
maniera del tutto naturale, ciò vi farà credere e vi impecorirà [vous abêtira, v’istupidirà]”33
(→ Abitudine). La brutalità provocatoria di questa espressione rivela in lui la convinzione
di quanto sia importante nel nostro agire l’“automatismo”, cioè l’insieme dei fattori pratici
(il sentimento, l’istinto, l’inerzia dei comportamenti ripetuti e delle abitudini), che
s’impongono spesso senza che ce ne avvediamo. Per suffragare la credibilità del
cristianesimo Pascal si affida, perciò, ad una facoltà diversa dalla ragione astratta: il
“cuore”, cioè l’intuizione e il sentimento. Egli afferma: “Il cuore, e non la ragione, sente
Dio. Ecco cos’è la fede: Dio sensibile al cuore, e non alla ragione”34. E ancora: “La fede è
differente dalla dimostrazione: questa è umana, quella è un dono di Dio. [...] una tal fede è
nel cuore, e fa dire non già scio, bensì credo”35. La persuasività del cuore appare più
penetrante e concreta e alle sue giustificazioni la ragione è estranea: “Il cuore ha le sue
ragioni, che la ragione non conosce”36. Dio si prospetta all’uomo in maniera chiaroscurale:
è “Deus absconditus”, che “si nasconde a coloro che lo tentano e si rivela a coloro che lo
cercano”37. La rivelazione che egli fa di se stesso in questo mondo non è sfolgorante, cioè
tale da imporsi inevitabilmente anche ai più refrattari, che si troverebbero pertanto
necessitati a riconoscerlo, né è insufficiente per quanti sono ben disposti ad accogliere i
segni della sua presenza: “C’è abbastanza chiarezza da illuminare gli eletti e abbastanza
oscurità da umiliarli. C’è abbastanza oscurità da accecare i reprobi e abbastanza chiarezza
da condannarli e da renderli immeritevoli di scusa”38.
La ragionevolezza della fede secondo John Locke
La tragica esperienza del fanatismo espresso nelle guerre di religione induce John Locke a
tenerne debitamente conto, perché si tratta di un atteggiamento pericoloso, che soltanto la
ragione “nostro ultimo giudice, e guida, in tutto” può controllare. Esso, infatti, “procede
dalla presunzione di un cervello acceso o pieno di sé”, la cui pericolosità è resa evidente dal
fatto che “opera più potentemente sulle persuasioni e le azioni degli uomini che non la
ragione o la fede”39. Alla ragione spetta il compito di valutare sia la credibilità di coloro che
ci chiedono l’assenso della fede religiosa sia l’affidabilità dei criteri in base ai quali una
rivelazione divina si propone come tale. Infatti “chi toglie via la ragione per far posto alla
rivelazione, spegne la luce di entrambe, e si comporta in modo simile a chi convincesse un
uomo a strapparsi gli occhi onde meglio ricevere, mediante un telescopio, la luce remota di
una stella invisibile”40. Sono impossibili gli asserti contrari alla ragione; ma è ragionevole
ammettere la plausibilità di proposizioni che sono non solo conformi, ma superiori alla
ragione stessa, se è Dio, l’essere supremo che non può ingannare, a rivelarle. Alla ragione
spetta comunque il compito di giudicare credibile un’eventuale rivelazione divina.
La fede postulatoria di Immanuel Kant
33
B. Pascal, Pensieri, 164, trad. di P. Serini, Oscar Classici, A. Mondadori, 1976
B. Pascal, Pensieri, 148, cit.
B. Pascal, Pensieri, 143, cit.
36
B. Pascal, Pensieri, 146, cit.
37
B. Pascal, Pensieri, 563, cit.
38
B. Pascal, Pensieri, 575, cit.
39
J. Locke, Saggio sull’intelligenza umana, trad. di C. Pellizzi, riveduta da G. Farina, Laterza, 1988, IV, 19, § 14,
pp. 825-826
40
ivi, IV, 19, § 4, p. 816
34
35
88
È noto il rigore con il quale Immanuel Kant sostiene le esigenze di un razionalismo critico,
mediante il quale esclude che l’uomo possa conseguire una conoscenza metafisica. Tuttavia
ciò non gli impedisce di affermare che alle verità metafisiche si può accedere per via non
teoretica, ma postulatoria per mezzo di una “fede razionale”. Ora, questa fede, “considerata
come principio di spiegazione [ossia teoreticamente], può esser chiamata ipotesi”; invece,
in rapporto alle esigenze morali del soggetto umano, è “un bisogno” ineludibile, che gli fa
dire che “è moralmente necessario ammettere l’esistenza di Dio”41. È questo il senso della
nota affermazione: “Io dunque ho dovuto sopprimere il sapere per sostituirvi la fede”42.
Senza la fede vien meno il senso etico della nostra esistenza. Infatti, già nella Critica della
ragion pura Kant dichiarava la ferma certezza di questa fede: “Poiché la prescrizione
morale è insieme massima mia (la ragione infatti comanda che essa deve esser tale), io
crederò immancabilmente nell’esistenza di Dio e in una vita futura, e son sicuro che niente
può far scuotere questa fede, poiché così sarebbero rovesciati i miei stessi principi morali,
ai quali io non posso rinunziare senza essere ai miei propri occhi degno di disprezzo”43.
Il “salto” della fede secondo Friedrich H. Jacobi
Il Romanticismo attribuisce alla fede una funzione importante nell’ambito stesso della
conoscenza, perché consente all’uomo di superare l’ambito fenomenico e di essere in
rapporto con l’Infinito. La facoltà che la esprime è il sentimento.
Un autore interessante a questo riguardo è Friedrich H. Jacobi, secondo il quale con la
fede possiamo innanzitutto “saltare” dal pensiero all’oggettività del mondo fuori di noi,
superando così l’immanentismo idealistico entro il quale gli sviluppi teoretici del criticismo
kantiano sembravano voler chiudere l’uomo. La fede, poi, ci mette in grado di innalzarci
dagli enti finiti all’essere incondizionato e divino, che ne è il fondamento metafisico. Jacobi
vede in particolare nell’idealismo di Friedrich W.J. Schelling un implicito ateismo, che
sembra riproporre l’identificazione spinoziana di Dio con la natura. Contro queste moderne
insidie egli afferma: “Ci devono essere verità originarie, semplici, immediatamente certe,
assolutamente positive [...] Su queste verità soltanto si fonda quella fiducia che nobilita il
cuore e lo spirito”. E ancora: “La fede in Dio è un istinto naturale per l’uomo come la sua
posizione eretta. Non avere questa fede è contro natura [...] e dipende da una deformazione
della facoltà conoscitiva”44. Jacobi scorge alla base di questa spontanea tendenza a credere
lo stesso dinamismo psichico che David Hume aveva denominato belief. → Credenza
È nota, peraltro, la sapida ironia con la quale Georg W.F. Hegel tratta la fede di Jacobi:
ciò che essa può provocare è soltanto un “salto mortale” per la filosofia. Il razionalismo
hegeliano contrasta decisamente con il misticismo sentimentale dei romantici, perché
sostiene che all’Infinito si possa accedere solo speculativamente, mediante la fatica del
concetto, e non attraverso l’immediatezza e l’ineffabilità del sentimento, che con il sapere
nulla ha a che vedere.
Il paradosso della fede secondo Søren Kierkegaard e Karl Barth
Una vigorosa esaltazione della fede è espressa da Søren Kierkegaard. Contro
l’immanentismo razionalistico di Hegel egli insiste sulla trascendenza di Dio. A suo
giudizio noi non abbiamo alcuna chiarezza concettuale dell’Assoluto e del suo mistero;
41
Critica della ragion pratica, Parte I, Libro II, Cap. II, 5, a cura di F. Capra, ed. rivista da E. Garin, Laterza,
1971, pp. 152-153
42
Critica della ragion pura, a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, riveduta da V. Mathieu, Laterza, 1971,
Pref. alla seconda edizione, p. 28
43
Critica della ragion pura, Dottrina trascendebtale del metodo, Cap. II, sez. III, cit., p. 627
44
F.H. Jacobi, Scritti e testimonianze, a cura di V. Verra, Loescher, 1966, p. 61
89
perciò voler dimostrare Dio è la pretesa più assurda della nostra ragione. L’approccio
razionale all’Assoluto è destinato alla sconfitta, perché non può che svolgersi in maniera
paradossale, cioè all’insegna della contraddizione, la quale, diversamente da quanto aveva
sostenuto Hegel, non è riscattabile da alcuna mediazione dialettica. Ecco alcune
significative parole a questo riguardo: “Se Dio è assolutamente diverso dall’uomo, allora
l’uomo è assolutamente diverso da Dio: ma come potrebbe l’intelletto pensare questo?
Sembra che qui ci troviamo davanti a un paradosso. [...] Un paradosso simile si può ora
pensare? [...] L’intelletto di certo non l’intende: come mai potrebbe concepirlo?” Di fronte
al paradosso esso “si accorge soltanto che sarà certamente la sua fine”. Ma la percezione di
questa sua rovina si dà soltanto “nel momento della passione” della fede45.
La posizione di Kierkegaard si configura come una netta espressione di fideismo e
misticismo. Egli descrive la fede con l’esempio di Abramo, al quale Dio chiede
paradossalmente il sacrificio del figlio della promessa, Isacco, in palese contraddizione sia
con la legge morale che con la stessa promessa di una lunga e ricca discendenza. La fede è
una certezza angosciosa, un riscatto dalla disperazione attraverso la contraddizione,
impersonata da Cristo. Questi, infatti, è Dio che si fa uomo e muore per gli uomini, è
l’eterno che assume la dimensione del tempo e proprio per questo è “segno di
contraddizione” e scandalo. Kierkegaard puntualizza ulteriormente: “La contraddizione
esistenziale implicita nel cristianesimo io l’ho espressa nel problema: ‘Può mai una
salvezza eterna essere decisa nel tempo con riguardo a qualcosa di storico?’”46. La fede è
scandalosa per la ragione, perché da un lato è l’uomo che deve scegliere e professare la sua
fede, ma dall’altro è Dio che suscita in lui questa fede e gli concede la grazia di aprirsi a lui.
A questo proposito ricordiamo anche che la “rinascita kierkegaardiana” del Novecento
parte, nell’ambito della teologia luterana, da Karl Barth, il quale si propone di recuperare
l’ispirazione fondamentale della Riforma protestante in riferimento non solo alla questione
tradizionale della giustificazione dell’uomo, ma, in particolare, al compito stesso della
teologia: se questa è un parlare di Dio, l’iniziativa è di Dio stesso, che parla all’uomo
mediante la sua parola incarnata, Gesù crocifisso, nel cui destino è sconfitta e condannata
ogni pretesa umana di parlare di Dio. È, questa, la cosiddetta theologia crucis, per la quale
l’evento cristiano non è un fenomeno intramondano, equiparabile ad una comune religione.
In quanto teologia, il pensiero cristiano non può costituirsi come una qualsiasi scienza, alla
quale spetterebbe il compito di giustificarsi razionalmente secondo i tradizionali criteri
dell’analogia entis, elaborati in particolare da Tommaso d’Aquino e dal cattolicesimo. La
comprensione dell’esistenza deve invece procedere dalla fede, i cui criteri interpretativi non
dipendono affatto dalla ragione umana, che su di essi non ha alcuna competenza.
All’analogia entis, suffragata costantemente dalla tradizione cattolica, Barth contrappone
l’analogia fidei, di cui parla San Paolo nella lettera ai Romani (12, 6). Su questi temi la
riflessione del grande teologo svizzero si dispiega appunto nel Commento alla Lettera ai
Romani (1919), nel saggio su Anselmo d’Aosta Fides quaerens intellectum (1931) e nella
monumentale Dogmatica ecclesiale (iniziata nel 1932, ma rimasta incompiuta). →
Analogia
La fede filosofica di Karl Jaspers
Nel Novecento Karl Jaspers dà un contributo interessante alla problematica filosofica della
fede. Egli è convinto che l’autentico pensare filosofico si svolge secondo una prospettiva
45
S. Kierkegaard, Briciole di filosofia, c. III, in Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni, 1972, pp. 224-225
S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica, parte II, c. 4, § 2, in Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni,
1972, p. 468
46
90
metafisica di trascendenza verso la totalità dell’essere, che tutto abbraccia come un
orizzonte onni-conglobante, infinito e intrascendibile, inoggettivabile e nascosto, da lui
denominato Umgreifende, termine composto tedesco derivato dalla preposizione um
(intorno a) e dal verbo greifen (prendere), che richiama l’ápeiron periéchon, “l’infinito che
tutto abbraccia”, di Anassimandro. → Periecontologia
Secondo Jaspers, quando riflettiamo in maniera appropriata sulla nostra condizione
esistenziale, allora il nostro pensare assume la forma della fede, perché è consapevole
dell’incompiutezza costitutiva della nostra conoscenza e alimenta in noi la convinzione che
la verità ci trascende. Egli lo chiama “fede filosofica” e lo distingue dalla fede religiosa. Su
di esso scrive specificamente due saggi intitolati: La fede filosofica (1948) e La fede
filosofica di fronte alla rivelazione (1962). È vero, osserva Jaspers, che anche la fede
religiosa ci fa dire che la verità non è a portata di mano nell’immanenza del mondo e della
storia, ma poi essa ne dispone come di un bene che si possiede ed è possibile organizzare e
sistemare in forme dogmatiche e definitive. Jaspers denomina questo atteggiamento
“cattolicità”, della quale dice: “La cattolicità vuole e afferma di possedere il sapere totale
con garanzie oggettive e con sicurezza”. La certezza incontrovertibile e assoluta che essa
esprime tende a tradursi in intolleranza. La fede filosofica, all’opposto, mantiene un
rapporto problematico con la verità, in maniera tale che “il pensiero rischia quella via che
conduce dal sapere determinato all’indeterminabile”47.
La fede filosofica non comporta di per sé l’adesione ad una particolare religione positiva,
perché la verità costituisce il punto di riferimento di una possibile convergenza
comunicativa tra gli uomini, che si muovono alla sua ricerca. La verità non va pensata né in
maniera dogmatica né scettica, dal momento che la pluralità delle situazioni delle singole
esistenze permette di intenderla come la prospettiva di un percorso mai concluso né
esauribile, ma tendenzialmente unificante, che si svolge attraverso la comunicazione che gli
uomini sono in grado di realizzare. L’inconcludenza, che sembra caratterizzare l’esito della
nostra ricerca, è costitutivo dell’autentico filosofare, che del sapere rivela l’amore, non il
possesso. La dichiarata incapacità della filosofia di dare soluzioni non è una banale
dimostrazione di nichilismo, ma il consapevole riconoscimento dello scacco in cui
incorrono necessariamente le presunzioni illusorie, dalle quali occorre liberarsi. Essa ci
educa ad interpretare positivamente i limiti dell’esistenza come rinvio all’essere, che
ovunque e sempre ci trascende e nei cui riguardi ci dobbiamo disporre in fiduciosa attesa.
FILOSOFIA
È una parola di origine greca, composta dal verbo φιλέω (philéo (amo) e dal sostantivo
σοφία (sophía), per designare letteralmente l’“amore del sapere” e l’“amore della
sapienza”, perché nasce dal desiderio di conoscere e si manifesta nella curiosità e nella
ricerca. L’uomo, infatti, nella sua condizione originaria è caratterizzato dalla sostanziale
ignoranza di se stesso e delle cose e dalla necessità di proiettarsi nel mondo in un’attività
d’ispezione e ricognizione. Se l’urgenza dei bisogni e degli impulsi lo sollecita
istintivamente ad un loro primario appagamento, poi, quando le necessità della
sopravvivenza sono assicurate, interviene qualcosa che lo va distinguendo sempre più in
maniera specifica: soddisfare liberamente il puro desiderio di conoscere. L’accompagna un
da Von der Wahrheit (Sulla verità), cit.da U. Galimberti, Il tramonto dell’Occidente nella lettura di Heidegger e
Jaspers, Feltrinelli, 2005, p. 591
47
91
atteggiamento interrogativo, che di continuo si rinnova di fronte a tutto ciò che suscita
stupore. Perciò Aristotele osserva che “gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come
in origine, a causa della meraviglia. [...] Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia
riconosce di non sapere. [...] Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi
dall’ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per
conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra:
quando già c’era pressoché tutto ciò che necessitava alla vita ed anche all’agiatezza e al
benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. [...] E come diciamo
uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte
le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa”70.
La testimonianza di Socrate la propone come assai impegnativa e in essa individua il
senso dell’esistenza, perché “una vita senza ricerca non è degna d’essere vissuta”, anche se
deve riconoscere che “unicamente sapiente è il dio; e […] poco vale o nulla la sapienza
dell’uomo”71. Platone poi è convinto che soltanto una cura amorosa e prolungata può far
attecchire e crescere una disposizione profonda alla ricerca della verità e all’acquisizione
della sapienza, perché la filosofia “non è una scienza come le altre: essa non si può in alcun
modo comunicare, ma come fiamma s’accende da fuoco che balza: nasce d’improvviso
nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in
comune, e poi si nutre di se medesima”; essa dà all’uomo “le cose più serie”, ed “egli le
serba riposte nella parte più bella che ha”72.
La filosofia pretende di essere vera scienza: l’autentico sapere non s’accontenta della
constatazione di fatti e della registrazione di puri dati, ma cerca d’individuare la ragion
d’essere, la causa, il perché delle cose, per sottrarle a quella condizione di opacità e
casualità, nelle quali spontaneamente si presentano, e far sì che rivelino un senso che le
renda intelligibili e apprezzabili; perciò è un sapere eminentemente “problematico” e
“critico” (dal verbo greco kríno: giudico), che sottopone ad una valutazione razionale non
solo i particolari contenuti che di volta in volta interessano, ma riflessivamente la stessa
attività conoscitiva, per determinarne le effettive condizioni di validità, le possibilità e i
limiti. L’atteggiamento opposto è solitamente denominato “dogmatismo”; esso consiste
nell’accettare opinioni e dottrine senza interrogarsi preliminarmente sulla loro fondatezza.
La rilevazione della natura critica e antidogmatica della filosofia è storicamente legata in
modo particolare ad Immanuel Kant, rappresentante massimo dell’Illuminismo filosofico
europeo del secolo XVIII. Kant afferma che “non si può imparare alcuna filosofia”, se con
questo termine s’intende un sapere compiuto e definitivo; infatti egli provocatoriamente
incalza i suoi interlocutori con queste domande: “Dove è essa, chi l’ha in possesso, e dove
essa può conoscersi?”. È sua convinzione che “la filosofia è una semplice idea di una
scienza possibile, non data mai in concreto, ma a cui si cerca di accostarsi per diverse vie”,
ossia che “si può imparare soltanto a filosofare, cioè ad esercitare il talento della ragione
nell’applicazione dei suoi principi generali a certi tentativi che ci sono, ma sempre con la
riserva del diritto della ragione di cercare questi principi stessi alle loro sorgenti e di
confermarli o rifiutarli”73.
Rifiutando qualsiasi acritico presupposto, l’autentico filosofare respinge, tuttavia, ogni
arroganza. Noi conduciamo le nostre ricerche nell’ambito universale dell’essere. Le
spiegazioni più immediate, alla portata di mano, non ci soddisfano, e così gli interrogativi si
70
Aristotele, La metafisica, A 2,982 b 10-27, a cura di G. Reale, Loffredo, 1968, vol. I, pp. 107-108
Platone, Apologia di Socrate, 38 a e 23 a, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, Laterza, 1971, vol. 1, p. 68
e p. 45
72
Platone, Lettera VII, 341 c-d e 344 c-d, trad. di A. Maddalena, in Opere complete, cit., vol. 8, p. 52 e p. 55
73
I. Kant, Critica della ragion pura, “Dottrina trascendentale del metodo”, sez. III, cap. III, cit., pp. 633-634
71
92
susseguono in una concatenazione che amplia sempre più l’indagine, il cui senso
complessivo è che l’orizzonte della conoscenza intende comprendere il Tutto e la domanda
pretende di essere totale e radicale, senza nulla escludere, nemmeno il soggetto che la pone,
soprattutto quando è colto dalla meraviglia suscitata dall’essere, il cui mistero la sua stessa
esistenza dischiude, ma non è in grado di decifrare, riproponendo incessantemente la
fondamentale domanda metafisica, così formulata da G.W. Leibniz: “Perché l’essere e non
piuttosto il nulla?” (→ Metafisica; Totalità; Essere; Nulla). Giunto, infatti, ai limiti estremi
delle sue possibilità, il filosofo, consapevole dei suoi limiti, sa che in quel domandare si
esprime “la pietà del pensare”74.
La filosofia non mira all’erudizione, ma cerca soprattutto d’individuare il principio o i
principi: ἀρχή o ἀρχαί (arché o archái) hanno chiamato questa causa o cause prime e
originarie gli antichi filosofi greci; successivamente le si è designate anche come
“fondamenti” (→ Causa; Fondamento). L’ambizione della filosofia è di misurarsi con la
questione della totalità, magari per riconoscerne l’insolvibilità oppure per criticare le
proprie pretese come eccessive o addirittura insensate. La problematica filosofica è da
sempre rivolta ai fondamenti della realtà, alle ragioni esplicative e ai criteri giustificativi del
conoscere, dell’agire e del produrre, secondo la sistemazione enciclopedica, già presente in
Aristotele, di tre tipi di scienze: teoretiche, pratiche e poietiche, perché nulla sembra
sfuggire all’interesse della filosofia. Essa è, di volta in volta, fisica, metafisica, ontologia,
logica, gnoseologia, epistemologia, etica, politica, teoria dell’arte e della tecnica.
Si può giustamente sostenere che la filosofia è connaturata all’uomo e alla comune
specificità di tutti gli uomini nel mondo dei viventi; ma, se si vuol rilevare un’origine ben
determinata di quel pensiero filosofico che si costituì progressivamente nell’ambito della
civiltà occidentale alla quale apparteniamo e che con una produzione concettuale propria e
un’autonoma elaborazione teoretica si assestò in una tradizione comune e continua, anche
se variegata nelle sue espressioni storiche e individuali, dobbiamo risalire al mondo greco
del VI secolo a. C.
L’affermarsi della filosofia accompagnò il progressivo discredito della mitologia, alla
quale si andò sostituendo sempre più l’esigenza di una ricerca razionale, che individuasse
cause e spiegazioni non fantastiche, ma analiticamente dibattute e argomentate degli eventi
naturali, soddisfacesse il bisogno di svelare l’ordine del mondo e desse un senso alla
condizione esistenziale dell’uomo. In generale l’organizzazione politica greca delle póleis
autonome in reciproca competizione dimostrò di essere un importante fattore di pluralismo,
creatività e libertà. Il mondo greco, poi, non aveva caste sacerdotali, che irrigidissero in
forme dogmatiche la visione mitologica del mondo e la rappresentazione degli dei; perciò
nel suo ambito si sviluppò una libertà sufficiente perché esse fossero sottoposte ad una
critica severa. Propriamente la filosofia greca cominciò a delinearsi quando
l’interpretazione del mondo offerta dal mito sulla base dell’immaginazione simbolica
cedette il passo al lógos, cioè al discorso razionale, consapevolmente critico e sistematico. I
Greci non si accontentarono di un sapere immediatamente utilitaristico e operativo, ma
svilupparono un atteggiamento teoretico, il cui scopo era la soddisfazione del desiderio di
conoscere; questo, poi, non si esaurì nella descrizione delle cose, ma cercò d’individuare le
cause e i principi. Infine la rilevazione della presenza di un ordine nel mondo li sollecitò a
registrare la regolarità degli eventi secondo configurazioni generali e astratte. Dagli altri
popoli ovviamente attinsero informazioni e suggerimenti, ma essi li svilupparono
razionalmente, dando sistematicità alle conoscenze.
74
M. Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, trad. di G. Vattimo, Mursia, 1976, p. 27
93
Considerata nei suoi sviluppi storici, la filosofia occidentale fu variamente interpretata da
coloro che la esercitarono, privilegiando di volta in volta il puro orientamento teoretico o
l’interesse per la prassi. Così, per esempio, dopo le grandi speculazioni di Platone e
Aristotele, gli autori delle scuole ellenistiche (l’epicureismo, lo stoicismo e lo scetticismo)
non evitarono affatto l’impegno di elaborare una visione generale del mondo, ma ciò
apparve loro per lo più strumentale rispetto ai problemi etici ed esistenziali, sui quali
concentrarono la loro attenzione. Esse intesero reperire le soluzioni e i rimedi più opportuni
ed efficaci alle questioni che suscitano inquietudine e turbamento nell’uomo. La filosofia,
perciò, fu proposta come una terapia della mente e dell’esistenza. Con Plotino, poi, tornò a
prevalere il pensiero metafisico, sostanziato da una forte misticismo religioso.
Nell’ambito del cristianesimo ci si rapportò alla tradizione filosofica in maniera non
univoca. Già San Paolo, in seguito alle disillusioni in cui era incorso nei riguardi della
sapienza dei Gentili (si consideri il suo primo contatto con la città di Atene all’Areopago, di
cui parlano gli Atti degli apostoli al cap. 17), aveva dichiarato: “Poiché nel disegno sapiente
di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di
salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i Giudei chiedono segni e i
Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei,
stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo
Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini”75. Nella successiva
riflessione dei Padri della Chiesa ci fu chi, come Tertulliano, sostenne un profilo
d’intransigenza e vide nella filosofia solo una causa di sviamento; a suo giudizio, infatti, “le
eresie in sostanza sono eccitate dalla filosofia”76. Rimase proverbiale il detto a lui attribuito,
che non figura letteralmente nei suoi scritti, ma corrisponde al suo convincimento che la
verità cristiana contrasta con la verità razionale: “Credo quia absurdum” (credo perché è
assurdo). A proposito della risurrezione di Cristo, per esempio, affermò: “È certa perché è
impossibile” (certum est quia impossibile)77. Tuttavia, ci fu anche chi, come Giustino (II
sec.), verso la filosofia assunse un atteggiamento di disponibilità a riconoscerne gli
elementi validi e veritieri, i “semi del Lógos” divino, di cui tuttavia rivendicava addirittura
la proprietà: essi “appartengono a noi cristiani”, perché ciò che hanno insegnato i Profeti e
Cristo è “la sola filosofia sicura ed utile”78. Su questa linea proseguì Agostino, il quale
osservò che i cristiani non hanno da temere una loro inferiorità, se i filosofi, in particolare i
platonici, dicono cose vere e conformi alla fede cristiana; devono, anzi, “rivendicarle” e
vantarle come proprie, perché i pagani ne sono “ingiusti possessori” (ab eis tamquam ab
iniustis possessoribus in usum nostrum vindicanda): poiché non hanno saputo farne buon
uso, per conoscere convenientemente Dio, le loro verità parziali devono essere restituite al
deposito naturale della verità piena e perfetta di Cristo79. Anche per Agostino, perciò, la
vera filosofia è il cristianesimo.
75
San Paolo, Prima lettera ai Corinti, 1, 21-25, trad. de La Bibbia di Gerusalemme, EDB-Borla, 1974
Tertulliano, De praescriptione haereticorum, I, 7,3, in G. Bosio, Iniziazione ai Padri, cit., vol. I, p. 345
Tertulliano, De carne Christi, 5; v. J. Kelly, Il pensiero cristiano delle origini, cit., p. 188
78
Giustino, Seconda apologia, cc. 8 e 13; Dialogo con Trifone,c. 8, in G. Bosio, Iniziazione ai Padri, SEI, 1966,
vol. I, rispettiv. pp. 159-161e p. 144
79
De doctrina christiana, II, 40.
Agostino interpreta allegoricamente l’appropriazione di quei beni preziosi (vasi, ornamenti d’oro e d’argento e
vesti), che gli antichi ebrei, fuggendo dall’Egitto, sottrassero agli egiziani, con l’intenzione di farne un uso
migliore. Anche i cristiani, egli dice, possono sentire come proprie le corrette dottrine dei pagani, integrandole
nella verità intera della loro fede. Agostino torna su questo tema nelle Confessioni, facendone un’applicazione a se
stesso: “Anch’io ero venuto a Te dai gentili e volsi lo sguardo all’oro che, per tuo volere, il popolo portò via
dall’Egitto: era tuo, infatti, dovunque fosse”. La capacità di apprezzare la verità parziale, contenuta nelle dottrine
76
77
94
Nelle scholae medioevali si seguitò a concepire il sapere in maniera unitaria, orientandolo
però gerarchicamente verso la sacra doctrina, cioè la scienza delle cose divine, rivelate da
Dio mediante le Sacre Scritture e poi sistemate e codificate nell’ambito della tradizione
dottrinale della Chiesa. Pertanto la teologia fu ritenuta la regina delle scienze e rispetto ad
essa tutte le altre, in particolare la metafisica, dovevano essere ancillae.
In sé considerata, comunque, la filosofia mantenne per secoli l’originaria pretesa di
configurarsi come un sapere integralmente razionale e universale, articolato in una pluralità
di discipline particolari e ancora così nell’età moderna la pensava René Descartes. Egli,
infatti, pur auspicandone un rinnovamento integrale e profondo sulla base di un metodo più
rigoroso, le cui regole derivava dalla matematica e pensava di poter usare come strumento
di unificazione del sapere, la strutturava organicamente “come un albero, di cui le radici
sono la metafisica, il tronco è la fisica e i rami che sorgono da questo sono tutte le altre
scienze”80.
Durante l’Illuminismo alla tradizionale tendenza onnivora della conoscenza filosofica si
andò affiancando un progressivo discredito della metafisica, sostenuto in particolare
dall’empirismo scettico di David Hume e rielaborato poi, in forme nuove, dal criticismo di
Immanuel Kant. Questi legò la teoresi filosofica alle esigenze epistemologiche della scienza
moderna, i cui fondamenti, metodologicamente preliminari alla ricerca effettiva, occorre far
emergere dalla problematizzazione delle sue condizioni di possibilità. Egli risolse la
questione in senso trascendentale. → Epistemologia; Scienza; Empirismo; Illuminismo;
Criticismo; Trascendentale
In controtendenza a questi orientamenti critici si sviluppò la poderosa speculazione
dialettica del Romanticismo, intrinsecamente orientata in senso metafisico. In particolare la
riproposizione di un sapere universale, impostato secondo le esigenze di un integrale
immanentismo spiritualistico, fu propria di G.W.F. Hegel, che considerò la filosofia “lo
scandaglio del razionale”, “la comprensione del presente e del reale, non la ricerca d’un al
di là, che sa Dio dove dovrebbe essere [...] Ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è
razionale. [...] Intendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò che è, è la ragione.
Del resto, per quel che si riferisce all’individuo, ciascuno è, senz’altro, figlio del suo tempo;
e anche la filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero”. In altre parole, la filosofia
prende atto della realtà, evidenziandone la necessaria struttura razionale; essa è simile alla
“nottola di Minerva” che “inizia il suo volo sul far del crepuscolo”81, cioè quando la realtà
si è già svolta ed è pertanto vana illusione volerla predeterminare e dirigere; è solo possibile
comprenderla nella sua immanente razionalità.
Nella forma speculativa del pensiero hegeliano Karl Marx identificò l’essenza ideologica
della filosofia, alla quale oppose le esigenze di una positività scientifica fondata sulla
prassi. → Ideologia; Materialismo storico
Sulle tracce del precedente empirismo illuministico il positivismo ripropose una concezione
strettamente epistemologica della filosofia, ma esso pure su questa base tenta di elaborare
un progetto enciclopedico e unitario del sapere. → Positivismo; Neopositivismo;
Enciclopedia
dei filosofi, s’accompagna in lui alla cautela di non assimilare alla verità ciò che non lo è. Perciò aggiunge: “Non
mi volsi agli idoli dell’Egitto” (Le confessioni, VII, 9, cit., p. 317).
80
R. Cartesio, I principi della filosofia, Lettera-prefazione all’abate Picot, in Opere, a cura di E. Garin, Laterza,
1967, vol. II, p. 19
81
G.W.F. Hegel, Lineamenti della filosofia del diritto, trad. it. di F. Messineo, Laterza, 1974, pp. 15, 16 e 20
95
Successivamente, tra i vari orientamenti del pensiero del Novecento si espressero in senso
antipositivistico l’indagine fenomenologica e le filosofie dell’esistenza. In particolare
citiamo Edmund Husserl, secondo il quale “il concetto positivistico della scienza del nostro
tempo è - da un punto di vista storico - un concetto residuo. Esso ha lasciato cadere tutti
quei problemi che erano stati inclusi nel concetto, ora troppo angusto ora troppo ampio, di
metafisica, tra gli altri quelle questioni che sono dette poco chiaramente ultime e
supreme”82. → Fenomenologia; Esistenzialismo
FINALISMO
Il finalismo o teleologia consiste nell’interpretare gli eventi mediante la causa finale (τέλος,
télos, in lingua greca), che possiamo definire come ciò in vista di cui qualcosa avviene.
La finalità dell’agire è propria degli enti dotati d’intelligenza; perciò l’attribuzione che la
estende ai processi naturali e storici presuppone comunque una mente ordinatrice,
trascendente o immanente ad essi. Un finalismo generalizzato e onnicomprensivo, associato
ad una positiva concezione dell’essere, secondo la quale l’essere e il bene coincidono (“ens
et bonum convertuntur” → Trascendentale), si configura come una concezione
provvidenzialistica del mondo (→ Provvidenza).
Al tradizionale finalismo, secondo il quale niente è a caso, presiede un principio
considerato assiomatico e di assoluta ovvietà, “per se notum” (noto di per sé), secondo la
tipica espressione della filosofia scolastica, che così lo formula: “omne agens agit propter
finem” (ogni agente agisce per un fine).
A. L’ordine del mondo rivela un finalismo universale
Eraclito e gli stoici
Già Eraclito individuava nel lógos immanente alla natura la legge divina ed eterna, che
“ama celarsi”83 e tuttavia “governa tutte le cose”84. Ad esso nulla e nessuno si possono
sottrarre, perché inconsapevolmente anche “coloro che dormono” sono “artefici e
collaboratori di quanto accade nell’universo”85.
Alcuni secoli dopo gli stoici riproposero la concezione eraclitea, dandole una
configurazione sistematica. Anche per loro nel mondo ogni minimo evento è ciò che deve
essere, giustificato dall’intrinseca razionalità che lo impone. Proprio perché la realtà
coincide con lo sviluppo di un’immanente trama razionale, niente è lasciato al caso e tutto è
perfetto, tutto ha un senso nel generale disegno del Lógos, anche se noi nella nostra
particolare situazione possiamo non coglierlo. A nulla serve recriminare contro gli aspetti
negativi dell’essere, perché ciò che isolatamente sembra male, nell’insieme organico del
Tutto è invece funzionale all’ordine e al bene universale.
Platone
82
E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, trad. di E. Filippini, Il Saggiatore,
1983, p. 37
83
Eraclito, in I Presocratici, Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1975, “Frammenti”,
123, p. 220
84
ivi, “Frammenti”, 72, p. 212
85
ivi, “Frammenti”, 75, p. 212
96
Diversamente da Democrito, per il quale tutto è affidato al caso e alla necessità, nel senso
che tutto avviene in assenza di una mente divina e in virtù di un rigoroso determinismo
meccanicistico (→ Caso; Determinismo), per Platone il mondo è il prodotto di una mente
divina, che lo ordina e lo trascende. Un divino artefice (il Demiurgo) realizzò quest’opera,
agendo su un’informe materia, modellandola secondo un progetto che ne rivela
l’intelligenza e la bontà. Il creatore riuscì ad imporsi sull’informe “ricettacolo di tutto ciò
che si genera”86, disponendolo verso scopi positivi. Infatti, “dio volendo che tutte le cose
fossero buone e, per quant’era possibile, nessuna cattiva, prese dunque quanto c’era di
visibile che non stava quieto, ma si agitava sregolatamente e disordinatamente, e lo ridusse
dal disordine all’ordine, giudicando questo del tutto migliore di quello. Ora né fu mai, né è
lecito all’ottimo di far altro se non la cosa più bella”87.
Aristotele
Anche la filosofia di Aristotele è caratterizzata da un costante e generale finalismo.
Nell’analisi degli eventi naturali egli riconosce l’importanza delle cause meccaniche, che
appaiono tuttavia destinate ad una funzione strumentale rispetto alla cause finali. Il
divenire, infatti, in quanto è transizione da una condizione potenziale alla sua attuazione,
comporta l’intrinseco attuarsi di un fine. Non a caso uno dei termini con i quali il filosofo
greco denomina l’atto è ἐντελέχεια (entelécheia), reso letteralmente in italiano con il
termine “entelechìa”. Di una sostanza esso intende indicare la realizzazione dello sviluppo
che la fa essere perfetta (ἐντελής, entelés), nel senso che ha conseguito il suo fine (τέλος,
télos). Il principio intrinseco attivo, che determina e struttura in maniera specifica una
materia, in sé indeterminata e generica, è la forma o essenza: essa coincide con l’atto che
realizza e compie le potenzialità insite nella materia. Ora, l’atto è prioritario rispetto alla
potenza, perché è l’atto che costituisce la causa e il senso di un possibile sviluppo della
potenza; la potenza, a sua volta, è necessariamente e sempre in funzione dell’atto.
Nella gerarchia universale dell’essere il divenire di tutte le cose dipende
fondamentalmente dal Motore immobile o Atto puro, che “muove come oggetto di amore”,
ossia come causa prima finale, che attrae a sé da sempre l’universo, producendo
direttamente “il movimento primo, eterno ed uno” del primo cielo mobile88.
Un’ulteriore conferma del finalismo aristotelico è data dalla teoria dei “luoghi naturali”,
secondo la quale tutti i corpi, in base agli elementi che li compongono (terra, acqua, aria,
fuoco, etere), tendono spontaneamente a disporsi dal basso all’alto là dove la loro natura li
ha destinati e a ritornarvi qualora ne siano forzatamente allontanati. → Luoghi naturali
La concezione cristiana
Le tesi fondamentali della dottrina cristiana (creazione, redenzione, prospettiva
escatologica) elaborano una complessa concezione del mondo, dell’uomo e della storia, che
è caratterizzata da un insistente e pervasivo finalismo provvidenzialistico. Perciò Tommaso
d’Aquino afferma che, se la “provvidenza”, genericamente intesa, si manifesta
nell’“ordinare le cose ad un fine” (“ordinare res in finem”), più precisamente essa destina
l’universo intero a Dio e alla sua gloria: “Totum universum, cum singulis suis partibus,
ordinatur in Deum sicut in finem, in quantum in eis per quamdam imitationem divina
86
Platone, Timeo, 49 a, trad. di C. Giarratano, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1971vol. 6, p.
401
87
ivi, 30 a, p. 377
88
Aristotele, La metafisica, , 7, 1072 a 25-26, 1072 b 3, 1073 a 25, a cura di G. Reale, Loffredo, 1968, II, pp. 242
e 245
97
bonitas repraesentatur ad gloriam Dei”. Tali concetti sono poi poeticamente così espressi
da Dante Alighieri:
“Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l’universo a Dio fa simigliante.
Qui veggion l’alte creature l’orma
Dell’etterno valore, il qual è fine
al quale è fatta la toccata norma.
Nell’ordine ch’io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,
più al principio loro e men vicine;
onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar dell’essere, e ciascuna
con istinto a lei dato che là porti”89.
B. Il rifiuto del finalismo: l’ordine è il risultato del determinismo della natura
Epicuro
Nel corso dei secoli nei riguardi del finalismo sono state avanzate varie critiche.
Nell’antichità la riproposizione della dottrina democritea da parte di Epicuro tenta di far
valere un’integrale interpretazione meccanicistica del mondo, che esclude esplicitamente
dagli eventi naturali la presenza di cause finali e fa sì che quel che non dipende dalla
causalità del moto sia il risultato del caso (→ Determinismo; Caso). I componenti
primordiali di tutto, cioè gli atomi, si uniscono e si separano tramite i contatti e gli urti,
determinando così il divenire della phýsis, in cui tutto si genera e si distrugge, nasce e
muore. Pretendere di interpretare finalisticamente e non meccanicamente gli eventi
significa rovesciare il corretto rapporto esistente tra le cose. Così, per esempio, nel
considerare l’organismo umano, il poeta latino Lucrezio, fedele discepolo di Epicuro, ci
invita a non incorrere nell’errore di “credere che la luminosa visione degli occhi sia stata
creata allo scopo di consentirci di guardare lontano e che l’altezza delle gambe e delle
cosce, ben fondata sui piedi, abbia la possibilità di piegarsi affinché riusciamo a muovere
lunghi passi”; infatti “nulla si è formato nel nostro corpo perché ce ne servissimo, ma ciò
che si è prodotto in esso determina anche il suo uso”. Similmente “la vista non c’era prima
che si formassero gli occhi né la parola prima che si producesse la lingua”. In generale
“tutte le membra furono prima che se ne facesse uso. Dunque non hanno potuto svilupparsi
in vista dell’utilità che se ne poteva derivare”. Quando si dice il contrario, si scambia
assurdamente l’effetto con la causa e ci si trova di fronte a ragionamenti che invertono
l’ordine reale, perché anticipano ciò che segue (e il poeta li qualifica per questo
praepostera); essi sono prodotti “da un modo di pensare corrotto” (perversa ratione)90.
Il meccanicismo moderno
Il meccanicismo moderno ripropone con ulteriore vigore la convinzione che in natura tutto
avviene in base alle leggi deterministiche del moto. È il successo della nuova scienza
meccanica che sospinge a ciò. Di per sé essa si dichiara incompetente a determinare i fini
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 65, art. 2 c;
Dante Alighieri, Paradiso, I, 103-114.
90
Lucrezio, De rerum natura, IV, vv. 825-842. In greco l’inversione logico-temporale dell’ordine dei termini è
indicata dalla nota espressione “hýsteron próteron”: ciò che è “posteriore” è posto come “anteriore”.
89
98
della cose. E la nuova filosofia la segue: si sente sollecitata a non restringere la spiegazione
meccanica alla dimensione fenomenica degli eventi naturali, ma ad estenderla
universalmente a tutto l’essere, implicando anche l’uomo. Sta in ciò il meccanicismo, che
esclude persino la fondatezza razionale del finalismo, ritenendola il frutto di un’illusione
soggettiva. Tuttavia le posizioni dei vari autori non sono assimilabili. Galileo Galilei non
nega la presenza della finalità nel mondo naturale, ma la ritiene semplicemente estranea alla
competenza della nuova ricerca sperimentale, che è rivolta soltanto all’individuazione delle
leggi del moto. Anche Francesco Bacone ritiene che l’individuazione delle cause finali sia
scientificamente sterile, ma, diversamente dal fisico italiano, considera di scarso valore le
stesse cause efficienti e insegue ambiguamente ancora le cause formali. (→ Metodo
sperimentale, Formazione del)
La filosofia cartesiana assume un’impostazione dualistica, in base alla quale il finalismo è
riconosciuto solo in riferimento alla res cogitans (la sostanza spirituale), ma è escluso dal
mondo fisico (res extensa). Questo dualismo evidenzia i suoi tratti più caratteristici e
problematici nella considerazione dell’uomo. Per Renato Cartesio, infatti, i corpi viventi
(gli animali e lo stesso corpo umano) operano soltanto in base alle leggi meccaniche, perché
sono automi, cioè macchine, il cui funzionamento sembra divenire sempre più accessibile
man mano che si sviluppano gli studi di anatomia. Ricordiamo che proprio in quegli anni
l’inglese William Harvey scopre la circolazione del sangue (De motu cordis et sanguinis,
1628). Cartesio non riconosce più l’anima vegetativa e l’anima sensitiva, cioè quei principi
che secondo l’aristotelismo presiedono con un immanente finalismo (le cosiddette
“entelechie”) allo sviluppo della vita non razionale. L’unico genere di anime che ancora
ammette sono gli spiriti razionali: li denomina res cogitantes, contrapponendoli alla res
extensa. La res cogitans è dotata di coscienza, è libera e ad essa si addice l’agire finalistico;
la res extensa, all’opposto, è necessariamente determinata dalle leggi meccaniche. Rimane
logicamente inspiegabile come due sostanze eterogenee possano entrare tra loro in rapporto
nel composto umano. Nella tradizione aristotelica, invece, l’anima e il corpo erano intesi
non come due sostanze, ma come due principi complementari (forma e materia, atto e
potenza), reciprocamente integrantisi allo scopo di realizzare un’unità sostanziale.
Baruch Spinoza, poi, esclude del tutto il finalismo dal mondo. Nel suo sistema ogni realtà
procede dall’unica sostanza divina ordine geometrico, cioè deduttivamente e con assoluta
necessità razionale. A suo giudizio, il finalismo è soltanto il frutto del pregiudizio e
dell’illusione antropocentrica, alimentata dal fatto che gli uomini da un lato sono
consapevoli dei propri desideri, dall’altro, tuttavia, non conoscono le vere cause degli
eventi naturali; sono perciò portati a orientare a se stessi tutte le occasioni da cui traggono
beneficio, considerandole “come mezzi per il loro utile” e rovesciando l’ordine corretto
delle cose. In questo senso hanno creato le nozioni di bene e male e, in base ad esse,
esprimono i conseguenti giudizi su ciò che avviene. Questo modo di pensare “considera
come effetto ciò che in realtà è causa, e viceversa. Poi rende posteriore ciò che per natura è
precedente”. Sono, questi, gli stessi termini con i quali Lucrezio, su citato, aveva espresso
la critica epicurea. Diversamente da Epicuro, però, Spinoza ritiene che nulla sia a caso e
ogni cosa si produca come il risultato di un’intrinseca e universale razionalità. Tale
risultato, comunque, va pensato come l’immancabile effetto di una causa, non come un
obiettivo intenzionalmente perseguito. Il filosofo olandese, infatti, sostiene che gli uomini,
ignorando i corretti rapporti causali, trasferiscono su Dio l’idea che hanno di se stessi e così
corrompono in senso antropomorfico la sua corretta rappresentazione, non avvedendosi
che, “se Dio agisce per un fine, necessariamente appetisce qualcosa di cui manca”. Nella
loro vanità essi immaginano che Dio agisca a loro beneficio, e questo pregiudizio tende a
99
permanere, nonostante che esso sia smentito dall’evidenza dei fatti, perché “vantaggi e
svantaggi capitano egualmente ai giusti e agli ingiusti senza distinzione”. Inoltre rinforzano
la loro illusione con nuovi espedienti giustificativi, affidandosi al mistero, perché “hanno
stabilito come cosa certa che i giudizi degli Dei superano di gran lunga la comprensione
umana”. A tale proposito Spinoza osserva amaramente che questo rifugiarsi nella volontà di
Dio è come ripararsi “nell’asilo dell’ignoranza”91.
C. Il finalismo e il determinismo sono compatibili: G.W. Leibniz e I. Kant
G.W. Leibniz pensa che sia possibile conciliare le legittime esigenze dei philosophi novi
con l’insegnamento della philosophia perennis, in particolare con l’aristotelismo (→
Philosophia perennis). Egli cerca di rendere compatibili il meccanicismo e il finalismo,
individuando per l’uno e per l’altro due diversi livelli di applicazione: il meccanicismo
riguarda il piano fenomenico della realtà, mentre il finalismo va riferito alla sua dimensione
metafisica, più profonda e perciò più vera. A questo livello egli individua la presenza delle
monadi, sostanze semplici e immateriali, nel cui ambito emergono, a livelli
progressivamente più elevati, la vita, l’attività psichica e la coscienza. Nel descrivere la
natura della monade Leibniz si avvale della nozione aristotelica di entelechìa, che gli
consente di affermare l’esistenza in natura di un finalismo originario e di un particolare
dinamismo, che Cartesio non era stato in grado di cogliere. Contro il filosofo francese egli
pensa di poter sostenere che quel che si conserva costante nel movimento è la “forza viva”
(l’energia cinetica), non la semplice “quantità di moto”. La forza è diversa dal movimento.
Ciò è reso evidente dal fatto che anche un corpo fermo, in quanto resiste al moto, possiede
una forza. Il movimento, invece, è un semplice fenomeno, cioè una variazione dei rapporti
spaziali nel tempo. Pertanto Leibniz pensa di poter denunciare il “memorabile errore” di
Cartesio, argomentando questa denuncia nella Brevis demonstratio erroris mirabilis
Cartesii (1686). Egli, poi, estende il finalismo alle infinite relazioni tra le monadi
dell’universo: il loro ordine si configura un’armonia prestabilita da Dio, che lo rende “il
migliore dei mondi possibili”. → Teodicea
Immanuel Kant conferma e porta a compimento l’epistemologia moderna anche in
relazione alla questione del finalismo. Egli è convinto che l’unica visione scientifica del
mondo sia quella meccanicistica, basata sulla categoria di causa-effetto; tuttavia ritiene che
nella nostra mente vi sia una tendenza irresistibile a pensare finalisticamente soprattutto il
mondo vivente. Ne parla soprattutto nella Critica del Giudizio (1790). La considerazione
puramente meccanica degli organismi biologici è da lui percepita come non sufficiente, al
punto che a suo giudizio “si può dire arditamente che è assurdo sperare che un giorno possa
sorgere un Newton capace di far comprendere secondo cause meccaniche anche solo la
produzione di un filo d’erba”92. L’interpretazione teleologica è espressione del sentimento e
non della ragione teoretica. Essa induce a considerare il mondo naturale “come se” fosse
organizzato secondo un fine. Pertanto ha un valore esclusivamente regolativo e non
costitutivo, perché cerca d’integrare il meccanicismo della fisica con una visione della
natura più soddisfacente per i bisogni morali dell’uomo. Il finalismo, infatti, è connesso alla
caratteristica propria dell’uomo di agire autonomamente secondo liberi scopi.
Henri Bergson: sia il determinismo che il finalismo sono inadeguati
B. Spinoza, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, “Appendice alla parte prima”, trad. di Sossio
Giametta, Boringhieri, 1971, pp. 58-66
92
I. Kant, Critica del Giudizio, a cura di A. Bosi, UTET, 1993, p. 369
91
100
Un inconsueto rifiuto del finalismo è presente nella filosofia spiritualistica di Henri
Bergson. Secondo questo filosofo tutto nel mondo avviene in virtù di un élan vital (slancio
vitale), l’energia che sospinge l’evoluzione da dietro (vis a tergo), cioè senza alcuna
possibilità di prevedere la formazione delle cose. Egli rifiuta come inadeguate sia la
rappresentazione meccanicistica che quella finalistica, perché in entrambe la realtà è
presupposta o nella causa meccanica o in quella finale, così che se ne possono prefigurare
tutti gli sviluppi futuri in conformità ad un disegno preesistente. Il finalismo, come il
determinismo, compromette la libera creatività del mondo. Nell’una e nell’altra forma la
causalità agisce in maniera tale da alterare la vera natura della “durata”, cioè il tempo
vissuto, perché le dà una configurazione spaziale di momenti esterni l’uno all’altro. →
Spontaneità; Tempo (Henri Bergson: il tempo spazializzato e la durata)
101
G
GEOMETRIE NON EUCLIDEE
Uno dei più importanti sviluppi della matematica ottocentesca fu rappresentato
dall’introduzione delle geometrie non euclidee, che misero in crisi l’antica e consolidata
convinzione che le proprietà dello spazio geometrico fossero le stesse dello spazio fisico.
La costruzione di geometrie alternative a quella classica dipese da un problema antico,
riguardante il quinto postulato di Euclide, che non aveva mai pienamente persuaso a
proposito della sua assiomatica evidenza e già dall’antichità aveva sollecitato i matematici a
provarne la natura teorematica attraverso una sua deduzione dagli altri postulati, tuttavia
senza che si conseguissero effettivi e conclusivi risultati.
All’inizio del XVIII secolo l’italiano Girolamo Saccheri tentò di confermarne la validità
per via indiretta, mediante una dimostrazione per assurdo, che aveva lo scopo di confutare
le ipotesi alternative. Queste erano accolte provvisoriamente, per rendere evidente che da
esse derivavano conseguenze contraddittorie e quindi logicamente insostenibili. Ora, se il
postulato euclideo affermava che attraverso un punto esterno ad una retta può passare una
sola parallela, le alternative ad esso dovevano invece affermare che ne possono passare
infinite o nessuna. Incorrendo in qualche errore, Saccheri credette di trovare la
contraddizione che cercava; in realtà predispose inconsapevolmente le condizioni logiche
per la costruzione di geometrie non euclidee. → Confutazione
Nell’immediato ci si dimenticò del suo tentativo e solo nel secolo successivo si riuscì ad
evidenziare compiutamente l’effettiva indipendenza del quinto postulato euclideo rispetto
agli altri quattro. In particolare il tedesco Karl Friedrich Gauss, il russo Nikolaj Ivanovič
Lobačevskij e l’ungherese János Bolyai, procedendo ciascuno per proprio conto, lo
sostituirono con il postulato, secondo il quale per un punto esterno ad una retta è possibile
tracciare infinite parallele ad essa, ottenendo una nuova geometria perfettamente coerente,
detta iperbolica. Nella seconda metà del secolo il tedesco B. Riemann, assumendo invece
uno spazio in cui non si dessero parallele, fondò la geometria ellittica.
Un’iniziativa ulteriormente innovativa e per molti sorprendente fu l’applicazione delle
nuove geometrie alla fisica, in particolare della geometria ellittica di Riemann alla teoria
della relatività generale di A. Einstein nel 1916.
A puntualizzare i nuovi criteri epistemologici della geometria, in termini che poi vennero
generalmente accolti, fu H. Poincaré. Egli assunse una posizione convenzionalistica, in base
alla quale la domanda quale sia la geometria “più vera” appariva ormai priva di senso,
perché “tanto varrebbe domandare se il sistema metrico è vero e le antiche misure false; se
le coordinate cartesiane sono vere e le coordinate polari false. Una geometria non può
essere più vera di un’altra, può soltanto essere più comoda”3. Perciò, secondo Poincaré, gli
assiomi vanno interpretati come semplici convenzioni, che sono liberamente scelte e
stipulate da coloro che nella comunità scientifica ne fanno uso. La geometria è una scienza
rigorosamente formale, che ricerca entro se stessa il proprio fondamento, svincolandosi da
ogni riferimento intuitivo e da ogni criterio di presunta verosimiglianza. → Assioma;
Postulato
3
H. Poincaré, La scienza e l’ipotesi, a cura di F. Albergamo, La Nuova Italia, 1950, p. 58
102
GNOSEOLOGIA
È un termine che il tedesco Alexander Gottlieb Baumgarten introdusse nel XVIII secolo,
derivandolo dalla composizione della parola greca γνῶσις (gnôsis), che significa
“conoscenza”, e della forma sostantivale astratta λογία, originata da λόγος (discorso). Con
esso egli intese designare genericamente la teoria della conoscenza, che suddivise in due
parti: l’estetica e la logica, riguardanti rispettivamente la conoscenza sensibile e la
conoscenza razionale. → Estetica; Logica
Nell’ambito più generale della filosofia, la gnoseologia considera per lo più i processi, le
forme e i modi della conoscenza. Si rinvia, quindi, ai termini particolari che specificano
queste forme e questi modi. → Intuizione; Dimostrazione; Astrazione; Immaginazione;
Rappresentazione; Specie; Definizione; Intelletto e Ragione, Ipotesi; Metodo; Logica;
Scienza; Opinione; Credenza; Fede
Va comunque precisato che talora si può riscontrare un più ampio uso del termine
“gnoseologia”, che lo riferisce anche alla questione critica della conoscenza, cioè lo applica
ai problemi che più specificamente sono attribuiti all’epistemologia, intesa kantianamente
come la disciplina che ha per oggetto le condizioni di validità delle nostre conoscenze. →
Epistemologia
103
I
IMMORTALITÀ DELL’ANIMA
Nella storia della filosofia occidentale la tesi dell’immortalità dell’anima è in forma
eminente legata al nome di Platone (→ Anima). Secondo il grande filosofo greco l’anima
preesiste al corpo ed è destinata a sopravvivergli immortale. La condizione corporea, infatti,
è la conseguenza di un’oscura colpa e perciò è desiderabile esserne liberati dalla morte;
tuttavia è illecito il suicidio, perché gli uomini appartengono agli dei, che “sono coloro che
hanno cura di noi”40. Non a caso Socrate, immortalato dai dialoghi del suo discepolo, invita
gli amici, che gli manifestano la loro apprensione per la sua sorte, a non considerare una
sventura la sua dipartita ormai vicina; non vuol apparire loro “assai da meno dei cigni, i
quali, appena si accorgono di dover morire, [...] cantano allora il loro canto più lungo e più
bello, presi come sono dalla letizia che di lì a poco se ne andranno al dio di cui sono
devoti”41. La filosofia insegna che la vita non è altro che preparazione a quel momento.
Gli argomenti di Platone
Platone sa che “quanto all’anima c’è negli uomini molta incredulità; perché temono che
quand’ella si sia distaccata dal corpo, non esista più in alcun luogo, e si guasti e perisca il
giorno stesso in cui l’uomo muore; temono cioè che, nell’atto medesimo in cui ella si
distacca dal corpo e ne esce, subito come soffio o fumo si dissipi e voli via, e così cessi
dall’esistere del tutto”. Pertanto, facendosi forte della proprie opposte convinzioni,
s’impegna alla dimostrazione di due cose: “primo, che l’anima séguita a esistere pur
quando l’uomo è morto; secondo, ch’ella conserva potere e intelligenza”42. A questo scopo
nel Fedone svolge diversi argomenti.
L’argomento dei contrari43, di ispirazione eraclitea, sostiene che in analogia con ciò che
avviene in natura, per cui tutto si genera dal suo contrario (il grande dal piccolo, il
debole dal forte, il veloce dal lento, il male dal bene, ecc.), anche la morte si genera
dalla vita e la vita si genera dalla morte.
L’argomento della reminiscenza44 intende dimostrare che, se conoscere è ricordare, è
anche necessario ammettere che l’anima è indipendente dal corpo, preesistendogli in
una vita antecedente, nella quale ha appreso ciò che ora ricorda.
L’argomento della semplicità dell’anima45 afferma che solo ciò che è composto, come
il corpo, si decompone ed è soggetto al divenire; l’anima, invece, essendo immateriale
come le idee eterne, non può subire alcuna alterazione e “permane invariabilmente
costante”.
L’argomento che si basa sull’affinità dell’anima con le idee eterne è così descritto:
“L’anima, quando per qualche sua ricerca si vale del corpo, adoperando la vista o
l’udito o altro senso qualunque, [...] allora è trascinata dal corpo a cose che non sono
40
Platone, Fedone, 62 b, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, cit., p. 111
ivi, 84 e - 85 a, p. 143
42
ivi, 70 a-b, cit., pp. 121-122
43
ivi, 70 c - 72 e, cit., pp. 122 ss.
44
ivi, 72e - 76 a, pp. 126 ss.
45
ivi, 78 b - 79 a, pp. 134 s.
41
104
mai costanti, ed ella medesima va errando qua e là e si conturba e barcolla come ebbra
[...] Quando invece l’anima procede tutta sola in se stessa alla sua ricerca, allora se ne
va colà dov’è il puro, dov’è l’eterno e l’immortale e l’invariabile; e, come di questi è
congenere, così sempre insieme con questi si genera, ogni volta che le accade di
raccogliersi in se medesima e le è possibile”46.
L’argomento che si avvale della definizione dell’anima come principio della vita ci
obbliga a dire che, “qualunque cosa ella investa di sé, sempre dove entra arreca vita
[...] Dunque l’anima non sarà mai che possa accogliere in sé il contrario”, cioè la
morte47. Possiamo affiancare a questa citazione anche una del Fedro, che si basa sulla
definizione dell’anima come principio del proprio movimento (αὐτοκίνετον,
autokíneton): “L’anima è immortale; perché ciò che sempre si muove è immortale. Ora
ciò che provoca movimento in altro ed è mosso esso stesso da qualcos’altro, se subisce
un arresto di movimento smette di vivere. Solo dunque ciò che muove se stesso, in
quanto non può abbandonare se stesso, mai cessa di essere in moto; anzi è scaturigine e
principio di moto di tutte le cose che sono mosse. Ora, il principio non è generato
perché, mentre ogni cosa che nasce deve per forza nascere da un principio, questo
invece non deve essere generato da niente: se altrimenti il principio procedesse da
qualcosa, cesserebbe di essere ancora il principio. Inoltre, dal momento che non è
generato, per forza sarà immortale; perché, se il principio venisse a mancare, né questo
potrebbe nascere da altro, né altro da esso, visto che è necessario che tutto abbia un
principio”48.
L’impostazione problematica di Aristotele
La gnoseologia anti-innatistica di Aristotele sembra imporre uno stretto vincolo tra l’anima
e il corpo, in particolare una dipendenza del pensiero dalla conoscenza sensibile e
immaginativa, e quindi dell’anima intellettiva dal corpo; ma a questo riguardo lo Stagirita
rivela una qualche incertezza e incoerenza. Così nel trattato Dell’anima talora si esprime:
“Proprio dell’anima sembra il pensare: ma se anche il pensare è una specie di
immaginazione o non si ha senza l’immaginazione, ne segue che neppur esso esisterà
indipendentemente dal corpo”. Tuttavia in altri luoghi della medesima opera, in forme ora
incerte e ora più sicure, apre a prospettive diverse: “Riguardo all’intelletto e alla facoltà
speculativa la cosa non è ancora chiara: sembra però che sia un genere d’anima diverso e
che esso solo possa essere separato, come l’eterno dal corruttibile”. E anche là dove
distingue i due intelletti, l’attivo e il passivo, egli descrive il primo nei termini seguenti:
“Questo intelletto è separato, immisto e impassivo [rispetto alla realtà sensibile], è per sua
essenza atto: e, infatti, l’agente è sempre più eccellente del paziente [...] Separato, esso è
solo quel che realmente è, e questo solo è immortale ed eterno”49. Altrove Aristotele
riconferma questa convinzione: “Solo l’intelligenza giunge dall’esterno e solo essa è divina,
perché l’attività corporea non ha nulla in comune con la sua attività”50.
Questi celebri passi saranno sottoposti nei secoli successivi a interpretazioni diverse e ad
aspri dibattiti. Alessandro di Afrodisia (III sec. d. C.), per esempio, intenderà l’intelletto
attivo come una realtà immortale e divina, coincidente con la mente stessa di Dio e presente
46
ivi, 79 c-d, p. 136
ivi, 105 d, p. 173
48
Platone, Fedro, 245 c-e, trad. di P. Pucci, in Opere complete, cit., vol. 3, pp. 243-244
49
Aristotele, Dell’anima, I (A), 1, 403a 8-10; II (B), 2, 413b 25-27; III (), 5, 430 a 18-23; trad. di R. Laurenti, in
Opere, cit., vol. 4, rispettiv. pp. 102, 132, 176-177
50
Aristotele, Riproduzione degli animali, II (B) 3, 736 b 27-29, trad. di D. Lanza, in Opere, cit., vol. 5, pp. 207208
47
105
in tutti gli uomini. L’arabo Averroè (XII sec.) considererà sia l’intelletto attivo che
l’intelletto passivo come sostanze separate, divine e uniche per tutti gli uomini, anche se
inferiori a Dio, perché coincidenti con l’intelligenza motrice della decima sfera; dunque
questa concezione comporterà la negazione dell’immortalità individuale. Tommaso
d’Aquino (XIII sec.), invece, includerà l’intelletto attivo nell’anima di ogni singolo uomo e
interpreterà l’affermazione di Aristotele sulla “separatezza” dell’intelletto nel senso che
esso “non è l’attività di alcun organo del corpo”51, al cui destino mortale è pertanto
sottratto.
Plotino: immortalità dell’anima, ma non risurrezione dei corpi
Plotino riprende e riconferma la tesi del dualismo antropologico di Platone. Si rifà
direttamente alle parole del grande maestro, quando ricorda che all’anima “cadder le ali” ed
essa “cadde nei ceppi del corpo”, perciò “è imprigionata e regge la sua catena; [...] ella è,
come si dice, ‘nel sepolcro’ e ‘nella caverna’; ma se si volge al pensare, ella è sciolta dalle
catene e risale, appena abbia preso dalla reminiscenza lo scatto iniziale, alla
contemplazione dell’Essere verace; poiché ella serba qualcosa, sempre: qualcosa che,
nonostante tutto, resta pur sempre in alto”52. Pertanto a Plotino appare inaccettabile la
prospettiva cristiana della risurrezione dei corpi, perché “quanto di anima è nel corpo non è
altro che anima addormentata; e il risveglio verace consiste nella risurrezione - quella vera
risurrezione che è dal corpo, non col corpo; poiché risorgere con un corpo equivale a cadere
da un sonno in un altro, a passare, per così dire, da un letto a un altro: ma il vero levarsi ha
qualcosa di definitivo: non da un corpo solo ma da tutti i corpi; i quali son proprio
radicalmente contrari all’anima”53.
Tommaso d’Aquino: argomenti razionali a supporto delle verità di fede
La teoria aristotelica, opportunamente interpretata, consente a Tommaso d’Aquino di
rappresentare l’unità psicosomatica dell’uomo in maniera tale da salvaguardare
contemporaneamente le due prospettive indicate dalla fede cristiana: la sopravvivenza
dell’anima oltre la morte e la risurrezione finale. Egli cerca di conciliare due tesi
apparentemente contraddittorie: a) l’anima umana è una forma sussistente, che in quanto
tale non dipende intrinsecamente dal corpo e dal suo destino; b) l’anima umana è la forma
sostanziale del corpo. Consideriamole distintamente.
A) L’anima umana è una forma sussistente, che in quanto tale non dipende intrinsecamente
dal corpo e dal suo destino; pertanto, quando esprime le sue funzioni spirituali, sia
teoretiche che pratiche, palesa una costitutiva autonomia dalla materia, dimostrabile sulla
base delle seguenti evidenze.
I nostri concetti si sottraggono ai limiti materiali di ciò che è nello spazio e nel tempo,
perché “i sensi non percepiscono la realtà se non nella puntualità del qui e ora, ma
l’intelletto coglie l’essere in maniera assoluta e valida sempre”; infatti, l’anima
razionale recepisce la realtà sensibile “secundum modum suum”: “mediante l’intelletto
conosce i corpi con una cognizione immateriale, universale e necessaria”, realizzando
così quella sua condizione specifica, che era stata indicata da Aristotele nella capacità
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 76, art. 1 ad primum
Plotino, Enneadi, IV, 8, IV, a cura di V. Cilento, Laterza, 1973, vol. II, pp. 338 s.
53
Plotino, Enneadi, III, 6, VI, cit., vol. II, p. 93
51
52
106
metafisica di riferirsi alla totalità dell’essere, cioè di “essere in certo qual modo tutto”
(quodammodo animam esse omnia)54.
Siamo consapevoli della verità e assolutezza dei principi, della necessità e immutabilità
delle relazioni logiche, che non dipendono dalle situazioni contingenti e relative
dell’esperienza sensibile, ma rinviano a quel fondamento metafisico, universale e
necessario, che è l’identità trascendentale del verum e dell’ens, in base al quale “non si
può conoscere l’essere se non sotto l’aspetto del vero” (ens non potest apprehendi sine
ratione veri)55.
Il nostro intelletto ha il potere di una “reditio completa” su se stesso, cioè è in grado di
ritornare a sé (redire ad se) e “dalla conoscenza di ciò che è intelligibile esso deriva la
conoscenza della sua stessa attività intellettiva” (ex eo quod cognoscit intelligibile,
intelligit ipsum suum intelligere)56. Questa sua capacità di ripiegarsi su se stesso
(reflexio intellectus supra se ipsum)57 è solitamente denominata “riflessione”,
“autocoscienza” e “interiorità”.
Siamo capaci di trascendenza sia nel pensare l’assoluto sia nel volere liberamente i
beni spirituali (la verità e la virtù) a preferenza dei beni immediati e sensibili. La nostra
libertà consiste nella capacità di autodeterminarci, perché abbiamo in noi stessi
l’iniziativa del nostro agire in virtù del libero arbitrio (“homo per liberum arbitrium
seipsum movet ad agendum”58). Questa condizione deriva dalla nostra natura razionale,
nel senso che “solo un ente fornito d’intelletto può agire in base ad un libero giudizio,
perché conosce la ragione universale del bene, dalla quale può giudicare che questo o
quello è buono. Perciò, ovunque c’è intelletto, c’è libero arbitrio”(ubicumque est
intellectus, est liberum arbitrium)59.
Per tutto ciò che s’è appena detto, è evidente che “il principio intellettuale che si
chiama mente o intelletto esprime di per sé un’attività alla quale il corpo non partecipa.
Ora non può operare autonomamente se non ciò che sussiste di per sé”. L’anima è
principio attivo dell’essere, è forma (esse autem per se convenit formae, quae est
actus); in quanto tale, “è impossibile che si separi da se stessa; quindi è impossibile che
una forma sussistente cessi di essere”; la materia, all’opposto, è passiva, “riceve
l’essere in atto, perché riceve la forma; perciò può corrompersi, perché la forma si
separa da essa”60.
Per sostenere l’immortalità dell’anima intellettiva, Tommaso ricorre anche ad un
argomento psicologico, connesso al desiderio umano, che così formula: “Ogni ente
dotato d’intelligenza desidera naturalmente di esistere per sempre. Ma non può essere
vano un desiderio naturale. Dunque ogni sostanza provvista d’intelletto è
incorruttibile” (Omne habens intellectum naturaliter desiderat esse semper. Naturale
autem desiderium non potest esse inane. Omnis igitur intellectualis substantia est
incorruptibilis)61.
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 75, art. 6 c; q. 84, art. 1 c; art. 2 ad secundum; v. Aristotele,
Dell’anima, III (), 8, 431 b.
55
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 16, art. 3 ad tertium
56
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 14, art. 2 ad tertium
57
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 76 art. 2 ad quartum; I, q. 85, art. 2 c; I, q. 87, art. 1 ad tertium
58
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 83, art. 1 ad tertium
59
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 59, art. 3 c
60
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 75, art. 2 c; art. 6 c
61
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 75, art. 6 c
54
107
B) L’anima umana è la forma sostanziale del corpo, ossia il principio che ne realizza
effettivamente le specifiche potenzialità; in questo senso e in opposizione al dualismo
dell’antropologia platonica il corpo è lo stesso attuarsi dell’anima nel substrato di per sé
indeterminato e potenziale della materia, e quindi è la condizione della sua perfetta
esistenza. La corporeità è una positiva ed intrinseca dimensione della natura umana, una
condizione originaria e necessaria della sua concretezza naturale, storica e sociale. D’altra
parte, il corpo, organicamente funzionante, ha l’attualità sostanziale che riceve dalla sua
forma, cioè dall’anima, senza la quale non può sussistere, come prova il dissolversi del
cadavere.
Ora, l’uomo dipende da Dio nel suo essere e nella destinazione finale, e soltanto in
riferimento a lui può attuare il proprio orientamento alla trascendenza e soddisfare il
desiderio di beatitudine, perché “ogni intelletto desidera naturalmente la visione dell’essere
divino” (omnis intellectus naturaliter desiderat divinae substantiae visionem)62. Perciò, se
da un lato “è impossibile che il nostro intelletto […] realizzi effettivamente la sua funzione
se non si rivolge alle rappresentazioni sensibili della nostra immaginazione (phantasmata)”,
tuttavia ciò riguarda “lo stato della vita presente, nel quale è congiunto ad un corpo
soggetto ai limiti della sensibilità”63, e non un’eventuale condizione di beatitudine
soprannaturale, perché “la visione dell’essenza divina non dipende dai phantasmata”.
Quindi “l’anima può essere beata senza il corpo”64. Essa comunque mantiene la sua
condizione ontologica una volta che sia stata separata dal corpo; perciò le “si addice
essenzialmente (secundum se) l’unione con il corpo”, per la quale conserva “un’attitudine e
un’inclinazione naturale”65. Per questa ragione, relativamente alla prospettiva escatologica
della risurrezione dalla morte, Tommaso pensa che, “come ogni parte è imperfetta e si
completa nella sua totalità, […] così anche l’anima è naturalmente più perfetta quando è nel
tutto, cioè nell’uomo composto di anima e di corpo, rispetto a quando è di per sé separata” e
“sarà più perfetta la beatitudine dell’anima dopo la riassunzione del corpo rispetto a
prima”66.
I dubbi di Pietro Pomponazzi
Il rinascimentale Pietro Pomponazzi (1462-1524), ricorrendo ad argomentazioni
esclusivamente filosofiche, che in apparenza non intendono intaccare le convinzioni del
dogma cristiano, nel Tractatus de immortalitate animae (1516) segue l’interpretazione dei
testi aristotelici data da Alessandro di Afrodisia e sostiene l’integrale naturalità dell’anima
umana, testimoniata dalla stretta dipendenza in cui essa è rispetto alla realtà sensibile.
Questa, infatti, è sia l’oggetto necessario della sua attività conoscitiva, perché, secondo la
tradizionale formula, nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu (niente è
nell’intelletto che prima non sia stato nei sensi), sia, in quanto corpo organico, il soggetto
materiale d’inerenza, del quale ha bisogno per esistere e operare. Per queste ragioni egli è
convinto che non sia pensabile un’autonomia dell’anima, che ne giustifichi la separabilità e
quindi l’immortalità. D’altra parte ritiene che la sua immortalità, anche se non può essere
razionalmente provata, debba essere ammessa per fede. Così egli sembra voler cautelarsi
contro gli interventi censori dell’autorità ecclesiastica con un atteggiamento che ha fatto
pensare ad una sua adesione alla cosiddetta “teoria della doppia verità”, già attribuita alcuni
secoli prima ad Averroè. → Doppia verità
Tommaso d’Aquino, Contra Gentiles, 1. III, c. 57
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 84, art. 7 c
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 4, art. 5 c
65
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 76, art. 1 ad sextum
66
Tommaso d’Aquino, Commento alle Sentenze, IV, 49 q. 1, a. 4 ql. 1
62
63
64
108
Gli argomenti di J.J. Rousseau e I. Kant
L’adesione di J.J. Rousseau e I. Kant alla tesi dell’immortalità dell’anima assume la forma
di una postulazione, che non è affatto arbitraria, ma si giustifica sulla base di esigenze
morali.
Secondo Rousseau, la prospettiva di una giustizia oltre la morte, che si fonda sull’“Essere
giusto che regge tutto” e “saprà ben compensare”, è ciò che consente di non cedere allo
sconforto di fronte allo scandalo dell’ingiustizia presente in questo mondo. Perciò
nell’Emilio egli afferma decisamente: “Quand’anche non avessi altra prova
dell’immaterialità dell’anima che il trionfo del cattivo e l’oppressione del giusto in questo
mondo, questo solo m’impedirebbe di dubitarne”67.
Kant affronta la questione dell’immortalità dell’anima innanzitutto teoreticamente nella
Critica della ragion pura. Egli ritiene che la tradizionale idea metafisica di anima sia il
risultato di paralogismi, che intervengono quando la ragione pretende di varcare i propri
limiti e identifica surrettiziamente l’anima con la coscienza trascendentale, alla quale
applica la categoria di sostanza, attribuendo ad essa la spiritualità e l’immortalità. L’esito a
cui conduce la critica teoretica di Kant è un esplicito agnosticismo.
Nella Critica della ragion pratica, poi, egli ripropone il problema in termini nuovi,
risolvendolo positivamente nell’ambito della questione morale. La tesi dell’immortalità
dell’anima, così come quelle della libertà e dell’esistenza di Dio, assume la forma di un
“postulato” e l’adesione ad essa è il risultato di un atto di “fede razionale”, ossia di
un’esigenza fondamentale della nostra ragione moralmente impegnata, che avverte la
necessità di “sopprimere il sapere per sostituirvi la fede”68. Teoreticamente, infatti,
l’immortalità dell’anima non è dimostrabile e quindi è soltanto un’ipotesi; tuttavia ci
sentiamo obbligati a sostenerla, perché senza di essa vien meno la plausibilità
dell’imperativo morale, cioè il senso etico della nostra esistenza. È un dato d’esperienza che
la perfezione morale non coincide con la morte fisica; pertanto si richiede che sia data
all’uomo la possibilità di proseguire incessantemente nel suo perfezionamento oltre la
morte, per corrispondere sempre più all’imperativo della legge morale. Ecco a questo
riguardo le esplicite parole di Kant: “La conformità completa della volontà con la legge
morale è la santità, una perfezione di cui non è capace nessun essere razionale del mondo
sensibile, in nessun momento della sua esistenza. Poiché essa, mentre nondimeno viene
richiesta come praticamente necessaria, può esser trovata soltanto in un progresso che va
all’infinito verso quella conformità completa […] è necessario ammettere un tale progresso
pratico come l’oggetto reale della nostra volontà. Ma questo progresso infinito è possibile
solo supponendo un’esistenza che continui all’infinito, e una personalità dello stesso essere
razionale”69.
IO
È la denominazione pronominale della coscienza e dell’autocoscienza, cioè della
soggettività pensante e libera. La nozione che essa implica è fondamentale nella filosofia
moderna e nella psicologia. → Coscienza; Autocoscienza
67
J.-J. Rousseau, Emilio, libro IV, in Opere, a cura di P. Rossi, Sansoni, 1972, p. 559
I. Kant, Critica della ragion pratica, Parte I, Libro II, Cap. II, 5, a cura di F. Capra, Laterza, 1971, pp. 152-153;
Critica della ragion pura, a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, riveduta da V. Mathieu, Laterza, 1971,
Prefazione alla seconda edizione, p. 28.
69
I. Kant, Critica della ragion pratica, Parte I, Libro II, Cap. II, 4, cit., pp. 148-149
68
109
R. Cartesio
Nell’intuizione illuminante del “cogito, ergo sum”, cioè nell’autocoscienza, Cartesio coglie
il punto d’Archimede, cioè il fondamento assolutamente indubitabile del sapere, che da
esso può svilupparsi replicandone metodicamente il criterio dell’evidenza.
Nella sua natura pensante l’io appare a Cartesio come res cogitans, cioè sostanza
spirituale, i cui attributi essenziali sono opposti a quelli della res extensa, identificantesi con
il mondo materiale e comprendente in sé il nostro corpo. Da ciò egli deriva la propria
ontologia dualistica, riguardante anche l’uomo. → Cartesianesimo
Inoltre il suo nuovo modo di concepire le idee come gli oggetti stessi della conoscenza,
orienta la gnoseologia moderna in senso fenomenistico. Infatti, se la mente, diversamente
dalla teoria classica, ha come proprio oggetto intenzionale un’idea e non un ente esistente al
di là di sé, non si capisce come sia possibile poi affermare che la realtà sussiste
esternamente al soggetto conoscente, cioè all’io. → Fenomenismo
I. Kant
Anche l’analisi teoretica del criticismo kantiano s’impernia sull’“io penso”, inteso tuttavia
come “coscienza trascendentale”. Esso, infatti, consiste non nella coscienza empiricamente
varia e mutevole dei singoli individui, ma nella comune struttura funzionale della mente
umana, considerata nella sua universalità; perciò, ha un carattere solo formale, che si
esprime nei modi di operare propri dell’intelletto, ossia attraverso le dodici attività
sintetiche delle categorie, che la coscienza trascendentale unifica e fonda, non consentendo
che l’attività pensante risulti frantumata e dispersa.
J.G. Fichte
Nell’idealismo fichtiano l’“Io” è l’origine dinamica di tutto ciò che esiste, e innanzitutto di
se stesso. È infatti causa sui, attività assoluta che non è limitata da qualcosa di esterno;
pertanto è infinito. → Causa sui
Tutto da lui procede, secondo la formula: “L’Io oppone in sé medesimo all’io divisibile
[cioè ad ogni soggetto empirico e finito] un non-io divisibile [cioè ognuno degli enti
naturali come oggetto opposto all’io]”. L’attività, mediante la quale l’Io infinito pone
all’interno di sé il non-io, è denominata kantianamente “immaginazione produttiva”. Essa,
tuttavia, diversamente da come l’aveva intesa il filosofo dell’Illuminismo, determina non
solo formalmente, ma anche materialmente la realtà intera del mondo, nel senso che la crea.
L’attività di questa originaria immaginazione creatrice è necessariamente inconscia, perché
la coscienza implica sempre un’opposizione, cioè la dualità già costituita tra un soggetto
pensante e un oggetto pensato. La coscienza, pertanto, interviene solo successivamente su
ciò che è già posto.
Nell’interpretazione di Fichte la realtà oggettiva (il non-io) costituisce il momento
negativo dialettico, che si oppone all’impegno e allo sforzo volitivo dei singoli io empirici.
Questi necessitano delle difficoltà e degli ostacoli, per affermare e realizzare la propria
libertà. Non a caso l’idealismo fichtiano è qualificato sia come “soggettivo”, per
l’insistenza con la quale rimarca la radicale preminenza del soggetto, sia come “etico”, per
la tensione morale che all’io è richiesta nell’affermare la propria attività e autonomia.
Martin Buber
Secondo il filosofo ebreo di lingua tedesca Martin Buber (1878-1965) il termine “Io”
qualifica la condizione personale dell’uomo, considerato nella sua strutturale relazione
dialogica con gli altri esseri dotati di spiritualità, ognuno dei quali si rapporta a lui in una
110
reciprocità d’interlocuzione, che caratterizza l’altro come un “Tu” e non come un semplice
Es, pronome tedesco di genere neutro, corrispondente al nostro “esso”, riferibile ad un
qualsiasi altro ente naturale. Soltanto nella relazione con un Tu l’uomo diventa un Io. La
dialogicità della relazione personale raggiunge il suo vertice nei riguardi di Dio. Buber
svolse questa tematica nello scritto Io e tu (1923).
S. Freud
L’Io è anche la denominazione di una delle tre istanze, che nella nota topica della
psicoanalisi di Sigmund Freud strutturano la complessità funzionale della nostra psiche.
All’Io compete il ruolo di organizzare la personalità secondo il principio di realtà, che ci
obbliga a tener conto delle esigenze oggettive della logica e di ciò che concretamente
richiedono i nostri rapporti con la natura e la società. L’Io si confronta con l’Es e il Superio, cioè rispettivamente con i bisogni primordiali della specie e con gli impegni di
civilizzazione richiesti dalla società. La sua formazione positiva richiede equilibrio e
compromesso. Quando questi non sono più garantiti e l’automatismo dell’Es eccede o il
Super-io prevarica, ci troviamo di fronte a situazioni variamente patologiche e a forme di
asocialità: se nel conflitto tra le opposte pretese l’equilibrio dell’Io risulta soltanto incrinato,
si configura un disturbo della personalità denominato “nevrosi”; se invece all’Io è tolto ogni
spazio di autonomia e la sua stessa personalità appare annullata, allora la sua condizione
esistenziale presenta la gravità della “psicosi” o follia. → Psicoanalisi
111
L
LANGUE / PAROLE
Si tratta di una combinazione oppositiva di termini, introdotta dal linguista svizzero
Ferdinand de Saussure (1857-1913) nell’opera Corso di linguistica generale (1916,
postumo).
Con langue egli intese designare il codice linguistico, interpretandolo come un sistema,
cioè una totalità organizzata di segni comunicativi, stabilita nell’ambito di un determinato
gruppo sociale. Ogni individuo, appartenente a questo gruppo, lo assimila e personalmente
se ne avvale, applicandolo come parole nella concretezza della vita quotidiana e
contribuendo egli stesso a farlo evolvere nel tempo.
Il binomio di “langue” e “parole” richiama quello, non meno noto, di “competenza” ed
“esecuzione” di N. Chomsky. → Competenza / esecuzione; Linguaggio
LIBERTÀ
La libertà è una proprietà essenziale della volontà, che è la facoltà con la quale un ente
razionale determina il proprio agire. Può essere favorita o mortificata dalle mutevoli
condizioni fisiche, sociali e culturali in cui si opera; infatti non è mai illimitata, ma è
obbligata a rapportarsi alla concreta situazione esistenziale nella quale si vive. Qui
accenniamo soltanto alle riflessioni che su di essa hanno svolto Pico della Mirandola, Karl
Jaspers e Jean-Paul Sartre. Per altri aspetti della complessa tematica che il concetto di
libertà può richiamare, si vedano le voci → Volontà; Libero arbitrio
Pico della Mirandola
Di Pico della Mirandola (1463-1494) è famosa l’orazione De hominis dignitate (1486),
tradizionalmente considerata un vero e proprio manifesto dell’umanesimo rinascimentale.
In essa traspare un’esaltante e orgogliosa consapevolezza della centralità dell’uomo
nell’universo e dell’importante funzione che a lui, intermediario libero e responsabile
dell’intera creazione, è stata affidata da Dio. Secondo Pico la complessa natura di questo
ente sintetizza i diversi aspetti del mondo, rispetto al quale, infatti, è un “microcosmo” e, in
quanto copula mundi, è l’anello di congiunzione tra lo spirito e la materia.
Pico fa pronunciare a Dio creatore le seguenti parole: “Non ti ho dato, Adamo, né un
posto determinato, né un aspetto tuo proprio, né alcuna prerogativa tua [...] La natura
determinata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai, da
nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai. Ti posi nel
mezzo del mondo, perché di là tu meglio scorgessi tutto ciò che è nel tuo mondo. Non ti ho
fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e
sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto. Tu potrai
degenerare nelle cose inferiori, che sono i bruti; tu potrai rigenerarti, secondo il tuo volere,
nelle cose superiori che sono divine”32.
Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo, trad. di E. Garin, a cura di G. Tognon, La Scuola, 1987,
p. 6
32
112
Karl Jaspers
La libertà dell’uomo non è illimitata e incondizionata. Sono stati principalmente i filosofi
dell’esistenza a rilevare l’importanza delle condizioni effettive della libertà. Ci si può,
infatti, realizzare sempre e solo in una particolare “situazione” esistenziale, nella quale
ognuno nella sua singolarità si configura inevitabilmente come un “Esserci” (→ Dasein)
rispetto al mondo di cui è parte. Da un lato la strutturale apertura alla trascendenza fa della
libertà una nostra caratteristica primaria ed essenziale, nel senso che ciascuno è ciò che
sceglie di essere; dall’altro, però, la possibilità di scelta è innanzitutto destinata ad accettare
ciò che si è. A questo proposito Karl Jaspers afferma: “Quando decido e agisco non sono
una totalità ma un io legato a quei determinati dati di fatto che mi si offrono nell’oggettività
e nella particolarità della mia situazione”. Ciò nonostante, agisce su di me la sollecitazione
a trascendere le condizioni date, ne avverto anche la premura, perché “il tempo già incalza”,
c’è “la necessità imposta dal tempo di venire ad una decisione e di scegliere tra vivere ora o
non vivere affatto”. È così che da un lato “nasce una specifica consapevolezza della
schiavitù che ci rende dipendenti dalle circostanze di tempo e di luogo”, dall’altro, tuttavia,
l’opzione, alla quale sono singolarmente chiamato in queste condizioni, “non è solo
espressione di un’irrimediabile negatività [...], ma è una scelta in cui divento consapevole di
quella libertà che è libertà originaria perché solo in essa mi riconosco, nella mia identità,
per quel che sono”33. → Situazione
Jean-Paul Sartre
Jean-Paul Sartre fa della libertà l’oggetto di una costante riflessione. Nel saggio L’essere e
il nulla (1943) afferma che l’intenzionalità costituisce la nostra coscienza come libertà,
impegnandola nella prospettiva di sempre nuove possibilità, in cui accade che i progetti
assunti varino di fronte a nuove scelte. Originariamente l’uomo è nulla, nel senso che a lui
spetta realizzarsi in una qualche direzione, perchè “la libertà umana precede l’essenza
dell’uomo e la rende possibile; l’essenza dell’essere umano è in sospeso nella sua libertà”.
La condizione emotiva che l’accompagna è l’angoscia. A questo riguardo il filosofo
francese si ispira direttamente a Søren Kierkegaard e a Martin Heidegger: mentre “la paura
è paura degli esseri del mondo, l’angoscia è angoscia di fronte a me stesso” e io “mi
angoscio proprio perché i miei comportamenti non sono che possibili”34. Ora, dire che
l’uomo è libero “non significa che esso sia fondamento a se stesso. [...] Noi siamo una
libertà che sceglie, ma non scegliamo di essere liberi: siamo condannati alla libertà”. Questa
è la “contingenza” della libertà, cioè la sua ineludibilità35.
Si dà una correlazione necessaria tra la coscienza e il mondo, perché la libertà non agisce
nel vuoto, ma integra nelle proprie finalità e nei propri progetti le condizioni oggettive in
cui si attiva. La situazione effettiva in cui ciascuno vive si presenta variamente
caratterizzata: “è il mio posto, il mio corpo, il mio passato, la mia posizione in quanto già
determinata dalle indicazioni degli altri, infine la mia relazione fondamentale con gli
altri”36. Quindi “è inutile domandarsi cosa sarei stato se questa guerra non fosse scoppiata
[...] Non mi distinguo da questa epoca stessa, non potrei essere trasportato ad un’altra epoca
senza contraddizione”37. La conseguenza immediata è che “tutto ciò che mi accade è mio”;
perciò sono responsabile di tutto ciò che faccio e di ciò che mi accade. La mia libertà è
K. Jaspers, Filosofia, II. Chiarificazione dell’esistenza, sezione II, cap. VI, a cura di U. Galimberti, UTET,
1978, p. 654
34
J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, trad. it. di G. Del Bo, Il Saggiatore, 1975, p. 62, p. 67 e p. 69
35
ivi, p. 586 e p. 588
36
ivi, p. 592
37
ivi, p. 667. Si ricordi che L’essere e il nulla è del 1943, nel pieno della seconda guerra mondiale.
33
113
assoluta, perché assumo anche le condizioni in cui essa si realizza. Questo è l’inesorabile e
ineluttabile destino dell’esistenza: “dal momento del mio nascere all’essere, porto il peso
del mondo da solo senza che nulla né alcuno possano alleggerirlo. [...] Io sono, in realtà,
responsabile di tutto, salvo che della mia responsabilità stessa, perché non sono il
fondamento del mio essere”38.
Sartre, a causa dell’esperienza fatta durante la guerra mondiale (prigionia e partecipazione
alla resistenza), va via via enfatizzando come aspetti centrali dell’esistenzialismo
l’ispirazione umanistica e l’importanza di assumere pubblicamente e consapevolmente le
proprie responsabilità storiche. Tra i primi frutti di questa trasformazione è lo scritto
L’esistenzialismo è un umanismo (1946). In esso egli osserva che, secondo la concezione
più tradizionale e diffusa, anche per l’uomo vale la regola generale che “l’essenza precede
l’esistenza”, nel senso che ogni uomo possiede una natura, della quale rappresenta un
esempio particolare; per l’esistenzialismo, invece, pensato rigorosamente, vale l’inverso:
“l’esistenza precede l’essenza”39. Il saggio sartriano, per l’appassionata ed efficace
esaltazione dell’uomo costruttore di sé e del suo destino, è solitamente accostato al
“manifesto” dell’umanesimo classico, la Oratio de hominis dignitate di Pico della
Mirandola da noi citata. Se già nella finzione letteraria di Pico l’uomo non è
originariamente determinato secondo una forma preordinata, ma si vede affidato dal
creatore il compito di decidere liberamente di sé secondo i suoi progetti, ancor più
radicalmente per Sartre l’uomo deve constatare che “l’esistenza precede l’essenza”, nel
senso che egli “esiste prima di poter essere definito da alcun concetto” e “non può essere
definito per il fatto che all’inizio non è niente”; soltanto in seguito potrà esibire una sua
forma, perché “sarà quale si sarà fatto, [...] sarà quello che avrà progettato di essere”40,
coinciderà con le scelte che avrà fatto. L’umanismo di Sartre è dichiaratamente ateo. Esso
comporta la consapevolezza che trovarsi affidati soltanto a se stessi nell’assenza di un Dio
“è molto scomodo”: “Siamo soli [...] L’uomo è condannato a essere libero, [...] senza
appoggio né aiuto, è condannato in ogni momento a inventare l’uomo”41. Il riconoscimento
della libertà come condizione costitutiva della coscienza non è compatibile con l’esistenza
di Dio, perché, se Dio fosse, l’uomo sarebbe da lui vincolato, la sua essenza sarebbe da lui
predeterminata. Secondo l’umanismo esistenzialista “non c’è altro universo che quello
umano, l’universo della soggettività umana. [...] Non c’è altro legislatore” che l’uomo42.
LINGUAGGIO
La “filosofia del linguaggio” non va confusa con la “linguistica”. Questa è una scienza
specifica, che considera il linguaggio umano come un fenomeno empiricamente complesso
e vario, di cui intende comparare con opportuna diligenza metodica le multiformi
espressioni e interpretare con rigorosa razionalità le strutture e le funzioni. La filosofia,
invece, manifesta sempre ambizioni fondamentali e d’ordine generale, pur partendo da
ambiti particolari.
Il linguaggio per sua natura coinvolge, più o meno direttamente, insieme alla linguistica,
che in sé già implica la fonetica, l’etimologia e la grammatica, diverse altre discipline, quali
38
ivi, p. 665 e p. 667
J.-P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, trad. it. di G. Mursia Re, Il Saggiatore, 1978, p. 46
ivi, p. 48
41
ivi, pp. 63-64
42
ivi, pp. 107-109
39
40
114
la semiotica, la logica, la retorica, la gnoseologia, l’epistemologia: tutte queste scienze
inevitabilmente s’intersecano quando la filosofia procede nei suoi tentativi di comprendere
il mondo nel quale l’uomo vive, agisce e parla.
Platone
Se consideriamo, ad esempio, l’attenzione che Platone e Aristotele prestano alle questioni
linguistiche, ci rendiamo conto che la filosofia è prioritariamente orientata a far emergere la
problematica ontologica e metafisica, di cui l’uomo lascia sempre implicitamente traccia
nell’uso del linguaggio. Così fa Platone, quando osserva che l’applicazione di uno stesso
nome ad una varietà di singoli enti non può essere casuale né può essere dovuta ad
omonimia, cioè ad una semplice coincidenza fonica, che designerebbe in maniera equivoca
realtà assolutamente estranee tra loro. Egli invece intende spiegarla come una conseguenza
del fatto che tutti quegli enti partecipano di una stessa “idea”, contrassegnata da quel nome.
→ Idea
In particolare, poi, occorre ricordare che egli si sente impegnato a contrastare le
argomentazioni dei sofisti, secondo i quali il linguaggio è teoreticamente impotente a
rilevare nelle cose un’oggettività universalmente riconoscibile. Pertanto nel Cratilo rigetta
il convenzionalismo linguistico estremo, in base al quale sarebbe possibile applicare
qualsiasi nome a qualsiasi cosa. Questa posizione soggettivistica non gli sembra in grado di
spiegare perché, in riferimento ad un certo ente, si consideri corretta una denominazione
invece di un’altra. Ad essa, quindi, oppone la tesi secondo la quale “il nome è come uno
strumento didascalico e sceverativo dell’essenza”, cosicché “le cose hanno lor nomi da
natura, e non ognuno è artefice di nomi, bensì quello solo che, riguardando al nome che da
natura ha ciascuna cosa, sia capace di esprimere l’idea di questa nelle lettere e nelle
sillabe”43.
La composizione del Cratilo è complessa e problematica, ma lascia comunque intendere
che il naturalismo linguistico di Platone non è così ingenuo come potrebbe in prima istanza
apparire. Egli scorge l’effettiva presenza della convenzionalità nella denominazione delle
cose e tuttavia mantiene fermo il riferimento ai nomi ideali, perché possono consentire
giudizi sul loro corretto impiego nell’ambito empirico. L’imitazione che il nostro
linguaggio quotidiano può fare di quei nomi ideali è sempre inadeguata; perciò il pensiero,
impegnato a conseguire una corretta conoscenza, deve procedere dalla vera essenza delle
cose e non dalla loro denominazione.
Nel Sofista, poi, Platone osserva che il linguaggio non può essere fatto soltanto di nomi
né solo di verbi. Un discorso, anche il più semplice, che può esaurirsi in una sola frase, per
esempio: “l’uomo sa”, “esprime un senso compiuto, collegando i verbi ai nomi. È per
questo che noi affermiamo che un tale discorso non solo denomina, ma pure discorre”44. In
tal modo il filosofo ateniese rileva che diversa è la funzione semantica dei nomi da quella di
un discorso compiuto: i nomi denominano, il discorso asserisce.
Diversamente dal Cratilo, che fa parte dei dialoghi del primo periodo dell’attività
platonica, la Lettera VII, che invece appartiene agli ultimi scritti, accondiscende senza
difficoltà alla tesi del convenzionalismo. Nella parte che è solitamente conosciuta come
l’excursus teoretico della lettera Platone vuol dar conto delle difficoltà che sono riservate a
chi intende dedicarsi alla filosofia. Perciò afferma che sulla via che conduce alla verità si è
obbligati a confrontarsi con i nomi, le definizioni, le immagini, l’effettiva conoscenza di cui
43
Platone, Cratilo, 388 b-c; 390 e, trad. di L. Minio Paluello, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni,
Laterza, 1971, vol. 2, pp. 21 e 24
44
Platone, Sofista, 262 b-d, trad. di A. Zadro, in Opere complete, cit., vol.2, pp. 250-251
115
si dispone e, infine, con l’idea, cioè con la realtà autentica di ciò che si va cercando.
Ovviamente anche il linguaggio, implicato nei nomi e nelle definizioni, può prevedere
inganni per i più sprovveduti. La sua equivocità si presta alle astuzie degli abili parlatori,
che puntano ad ingannare i loro interlocutori. A questo riguardo Platone non ha remore a
sostenere che “i nomi, per coloro che li mutassero chiamando le cose col nome contrario,
avrebbero lo stesso valore”. Si può intravedere la verità soltanto “dopo gran tempo e con
molta fatica […]; allora a stento, mentre che ciascun elemento (nomi, definizioni, immagini
visive e percezioni), in dispute benevole e discussioni fatte senza ostilità, viene sfregato con
gli altri, avviene che l’intuizione e l’intellezione di ciascuno brillino a chi compie tutti gli
sforzi che può fare un uomo”45.
Aristotele
A proposito degli interessi linguistici espressi da Aristotele, si può osservare, per esempio,
che nell’analisi grammaticale dei termini egli distingue la funzione di un nome rispetto a
quella di un attributo o a quella di un verbo e osserva che questi non possono essere usati
autonomamente, ma solo in riferimento ad un nome, mentre questo gode di una sua propria
indipendenza. Così egli non fa che segnalare attraverso considerazioni linguistiche la
diversa condizione ontologica della sostanza rispetto alle altre categorie. → Sostantivo
Sulla questione della naturalità o convenzionalità dei nomi Aristotele dichiara
apertamente che nessuno di essi è tale per natura, ma solo per convenzione46.
Epicuro
Epicuro, invece, sostiene che il linguaggio in origine dovesse essere il risultato di
immediate disposizioni naturali e soltanto in seguito siano intervenuti gli artifici della
convenzione. Egli ne parla nell’Epistola a Erodoto, nella quale si rappresenta la condizione
ancora tutta istintuale dell’umanità primitiva, dedita a soddisfare i bisogni più elementari.
Per questa umanità doveva essere preponderante la funzione espressiva del linguaggio,
connessa alle emozioni. Soltanto in un momento successivo s’imposero l’utilità della
comunicazione e la creatività pragmatica della ragione. Inoltre, la varietà delle situazioni
ambientali, l’estendersi dell’esperienza e le esigenze della socialità reclamavano un
ampliamento dell’iniziale patrimonio linguistico, che fu reso possibile mediante decisioni
concordate. Perciò, dice espressamente Epicuro, “i nomi [delle cose] non furono in
principio stabiliti per un accordo, ma le diverse nature degli uomini, dovendo subire
affezioni particolari a seconda dei singoli popoli, e cogliendo particolari rappresentazioni,
facevano uscire in maniera particolare l’aria dietro l’impulso di ciascuna di quelle affezioni
e rappresentazioni, a seconda anche delle eventuali differenze fra popolo e popolo,
dipendenti dai luoghi da essi abitati; infine di comune accordo a seconda di ciascun popolo
furono stabilite particolari espressioni per potersi capire reciprocamente con la maggior
chiarezza e più concisamente”47.
Gli stoici
Gli stoici trattano delle questioni linguistiche nell’ambito della logica, termine, questo, a cui
essi danno un significato molto ampio, essendo suoi oggetti i lógoi, cioè i discorsi. Quando
si rivolge ai discorsi continui, essa è “retorica”; quando invece fa l’analisi degli elementi
che li compongono è “dialettica”, Questa, a sua volta, è “grammatica” quando l’oggetto
45
Platone, Lettera VII, 343 b; 344 b, trad. di A. Maddalena, in Opere complete, cit., vol. 8, p. 54. Il cosiddetto
excursus teoretico coincide con 341 c – 345 a.
46
Aristotele, De interpretatione, 2, 16 a 19 ss.
47
Epicuro, Epistola a Erodoto, in Opere, 2, 75-76, a cura di G. Arrighetti, Einaudi, 1973, p. 66
116
della sua attenzione sono le parole ed è “logica” in senso specifico quando riguarda i nostri
processi mentali (le rappresentazioni, le proposizioni e i ragionamenti) e i criteri della loro
validità veritativa.
Gli stoici riconoscono esplicitamente all’analisi linguistica un’autentica e autonoma
scientificità, nel senso che non la subordinano a preoccupazioni ontologiche, come invece
sembrava fare Aristotele. La considerazione integrale della significazione linguistica a loro
giudizio comporta tre elementi: il “significante”, cioè la parola, il “significato”, cioè la
corrispondente rappresentazione mentale, e l’oggetto a cui questa si riferisce, ossia ciò che
oggi noi denominiamo “referente”; il primo e il terzo sono corporei, il secondo, invece, è
incorporeo. Il significato è detto dagli stoici λεκτόν (lektón), termine per lo più tradotto con
“esprimibile” (più corretto sarebbe “espresso”, “enunciato”). Pertanto, mentre Aristotele era
da subito interessato ad evidenziare la funzione ontologicamente rivelativa del pensiero, gli
stoici, invece, considerano la logica come scienza dei segni, nella quale il pensiero e il
linguaggio svolgono congiuntamente la loro funzione specifica e autonoma, rivolta
direttamente alle esigenze di correttezza razionale, che soltanto in un secondo momento ci
si può preoccupare di riferire alla realtà del mondo esterno.
La filosofia medioevale
Anche nel Medioevo il pensiero e il linguaggio sono oggetto di un interesse unitario, e la
logica, che li comprende entrambi, è denominata scientia sermocinalis, cioè scienza del
linguaggio. In particolare è stato importante l’impegno dei logici medioevali nel distinguere
i termini in categorematici e sincategorematici e nell’analizzare le varie forme di
suppositio. → Logica; Categorematici e sincategorematici, termini; Suppositio
I logici di Port-Royal e G. Leibniz
Nell’età moderna l’interesse teoretico si volge significativamente al progetto di una
possibile grammatica universale, che dovrebbe far emergere la struttura razionale
sottostante alla mobile varietà delle lingue empiricamente date. Questo progetto è solo
genericamente presente al razionalismo cartesiano; ad esso invece intendono corrispondere
i logici di Port-Royal, Antoine Arnauld e Pierre Nicole, e ancor più G.W. Leibniz, che con
la sua characteristica universalis fa un concreto tentativo, ancor più diretto e conseguente,
d’impostarlo ed elaborarlo. → Logica
G.B. Vico
Nel Settecento con Giambattista Vico e poi soprattutto nel Romanticismo ottocentesco si
manifesta un progressivo interesse per l’origine storica del linguaggio.
Già nel De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda
(L’antichissima sapienza delle popolazioni italiche derivabile dalle origini della lingua
latina), del 1710, Vico svolge una personale analisi storico-filologica della lingua latina,
nella quale scorge la secolare sedimentazione della sapienza delle antiche popolazioni
italiche. Al di là della problematica scientificità degli effettivi risultati conseguiti, l’opera
va segnalata per l’interessante intuizione che la sorregge, applicabile in generale alla lingua
parlata da ogni popolo.
Nella Scienza nuova, del 1744, Vico connette la formazione di questo mezzo umano di
espressione e di comunicazione al secolare processo della civilizzazione, cioè
all’allontanamento dalla primitiva condizione ferina. Pertanto, a suo giudizio il linguaggio
dell’umanità antica non assunse originariamente significazioni simboliche astratte e
razionali, ma si realizzò mediante le forme sensibili della rappresentazione mimetica, che
sono proprie dei gesti e dei suoni (le onomatopee). In quegli albori della storia presero
117
forma una “prima sapienza” e una “sapienza poetica”, “una metafisica non ragionata ed
astratta qual è questa or degli addottrinati, ma sentita ed immaginata quale dovett’essere di
tai primi uomini, siccome quelli ch’erano di niuno raziocinio e tutti robusti sensi e
vigorosissime fantasie”48. La sapienza poetica non fu un abbellimento fantastico di concetti
già presenti in forma razionale; fu invece l’espressione di “universali fantastici”49 (→
Universale), ossia di rappresentazioni sensibili, originariamente dotate di significati
generali, come, per esempio, la raffigurazione simbolica della forza e del valore in Achille
o quella dell’ingegno in Ulisse.
Le teorie romantiche
L’attenzione al linguaggio si manifesta poi soprattutto in Germania, dove nasce e si
sviluppa con maggior vigore la nuova temperie culturale del Romanticismo. Così per
Johann Gottfried Herder (1744-1803) e Karl Wilhelm von Humboldt (1767-1835) il
linguaggio è l’espressione più evidente della specificità spirituale dell’uomo, che ne è il
creatore e anche il prodotto. In quanto tale l’uomo è un essere storico.
L’uno e l’altro autore da un lato elaborano il tema ideale dell’Humanität (umanità)
ispirandosi alla tradizione estetica del classicismo e al nuovo interesse per la storia, intesa
come la dimensione propria dell’uomo; dall’altro, prendendo le distanze dall’universalismo
razionalistico dell’Illuminismo, rivolgono l’attenzione alle diverse identità culturali dei
popoli, che nella storia emergono e si confrontano. Di queste identità sono espressioni le
lingue nazionali. In quanto tali, esse non sono semplici meccanismi della comunicazione né
strumenti di una razionalità astratta, perché coinvolgono, insieme all’intelletto, la fantasia e
il sentimento. Ogni lingua è una realtà vivente, un complesso organismo nel quale, non solo
si coordinano in forma unitaria tutte le sue parti, ma si rivela anche la Weltanschauung
(concezione del mondo) di un popolo. Humboldt, in particolare, dà un forte impulso allo
studio comparato delle lingue. Tra i suoi scritti ricordiamo il saggio Sulla differenza della
struttura linguistica dell’uomo e sulla sua influenza sullo sviluppo spirituale del genere
umano (1830). → Weltanschauung
Ludwig Wittgenstein
L’intenzione di evidenziare al di sotto del linguaggio ordinario un’ideale struttura
logicamente rigorosa è coltivata nel Novecento in particolare da Bertrand Russell e dal
primo Ludwig Wittgenstein. Questi, poi, cambia decisamente il precedente orientamento,
attribuendo alla filosofia non più il compito di costituire il linguaggio, ma di analizzarlo
nella ricchezza e nella varietà delle sue espressioni empiriche, legate ai concreti bisogni e
agli usi della vita. I contributi dati da Wittgenstein alla filosofia del linguaggio sono
particolarmente importanti. A questo riguardo si invia alle voci → Logica; Senso e
significato
Noam Chomsky
Nel Novecento lo statunitense Noam Chomsky pensa di potersi rifare al razionalismo
cartesiano nel sostenere l’idea di una grammatica universale, connessa alle strutture
profonde e innate della nostra razionalità e configurata in maniera tale da poter “generare”
l’infinità dei dati linguistici empiricamente possibili. Non a caso la sua analisi linguistica è
denominata “generativo-trasformazionale”. Questa espressione è composta dai termini
“trasformare” e “generare”, che sono mutuati dall’uso matematico e significano: derivare
48
49
G.B. Vico, La scienza nuova, II, I, a cura di P. Rossi, Rizzoli, 1963, pp. 183-184
ivi, I, II (Degnità XLIX) p. 127
118
secondo determinate regole di calcolo. Egli, infatti, è convinto che il rapporto vigente tra la
grammatica e le infinite creazioni linguistiche non è di tipo induttivo, ma deduttivo.
Secondo Chomsky si rivela ormai del tutto inadeguato il modello comportamentistico o
behavioristico, secondo il quale l’apprendimento e quindi l’uso del linguaggio
dipenderebbero dall’addestramento, cioè dal ripetersi del meccanismo stimolo-risposta. La
critica che egli rivolge al behaviorismo contribuisce, al di fuori dello specifico ambito della
linguistica, all’affermarsi del cognitivismo, cioè di quel movimento di psicologia
sperimentale, che nello studio dei processi cognitivi tende a trattare la mente secondo un
modello informatico, ossia come un insieme di processi che si svolgono in analogia con
l’operare di un computer. → Cognitivismo
Inoltre di Chomsky è nota la distinzione tra “competenza” (competence) ed “esecuzione”
(performance), alla quale poi sovrappone quella di “struttura profonda” e “struttura
superficiale”. Queste distinzioni richiamano quella dello svizzero Ferdinad de Saussure tra
langue e parole. → Langue / Parole; Competenza / esecuzione; Diacronia / Sincronia
Dei numerosi scritti di Chomsky ricordiamo Strutture sintattiche (1957) e Aspetti della
teoria della sintassi (1965).
Esistenza e linguaggio
Martin Heidegger ritiene che l’analisi del linguaggio non possa ridursi ad una tradizionale
analisi logica, la quale considera soltanto il discorso assertivo e ci mette di fronte ad entità
puramente oggettive, fondandosi su una “ontologia della semplice presenza”50. È vero che,
come dicevano i greci antichi, l’uomo è ζῷον λόγον ἔχον (zôon lógon échon), cioè animale
dotato di parola, un’espressione che successivamente fu riprodotta in quella di animal
rationale. Questa “non è certamente ‘falsa’; è però tale da nascondere il terreno fenomenico
da cui […] è stata tratta”; infatti “l’uomo si presenta come l’ente che parla”51. Tuttavia, si
richiede che l’analisi del linguaggio sia fondata su un’ontologia dell’esistenza, la quale
renda evidente che il fenomeno del linguaggio “ha le sue radici nella costituzione
esistenziale dell’apertura dell’Esserci”52. Ricordiamo che per Heidegger l’uomo, in quanto
Esserci (Dasein), è strutturalmente inserito nel mondo, e perciò è originariamente in
comunicazione con gli altri. Mediante il discorso egli “si esprime”, ma “non perché sia
dapprima incapsulato in un ‘dentro’ contrapposto a un fuori, ma perché esso, in quanto
essere-nel-mondo, comprendendo, è già ‘fuori’. Ciò che viene espresso è proprio l’esserfuori”. Questa originaria apertura lo dispone, in quanto essere-con-gli altri, non solo a
parlare e, altrettanto eloquentemente, a tacere, ma anche a “stare a sentire” e ad ascoltare53.
Ermenuetica e linguaggio
L’esperienza linguistica è anche coinvolta nella costruzione di un’ontologia generale. Su di
essa si sofferma la riflessione della filosofia ermeneutica di Martin Heidegger e di Hans
Georg Gadamer. A questo riguardo si consideri la voce → Ermeneutica (L’ermeneutica
come attività filosofica generale: M. Heidegger e H.G. Gadamer)
50
M. Heidegger, Essere e tempo, § 34, trad. it. di P. Chiodi, Longanesi, 1970, p. 259
ivi, p. 258
52
ivi, p. 251
53
ivi, p. 254 e pp. 257-258
51
119
M
MATERIALISMO STORICO
È la denominazione che Karl Marx dà alla propria teoria della storia, da lui contrapposta al
misticismo idealistico della filosofia hegeliana e, in generale, alle interpretazioni
ideologiche, che non sono in grado di rilevare il “movimento reale” della società nel corso
del tempo.
La critica del misticismo idealistico e del materialismo meccanicistico
Marx intende descrivere non come gli uomini “possono apparire nella rappresentazione
propria o altrui, bensì quali sono realmente” nelle concrete interazioni con i loro simili e
con la natura, che da essi è progressivamemnte modificata mediante il lavoro. Infatti le idee
non hanno una loro consistenza autonoma, “non hanno storia, non hanno sviluppo, ma gli
uomini che sviluppano la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali
trasformano, insieme con questa loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro
pensiero”. Perciò, “si possono distinguere gli uomini dagli animali per la coscienza, per la
religione, per tutto ciò che si vuole; ma essi cominciarono a distinguersi dagli animali
allorché cominciarono a produrre i loro mezzi di sussistenza”; ed è ovvio che questa
“produzione della vita materiale” “ancora oggi, come millenni addietro, deve essere
compiuta ogni giorno e ogni ora semplicemente per mantenere in vita gli uomini”45. Il
lavoro, dunque, è alla base della storia, perché per mezzo del lavoro l’uomo si è allontanato
socialmente dall’animalità delle origini. Nel corso del tempo si è necessariamente imposta
una “divisione sociale del lavoro”: innanzitutto la separazione del lavoro industriale e
dell’attività commerciale dal lavoro agricolo e poi nei loro ambiti si sono differenziate
capacità e competenze, mediante le quali gli individui e i raggruppamenti sociali hanno
stabilito rapporti di interdipendenza sempre più stretti, in relazione ai loro diversi bisogni e
interessi.
Contro la genericità astratta del naturalismo feuerbachiano Marx afferma nelle Tesi46 che
l’uomo non è un’“essenza” atemporale, ma una concreta realtà storica, socialmente
determinata: è “l’insieme dei rapporti sociali”. Inoltre, si dichiara convinto che occorra
recuperare l’importanza della dialettica, che Feurbach non ha colto, perché altrimenti ci si
lascia sfuggire la possibilità di comprendere che l’uomo è il risultato della propria storica
attività. Infatti “il difetto principale d’ogni materialismo fino ad oggi (compreso quello di
Feuerbach) è che l’oggetto (Gegenstand), la realtà, la sensibilità vengono concepiti solo
sotto la forma dell’obietto (Objekt) o dell’intuizione, ma non come attività sensibile umana,
prassi, non soggettivamente47. Di conseguenza il lato attivo fu sviluppato astrattamente, in
opposizione al materialismo, dall’idealismo”. Riconoscere l’importanza della soggettività
attiva consente di superare l’unilateralità del tradizionale materialismo meccanicistico, che
K. Marx, L’ideologia tedesca, trad. it. di F. Codino, Editori Riuniti, 1977, pp. 12-13, 8 e 18
K. Marx, Tesi su Feuerbach (1, 2, 3, 6, 7, 11), in Opere di Marx-Engels, Editori Riuniti, 1972, vol. V, pp. 3-5
47
La distinzione terminologica della lingua tedesca, qui rilevata, consente di indicare con Objekt (dal latino
obicere, contrapporre) l’oggetto in assoluta indipendenza dal soggetto, e con Gegenstand (in quanto gegen steht,
sta di fronte) il prodotto di un’oggettivazione, ossia l’oggetto costituito in relazione all’attività conoscitiva e
pratica del soggetto umano.
45
46
120
ha sempre rilevato la determinazione causale delle circostanze, dimenticando, tuttavia, che
“le circostanze sono modificate dagli uomini”.
Per modificare la realtà, non è sufficiente la critica filosofica; occorre invece la “prassi”,
con la quale “l’uomo deve provare la verità, cioè la realtà e il potere, il carattere immanente
del suo pensiero”, modificando i rapporti sociali. Finora “i filosofi hanno soltanto
diversamente interpretato il mondo; si tratta di trasformarlo”.
La riflessione marxiana appare complessa e articolata: da un lato, contro l’illusione
idealistica che induce a considerare lo spirito come il fondamento originario della realtà, in
maniera tale che questa sembra poggiare sulla testa anziché sui piedi, ribadisce che “non è
la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere
sociale che determina la loro coscienza”48; dall’altro, tuttavia, ha cura di insistere
sull’iniziativa del soggetto umano e sull’efficacia della sua azione nelle condizioni concrete
che gli sono naturalmente e storicamente date.
Struttura e sovrastruttura
La “produzione sociale dell’esistenza” avviene nell’ambito di determinate “formazioni
economico-sociali”, che vanno intese come totalità organiche e dialettiche. In esse Marx
distingue una “struttura” e una “sovrastruttura”. Le indicazioni fondamentali a questo
riguardo ce le dà nella Prefazione a Per la critica dell’economia politica (1859).
La struttura comprende le forze produttive e i rapporti di produzione. Le forze produttive
sono tutto ciò che interviene attivamente nella produzione: gli uomini, ossia la forza-lavoro,
gli strumenti, le conoscenze scientifiche e tecniche. I rapporti di produzione sono
determinati dalla proprietà e dal controllo dei mezzi produttivi; essi regolano le forme di
dipendenza presenti nell’attività produttiva e la divisione di ciò che si produce. A questo
riguardo Marx rileva che “nella produzione sociale della loro esistenza gli uomini entrano
in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione
che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali”.
Forze produttive e rapporti di produzione realizzano insieme un particolare “modo di
produzione” storicamente determinato (per esempio, feudale o borghese).
La sovrastruttura è data dall’insieme delle forme giuridiche, istituzionali e politiche, dalla
cultura, dall’etica, dalle elaborazioni dottrinali e ideologiche, dalle espressioni religiose.
Essa non è autonoma, ma si eleva sulla “base reale” della struttura, dalla quale dipende più
o meno direttamente. Nella dialettica storica la sovrastruttura dimostra in vari modi la
propria efficacia, ma è la struttura che risulta determinante “in ultima istanza”, secondo la
nota espressione di F. Engels contenute in una lettera a J. Bloch del 21 settembre 1890.
Una formazione economico-sociale risulta complessivamente stabile finché un
determinato sviluppo delle forze produttive è positivamente connesso a determinati rapporti
di produzione e di proprietà; quando questi contrastano quello sviluppo, si crea una
situazione di conflitto, cioè una contraddizione dialettica, che sospinge verso condizioni
storiche di rivoluzione sociale. Le nuove forze produttive sono sempre rappresentate da una
classe che storicamente va affermandosi (ad esempio la borghesia capitalistica nell’età
moderna), mentre i tradizionali rapporti di proprietà sono rappresentati da una classe già
dominante, ma ormai sulla via del declino (ad esempio la nobiltà legata alle tradizionali
condizioni feudali). Il dominio e l’egemonia sociale riguardano non solo la produzione e la
distribuzione della ricchezza, ma anche le forme e le espressioni della cultura, perché “le
K. Marx, Prefazione a Per la critica dell’economia politica, trad. di E. Cantimori, Einaudi, 1975, integrata
nell’edizione de Il Capitale, p. 957
48
121
idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè la classe che è la
potenza materiale dominante è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante”49.
Nello sviluppo storico occidentale Marx individua in successione tre modi sociali di
produzione: quello antico di tipo schiavistico, quello feudale e quello borghese. Tutti e tre
hanno prodotto società divise in classi. Ora, invece, la radicalità e la generalità dei processi
indotti dal capitalismo prospettano un futuro ben diverso: una società senza classi. Il
comunismo sarà l’esito inevitabile della dialettica storica nell’età contemporanea,
caratterizzata da un asservimento sempre più esteso della popolazione nel sistema
produttivo in atto, cioè da una diffusa proletarizzazione. Ecco alcune significative parole di
Marx a questo riguardo: “Il comunismo per noi non è uno stato di cose che debba essere
instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il
movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti”50.
I rilievi critici di Max Weber
Un’efficace critica epistemologica del materialismo storico è quella svolta da Max Weber,
che possiamo così riassumere.
Nei processi storico-sociali il materialismo storico considera l’aspetto economico come
necessariamente prioritario e universalmente determinante in quanto “strutturale”;
quindi tutti gli altri aspetti risultano secondari in quanto “sovrastrutturali”. È inevitabile
che con questa impostazione il marxismo incorra nella propria dogmatizzazione.
Il materialismo storico ha preteso di condurre uno studio “scientifico” del capitalismo sulla
base di un giudizio di valore negativo dei suoi aspetti alienanti, contravvenendo così a una
condizione fondamentale perché un’analisi storica sia scientifica, cioè il rispetto del criterio
di “avalutatività”. Si potrebbe tradurre questo rilievo critico in termini marxiani, dicendo
che la stessa analisi di Marx è un’operazione ideologica. → Valore (Max Weber:
“politeismo dei valori” e “avalutatività” nella conoscenza storica)
L’opera forse più nota di Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo (1905), è
un chiaro esempio di interpretazione storica che inverte il rapporto causale fra “struttura” e
“sovrastruttura”. In essa, infatti, l’autore intende evidenziare l’importanza assunta nella
storia economica moderna dell’Occidente da determinati fattori religiosi. Il fatto che l’avvio
del capitalismo moderno sia avvenuto nei paesi dove si è diffuso il protestantesimo
calvinista non gli appare casuale. Il calvinismo puritano non destina la ricchezza
direttamente al consumo e al lusso, perché la considera come il frutto di una vita dedita al
lavoro e all’impegno richiesti dalla propria vocazione-professione (Beruf) in questo mondo;
pertanto nel suo accumulo e nel progressivo investimento, che essa consente, vede il segno
della benedizione di Dio, il quale mediante il successo negli affari dà ai suoi fedeli
un’indicazione positiva della loro predestinazione tra gli eletti. Questo severo
atteggiamento ascetico si dimostra efficacemente consono al consolidarsi dello spirito
acquisitivo del capitalismo, tutto proteso alla valorizzazione del profitto accumulato. Sarà
questo spirito storicamente a rimanere, una volta che sarà venuta meno la motivazione di
fede delle origini. Sorge così “un éthos specificamente borghese”, a cui l’originaria ascesi
religiosa conferisce anche “la tranquilla sicurezza che la disuguale divisione dei beni di
questo mondo è un’opera speciale della provvidenza di Dio, il quale con queste differenze,
come con la grazia particolare segue i suoi scopi arcani, a noi sconosciuti”51. Oggi, se si
K. Marx, L’ideologia tedesca, cit., p. 35. La nozione di egemonia sociale, che si esprime nella capacità di far
valere una “direzione intellettuale e morale”, è stata sviluppata in particolare da Antonio Gramsci. → Società
civile
50
ivi, p. 25
51
M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, trad. di P. Burresi, Sansoni, 1977, pp. 298-299
49
122
domandasse agli intraprendenti borghesi “il senso del loro affaticarsi senza posa, che non si
accontenta mai di quel che già possiede”, essi “risponderebbero che gli affari con il
continuo lavoro che comportano sono diventati indispensabili alla loro vita. Questa è
l’unica motivazione esatta che esprime ciò che, dal punto di vista della felicità personale,
appare irrazionale in tale condotta di vita, nella quale l’uomo è fatto per l’azienda e non
viceversa”52. Il modo in cui la civiltà capitalistica considera il lavoro come “assoluto scopo
a se stesso” e come “vocazione” “non è qualche cosa che si trovi in natura, [...] ma il
risultato di un lungo processo educativo”53.
Weber è consapevole dei limiti insiti in questa particolare ottica interpretativa. Con essa
egli cerca soltanto di evidenziare “un solo punto, sia pure importante” tra diversi altri
possibili. Conclude perciò il suo scritto precisando che “non può essere nostra intenzione di
sostituire ad un’interpretazione causale della civiltà e della storia astrattamente
materialistica un’altra spiritualistica, ugualmente astratta”54.
MECCANICISMO
Il meccanicismo è una concezione generale della natura e, in questo senso, è una teoria
filosofica, che nel dar conto dei fenomeni fisici intende avvalersi di due soli principi: la
materia e il movimento. Essa non coincide sempre con un materialismo integrale, quale fu
l’atomismo di Democrito e di Epicuro, e non esclude necessariamente una dimensione
metafisica dell’essere, trascendente la natura. Tale fu, per esempio, nell’età moderna la
posizione di Cartesio, che interpretò meccanicisticamente gli eventi del mondo naturale (la
res extensa), ma attribuì alla mente (la res cogitans) una condizione ontologica ben distinta,
cioè quella spirituale, capace di trascendenza. Per la spiegazione dei fenomeni fisici il
meccanicismo cartesiano, diversamente dalla tradizione galileiano-newtoniana, pensava di
potersi avvalere del semplice principio di conservazione della “quantità di moto”, a
proposito del quale affermava che, data originariamente nel mondo una quantità di moto
ben definita, nel corso del tempo essa si va distribuendo tra i corpi attraverso l’inerzia e gli
urti, determinando tutti gli sviluppi possibili del sistema complessivo. Così Cartesio
intendeva bandire dalla fisica la nozione di forza agente a distanza per attrazione o
repulsione (forze elettriche, magnetiche, gravitazionali), perché essa avrebbe comportato
necessariamente un’interpretazione o finalistica, qual era stata quella dell’aristotelismo, o
animistica.
Il successo storico arrise alla tradizione galileiano-newtoniana, che si era dotata di un
efficace metodo sperimentale. Essa rese plausibile un’interpretazione meccanica degli
eventi naturali, generalizzata all’universo intero. Durante il positivismo ottocentesco il
meccanicismo assunse una forte valenza ideologica sia per la pretesa d’imporsi come una
teoria filosofica generale sia per il sostegno che intendeva dare alle ottimistiche prospettive
di progresso di quel particolare momento storico.
Le realtà “ultime”, alle quali fisicamente tale meccanicismo riconduceva l’universo,
erano: lo spazio e il tempo, intesi in maniera newtoniana come i grandi contenitori degli
eventi, ma da essi indipendenti (assoluti), la materia, il movimento e le forze. Tra le
caratteristiche più generali del meccanicismo ottocentesco possiamo ricordare:
il determinismo, ossia la spiegazione di tutti i fenomeni in base al principio di
causalità, che comporta la prevedibilità certa degli eventi;
52
ivi, pp. 127-128
ivi, pp. 118-119
54
ivi, p. 307
53
123
il riduzionismo, cioè la tendenza a ridurre ogni realtà a condizioni materiali e fisicomeccaniche, quindi a non riconoscere come specifiche e distintive le proprietà del
vivente, in particolare dell’uomo;
la reversibilità, consistente sia nell’illimitata riproducibilità dei processi fisici,
considerati come identici, sia nella disponibilità teorica del tempo ad essere percorso
indifferentemente in un verso o nell’altro;
l’assimilazione dello scienziato ad un osservatore assolutamente oggettivo, che, nel
sottoporre il mondo al proprio sguardo non lo condiziona né, a sua volta, è da esso
condizionato.
Un’efficace e sintetica rappresentazione della concezione meccanicistica del mondo del
primo Ottocento la diede Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) con queste celebre
affermazione: “Dobbiamo considerare lo stato presente dell’universo come l’effetto del suo
stato anteriore e come la causa del suo stato futuro. Un’intelligenza che, per un dato istante,
conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura e la collocazione rispettiva degli esseri
che la compongono, se per di più fosse abbastanza profonda per sottomettere questi dati
all’analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi
dell’universo e dell’atomo più leggero: nulla sarebbe incerto per essa e l’avvenire, come il
passato, sarebbe presente ai suoi occhi”55.
Il successo conseguito dalla meccanica newtoniana alimentò per lungo tempo la fiducia di
poter estendere il suo modello interpretativo a tutta la fisica. Solitamente si riteneva che
questo modello avesse una consistenza ontologica, cioè raffigurasse specularmente
l’oggettiva realtà del mondo. Perciò nelle scienze sperimentali fu per tutto l’Ottocento il
paradigma dominante; tuttavia andò incontro a progressive difficoltà, dovute agli sviluppi
scientifici che esigevano nuovi e più adeguati approcci metodologici e interpretativi.
Le nuove conoscenze elettromagnetiche faticavano ad adeguarsi al modello newtoniano
dell’azione a distanza entro uno spazio vuoto e inerte; a questo, infatti, mediante la nozione
di “campo”, si sostituì la rappresentazione di uno spazio continuo e dinamico, percorso da
una molteplicità di linee di forza. Ciò, inoltre, indusse a pensare gli atomi come centri di
forza e non come rigide particelle di materia, ponendo così le basi per il superamento del
dualismo materia-energia, la cui conferma sarà data soltanto dalla teoria della relatività
ristretta di Einstein.
Anche dalla termodinamica provenivano critiche al modello meccanicistico. Essa rese
problematica la concezione del tempo come contenitore indifferente agli eventi che in esso
accadono e mostrò che questi si svolgono invece in una storia irreversibile, le cui vicende
possono essere previste non su base deterministica, ma in termini probabilistici. Il primo
principio della termodinamica, riguardante la conservazione dell’energia, non si poneva in
contrasto con la meccanica, la quale da molto tempo aveva assimilato principi di
conservazione: conservazione della materia e della quantità di moto per Cartesio,
conservazione della forza viva o energia cinetica per Leibniz. Il secondo principio della
termodinamica apparve, invece, in contraddizione con essa. Infatti il passaggio del calore
da un corpo ad un altro non può avvenire indifferentemente in entrambi i sensi, perché non
è possibile ricavare lavoro dal calore se non si dispone di due sorgenti a diversa
temperatura. Pertanto fu palese che esistono fenomeni naturali irreversibili.
Inoltre la costruzione delle geometrie non euclidee mise in crisi l’antica e consolidata
convinzione che le proprietà dello spazio geometrico siano le stesse dello spazio fisico. Di
55
Citato da L. Geymonat in Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. IV, Garzanti, 1971, p. 90
124
una di esse si avvarrà Einstein nella teoria della relatività generale → Geometrie non
euclidee
METAFISICA
Il termine “metafisica” deriva dall’espressione greca τὰ μετά τὰ φυσικά (tà metà tà
physiká), con la quale nel I sec. a. C. Andronico di Rodi, incaricato di riordinare gli scritti
di Aristotele non ancora pubblicati e denominati “acroamatici” o “esoterici”, perché erano
destinati agli ascoltatori interni alla scuola, intese semplicemente distinguere i quattordici
libri del grande maestro, che poi furono chiamati “La metafisica”, sulla base della loro
materiale collocazione, che li vedeva disposti “dopo quelli di fisica”, cioè letteralmente
metà tà physiká.
La metafisica nella filosofia antica
Tale denominazione si prestò felicemente a rappresentare anche il loro contenuto. La
metafisica, infatti, oltre a porsi ad un generale livello teoretico metempirico, ha in
particolare come oggetto di studio l’essere che è oltre (metà) la natura (tà physiká) e
trascende la realtà del mondo sensibile (→ Trascendenza).
Platone per primo, al seguito di Socrate, si era dimostrato convinto che il mondo sensibile
non ha in sé la spiegazione dei problemi che suscita, perché – come egli stesso sostenne
contro i “fisici” che intendevano spiegare la φύσις (phýsis), cioè la la natura, con
l’indicazione di cause materiali e meccaniche - non è la causa di se stesso e “quel potere
onde cielo e terra si trovano oggi disposti come fu possibile un giorno fossero disposti nel
modo migliore, codesto potere né lo ricercano essi né credono abbia alcuna sua forza divina
[...] e ciò che è il bene, che è ciò che lega ogni cosa al suo fine, non pensano affatto”.
Quindi, egli concluse, occorre “mutare modo di navigazione”60, cioè affidarsi ad una ricerca
superiore e più impegnativa di una semplice “fisica”, perché ambisce ad andar oltre la
“phýsis”. Platone la chiamò “dialettica”; Aristotele, invece, la denominò “filosofia prima” e
“teologia”. Solo in seguito alla sistemazione delle opere aristoteliche, fatta da Andronico, si
cominciò a designarla come “metafisica”. Essa godette a lungo di una grande
considerazione, essendo ritenuta la più importante delle scienze.
Aristotele le diede una sistemazione disciplinare, configurandola
come “ontologia”, interessata allo studio dell’essere, considerato nella sua dimensione
più universale (“l’essere in quanto essere”);
come “filosofia prima”, orientata a “speculare intorno ai principi primi” e agli aspetti
fondamentali dell’essere, riguardanti in particolare la questione della sostanza;
come “teologia”, intenta alla realtà sovrasensibile, cioè all’essere divino, perfetto ed
eterno61.
L’esercizio della speculazione metafisica realizza la virtù dianoetica della sapienza. →
Sapienza
Un grandissimo esempio di pensiero metafisico fu quello del neoplatonico Plotino. →
Neoplatonismo
60
61
Platone, Fedone, 99 c-d, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, cit., vol. 1, pp. 164 s.
Aristotele, La metafisica, passim: A 2, 1, E, 1, a cura di G. Reale, Loffredo, 1968, vol. I
125
Assestata lungo queste linee, la metafisica fu recepita e riproposta nei secoli successivi.
Durante il Medioevo cristiano fu posta come ancilla theologiae al servizio e a presidio di
una dottrina che proclamava di fondarsi su una rivelazione e si appellava alla fede dei suoi
uditori.
Al di là della complessa sistemazione razionale che le fu data sulle tracce
dell’insegnamento platonico e aristotelico, occorre rilevale che la prima ed essenziale
questione metafisica, che sottende tutte le altre, è indotta da quell’originario stupore che
insorge quando osserviamo ingenuamente il mondo ed è solitamente espresso dalla
domanda formulata dal filosofo tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz: “Perché l’essere e non
piuttosto il nulla?”62 Formalmente considerato, questo interrogativo pare assurdo, cioè
logicamente impossibile, perché entifica il nulla; ma sul piano dell’esistenza esso
comunque inevitabilmente s’affaccia e sempre immancabilmente si rinnova, perché non
viene mai meno il mistero dell’essere. Pertanto la metafisica è innanzitutto il paradossale
tentativo di pensare la trascendenza dell’essere, che non può realizzarsi nella forma di un
compiuto sapere, ma soltanto riproporsi come un’inesauribile domanda. → Essere; Nulla
La questione della metafisica nella filosofia moderna: D. Hume e I. Kant
Il pensiero moderno andò progressivamente intaccando il credito secolare della metafisica,
nonostante la riproposizione che ne fecero Renato Cartesio, Baruch Spinoza e Gottfried
Wilhelm Leibniz, tanto che durante l’Illuminismo del XVIII secolo David Hume pensò di
poter ormai sentenziare la sua condanna a morte: “Quando scorriamo i libri di una
biblioteca, […] che cosa dobbiamo distruggere? Se ci viene alle mani qualche volume, per
esempio di teologia o di metafisica scolastica, domandiamoci: Contiene qualche
ragionamento astratto sulla quantità o sui numeri? No Contiene qualche ragionamento
sperimentale su questioni di fatto e di esistenza? No. E allora, gettiamolo nel fuoco, perché
non contiene che sofisticherie ed inganni”63. → Scienza
Immanuel Kant nei confronti della metafisica dichiarò di sentirsi come un innamorato
deluso: da un lato riconobbe che ad essa si era sempre guardato come alla “regina di tutte le
scienze”, perché le questioni che essa affrontava s’imponevano per la loro importanza;
dall’altro, però, dovette constatare che i tempi erano decisamente mutati: “Ormai la moda
del nostro tempo porta a disprezzarla”, suscitando addirittura nei suoi confronti un
“fastidio” e un apparente “totale indifferentismo”. A tale proposito egli si sentì comunque
obbligato a riconoscere che questa apparente indifferenza “non è per certo effetto di
leggerezza, ma del giudizio maturo dell’età moderna che non vuol più lasciarsi tenere a
bada da una parvenza di sapere, ed è un invito alla ragione ad assumersi nuovamente il più
grave dei suoi uffici, cioè la conoscenza di sé, e ad erigere un tribunale che la garantisca
nelle sue pretese legittime, ma condanni quelle che non hanno fondamento [...] e questo
tribunale altro non può essere se non la critica della ragion pura stessa”64.
Personalmente Kant era convinto che le importanti e inevitabili questioni, alle quali si era
da sempre dedicata la metafisica, siano teoreticamente irrisolvibili; infatti “la ragione
umana ha il destino particolare di essere tormentata da problemi che non può evitare,
perché le son posti dalla natura della stessa ragione, ma dei quali non è può trovare la
62
G.W. Leibniz, Scritti filosofici, a cura di D.O. Bianca, UTET, 1967 (rist. 1988), vol. I, p. 278
D. Hume, Ricerca sull’intelletto umano, XII, III, in Opere filosofiche, vol. II, trad. di M. Dal Pra e E. Mistretta,
a cura di E. Lecaldano, Laterza, 1987, p. 175
64
I. Kant, Critica della ragion pura, a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, riveduta da V. Mathieu, Laterza,
1971, Pref. alla Ia ediz., vol. I, pp. 6 e 7
63
126
soluzione, perché oltrepassano ogni potere della ragione umana”65. C’è nell’uomo
un’insopprimibile tendenza all’incondizionato e alla totalità dell’essere, ma egli s’illude se
pensa di poter teoreticamente andar oltre l’esperienza fenomenica. La ragione scambia per
realtà effettive i suoi vuoti tentativi di conseguire una spiegazione assoluta e totale della
realtà mediante le tre “idee” di anima, mondo e Dio (→ Idea; Ideale). Perciò Kant definì la
metafisica, in quanto dialettica, “logica dell’apparenza”. Ai suoi insidiosi ragionamenti
rivolse una critica puntigliosa, il cui esito fu la dichiarazione di un esplicito agnosticismo
teoretico, per sopperire al quale indicò la soluzione di una “fede razionale”66, ossia la
postulazione di una dimensione transfenomenica, sulla base di pure esigenze morali. →
Fede e fideismo (La fede postulatoria di Immanuel Kant)
Alla vecchia metafisica “trascendente”, che vorrebbe “sorpassare i limiti della esperienza
possibile”, Kant contrappose poi una nuova metafisica “critica” e “scientifica”, concepita
come la scienza dei concetti puri e dei principi a priori del conoscere e dell’agire67, rispetto
alla quale le sue Critiche sarebbero soltanto una trattazione propedeutica. Questo spiega i
titoli di alcune sue opere: Prolegomeni ad ogni metafisica futura che si presenterà come
scienza, Fondazione della metafisica dei costumi, Principi metafisici della scienza della
natura.
La metafisica nella filosofia romantica
Con il Romanticismo assistiamo ad un radicale capovolgimento del criticismo kantiano:
questo era stato una filosofia del finito, che sul piano teoretico aveva confinato la
conoscenza nell’ambito fenomenico; la nuova filosofia riportò in auge il pensiero
metafisico, celebrandone superbamente i trionfi.
Il tema dell’Infinito costituì per gli autori romantici un riferimento costante e
ineliminabile, secondo le due opposte prospettive dell’immanentismo monistico-panteistico
e del trascendentismo. Occorre, inoltre, rilevare che, se l’orientamento prevalente e più
caratteristico della temperie romantica attribuiva al sentimento o alla fede la possibilità di
accedere all’Assoluto, Georg W.F. Hegel, invece, sostenne che ad esso si possa giungere
adeguatamente soltanto mediante il sapere speculativo e “la fatica del concetto”. Con Hegel
ci troviamo di fronte ai fasti di una grandiosa metafisica dell’immanenza. →
Romanticismo; Idealismo
La metafisica e la questione della sua significanza
In linea con la tradizione dell’empirismo inglese e con la cultura dell’Illuminismo, il
Positivismo ottocentesco considerò “astratta” la razionalità metafisica e rivolse contro di
essa la propria critica, oppondole una razionalità “positiva”, identificata da Auguste Comte
con le moderne scienze empiriche e da lui genericamente comprese nella “fisica”, cioè nella
scienza della natura, ormai accreditata dall’uso del metodo sperimentale. Secondo le sue
dirette parole, il sapere positivo “rinuncia ormai alle ricerche assolute che convenivano solo
alla sua infanzia e circoscrive i suoi sforzi nell’ambito progressivo della vera osservazione,
sola base possibile delle conoscenze veramente accessibili, sagacemente adattate ai nostri
bisogni reali. La logica speculativa era fino ad allora consistita nel ragionare, in modo più o
meno sottile, secondo principi confusi che, non comportando alcuna prova sufficiente,
suscitavano sempre dibattito senza un esito condiviso. Essa riconosce ormai, come regola
65
ivi, p. 5
I. Kant, Critica della ragion pratica, Parte I, Libro II, Cap. II, 5, a cura di F. Capra, ed. rivista da E. Garin,
Laterza, 1971, p. 152
67
I. Kant, Critica della ragion pura, Dialett. trasc., Introduz. I; Dottrina trasc. del metodo, cap. III, cit., vol. II,
pp. 287 e 635-636
66
127
fondamentale, che ogni proposizione che non è strettamente riducibile alla semplice
enunciazione di un fatto, particolare o generale, non può presentare nessun senso reale e
intelligibile”. E concludeva affermando che il nuovo orientamento si accontentava ormai
della “semplice ricerca delle leggi, cioè delle relazioni costanti che esistono tra i fenomeni
osservati, [...] senza mai penetrare il mistero della loro produzione”68. L’epistemologia
positivistica ritenne di poter legittimare questa posizione richiamandosi alla nota formula
metodologica di Isaac Newton: hypotheses non fingo.
Comte, inoltre, sulle orme di Hume, espresse una prima enunciazione di quel principio
che poi il Neopositivismo novecentesco denominerà “criterio di significanza”, facendone il
punto fondamentale della propria epistemologia: “Ogni proposizione che non è strettamente
riducibile alla semplice enunciazione di un fatto, particolare o generale, non può presentare
nessun senso reale e intelligibile”69. Anche per i neopositivisti, infatti, le proposizioni della
metafisica sono per definizione senza senso, perché non sono verificabili. È nota la
formulazione sintetica che del criterio di significanza diede Moritz Schlick: “Il significato
di una proposizione è il metodo della sua verifica”70. Secondo Rudolf Carnap la metafisica
non dà conoscenze, ma segnala in forma impropria la presenza di emozioni e sentimenti,
che andrebbero più adeguatamente espressi mediante la musica, “il più puro mezzo
espressivo del sentimento della vita”; perciò “i metafisici non sono che dei musicisti senza
capacità musicale”71. Essi compiono un abuso del linguaggio, che così è costretto a
riprodurre puri stati soggettivi, rendendo impossibile un’effettiva comunicazione e
lasciando ognuno chiuso nel castello delle sue convinzioni.
L’epistemologia di Karl Popper rintuzzò le pretese del “criterio di significanza”,
sostenendo la plausibilità razionale della metafisica. A suo giudizio, infatti, la metafisica
non è di per sé priva di senso e non esprime puri stati emotivi e sentimentali, ma teorie
razionali, che si possono capire, criticare e discutere, anche se non sono empiricamente
controllabili, cioè “falsificabili”. Infatti il vero “criterio di demarcazione” tra le teorie
scientifiche e le teorie metafisiche è la falsificabilità delle prime e la non falsificabilità delle
seconde. È del tutto improprio volerlo usare per determinare la loro sensatezza.
Il nichilismo antimetafisico di Friedrich Nietzsche
Una delle voci più aspramente antimetafisiche, che contribuì a caratterizzare a fondo la
cultura del Novecento, fu quella di Friedrich Nietzsche. I temi, che più direttamente
impegnarono in questo senso il suo pensiero, furono la “morte di Dio” e il “nichilismo”.
Con l’annuncio della “morte di Dio” egli intendeva prospettare per i nuovi tempi
l’abbandono della tradizionale metafisica, il rifiuto di quei fondamenti presuntivamente
assoluti, con i quali si è voluto finora sorreggere la vita dell’uomo, distogliendolo dalla
realizzazione di se stesso, perché “il concetto di ‘Dio’ è stato fino a oggi la più grande
obiezione contro l’esistenza”72. Il presupposto, da cui Nietzsche partiva, consisteva in un
radicale naturalismo vitalistico, che, per esempio, espresse con queste parole: “Vi
scongiuro, o fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di
sovraterrene speranze !”73; e anche: “In Dio è dichiarata inimicizia alla vita, alla natura, alla
68
A. Comte, Discorso sullo spirito positivo, a cura di A. Negri, Laterza, 1985, pp. 15 e 17
A. Comte, Discorso sullo spirito positivo, cit., p. 15
70
M. Schlick, Meaning and verification, cit. da F. Barone, Il neopositivismo logico, vol. I, Laterza, 1977, p. 252
71
R. Carnap, Il superamento della metafisica mediante l’analisi logica del linguaggio, in AA. VV., Il
neoempirismo, a cura di A. Pasquinelli, UTET, 1969, pp. 530-531
72
F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, in Opere complete, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, vol. VI/3,
1970, p. 93
73
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, in Opere complete, cit.,vol. VI/1, 1973, p. 6
69
128
volontà di vivere! Dio, la formula di ogni calunnia dell’‘aldiquà’, di ogni menzogna
dell’‘aldilà’”74.
In Nietzsche, poi, strettamente connesso sia al pensiero metafisico sia alla prospettiva
della sua distruzione è il tema complesso del “nichilismo” (→ Nichilismo). Il nichilismo è
da lui configurato come un atteggiamento ambivalente, negativo o positivo, a seconda che
lo si intenda come l’annullamento della vitalità umana o come la condizione della sua
realizzazione. Nella variegata descrizione che ce ne è data appare particolarmente
significativa la distinzione tra il “nichilismo passivo” e il “nichilismo attivo”. Il primo è
tipico della tradizione metafisica e religiosa: esso comporta la vanificazione dei valori
vitali, la svalutazione della natura e la fuga dal mondo. Il secondo coincide con il senso di
smarrimento, vero e proprio sgomento del vuoto e del nulla, che si produce all’annuncio
della “morte di Dio”, cioè con la fine della metafisica e dei tradizionali valori. Secondo
Nietzsche il superamento del nichilismo va affidato all’über-mensch, l’“oltre-uomo”, colui
che rifiuta l’autorepressione imposta dalla morale, accetta la libera manifestazione della
propria naturalità e delle forze vitali, valorizza il corpo e i suoi istinti. Se la volontà del
nulla (nichilismo passivo) è stata alla base delle “menzogne millenarie”, l’opposta “volontà
di potenza” consisterà nella libertà con cui l’“oltre-uomo” imporrà le proprie interpretazioni
al caos della vita e al mondo, e ricreerà l’essere adeguandolo alle proprie iniziative in uno
sforzo di inesausto superamento. Essa sarà il fondamento dell’“eterno ritorno
dell’identico”, ossia dell’accettazione affermativa e giustificatrice del mondo: farà sì che
ogni “così fu” divenga “così volli che fosse”, “così voglio” e “così vorrò”, volendolo
“riavere per tutta l’eternità” [...] così come esso è stato ed è, gridando insaziabilmente: ‘da
capo’”75. → Fato, Destino, Fortuna
L’intuizione metafisica nella filosofia di Henri Bergson
Tra la fine dell’Ottocento e il Novecento contro l’epistemologia positivistica insorsero varie
filosofie spiritualistiche. L’esigenza di sostenere il pensiero metafisico fu ben rappresentata
da Henri Bergson. Egli distinse la funzione prevalentemente pragmatica dell’intelligenza,
con la quale nel processo evolutivo del mondo l’homo faber ha provveduto alle sue più
immediate necessità, dalla funzione eminentemente teoretica dell’intuizione, con la quale
l’homo sapiens può realizzare la conoscenza metafisica, ossia la comprensione
fondamentale della vita (→ Intuizione). L’intelligenza è analitica e ci consente di girare
intorno all’oggetto, l’intuizione invece ci permette di immedesimarci in esso.
Nell’esperienza metafisica si ricerca il contatto “simpatetico” e amoroso con l’Assoluto,
nella cui energia creatrice si evolve il mondo. In tal modo essa tende a diventare esperienza
mistica. Soltanto il misticismo può garantirci contro il rischio che la morale e la religione
degenerino: la prima nella rigidità abitudinaria e non vitale della “morale
dell’obbligazione”, la seconda nelle forme superstiziose e puramente rituali di una
“religione statica”. → Misticismo
La metafisica di Karl Jaspers: trascendenza e fede filosofica
Anche Karl Jaspers intese ripristinare con grande convinzione la positività del pensiero
metafisico. Oggetto costante del suo pensiero è l’esistenza umana, compresa dentro
l’orizzonte infinito dell’essere. Della ricerca ontologica così indicò i progressivi livelli
d’interesse: “Percorrendo il mondo apprende il conoscibile per poi distanziarsene e divenire
così orientazione filosofica nel mondo; destandosi dal mero esserci-nel-mondo si realizza
74
75
F. Nietzsche, L’Anticristo, in Opere complete, cit., vol. VI/3, 1970, § 18, p. 238
F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, 56, in Opere complete, cit., vol. VI/2, 1968, p. 61
129
come chiarificazione dell’esistenza; infine evoca l’essere e diventa metafisica”76. In
particolare distinse due modi di svolgere l’attività teoretica: il “conoscere” dell’intelletto e
il “comprendere” della ragione. Il primo realizza un “orientamento nel mondo” sempre
particolare e relativo: si rivolge ai fenomeni e agli oggetti del mondo mediante le
costruzioni concettuali approntate dalle varie discipline scientifiche. Il secondo è l’autentico
pensare filosofico, che si svolge secondo una prospettiva di trascendenza verso la totalità
dell’essere che tutto abbraccia ed è perciò infinito, intrascendibile e in oggettivabile.
Jaspers lo denomina Umgreifende, un termine tedesco che egli deriva verbo greifen
(prendere) in composizione con la preposizione um (intorno a) e che richiama l’antica
espressione greca di Anassimandro ápeiron periéchon (→ Periecontologia). Del nostro
rapporto originario e permanente con esso Jaspers affermò: “Noi viviamo stabilmente quasi
come in un orizzonte del nostro sapere, ciò nondimeno ci spingiamo oltre ogni orizzonte
che ci rinserra e ci toglie la visuale. Ma noi non conosciamo nessun punto stabile, da cui
sparisca l’orizzonte limitatore, da cui si possa abbracciare la totalità illimitata [...] L’Essere
resta per noi incircoscrivibile, esso ci trascina da ogni parte verso l’infinito. [...] Questo
Essere noi lo chiamiamo l’ulteriorità inglobante. Essa non è l’orizzonte, nel quale sta il
nostro particolare sapere, ma ciò che non si rende mai visibile, neppure soltanto come
orizzonte, ciò, anzi, da cui sorgono tutti i nuovi orizzonti”77. Erra colui che separa in
maniera assoluta l’esperienza e la trascendenza, configurando la realtà secondo un
inaccettabile dualismo, in base al quale “Dio e il mondo starebbero l’uno di fronte all’altro
come estranei”. Infatti, “una volta che l’immanenza e la trascendenza sono divenute del
tutto eterogenee, per noi non c’è più alcuna trascendenza”. Perciò, la trascendenza e
l’immanenza “occorre pensarle dialetticamente nella cifra come trascendenza immanente,
se non si vuole che la trascendenza vada irrimediabilmente perduta”78.
Tutto ciò che costituisce la nostra esperienza naturale e storica può essere “cifra”, cioè
significazione simbolica della trascendenza dell’essere, il cui mistero non è mai
direttamente svelato, ma è affidato ad un’interpretazione, che nella concreta limitatezza
dell’esistenza allude e invia a ciò che va al di là di essa. L’esistenza rivela in negativo la
trascendenza dell’essere nelle “situazioni-limite” che la caratterizzano: l’ineludibilità della
propria effettiva condizione storica, l’incompiutezza del sapere nella dimensione temporale
che sempre ci accompagna, l’insufficienza nella quale ci imbattiamo in ogni impresa,
l’inquietudine, il “non poter vivere senza lotta e dolore, dover assumere inevitabilmente la
propria colpa, dover morire”. Noi le avvertiamo come costitutive della nostra condizione e
tuttavia “sfuggono alla nostra comprensione, così come sfugge al nostro esserci ciò che sta
al di là di esse. Sono come un muro contro cui urtiamo e naufraghiamo”. In esse si rende
palese l’impossibilità radicale dell’esistenza, cioè il fatto che l’esistenza coincide con lo
“scacco” e il “naufragio” delle sue possibilità, con “il non poter non”. Lo sconforto e il
silenzio, ai quali sembra doversi rassegnare, possono tuttavia diventare l’occasione in cui
“il limite svolge la sua autentica funzione, e cioè quella di essere nell’immanenza un rinvio
alla trascendenza”79, una positiva apertura al mistero dell’essere. Sfuggendo alla tentazione
del pessimismo (“scacco inautentico”), abbiamo modo di assumere coscienza della nostra
storicità, che consente l’attraversamento del tempo da parte dell’eterno. In questa direzione
il nostro pensare si presenta sempre più come una forma di fede, perché è consapevole
dell’incompiutezza costitutiva della nostra conoscenza e alimenta in noi la convinzione che
76
K. Jaspers, Filosofia, Introduzione alla filosofia, parte II, a cura di U. Galimberti, UTET, 1978, pp. 140-141
K. Jaspers, La filosofia dell’esistenza, trad. it. di O. Abate, Bompiani, 1967, pp. 35-36
78
K. Jaspers, Filosofia, cit., III. Metafisica, cap. IV, parte IV, pp. 1076-1078
79
K. Jaspers, Filosofia, cit., II. Chiarificazione dell’esistenza, sezione III, cap. VII, pp. 678-679
77
130
la verità ci trascende. Jaspers la chiamò “fede filosofica”. La dimensione metafisica della
filosofia non realizza propriamente un sapere, perché in tal caso l’essere sarebbe trasceso.
La metafisica si dà solo nella forma di una inesauribile domanda, rispetto alla quale
l’impossibilità di una positiva risposta si rivela come la “cifra” più eloquente della
trascendenza dell’essere. → Fede e fideismo
Martin Heidegger: la metafisica è l’oblio dell’essere
Nella filosofia di Martin Heidegger il termine “metafisica” ha una connotazione negatica.
Per lui la metafisica coincide con il millenario processo storico, che da Platone a Nietzsche
ha prodotto un inconsapevole “oblio dell’essere”. In questa lunga tradizione l’ontologia è
diventata una specie di “fisica”, perché si è scambiato l’essere con gli enti, pretendendo
così di dominarlo sia teoreticamente mediante la scienza che praticamente mediante la
tecnica. Per come tradizionalmente si è voluto intendere la scienza, ciò che è indagato è
“unicamente l’ente e al di là di questo niente”80. Si sono imposte le norme della correttezza
gnoseologica e logica, e mediante la tecnica si è preteso di trattare anche operativamente
l’ente come un oggetto, ossia come ciò che sta di fronte (ob-jectum) ad un soggetto e alla
sua progettazione dominante. Si è smarrito così il senso veritativo di ciò che è, rovesciando
l’originario rapporto con l’essere in maniera tale che non è più l’essere a rivelarsi, ma è il
soggetto a voler disporre del mondo, stabilendo le regole di una scienza pragmaticamente
efficace (→ Verità). Il dominio tecnico sulle cose è il compimento stesso della metafisica,
che porta al suo parossismo la nietzschiana “volontà di potenza”. Nietzsche, perciò, non ha
affatto superato il nichilismo: egli l’ha denunciato come fenomeno che caratterizza la storia
dell’Occidente, ma l’ha anche portato al suo perfezionamento, quando ha indicato nella
volontà di potenza il fondamento dei nuovi valori. Il trionfo della tecnica è il trionfo stesso
del nichilismo, cioè lo smarrimento completo del senso dell’essere.
Heidegger non intese concludere con una banale e moralistica condanna della tecnica.
L’importante, egli disse, è mantenersi liberi nei suoi confronti, non assolutizzarla. Soltanto
un “pensiero meditante”, opposto al “pensiero calcolante”, può porsi la questione
ontologica del senso della tecnica, che all’uomo si nasconde nel momento stesso in cui essa
ostenta la propria invadente presenza. Pensato adeguatamente, anche il fenomeno storico
della tecnica consente che si disveli la verità dell’essere.
La prospettiva della filosofia di Heidegger non è “umanistica”, cioè non è incentrata
sull’uomo, anche se l’Essere ha bisogno dell’uomo per rivelarsi, perché non si dà senza di
lui; però l’uomo non è il signore dell’Essere, perché il suo compito è di custodirne la verità,
la quale dipende soltanto dall’Essere e dalla sua iniziativa. Il millenario percorso storico del
pensiero metafisico in questo Occidente, terra del tramonto, non ha necessariamente un
esito catastrofico e apocalittico, perché esso coincide con lo stesso “destino” chiaroscurale
della verità dell’Essere, nel suo disvelarsi e sottrarsi nel proprio mistero. Perciò, noi uomini
dell’Occidente e figli della civiltà tecnologica “dovremo un giorno aspettare l’estremo del
mattino nell’estremo della sera”; l’importante è che coloro che pensano “restino sulla
breccia e siano presenti al momento giusto”81. → Essere
M. Heidegger, Che cos’è metafisica?, in Segnavia, a cura di F. Volpi, Adelphi, 1987, p. 61
M. Heidegger, La sentenza di Nietzsche: “Dio è morto”, in Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova
Italia, 1973, p. 194
80
81
131
METODO
Questo termine, di origine greca (μέθοδος, méthodos), designa etimologicamente la via
(ὁδός, hodós), attraverso e quindi oltre (μετά, metá) la quale si giunge alla meta prevista.
Nell’uso corrente esso indica un insieme organico di regole procedurali, che occorre
applicare per svolgere in maniera ottimale una particolare attività teoretica (finalizzata alla
conoscenza) o pratica (destinata all’applicazione delle conoscenze) e conseguire così
determinati risultati.
La questione del metodo fu al centro dell’attenzione nell’età moderna e riguardò non solo
le esigenze sperimentali con le quali G. Galilei e F. Bacone pensarono che si potesse
organizzare una nuova fisica (→ Metodo sperimentale, Formazione del), ma l’impostazione
generale della stessa filosofia, pensata criticamente nei suoi presupposti fondamentali. Ciò
avvenne sia con R. Cartesio, che pensò di dover sottoporre ad un “dubbio metodico” (→
Dubbio; Cartesianesimo) ogni forma di conoscenza precedentemente acquisita, sia con J.
Locke e poi soprattutto con I. Kant, i quali, di fronte ai problemi più impegnativi e
controversi della ricerca filosofica, ritennero che fosse necessaria una preliminare
discussione sulle nostre stesse facoltà teoretiche e sulle effettive condizioni di possibilità
del loro esercizio (→ Criticismo). Tale questione, nei suoi aspetti essenziali, rimane ancora
alla base della problematica epistemologica (→ Epistemologia).
Da un punto di vista storico qui ricordiamo ancora che secondo Hegel non solo il
criticismo kantiano, ma tutta l’impostazione metodologica della gnoseologia moderna
incorrerebbero in una sostanziale contraddizione, che li costringerebbe ad un esito assurdo,
simile a quella di chi vuole imparare a nuotare prima di buttarsi in acqua, perché
un’indagine sulle nostre capacità conoscitive non può avvenire se non conoscendo. In tal
modo Hegel intendeva rilevare che l’attività teoretica è originaria e intrascendibile, perché
non è possibile “osservarla” dall’esterno, non essendoci in alcun modo un “esterno”. La sua
obiezione rendeva evidente che c’era una separazione ormai incolmabile fra Kant e
l’idealismo romantico. L’idealismo romantico, infatti, si riproponeva di conseguire un
sapere autofondato e assoluto. → Idealismo
METODO IPOTETICO-DEDUTTIVO
Nel passato si era per lo più convinti che nella ricerca empirica fosse applicata la logica
induttiva, ossia il procedimento in base al quale si ritiene di poter derivare da un numero
limitato di dati osservativi uniformi una nozione o una regola generale. Tuttavia già
nell’Ottocento, mentre John Stuart Mill continuava a sostenere le ragioni del metodo
induttivo e riconosceva perciò anche alla sola osservazione il potere di cogliere in maniera
probante i rapporti causali tra i fenomeni, Auguste Comte, invece, esponeva idee più
complesse e problematiche. Anch’egli affermava che “l’autentico spirito positivo consiste
soprattutto nel vedere per prevedere, nello studiare ciò che è per concluderne ciò che sarà,
secondo il dogma generale dell’invariabilità delle leggi naturali”, preoccupandosi di
chiarire che questa giusta e sempre più diffusa convinzione non è affatto una “nozione
innata”, non ha nulla di metafisico, ma ha un’origine empirica, perché “non è potuta
risultare se non da una lenta graduale induzione, collettiva e individuale ad un tempo”82;
però, in un confronto più specifico con tale questione, criticava le possibilità conoscitive
della semplice procedura induttiva e riteneva che il metodo deduttivo-sperimentale fosse
82
A. Comte, Discorso sullo spirito positivo, cit., pp. 21-22
132
l’unico scientificamente valido. Egli notava in particolare, contro un’ingenua e
semplicistica maniera di considerare l’esperienza, che ogni nostra osservazione avviene
entro un contesto teorico che consente di determinarne il senso. Infatti “se da un lato ogni
teoria positiva deve necessariamente essere fondata su osservazioni, è ugualmente
comprensibile, da un altro lato, che, per compiere osservazioni, il nostro spirito ha bisogno
di una qualsiasi teoria. Se, contemplando i fenomeni, non li richiamiamo subito a qualche
principio, non solo ci sarebbe impossibile combinare queste osservazioni isolate e di
conseguenza trarne dei frutti, ma saremmo anche incapaci di assimilarli; e, più spesso, i
fatti resterebbero impercettibili sotto i nostri occhi”83.
Negli stessi anni l’inglese William Whewell (1794-1866), di cui menzioniamo la
Filosofia delle scienze induttive fondata sulla loro storia (1840), si dichiarava convinto che
le scienze empiriche procedessero, non attraverso generalizzazioni successive degli eventi
osservati, ma mediante l’invenzione di “congetture fortunate” e il loro successivo controllo.
A suo giudizio queste ipotesi vengono quindi integrate nella nostra esperienza e noi
“vediamo” le cose in conformità ad esse; perciò “i fatti di oggi sono le ipotesi di ieri”. In
quest’ottica le quattro forme d’induzione indicate da Mill (per concordanza, per differenza,
per variazione concomitante, per residuo → Induzione), più che strumenti di scoperta,
potevano apparire soltanto come strumenti di controllo delle ipotesi. Whewell, nel rifiutare
il tradizionale empirismo, esplicitava un’influenza kantiana; tuttavia, contrariamente a
Kant, riteneva che le idee con cui interpretiamo la realtà siano condizionate dall’effettiva
efficacia con la quale riescono ad organizzare l’esperienza e pertanto non siano strutture
permanenti o “trascendentali”, cioè universali e necessarie, della nostra mente. Questi
rilievi problematici sull’induzione erano delle felici anticipazioni dell’epistemologia
popperiana.
Fu Karl Popper che con maggior impegno e sistematicità portò l’attacco critico al
tradizionale induttivismo e ad esso oppose un più ragionevole e concreto metodo ipoteticodeduttivo. A suo giudizio, infatti, non solo l’induzione non è logicamente giustificabile, ma
la nostra mente non procede in maniera induttiva. Innanzitutto le asserzioni singolari,
connesse a constatazioni empiriche, non possono convalidare logicamente le teorie
universali, perché rimane insuperabile la differenza tra l’esperienza concretamente
compiuta, che è sempre limitata per quanto ricca sia di informazioni, e le potenzialità
infinite della natura che essa non può mai esaurire: “per quanto numerosi siano i casi di
cigni bianchi che possiamo aver osservato, ciò non giustifica la conclusione che tutti i cigni
sono bianchi”. Ancor più ingiustificabile è il principio d’induzione, che “dev’essere a sua
volta un’asserzione universale. [...] Per giustificarlo, dovremmo impiegare inferenze
induttive; e per giustificare queste ultime dovremmo assumere un principio induttivo di
ordine superiore, e così via. In tal modo il tentativo di basare il principio d’induzione
sull’esperienza fallisce, perché conduce necessariamente a un regresso infinito”84. Pertanto
appare rigorosamente insostenibile la “verificabilità” delle teorie. Lo scopo della scienza
non è il conseguimento di una verità definitiva, ma, più modestamente, l’elaborazione di
teorie verosimili. → Verosimiglianza; Fallibilismo
Inoltre, noi non procediamo meccanicamente dai fatti alle teorie, come ritiene il
tradizionale, ma ingenuo “osservativismo” di chi pensa che lo scienziato osservi la natura
senza presupposti e idee precostituite, cioè in maniera assolutamente “oggettiva”. Infatti “la
convinzione che la scienza proceda dall’osservazione alla teoria [...] è davvero assurda. [...]
83
A. Comte, Corso di filosofia positiva, lez. I, riportato da AA. VV., Il testo filosofico, B. Mondadori, 3/1, 1993, p.
413
84
K.R. Popper, Logica della scoperta scientifica, trad. di M. Trinchero, Einaudi, 1970, pp. 6 e 7
133
L’osservazione è sempre selettiva. Essa ha bisogno di un oggetto determinato, di uno scopo
preciso, di un punto di vista, di un problema. [...] Gli oggetti sono posti in relazione ai
bisogni e agli interessi. [...] nel caso dello scienziato sono determinanti i suoi interessi
teorici, il particolare problema affrontato, le congetture, le anticipazioni e le teorie che egli
accetta come presupposti: il suo quadro di riferimento o ‘orizzonte di aspettazioni’”85.
Perciò la nostra mente non è una tabula rasa, come pensavano gli empiristi, un semplice
vuoto che si lascia passivamente riempire, ma una tabula plena. Nell’approccio ai “dati” e
ai “fatti”, tanto mitizzati dal positivismo per la loro capacità d’informarci, noi ci portiamo
appresso elementi teorici di cui siamo più o meno consapevoli e che costituiscono la nostra
storia. Ovviamente nel confronto con la realtà empirica le nostre teorie sono sottoposte al
continuo controllo della loro validità: in rapporto alla severità delle prove, l’eventuale
superamento ne determina il grado di “corroborazione”, che è in ogni caso provvisoria e
ipotetica; altrimenti s’impone la loro sostituzione con altre. Appare comunque semplicistico
e futile domandarsi se viene prima l’osservazione o l’ipotesi; è come chiedersi se viene
prima l’uovo o la gallina.
Per il rifiuto dell’ingenuo empirismo tradizionale l’epistemologia popperiana può
presentare qualche affinità con l’impostazione gnoseologica di Kant e la sua “rivoluzione
copernicana”, come appare da queste parole: “Senza attendere, passivamente, che le
ripetizioni imprimano in noi, o ci impongano, delle regolarità, noi cerchiamo attivamente di
imporre delle regolarità al mondo. Cerchiamo di scoprire in esso delle similarità, e di
interpretarlo nei termini di leggi da noi inventate”86. Di questa tendenza non siamo
immediatamente consapevoli. Riguardo ad essa possiamo dire che, se da un lato sembra
insostenibile la tradizionale teoria delle idee innate, dall’altro, tuttavia, appare convincente
la presenza in noi di una “aspettazione ‘istintiva’ a reperire delle regolarità”, della quale
Popper dice: “corrisponde molto da vicino al ‘principio di causalità’ che Kant riteneva fosse
parte della nostra struttura mentale e considerava valido a priori”. A questo riguardo, però,
egli osserva che “l’aspettazione non è valida a priori. Essa infatti può restare insoddisfatta”.
Si può dunque dire che “Kant volle dimostrare troppo”87, perché era convinto che le “forme
a priori”, in quanto condizioni “trascendentali” del sapere, fossero necessariamente valide;
invece, i nostri schemi mentali sono delle semplici ipotesi, connesse alla nostra particolare
condizione storico-culturale ed esperienziale, e perciò sono sempre rivedibili.
Secondo Popper, poi, non esiste un metodo per scoprire una teoria scientifica, perché le
ipotesi della scienza possono scaturire dalle fonti più diverse: ad esempio, dal mito, dalla
metafisica, dal caso. Esiste, al contrario, un metodo in base al quale noi controlliamo la
scientificità delle teorie: esso consiste nel procedere per “congetture e confutazioni”, o, più
genericamente, “per prova ed errore”, di fronte alla condizione perennemente problematica
della realtà. Occorre peraltro rilevare che “il metodo per prove ed errori, naturalmente, non
equivale direttamente all’atteggiamento scientifico e critico, cioè al metodo per congetture
e confutazioni. Il metodo per prove ed errori non viene applicato soltanto da Einstein, ma
anche, in maniera più dogmatica, dall’ameba. La differenza non sta tanto nelle prove,
quanto in un atteggiamento critico e costruttivo di fronte agli errori” 88.
85
K.R. Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, trad. di G. Pancaldi, Il
Mulino, 1972, in “Congetture e confutazioni” di Popper e il dibattito epistemologico post-popperiano, a cura di
G. Brianese, Paravia, 1988, pp. 80-82
86
ivi, p. 78
87
ivi, pp. 82-84
88
ivi, p. 92
134
METODO SPERIMENTALE, Formazione del
Il metodo sperimentale consiste nell’applicazione sistematica di un insieme di regole
procedurali allo studio dei fenomeni empirici, per controllare la validità delle ipotesi che li
possono spiegare. La forma standardizzata dell’esperimento consente la ripetibilità
dell’applicazione e quindi l’accertamento e la valutazione comparata degli esiti conseguiti.
All’introduzione storica del metodo sperimentale è connessa la nascita della fisica
moderna, i cui meriti vanno attribuiti principalmente a Galileo Galilei e ad Isaac Newton.
Ad un livello epistemologico più generale non possiamo tuttavia trascurare l’orientamento
sperimentalistico di Francesco Bacone.
Francesco Bacone e Galileo Galilei a confronto
Nei primi decenni del XVI secolo sia Bacone che Galilei sono impegnati a strutturare il
modello generale della moderna sperimentazione scientifica; tuttavia le loro intenzioni e i
criteri operativi da essi adottati sono soltanto in parte comuni; i risultati, poi, appaiono
nell’uno e nell’altro caso diversamente efficaci e risolutivi.
Galilei non stende alcun trattato metodologico; le modalità concrete alle quali si attiene si
possono derivare dagli appunti e dalle osservazioni non sistematiche, che sono sparsi nei
suoi vari scritti. Bacone, invece, progetta un’ambiziosa Instauratio magna scientiarum
(pubblicata incompiuta nel 1620), con la quale vorrebbe avviare ab imis fundamentis la
ricostruzione dell’intero sapere in una prospettiva enciclopedica. Alle velleità della filosofia
tradizionale, la quale pretendeva di “anticipare” la natura con sterili svolgimenti dialettici di
concetti, entrambi contrappongono il proposito di “interpretarla”, sollecitandola a
rispondere e a mettere a nostra disposizione la conoscenza dei suoi segreti. In particolare
secondo Bacone l’uomo deve considerarsi “ministro e interprete della natura” e “la natura
non si vince se non ubbidendo ad essa”89; l’intervento umano, peraltro, deve dimostrarsi
attivo nell’individuare i mezzi più opportuni per costringere la natura a rispondere da sé alle
nostre domande, che non a caso devono essere instantiae, cioè espressioni dell’instare,
dell’incalzare, del premere da vicino e in maniera insistente, ma non devono interferire con
indebite anticipazioni. È la natura a doverci dire com’è. Bacone osserva che anche la logica
tradizionale muoveva dall’esperienza, tuttavia lo faceva sbrigativamente: “dal senso e dai
particolari si volava ai principi più generali come verso poli fissi intorno ai quali si
svolgono le dispute; da questi principi poi si facevano derivare tutti gli altri mediante le
proposizioni medie. Metodo, questo, senza dubbio molto rapido, ma precipitoso, inadatto a
condurci alla natura e invece adatto e favorevole alle dispute. Secondo noi, invece, gli
assiomi devono ricavarsi insensibilmente e gradatamente in modo da giungere solo in
ultimo ai principi generali”. Va pertanto escluso il metodo deduttivo-sillogistico degli
aristotelici, che si è rivelato “sterile di opere” e capace soltanto di alimentare inutili
dibattiti, imperniati su nozioni “confuse e arbitrariamente astratte dalle cose”. La forza del
sillogismo consiste nel fatto che “costringe all’assenso”; esso, però, “non costringe le cose”.
Ciò dimostra che “la logica, com’è attualmente, è inutile all’invenzione delle scienze” e che
“la sola speranza sta nell’induzione vera”, la quale non procede “per semplice
enumerazione”. Così essa si ridurrebbe a “qualcosa di puerile che conclude precariamente”,
perché “è esposta al pericolo di un’istanza contraddittoria [cioè di casi che la possono
contraddire]; coglie soltanto i fatti consueti e non perviene a una conclusione”90.
F. Bacone, La grande instaurazione, Divisione dell’opera, in Scritti filosofici, a cura di P. Rossi, UTET, 1975, p.
543
90
F. Bacone, La grande instaurazione, in Scritti filosofici, cit., pp. 552-553
89
135
Anche Galilei è consapevole che l’esperienza della quale si deve avvalere la scienza non
può essere semplicemente quella ordinaria, soggetta alle illusioni soggettive, ma una
condizione operativa sottoposta al rigoroso controllo dello scienziato, che in essa si
“cimenta” con la natura, provocandola attivamente per ottenere corrette risposte alle sue
domande e accertare la validità delle ipotesi. Perciò egli chiama “cimento” l’esperimento
scientifico, autentica novità rispetto al passato e origine della scienza moderna. Invece nella
tradizionale filosofia scolastica, che si rifaceva ad Aristotele, si assisteva da un lato
all’invadenza di una dialettica formalistica, alla prevaricazione sillogistica di concetti che
non avevano un vero riscontro empirico, ma dall’altro lo stesso adeguamento all’esperienza
era eccessivo, perché portava ad accettare in maniera acritica i fenomeni così come si
davano immediatamente.
Per conoscere la natura non c’è altra via che l’osservazione diretta e gli esperimenti, con i
quali rimediamo all’insufficienza dell’esperienza ordinaria, perché soltanto in essi i sensi
trovano le condizioni opportune e controllate per funzionare validamente. Secondo Bacone
si tratta di una experientia litterata, sorretta e guidata da un metodo, perché l’esperienza,
“se si presenta da sé, è caso; se è il risultato di una ricerca, si chiama esperimento”; al di
fuori di una disciplina metodologica è “un mero andare a tentoni”, un aggirarsi “come in un
labirinto”91.
Nella parte propositiva (pars construens) del suo lavoro, poi, Bacone sostiene che è
possibile e necessario un rigoroso procedimento induttivo, che si svolge non più “per
enumerazione”, ma “per eliminazione”: “un’induzione di forma tale da risolvere e
analizzare l’esperienza e concludere necessariamente mediante legittime esclusioni e
eliminazioni” delle ipotesi che risultano false92. Egli pensa di poterla realizzare mediante
osservazioni numerose e accurate dei fenomeni, che vanno catalogate ordinatamente in
tabulae, per assicurarci un rigoroso controllo: sulle tabulae praesentiae si registrano le
circostanze nelle quali si presenta il fenomeno oggetto d’indagine; sulle tabulae absentiae
si annotano le condizioni nelle quali il fenomeno non si verifica, contrariamente a ciò che si
è precedentemente ipotizzato; sulle tabulae graduum si descrivono le mutazioni d’intensità
del fenomeno in relazione al variare delle circostanze. Queste tabulae si rifanno ai tre
tradizionali corollari del principio di causa, così formulati nel latino della filosofia
scolastica: “posita causa, ponitur effectus”, “sublata causa, tollitur effectus”, “variante
causa, variatur effectus” (→ Causa, principio di). L’analisi accurata delle tavole permette
metaforicamente di fare un primo provvisorio raccolto (vindemiatio), cioè di formulare una
prima ipotesi a proposito di ciò che determina e spiega il fenomeno indagato. Il metodo
sperimentale richiede che la si metta alla prova e, nel caso che gli ulteriori accertamenti o,
per dirla con le parole di Bacone, le nuove instantiae la smentiscano, occorre tentare nuove
ipotesi, da controllare a loro volta con nuovi esperimenti. Perché l’induzione proceda “per
gradi continui, senza salti o interruzioni [...] dai particolari agli assiomi minori, da questi ai
medi, poi agli altri superiori, e finalmente agli assiomi più generali”93, il nostro autore si
dimostra estremamente accurato nel prefigurare una ricca e complessa tipologia di aiuti per
l’intelletto. Vogliamo soltanto citare le “istanze prerogative”, tra le quali, in particolare,
l’instantia crucis, così chiamata dagli incroci viari, dove occorre superare ogni residua
indecisione: essa consiste in un esperimento ultimativo, in base al quale abbiamo modo di
scegliere tra due diverse ipotesi, entrambe apparentemente plausibili.
91
F. Bacone, La grande instaurazione, Novum Organum, I, § LXXXII, in Scritti filosofici, cit., pp. 593-594
F. Bacone, La grande instaurazione, cit., pp. 552-553
93
F. Bacone, La grande instaurazione, Novum Organum, I, § CIV, in Scritti filosofici, cit., p. 613
92
136
Il metodo galileiano, invece, non è né la semplice induzione, che generalizza l’esperienza
particolare, né la semplice deduzione, che procede dai principi alla loro applicazione ai casi
particolari, ma è una combinazione di entrambe. Egli lo descrive talora come una
compresenza di analisi e di sintesi, più precisamente di “metodo risolutivo”, con il quale si
parte dall’esperienza per ricondurre i fenomeni ai loro elementi più semplici o ai principi
che li determinano, e di “metodo compositivo”, con il quale, all’inverso, si applicano i
principi generali alla produzione sperimentale dei fenomeni. Più frequentemente lo presenta
come una combinazione di “sensate esperienze” e di “certe (o necessarie) dimostrazioni”.
Noi possiamo considerarlo un metodo ipotetico-deduttivo e sperimentale, perché le
operazioni con le quali si dispiega sono: la formulazione di un’ipotesi, che prefigura,
mediante lo strumento rigoroso della matematica, le relazioni tra i fenomeni e le leggi che
le governano; il successivo controllo della sua validità nell’effettivo confronto con i dati
osservativi dell’esperienza; l’intervento di nuove ipotesi in seguito ad un’eventuale
falsificazione delle precedenti.
Ma che cosa cerchiamo di conoscere con i nostri esperimenti? Ovviamente le cause dei
fenomeni, perché, dice Bacone, “si sostiene giustamente che ‘sapere veramente è sapere per
cause’” (scire per causas) e correttamente ne è stata codificata la tipologia, che ne
individua quattro: efficiente, materiale, formale e finale. Tuttavia la conoscenza della causa
finale va considerata “sterile” o anche “tanto lontana dal giovare alle scienze che anzi le
corrompe, fatta eccezione per lo studio delle azioni umane”; la causa materiale e quella
efficiente sono “estrinseche e superficiali, quasi senza importanza per la scienza vera e
attiva”94; invece la causa formale è necessaria per assicurarci una vera scienza della natura.
Questa convinzione baconiana appare in prima istanza sorprendente, se pensiamo alla sua
critica insistente e aspra nei riguardi della tradizione aristotelica. Che cos’è, infatti, la
“forma” di una cosa, se non la sua essenza, ossia ciò che la determina costitutivamente nella
sua identità specifica? Proprio a questo proposito la contemporanea fisica galileiana
dichiara: “Il tentar l’essenza l’ho per impresa non meno impossibile e per fatica non men
vana nelle prossime sustanze elementari che nelle remotissime e celesti” 95. Tuttavia le
indicazioni che Bacone dà sulla “forma” di un fenomeno naturale non intendono essere la
semplice trascrizione della dottrina metafisica di Aristotele. Egli ne parla in termini di
“schematismo latente” e di “processo latente”, volendo riferirsi con la prima espressione
alla struttura dei corpi e con la seconda alla legge che ne determina la produzione, gli
sviluppi e i cambiamenti. L’analisi di questi due aspetti, statico e dinamico, non consiste in
definizioni concettuali, ma è di natura tecnico-operativa e si risolve nell’evidenziare
empiricamente la funzionalità degli oggetti trattati. Egli immette nella teoria aristotelica
l’esigenza moderna dello sperimentalismo e tra le applicazioni prevede anche “la
trasformazione dei corpi concreti l’uno nell’altro, possibili entro certi limiti”96. Occorre
inoltre osservare che al di là delle dure critiche da lui mosse contro il pensiero magico, ciò
sembra confermare che nella sua cultura resta un legame con la concezione alchimistica
della natura, secondo la quale è possibile mutare un corpo rimuovendone determinate
“forme”, “nature” o “qualità” e “introducendo” in esso “nuove nature”. È netta, comunque,
la differenza tra le “forme” baconiane e le “leggi di natura” delle quali parla la scienza
moderna. Essa è data da un lato dal persistere stesso nella teoria di Bacone della nozione
tradizionale di “forma” e dall’altro dall’oggettiva inadeguatezza del suo sperimentalismo a
94
F. Bacone, La grande instaurazione, Novum Organum, II, § II, in Scritti filosofici, cit., p. 639 e Sulla dignità e
sull’accrescimento delle scienze, III, 5
95
G. Galilei, Istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari e loro accidenti, Terza lettera a M. Welser, in
Opere, ed. naz. diretta da A. Favaro, Barbera, 1890-1909, ristampa 1929-39, vol. V, p. 187
96
F. Bacone, La grande instaurazione, Novum Organum, II, § I, in Scritti filosofici, cit., p. 639
137
proporsi in maniera efficace rispetto alla nitida proposta metodologica galileiana. Il suo
limite più evidente risiede nell’incapacità di cogliere l’importanza della matematica per
elaborare i dati empirici, cioè di capire che la fisica ha la necessità di avvalersi di essa per
poter davvero reinventarsi come nuova. Non a caso le instantiae, ossia le interrogazioni di
cui parla il filosofo inglese, non si risolvono in equazioni e in determinazioni quantificate
dei rapporti costanti che noi cogliamo tra i fenomeni.
Più limpidamente di Bacone e senza alcuna ambiguità Galilei non nutre velleità
metafisiche riguardanti conoscenze assolute e definitive, rivolte alle cause ultime e alle
essenze, ma si confronta sempre con teorie circoscritte in termini precisi e rigorosi, e
considerate sempre rivedibili in rapporto all’esperienza. L’accertamento sperimentale non
si traduce necessariamente in una verifica diretta delle teorie e dei principi; talora, infatti, ci
si deve accontentare di una conferma indiretta, che deriva dalle conseguenze di quelle
teorie e di quei principi. Così avviene, per esempio, con il principio d’inerzia.
Nell’esperimento, poi, lo scienziato che voglia confrontarsi con un’esperienza non
perturbata da fattori che si aggiungono inevitabilmente a quelli che egli desidera mettere
alla prova e perciò complicano la situazione problematica, se non ha a disposizione una
tecnica adeguata per conseguirla, non può far altro che “astrarre” dagli elementi che non
interessano, cioè supporne l’assenza, immaginare, per esempio, piani talmente levigati che
non diano luogo ad alcun attrito, congetturare un ambiente vuoto, nel quale l’aria non sia
d’impedimento, perfino realizzare soltanto un esperimento mentale, sottoposto però
criticamente al controllo razionale.
Nel percorso conoscitivo della fisica la matematica accompagna e compenetra sia il
momento dell’osservazione dei fenomeni, i cui aspetti quantificabili vanno sottoposti ad un
diligente calcolo, sia l’elaborazione delle ipotesi o teorie, nelle quali rigorosamente si
enunciano i principi e si deducono le conseguenze, che occorre poi controllare
empiricamente. Non serve reclamare la perfezione delle rappresentazioni matematiche,
come fa il sostenitore di Aristotele (“sphoera tangit planum in puncto”), per irrigidirsi poi
sul fatto che “come si viene alla materia, le cose vanno per un altro verso”. Perché lo
scienziato possa riportare l’esperienza al rigore e alla perfezione del modello
matematicamente elaborato, “bisogna che difalchi [cioè tolga] gli impedimenti della
materia”, come avviene per il bravo commerciante, che sa far la tara alla mercanzia
trattata97. Sia i platonici che gli aristotelici consideravano il mondo celeste come un mondo
di regolare perfezione e ad esso, perciò, applicavano raffinati modelli matematici, che
invece ritenevano esclusi dall’imperfezione del mondo terrestre. Galilei mette fine a questa
separazione. Parte dalla convinzione che i tradizionali due mondi siano omogenei e ne
deriva la conseguenza che anche il metodo di indagine che li riguarda vada unificato.
Innova la fisica, perché l’esperienza di cui si avvale non è più qualitativa, ma è ricondotta
alle proprietà misurabili e geometrizzabili; infatti “il voler trattar le quistioni naturali senza
geometria è un tentar di fare quello che è impossibile ad esser fatto”98. Ritiene che, per
poter interpretare il mondo adeguatamente, occorra saperlo “leggere”, perché “la filosofia è
scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io
dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e
conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son
triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne
97
98
G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, a cura di F. Flora, Rizzoli, 1959, p. 246 e p. 251
G. Galilei, Dialogo, cit., p. 246
138
umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto”99. →
Qualità e quantità
Con tutto ciò Galilei pone le basi del metodo sperimentale, di cui si avvarrà con enormi
successi la scienza moderna. I criteri interpretativi della realtà fisica e le fondamentali
regole operative di cui si avvalse Galilei rimangono anche oggi sostanzialmente gli stessi.
Le “regulae philosophandi” di Isaac Newton
La fisica newtoniana, come indica il titolo stesso dell’opera Philosophiae naturalis
principia mathematica (1687), è un’indagine sulla natura che si avvale della matematica
come di uno strumento essenziale: procede lungo la linea tracciata da Galilei, secondo il
quale si possono trattare in maniera scientifica soltanto gli aspetti quantificabili del mondo,
e condivide la convinzione, particolarmente in auge nella cultura matematistica del
Seicento, che Euclide è un modello insuperabile di rigore razionale.
Rispetto allo scienziato italiano fa un uso ancor più sistematico della matematica,
rivelando una competenza più sicura ed estesa a nuovi importanti sistemi di calcolo, che
egli stesso contribuisce ad introdurre e anche ad applicare alla meccanica. Ci riferiamo in
particolare al calcolo infinitesimale, da lui elaborato in due scritti: Analysis per aequationes
numero terminorum infinitas (1711) e Methodus fluxionum et serierum infinitarum (1736,
postumo).
L’analogia formale della Philosophiae naturalis con gli Elementi di Euclide appare chiara
dalla struttura del primo libro: la trattazione procede deduttivamente dalle definizioni delle
nozioni fondamentali (quantità di materia, quantità di moto, specificazioni riguardanti le
forze) e dagli assiomi o principi generali della dinamica ai teoremi. In particolare, poi,
Newton dalla legge di gravitazione universale deduce, con procedimento geometrico, quelle
leggi di Keplero, dalle quali l’ha effettivamente derivata. Nell’opera, tuttavia, c’è una
combinazione sostanziale di induzione e deduzione, i cui risultati si confermano
reciprocamente in maniera circolare, ma non viziosa: Newton perviene per via induttiva ai
principi e alle leggi generali, da cui poi deduce sia altre leggi di estensione inferiore sia i
fenomeni. Dedurre i fenomeni significa spiegarli in maniera necessaria, evidenziare in essi
il determinismo della natura. Tuttavia, se il metodo deduttivo è uno strumento importante di
rigorosa esposizione scientifica, la conoscenza della natura ha sempre bisogno del supporto
dell’esperienza sia nella fase preliminare dell’approccio osservativo e induttivo sia nel
momento della conferma sperimentale della teoria. Questa circolarità di induzione e
deduzione è presente ed evidente nelle famose quattro regulae philosophandi che Newton
espone all’inizio del terzo libro dei Principia100:
“Regola I: Delle cose naturali non devono essere ammesse cause più numerose di quelle
che sono vere e bastano a spiegare i fenomeni.
Come dicono i filosofi: la natura non fa nulla invano, e inutilmente viene fatto con molte
cose ciò che può essere fatto con poche. La natura, infatti, è semplice e non sovrabbonda in
cause superflue delle cose”. È un’esplicita riproposizione del tradizionale principio di
economia: “Frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora”, il cui assunto,
assiomatico, si ritiene sia fondato sull’esperienza. Esso comporta il rifiuto di teorie
complicate a vantaggio di altre, che, a parità di efficacia esplicativa, sono più semplici. →
Economia, Principio di
99
G. Galilei, Il Saggiatore, Opere, ed. naz. diretta da A. Favaro, Barbera, 1890-1909, ristampa 1929-39, vol. vol.
VI, p. 232
100
I. Newton, Principi matematici della filosofia naturale, cit., libro III, Regole del filosofare, pp. 609-613
139
“Regola II: Perciò, finché può essere fatto, le medesime cause vanno assegnate ad effetti
naturali dello stesso genere”. Si afferma sostanzialmente il principio di uniformità della
natura e, conseguentemente, nell’ambito della spiegazione teorica si dichiara la legittimità
del criterio dell’analogia.
“Regola III: Le qualità dei corpi che non possono essere aumentate e diminuite, e quelle
che appartengono a tutti i corpi sui quali è possibile impiantare esperimenti devono essere
ritenute qualità di tutti i corpi”. Si afferma il principio di omogeneità e costanza della
natura, lo si considera fondato sull’esperienza e, a sua volta, tale da giustificare l’induzione,
cioè la generalizzazione dei risultati delle nostre ricerche, perché “non devono essere
inventati sconsideratamente dei sogni né ci si deve allontanare dall’analogia della natura,
dato che essa suole essere semplice e sempre conforme a sé”. Infatti, nota Newton, “le
qualità dei corpi non si conoscono altrimenti che per mezzo di esperimenti”; per esempio
“deduciamo che tutti i corpi sono impenetrabili non con la ragione, ma col senso”. Non ci
può essere una scienza a priori della natura, perché “abbiamo imparato dai fenomeni”.
“Regola IV: Nella filosofia sperimentale le proposizioni ricavate per induzione dai
fenomeni, devono, nonostante le ipotesi contrarie, essere considerate vere o rigorosamente
o quanto più possibile, finché non interverranno altri fenomeni, mediante i quali o sono
rese più esatte o vengono assoggettate ad eccezioni”. La vera scienza sperimentale non ha
nulla a che vedere con il dogmatismo; essa è essenzialmente caratterizzata dalla capacità di
autocontrollarsi nel confronto con l’esperienza e dalla disponibilità a rivedere le proprie
posizioni e ad autocorreggersi.
140
N
NATURA, STATO DI
L’espressione “stato di natura” ricorre sia nel linguaggio della filosofia moderna che in
quello della teologia cattolica.
Espressione della filosofia moderna
L’uso filosofico dell’espressione riguarda soprattutto il dibattito giusnaturalistico e le teorie
contrattualistiche dello Stato. Queste, infatti, si fondano sul riconoscimento di una
condizione prepolitica dell’umanità, coincidente appunto con uno stato di natura, che
qualcuno (Thomas Hobbes) ha caratterizzato come asociale, ma i giusnaturalisti hanno
inteso come già regolato dal diritto naturale; tutti comunque erano convinti che questa una
condizione di tal genere sia di per sé insufficiente a garantire agli uomini un sicuro
progresso storico. Pertanto hanno teorizzato la società politica (lo Stato per antonomasia)
come una formazione che occorre realizzare mediante un patto, consistente in una generale
delega del potere pubblico a beneficio di tutti. In tal modo la società politica sostituisce
l’originario stato di natura. → Contrattualismo
Non tutti hanno pensato che lo stato di natura sia realmente esistito. Jean-Jacques
Rousseau, per esempio, lo escludeva, ritenendo che esso potesse avere soltanto il valore di
un’ipotesi teorica, destinata a predisporre un ideale criterio di giudizio, per valutare la
concreta corrispondenza della realtà storica alle vere esigenze dell’uomo.
Anche a proposito del patto costituente, che sta alla base della società politica, Immanuel
Kant riteneva che esso non è di per sé identificabile con un preciso fatto storico, perché
consiste essenzialmente in un’idea regolativa, ossia in un modello ideale, al quale chi
gestisce il potere deve sempre rifarsi. → Politica (Teorie politiche)
Espressione della teologia cattolica
Nella teologia cattolica per “stato di natura” s’intende l’ipotetica condizione in cui si
sarebbe trovato l’uomo, se Dio non l’avesse elevato per grazia allo stato soprannaturale e
non l’avesse destinato alla visione beatifica della sua essenza.
La tarda scolastica, rappresentata in particolare da Tommaso De Vio, detto il Caietano
(1468-1534), ha irrigidito tale nozione, configurandola come una “natura pura”, cioè una
condizione di vita in sé perfetta e autosufficiente. In tal modo, però, il dono che Dio fa di sé
all’uomo, cioè la grazia, rischia di apparire non come il vero e originario senso della
creazione, ma come qualcosa di superfluo rispetto a ciò di cui l’uomo naturalmente sente il
bisogno.
È vero che la nozione di “natura pura” è stata introdotta allo scopo di rimarcare l’assoluta
gratuità della grazia, tuttavia per la sua astrattezza, che non considera adeguatamente
l’intrinseca realtà dell’uomo, appare del tutto insoddisfacente alla teologia contemporanea.
Questa, infatti, intende innanzitutto rilevare la condizione specifica dell’uomo rispetto agli
altri enti del mondo, identificandola con il possesso di una natura “aperta”, cioè
essenzialmente orientata a trascendere l’ambito limitato del mondo fisico verso la realtà
assoluta di Dio, che sola può appagarne l’aspirazione infinita. Questa apertura è definita
come potentia oboedientialis, cioè come capacità di accondiscendere umilmente ad un
dono, che è tale perché l’uomo non può disporne, ma ne avverte soltanto un profondo
141
bisogno (desiderium naturale). Pertanto la cosiddetta elevazione soprannaturale s’innesta
nella struttura stessa dell’effettiva natura umana. A questo proposito menzioniamo come
autorevole testimone di questa più genuina tradizione teologica Tommaso d’Aquino. Egli
ravvisa nel naturale orientamento dell’uomo alla trascendenza un’innata possibilità di
rendersi disponibile ad un’eventuale gratuita iniziativa divina, che lo destini alla beatitudine
soprannaturale, cioè alla visione stessa di Dio. In questo senso egli dice che l’anima è
naturalmente in grado di accogliere la grazia (“naturaliter anima est gratiae capax”)8.
NOMINALISMO
È la posizione di coloro, per i quali gli universali, cioè i concetti, non hanno alcuna
consistenza ontologica, perché sono soltanto o puri nomi o semplici rappresentazioni
mentali, che intendono contrassegnare in forma generale le condizioni di somiglianza che
cogliamo tra le realtà individuali. Per i nominalisti, infatti, la realtà effettiva è
necessariamente individuale (“nihil est praeter individuum”: non c’è che l’individuo).
Nominalisti sono principalmente gli empiristi. → Universali, Il problema degli
NULLA
Il termine “nulla” deriva dal neutro plurale latino nulla (nessuna cosa), così come il suo
sinonimo “niente”, originato dall’espressione latina nec entem (nemmeno un ente), è
l’opposto negativo del termine essere.
Parmenide
Parmenide pose per primo il problema del non essere, configurandolo necessariamente in
rapporto all’essere e affermandone con assoluta intransigenza l’impensabilità. Egli osservò
che il pensiero coglie in tutto la determinazione essenziale e immutabile dell’essere, perché
di tutto si è obbligati a dire che è. L’affermazione: “l’essere è”, con la quale il filosofo
greco sintetizza il proprio pensiero, non è riducibile ad una banale tautologia; con essa,
invece, egli esprime l’originario stupore metafisico che coglie l’uomo alla presenza delle
cose. L’incontrovertibile legge, “la sola pensabile”, secondo la quale l’essere si rivela a
Parmenide come ciò che “è e non è possibile che non sia”, implica come suo inevitabile
risvolto negativo che il non essere “non è e non è possibile che sia” e pertanto “né lo puoi
pensare né lo puoi esprimere”: “è un sentiero del tutto inindagabile”37. Con queste
affermazioni il maestro di Elea esplicita il principio, logico e ontologico, di non
contraddizione, supremo e ineludibile criterio di razionalità e di senso, non rispettando il
quale si incorre nell’assurdo. Soltanto i “mortali che nulla sanno” e sembrano essere “gente
dalla doppia testa”38, confondono e mescolano a capriccio l’essere con il non essere e
dell’essere non sanno rilevare le proprietà; soprattutto non riconoscono che l’essere esclude
la molteplicità e il divenire. L’essere, infatti, è uno. In che cosa si potrebbero distinguere i
molti? Non in base al non essere, che non è, né in base all’essere, che invece li accomuna.
Da che cosa, poi, dovrebbe derivare? Dal non essere? Ma dal non essere nulla può
provenire. Dall’essere? Ma l’essere è e non diviene.
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 113, art. 10 c
Parmenide, ne I Presocratici, Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1975, vol. I,
“Frammenti”, vv. 2-7, p. 271
38
ivi, vv. 5-6, p. 272
8
37
142
Dalla scuola eleatica deriva sostanzialmente l’assioma, poi fissato in termini latini: “ex
nihilo nihil fit” (dal nulla nulla proviene). A questo riguardo, infatti, Melisso di Samo,
discepolo di Parmenide, dice: “Sempre era ciò che era e sempre sarà. Se, infatti, fosse
generato, sarebbe necessario che, prima che fosse generato, non fosse nulla: e se, prima,
non era nulla, per nessuna ragione nulla si sarebbe potuto generare dal nulla”39.
Un’intransigente riproposizione della verità ontologica parmenidea la ritroviamo nel
filosofo a noi contemporaneo Emanuele Severino, secondo il quale il fenomeno storico del
nichilismo deriva dalla confusione che la cultura occidentale con la sua fede nel divenire ha
prodotto tra l’essere e il nulla. → Nichilismo
Platone e Aristotele
I ragionamenti del maestro di Elea contrastano, tuttavia, con la solida incontrovertibilità
dell’esperienza, dove il divenire e la molteplicità regnano sovrani. La rigidità della sua
posizione non appare sostenibile né a Platone né ad Aristotele. Nei suoi confronti il primo
ritiene di dover diventare “quasi un parricida”, perché, egli afferma, “dovremo sostenere
con forza che ciò che non è, in certo senso, è esso pure e che ciò che è, a sua volta in certo
senso non è”40, infrangendo il severo divieto di parlare del non essere. Il non essere, infatti,
non va inteso in senso assoluto, ma relativo, come non essere rispetto a qualcosa, cioè come
diverso. Di ogni cosa si può dire che è se stessa in quanto è diversa e distinta dalle altre,
cioè in quanto non è le altre. “Omnis determinatio est negatio”, dirà Baruch Spinoza41 con
una formula latina, secondo la quale, per determinare ciò che una cosa è, occorre anche dire
ciò che essa non è.
Lungo la svolta determinata da Platone procede Aristotele, che rifiuta di considerare
l’essere in maniera univoca, come se fosse un unico genere universale, e ne indica invece
l’originaria “polivocità”, perché “l’essere si dice in molteplici significati”42. È sulla base di
un essere così configurato e della decisiva critica mossa da Platone nei riguardi di
Parmenide che Aristotele svolge le sue analisi dei concetti implicanti il non-essere: la
negazione, la privazione, la potenza, l’opposizione e la contraddizione, la falsità.
Gli atomisti
Con la fisica atomistica di Leucippo e Democrito, adottata poi da Epicuro, assistiamo ad
una traduzione materialistica dell’ontologia eleatica. È Aristotele che ci descrive la
corrispondenza delle tesi dell’atomismo rispetto a quelle di Parmenide e, nello stesso
tempo, ne individua le premesse nella preoccupazione di tener conto dell’esperienza, allo
scopo di “accordare le dottrine con i fenomeni”43. Nella Metafisica afferma infatti che gli
atomisti “sostengono che l’essere non ha affatto più realtà del non-essere, in quanto il pieno
non ha più realtà del vuoto”44. In tal modo essi hanno tradotto in concetti fisici i concetti
ontologici degli eleati. → Atomismo; Vuoto
Epicuro
Anche l’ontologia epicurea, che adotta gli elementi essenziali della fisica di Democrito, si
richiama all’impostazione della scuola eleatica mediante tre enunciazioni assiomatiche:
39
Melisso, Diels-Kranz, 30 B 1, trad. di G. Reale, in Storia della filosofia antica, Vita e pensiero, I, Milano, 1979,
p. 143
40
Platone, Sofista, 241 d, trad. di A. Zadro, in Opere complete, cit., vol. 2, p. 223
41
Spinoza, Epistulae, L
42
Aristotele, La metafisica, , 2, 1003 a 32, a cura di G. Reale, Loffredo, 1968, vol. I, p. 291
43
Aristotele, Generazione e corruzione, A, cap. 8, 324 b 35 – 325 a 32
44
Aristotele, La metafisica, A, 4, 985 b 7-8, cit., p. 115
143
l’evidenza delle prime due è rafforzata da un’indiretta dimostrazione “per assurdo”;
l’evidenza della terza, connessa alle prime due, è derivata dalla definizione del Tutto.
“Nulla nasce dal nulla”, altrimenti “qualsiasi cosa nascerebbe da qualsiasi cosa, senza
alcun bisogno di semi generatori”. In tal modo Epicuro riconferma la dichiarazione di
Melisso.
“Ciò che scompare non finisce nel nulla”, altrimenti “tutto sarebbe già distrutto, non
esistendo più ciò in cui si è dissolto”.
Il Tutto è eterno e infinito; infatti “il tutto sempre fu come è ora, e sempre sarà, poiché
nulla esiste in cui possa tramutarsi, né oltre il tutto il nulla che penetrandovi possa
produrre mutazione”. Inoltre “il Tutto è infinito, poiché ciò che è finito ha un estremo,
e l’estremo si può scorgere rispetto a qualcos’altro, ma il Tutto non si può scorgere da
qualcos’altro, di modo che non avendo estremo non ha nemmeno limite, e ciò che non
ha limite è illimitato [ápeiron]”45. Per Epicuro la natura è il Tutto.
Prescindendo dalla fisicizzazione dell’ontologia eleatica, realizzata dall’atomismo,
anche a proposito di questa terza enunciazione sull’essere infinito si può scorgere un
riflesso del pensiero di Melisso, che a questo riguardo prende le distanze da Parmenide
(→ Infinito).
Plotino
Nella metafisica di Plotino il discorso sul non essere riguarda gli estremi opposti della
realtà da lui descritta: l’Uno e la materia. Innanzitutto la trascendenza e l’assolutezza del
principio originario, da cui tutto proviene, impongono di sottrarre l’Uno ad ogni
determinazione positiva, perché l’eventuale tentativo di configurarne l’identità, cioè di dire
che cos’è, lo sminuirebbe come ente tra gli enti. L’Uno “è senza forma, non è essenza;
poiché l’essenza dev’essere qualcosa di ben determinato, vale a dire di definito: invece,
quanto all’Uno, non è proprio dato di coglierlo come ‘determinato’, giacché allora non
sarebbe più principio, ma sarebbe unicamente quella cosa di cui tu dici che ‘è questo’”;
l’Uno, perciò, “è al di là dell’essere” ed è al di là del pensiero, è “l’Ineffabile” (ἄρρητος,
árretos): tutti i nomi, ai quali tentiamo di ricorrere, si rivelano inadeguati, e “anche questo
nostro nome ‘Uno’ non ha altro valore che di ‘soppressione’ relativamente al molteplice
[...] Che se l’Uno - nome e cosa significata - avesse un valore positivo, esso riuscirebbe in
fin dei conti assai meno chiaro che se non gli si desse nome alcuno”46. Qui siamo all’origine
della teologia “apofatica” o “negativa”, di cui si avvarrà tutta la tradizione mistica
occidentale: la consapevolezza e il rispetto della trascendenza del divino impongono che se
ne parli non direttamente, data la nostra inadeguatezza, ma indirettamente, affermando non
ciò che è, ma ciò che non è; esso non va confuso con la realtà finita e a suo riguardo è
necessario il silenzio. Pertanto, l’origine prima delle cose ci si configura come assenza e
negazione di ogni determinazione, cioè come nulla.
45
Epicuro, Lettera a Erodoto in e il problema del piacere nella filosofia antica, trad. di G. Arrighetti a cura di S.
Maso, Paravia, 1994, pp. 41 e 43.
Lucrezio nel De rerum natura (I, vv.150; 248; 958-959) ribadirà queste tesi: “Mai nessuna cosa è stata creata dal
nulla per intervento degli dei” (nullam rem e nilo gigni divinitus umquam); “nessuna cosa ritorna al nulla” (haud
igitur redit ad nilum res ulla); “l’universo da nessuna parte è limitato” (Omne quod est igitur nulla regione viarum
/ finitumst). Per questa terza tesi ricorrerà all’efficace argomentazione dell’arciere, collocato all’ipotetico estremo
del mondo, da dove è invitato a lanciare una freccia (ivi, I, vv. 972-987 → Spazio, Le aporie di Zenone e la teoria
dell’atomismo).
46
Plotino, Enneadi, V, 5, VI, a cura di V. Cilento, Laterza, 1973, vol. III / 1, pp. 66 s.
144
In posizione opposta all’Uno sta la materia. Conformemente a quanto sosteneva la
tradizione platonica, essa è complementare alla forma. Dal mondo intelligibile, cioè dal
Noûs, provengono le forme ideali, gli eterni modelli delle cose, con i quali la forza
animatrice della natura plasma e determina variamente la materia, in sé indeterminata e
indefinita. La materia, infatti, non è ontologicamente qualcosa di positivo, che possa
autonomamente sussistere; essa può emergere concretamente dal nulla soltanto se prende
forma, perché in sé, nella sua assoluta indeterminatezza, è qualificabile soltanto in maniera
negativa, come “privazione” e come non essere. In sé è altrettanto ineffabile dell’Uno; ma
dell’Uno noi non possiamo dire alcunché a causa della sua sovrabbondante ricchezza, che
la nostra mente non può contenere, perché è infinita e ci trascende, invece la materia sfugge
alle possibilità del nostro discorso a causa della sua estrema povertà, perché è
assolutamente indefinita, e pertanto è caratterizzata da un’infinità negativa. La materia è il
limite ultimo del processo che irradia dall’Uno, l’ombra dove termina la luce; essa è
mancanza e privazione.
Il pensiero cristiano
Secondo il pensiero cristiano il riferimento al nulla è essenziale per far emergere
l’originaria e costitutiva condizione creaturale del mondo. Considerati in sé, gli enti creati
sono contingenti, nel senso che non esistono necessariamente: lo dimostrano il loro inizio e
il loro divenire. Il fondamento primo e assoluto dell’esistenza degli enti contingenti non
può ovviamente essere il nulla, perché dal nulla nulla viene; ma poiché qualcosa esiste,
qualcosa esiste necessariamente. La tradizione religiosa l’ha chiamato Dio.
La questione fondamentale della metafisica sembra, comunque, non poter eludere il
richiamo al nulla. Essa è così espressa da G.W. Leibniz: “Perché esiste qualcosa anziché
niente? giacché il nulla è più semplice e più facile di qualcosa”47. Il rischio è che così si
entifichi il non essere, incorrendo nel divieto di Parmenide. → Creazione, Contingenza
G.W.F. Hegel
Nella Scienza della logica (1816) Hegel considera il nulla come coincidente con l’essere.
L’essere, infatti, pensato nella sua massima astrazione, in quanto non è alcunché di
determinato, richiama dialetticamente il suo opposto, cioè il nulla, dal quale e nel quale
diviene. Il divenire, perciò, è il superamento dell’astrattezza dell’essere e del nulla, perché
il movimento è la vera struttura della realtà e del pensiero.
Hegel, poi, riprendendo sostanzialmente la critica di Platone nei riguardi di Parmenide e
richiamandosi alla sentenza spinoziana su citata (“Omnis determinatio est negatio”)48,
individua nella negazione la condizione necessaria del dinamismo del reale. La negazione
dialettica, infatti, è una “negazione determinata”, perché non è finalizzata semplicemente ad
eliminare, ma “ha un contenuto” positivo, “è un nuovo concetto, che è superiore e più ricco
che non il precedente. [Infatti...] è l’unità di quel concetto e del suo opposto”; in altri
termini “quello che si contraddice non si risolve nello zero, nel nulla astratto, ma solo nella
negazione del suo contenuto particolare”49. → Dialettica
L. Feuerbach
47
G.W. Leibniz, Principi della natura e della grazia fondati sulla ragione, in Scritti filosofici, vol. I, a cura di
D.O. Bianca, UTET, 1967 (rist. 1988), p. 278
48
citata in G.W.F. Hegel, Scienza della logica, a cura di A. Moni e C. Cesa, Laterza, 1974, I, p. 108
49
G.W.F. Hegel, Scienza della logica, cit., I, p. 36
145
Nello scritto intitolato Per la critica della filosofia hegeliana (1839)50 L. Feuerbach svolge
un’analisi critica del concetto di nulla, rilevando l’assoluta assurdità o contraddittorietà di
una sua entificazione metafisica in opposizione all’essere. A questo proposito afferma che il
pensiero del nulla, assunto in opposizione universale all’essere, “confuta se stesso”, perché
“chi pensa nulla non pensa, appunto. Il nulla è la negazione del pensare; può essere quindi
pensato solo quando se ne fa qualcosa”, cioè quando è assunto in forma determinata in
relazione agli enti, come avviene, per esempio, per i singoli individui, nel cui destino
nullificante della morte si evidenzia la loro concreta opposizione al genere, che ad essi
sopravvive. Invece quando è affermato di per sé e assolutamente, il nulla o è una semplice
espressione verbale o, concettualmente, manifesta una netta irrazionalità, risultando, in
quanto tale, uno spettro arbitrario dell’immaginazione. Razionalmente può svolgere
soltanto una funzione “privativa”, com’è per l’oscurità, che non è qualcosa, ma è la
semplice assenza della luce. Feuerbach rileva in particolare l’assurdità del concetto di nulla
nella teoria della creazione, che la teologia cristiana ha voluto opporre alla concezione
pagana dell’eternità del mondo.
A.. Schopenhauer
Nel pensiero di A. Schopenhauer il nulla emerge dal desiderio di emanciparsi dalla miseria
del vivere. La vita, infatti, è impulso e desiderio, che perennemente insorgono e
ineludibilmente restano insoddisfatti: “per un desiderio, che venga appagato, ne rimangono
almeno dieci insoddisfatti; inoltre, la brama dura a lungo, le esigenze vanno all’infinito,
l’appagamento è breve e misurato con mano avara. [...] rassomiglia soltanto all’elemosina,
la quale gettata al mendico prolunga oggi la sua vita per continuare domani il suo
tormento”51. La soluzione non può essere il suicidio, che è un’esasperata riaffermazione
della volontà di vita attraverso il rifiuto delle condizioni avute in sorte. Il suicidio, poi,
comporta la soppressione dell’individuo, ma lascia intatta la Volontà universale, vera
sostanza del mondo, di cui l’individuo è una particolare manifestazione fenomenica.
Rimedi progressivamente efficaci sono invece l’arte, la morale e soprattutto l’ascesi, con la
quale si può puntare all’estinzione di ogni sentire, all’estirpazione del desiderio, alla
soppressione della volontà di vivere, cioè alla sua conversione in “nolontà”, che comporta
l’esperienza del nulla, il nirvana buddista. Così Schopenhauer lo intravede: “Allora, in
luogo dell’incessante, agitato impulso; in luogo del perenne passar dal desiderio al timore e
dalla gioia al dolore; in luogo della speranza mai appagata e mai spenta, ond’è formato il
sogno di vita d’ogni uomo ancor volente: ci appare quella pace che sta più in alto di tutta la
ragione, quell’assoluta quiete dell’animo pari alla calma del mare”52.
A.
S. Kierkegaard
Søren Kierkegaard e, al suo seguito, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre ripropongono la
considerazione del nulla come un tema che è inevitabilmente sotteso alla questione
dell’esistenza. Per questi autori il nulla non è un semplice concetto, ma rivela la propria
concretezza nell’esperienza vissuta
Søren Kierkegaard recupera la dimensione di contingenza e finitezza che la parola
“esistenza” originariamente aveva e ne restringeva l’applicazione alle creature, il cui essere
“ex-sistit”, “deriva da”, sia nel senso che dipende da una realtà esterna, che la trascende e
50
L. Feuerbach, Per la critica della filosofia hegeliana, in Scritti filosofici, a cura di C. Cesa, Laterza, 1976, pp. 84
ss.
51
A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di P. Savj- Lopez e G. De Lorenzo,
Laterza, 1979, vol. II, p. 270
52
A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., vol. II, p. 535
146
la fonda, cioè Dio, sia nel senso che proviene dal non essere. Perciò di Dio Kierkegaard
afferma: “Dio non esiste, Egli è eterno”53.
L’“esistenza” è intrinsecamente caratterizzata da una condizione permanente di
possibilità, che è insieme positiva e rischiosa, perché in essa, per definizione “tutto è
ugualmente possibile”54. Poiché è indeterminata nei suoi esiti, è esposta al sentimento
dell’angoscia, che suscita in noi un turbamento inquietante e totale. L’angoscia “abita porta
a porta” con noi: è la “vertigine” della libertà, perché “chi volge gli occhi al fondo di un
abisso, è preso dalla vertigine. [...] In questa vertigine la libertà cade”55. L’angoscia rende
evidente che l’esistenza è permanentemente sospesa sul nulla. Essa non appartiene
all’animale, ma all’uomo; si distingue dal semplice timore, che “si riferisce a qualcosa di
determinato”, perché, all’opposto, “il nulla genera l’angoscia”: essa “è la realtà della libertà
come possibilità per la possibilità”56. → Esistenza; Angoscia
M. Heidegger
Nel Novecento Martin Heidegger torna a rimarcare l’importanza della “tonalità emotiva”
dell’angoscia, che sempre accompagna l’esistenza, nella quale l’uomo si trova “gettato” in
una condizione di pura e semplice “fatticità”. L’“essere nel mondo”, infatti, lo costituisce
essenzialmente come “Esserci” (Dasein). Non è lui il padrone dell’essere. Soprattutto nella
prospettiva anticipatrice della morte egli ha modo di avvertire la propria precarietà e
contingenza. Con lo spaesamento che l’angoscia gli provoca, l’Esserci è posto di fronte al
nulla. Ora, se è pur vero che l’esistenza è di per sé “possibilità”, ossia prospettazione
costante di un qualche progetto, che gli permette di trascendere la posizione
precedentemente acquisita, e in tal senso l’Esserci potrebbe in prima istanza apparire il
fondamento di se stesso, perché a sé egli è affidato, poi però avverte che “non può mai
insignorirsi di questo fondamento”, cioè che questo “esser-fondamento significa non esser
mai signore dell’essere più proprio. […] L’Esserci, essendo-fondamento, è come tale, una
nullità di se stesso”57. Nel pensiero della morte, nella “decisione anticipatrice” di essa, che
non consiste nel realizzarla con il suicidio, l’Esserci ha modo di vivere il proprio nulla
come la sua possibilità più propria e permanente e non come un semplice fatto tra gli altri.
Anticipare consapevolmente nell’angoscia la propria morte significa per l’Esserci mettersi
davanti al nulla da cui proviene e verso cui va, per accettare la propria costitutiva finitezza.
→ Morte
L’ontologia di Heidegger non intende affatto eludere la questione del nulla; ne fa invece un
tema di centrale importanza. È pur vero, egli dice, che “la scienza con superiore
indifferenza lo ripudia come ciò che ‘non c’è’” e che nell’affrontarlo “avvertiamo qualcosa
di strano”, perché in qualche modo il niente assume contraddittoriamente le sembianze di
un essente. Infatti “la norma del pensare in generale comunemente accettata, la ‘Logica’
universale col suo principio di non contraddizione, sopprime la questione, poiché il
pensiero – che è sempre essenzialmente pensiero di qualcosa – dovrebbe qui agire contro il
suo proprio essere come pensiero del niente”58. Tuttavia, afferma Heidegger, “noi non ci
lasciamo fuorviare dalla formale impossibilità della questione, e la teniamo ferma”59, anche
53
S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica, parte II, c. 3, § 2, in Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni,
1972, p. 441
54
S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, a cura di C. Fabro, Sansoni, 1953, pp. 194-5
55
S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 74
56
S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, cit., p. 51
57
M. Heidegger, Essere e tempo, § 58, trad. it. di P. Chiodi, Longanesi, 1970, p. 428
58
M. Heidegger, Che cos’è la metafisica?, a cura di A. Carlini, La Nuova Italia, 1992, p. 11
59
ivi, p. 13
147
perché non è eludibile il fatto che “l’angoscia rivela il niente […] l’angoscia ci tien sospesi,
perché porta l’essente nella sua totalità a scomparire”60, a dileguarsi nell’insignificanza. Ciò
consente che nel nulla si riveli l’essere. Il niente, perciò, “non è un oggetto, né in generale
un essente; […] Il niente è la condizione che fa possibile la rivelazione dell’essente come
tale per l’essere esistenziale dell’uomo. Il niente non dà soltanto il concetto opposto a
quello di essente, ma appartiene originariamente all’essenza dell’essere stesso. Il
nientificare del niente avviene nell’essere dell’essente”61. Pertanto Heidegger rifiuta la
classica formula perentoria, per la quale “ex nihilo nihil fit”, dal niente nulla procede. Per
lui assume un’importanza fondamentale la tesi che l’Essere stesso è il ni-ente, cioè nulla
dell’ente, con il quale non può essere confuso. Lo scambio degli enti con l’Essere è stato,
invece, l’errore secolare della metafisica, che ha impedito all’Essere di emergere nella sua
verità. Occorre ritrovare nella condizione del nulla lo stupore originario che ci risveglia al
senso dell’Essere, facendo ancora una volta sbocciare la domanda: “Perché?”62
In tal modo Heidegger concorda con l’affermazione di Hegel che “il puro essere e il puro
niente è, dunque, lo stesso”, una volta che le siano tolte l’indeterminatezza e
l’immediatezza con cui era stata da lui pensata, e invece sia inserita nella concretezza
dell’esistenza63. Si sente anche di poter sostenere la tesi che “il niente è l’origine della
negazione, non viceversa”64, perché la questione del nulla, compresa adeguatamente, non è
risolvibile mediante una logica intellettualistica, ma soltanto in un’ottica ontologica, che
emerge nella nostra esistenza quando siamo colti dalle tonalità emotive più radicali, quali la
noia, la gioia, l’angoscia, nelle quali “la totalità dell’ente è messa in gioco quanto al suo
essere e al suo significare”, perché “nella noia tutto diventa insignificante, nella gioia tutto
esaltante, nell’angoscia tutto si sottrae, sicché resta il niente a cui appigliarsi”65.
A quest’ottica Rudolf Carnap oppone le esigenze della logica, applicandola alle
dimensioni dell’esperienza ordinaria e considerando sostanzialmente privo di senso, anche
se apparentemente corretto nella sua espressione sintattica, il discorso ontologico. A suo
giudizio, infatti, quando usualmente diciamo: “Fuori non c’è nulla”, intendiamo in un
linguaggio formalmente corretto: “Non c’è qualcosa che sia fuori”. Diversamente da ciò, i
metafisici intendono la parola “nulla” come se fosse la denominazione di qualcosa, e così
entificano in maniera equivoca le semplici negazioni (i “non”) che intervengono nelle
proposizioni esistenziali di forma negativa66.
Di rincalzo, però, Umberto Galimberti, parafrasando il pensiero di Heidegger e
mettendolo a confronto con le esigenze intellettualistiche della logica e della spiegazione
causale perseguita dalla scienza, osserva: “Il niente che si avverte nell’angoscia non è
‘qualcosa’ e neppure si presenta come un contenuto o un oggetto, per cui nessuna logica
oggettivante è in grado di coglierlo. La scienza non ode il silenzio del niente. Raccolta e
impegnata nella considerazione dell’ente non è in grado di cogliere quel niente che si
determina in occasione dell’assentarsi dell’ente. Per questo di fronte alla domanda
filosofica: ‘Perché in generale c’è l’ente e non piuttosto il nulla?’ la scienza non avverte
l’essenzialità dell’aggiunta ‘e non il nulla’, ma, trattenendosi nella prima frazione della
domanda ‘perché in generale c’è l’ente?’ s’affretta a cercarne la causa, capovolgendo così il
60
ivi, p. 19
ivi, pp. 23-24
62
ivi, p. 33
63
ivi, p. 30
64
ivi, p. 26 e p. 13
65
U. Garimberti, Il tramonto dell’Occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers, Feltrinelli, 2005, p. 57
66
R. Carnap, Il superamento della metafisica mediante l’analisi logica del linguaggio, in AA. VV., Il
neoempirismo, a cura di A. Pasquinelli, UTET, 1969, pp. 515-518
61
148
senso e la radicalità della domanda. Il ‘non-nulla’ non è un chiarimento aggiunto al
discorso, ma è ciò che, precedendo il discorso, lo rende significante. L’ente è perché non è
nulla. Il ‘non-nulla’ è quindi la rivelazione dell’essere dell’ente”67. Questo rilievo è riferito
ad un orientamento tipico della scienza e della stessa tradizionale metafisica, che, nel
soddisfare le loro richieste, si attengono entrambe al principio di causalità, applicato
rispettivamente dall’una e dall’altra al diverso livello delle cause “seconde”, riguardanti i
fenomeni empirici, e delle cause “prime” o fondamentali. In tal modo, però, sia la scienza
che la metafisica non colgono il significato vero e profondo della domanda leibniziana,
riproposta da Heidegger: “Perché in generale c’è l’ente e non piuttosto il nulla?” A questo
proposito, infatti, Umberto Galimberti puntualizza: “Qui non si chiede ‘chi ha fatto essere
l’ente, preferendolo al nulla’, ma si chiede: ‘che senso ha che a essere sia l’ente e non il
nulla?’. Se ci si limitasse a chiedere la causa dell’essere dell’ente, invece che il suo senso,
non ci si muoverebbe sul piano filosofico che mette in questione la totalità, ma su quello
scientifico che, lungi dal problematizzare il valore del principio di causalità, lo
assumerebbe senz’altro come struttura anticipante [= presupposto] al cui interno collocare,
e quindi limitare, la portata della domanda”68. → Senso e significato
J.-P. Sartre
Ritroviamo il nulla anche al centro della riflessione di Jean-Paul Sartre. Non a caso
L’essere e il nulla (1943) è la sua opera teoreticamente più impegnativa.
Nell’ontologia sartriana l’essere, come correlato oggettivo della coscienza, è il mondo, e
il nulla è la coscienza. Essi sono indicati, con formule di ascendenza hegeliana,
rispettivamente come “in-sé” e “per-sé”. Dell’“in-sé” Sartre dice che è “opaco”, “non ha
segreti: è massiccio”, “non può essere né derivato dal possibile né essere ricondotto al
necessario”, cioè è pura presenza, è “contingente”, “non è mai né possibile né impossibile,
è”; ad esso risulta appropriata la rigida applicazione del principio d’identità, cioè la
definizione tautologica: “l’essere è ciò che è”. L’essere del per sé, invece, può essere
definito come “ciò che è ciò che non è e ciò che non è ciò che è”69, ossia come “nulla”.
Infatti, la coscienza, rivolta al mondo e ad esso contrapposta, è in grado di annullare il
mondo in quanto realtà data, per esempio tramite l’immaginazione, o anche nella
percezione, per mezzo della funzione selettiva dell’attenzione, la quale fa emergere in
primo piano ciò a cui si rivolge ed è interessata, “annullando” sullo sfondo il resto.
Pensiamo, poi, agli interventi interrogativi della coscienza di fronte al mondo, perché
“esiste, per chi interroga, la possibilità permanente ed obiettiva di una risposta negativa. [...]
La possibilità permanente del non-essere, fuori di noi ed in noi, condiziona le nostre
domande sull’essere. Ed ancora il non-essere circoscrive la risposta: ciò che l’essere sarà si
distaccherà necessariamente sullo sfondo di ciò che non è. Quale che sia questa risposta,
potrà formularsi così ‘L’essere è ciò, e, al di fuori di ciò, niente’”70. Ancor più radicalmente
si esprime questa possibilità di tenere il mondo “in sospeso” nel nulla, quando “il Dasein
[l’Esserci, come lo chiama Heidegger, cioè l’uomo] realizza la contingenza del mondo, cioè
pone il problema: ‘In base a che cosa vi è qualcosa, piuttosto che niente?’ [...] Ecco che il
nulla è dato come ciò per cui il mondo riceve i suoi contorni di mondo”71.
Infine, più concretamente la coscienza esprime il suo potere di annullamento di ciò che è,
ossia della situazione data, quando fa uso della libertà, mediante la quale “ha da essere ciò
U. Garimberti, Il tramonto dell’Occidente, cit., pp. 57-58
ivi, p. 54
J.P. Sartre, L’essere e il nulla, trad. it. di G. Del Bo, Il Saggiatore, 1975, p. 32
70
ivi, pp. 39-40
71
ivi, p. 54
67
68
69
149
che è”72, coincidendo con il progettarsi di sé e con i propri atti. La libertà che la costituisce
è intenzionalità che si sottrae ai dati di fatto, per impegnarsi in prospettive sempre nuove, in
cui è possibile che i progetti assunti varino di fronte a ulteriori scelte. “Il per sé, infatti, è un
essere il cui essere si problematizza nel suo essere sotto forma di progetto di essere”73.
Originariamente l’uomo è nulla; a lui spetta realizzarsi in una qualche direzione, perchè “la
libertà umana precede l’essenza dell’uomo e la rende possibile, l’essenza dell’essere umano
è in sospeso nella sua libertà”74. Sartre si rifà direttamente a Kierkegaard e a Heidegger nel
richiamare la stretta connessione tra la libertà e l’angoscia: mentre “la paura è paura degli
esseri del mondo, l’angoscia è angoscia di fronte a me stesso”75 e io “mi angoscio proprio
perché i miei comportamenti non sono che possibili”76. L’angoscia è la coscienza della
libertà, è l’esperienza radicale del nulla.
72
ivi, p. 32
ivi, p. 678
ivi, p. 62
75
ivi, p. 67
76
ivi, p. 69
73
74
150
O
ORGANICISMO
È così denominata una qualsiasi teoria della realtà (natura, storia, società), che assume
come criterio interpretativo l’analogia con l’organismo vivente, la cui struttura è costituita
da una pluralità di parti, funzionalmente interdipendenti a beneficio del tutto, al quale
servono come strumenti (“organi” nell’etimologia greca). Alla concezione organicistica
presiede il “principio olistico”, in base al quale si considera l’organismo come un tutto (in
greco ὅλον, hólon) e il tutto come una realtà superiore alla semplice somma delle parti. Si
tratta, perciò, di un’interpretazione intrinsecamente finalistica, che nell’organismo coglie
un’immanente integrazione delle parti. → Totalità; Funzionalismo
151
P
PASSIONE
È un termine di derivazione latina (passio). Il corrispondente termine greco πάθος (páthos)
è tradotto spesso con il generico “affezione” (dal latino affectio o affectus; → Affezione),
che designa la condizione passiva che può riguardare (in latino “afficere”) ogni ente,
quando subisce l’azione altrui. È tradotto, invece, con il più specifico “passione”, quando si
riferisce allo stato di alterazione e turbamento della mente o dell’anima. La passione è più
intensa del sentimento ed è più stabile dell’emozione. Nell’ontologia aristotelica la passione
è una delle categorie. Anch’essa, come l’azione, che è il suo opposto, presuppone la
sostanza, a cui inerisce. → Categorie; Azione
Platone
Platone attribuisce la passionalità alle parti irrazionali dell’anima, cioè all’ἐπιθυμία
(epithymía) e al θυμός (thymós), termini che sono ordinariamente tradotti con
“concupiscibile” e “irascibile”. È nota la descrizione che ce ne dà nel mito della biga alata
del Fedro, secondo il quale spetta alla nostra parte razionale, come ad un coscienzioso
auriga, tenere sotto controllo il carro dell’anima, che è soggetto al traino indisciplinato di
un indomito cavallo nero (la parte concupiscibile), quando accondiscende agli impulsi
istintivi. L’auriga può essere agevolato dall’aiuto che gli dà il cavallo bianco (la parte
ardimentosa) nell’affrontare le difficoltà e gli ostacoli.
Tra i dialoghi platonici il Fedro è particolarmente efficace nel rappresentare la passione
erotica (ἔρως, éros), suscitata dalla bellezza, la cui idea è più vivacemente presente di tutte
le altre idee nella nostra esperienza. Tra le essenze essa è “la più percepibile dai sensi e la
più amabile di tutte”, ed è tale da coinvolgere tutto l’uomo e tutta l’anima nelle sue diverse
parti in una tensione che eccede la compostezza di una vita tranquilla. Nell’amore intenso,
infatti, si realizza uno stato di “delirio”, “rapimento”, “estasi”, “smarrimento”, che
comporta un vero “patimento dell’anima”. Il susseguirsi concitato di questi termini, a cui
Platone ricorre, rappresenta un’efficace sintomatologia del mal d’amore. Essa è data da
varie reazioni psicofisiche, che non dipendono dalla nostra volontà: “rabbrividire”,
“accendersi di calore”, “palpitare”, essere sottoposti alle “trafitture” e agli “assilli” del
desiderio, che ci sommerge nella sua onda, “smaniare” e subire gli “affanni” per l’oggetto
amato15.
Le filosofie ellenistiche: l’epicureismo e lo stoicismo
Nell’ellenismo la filosofia assume come suo principale compito la terapia dell’anima da
tutto ciò che ne insidia la serenità. Pertanto, contro la paura degli dei, della morte e del
dolore Epicuro suggerisce il rimedio del quadrifarmaco, che consiste innanzitutto in
un’operazione di corretta conoscenza, che ci consente di attribuire gli eventi alle loro cause
naturali e di accettare razionalmente il nostro destino nell’ambito della natura, cogliendo
con saggezza tutte le opportunità di godere con equilibrio ciò che la vita offre (carpe diem).
15
Platone, Fedro, 250 d; 251 a - 252 b, trad. di P. Pucci, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, Laterza,
1971, vol. 3, pp. 251 ss.
152
Il risultato pratico della saggezza nell’ambito dell’esistenza è l’atarassìa (ἀταραξία,
ataraxía), cioè l’assenza di turbamento dell’anima. → Epicureismo; Atarassia
A loro volta gli stoici intendono convincere gli uomini ad accogliere con animo sereno
l’inevitabilità degli eventi e a praticare l’indifferenza (ἀδιαφορία, adiaphoría) verso tutto
ciò che può inquietarli, perché il mondo è interamente predeterminato e governato dal
Lógos (la ragione universale). L’unico saggio atteggiamento, che è possibile assumere,
consiste nell’adeguarsi a questa necessità. Soltanto il sapiente è in grado di raggiungere lo
stato di “apatia” (ἀπάθεια, apátheia), cioè lo sradicamento delle passioni, tra le quali quelle
fondamentali sono il desiderio e la paura, il piacere e il dolore. Derivano tutte dalle false
opinioni su ciò che possiamo considerare bene o male: le prime due dipendono dalle
prospettive future, la terza e la quarta riguardano il presente. Nulla può insidiare il sapiente
dall’esterno, perché si è assicurato un perfetto autocontrollo razionale. → Stoicismo
Renato Cartesio e Baruch Spinoza
In epoca moderna rivolgono la loro attenzione all’analisi delle passioni Renato Cartesio e
Baruch Spinoza.
Di Cartesio ricordiamo lo scritto Le passioni dell’anima (1649). Diversamente dalle azioni,
nelle quali si esprime la nostra capacità d’iniziativa e di autodeterminazione, le passioni si
identificano con quegli eventi involontari, che noi subiamo in noi stessi e sono causati dagli
“spiriti vitali”, cioè dagli impulsi meccanici che agiscono nel nostro corpo. Esse non sono
di per sé negative, perché sono funzionali alla positiva realizzazione della nostra corporeità
nella sua interazione con l’ambiente. Da esse l’anima è avvertita di ciò che può recar danno
o procurare vantaggio al corpo. Queste due opposte condizioni suscitano innanzitutto le
passioni primarie della tristezza e della gioia, che a loro volta determinano l’odio e l’amore
nei riguardi di ciò che le suscita. Non ha senso pensare di estirparle, perché la moralità
consiste nel governarle e moderarle, per non lasciarsi dominare e travolgere. L’anima, che
sa tenerle sotto il controllo della propria razionalità, consegue la saggezza.
Spinoza tratta delle passioni nell’Ethica ordine geometrico demonstrata (1677, postuma)
sulla base di un rigoroso razionalismo “geometrico”, il cui scopo è di farci comprendere i
meccanismi che le generano e disporci a governarle. Egli chiama genericamente “affetti”
gli stati emotivi che determinano l’accrescimento o la diminuzione della “tendenza
all’autoconservazione” (conatus sese conservandi), cioè dell’originaria energia vitale, con
la quale spontaneamente ci identifichiamo. In rapporto a questi due opposti risultati,
positivo o negativo, gli affetti sono azioni o passioni.
Secondo Spinoza la nostra mente è in grado di percepirsi libera e attiva quando considera
le cose sub specie aeternitatis, cioè quando si pone nell’ottica dell’eternità. Infatti la
garanzia di una corretta conoscenza può essere data soltanto dalla capacità razionale di
riferire ogni evento alla sostanza divina, che è la causa originaria e universale. Se
conseguiamo questo livello, riusciamo a sottrarci alla “schiavitù”, che c’impongono le
passioni, “poiché l’uomo soggetto agli affetti non appartiene a se stesso ma alla fortuna”,
cioè al caso. Soltanto mediante la ragione possiamo garantirci libertà e autonomia, tuttavia
non direttamente, ma in quanto la ragione stessa diventa una forza emotiva, perché “un
affetto non può essere impedito né tolto, se non mediante un affetto contrario e più forte”.
Così “la vera conoscenza del bene e del male non può impedire nessun affetto in quanto
153
vera [ossia nel suo aspetto teoretico], ma soltanto in quanto è considerata come affetto”16.
Possiamo constatare la verità di questa affermazione, riferendoci alla nostra stessa
esperienza: la suggestione degli impulsi passionali vien meno o si attenua di fronte
all’intervento consapevole della ragione.
PENSIERO
È un termine che designa genericamente le funzioni teoretiche superiori della mente.
Tuttavia, per la sua derivazione etimologica dal verbo latino pensare, che significa
“pesare”, esso è preferibilmente riferito, più che all’intuizione intellettiva, alla discorsività
della ragione, alla quale compete “soppesare”, cioè valutare, gli argomenti favorevoli e
contrari ad una determinata tesi. → Intelletto e ragione
Un simile rilievo va fatto anche per il corrispondente termine latino cogitatio. Esso deriva
dal verbo cogitare, cioè co-agitare, “agitare insieme”, ed esprime il metaforico movimento
che si svolge in una mente che connette i vari aspetti della realtà in maniera tale da
giungere, attraverso progressive mediazioni, a logici e consequenziali risultati. →
Ragionamento
Nella filosofia moderna d’impostazione cartesiana la cogitatio è soprattutto specificata
dall’intrinseca consapevolezza (coscienza) che la caratterizza. Renato Cartesio, infatti, così
la definisce: “Cogitationis nomine intelligo illa omnia quae in nobis sunt, quatenus eorum
in nobis conscientia est” (Con il nome di cogitatio intendo tutto ciò che è in noi, in quanto
ne abbiamo consapevolezza)17. → Coscienza
Interessante è anche la distinzione fatta da Giambattista Vico tra cogitare e intelligere: il
primo designa la capacità dell’uomo di “andar raccogliendo” dall’esterno qualche
particolare aspetto del mondo, perché l’uomo è solo “partecipe di ragione, non possessore
di essa”; il secondo, invece, spetta solo a Dio, che è in grado di vedere dentro (legere intus)
gli enti da lui creati, cioè di “leggere perfettamente e conoscere chiaramente”; egli, infatti, è
il “fattore di tutte le cose, perfettissimo, perché rappresenta, a sé, in quanto li contiene, sia
gli elementi esterni sia quelli interni delle cose”18.
Immanuel Kant, poi, teorizza la funzionalità di un pensiero “puro” e ad essa dedica la sua
massima opera teoretica, intitolandola: Critica della ragion pura. Nell’uso che egli ne fa
l’aggettivo “puro” si oppone ad “empirico”, perché intende designare la facoltà razionale
come condizione a priori, universale e necessaria, della conoscenza umana. → Criticismo
Successivamente G.W.F. Hegel, insieme a tutto il movimento idealistico, intende
superare il formalismo e il criticismo di Kant, per riproporre in forma dialettica l’antica
identità parmenidea tra pensare ed essere. → Dialettica; Idealismo
B. Spinoza, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, Parte IV, Prefazione e prop. 7 e 14, trad. di Sossio
Giametta, Boringhieri, 1971
17
Cartesio, Principia philosophiae, I, 1, 9
18
G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda, I, 1, in La scienza nuova e
altri scritti, a cura di N. Abbagnano, UTET, 1976, p. 194
16
154
POLITICA (Teorie politiche)
Il termine “politica” nella sua antica origine greca (πολιτική, politiké) era un aggettivo, che
qualificava tutto ciò che riguardava la πόλις (pólis), in particolare l’ordinata convivenza dei
cittadini. Nel sistema policentrico della tradizione ellenica la pólis era l’ambito basilare
della vita sociale, per il quale si prevedeva l’organizzazione di un governo autonomo. Nel
prosieguo storico della civiltà occidentale questo modello si ripropose in forme simili nel
nostro Medioevo comunale. Successivamente, però, la cittadinanza, ossia l’identità unitaria
di una comunità, si estese per lo più a comunità territorialmente più ampie e
demograficamente più consistenti e complesse, denominate Stati.
Nel suo uso sostantivato “politica” sottintende la parola τέχνη (téchne), cioè “arte” o
“tecnica”, perché riguarda l’arte di governare la cosa pubblica (la res publica di cui
parlavano gli antichi romani), cioè gli interessi generali della comunità.
1. La politica ateniese nell’età di Pericle e la teoria democratica di Protagora
La politica è uno dei temi importanti a cui rivolge la propria attenzione il pensiero
filosofico della Grecia classica. L’interesse è suscitato soprattutto dal diffondersi nelle
póleis del V secolo a. C. del modello democratico di organizzazione e governo della vita
associata, cioè dell’ἰσονομία (isonomía), che significa letteralmente uguaglianza di fronte
alla legge. A questo riguardo Tucidide, lo storico dell’Atene di Pericle, ci documenta che
“le leggi assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private”; tuttavia,
aggiunge, “noi non ignoriamo i meriti dell’eccellenza. Quando un cittadino si distingue,
allora sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, non come un atto di privilegio,
ma come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento”. La
democrazia ateniese s’impone in un contesto di libertà e creatività. Con consapevole
orgoglio Pericle così parla: “Noi non consideriamo le discussioni come un ostacolo sulla
strada dell’azione politica, ma come indispensabile premessa ad agire saggiamente. Noi
crediamo che la felicità sia il frutto della libertà e la libertà il frutto del valore [...] Atene è
la scuola dell’Ellade e ogni Ateniese cresce sviluppando in sé un felice versatilità, la
prontezza a fronteggiare le situazioni e la fiducia in se stesso”37. Ovviamente occorre tener
conto che questa è un’idealizzazione della condizione pubblica di Atene, che ha anche lo
scopo di legittimare le pretese egemoniche di questa pólis su tutta la Grecia. È lo stesso
Tucidide a descrivere la cinica prevaricazione dei suoi concittadini nei confronti dell’isola
di Melo, la quale, pur essendo alleata di Sparta, si è dichiarata neutrale nel conflitto tra le
due póleis: dagli abitanti dell’isola ci si attende semplicemente la sottomissione, senza
attardarsi inutilmente a discutere di che cos’è giusto, perché il diritto è tenuto in
considerazione solo in condizioni di pari forza, “mentre chi è più forte fa quello che può e
chi è più debole cede”. Con spietata arroganza ai loro interlocutori, che vorrebbero
rimanere estranei al conflitto, la delegazione ateniese ribatte: “No, perché la vostra ostilità
non ci danneggia tanto quanto la vostra amicizia, manifesto esempio per i sudditi della
nostra debolezza, mentre l’odio lo è della nostra potenza”38. L’orgoglioso rifiuto di
adeguarsi alla prepotenza ateniese determina il tragico destino di Melo: la strage dei maschi
adulti e la riduzione in schiavitù delle donne e dei fanciulli.
37
Tucidide, Le storie (La guerra del Peloponneso), II, 37, 40-41, trad. di C. Moreschini, Sansoni, 1967, pp. 97 e
110
38
Tucidide, op. cit., V, 89 e 95
155
Comunque, il buon governo della vita sociale è al centro dell’attenzione pubblica ed è
oggetto dell’interesse generale, perché lo si vede sempre più come una fondamentale
condizione di generale progresso.
Protagora di Abdera, ospite di Pericle in un’Atene che poi lo bandisce a causa del suo
agnosticismo religioso, dà un significativo contributo al dibattito che si svolge nell’agorá.
Ce lo attesta Platone. Protagora è convinto che in riferimento alla vita politica a nessuno
debba essere precluso il diritto alla competenza, che è possibile realizzare mediante
l’ammaestramento e l’educazione (paidéia), affidati a chi è già sapiente (→ Paidéia). La
sua teoria democratica è esposta nel noto mito di Prometeo ed Epimeteo del dialogo
platonico, che dal nome del sofista deriva il titolo39. Alle origini della storia umana
Epimeteo (= l’imprevidente) con sconsiderata superficialità distribuì ai viventi le facoltà e
abilità naturali per conto degli dei, non riservando nulla all’uomo, che sembrò così
destinato ad una triste prospettiva, perché era “nudo, scalzo, senza giaciglio, senz’armi”. A
soccorrere l’umanità intervenne Prometeo (= il previdente), che rubò ad Efesto e ad Atena il
fuoco e l’abilità tecnica. Questo atto gli procurò la nota punizione divina, ma per l’uomo fu
la garanzia della sopravvivenza e del benessere, perché, “unico tra gli animali, credette
negli dei, ed eccolo a erigere altari e immagini sacre. Poi con l’arte ben presto articolò la
voce in parole e inventò case, vestiti, calzari, giacigli e scoprì gli alimenti che ci dà la
terra”. Queste abilità, tuttavia, non si dimostrarono sufficienti, perché è vero che gli uomini
“cercarono allora di radunarsi e salvarsi fondando città; ma quando facevan tanto da
raccogliersi, si recavano offesa tra loro, appunto perché non possedevano l’arte politica;
sicché di nuovo si disperdevano e perivano”. Fu Zeus a prendere l’iniziativa di salvarli,
inviando Hermes “a portare agli uomini Rispetto e Giustizia, perché fossero ordinatori della
città e vincoli conciliatori di reciproco affetto”. A differenza delle abilità tecniche, che
possono essere presenti in alcuni e non in altri, Zeus volle che “Giustizia e Rispetto”
fossero assegnati a tutti: “che tutti ne partecipino; ché se solo pochi li avessero, come
avviene per le altre arti, le città non potrebbero esistere”.
La democrazia ha in Protagora un propugnatore convinto: la paidéia deve prevedere per
tutti i cittadini la formazione della principale areté, che è la virtù politica. Il bellissimo mito
illustra in maniera efficace la concezione progressiva della storia, che nei secoli a venire
caratterizzerà sempre più la cultura occidentale: essa non è più intesa come un processo di
decadimento da una presunta età felice delle origini, ma come il percorso di civilizzazione,
che l’uomo stesso ha il compito di realizzare con il lavoro competente e il governo della
società.
2. L’utopia platonica e la politica come “arte regia”
Il governo di Pericle, tuttavia, nell’assecondare ricchezza e benessere, determina con gli
eccessi della sua ambizione anche l’avvio della crisi politica di Atene, che si consuma nella
guerra del Peloponneso, quindi nella violenza della tirannide e infine nel ritorno di una
democrazia disordinata e rancorosa, di cui è vittima illustre Socrate. In riferimento a questo
drammatico contesto la Lettera VII di Platone ci documenta in maniera autobiografica
l’importanza che per lui ha la riflessione politica. Di fronte all’asprezza delle vicende il
filosofo conclude sconfortato: “Mi sembrava che fosse difficile partecipare
all’amministrazione dello stato, restando onesto. [...] Le leggi e i costumi si corrompevano
e si dissolvevano straordinariamente, sicché [...] finii per sbigottirmene [...] e fui costretto a
dire che solo la retta filosofia rende possibile di vedere la giustizia negli affari pubblici e in
39
Platone, Protagora, 320 c ss., in I Presocratici, Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Laterza,
1975, Vol. 2, cit., pp. 899-901
156
quelli privati, e a lodare solo essa. Vidi dunque che mai sarebbero cessate le sciagure delle
generazioni umane, se prima al potere politico non fossero pervenuti uomini veramente e
schiettamente filosofi, o i capi politici delle città non fossero divenuti, per qualche sorte
divina, veri filosofi”40.
Egli è convinto che, pur non avendo intrapreso la carriera nell’amministrazione della
città, Socrate sia stato il solo in Atene ad evidenziare “la vera arte politica e a metterla in
pratica”41, perché l’agire politico è propriamente un agire etico, rivolto al conseguimento
della giustizia. Per Platone nella vita dell’uomo la politica non è un ambito autonomo e
separato dalla sua personale realizzazione. L’individuo, infatti, è necessariamente integrato
nell’organicità delle relazioni comunitarie. A questo riguardo afferma: “Quando,
supponiamo, veniamo colpiti a un dito, se ne accorge tutta la comunione del corpo con
l’anima, ordinata in un unico sistema sotto l’elemento che in essa governa; e sente tutta
quanta insieme il dolore della parte offesa”; così, nell’ambito di un vero stato, “se un solo
cittadino è colpito da un caso qualsiasi, buono o cattivo, questo stato riconoscerà subito che
quel caso lo tocca direttamente e condividerà tutto il piacere o il dolore del suo cittadino”42.
È, perciò, impensabile non organizzare in maniera unitaria la vita e il destino dell’individuo
insieme alla vita e al destino dello Stato. In questo senso i dieci libri della Repubblica, che
trattano del “governo della città” (questo è propriamente il significato letterale del titolo
greco Πολιτεία, Politéia), sono la sintesi del pensiero platonico, perché la descrizione dello
Stato ideale, che essa intende fare, coinvolge in sé la considerazione dell’agire morale degli
individui ed è svolta nella prospettiva dei destini ultimi dell’uomo, prefigurati dal grande
mito finale di Er, secondo il quale i diversi comportamenti tenuti durante la vita presente
decidono delle sorti future. Il problema etico s’incentra sulla questione della giustizia, che è
presente già nel primo libro. Socrate rifiuta le tesi del sofista Trasimaco, per il quale essa
non è altro che l’utile del più forte e la vita dell’uomo ingiusto è più felice di quella del
giusto. Per definire che cos’è la giustizia, occorre considerare la complessa natura sia
dell’individuo che dello Stato, perché c’è una perfetta omogeneità strutturale e una
conseguente corrispondenza tra le funzioni esercitate dall’uno e dall’altro e tra i possibili
modi in cui entrambi si organizzano.
Platone rileva la condizione originaria che fa sorgere l’esigenza di una comunità politica:
“uno stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti bisogni”43, ai
quali tutti possono provvedere soltanto in parte, sulla base delle particolari competenze
acquisite. Ci sono, infatti, mestieri e professioni produttive di vario genere, che
costituiscono la classe di coloro che soddisfano le necessità più immediate della vita. Uno
Stato, tuttavia, richiede lo svolgimento di funzioni specifiche, che sono importanti per la
tutela e l’ordinamento complessivo della comunità: ad esse devono provvedere i custodi,
che si suddividono in guerrieri e governanti. Perché siano esercitate adeguatamente, le
diverse funzioni devono essere affidate non indiscriminatamente a chiunque, ma agli
individui meglio predisposti per natura, a seconda che prevalga nelle loro anime la parte
razionale o la parte ardimentosa o quella concupiscibile. Non nasciamo tutti eguali; non si
deve, perciò, pretendere che tutti possano svolgere qualsiasi compito, ma che ognuno si
impegni soltanto in quello che corrisponde alle sue capacità e che effettivamente può
risultare più utile per la comunità. Ognuna delle tre classi di cittadini deve agire per il
40
Platone, Lettera VII, 325 a - 326 b, cit., vol. 8, pp. 35 s.
Platone, Gorgia, 521 d, trad. di F. Adorno, in Opere complete, Laterza, 1971, vol.5, p. 247
42
Platone, La Repubblica, V, 462 c-e, cit., p. 184
43
Platone, La Repubblica, II, 369 b, p. 85
41
157
meglio secondo la propria funzione, operando così con specifica virtù44: chi governa deve
dimostrare “sapienza” e “saggio consiglio”; i guerrieri devono possedere il “coraggio”; da
tutti i cittadini, ma specialmente da quelli della terza classe, che operano nell’ambito diretto
dell’economia, ci si attende la “temperanza”, che è la capacità di disciplinare i desideri e di
atteggiarsi con moderazione a favore di un complessivo accordo delle classi inferiori con le
classi superiori. La “giustizia”, infine, non è una virtù particolare, ma universale, perché
consiste nel “far esplicare a ciascuno il proprio compito entro lo stato”45, realizzando così il
principio sul quale si fonda un’ordinata vita comune: ognuno deve essere rivolto a ciò che
per sua natura è capace di fare. Perché i governanti possano conseguire la “sapienza” e il
“saggio consiglio” per il buon governo, con un’opportuna paidéia (→ Paidéia) deve essere
loro assicurato tutto l’itinerario conoscitivo descritto nel mito della caverna46. Solo così essi
potranno essere filosofi in grado di sollevarsi, mediante la dialettica, dalle cose sensibili alle
idee e poi volgersi nuovamente a questo mondo, per governarlo secondo la sapienza
acquisita.
In rapporto allo Stato ideale Platone descrive le forme corrotte di governo. Esse sono: la
timocrazia, che ripone lo scopo dell’attività politica nel soddisfare l’ambizione e l’onore;
l’oligarchia, che orienta l’impegno politico all’acquisizione della ricchezza, intesa come
valore supremo; la democrazia, nella quale imperversa una sfrenata libertà e la “licenza di
fare ciò che si vuole”47; la tirannide, che è la forma peggiore, perché toglie con la violenza
ogni libertà: essa è l’esito a cui conduce l’anarchia democratica. A tali forme
corrispondono, sul piano individuale, quegli atteggiamenti negativi che assumono le anime,
quando ricevono una cattiva educazione e sono dominate dalla parte irascibile o dalla parte
concupiscibile.
Platone è ben consapevole dell’idealità dello Stato da lui teorizzato nella Repubblica, del
quale dice: “non credo che esista in alcun luogo della terra”; in questo mondo imperfetto
esso è una vera “utopia”, termine di origine greca, composto dalla negazione οὑ (u, non) e
dal sostantivo τόπος (tópos, luogo): un “non luogo”, un luogo inesistente; “forse nel cielo
ne esiste un modello, per chi voglia vederlo e con questa visione fondare la propria
personalità”48. Così egli ripropone il consueto generale dualismo presente nella sua
filosofia, costituito dalla limitatezza della nostra effettiva esperienza e dalla esemplarità
dell’archetipo ideale. La descrizione del modello non intende però essere un’evasiva e futile
astrattezza, ma l’indicazione della vera natura della città ideale, che orienta il nostro
impegno ad approssimarci quanto più è possibile alla sua perfezione.
Nei più tardi dialoghi dedicati alla riflessione politica, il Politico e le Leggi, Platone si
confronta con la questione dell’attuabilità del governo ideale. In essi riconferma la
convinzione che è “degno” del potere chi è capace di “governare con virtù e scienza” e sa
“attribuire a tutti imparzialmente ciò che è giusto e ciò che è sacro attribuire”49. Colui che
effettivamente fosse capace di ciò, sarebbe al di sopra delle leggi, non ne avrebbe bisogno,
perché le leggi sono di per sé impersonali e astratte, e non tengono conto del variare delle
situazioni concrete né delle condizioni particolari dei singoli uomini. Tuttavia esse sono
necessarie in assenza del meglio ideale, che solo governanti filosofi dotati di scienza
potrebbero realizzare. Alle leggi è affidato l’ordine sociale, che deve risolvere gli interessi
44
ivi, IV, 428 b - 432 e, pp.148-153
ivi, IV, 433 d, p. 154
46
ivi, VII, 514 a-518 b, pp. 237-240
47
ivi, VIII, 557 b, p. 283
48
ivi, IX, 592 a-b, p. 322
49
Platone, Politico, 301 d, trad. di A. Zadro, in Opere complete, cit., vol. 2, p. 324
45
158
particolari in vicendevole conflitto. Esse non hanno soltanto il compito di costringere i
riottosi, ma anche quello di educare mediante la convinzione.
Anche l’arte politica, come in generale tutte le arti, è tenuta ad evitare gli estremi, cioè il
difetto e l’eccesso, e ad individuare “la giusta misura”, perché ciò che essa fa sia
riconoscibile come “conveniente”, “opportuno”, “dovuto” e quindi risulti “una cosa buona e
bella”50. La politica è βασιλική τέχνη (basiliké téchne), cioè “arte regia”, che comporta la
responsabilità di organizzare e dirigere l’uso di altre arti, quali la strategia, che abilita a
condurre efficacemente una guerra, la giurisprudenza e la retorica. Infatti, l’acquisizione di
queste tecniche fa sì che si sappia semplicemente come è possibile realizzare determinate
cose, ma non se sia necessario farle né a quale scopo vadano fatte51. Perciò, dover agire
“sulla base della conoscenza della giusta misura è proprio di grande legislatore”52.
3. Aristotele: per l’uomo una vita sociale organizzata è una condizione etica
Per Aristotele la politica, insieme all’etica, è una scienza pratica, perché il suo scopo non è
la teoria ma l’azione. Innanzitutto egli osserva che l’individuo non è autosufficiente, perché
per natura l’uomo è fatto per vivere insieme agli altri. Pertanto, nel costituirsi
dell’organizzazione politica, vede una manifestazione di naturalità della condizione umana.
Così si esprime nel trattato sulla Politica: “La comunità che risulta di più villaggi è lo stato,
perfetto, che raggiunge ormai, per così dire, il limite dell’autosufficienza completa: formato
bensì per rendere possibile la vita, in realtà esiste per render possibile una vita felice.
Quindi ogni stato esiste per natura, se per natura esistono anche le prime comunità: infatti
esso è il loro fine [...] Ciò per cui una cosa esiste, il fine, è il meglio e l’autosufficienza è il
fine e il meglio. Da queste considerazioni è evidente che lo stato è un prodotto naturale e
che l’uomo per natura è un essere socievole [...] Se non è autosufficiente, ogni individuo
separato sarà nella stessa condizione delle altre parti rispetto al tutto, e quindi chi non è in
grado di entrare nella comunità, o per la sua autosufficienza non ne sente il bisogno, non è
parte dello stato, e di conseguenza è o bestia o dio”. La naturalità della convivenza umana è
d’ordine diverso da quel che è naturale per gli altri viventi, perché è vero che tutti gli
animali sono in grado di emettere suoni, cioè hanno “la voce”, con la quale danno sfogo
alle emozioni, segnalando “quel che è doloroso e gioioso”, ma “l’uomo, solo tra gli animali,
ha la parola”, che “è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di
conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è infatti proprio dell’uomo rispetto agli altri
animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e
degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo Stato” 53. Per
l’uomo la vita sociale è una condizione etica, perché “senza la virtù è l’essere più sfrontato
e selvaggio e il più volgarmente proclive ai piaceri d’amore e del mangiare. Ora la giustizia
è l’elemento [= il principio costitutivo] dello Stato; infatti il diritto è il principio ordinatore
della comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò che è giusto”54. La giustizia è la
virtù che realizza la complessiva armonia di un organismo sociale. Pertanto, in questo
senso, secondo Aristotele l’uomo è compiutamente realizzato nella sua natura in quanto è
ζῷον πολιτικόν (zóon politikón), un essere che è destinato a vivere con gli altri, libero
cittadino di una pólis, dove si confronta con i suoi simili e con essi decide non mediante la
costrizione e la violenza, ma dibattendo le questioni in forma socialmente persuasiva, ossia
50
Platone, Politico, 284 a-b, e, cit., pp. 301-302
ivi, 304 a, cit., p. 327
52
Platone, Leggi, III, 691 d, trad. di A. Zadro, in Opere complete, cit., vol. 7, p. 113
53
Aristotele, Politica, I (A) 2, 1252 b 28 - 1253 a 29, trad. di R. Laurenti, in Opere, a cura di G. Giannantoni,
Laterza, 1973, vol. 9, pp. 6-7
54
Aristotele, Politica, I (A) 2, 1253 a 36-39, cit., p. 7
51
159
con la parola. In questo senso, come ben intesero i greci antichi e quindi anche Aristotele,
egli è ζῷον λόγον ἔχον (zóon lógon échon), cioè un vivente dotato di parola, quindi capace
di discorso e non semplicemente un animal rationale, come astrattamente l’originaria
espressione greca fu tradotta in lingua latina.
Pur essendo la comunità politica una realtà naturale, la scienza che la riguarda, come
avviene in generale per l’etica, non procede in maniera rigidamente dimostrativa, perché è
rivolta al libero agire dell’uomo e nei suoi confronti “sembra che l’esperienza aiuti non
poco; altrimenti infatti non si diventerebbe neppure uomini politici attraverso la pratica
delle cose politiche”55. Un buon aiuto può venire dal confronto con l’esperienza effettiva
dei vari popoli, sulla base delle loro costituzioni, per accertare che cos’è che conserva o
distrugge gli Stati. È ovviamente importante sapere qual è la costituzione migliore, che,
tuttavia, non è tale in assoluto secondo una configurazione puramente ideale, come aveva
ritenuto Platone. Pertanto il legislatore “non deve studiare soltanto la costituzione migliore,
ma anche quella possibile, e parimenti quella che è più facile e più comune a tutti gli
stati”56.
Sulle tracce di Platone anche Aristotele ricorre ad una tipologia di tre forme politiche, che
sono determinate dal diverso numero di soggetti (uno, pochi, molti) che possono governare
lo Stato con lo scopo di conseguire l’interesse comune (modelli positivi) o l’interesse
proprio (modelli negativi). Esse sono: la monarchia o la tirannide, l’aristocrazia (governo
dei migliori) o l’oligarchia (governo dell’élite più ricca), la “politìa” o la democrazia.
Diversamente da oggi il termine “democrazia” ha per Aristotele, com’era già per Platone,
una connotazione negativa, perché denomina il governo della moltitudine economicamente
più povera in opposizione ostile verso gli altri. La “politìa” (dal greco πολιτεία, politéia,
che letteralmente significa governo della città), corrisponde invece al governo di molti per
il bene comune; i molti in questo caso sono i cittadini delle classi medie: “essi non bramano
le altrui cose, come i poveri, né gli altri le loro, come fanno appunto i poveri dei beni dei
ricchi”57. Aristotele applica ai gruppi sociali il fondamentale criterio distintivo del
comportamento eticamente positivo dell’individuo: la medierà (→ Mesótes). Pertanto la
classe individuata in posizione mediana tra le posizioni estreme della massa più misera e
dell’élite più ricca è da lui considerata la più adeguata al governo dello Stato, perché dà
maggiori garanzie di equilibrio, di ordine e di equità per il maggior numero di persone.
Nell’individuare la “politìa” come forma migliore Aristotele non dà prova di alcuna rigidità
argomentativa. Egli, infatti, è convinto che la politica non è una scienza apodittica, perché il
suo oggetto (il buon governo) è conseguibile in diversi modi; perciò, non si può escludere
che anche la monarchia e l’aristocrazia siano buone, purché si propongano come fine il
bene comune e assicurino che il governo sia realmente esercitato dai migliori; tuttavia,
poiché gli uomini eccellenti sono piuttosto rari, ad Aristotele appare ragionevole
considerare la “politìa” come forma di governo generalmente più conveniente.
Il criterio della “medietà”, poi, accompagna lo Stagirita nella determinazione di altre
importanti condizioni di un buon governo, quali l’ampiezza del territorio, la consistenza
demografica e la disponibilità delle risorse economiche, che devono essere tali da assicurare
l’autosufficienza complessiva, perché i beni materiali, per la loro funzione strumentale,
sono utili nella giusta misura, mentre invece un loro eccesso è dannoso. Alle comunità
devono importare gli stessi principi che presiedono al comportamento degli individui,
perché la moralità è una condizione di buon successo anche per lo Stato. Ciò vale anche
55
Aristotele, Etica nicomachea, X (K), 9, 1181a 10-12, trad. di A. Plebe, in Opere, cit., vol. 7, p. 273
Aristotele, Politica, IV (), 1, 1288 b 38-39, cit., p. 116
57
ivi, IV () 11, 1295 b 30-32, p.136
56
160
nell’attività economica, denominata con termine greco χρηματιστική (chrematistiché),
aggettivo sostantivato che sottintende τέχνη (téchne). La “crematistica”, infatti, è la tecnica
di realizzare la ricchezza, che può essere attuata in modi diversi: o provvedendo ciò che è
necessario e utile mediante il lavoro e lo scambio di beni con beni equivalenti o nelle forme
innaturali e dannose dell’accumulazione della ricchezza e del denaro senza alcuna
moderazione. Quando è questa la forma economica che s’impone, la ricchezza illimitata si
tramuta in fine della vita stessa e ciò è causa di degenerazione della vita politica. →
Bisogno
Aristotele propone una concezione dello Stato moderatamente organicistica, nel senso che
la comunità politica generale deve integrare in sé, oltre agli individui, le comunità minori,
cioè il villaggio e la famiglia, ma nel rispetto di ciò che naturalmente compete a tutte queste
realtà. Egli, perciò, rifiuta il comunitarismo platonico, perché la sua struttura
eccessivamente unitaria e rigida comporta il misconoscimento delle naturali autonomie, che
competono agli individui e alle famiglie. A suo giudizio, l’esito di un’eventuale attuazione
dell’ideale platonico non potrebbe essere che negativo. Infatti “di quel che appartiene a
molti non si preoccupa proprio nessuno”58. → Sussidiarietà
I pensieri di Aristotele non sono sempre congruenti con i principi più nobili della sua
filosofia, ma sono talora frutto di insuperati pregiudizi, che a noi appaiono immediatamente
disdicevoli. Un radicato etnocentrismo lo fa convinto assertore della naturale superiorità dei
Greci rispetto ai “barbari”; gli sembrano ovvie e naturali l’inferiorità della donna rispetto al
maschio e la schiavitù; la condizione del lavoro manuale di chi pratica l’agricoltura o
costruisce strumenti o è dedito al commercio gli appare indegna dei veri cittadini, che si
occupano del governo, del culto, della guerra e godono di tempo e libertà per provvedere
alla propria cultura e ad una vita virtuosa e perfetta.
4. Il cosmopolitismo ellenistico e romano
L’imporsi di strutture monarchiche geograficamente rilevanti, che, a cominciare
dall’imperialismo macedone di Filippo II e del figlio Alessandro, inglobano e rendono
sempre più insignificanti le istanze locali, porta a termine la crisi della pólis. Le filosofie
dell’ellenismo ne risentono immediatamente: la politica non è più al centro della loro
attenzione, al punto che Epicuro ritiene disdicevole per il saggio l’impegno pubblico,
perché lo considera fonte di turbamento. Perciò è convinto che “ci si deve liberare dal
carcere degli affanni e della politica” e pensa che “di tutti i beni che la saggezza procura per
rendere l’intera vita felice, il massimo è l’acquisto dell’amicizia”59, per il cui valore
dimostra una squisita sensibilità. Nel suo “giardino” sono ammessi anche donne e schiavi e
si coltiva la convivialità e l’amicizia.
La dimensione privata e le relazioni tra gli individui sono ormai il naturale oggetto
d’interesse dell’etica. Questa, tuttavia, è intesa in una prospettiva di universalità, che induce
a considerare i legami etnici sempre meno importanti e a dare, invece, rilievo alla
comunanza di natura di tutti gli uomini. La convinzione stoica che il mondo è una realtà,
che stringe insieme in un’unica sorte tutte le cose ed è governata da una sola legge eterna e
universale, favorisce, soprattutto nei pensatori romani, riflessioni importanti sull’unità del
genere umano, sulla sua comune origine e sul suo destino. Si giunge a riconoscere che le
divisioni tra gli uomini e le discriminazioni sociali sono in contrasto con quella legge, per la
quale tutti sono cittadini del mondo con uguali diritti (cosmopolitismo).
58
ivi, II (B), 3, 1261 b 33-34, p. 34
Epicuro, Sentenze, 29, 116 in L’“etica” di Epicuro e il problema del piacere nella filosofia antica, a cura di S.
Maso, Paravia, 1994, pp. 74 e 90
59
161
Cicerone riflette sulla legge naturale, che deve stare alla base delle legislazioni dei vari
popoli, perché “essa non inizia ad essere una legge da quando è stata scritta, ma da quando
è nata. Ed essa è nata insieme con la mente divina” (non incipit lex esse quom scripta est,
sed tum quom orta est. Orta autem est simul cum mente divina)60. Nel De republica emula
in qualche modo Platone, proponendo tuttavia non un modello utopico, ma la realtà storica
di Roma, la cui costituzione mista gli sembra il meglio concretamente possibile, perché
incarna armonicamente nel senato, nei comizi popolari e nei consoli i tre tipi classici di
gestione del potere: l’aristocrazia, la democrazia e la monarchia. La viva percezione della
crisi repubblicana lo induce a richiamarsi ai valori etici del mos maiorum, per poterla
arrestare e invertirne il corso. A questo scopo ritrae l’ideale uomo di governo, indicandolo
come princeps civitatis e moderator rei publicae, cioè il leader tra i cittadini e il reggitore
della cosa pubblica, perché è dotato del prestigio che gli deriva dai valori che impersona.
Seneca, poi, pensa che la nobiltà autentica e la libertà vera siano il frutto dell’impegno
etico a ben operare. Così, per esempio, si esprime: “L’universo che ti sta davanti e che
contiene in sé quanto esiste di divino e di umano, è un’unica realtà: siamo membra di un
grande corpo. La natura ci ha fatto fratelli, generandoci dagli stessi elementi e per uno
stesso destino. Essa ha immesso in noi un reciproco affetto e ci ha fatti perché potessimo
vivere insieme. Ha istituito ciò che è equo e giusto; per come ci ha fatti, è cosa più misera
far del male che essere offesi: su suo ordine le nostre mani siano sempre pronte a far del
bene. Ci stia sempre nel cuore e sulla bocca quel verso ‘homo sum, humani nihil a me
alienum puto’ (sono uomo e niente di quanto è umano ritengo che mi sia estraneo).
Teniamo ben presente questo pensiero: siamo nati per vivere insieme”61.
5. La politica nel Medioevo: Tommaso d’Aquino e Marsilio da Padova
La dissoluzione dell’impero romano e l’imporsi, con il feudalesimo, dei rapporti di fedeltà
personale determinano nell’Europa occidentale la fine del diritto pubblico antico.
In seguito al faticoso assestamento di nuove istituzioni, nell’Europa medioevale si
contrappongono sul piano ideologico generale le pretese cesaropapiste del Sacro Romano
Impero e quelle teocratiche del Papato.
Ancora agli inizi del XIV secolo Dante Alighieri, che non sembra avvedersi
dell’importanza storicamente decisiva delle emergenti realtà nazionali, con il De
Monarchia continua a sostenere l’universalità dell’impero, coincidente con realtà storica
della cristianità, e argomenta a favore dell’equilibrio e dell’armonia tra i poteri politico e
religioso, entrambi divinamente garantiti, sulla base della divisione dei loro compiti.
Alla riscoperta medioevale del pensiero aristotelico si accompagnano due modi diversi di
ripensare la politica. C’è innanzitutto quello rappresentato da Tommaso d’Aquino (secolo
XIII), che integra gli spunti recepiti dall’antichità nella realtà istituzionale contemporanea,
della quale non intende affatto compromettere l’assetto. Egli vede nella monarchia il
migliore governo possibile, perché garantisce meglio l’ordine e l’unità sociale. La tirannide,
che ne è la forma pervertita, è invece il governo più dannoso, contro il quale è lecito
ribellarsi, purché non ne derivino conseguenze peggiori e si escluda il tirannicidio di
iniziativa privata. A questo proposito scrive l’opuscolo De regimine principum.
Tommaso, inoltre, ritiene che una garanzia fondamentale di una corretta legislazione sia
data dal rispetto della legge naturale, perché “la legittimità di ogni legge, che l’uomo può
produrre, deriva dalla legge di natura; nel caso che discordasse in qualcosa da essa, non
sarebbe più una legge, ma una sua degenerazione” (omnis lex humanitus posita intantum
60
61
Cicerone, De legibus, II, 4
Seneca, Lettere a Lucilio, XCV, 52-53. Il verso citato è di Terenzio (Heautontimorúmenos, I, 1, 25).
162
habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali
discordet, iam non erit lex sed legis corruptio)62.
Qualche decennio dopo si rifà ad Aristotele anche Marsilio da Padova, ma con una
sensibilità nuova, che prefigura teorie politiche moderne. La sua esperienza è legata al suo
insegnamento presso l’università parigina come magister artium e poi rettore, e alle vicende
politico-religiose che oppongono l’imperatore Ludovico il Bavaro e il papa. Insieme agli
Spirituali e a Guglielmo di Ockham sostiene le rivendicazioni del Bavaro. Nel Defensor
pacis (1324) argomenta a favore di una teoria democratica, attribuendo la potestà
legislativa, ossia la manifestazione fondamentale della sovranità, al popolo, che egli intende
ora come l’insieme dei cittadini (universitas civium), ora preferibilmente come la parte più
importante (valentior pars) di essi. Il popolo delega ad altri, ma con la facoltà di una
possibile revoca, l’effettivo esercizio del potere esecutivo, che va esercitato nel rispetto e
nell’ambito delle leggi.
Qui appaiono già profilate le nozioni di sovranità popolare e di Stato di diritto, che
caratterizzeranno le teorie moderne di Locke e Rousseau. La comunità politica, a cui pensa
Marsilio, è rappresentata non solo dal Comune e dalla Signoria, ma anche dallo Stato
nazionale. Inoltre egli teorizza la laicità dello Stato; si preoccupa infatti di determinare una
netta distinzione tra la vita religiosa e la vita civile, riconoscendo all’istituzione politica
l’uso esclusivo del potere coattivo, il cui esercizio il clero non può affatto pretendere,
perché la Chiesa come Cristo deve predicare in povertà il Vangelo. Soltanto il rispetto delle
loro diverse competenze può assicurare una loro pacifica convivenza.
6. Il realismo machiavellico, la “ragion di Stato” e il tentativo cattolico di sostenere una
politica ecclesiastica fondata sul principio della “potestas indirecta”.
Nella crisi politica italiana del Rinascimento Niccolò Machiavelli è l’intellettuale più
lucidamente consapevole della precarietà storica in cui si vengono a trovare i piccoli stati
della penisola, perennemente in lotta tra loro e costretti a confrontarsi con l’ambizione
imperialistica delle nuove monarchie nazionali europee. In questa situazione, come
segretario della Repubblica fiorentina egli ha modo di percepire il senso delle vicende che
si stanno svolgendo. Come rimedio all’emergenza, nel Principe (1520) propone di por fine
al vacuo idealismo tradizionale di coloro che, nel descrivere i compiti della politica,
procedono deduttivamente da principi astratti e di guardare invece con spregiudicatezza alla
“verità effettuale”, la quale esige che qualcuno (ovviamente un “principe” in un’Italia di
principati), si assuma con tempestività e realismo il compito d’impedire che la penisola
diventi un dominio straniero. Il realismo politico che Machiavelli propone e che sarà
tradizionalmente sintetizzato nella formula “il fine giustifica i mezzi”, da lui prende il nome
di “machiavellismo”. Egli così lo descrive: “Nelle azioni di tutti gli uomini, e massime de’
principi, dove non è iudizio a chi reclamare [= quando non c’è un tribunale a cui ricorrere],
si guarda al fine. Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e mezzi
saranno sempre iudicati onorevoli e da ciascuno laudati”63. Il machiavellismo mette a dura
prova la tradizionale considerazione etica della politica, perché la “virtù” del principe, alla
quale il segretario fiorentino vorrebbe affidare l’impresa, si esprime nell’astuzia e nella
forza, per mezzo delle quali egli può tentare di misurarsi con l’imprevedibile “fortuna” (la
sorte) e cercare di uscirne vincente. → Fato, Destino, Fortuna
Nell’età moderna il machiavellismo, pur essendo pubblicamente criticato in nome dei
princìpi etici tradizionali, è effettivamente applicato nell’ordinaria azione di governo di
62
63
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 95, art. 2 c
N. Machiavelli, Il principe, XVIII
163
chiunque assume come criterio fondamentale di valutazione politica l’interesse dello Stato,
a cui pertanto subordina anche le esigenze dell’ordinaria moralità. Questo “realismo”
condiziona gli stessi studi della storia antica. Infatti, diversamente dal passato, si preferisce
la lettura di Tacito a quella di Tito Livio. Questa tendenza è solitamente designata come
“tacitismo”: rispetto al puro, ma astratto idealismo repubblicano di Livio, si ritiene più
istruttivo confrontarsi con i riprovevoli “arcana imperii” (i segreti del potere) dell’impero
romano descritto da Tacito, per premunirsi contro i tristi effetti del potere assoluto del
tempo presente.
La nuova e fortunata espressione con cui è denominato l’interesse primario della politica
è “ragion di Stato”, coniata da Giovanni Botero, che ad essa dedica il suo scritto più noto:
Della ragion di Stato (1589). Con Botero, educato secondo i criteri pedagogici della
Compagnia di Gesù, siamo in piena Controriforma. Dopo aver definito lo Stato “un
dominio fermo sopra popoli” e la “ragione di Stato” “notizia [cioè conoscenza] di mezzi atti
a fondare, conservare ed ampliare un dominio così fatto”, egli afferma che “sarebbe
necessario che il prencipe non mettesse cosa nissuna in deliberazione nel conseglio di Stato,
che non fosse prima ventilata in un conseglio di conscienza, nel quale intervenissero dottori
eccellenti in teologia ed in ragione canonica [cioè in diritto canonico], perché altramente
caricherà la conscienza sua e farà delle cose, che bisognerà poi disfare, se non vorrà
dannare l’anima sua e dei successori”64. Suggerendo di avvalersi della religione come di un
perfetto instrumentum regni (strumento di potere), per mantenere obbedienti i popoli,
Botero auspica un modello di Stato confessionale, che è l’opposto dello Stato laico,
configurato dalle odierne costituzioni democratiche.
Nell’Europa del tardo Cinquecento e del Seicento la Riforma protestante ha ormai posto
termine all’universalismo unitario della cristianità occidentale, confermando
definitivamente quel che era già in parte avvenuto con la fine del Medioevo, ossia la
formazione di poteri territoriali sovrani. Pertanto la teologia cattolica si vede obbligata a
modificare la teoria medioevale della potestas directa, esercitata dal papato sulla cristianità,
che in varie occasioni era stata sciolta dall’obbedienza ai suoi governanti, renitenti al volere
del potere religioso. Nell’età della Controriforma Roberto Bellarmino, che come membro di
diverse congregazioni cardinalizie e in particolare come consultore del Sant’Uffizio è
incaricato di proporre soluzioni a vari problemi dottrinali e di politica ecclesiastica, nel
Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus (1610) formula la nuova
dottrina della potestas indirecta del papato, intendendola come un potere che è esercitato
sulle popolazioni attraverso i loro governanti, sollecitati ad essere il “braccio secolare” della
Chiesa nel mondo. Tuttavia la giustificazione di questa teoria rimane sempre quella
tradizionale, che aveva già sostenuto le antiche pretese della potestas directa: il potere
spirituale, in ragione dei suoi fini ultraterreni, è superiore al potere temporale, che ha scopi
mondani. L’arroccamento secolare su tali posizioni fino a tempi relativamente recenti
isolerà sempre più la gerarchia della Chiesa cattolica dagli sviluppi del mondo moderno.
Ancora agli inizi del XX secolo conformarsi agli sviluppi storici delle autonomie secolari
della politica sarà tacciato di “modernismo”.
7. Jean Bodin: la teorizzazione moderna della sovranità
Alla costruzione storica dello Stato moderno si accompagna una complessa elaborazione
teorica, che prevede innanzitutto di dover determinare la nozione di sovranità e le
condizioni del suo esercizio. Nel tormentato periodo delle guerre di religione in Francia tra
cattolici e ugonotti Jean Bodin si riconosce nelle posizioni dei cosiddetti politiques, che
64
G. Botero, Della ragion di Stato e scritti politici minori, a cura di L. Firpo, Utet, 1948, I, I, p. 55 e II, XV, p. 133
164
cercano di superare le controversie e i conflitti, richiamandosi alle norme non religiose, ma
politiche della convivenza. Poiché le divisioni religiose sono alimentate dalle contese
interne alla nobiltà, che tradizionalmente pretende di condizionare il potere della
monarchia, con I sei libri della Repubblica (1576) egli vuol indicare nell’esercizio della
sovranità la condizione fondamentale di un ordinato Stato di diritto, nel quale possa valere
una legge universalmente riconosciuta. Si osservi, per inciso, che il termine “repubblica”,
presente nel titolo citato, va inteso non nel senso specifico di forma di governo contrapposta
a quella monarchica, ma nel senso generico del latino “res publica”, che designa “la cosa
comune”, cioè lo Stato.
Bodin giustifica l’assolutismo, perché intende sottrarre il potere politico alla tradizione
feudale e ai condizionamenti delle parti, che ne vanificano il compito primo di garanzia
dell’ordine. Perciò afferma: “Per sovranità s’intende quel potere assoluto e perpetuo ch’è
proprio dello Stato”65. Il vero sovrano deve essere colui che non riconosce un superiore
(“superiorem non recognoscens”) e pertanto è svincolato dalle leggi (“legibus solutus”),
perché esse promanano dalla sua volontà. E precisa che, se così non fosse, ma lo si
sottoponesse a obblighi e condizioni, la sovranità non sarebbe più tale, cioè assoluta, “a
meno che tali condizioni non siano le leggi di Dio e della natura”66. Infatti Bodin non
intende legittimare il dispotismo arbitrario, perché anche il principe è tenuto a conformarsi
alle leggi superiori volute da Dio e insite nella natura. La convinzione che esista questo
limite morale e giuridico d’ordine superiore spiega la critica che egli fa del machiavellismo.
La sua teoria precorre per questo aspetto il giusnaturalismo. → Giusnaturalismo
8. La concezione contrattualistica dello Stato: Thomas Hobbes e la teorizzazione
dell’assolutismo
La moderna concezione della politica ha alla sua base la convinzione che lo Stato si
costituisce mediante un patto tra tutti i membri di una società, che vogliono realizzare una
forma di convivenza sicura e stabile. A tale scopo decidono di cedere la loro originaria e
naturale libertà e autonomia ad un’istituzione, che così può esercitare legittimamente un
potere pubblico a beneficio della comunità. → Contrattualismo
Due sono le fondamentali interpretazioni del patto fondativo dello Stato: quella
assolutistica, rappresentata da Thomas Hobbes, e quella giusnaturalistica di tendenza
liberale.
Hobbes rifiuta la distinzione giusnaturalistica tra il pactum unionis, che porta al
superamento dello stato naturale e costituisce la società politica, e il pactum subjectionis,
che è il bilaterale impegno dei governati e dei governanti al rispetto del patto. Per lui il
patto è unico, nel senso che gli individui riconoscono la necessità di rinunciare in maniera
irrevocabile al “diritto di natura”, cioè alla propria volontà egoistica, per accettare
un’autorità assoluta, che assicuri la pace generale. Alla base dell’assolutismo hobbesiano
c’è una concezione pessimistica della natura umana. L’uomo, infatti, non è spontaneamente
socievole, ma, al contrario, nei rapporti con i suoi simili non è diverso da un lupo, secondo
la formula plautina: “homo homini lupus”67. In natura non esiste alcun criterio oggettivo e
da tutti riconoscibile di ciò che è giusto e ingiusto, onesto e disonesto, perché “dove non c’è
potere comune, non c’è legge; dove non c’è legge, non c’è ingiustizia. La forza e la frode
sono in guerra le due virtù cardinali”68. In questa situazione, se apparentemente nessuno è
più sicuro, perché gli esiti dei rapporti vicendevoli sono affidati all’arbitrio e al caso, il
65
J. Bodin, I sei libri dello Stato, a cura di M. Isnardi Parente, UTET, 1964, p. 345
J. Bodin, I sei libri dello Stato, cit., p. 354
67
Plauto, Asinaria, II, 4,88
68
Th. Hobbes, Leviatano, I, XIII, a cura di G. Micheli, La Nuova Italia, 1976, p. 122
66
165
timore, che riguarda il bene primario della vita, diventa la motivazione decisiva, che
sollecita la nostra ragione ad elaborare un rimedio all’insicurezza generale. La ragione,
infatti, è la capacità di calcolare e prevedere, che ci mette in grado di prefigurarci le
conseguenze rischiose di un comportamento individuale non regolamentato, ma
abbandonato al “diritto di natura”, cioè all’egoismo originario. A tale scopo ci suggerisce
delle opportune “leggi di natura”, cioè le norme razionali che contrastano questi pericoli.
Hobbes ne elenca diciannove. Tra di esse la prima e fondamentale è “cercare la pace e
conseguirla”; la seconda prevede di attenersi al criterio della reciprocità nel rinunciare
all’uso indiscriminato del diritto di natura; la terza stabilisce che “bisogna stare ai patti”
(pactis standum o pacta sunt servanda), se si vuol garantire la pace69. Diversamente dai
giusnaturalisti, Hobbes è l’unico che opera questa distinzione tra “diritto di natura” e “leggi
di natura”.
Le leggi naturali ci sono suggerite utilmente dalla ragione, ma di per sé esse obbligano
solo nell’ambito della coscienza (in foro interno). Questo limite è risolvibile mediante
l’introduzione di un potere esterno in grado di costringere tutti, perché “le leggi di natura
(come la giustizia, l’equità, la modestia, la misericordia, e insomma il fare agli altri quel
che vorremmo fosse fatto a noi) in se stesse, senza il terrore di qualche potere che le faccia
osservare, sono contrarie alle nostre passioni naturali che ci spingono alla parzialità,
all’orgoglio, alla vendetta e simili. I patti senza la spada sono solo parole e non hanno la
forza di assicurare affatto un uomo”70. → Positivismo giuridico
La timorosa preoccupazione per la sicurezza sociale fa sì che Hobbes, indipendentemente
dal modello politico dell’assolutismo a cui lega l’elaborazione del suo pensiero, rilevi con
grande nitidezza quella funzione fondamentale e primaria dello Stato, che nel Novecento
Max Weber con una felice espressione identificherà con il “monopolio dell’uso della forza
legittima”71 nell’ambito di un determinato territorio contro gli oppositori interni e, in
guerra, contro i nemici esterni.
9. La concezione contrattualistica dello Stato: John Locke e la teorizzazione del
liberalismo
L’interpretazione liberale del patto fondativo dello Stato è compiutamente definita da John
Locke, che la deriva dai principi del giusnaturalismo (→ Giusnaturalismo). Storicamente il
liberalismo si afferma come una teoria antiassolutistica, che nei riguardi del potere politico
intende stabilirne i limiti a beneficio di diritti individuali qualificabili come naturali e in
quanto tali inderogabili: la tutela dell’incolumità, la libertà e la proprietà dei beni che
ognuno ha ottenuto con il proprio lavoro. Pertanto, il patto che costituisce lo Stato non
implica affatto la rinuncia ai diritti naturali, ma interpreta il potere politico come uno
strumento che garantisce la loro tutela. A questo scopo occorre regolamentarlo,
preordinandone innanzitutto la divisione. Ciò evita il rischio che diventi assoluto, cioè si
concentri senza alcun controllo in una sola istituzione. Avvalendosi dell’esperienza storica
dell’Inghilterra di quegli anni, Locke riconosce ai cittadini anche un diritto di ultima istanza
alla rivoluzione, che egli considera come la garanzia estrema contro la prevaricazione
consolidata e l’abuso grave, non diversamente rimediabili, di chi ha il potere.
Si può osservare che il liberalismo si ispira in origine ai principi universalistici del
giusnaturalismo e riconosce, pertanto, che la sovranità risiede nel popolo. Tuttavia
storicamente questo spirito viene vanificato nella concreta applicazione della dottrina,
69
Th. Hobbes, Leviatano, I, XIV e XV, cit., pp. 123-138
Th. Hobbes, Leviatano, cit., II, XVII, p. 163
71
M. Weber, Economia e società, Edizioni di Comunità, 1980, IV, p. 9
70
166
perché il godimento dei diritti politici è subordinato ai criteri del sesso, del censo e
dell’istruzione. → Liberalismo
10. La concezione contrattualistica dello Stato: Jean-Jacques Rousseau e la teorizzazione
della democrazia diretta
L’interpretazione democratica del patto fondativo dello Stato ci è data da Jean-Jacques
Rousseau nel Contratto sociale (1762). Il filosofo francese ha di fronte a sé due evidenze:
una riguarda l’universale e inalienabile libertà originaria, storicamente compromessa da un
distorto processo di civilizzazione, che ha prodotto corruzione e sopraffazione; l’altra si
riferisce alla necessità di garantire un legittimo ordine sociale, dal momento che
l’autosufficienza individuale è ormai impossibile. Egli non condivide la convinzione
giusnaturalistica che sia possibile rinunciare all’indipendenza che individualmente ognuno
ha connaturata in sé, perché “nessun uomo ha per natura autorità sul suo simile e la forza
non crea alcun diritto”. Un’ipotetica “alienazione” di sé e della propria originaria libertà è
“una cosa assurda e inconcepibile: un tale atto è illegittimo e nullo [...] Rinunciare alla
propria libertà vuol dire rinunciare alla propria qualifica di uomo, ai diritti dell’umanità e
anche ai propri doveri”72.
Originariamente, secondo Rousseau, l’uomo non è un essere sociale, perché la società è
un prodotto della storia; della società gli uomini hanno sentito il bisogno nel momento in
cui le difficoltà a rimanere nello stato naturale hanno prevalso ed essi hanno percepito che
“il genere umano perirebbe se non cambiasse il suo modo di esistere”, organizzandosi
insieme73. La società poi è andata degenerando rispetto alle possibili attese; perciò occorre
riformarla, ponendo rimedio a ciò che insidia i rapporti umani non attraverso un impossibile
ritorno allo stato naturale, ma mediante una reimpostazione della convivenza sociale,
attuata in maniera tale da salvaguardare la libertà originaria e la sostanziale uguaglianza tra
gli uomini.
All’individualismo della teoria liberale, per la quale il patto ha lo scopo di delimitare il
potere pubblico, destinandolo ad essere strumento dei diritti inalienabili dei singoli,
Rousseau oppone un’integrale socializzazione degli individui, perché “in luogo della
persona singola di ciascun contraente, questo atto di associazione produce un corpo morale
collettivo, composto di tanti membri quanti sono gli aventi diritto al voto dell’assemblea”.
Ci troviamo così di fronte ad una concezione organicistica della società. Il “corpo morale
collettivo” nel contratto sociale “riceve la sua unità, il suo ‘io’ comune, la sua vita e la sua
volontà”74. Esso integra in sé gli individui come sue parti, funzionalmente interconnesse a
beneficio del tutto, a cui servono come strumenti. La comunità è la depositaria del potere ed
essa si esprime attraverso la volontà generale. Coerentemente con questa concezione
Rousseau si premura di distinguere tra “la volontà di tutti e la volontà generale: questa
riguarda solo l’interesse comune, l’altra l’interesse privato e non è che una somma di
particolari volontà”75. L’esercizio della volontà generale è la “sovranità”, che “non può mai
essere alienata”, per la stessa ragione per cui non è alienabile la libertà dell’uomo. La
sovranità si esprime nell’attività legislativa e non va confusa con il governo, al quale
compete l’esecuzione delle leggi. La sovranità non è delegabile. Perciò la democrazia
teorizzata dal filosofo ginevrino non è la democrazia indiretta o rappresentativa, ma quella
diretta, perché “la sovranità non può essere rappresentata, per la stessa ragione per cui non
72
J.J. Rousseau, Il contratto sociale, I, 4, trad. di G. Barni, Rizzoli, 1974, pp. 42 e 43
ivi, I, 6, p. 47
74
ivi, I, 6, p. 49
75
ivi, II, 3, p. 59
73
167
può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale e la volontà non è
soggetta a rappresentanza”76. → Alienazione
Nei riguardi della democrazia rousseauiana non si possono evitare sostanziali perplessità,
tenendo anche conto di quale uso del potere faranno coloro che riterranno di rifarsi ad essa,
in particolare i giacobini durante la rivoluzione francese. La teoria di Rousseau, infatti,
presenta ambiguità e contraddizioni, che emergono dalle sue stesse parole là dove prefigura
una democrazia che tende inevitabilmente a diventare un potere totalitario: “Se lo stato o la
città non sono che una persona morale, la cui vita sta nell’unione dei suoi membri e se la
sua preoccupazione più importante è quella della propria conservazione, gli è necessaria
una forza universale e propulsiva per spingere e disporre ogni parte nel modo più
conveniente per il tutto. Nello stesso modo con cui la natura dà a ogni uomo un potere sulle
sue membra, il patto sociale dà al corpo politico un potere assoluto sui suoi soggetti ed è
appunto questo potere che, guidato dalla volontà generale, porta il nome di sovranità”77.
Secondo Rousseau è l’impegno ad integrarsi nel corpo comune e nella volontà generale che
permette di trasformare l’originaria indipendenza naturale in vera libertà, cioè in “libertà
civile”, che è poi “la libertà morale, la sola che renda l’uomo padrone di se stesso, in quanto
il sottostare all’impulso dei soli appetiti è schiavitù, mentre l’obbedienza a una legge, che
l’uomo si è prescritta, è libertà”78.
A proposito dell’uguaglianza Rousseau osserva che ordinariamente la si ritiene “una
chimera della teoria che non può esistere in pratica”; ma, egli obietta, “è precisamente
perché la forza delle cose tende sempre a distruggere l’uguaglianza, che la forza della
legislazione deve sempre tendere a mantenerla”79. L’intervento moderatore della legge per
assicurare una condizione di sostanziale equità è efficace, per esempio, nei confronti della
proprietà dei beni. Nella sua configurazione giuridica, questa non è un diritto naturale,
come pensava invece Locke, ma una realizzazione storica. Il filosofo ginevrino innanzitutto
afferma che “lo stato è, rispetto ai suoi membri, padrone di tutti i loro beni in base al
contratto sociale, il quale, nello stato, serve da base a tutti i diritti”80; sostiene poi che,
proprio per assicurare quell’“uguaglianza morale e legale al posto di ciò che la natura aveva
potuto stabilire come ineguaglianza fisica tra gli uomini”81, lo stato sociale fa sì che “nessun
cittadino sia tanto ricco da poterne comprare un altro e nessuno tanto povero da esser
costretto a vendersi”82.
Anche Rousseau è costretto a riconoscere che un’effettiva realizzazione della democrazia
diretta è possibile solo in uno stato di piccole dimensioni, com’è il caso di Ginevra o dei
cantoni svizzeri, da lui alquanto idealizzati, come appare da questo passo: “Quando si
vedono presso il popolo più felice del mondo dei gruppi di contadini regolare gli affari di
stato sotto una quercia e condursi sempre saggiamente, ci si può impedire di disprezzare le
raffinatezze delle altre nazioni, che si rendono illustri e degne di disprezzo con tanta arte e
mistero?”83 → Democrazia
11. Montesquieu: il modello politico repubblicano e la divisione dei poteri
76
ivi, III, 15, pp. 117-118
ivi, II, 4, pp. 60-61
78
ivi, I, 8, p. 52
79
ivi, II, 11, p. 80
80
ivi, I, 9, p. 53
81
ivi, I, 9, p. 55
82
ivi, II, 11, p. 80
83
ivi, IV, 1, p. 125
77
168
Una particolare linea di sviluppo della riflessione politica, che dal Medioevo attraversa l’età
moderna, conserva la memoria storica dell’antica repubblica romana, inducendo a
configurare l’esercizio del potere politico non soltanto secondo la divisione tripartita di
Aristotele, ma anche secondo la tipologia che oppone la monarchia e la repubblica. Questa
non è di per sé identificata con la democrazia; infatti nel passato storico europeo si danno
per lo più esempi di repubbliche oligarchiche (pensiamo a Venezia e a Genova); tuttavia,
continuando a indicare, sulle tracce di Cicerone e di Livio, nell’antica esperienza romana il
perfetto modello di governo misto, come fa Machiavelli e si continua a fare fino alla
rivoluzione francese, la repubblica diventa la forma di governo che distribuisce i poteri ad
una pluralità di organi collegiali, evitando così il rischio della loro concentrazione e
dell’abuso tirannico che se ne può fare. A questo modello policratico può facilmente
sovrapporsi il nuovo modello liberale, che teorizza esplicitamente la divisione e l’equilibrio
dei poteri: un tratto, questo, che caratterizza essenzialmente anche la nostra attuale
democrazia.
Occorre, peraltro, non appiattire anacronisticamente i diversi periodi storici.
Montesquieu, per esempio, che è solitamente considerato un anticipatore della distinzione
liberale dei poteri, rimane ancora fortemente legato alla tradizione. Nel suo scritto più
impegnativo, Lo spirito delle leggi (1748), in prima istanza attribuisce alle diverse forme di
governo, che sono la repubblica, la monarchia e il dispotismo, princìpi ispiratori specifici,
individuandoli rispettivamente nella “virtù”, cioè nell’amor patrio, nell’“onore”, cioè nel
sentimento che lega ciascuno allo status sociale previsto dal suo proprio rango, e nel
“timore” che suscita l’arbitrio del despota. Ciò che soprattutto lo preoccupa è il rischio di
una degenerazione della monarchia francese verso il dispotismo, com’era avvenuto durante
il recente regno di Luigi XIV. Egli non pensa agli universali diritti del giusnaturalismo,
perché per lui la libertà consiste nella certezza e nel rispetto dei diversi diritti che
competono tradizionalmente ai vari ceti sociali. In particolare ritiene importanti le libertates
(i privilegi) della nobiltà di toga, di cui egli stesso fa parte nel parlamento di Bordeaux,
perché le considera strumenti opportuni per limitare il rischio del dispotismo monarchico.
Prescindendo da questi suoi legami con la precedente tradizione storica, va comunque
riconosciuto che la sua teoria della divisione dei poteri contribuisce effettivamente a
predisporre un superamento dell’assolutismo, perché è sempre più interpretata nella
prospettiva del liberalismo moderno.
12. Immanuel Kant: una politica orientata a garantire la pace perpetua. Repubblica e
ordinamento cosmopolitico
Immanuel Kant fa propria la concezione contrattualistica del potere politico presente nella
tradizione giusnaturalistica. Anch’egli pensa che, per garantire un’ordinata convivenza tra
gli uomini, non sia sufficiente la socialità della condizione naturale, nella quale la coscienza
del diritto non è ancora in grado d’imporsi, ma sia necessario lo Stato, che si fonda su un
originario patto costitutivo e sul consenso che ne consegue. Il patto, tuttavia, non è di per sé
identificabile con un preciso fatto storico, perché consiste essenzialmente in un’idea
regolativa, ossia in un modello ideale, al quale chi gestisce il potere deve sempre rifarsi, ma
dal quale, diversamente da quel che pensava Locke, non discende per chi è governato il
diritto alla resistenza e alla rivoluzione, qualora constati che i governanti vengono meno
agli impegni assunti. Il tipo di governo a cui Kant si sente legato è ancora quello
dell’assolutismo illuminato di Federico II. Egli, comunque, difende il diritto di manifestare
pubblicamente il proprio libero pensiero, in coerenza con l’inderogabile impegno educativo
da lui espresso nel noto saggio Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?.
169
Nello scritto Per la pace perpetua indica come specifica garanzia di pace la costituzione
repubblicana degli Stati. Contrapponendola al dispotismo, che “è l’arbitraria esecuzione
delle leggi che lo Stato si è dato”, considera la repubblica come la migliore forma di
governo, perché la legge vi è sovrana e, in particolare, essa “applica il principio politico
della separazione del potere esecutivo (governo) dal potere legislativo”84. La forma
repubblicana si realizza in un sistema rappresentativo, finalizzato a garantire sia la libertà e
l’uguaglianza giuridica che la pace, perché “se (come in questa costituzione non può non
accadere) è richiesto l’assenso dei cittadini per decidere se la guerra debba o non debba
essere fatta, nulla di più naturale pensare che, dovendo far ricadere sopra di sé tutte le
calamità della guerra [...], essi rifletteranno a lungo prima di iniziare un così cattivo
gioco”85.
Secondo Kant la repubblica non va confusa con la democrazia, che insieme all’autocrazia
e all’aristocrazia è una delle tre sole forme possibili di Stato, designate anche come “forme
del potere” (formae imperii), in riferimento al fatto che “uno o pochi tra loro uniti o tutti
insieme quelli che costituiscono la società civile sono investiti del potere sovrano”86. Della
democrazia Kant non ha un concetto positivo. Mentre delle altre due forme di costituzione
politica possiamo dire che sono “difettose”, ma in esse “è almeno possibile assumere una
forma di governo conforme allo spirito di un sistema rappresentativo”, ciò non avviene con
la costituzione democratica. Nei suoi riguardi così si esprime: “Delle tre forme di Stato la
forma democratica nel senso proprio della parola è necessariamente un dispotismo, perché
essa stabilisce un potere esecutivo in cui tutti deliberano sopra uno ed eventualmente anche
contro uno (che non è d’accordo con loro), e quindi tutti deliberano anche se non sono tutti,
il che è una contraddizione della volontà generale con se stessa e con la libertà”87.
Per garantire una “pace perpetua”, Kant prefigura, inoltre, un ordinamento cosmopolitico
che porti gli Stati ad uscire da una condizione che non è ancora giuridica, ma naturale, nella
quale cioè la pace può essere solo precaria, come sarebbe per le relazioni tra gli individui
qualora li si pensasse prima e al di fuori dello Stato. Egli auspica che per una generale
tutela si realizzi un patto associativo tra eguali, che non istituisca un potere sovrano
sovrastante i singoli Stati, ossia uno Stato propriamente federale, ma una confederazione.
Per le relazioni tra gli Stati prospetta un pactum unionis, ma non un pactum subjectionis. A
questa associazione consegue la creazione di un diritto cosmopolitico, in base al quale uno
straniero non si sente più trattato come un nemico. Tra l’altro egli afferma: “Siccome in
fatto di associazione di popoli della terra (più o meno stretta o larga che sia) si è
progressivamente pervenuti a tal segno che la violazione del diritto avvenuta in un punto
della terra è avvertita in tutti i punti, così l’idea di un diritto cosmopolitico non è una
rappresentazione fantastica di menti esaltate, ma il necessario coronamento del codice non
scritto, così del diritto pubblico interno come del diritto internazionale, per la fondazione di
un diritto pubblico in generale e quindi per l’attuazione della pace perpetua, alla quale solo
a questa condizione possiamo sperare di approssimarci continuamente”88. Appare evidente
la modernità di questa prospettiva.
13. La concezione organicistica dello Stato in J.G. Fichte e G.W.F. Hegel: lo Stato etico.
La riproposizione di tale teoria da parte di Giovanni Gentile
84
I. Kant, Per la pace perpetua, in Scritti di filosofia politica, a cura di D. Faucci, La Nuova Italia, 1990, p. 100
ivi, pp. 96-99
ivi, p. 100
87
ibidem
88
ivi, p. 147
85
86
170
La filosofia politica del Romanticismo è rappresentata principalmente dalle teorie di Fichte
e di Hegel.
J.G. Fichte parte da una posizione liberale, secondo la quale la società politica è un
semplice mezzo di garanzia dei diritti individuali, ed evolve poi verso una concezione
organicistica dello Stato nazionale, nel senso che gli individui sono considerati come sue
parti, i cui interessi sono subordinati al bene generale. Lo Stato ha il compito di assicurare
la giustizia sociale, di regolare e programmare la produzione e lo scambio dei beni, così da
garantire l’autosufficienza economica entro i propri confini. Lo statalismo socialistico e
autarchico di Fichte assume un profilo sempre più nazionalistico. A partire
dall’occupazione napoleonica della Germania con i Discorsi alla nazione tedesca questo
filosofo diventa uno dei grandi “padri” del nazionalismo germanico, che nell’Ottocento
riscopre i motivi storici e culturali del proprio orgoglio.
Per G.W.F. Hegel lo Stato costituisce il momento dialetticamente più alto di realizzazione
etica dello Spirito oggettivo, perché nel suo ambito si attua nella concretezza storica il bene
possibile di tutto un popolo. In sintesi, “lo Stato è la sostanza etica consapevole di sé”89,
perché rappresenta la consapevolezza razionale del fine verso cui si indirizza la vita
comune di una nazione. È “sostanza”, perché ha in se stesso la propria ragion d’essere, nel
senso che giustifica da sé l’esercizio della sovranità, senza derivarla dall’esterno, ed è il
soggetto della storia.
Su questa base Hegel respinge la concezione liberale, per la quale lo Stato, secondo la
tradizione giusnaturalistica, è lo strumento che assicura la realizzazione dei diritti naturali
degli individui; infatti non si danno diritti prima e al di fuori della società, perché nella
condizione naturale c’è “l’esistenza della forza e il farsi valere della violenza; - e uno stato
di natura è uno stato della prepotenza e del torto, di cui non può esser detto niente di più
vero se non che da esso bisogna uscire. Per contro, la società è la condizione in cui soltanto
il diritto ha la sua realtà”90. Hegel insiste sulla necessaria subordinazione degli interessi
individuali all’interesse comune: “Si fa un calcolo sbagliato, quando nell’esigenza di questo
sacrificio, lo Stato è considerato soltanto come società civile, e, come proprio scopo finale,
è considerata soltanto la garanzia della vita e della proprietà degli individui”91. → Società
civile
Hegel non accetta nemmeno la teoria democratica, perché il popolo al di fuori dello Stato
è soltanto una moltitudine amorfa. La sua è una concezione organicistica: non sono gli
individui che formano la comunità politica, ma è questa che integra in sé gli individui e fa
valere nei loro riguardi non soltanto una precedenza temporale, per la quale essi nascono
nel suo ambito già costituito, ma soprattutto la propria importanza, perché è superiore ad
essi, come il tutto è superiore alle parti che lo compongono, cosicché in rapporto ad essa “i
singoli individui sono soltanto momenti”92. Lo Stato hegeliano, però, non è dispotico, cioè
non è basato sull’arbitrio, ma è uno Stato di diritto, fondato sul rispetto delle leggi. La
libertà individuale, che pretende di far riferimento a se stessa, è arbitrio astratto; invece “lo
Stato è la realtà della libertà concreta”93. Nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche Hegel
così parafrasa questa affermazione: nello Stato “ogni vera legge è una libertà; giacché
contiene una determinazione razionale dello spirito oggettivo, e quindi un contenuto della
89
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, a cura di B. Croce, Laterza, 1973, vol. II, § 535, p. 473
ivi, vol. II, § 502, p. 454
91
G.W.F. Hegel, Lineamenti della filosofia del diritto, (“Aggiunte” di E. Gans, allievo e collega di Hegel), trad. it.
di F. Messineo, Laterza, 1974, p. 318
92
ivi, p. 430 (“Aggiunte” di E. Gans)
93
ivi, p. 246
90
171
libertà. Per contrario, niente è diventato più ordinario dell’idea, che ciascuno debba limitare
la sua libertà in relazione alla libertà degli altri; e che lo Stato sia la condizione in cui ha
luogo tale limitazione reciproca, e le leggi siano i limiti. In questi modi di vedere la libertà è
concepita soltanto come un capriccio accidentale e un arbitrio”94. In senso più generale
Hegel ribadisce che “la libertà vera è, in quanto eticità, questo: che il volere non ha per i
suoi scopi un contenuto soggettivo, cioè egoistico, ma un contenuto universale”95.
La costituzione di uno Stato, cioè l’insieme delle regole fondamentali che l’organizzano,
non è un codice astratto, ma è l’espressione dello spirito di un popolo (Volksgeist), della sua
storia collettiva e della tradizione culturale. Napoleone, infatti, ha fallito quando ha voluto
imporla dall’esterno agli spagnoli.
Hegel identifica la costituzione “razionale” del periodo contemporaneo con la monarchia
costituzionale, la quale prevede la distinzione dei poteri. Egli guarda al caso prussiano, nel
quale il potere legislativo compete solo in parte alle assemblee rappresentative delle classi e
dei ceti, perché il loro limite sta nella naturale inclinazione a sostenere gli interessi
particolari e corporativi di coloro che rappresentano; all’esercizio di questo potere, perciò,
concorrono sia il governo sia il monarca. Il primo, che esercita anche la funzione
giudiziaria e quella di polizia, operanti nell’ambito della società civile, esprime l’interesse
generale attraverso i ministri e i pubblici funzionari, che per questo sono definiti classe
universale; il monarca rappresenta l’unità dello Stato.
Lo Stato nella sua azione non è limitato dalla morale, che ha nella coscienza individuale il
suo ambito di competenza, perché esso ha un bene generale da assicurare; in questo senso è
uno Stato etico.
Hegel enfatizza la funzione storica dello Stato, al punto da dichiarare: “l’ingresso di Dio
nel mondo è lo Stato”96. In sintonia con la cultura romantica degli Stati nazionali non pensa
ad un’organizzazione politica cosmopolitica, che superi il monopolio che essi detengono
della sovranità, disciplini i loro reciproci rapporti e gli eventuali conflitti. L’unico arbitro
che egli riconosce è lo Spirito universale (Weltgeist), che si manifesta nella storia attraverso
l’azione degli Stati, in particolare di quelli che riescono a far valere la loro egemonia. Ciò
avviene anche mediante la guerra, la quale talora risulta inevitabile per esprimere e
sostenere la vitalità dei popoli, come “il movimento dei venti preserva il mare dalla
putrefazione, nella quale lo ridurrebbe una quiete durevole”97.
Nel Novecento Giovanni Gentile (1875-1944) riprende questa teoria organicistica dello
Stato etico, facendone il sostegno ideologico del fascismo italiano. Ecco alcune sue
significative affermazioni: “Lo Stato è la nazione consapevole della sua unità storica. [...]
L’uomo che nella sua singola personalità si senta estraneo a tale forma, è un’astrazione
storica [...Lo] Stato ha un’esistenza interiore; e tutte le sue esterne manifestazioni
(territorio, forza esecutiva del potere, uomini rappresentativi dei vari poteri dello Stato,
ecc.) traggono il loro valore dalla volontà che le riconosce e vuole come elementi necessari
e costitutivi della forma storica e attuale dello Stato. E bisogna riferirsi a questa interiorità,
e intenderla rigorosamente, per rendersi conto del carattere etico dello Stato [...] Lo Stato
nella sua essenziale interiorità non solo è volontà etica, ma è, in generale, autocoscienza,
quindi umanità piena e perfetta. [...] La principale difficoltà che ostacola l’esatta
intelligenza del carattere etico dello Stato è la relazione statica e assolutamente meccanica
94
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, cit., vol. II, §539, pp. 476-477
ivi, cit., vol. II, § 469, p. 432
G.W.F. Hegel, Lineamenti della filosofia del diritto, (“Aggiunte” di E. Gans, allievo e collega di Hegel), cit., p.
430
97
ivi, p. 318
95
96
172
in cui sono concepiti il cittadino e lo Stato: il particolare e l’universale. Onde si pensa che il
particolare è particolare e non universale; e viceversa. E ciascuno dei due termini si oppone
all’altro, rigidamente, irriducibilmente. Laddove i due termini così concepiti sono due
astrazioni, e il concreto è la loro unità dialettica, cioè il particolare che si fa universale. [...]
Lo Stato vero non limita ma slarga, non deprime ma potenzia la personalità del cittadino:
non l’opprime ma la libera”98. → Totalitarismo
14. Karl Marx: lo Stato è uno strumento della classe dominante; il comunismo è il suo
definitivo superamento dialettico.
Nei confronti con l’idealismo hegeliano Karl Marx si rifà alla critica materialistica di
Feuerbach, secondo la quale il cammino percorso dalla filosofia speculativa dall’astratto al
concreto e dall’ideale al reale è un cammino alla rovescia: ciò che nella realtà è il soggetto
diventa predicato e viceversa, ossia il pensiero, che è una manifestazione dell’essere,
diventa una realtà in sé sussistente, della quale l’essere è considerato un’espressione
derivata e secondaria. Interpretando le realtà empiriche come manifestazioni di una
sostanza razionale, le si giustifica e le si legittima in quanto razionali. Pertanto, ciò che in
generale occorre fare è “rimettere la realtà sui piedi”, ponendo fine a questo “misticismo
logico”. → Alienazione
Marx ritiene di dover applicare questo rovesciamento materialistico in particolare alla
teoria politica hegeliana, dalla quale lo Stato monarchico prussiano era interpretato come
l’espressione più alta della razionalità storica del tempo presente. Questa operazione
idealistica, oltre che logicamente scorretta, secondo Marx, è evidentemente apologetica nei
riguardi dell’assetto storico in atto. In questo senso la teoria hegeliana è “ideologia”. →
Ideologia
Già nel saggio giovanile intitolato La questione ebraica (1844), Marx teorizza la propria
inversione materialistica, che possiamo riassumere in questi termini: a realizzare la
funzione storico-sociale più importante ed efficace non è lo Stato, che si dichiara garante
dell’interesse comune, ma è la società civile, nella quale si affermano gli interessi
particolari (→ Società civile). L’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è solo
formale: proclamata a parole in solenni principi, essa non fa che presupporre e ratificare la
loro sostanziale ed effettiva disuguaglianza. Come i cristiani, pur essendo diseguali in terra,
si consolano di essere tutti eguali in cielo, così alla reale disuguaglianza presente nella
società civile, o borghese, viene proposta la consolazione illusoria dell’universale
uguaglianza di fronte allo Stato; e ognuno di noi vive “una doppia vita”: “celeste” come
“citoyen” nell’ambito dell’istituzione pubblica e “terrena” come “bourgeois”, uomo privato
proteso ai suoi interessi. Pertanto “lo Stato sopprime a suo modo la differenza di nascita, di
ceto, di educazione, di professione, dichiarando differenze prive di significato politico
nascita, ceto, educazione, professione, chiamando a partecipare egualmente alla sovranità
popolare qualunque membro del popolo, senza riguardo a queste differenze, trattando tutti
gli elementi della reale vita popolare dal punto di vista statale. Nondimeno lo Stato lascia
che la proprietà privata, l’educazione, la professione agiscano a modo loro”. Diversamente
da come pensava Hegel, non è l’eticità dello Stato, nell’astratta consapevolezza del bene
comune, a riscattare effettivamente dal loro egoismo gli interessi particolari che si
esprimono nella società civile, ma è la società civile che fa dello Stato un semplice
strumento degli interessi della classe dominante. Perciò “l’emancipazione politica non è la
98
G. Gentile, Introduzione alla filosofia, Sansoni, 1958, p. 33
173
forma completa e perfetta dell’emancipazione umana”99. Marx pensa ormai ad una società
in cui possa realizzarsi una democrazia sostanziale, che comporti l’integrazione effettiva
degli individui nella comunità, ossia il comunismo. La sua concezione dello Stato rimane
coerente in tutta l’evoluzione del suo pensiero. Nel periodo della sua maturità intellettuale
la hegeliana “società civile” diventa la “struttura” sociale, mentre lo Stato è inserito in una
complessa “sovrastruttura”.
Del potere politico e dello Stato nel Manifesto del partito comunista (1848) afferma: “Il
potere politico dello Stato moderno non è che un comitato, il quale amministra gli affari
comuni di tutta quanta la classe borghese”. E anche: “Il potere politico, nel senso proprio
della parola, è il potere organizzato di una classe per l’oppressione di un’altra”. La stessa
rivoluzione del proletariato costituirà lo Stato proletario prima che la realizzazione della
società comunista, senza più classi, ne determini il superamento: “Il proletariato si servirà
della sua supremazia politica per strappare alla borghesia, a poco a poco, tutto il capitale,
per accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello Stato, vale a dire del
proletariato stesso organizzato come classe dominante”100. → Società civile; Materialismo
storico; Democrazia; Comunismo;
15. John Stuart Mill: libertà individuale ed emancipazione femminile
La storia del mondo occidentale nel corso dell’Ottocento e del Novecento va realizzando
ovunque, anche se in maniera non sempre soddisfacente, un modello politico che integra in
sé i principi del liberalismo e della democrazia rappresentativa, cioè la democrazia liberale.
A ciò John Stuart Mill dà un significativo contributo teorico con due noti saggi: On liberty
(1859) e The subjection of women (1869).
On liberty (1859) è un classico del pensiero liberale, nel quale Mill, dopo una precedente
ampia recensione di Democrazia in America (1840) di Alexis Clérel de Tocqueville, torna a
confrontarsi con i problemi che già il pensatore politico francese aveva posto in quella sua
opera. L’argomento fondamentale trattato da Mill è il seguente: “la natura e i limiti del
potere che la società può legittimamente esercitare sull’individuo”. La questione della
libertà individuale non è affrontata astrattamente, ma in concreto rapporto al rilevante
fenomeno storico della formazione di una società di massa, nella quale si rendono evidenti
nuove espressioni di dominio rispetto alle forme classiche del passato, in particolare il
dispotismo dell’opinione pubblica, che impone l’omologazione dei modi di pensare e di
agire, l’uniformità degli stili di vita ed il conformismo dei gusti, la repressione del dissenso
e dell’originalità. La prospettiva è la diffusione della mediocrità, la riduzione al silenzio
della critica e dell’autonomia del giudizio, l’inaridirsi dell’iniziativa creatrice e originale.
Mill è convinto di vivere in un’epoca in cui “il pensiero politico ormai comprende
generalmente ‘la tirannia della maggioranza’ tra i mali da cui la società deve guardarsi.”
Quando la società stessa è il tiranno, “esercita una tirannide sociale più potente di molti tipi
di oppressione politica, poiché, anche se generalmente non viene fatta rispettare con pene
altrettanto severe, lascia meno vie di scampo, penetrando più profondamente nella vita
quotidiana e rendendo schiava l’anima stessa”101. L’antidoto al triste destino di un “governo
della mediocrità” consiste nell’incoraggiare la diversità e l’originalità. Pertanto “nella
nostra epoca, il semplice esempio di anticonformismo, il mero rifiuto di piegarsi alla
consuetudine, è di per se stesso un servigio all’umanità”102. Convinto della superiorità del
sistema rappresentativo parlamentare, Mill guarda con sospetto alla proclamazione
99
K. Marx, Scritti politici giovanili, a cura di L. Firpo, Einaudi, 1950, p. 363 e p. 362
K. Marx, Manifesto del partito comunista, trad. it. di P. Togliatti, Editori Riuniti, 1974, p. 58, p. 89 e p. 87
101
J. Stuart Mill, Saggio sulla libertà, trad. it. di S. Magistretti, Il Saggiatore, 1981, p. 23 e pp. 26-27
102
ivi, pp. 96-97
100
174
rousseauiana della sovranità popolare, perché anche “il popolo può desiderare opprimere
una propria parte”; è possibile, infatti, una democrazia autoritaria, compatibile con ampie
dimostrazioni di consenso popolare. Il futuro di un’autentica democrazia è dato dalla
prospettiva di una democrazia liberale, che salvaguardi il diritto di opposizione delle
minoranze e l’autonomia e originalità degli individui. L’unico criterio che legittima
un’interferenza esterna sull’indipendenza individuale è indicato da Mill in questi termini:
“Il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di
una comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per evitare danno agli altri. Il bene
dell’individuo, sia esso fisico o morale, non è una giustificazione sufficiente. Non lo si può
costringere a fare o non fare qualcosa perché è meglio per lui, perché lo renderà più felice,
perché, nell’opinione altrui, è opportuno o perfino giusto: questi sono buoni motivi per
discutere, protestare, persuaderlo o supplicarlo, ma non per costringerlo nel caso si
comporti diversamente […] Il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve
render conto alla società è quello riguardante gli altri: per l’aspetto che riguarda soltanto lui,
la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo,
l’individuo è sovrano [Over himself, over his own body and mind, the individual is
sovereign]”103.
Il saggio The subjection of women (1869) ci attesta poi la particolare sensibilità di Mill per
la “questione femminile”, della quale il misconoscimento ottocentesco del diritto elettorale
era solo un aspetto. All’inizio del saggio egli si dichiara pienamente convinto che “il
principio che regola le vigenti relazioni sociali dei due sessi, - la sottomissione di un sesso
all’altro in nome della legge - è cattivo in se stesso, ed è oggi uno dei principali ostacoli al
progresso dell’umanità”. In questo caso la consuetudine non depone a favore del buon
diritto: “Non c’è nessuna presunzione in suo favore che possa essere derivata dalla sua
esistenza” (no presumption in its favour can be drawn from the fact of its existence). Si può
solo dire che è durato fino ad oggi, mentre altre istituzioni nate dalla stessa negativa
origine, per esempio la schiavitù, prodotta dalla violenza e dal sopruso, sono scomparse. A
tale riguardo Mill afferma con decisione che “la disparità di diritti fra l’uomo e la donna
non ha altra origine che la legge del più forte” (the inequality of rights between men and
women has no other source than the law of the strongest). Il protrarsi nei secoli di questa
disparità ha plasmato a tal punto in entrambi i sessi la consuetudine di determinate relazioni
e l’assuefazione a determinati atteggiamenti, che essi sono ormai scambiati per una
condizione naturale, cosicché “innaturale in genere significa solo inconsueto e tutto ciò che
è abituale appare naturale. Poiché la soggezione della donna all’uomo è un modo d’essere
universale, qualsiasi allontanamento da esso appare in maniera del tutto ovvia (naturale)
innaturale” (“So true is it that unnatural generally means only uncustomary, and that
everything which is usual appears natural. The subjection of women to men being a
universal custom, any departure from it quite naturally appears unnatural”104). In
particolare il fatto che si rappresenti la donna in una disposizione di spontanea
accondiscendenza verso la sua attuale condizione è l’effetto di una penetrante ed efficace
educazione, che corrisponde ai desideri interessati degli uomini. Pertanto Mill osserva che
“ciò che oggi è chiamato la natura delle donne è una cosa eminentemente artificiale – il
risultato per certi versi di una repressione imposta, per altri di una sollecitazione innaturale”
“What is now called the nature of women is an eminently artificial thing — the result of
forced repression in some directions, unnatural stimulation in others”105).
103
ivi, p. 26 e pp. 32-33
J. Stuart Mill, The subjection of women, cap. I
105
J. Stuart Mill, The subjection of women, cap. I
104
175
16. Carl Schmitt: la politica è determinata dall’opposizione “amico-nemico”
In un saggio del 1927, intitolato Il concetto di politico, il tedesco Carl Schmitt afferma che
non è possibile rendersi conto di che cos’è lo Stato se non presupponiamo il concetto di
“politico”. Anche la politica, infatti, come gli altri ambiti specifici dell’esperienza umana,
dispone di un criterio autonomo per determinarsi nella sua struttura essenziale. Se l’estetica,
l’economia e la morale si fondano sulle opposizioni fondamentali che sussistono
rispettivamente tra il bello e il brutto, l’utile e il dannoso, il buono e il cattivo, la politica,
invece, si basa sul rapporto che oppone l’amico e il nemico. Percepiamo l’affinità con
l’amico, con il quale riconosciamo di condividere una comune identità, e avvertiamo
l’estraneità esistenziale del nemico. Questi è il nemico pubblico, che la lingua latina
designa come hostis, non come inimicus, appellativo riferibile alla persona che è oggetto di
avversione in un rapporto privato. Sulla base di questa distinzione Schmitt osserva che “non
v’è bisogno che il nemico politico sia moralmente cattivo o esteticamente brutto; egli non
deve necessariamente presentarsi come concorrente economico e forse può anche apparire
vantaggioso fare affari con lui. Egli è semplicemente l’altro, lo straniero”106. L’essenzialità
strutturale del rapporto oppositivo tra amico e nemico nell’ambito della politica non ha
come conseguenza necessaria la deflagrazione della guerra tra Stati o della guerra civile
entro i confini di uno stesso Stato; tuttavia, finché sussiste l’opposizione, c’è sempre una
reale possibilità che il conflitto esploda. Schmitt condivide e ripropone il pessimismo
antropologico di Thomas Hobbes, secondo il quale per natura gli uomini sono
reciprocamente ostili (“homo homini lupus”).
Sulla base di queste convinzioni egli afferma, in una forma solo apparentemente
paradossale, che il liberalismo non è una vera teoria politica, perché non accetta che una
struttura collettiva (lo Stato) decida per gli individui e si propone come l’espressione diretta
dei diritti individuali, alla cui tutela riduce strumentalmente la funzione stessa dello Stato,
che ne risulta così subordinato. Del liberalismo Schmitt non condivide l’antropologia
ottimistica, che riconosce la naturale razionalità degli individui. Inoltre egli esclude che sia
possibile un governo mondiale e che la struttura statale sia destinata a finire: “Sulla terra,
finché esiste uno Stato, vi saranno sempre più Stati e non può esistere uno ‘Stato’ mondiale
che comprenda tutta la terra e tutta l’umanità”107.
Nello scritto del 1931, intitolato Il custode della Costituzione, Schmitt evidenzia la
propria avversione al parlamentarismo, a cui ritiene siano connessi non episodicamente, ma
strutturalmente l’incontrollabile arbitrio dei partiti, la loro rissosità, l’eccesso dei privilegi e
la separazione degli eletti dagli elettori. Storicamente egli sta assistendo al progressivo
sgretolamento della repubblica di Weimar, contro il quale auspica la formazione di uno
Stato forte, che disciplini lo scomposto dinamismo generale mediante la valorizzazione del
rapporto diretto tra il Presidente e il popolo che l’ha eletto e mediante il ricorso alla
decretazione d’urgenza del governo del Presidente in sostituzione della tradizionale
legislazione ordinaria. Di lì a poco Schmitt darà il proprio assenso al regime nazista.
PRASSI, Filosofia della
“Filosofia della prassi” è l’espressione della quale si serve Antonio Gramsci nei Quaderni
del carcere per designare la concezione del mondo che andrebbe svolta sistematicamente a
106
107
C. Schmitt, Il concetto di Politico, in Le categorie del “politico”, Il Mulino, 1972, p. 109
ivi, p. 137
176
partire dai semplici spunti che ha lasciato Karl Marx nei suoi scritti. Per ora, egli annota, ne
abbiamo solo “aforismi e criteri pratici”, in particolare nelle Tesi su Feuerbach e nella
Prefazione a Per la critica dell’economia politica, perché Marx “ha dedicato le sue forze
intellettuali ad altri problemi, specialmente economici”, e tuttavia “in questi criteri pratici e
in questi aforismi è implicita tutta una concezione del mondo, una filosofia”, che ora si
tratta di realizzare117. La denominazione gramsciana di “filosofia della prassi” è
direttamente ispirata alle Tesi su Feuerbach, nelle quali si afferma che “nella prassi l’uomo
deve provare la verità, cioè la realtà e il potere, il carattere immanente del suo pensiero”, e
alla prassi deve affidare la trasformazione e la rivoluzione dei rapporti sociali, perché finora
“i filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo; si tratta di trasformarlo”118.
Gramsci, perciò, partendo dai principi indicati dal materialismo storico di Marx, aspira ad
elaborare una concezione generale del mondo, una vera e propria Weltanschauung. →
Materialismo storico
L’affermazione, apparentemente banale, che anche Gramsci fa, cioè che tutti gli uomini
sono “filosofi”, rivela la sua importanza nel momento in cui egli osserva che “occorre
distruggere il pregiudizio molto diffuso che la filosofia sia alcunché di molto difficile per il
fatto che essa è l’attività intellettuale propria di una determinata categoria di scienziati
specialisti o di filosofi professionali e sistematici”. C’è una “filosofia spontanea”, rispetto
alla quale si tratta di attivarsi criticamente, perché spesso il nostro pensare avviene “in
modo disgregato e occasionale”, che è come un “‘partecipare’ a una concezione del mondo
‘imposta’ meccanicamente dall’ambiente esterno, e cioè da uno dei tanti gruppi sociali nei
quali ognuno è automaticamente coinvolto fin dalla sua entrata nel mondo cosciente”, senza
che si riesca ad essere “guida di se stessi” e a dare “l’impronta alla propria personalità” 119.
Inoltre, se è vero che tutti gli uomini sono filosofi, tuttavia non tutti “fanno filosofia” come
professionisti e intellettuali di una determinata classe sociale, che può essere dominante o
subalterna. Gli intellettuali cooperano nel primo caso a confermare e a giustificare
l’egemonia culturale vigente, nel secondo caso a tentare di cambiarla mediante la critica e
l’elaborazione di concezioni alternative.
L’analisi gramsciana fa emergere una situazione complessa. Bisogna innanzitutto essere
realisticamente consapevoli che “per la propria concezione del mondo si appartiene sempre
a un determinato aggruppamento, e precisamente a quello di tutti gli elementi sociali che
condividono uno stesso modo di pensare e di operare. […] si è sempre uomini-massa o
uomini-collettivi”. Per ognuno “l’inizio dell’elaborazione critica è la coscienza di quello
che è realmente, cioè un ‘conosci te stesso’ come prodotto del processo storico finora
svoltosi che ha lasciato in te stesso un’infinità di tracce accolte senza beneficio
d’inventario. Occorre fare inizialmente un tale inventario”120.
Il sapere, poi, non è mai soltanto contemplativo, ma è sempre orientato in senso pratico.
In quanto è caratterizzata da determinati interessi e proiettata attivamente ad organizzare la
realtà, la filosofia è necessariamente politica: essa intende agire storicamente. Infatti “si può
dire che il valore storico di una filosofia può essere ‘calcolato’ dall’efficacia ‘pratica’ che
essa ha conquistato. […] Se è vero che ogni filosofia è l’espressione di una società,
dovrebbe reagire sulla società, determinare certi effetti, positivi e negativi: la misura in cui
appunto reagisce è la misura della sua portata storica, del suo non essere ‘elucubrazione’
individuale, ma ‘fatto storico’”121. Ora, succede piuttosto spesso che “l’uomo attivo di
117
A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, 1975, Quaderno 11, § 26, vol. II, p. 1432
K. Marx, Tesi su Feuerbach, 2 e 11, in Opere di Marx-Engels, Editori Riuniti, 1972, vol. V, p. 3-5
A. Gramsci, Quaderni del carcere, cit., Quaderno 11, § 12, vol. II,, pp. 1375-1376
120
Op. cit., Quaderno 11, § 12, vol. II, p. 1376
121
Op. cit., Quaderno 7, § 45, vol. II, p. 894
118
119
177
massa” abbia, per così dire, due coscienze: una è “implicita nel suo operare” ed è
importante, perché “realmente lo unisce a tutti i suoi collaboratori nella trasformazione
pratica della realtà”; un’altra, invece, “superficialmente esplicita o verbale”, è ereditata dal
passato acriticamente, ma bisogna prenderla in seria considerazione, perché “non è senza
conseguenze: essa riannoda a un gruppo sociale determinato, influisce nella condotta
morale, nell’indirizzo della volontà”122.
Gramsci è consapevole che una complessiva e profonda trasformazione storica è richiesta
dalla dialettica sociale della nostra epoca: essa comporta un rivoluzionamento nella stessa
concezione del mondo, cioè l’esigenza di una filosofia adeguata, già annunciata fin dal
primo Ottocento dalla “filosofia classica tedesca”, che “introdusse il concetto di ‘creatività’
del pensiero, ma in senso idealistico e speculativo”. Poi, però, con il materialismo storico
Marx ha cominciato ad appropriarsi di questa creatività, insegnando “come non esista una
‘realtà’ per sé stante, in sé e per sé, ma in rapporto storico con gli uomini che la
modificano”123. Rispetto a questa filosofia della prassi il pensiero di Benedetto Croce si
rivela come una pura “filosofia speculativa”, che ha privato la dialettica hegeliana “di ogni
vigore e di ogni grandezza, rendendola una quistione scolastica di parole”; perciò “stabilire
con esattezza il significato storico e politico dello storicismo crociano significa appunto
ridurlo alla sua reale portata di ideologia politica immediata, spogliandolo della grandezza
brillante che gli viene attribuita come di manifestazione di una scienza obbiettiva, di un
pensiero sereno e imparziale che si colloca al di sopra di tutte le miserie e le contingenze
della lotta quotidiana, di una disinteressata contemplazione dell’eterno divenire della storia
umana”124. Così l’idealismo riconferma la sua intrinseca natura metafisica; invece non ha
nulla di metafisico la “struttura” economico-sociale, che Marx ha individuato nell’analisi
del processo storico: “L’affermazione del Croce che la filosofia della praxis ‘stacca’ la
struttura dalle superstrutture, rimettendo così in vigore il dualismo teologico e ponendo un
‘dio ignoto-struttura’ non è esatta e non è neanche molto profonda invenzione. L’accusa di
dualismo teologico e di disgregazione del processo del reale è vacua e superficiale”125.
Nella riflessione crociana la storia effettiva “diventa una storia formale, una storia di
concetti, e in ultima analisi una storia degli intellettuali, anzi una storia autobiografica del
pensiero del Croce, una storia di mosche cocchiere”126.
In maniera ben diversa da quella crociana occorre costruire la filosofia della prassi. Essa
deve essere una vera filosofia dell’immanenza, depurata di ogni elemento metafisico e
svolta nell’ambito concreto della storia. Una volta che sia tolta di mezzo la trasfigurazione
idealistica e speculativa, lo storicismo è in grado di dimostrare che l’uomo è il protagonista
della storia da lui prodotta. Pertanto, “la filosofia della praxis è lo ‘storicismo’ assoluto, la
mondanizzazione e terrestrità assoluta del pensiero, un umanesimo assoluto della storia. In
questa linea è da scavare il filone della nuova concezione del mondo”127.
Antonio Gramsci, che pur riconosce nella complessa realtà sociale l’unità organica della
struttura e della sovrastruttura, a questa rivolge un’attenzione preminente, perché è nel suo
ambito che una classe riesce a realizzare la propria egemonia sull’intera società, facendo
valere i suoi particolari interessi come interessi di tutti e la sua concezione del mondo come
“senso comune”, ossia come ovvia filosofia prevalente. → Società civile
122
Op. cit., Quaderno 11, § 12, vol. II, p. 1384
Op. cit., Quaderno 11, § 59, vol. II, pp. 1485-1486
124
Op. cit., Quaderno 10, § 41, vol. II, pp. 1326-1327
125
Op. cit., Quaderno 10, § 41, vol. II, p. 1300
126
Op. cit., Quaderno 10, § 1, vol. II, p. 1241
127
Op. cit., Quaderno 11, § 27, vol. II, p. 1437
123
178
PSICOANALISI
In senso specifico questo termine designa sia la teoria psicologica, elaborata da Sigmund
Freud (1856-1939) come interpretazione della sua attività clinica, che l’applicazione
terapeutica di questa stessa teoria. Essa ha dimostrato la sua importanza non soltanto
nell’ambito specifico della psicologia, ma nella comprensione più generale richiesta dalla
moderna problematica antropologica.
1. L’importanza dell’inconscio nella formazione della personalità
Già nei primi approcci clinici alle nevrosi e alle loro tipiche manifestazioni Freud si
confrontò con i problemi epistemologici che la consolidata interpretazione della medicina
positivistica inevitabilmente poneva a chi intendesse accettare la serietà dei disturbi della
personalità, anche in assenza di evidenze patologiche organiche e di lesioni somatiche.
Infatti la considerazione che il positivismo aveva della psicologia era tendenzialmente
riduzionistica, tale cioè da non riuscire ad apprezzarne adeguatamente la specificità e
l’importanza. Freud studiò in un primo tempo in Francia e poi a Vienna, in collaborazione
con Josef Breuer, l’efficacia terapeutica dell’ipnosi, che veniva usata sia per inibire i
sintomi isterici (disturbi comportamentali e sensoriali, paralisi motorie, idee ossessive,
azioni compulsive, afasia, anoressia, ecc.) sia per richiamare alla memoria eventi del
passato che si collegavano ad essi. Egli si dimostrò sempre più convinto dell’esistenza di
malattie autenticamente psichiche e acquisì una progressiva chiarezza sulla loro natura
psicogena, perché gli apparivano determinate da esperienze traumatiche e da conflitti
prevalentemente inconsci, tali da comportare intense cariche emotive ed affettive e da
investire organi o parti del corpo. Constatava, infatti, che la scarica emotiva o “abreazione”,
conseguente al recupero di un passato che era stato rimosso dalla coscienza, determinava un
evidente alleviamento e una tendenziale liberazione dai sintomi, fenomeno, questo, che poi
fu chiamato “catarsi”. → Catarsi
A Freud la psiche umana andò profilandosi ben diversa da come generalmente la si era
considerata nel passato: non più identificabile con la semplice coscienza, che appare invece
come una sua parte, spesso precaria e fragile, essa fa emergere il suo lato più oscuro e
profondo, l’inconscio, che, proprio perché si sottrae al controllo della parte razionale,
condiziona fortemente la nostra personalità e il suo comportamento. A voler dire la cosa
con le parole del fondatore della psicoanalisi, “non solo l’Io non è più padrone in casa
propria, ma deve fare assegnamento su scarse notizie riguardo a ciò che avviene
inconsciamente nella sua psiche”181. Pertanto nel perbenismo, spesso ipocrita, della cultura
europea del tardo Ottocento e del primo Novecento la psicoanalisi suscitava scandalo; essa
metteva in crisi la tradizionale autostima connessa alla nostra identità coscienziale. A molti
sembrò un’ulteriore umiliazione della dignità umana dopo quella prodotta
dall’evoluzionismo darwiniano.
La scarsa efficacia riscontrata nell’uso dell’ipnosi sollecitò Freud a individuare nel
metodo delle libere associazioni un diverso modo di realizzare l’analisi clinica, che andò
sempre più consolidandosi come caratteristico della sua scuola. Nella convinzione che i
contenuti mentali si collegano spontaneamente e deterministicamente tra loro secondo
catene associative, il paziente fu posto in una condizione di rilassamento e sollecitato
dall’analista ad abbandonarsi ad esse, allo scopo di far emergere quanto nella sua
181
Freud, Introduzione alla psicoanalisi, in Opere, a cura di C.L. Musatti, Boringhieri, 1976, vol. VIII, p. 446
179
esperienza egli aveva rimosso dalla coscienza, perchè non riusciva a sopportare la
sofferenza o la vergogna che gli provocava. Secondo la psicoanalisi il meccanismo di difesa
della “rimozione” non costituisce un annullamento, perché quel che si rimuove continua ad
agire (Freud a questo riguardo parlò di “ritorno del rimosso”) e a segnalarsi nei sintomi
delle nevrosi e dei disturbi della personalità, anche se oppone resistenza ai tentativi di
riportarlo alla coscienza182. Interviene in ciò una forma di “censura”, che successivamente
Freud attribuì al Super-io. Nel rapporto terapeutico il paziente tende a rivivere le esperienze
traumatiche del passato e ad investire l’analista delle cariche affettive (positive o negative),
che originariamente nella vita reale erano rivolte ad altri (in particolare le figure parentali):
è il fenomeno del “transfert” (= traslazione affettiva).
2. La psicoanalisi come arte dell’interpretazione
Per l’analisi della nostra personalità tutti i nostri comportamenti hanno un senso: anche ciò
che sembra banale è utile alla comprensione di noi stessi. La casualità di gesti e di eventi
(lapsus, errori, dimenticanze, incidenti, ecc.), che Freud considera in Psicopatologia della
vita quotidiana (1901), è spesso solo apparente: il determinismo psichico consente di
decifrarli come manifestazioni camuffate dell’inconscio. Ma la “via regia che porta alla
conoscenza dell’inconscio nella vita psichica” è il sogno. In esso, infatti, la censura, pur
non venendo mai meno del tutto, si allenta, lasciando trasparire in forme indirette
l’esperienza rimossa. Non a caso una delle opere fondamentali della psicoanalisi freudiana
è L’interpretazione dei sogni (1900)183. L’autore distingue nei sogni il contenuto palese,
ossia ciò che di essi riusciamo a raccontare, con tutte le loro inverosimiglianze e
paradossalità, e il contenuto latente, che è il lato propriamente significativo e importante
dell’esperienza onirica, rispetto al quale ciò che è manifesto si presenta come una
complessa metafora da decifrare, perché è l’esito di elaborati travestimenti, a cui la censura
costringe gli impulsi e i desideri rimossi. Da questo punto di vista quel che l’analista fa è
una vera attività ermeneutica. Anche Freud, accanto a Marx e a Nietzsche, è stato
efficacemente indicato da Paul Ricoeur come un “maestro del sospetto”. Mentre Marx
criticò le ideologie come espressioni di particolari interessi materiali e Nietzsche svolse una
radicale demitizzazione delle verità e dei valori su cui si fonda la cultura occidentale
platonico-cristiana, Freud fece l’analisi dei complessi meccanismi con i quali l’io tende a
difendersi contro quanto avverte come non accettabile e penoso per la coscienza,
rimuovendolo, mascherandolo, deformandolo, sostituendolo. Perciò la forma densamente
simbolica del sogno, indotta dalla censura, tende a nascondere gli impulsi e i desideri, e
tuttavia non riesce a sottrarli a chi sappia decifrarla; i sintomi nevrotici non sono muti e
opachi per l’analista che è in grado di intenderli in riferimento alle cause che li hanno
determinati; molti eventi quotidiani, solo apparentemente banali, non sono casuali, ma si
lasciano comprendere come espressioni della dimensione inconscia della nostra psiche;
anche le produzioni simboliche della cultura per la loro interpretazione possono richiedere
di essere viste come il travestimento sublimato di motivazioni pulsionali. Si può dire che
c’è sempre un senso da decifrare nella vita psichica dell’uomo: “Dovunque sinora sembrava
Sulla base del processo psichico che presiede alla rimozione, possiamo menzionare alcuni altri “meccanismi di
difesa”, con i quali l’io tende a respingere da sé le vere cause dei suoi disagi. C’è il meccanismo della “negazione”,
che consiste nel negare quel che fino ad ora è stato rimosso e costituirebbe una ragione di sofferenza dover invece
ammettere. Con il meccanismo della “razionalizzazione”, poi, si cerca di dare spiegazioni logicamente coerenti e
moralmente accettabili di atteggiamenti e comportamenti, che si prestano ad essere pubblicamente censurati.
Ricordiamo, infine, il meccanismo della “proiezione”, che consiste nel proiettare su un’altra persona o su una cosa
ciò che non si riconosce come proprio.
183
“L’interpretazione dei sogni” di Freud e la scoperta dell’inconscio come problema filosofico, a cura di M.L.
Martini, Paravia, 1994; in particolare la citazione appena fatta è presente nel VII capitolo a p. 170
182
180
regnasse soltanto il capriccio più bizzarro, il lavoro psicoanalitico ha indicato la presenza di
una legge, di un ordine, di una concatenazione, o perlomeno l’ha fatta intuire nei casi in cui
la ricerca era ancora incompiuta”184.
3. La complessa struttura della personalità
Freud ci offrì due “topiche” psicologiche, che strutturano la complessità funzionale della
nostra psiche, in relazione ai “luoghi” metaforici che ne individuano le diverse istanze. La
prima è abbastanza semplice e suddivide la psiche in conscio, preconscio (ciò che sfugge
momentaneamente alla coscienza, ma è possibile riportarvelo con uno sforzo d’attenzione)
e inconscio (ciò che è stato radicalmente rimosso e tende stabilmente a rimanere tale). La
seconda topica è sicuramente più feconda. Essa presenta la seguente suddivisione della
psiche: l’Es, il Super-io e l’Io. L’Es, pronome tedesco di genere neutro, corrispondente al
nostro “esso”, è la parte pulsionale della personalità (→ Pulsione), la quale obbedisce al
principio del piacere e ignora le condizioni limitative d’ordine fisico, le leggi della logica e
della morale. Il Super-io corrisponde a ciò che comunemente si chiama coscienza morale;
comprende i precetti e i divieti comportamentali assimilati attraverso un’identificazione con
l’adulto che presiede al processo educativo e che solitamente è la figura paterna, la cui
funzione il Super-io perpetua nella vita. All’Io compete il ruolo di organizzare la
personalità secondo il principio di realtà, che ci obbliga a tener conto delle istanze oggettive
della natura e della società. L’Io deve confrontarsi, in base al criterio dell’equilibrio e del
compromesso, con l’Es e il Super-io, cioè rispettivamente con le esigenze primordiali della
specie e con le esigenze della società e della civilizzazione. Quando questo equilibrio non è
più garantito e l’Es o il Super-io prevaricano, ci troviamo di fronte a situazioni variamente
patologiche e a forme di asocialità: se nel conflitto tra le opposte pretese l’equilibrio dell’Io
risulta incrinato, si configura un disturbo della personalità, che è denominato “nevrosi”; se
invece all’Io è tolto ogni spazio di autonomia e ogni capacità di mediazione, la sua stessa
personalità appare annullata e la condizione esistenziale presenta la gravità della “psicosi” o
follia.
4. L’importanza della sessualità e le fasi del suo sviluppo
Freud non identificò più la sessualità con la semplice genitalità, ma ne propose
un’interpretazione più ampia e complessa, attribuendola già al bambino fin dalla più tenera
età; ne analizzò lo sviluppo in fasi successive, che intervengono a realizzare di volta in
volta funzioni specifiche e parziali, le quali tuttavia tendono a integrarsi in un processo
unitario, che coinvolge progressivamente tutta la struttura psicofisica dell’individuo in
cammino verso la sua maturità. All’indirizzo di una consolidata tradizione culturale, che da
sempre si era compiaciuta di angelicarne la figura, Freud parlò provocatoriamente del
bambino come di “un essere perverso polimorfo”. Con ciò non intese tuttavia attribuire un
senso morale alla cosiddetta perversione, ma volle semplicemente evidenziare il fatto che
nel periodo iniziale della vita il fine della sessualità non è la riproduzione, ma il
conseguimento del puro piacere. Freud chiamò “libido” l’energia sessuale. Essa è in grado
di dirigersi verso le mete e gli oggetti più diversi. In particolare, lo sviluppo della sessualità
procede localizzandosi nelle “zone erogene”, così chiamate perché generano piacere. Il
padre della psicoanalisi distinse le seguenti fasi:
La fase orale (primo anno e mezzo di vita) è connessa all’importante funzione
psicofisica del succhiare.
184
S. Freud, L’interesse per la psicoanalisi, in Opere, cit., vol. VII, 1975, p. 258
181
La fase anale (fino al raggiungiungimento dei tre anni) è collegata all’attività della
defecazione, che è utilizzata dal bambino per attirare su di sé l’attenzione di chi lo
cura; egli, infatti, può dimostrare disponibilità o resistenza, concedendo o trattenendo
le feci.
La fase fallica è congiunta all’esplorazione del corpo proprio e altrui e
all’individuazione delle differenze di genere. A questo riguardo occorre rilevare
l’importanza simbolica che Freud dà al pene nell’analisi del “complesso di
castrazione”: la mutilazione dell’organo è avvertita come un’effettiva condizione di
frustrazione e invidia dalla bambina e come una minaccia dal bambino.
La fase di latenza interviene dopo il quinto anno e dura fino alla pubertà; essa
corrisponde ad un apparente arresto nello sviluppo della sessualità, perché l’interesse
per le attività sessuali sembra diminuire e compare il sentimento del pudore.
La fase genitale, che subordina allo scopo della generazione gli impulsi della libido,
insorge e matura con l’età puberale.
Connesso allo sviluppo della sessualità, in particolare alla fase fallica, è il cosiddetto
“complesso di Edipo”, che simbolicamente sembra riprodurre la vicenda, narrata dalla
tragedia greca antica, del personaggio destinato inconsapevolmente dal Fato ad uccidere il
padre e a sposare la madre. Esso descrive l’attaccamento amoroso e geloso del bambino nei
confronti del genitore di sesso opposto e l’ostilità verso il genitore di ugual sesso, visto
come un concorrente. Secondo la psicoanalisi la maniera con cui si svolge e si risolve
questa situazione è importante nella strutturazione della personalità e nell’orientamento del
desiderio. Ad essa si accompagna l’angoscia di castrazione, indotta dalla disapprovazione
degli adulti per l’interesse rivolto dal bambino alla parte genitale del corpo e per i suoi
desideri incestuosi. Se lo sviluppo attraverso le varie fasi è stato sufficientemente organico
e ordinato, l’individuo ha assimilato il divieto dell’incesto ed è pronto alla propria
socializzazione: i suoi desideri troveranno soddisfazione in un partner sessuale legittimo.
Qualora la dinamica evolutiva ora descritta non si sia positivamente compiuta, nel
soddisfare gli impulsi della libido si danno fenomeni anomali di “fissazione” o
“regressione” a stadi precedenti.
5. La civiltà: religione e cultura
Freud in Totem e tabù (1913) fece propria l’ipotesi darwiniana che gli uomini all’origine
vivessero in orde, ciascuna delle quali sarebbe stata controllata da un maschio, che avrebbe
avuto a sua esclusiva disposizione tutte le femmine e impedito ai giovani suoi figli di unirsi
ad esse, costringendoli a cercare eventuali compagne al di fuori di quel gruppo. Secondo il
nostro autore una coalizione di questi giovani figli avrebbe portato all’uccisione del padre,
quindi all’insorgenza di un senso di colpa collettivo e di un bisogno di espiazione, che li
avrebbe indotti a interiorizzare la proibizione precedentemente imposta dal genitore di
unirsi con le donne della propria orda. Così si sarebbe determinato il tabù dell’incesto. A
rappresentare la figura dell’antenato-padre, e con esso l’identità del gruppo, sarebbe stato
introdotto un simbolo totemico, cioè un animale o una pianta che ne avrebbe sostituito e
continuato la presenza. Per la sacralità che lo pervade il totem non può essere ucciso, se non
ritualmente nelle circostanze previste dal culto religioso.
La religione attirò l’attenzione di Freud soprattutto nella versione datale dall’ebraismo.
Dio per la comunità è l’oggettivazione amplificata dell’immagine ambivalente del padre,
temuto e insieme amato, cioè considerato nei ruoli tipici che gli sono attribuiti: la funzione
etica del Super-io (il Dio legislatore) e la funzione provvidenziale dell’essere potente e
buono, che assicura una felicità piena come premio dell’obbedienza accordatagli. La
dipendenza dalla figura paterna caratterizza la vita del credente come un protrarsi della
182
condizione infantile; egli, infatti, tende ad appagare in maniera illusoria i propri desideri,
rifiutando il principio di realtà. Così, per esempio, si esprime il nostro autore in L’avvenire
di un’illusione (1927): “Come sappiamo, la terribile sensazione di impotenza del bambino
ha fatto nascere in lui il bisogno di protezione - protezione tramite l’amore - cui il padre ha
provveduto; il riconoscimento che tale impotenza dura per tutta la vita ha causato il
perdurare dell’esistenza di un padre, questa volta più potente. Mediante il benigno governo
della Provvidenza divina, l’angoscia di fronte ai pericoli della vita viene placata”185.
Nello scritto Il disagio della civiltà (1929) Freud sostenne che gli uomini sono giunti alla
cultura, cioè a quell’insieme di prestazioni, tipicamente umane, che è costituito dalla
scienza, dall’arte, dalla filosofia e dalla religione, perché una soddisfazione indiscriminata
degli impulsi avrebbe compromesso la vita e il piacere di tutti. Perciò la civiltà comporta
inevitabilmente quel disagio che è connesso alla disciplina della nostra realtà pulsionale,
sessuale o aggressiva, e tuttavia in compenso offre sicurezza. Il pensiero freudiano sembra
riecheggiare quello di Hobbes. “L’uomo non è una creatura mansueta [...]; è vero invece
che occorre attribuire al suo corredo pulsionale anche una buona dose di aggressività. Ne
segue che egli vede nel prossimo non soltanto un eventuale soccorritore e oggetto sessuale,
ma anche un oggetto su cui può magari sfogare la propria aggressività [...] Homo homini
lupus: chi ha il coraggio di contestare quest’affermazione dopo tutte le esperienze della vita
e della storia? [...] Se la civiltà impone sacrifici tanto grandi non solo alla sessualità ma
anche all’aggressività, allora intendiamo meglio perché l’uomo stenti a trovare in essa la
sua felicità. Di fatto l’uomo primordiale stava meglio, poiché ignorava qualsiasi restrizione
pulsionale. In compenso la sua sicurezza di godere a lungo di tale felicità era molto esigua.
L’uomo civile ha barattato una parte della sua possibilità di felicità per un po’ di
sicurezza”186.
Rinunciando in parte al principio del piacere, possiamo rivolgere le energie psichiche così
sottratte agli impulsi verso scopi culturali. Freud descrisse questo processo come
“sublimazione”, nel senso che l’energia psichica viene deviata verso una meta non sessuale
e diretta ad oggetti socialmente apprezzati.
Nel periodo finale della sua attività, anche su sollecitazione delle minacce alla pace che si
andavano addensando in Europa e nel mondo, Freud orientò sempre più la propria
attenzione agli impulsi distruttivi presenti nell’uomo e nella storia, simbolicamente riassunti
in Thánatos (= morte) e contrapposti ad Eros. Questo dualismo pulsionale sembrò assumere
un significato quasi mitico.
6. La coscienza come compito
A conclusione di queste brevi note vogliamo rilevare nella teoria psicoanalitica la
compresenza problematica di due contrastanti aspetti: essa da un lato descrive il
determinismo imposto dalla parte inconscia e irrazionale della nostra psiche, dall’altro
attribuisce alla coscienza e al suo controllo la possibilità di affrontare con equilibrio,
positività e senso della misura le nostre pulsioni e le forze distruttive della convivenza
sociale. La soluzione dell’apparente contraddittorietà insita in questa situazione esistenziale
sta nel comprendere che la coscienza non è solo un dato, ma è soprattutto un compito.
Freud, come già Marx e Nietzsche, fu un distruttore della coscienza “falsa”, immediata e
illusa, che “fa resistenza a comprendersi”187, cioè ad accogliere quella verità su di sé che
S. Freud, L’avvenire di un’illusione, in Opere, cit., vol. X, 1978, p. 460
S. Freud, Il disagio della civiltà, in Opere, cit., vol. X, 1978, p. 602
187
P. Ricoeur, La psicanalisi e il movimento della cultura contemporanea, in Il conflitto delle interpretazioni, trad.
di R. Balzarotti, F. Botturi, G. Colombo, Jaca Book, 1977, p. 167
185
186
183
avverte come dolorosa per il proprio narcisismo, perché mette in discussione le sue
ingannevoli certezze. Così Ricoeur ha puntualizzatomesso a fuoco alcune riflessioni del
fondatore della psicoanalisi: “Di questa ‘resistenza’ alla verità Freud ha meravigliosamente
parlato in un testo famoso e citato di frequente: Una difficoltà della psicanalisi (1917). La
psicanalisi, dice Freud, è, in ordine cronologico, l’ultima delle ‘gravi umiliazioni’ che ‘il
narcisismo, l’amor proprio dell’uomo in generale, ha finora provato e che gli sono derivate
dall’investigazione scientifica’. Ci fu all’inizio l’umiliazione cosmologica, inflittagli da
Copernico, che distrusse l’illusione narcisista secondo cui l’abitacolo dell’uomo starebbe
fermo al centro delle cose. Poi fu l’umiliazione biologica, quando Darwin pose fine alla
pretesa dell’uomo di essere separato dal regno animale. Infine venne l’umiliazione
psicologica: l’uomo, che sapeva già di non essere né il signore del Cosmo né il signore dei
viventi, scopre di non essere il signore neppure della propria Psiche”188. Perciò la
psicoanalisi ha questa ambizione: liberare e rigenerare la nostra psiche, ampliando
dinamicamente la nostra coscienza. Sia Marx e Nietzsche sia Freud, dice ancora Ricoeur,
“cominciano col sospetto circa le illusioni della coscienza e continuano con l’artificio del
deciframento; tutt’e tre, da ultimo, lungi dall’essere detrattori della ‘coscienza’, mirano ad
una sua estensione”. In particolare “ciò che vuole Freud, è che l’analizzato, facendo proprio
il senso che gli era estraneo, allarghi il suo campo di coscienza, viva meglio e insomma sia
un po’ più libero, e, se possibile, felice. Uno dei primi omaggi resi alla psicanalisi parla di
‘guarigione attraverso la coscienza’. La parola è giusta, a condizione che si dica che
l’analisi vuole sostituire ad una coscienza immediata e dissimulante una coscienza mediata
e istruita dal principio di realtà”189.
7. La psicoanalisi oltre e dopo Freud
La psicoanalisi andò progressivamente dimostrando persuasività ed efficacia non soltanto
nella pratica terapeutica, ma anche nell’ambito più generale della cultura; tuttavia il
movimento psicoanalitico espresse ben presto una varietà di interpretazioni dei complessi
dinamismi psichici. In particolare citiamo i due più noti casi di “dissidenza” del secondo
decennio del secolo ventesimo: quelli di Alfred Adler e di Carl Gustav Jung, discepoli e
collaboratori di Freud, che rifiutarono di riconoscere la centralità data dal maestro alla
sessualità e alle sue dinamiche nella formazione della personalità e proposero teorie
alternative. Le loro interpretazioni assunsero anche nuove denominazioni: “psicologia
individuale” quella di Adler, “psicologia analitica” o “psicologia del profondo” quella di
Jung. Secondo Alfred Adler la causa fondamentale delle nevrosi è da ricercare nella
pulsione aggressiva e nelle sue manifestazioni come volontà di potenza. Secondo Carl
Gustav Jung l’energia psichica (libido) non si caratterizza necessariamente in senso
sessuale, ma può assumere una pluralità di qualificazioni a seconda gli ambiti di attività in
cui si esprime. Per lui, poi, accanto ad un inconscio personale, esiste un “inconscio
collettivo”, depositario di “archetipi”, cioè di immagini primordiali e simboli universali,
comuni a tutta la specie umana, anche se variamente recepiti dalle diverse culture,
soprattutto nel loro immaginario religioso. Essi riguardano, per esempio, la nascita, la
morte, la madre, il padre, l’amore, Dio, la guerra e la pace. Jung fu attratto dallo
spiritualismo delle religioni orientali e dall’esoterismo.
Lo stato della psicoanalisi appare oggi alquanto problematico, soprattutto perché i grandi
cambiamenti storici contemporanei hanno indotto dinamiche complesse e nuove, alle quali
sono connesse patologie che non ricalcano più quelle che erano rilevate da Freud nella
188
189
ibidem. Questo tema Freud l’aveva già evidenziato nell’Introduzione alla psicoanalisi (1915).
P. Ricoeur, op. cit., p.166
184
Vienna di fine Ottocento. Sembra, pertanto, ovvio chiedersi che cosa rimane vitale della
teoria freudiana. A questo proposito è appropriata la seguente osservazione di U.
Galimberti190: “È questa una domanda legittima, ma che forse vale solo per le scienze
esatte, dove verifiche oggettive e sperimentazioni sempre più approfondite consentono di
validare o invalidare una teoria. La psicoanalisi non è una scienza ‘esatta’, ma si inscrive
nell’ambito delle scienze ‘storico-ermeneutiche’. E questo perché la psiche è così solidale
con la storia da essere profondamente attraversata e modificata dallo spirito del tempo, che
è possibile cogliere e descrivere solo con l’arte dell’interpretazione o, come oggi si
preferisce dire, col lavoro ermeneutico. Questo spiega perché, a partire da Freud, si sono
sviluppati tanti percorsi interpretativi, approdati ad altrettante teorie psicoanalitiche, da cui
hanno preso avvio le diverse scuole. In comune esse hanno il concetto di ‘nevrosi’ che
Freud, dopo aver rifiutato di considerare la nevrosi una malattia del sistema nervoso come
voleva la medicina di stampo positivista in voga al suo tempo, ha trasferito dal piano
‘biologico’ a quello ‘culturale’”.
Volendo poi soltanto abbozzare un profilo analitico della psiche, storicamente adeguato
alla nostra attuale società, sempre U. Galimberti, richiamandosi a La fatica di essere se
stessi (ed. ital. Einaudi) del sociologo francese Alain Ehrenberg, afferma: “Dagli anni
Settanta in poi il disagio psichico ha cambiato radicalmente forma: non più il ‘conflitto
nevrotico tra norma e trasgressione’ con conseguente senso di colpa ma, in uno scenario
sociale dove non c’è più norma perché tutto è possibile, la sofferenza origina da un ‘senso
di insufficienza’ per ciò che si potrebbe fare e non si è in grado di fare, o non si riesce a fare
secondo le attese altrui, a partire dalle quali ciascuno misura il valore di se stesso”. Ne
consegue che “un fallimento in questa competizione generalizzata, tipica della nostra
società, equivale a una non tanto mascherata esclusione sociale”191. Non a caso la nevrosi
tipica dei nostri tempi si sviluppa sulla base di un’ossessiva “ansia da prestazione”. Essa si
esprime nella forma di un’apprensione tormentosa, che accompagna come uno sfondo
continuo la nostra quotidiana attività, dandoci la sensazione molesta di dover sempre
sostenere una prova e dar conto delle nostre capacità.
190
191
U. Galimberti, Quel che resta di Freud, in “la Repubblica”, 3 Gennaio 2010
ibidem
185
R
RELATIVITÀ
È la condizione di ciò che è relativo e non ha un valore assoluto. Nella tradizione filosofica
è stato evidenziato in particolare l’orientamento di coloro che, in opposizione al
dogmatismo, hanno sostenuto la relatività della conoscenza. A questo riguardo si vedano le
voci → Relativismo; Relazione; Assoluto
Nell’ambito della fisica si segnalano due importanti teorie, universalmente riconosciute,
secondo le quali in senso generale non si danno in natura osservatori e sistemi di
riferimento assoluti. Queste teorie fanno riferimento ai nomi di Galileo Galilei e Albert
Einstein.
La relatività galileiana
Tra gli argomenti di cui si servì Nicolò Copernico per suffragare la propria tesi c’è
un’interessante considerazione sulla percezione del moto, che è sempre relativa alla
condizione dinamica in cui si trova l’osservatore rispetto all’oggetto osservato. Copernico
infatti affermava: “Ogni movimento locale apparente avviene o perché si muove la cosa
vista o perché si muove colui che la vede o per un movimento, beninteso diverso, di
entrambi. Perché quando i mobili [cioè la cosa vista e lo spettatore] si muovono
uniformemente nella stessa direzione, il movimento non viene percepito. Ora, è dalla terra
che si scorge e viene presentato alla nostra vista quel circuito celeste. Se dunque un qualche
movimento spettasse alla terra, questo si riscontrerebbe, eguale, in tutte le cose che le sono
esterne, ma come se fossero trascinate in direzione opposta, come appare anzitutto per la
rivoluzione quotidiana”23.
Per completezza d’informazione va detto che, ancor prima di Copernico, il filosofo
francese Nicola di Oresme (1325-1382), sulla base di questa comune esperienza della
relatività del movimento, che può essere attribuito sia all’oggetto osservato che
all’osservatore, nel commento al De coelo di Aristotele aveva sostenuto la plausibilità
dell’ipotesi del moto rotatorio diurno della Terra.
L’indicazione di Copernico non poggiava, tuttavia, su una solida e analitica base
scientifica di meccanica generale e l’astronomo polacco ancora non ne derivava una sicura
contestazione delle tradizionali obiezioni tolemaiche all’ipotesi del moto della Terra.
Queste continuavano ad apparire del tutto convincenti al senso comune. Si riteneva infatti
che, stanti le dimensioni della Terra e la durata del giorno, l’ipotetico movimento della
Terra dovrebbe essere talmente rapido e impetuoso che i corpi che non poggiano su di essa,
per esempio le nubi, sembrerebbero procedere in senso opposto e non si vedrebbero i
proiettili e gli uccelli andare verso oriente, perché la Terra li anticiperebbe sempre in questa
direzione; i gravi, poi, non cadrebbero perpendicolarmente, ma subirebbero una deviazione
verso ovest.
La risposta risolutiva a simili obiezioni la diede Galilei con una teoria della relatività, che
da lui prende il nome. Tuttavia, a onor del vero va detto che prima di Galilei a opporre alle
obiezioni di Tolomeo la relatività del movimento era stato Giordano Bruno in una pagina
23
N. Copernico, Le rivoluzioni delle sfere celesti, in Opere, a cura di F. Barone, UTET, 1979, I, 5, p. 190
186
della Cena delle Ceneri, dove osservava: “Con la Terra [...] si muoveno tutte le cose che si
trovano in terra”, per cui non c’è modo di accorgersi del suo movimento, restando su di
essa. Avviene la stessa cosa quando “alcuno che è dentro la nave gitta per dritto una pietra:
quella per la medesima linea ritornerà a basso, muovasi quantosivoglia la nave, pur che non
faccia degl’inchini”, cioè dei moti di beccheggio24. La ragione per cui Galilei, nell’esporre
la propria teoria, non citò Bruno, dal quale sembra derivare l’esempio della nave, è
facilmente individuabile nel tragico destino occorso al filosofo di Nola.
L’esposizione di Galilei è presente in una nota pagina del Dialogo sopra i due massimi
sistemi del mondo. La sua teoria può essere così sintetizzata: sulla base di osservazioni
compiute all’interno di un sistema, che non consente di poter riferirsi a qualcosa di esterno,
non è possibile stabilire se esso è in quiete o in moto rettilineo uniforme. Va colta la
connessione di questa teoria con il principio d’inerzia, che equipara la condizione della
quiete e quella del moto rettilineo uniforme. Così la presentò Galilei: “Rinserratevi con
qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate
d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti; siavi anco un gran vaso d’acqua, e
dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada
versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso; e stando ferma
la nave, osservate diligentemente la nave [...] Osservate che avrete diligentemente tutte
queste cose [...] fate muover la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur che il moto sia
uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in
tutti li nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina o
pure sta ferma: [...] le gocciole cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur
una verso poppa [...] E di tutta questa corrispondenza d’effetti [= conformità degli stati di
quiete e di moto rettilineo uniforme] ne è cagione l’esser il moto della nave comune a tutte
le cose contenute in essa ed all’aria ancora, che per ciò dissi io che si stesse sotto coverta;
che quando si stesse di sopra e nell’aria aperta [se, per esempio, si desse la possibilità di
osservare dalla terraferma in parallelo al percorso della nave] e non seguace del corso della
nave, differenze più e men notabili si vedrebbero in alcuni de gli effetti nominati”25.
Pertanto, se ammettiamo il moto di rotazione della Terra, noi non ce ne avvediamo, finché
facciamo parte del suo sistema di riferimento, perché ne condividiamo il movimento. Se poi
lasciamo cadere da una torre un oggetto, anch’esso partecipa allo stesso movimento di
traslazione, che non altera perciò il suo movimento di caduta, ma si compone con esso. È
come se i due diversi movimenti avvenissero in successione.
La relatività einsteiniana
La teoria della relatività speciale (1905) di Albert Einstein può essere considerata una
generalizzazione di quella galileiana, nel senso che la estende dai fenomeni meccanici a
quelli elettromagnetici. Inoltre spazio e tempo non sono più proprietà assolute del mondo,
ma relative all’osservatore: ogni sistema di riferimento ha il suo tempo e il suo spazio
particolari, dipendenti dal suo stato di moto. È opportuno ribadire che, contrariamente a
quanto talvolta si è inteso, la relativizzazione del tempo e dello spazio non significa una
relativizzazione di tutte le proprietà fisiche, perché la tesi della relatività dello spazio e del
tempo deriva invece proprio dalla tesi dell’invarianza delle leggi meccaniche ed
24
G. Bruno, Dialoghi italiani, a cura di G. Gentile (3a ed. a cura di G. Aquilecchia), Sansoni, 1958, pp. 116-117
G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, a cura di F. Flora, Rizzoli, 1959, pp. 228-229.
Galilei sembra non rendersi conto che il moto circolare della Terra non può essere propriamente un moto inerziale.
L’esattezza di questo rilievo, tuttavia, non impedisce che per le nostre ordinarie esperienze si possa in maniera
approssimativa considerare la Terra come un sistema inerziale.
25
187
elettromagnetiche, a cominciare da quella che riguarda la velocità della luce nel vuoto
rispetto a tutti i sistemi inerziali.
Un ulteriore aspetto della teoria einsteiniana del 1905, che ha avuto una grande
importanza negli sviluppi della fisica contemporanea, è costituito dalla tesi dell’equivalenza
tra massa ed energia.
Mentre quella del 1905 è limitata ai sistemi inerziali, la teoria della relatività generale del
1916 sostiene l’equivalenza di tutti i sistemi di riferimento, qualunque sia il loro stato di
moto, ai fini di una formulazione delle leggi generali della natura. Nell’elaborarla Einstein
si avvalse della geometria ellittica di B. Riemann, la cui maggior complessità rispetto a
quella euclidea è compensata dalla semplificazione che essa consente alla formulazione
delle leggi fisiche. Si profilano così rappresentazioni del mondo radicalmente nuove
rispetto alla tradizione. “Secondo il modello cosmografico del fondatore della teoria della
relatività, la materia si ‘incurverebbe’ su se stessa, per cui il mondo sarebbe illimitato ma
finito, simile ad una sfera illimitatamente percorribile, anche se finita. Di conseguenza,
mentre nel modello euclideo di spazio è possibile tracciare una retta che va all’infinito, nel
cosmo di Einstein una retta all’infinito tende a ripiegarsi su se medesima, dando origine ad
una sorta di circolo, tanto che un ipotetico viaggiatore dell’universo tornerebbe sempre al
punto da cui è partito”26.
RELIGIONE
Il termine latino religio è di derivazione incerta. Nella tradizione cristiana fin da Lattanzio
(Divinae institutiones, IV, 28) è fatto preferibilmente dipendere dal verbo religare, nel
senso che esso designa il legame di pietà che unisce l’uomo a Dio. Cicerone, invece, nel De
natura deorum (II, 28) indica il verbo relegere, assumendolo nel senso di “considerare con
diligenza” ciò che riguarda il culto della divinità. Il termine “religione” denota comunque
genericamente un insieme di credenze e di pratiche rituali, mediante le quali nei riguardi del
“divino” si intende esprimere una fede e l’ossequio del culto, ingraziarsi la sua potenza e
benevolenza e, nelle forme spiritualmente più elevate ed emotivamente esaltanti, farlo
oggetto della contemplazione mistica.
Nel moderno processo storico di differenziazione del sapere in una pluralità di discipline
particolari anche la religione è diventata una delle scienze umane, per lo più integrata
nell’ambito più generale dell’antropologia culturale e affrontata con un metodo di studio
che, pur non trascurando l’interesse storico, nel corso del Novecento si è dato
un’impostazione prevalentemente fenomenologica, orientata a cogliere nelle manifestazioni
religiose le specifiche strutture di senso che le caratterizzano in forme tipiche ed essenziali,
quali l’esperienza del sacro, la rappresentazione mitica, la percezione della trascendenza, la
mistica, la pietà, l’ascesi. I vari fenomeni religiosi, empiricamente osservati e analizzati,
sono in tal modo destinati ad una comparazione tematica. Tra gli autori che si sono
prodigati in questi studi menzioniamo il tedesco Rudolf Otto, l’olandese Gerardus Van der
Leeuw, il rumeno Mircea Eliade.
Nella concretezza dell’esperienza storica la religione si è sempre presentata come qualcosa
di complesso, corrispondente ad una varietà di motivazioni teoretiche e pratiche. Essa,
infatti, ha cercato di soddisfare in forme per lo più fantasiose (i miti) un fondamentale
bisogno di conoscenza, orientato a diradare l’originaria ignoranza delle cause dei fenomeni
26
N. Abbagnano, G. Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, Paravia, 1999, vol. B/1, p. 124
188
naturali, e si è prodigata ad alleviare l’angoscia esistenziale indotta dalla prospettiva della
morte. Ha svolto, poi, la funzione di assicurare, mediante la sacralità delle norme, un ordine
sociale, rafforzando la coesione interna della comunità che la esprimeva. Politicamente ne
hanno fatto spesso un uso interessato i pubblici detentori del potere, riducendola così ad
instrumentum regni (strumento del potere).
Nell’ambito della riflessione filosofica autori quali F.D.E. Schleiermacher e S.
Kierkegaard hanno identificato l’elemento costitutivo e specifico della religione, in quanto
esperienza vissuta, rispettivamente nel sentimento di dipendenza dall’Infinito e nella fede
nell’Assoluto. In particolare Schleiermacher ha rimarcato con vigore l’esigenza di non
confondere la religione con una forma di sapere metafisico e nemmeno con un insieme di
norme morali; per Kierkegaard la fede nell’Assoluto va intesa come un’adesione non
speculativa, ma esistenziale al mistero cristiano, razionalmente scandaloso e paradossale.
(→ Romanticismo).
Tra le distinzioni concettuali storicamente più ricorrenti c’è quella tra religione “naturale” e
religione “positiva”: similmente all’analoga distinzione riguardante il diritto (→
Giusnaturalismo; Positivismo giuridico), anche questa intende identificare la prima con un
ipotetico e ideale prodotto della sola ragione umana universalmente considerata (→
Deismo) e la seconda con la prassi effettiva vigente presso i vari popoli. Talora invece alla
religione “naturale” si contrappone la religione “rivelata”, che rivendica la propria
autenticità sulla base di un’autonoma e gratuita rivelazione di Dio, reperibile in libri sacri,
quali la Bibbia per l’ebraismo e il cristianesimo e il Corano per l’islamismo.
Le credenze religiose hanno sempre avuto ovvie connessioni con la problematica filosofica,
risentendo inevitabilmente delle contrastanti soluzioni date alle questioni della metafisica.
A questo proposito si considerino le seguenti voci tematiche: → Dio; Assoluto; Infinito;
Teismo; Deismo; Enoteismo; Panteismo; Antropomorfismo; Mito e filosofia; Metafisica;
Fede e fideismo; Teologia; Teologia apofatica; Mistero; Alienazione; Ateismo;
Agnosticismo; Cristianesimo e filosofia
RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
Con il termine “rivoluzione” oggi solitamente ci si riferisce ad un radicale mutamento
sociale, politico o culturale, ma in origine con la parola latina “revolutio” non s’intendeva
alcunché di traumatico, perché essa riguardava il moto circolare dei corpi celesti, cioè un
moto che è sempre uguale a se stesso nella sua ricorrente ciclicità. Pertanto il titolo
dell’opera più importante di Nicolò Copernico De revolutionibus orbium coelestium (1543)
non aveva in sé alcuna intenzione “rivoluzionaria”, riguardando letteralmente “i moti
circolari delle sfere celesti”. Tuttavia, quest’opera fu rivoluzionaria nei suoi effetti,
nonostante permanessero nella sua elaborazione aspetti tradizionali, che impedivano una
teorizzazione astronomica integralmente nuova. Pensiamo in particolare all’assiomaticità
con la quale continuava a ritenere che i moti celesti si svolgessero in maniera rigorosamente
circolare: fin dall’antichità solo il cerchio sembrava in grado di giustificare, per la sua
perfezione, la regolarità dei fenomeni celesti nei loro ricorsi. L’irrigidirsi acriticamente su
questa concezione contribuì a far sì che l’operazione copernicana non riuscisse a soddisfare
l’attesa di una maggior semplicità nella descrizione dell’universo, perché Copernico dovette
ancora ricorrere, come già avevano fatto i tolemaici, ai tradizionali artifici geometrici,
costituiti dagli epicicli e dai deferenti (→ Economia, Principio di). A consentire il
189
superamento dello stallo teorico fu il tedesco Giovanni Keplero, che introdusse il moto
ellittico, elaborando su di esso le tre leggi che portano il suo nome, dalle quali poi Newton
derivò la legge della gravitazione universale. Inoltre, a rompere davvero le barriere di un
universo limitato, qual era ancora quello copernicano, furono l’intuizione metafisica di
Giordano Bruno e la concezione matematistica dello spazio di Renato Cartesio. Nonostante
questi limiti, Copernico inaugurò la rivoluzione scientifica moderna, che tra la metà del
secolo XVI e l’inizio del XVII, cioè tra la sua epoca e quella di Isaac Newton, riguardò non
solo l’astronomia, ma i concetti fondamentali e generali della fisica, così come, a partire da
Galileo Galilei, lo stesso metodo della ricerca. → Metodo sperimentale, Formazione del;
Fisica antica e fisica moderna
Per l’importanza delle conseguenze e la generalità degli obiettivi, questa rivoluzione
divenne paradigmatica nello studio storico della scienza, soprattutto in riferimento alle
svolte epistemologiche che inevitabilmente intervengono nel corso del tempo. Pertanto si è
soliti qualificare come rivoluzionarie per la biologia del XIX secolo la teoria
evoluzionistica di Charles Darwin e per la fisica del XX secolo la teoria della relatività di
Albert Einstein. A questo riguardo un classico dell’epistemologia è La struttura delle
rivoluzioni scientifiche (1962) di Thomas Kuhn. Egli rilevò nella storia della ricerca
scientifica un’ordinaria resistenza al cambiamento delle tradizionali teorie, che
costituiscono la scienza “normale”. Le anomalie empiriche e concettuali, nelle quali prima
o poi una teoria incorre nel corso del tempo, non inducono troppo facilmente a mutarla.
Agisce per lo più la riluttanza ad elaborare teorie nuove. Una rivoluzione scientifica
interviene solo quando le anomalie diventano talmente numerose e importanti da rendere
evidente l’inefficienza della teoria tradizionale. Essa mette fine ad un periodo di profonda
incertezza: si abbandonano i vecchi “paradigmi”, ossia i tradizionali modi di interpretare i
fenomeni, praticare la ricerca, elaborare e trasmettere il sapere, per adottarne di nuovi. Il
passaggio da un paradigma ad un altro costringe a vedere il mondo in maniera
completamente nuova, come avviene in una “conversione” religiosa. Le osservazioni
empiriche, infatti, assumono significati differenti nei diversi contesti teorici che le
interpretano. In questo senso i nuovi paradigmi impongono un radicale riorientamento
gestaltico dei fenomeni osservati. → Scienza (Thomas Kuhn: normalità e rivoluzione nella
scienza); Paradigma; Gestaltpsycologie
190
S
SAPIENZA
L’originario termine latino sapientia ha la sua radice nel verbo sàpere, il cui significato
primo è quello di “aver sapore”. Anche “sapiente” (participio presente di sàpere) e “saggio”
o “savio” (dal tardo latino sapidus, da cui sapius) hanno la stessa dipendenza etimologica.
L’uso metaforico di tutte queste voci implica un evidente giudizio di valore.
In greco e nel latino classico sono linguisticamente diversi i corrispondenti termini σοφία
(sophía) e sapientia (sapienza) dai termini φρόνησις (phrónesis) e prudentia (saggezza);
non altrettanto distinto e costante è il significato che i vari autori attribuiscono loro nell’uso
che ne fanno. Invece sia il greco σοφός (sophós) che il latino sapiens sono
indifferentemente il saggio o il sapiente.
Aristotele
Nella filosofia antica solo Aristotele distinse nettamente la sapienza (sophía) dalla saggezza
(phrónesis). Egli considerò la sapienza come la più nobile delle virtù dianoetiche, che sono
connesse all’esercizio della ragione teoretica. Essa unisce in sé l’intelligenza, cioè la
conoscenza dei principi, e la scienza, cioè il sapere dimostrativo, ed è rivolta alla realtà più
eccelsa, che è quella divina. Il suo esercizio coincide, pertanto, con la “filosofia prima” o
“teologia”, cioè con la metafisica. → Saggezza; Metafisica
Secondo Aristotele la perfetta attività teoretica è disinteressata e libera; in quanto tale,
realizza la forma superiore di vita a cui si possa pensare. In grado eminente essa è propria
di Dio, che è νόησις νοήσεως (nóesis noéseos), cioè “pensiero del pensiero”. Il suo
esercizio ci assimila a lui, assicurandoci una vera beatitudine. Infatti “noi immaginiamo che
gli dei siano sommamente beati e felici” e che l’attività più consona alla loro natura sia la
contemplazione; “quindi anche tra le attività umane quella che è più congenere a questa,
sarà quella più capace di render felici. Prova di ciò è anche il fatto che gli altri esseri viventi
non partecipano della felicità, poiché sono completamente privi di questa attività. Invece
per gli dei tutta la vita è beata, e per gli uomini lo è in quanto vi è in essi un’attività simile a
quella […] Per quanto dunque s’estende la speculazione, di tanto s’estende anche la
felicità”9. E quale può essere l’espressione più alta dell’attività teoretica, se non “la
contemplazione di dio”?10
Il tardo periodo ellenistico
Nel tardo periodo ellenistico, in coincidenza con la diffusione di una forte sensibilità
religiosa e mistica, il tema della sapienza, intesa specificamente come virtù teoretica rivolta
alla contemplazione della realtà divina, assunse una nuova rilevanza.
Nelle Enneadi Plotino identifica la Sapienza con il Noûs, il divino Intelletto e seconda
ipostasi: essa è eterna e creatrice11, perché contiene in sé i modelli ideali degli enti, le cui
9
Aristotele, Etica nicomachea, X (K), 8, 1178 b 8, 23-30, trad. di A. Plebe, in Opere, a cura di G. Giannantoni,
Laterza, 1973, vol. 7, p. 267
10
Aristotele, Etica Eudemia, VIII (Θ), 3, 1249 b,17, trad. di A. Plebe, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza,
1973, vol. 8, p. 192
11
Plotino, Enneadi, V, 8, 4
191
forme poi l’Anima, assumendo l’aspetto della phýsis (natura), immette nella materia. Per
l’uomo l’accesso alla sapienza è possibile mediante la filosofia e soprattutto nell’esperienza
mistica dell’estasi, che ci mette in immediato contatto con il divino. → Estasi; Teologia
apofatica; Misticismo; Teosofia
La sapienza cristiana
Della Sapienza parlano i testi biblici denominati sapienziali: i Proverbi, il Siracide e la
Sapienza. Essi la ritraggono in forma personificata, identificandola con Dio creatore e
salvatore, che per mezzo di essa si rivela agli uomini. Nel prologo del Vangelo di Giovanni
la Sapienza divina è ormai perfettamente identificata con il Lógos, il Verbo divino che in
Gesù Cristo “si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”.
La sapienza cristiana entrò in tensione con la filosofia greca. Ciò avvenne in particolare
con San Paolo, che nel primo capitolo della prima lettera ai Corinti contrappose con
orgoglio alla sapienza degli uomini l’apparente e scandalosa insipienza di “Cristo
crocifisso”, la cui grandezza può rivelarsi solo a chi ha fede.
A proposito dei rapporti tra filosofia e fede si invia alle voci → Fede e cristianesimo;
Fede e fideismo
Sant’Agostino
Sant’Agostino assimilò a fondo sia lo spirito neoplatonico che la dottrina biblica.
Analogamente a Plotino egli descrisse il processo della conoscenza come un’ascesa verso la
realtà eterna e trascendente; tuttavia ritenne di dover superare decisamente il modello
pagano, convinto com’era che l’uomo necessiti della grazia illuminante di Dio, alla quale
può rendersi disponibile mediante la fede. Il credente è diretto e accompagnato dalla verità
del Lógos incarnato, Gesù Cristo, e può constatare che la conoscenza dimostrativa di ciò
che avviene nel tempo, cioè la scienza, diventa “sapienza” quando mediante la fede si volge
al mistero divino, che comprende in sé anche il destino ultimo dell’uomo, acquisendone un
superiore livello di intelligenza. È questo il senso delle formule agostiniane: “tendimus per
scientiam ad sapientiam” (per mezzo della scienza tendiamo alla sapienza) e “intellectus
fidei” (l’intelligenza applicata a ciò che si crede)12.
Tommaso d’Aquino
Tommaso d’Aquino realizzò una perspicua sintesi tra il pensiero aristotelico e la sacra
doctrina cristiana, cioè la verità rivelata. Anche per lui, com’era per il grande filosofo
greco, la sapienza coincide con la metafisica, la quale congiunge in sé l’intellectus
principiorum, cioè il sapere intuitivo che riguarda i principi, e la scientia conclusionum,
cioè il sapere dimostrativo. Perciò “la sapienza è una scienza, perché ha ciò che è comune a
tutte le scienze, così da poter dimostrare le conclusioni dai loro principi; ma, poiché ha
qualcosa che le è proprio ed è superiore alle altre scienze, che la mette in grado di
giudicarle tutte, non solo quanto alle conclusioni, ma quanto ai primi principi, così essa è in
grado di giustificare la sua virtù, che è più perfetta di quella di una semplice scienza” 13.
Come per Agostino e per San Paolo, anche per Tommaso la sapienza del credente è di
livello superiore a quella che può fornire la ricerca filosofica, perché dipende dalla grazia
divina; in essa, infatti, è riconoscibile un dono dello Spirito Santo14.
Sant’Agostino, De Trinitate, XIII, 19, 24. vedi: G. Söhngen, La sapienza della teologia sulla via della scienza,
in Mysterium salutis, a cura di J. Feiner e M. Löhrer, Queriniana, 1968, vol. 2, p. 582
13
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 57, art. 2 c, ad primum
14
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 1, art. 6
12
192
SCETTICISMO
Questo termine deriva dal greco σκέψις (sképsis), che talora è reso nella nostra lingua con
“scepsi” e significa “esame”, “ricerca”, quindi anche “indugio” determinato dall’esitazione.
In senso generale lo scetticismo è l’atteggiamento di chi è nel dubbio e non ha modo di
uscirne, perché non gli sembrano convincenti le ragioni dei “dogmatici”, i quali ritengono
che la verità sia accessibile. → Dubbio
Secondo la testimonianza di Diogene Laerzio15, gli antichi filosofi d’indirizzo scettico
erano variamente denominati: oltre a “scettici” (σκεπτικοί, skepticói), perché erano intenti
ad un’indagine senza fine, destinata a non portare risultati positivi, erano, in senso analogo,
chiamati “zetetici” (ζητητικοί, zetetikói), cioè incessantemente “orientati alla ricerca”,
perché intendevano comprovare la loro convinzione che la verità non è alla portata degli
uomini; oppure erano qualificati come “aporetici” (ἀπορητικοί, aporetikói), cioè dubitanti o
problematici, o anche come “efettici” (ἐφεκτικοί, efectikói), perché in tutte le questioni
praticavano la sospensione del giudizio, cioè l’ἐποχή (epoché), termine che insieme
aἐφεκτικός deriva dal verbo ἐπέχω (epécho), che significa “mi fermo”, “indugio”.
Storicamente lo scetticismo ebbe varie espressioni nel mondo antico, in particolare
nell’ambito dell’ellenismo. Fu rappresentato innanzitutto da Pirrone di Elide (IV-III sec. a.
C.). Influenzò anche l’Accademia platonica, quando tra il III e il II sec. a. C. vi insegnarono
Arcesilao di Pitane e Carneade di Cirene. → Platonismo
Esponenti dello scetticismo furono poi Enesidemo di Cnosso (II-I sec. a. C.), Agrippa (I
sec. a. C.) e, qualche secolo dopo, Sesto Empirico (II-III sec. d. C.), che è la fonte più
importante della nostra conoscenza su tutto lo scetticismo antico.
Le critiche degli scettici contro i dogmatici sono raccolte in una serie di “tropi”, cioè di
argomentazioni dialettiche, che a loro giudizio giustificano la “sospensione del giudizio” o
epoché. → Tropo; Epoché
Sesto Empirico si preoccupò di rispondere ai dogmatici, i quali ritorcevano sullo stesso
scetticismo l’accusa di essere una forma di inconsapevole dogmatismo, dal momento che lo
scettico è certo della propria verità. Lo scettico, inoltre, si contraddice, perché
“l’espressione ‘tutte le cose sono false’ afferma insieme con la falsità di tutto il resto anche
la falsità di se stessa”. Sesto Empirico ribatté dichiarando che lo scettico non si contraddice
affatto, perché si attiene semplicemente ai “fenomeni”, cioè “esprime quello che a lui
appare [...] senza asseverazioni dogmatiche, nulla categoricamente affermando circa le cose
che sono fuori di lui”. Dunque, “criterio dell’indirizzo scettico è il fenomeno”, che regola
l’opinare e l’agire (→ Fenomenismo). Ciò che lo scettico intende conseguire è
“l’imperturbabilità”, perché, diversamente dai dogmatici, “chi dubita se una cosa sia bene o
male per natura, né fugge né persegue nulla con ardore: perciò è imperturbato”16. →
Atarassia
15
16
Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 70
Sesto Empirico, Schizzi pirroniani, I, 13, 21, 22, 25, tr. di O. Tescari, Laterza, 1988, pp. 4-10
193
SCIENZA
Fin dalle origini la filosofia greca ha attribuito al lógos l’ordine della natura. Di esso
Eraclito afferma: “Questo lógos governa tutte le cose”17. L’ordine si rivela nella regolarità
degli eventi, di cui la scienza intende dare una corretta rappresentazione, facendo emergere
le cause. Soltanto l’individuazione delle cause può soddisfare il desiderio di conoscere, che
sempre ci accompagna e non s’accontenta di semplici constatazioni, ma cerca spiegazioni.
Per Platone sono “epistéme” sia la “diánoia” sia, soprattutto, la “nóesis”, che si realizza
nella dialettica
Platone oppone l’ἐπιστήμη (epistéme), cioè la scienza, alla δόξα (dóxa), cioè all’opinione.
Configura la scienza mediante questa domanda retorica: “Per sua natura la scienza non ha
per oggetto ciò che è, ossia conoscere come è ciò che è?” E dell’opinione afferma che è
“qualcosa di intermedio tra l’ignoranza e la scienza”18.
A Menone, nell’omonimo dialogo, Socrate dichiara che “anche le opinioni vere”, quelle
che ci sono più care e si dimostrano “capaci di realizzare tutto il bene possibile”, sono come
le statue del mitico Dedalo, che parevano vive e davano l’impressione di non poterle
trattenere né di possederle davvero. Esse, infatti, “non acconsentono a rimanere per lungo
tempo, e fuggono via dall’anima umana, per cui non hanno un gran significato, a meno che
non s’incatenino con un ragionamento fondato sulla causalità. Ma proprio in questo,
compagno Menone, consiste l’anamnesi, quella reminiscenza su cui sopra ci siamo
accordati. Se collegate, esse dapprima divengono scienza e, quindi, cognizioni stabili. Ecco
perché la scienza vale più della retta opinione: la differenza tra scienza e retta opinione sta,
appunto, nel collegamento”19, cioè nella connessione causale con l’idea, che rende
definitivamente stabile la mobilità dell’opinione, distruggendola come tale e trasformandola
in scienza. È la scienza che può giudicare se un’opinione è vera o falsa. Finché è opinione
retta e vera quel che uno pensa, anche il comportamento tende ad essere corretto, tuttavia,
“credendo d’esser nel vero, ma senza averne l’intelligenza”20, egli non ne può dare una
ragione definitiva e soddisfacente.
Platone è convinto che l’uomo viva in una condizione intermedia tra l’ignoranza e la
conoscenza, che lo impegna in una ricerca problematica, cioè nel percorso ascensivo dalla
dóxa all’epistéme, nel quale spesso ci dobbiamo accontentare della πίστις (pístis), cioè della
“credenza”, che evidenzia i nostri limiti. L’intelligenza, infatti, quando produce lo sforzo
più intenso oltre la phýsis (natura) è nella fede ed è consapevole di essere in un qualche
rapporto con la verità, che, peraltro, non può dominare, ma soltanto evocare indirettamente
mediante il mito, cioè con un discorso verosimile. Sono epistéme, invece, sia la διnάοια
(diánoia) che la νόησις (nóesis). La diánoia è la conoscenza razionale discorsiva, propria
dei matematici, i quali partendo da ipotesi, cioè da posizioni ammesse come vere,
sviluppano passaggi coerenti e progressivi, per giungere ad una conclusione necessaria. La
nóesis è l’intellezione, con la quale il filosofo, risalendo dialetticamente attraverso le
connessioni esistenti tra le cose e le idee e tra le idee stesse, intende conseguire una scienza
perfetta, non più condizionata da ipotesi, ma diretta ad individuare un principio che non sia
ulteriormente problematico, cioè che non richieda altre spiegazioni. La nóesis è in grado di
cogliere nel Bene il principio assoluto, al vertice del mondo ideale e perfetto.
Eraclito, I Presocratici, Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1975, “Frammenti”, 72,
p. 212
18
Platone, La Repubblica, V, 477 a-b, in Opere complete, cit., vol. 6, p. 200
19
Platone, Menone, 97 e - 98 a, trad. di F. Adorno, in Opere complete, cit., vol. 5, p. 301
20
ivi, 97 b, p. 300
17
194
Di tutto ciò Platone parla nel sesto e nel settimo libro della Repubblica. Egli è convinto
che il mondo sensibile non abbia in sé la spiegazione dei problemi che suscita, perché non è
la causa di se stesso; invece i più tra gli uomini, “brancolando come nel buio”, s’illudono di
trovare le vere cause là dove non possono essere, “ma quel potere onde cielo e terra si
trovano oggi disposti come fu possibile un giorno fossero disposti nel modo migliore,
codesto potere né lo ricercano essi né credono abbia alcuna sua forza divina [...] e ciò che è
il bene, che è ciò che lega ogni cosa al suo fine, non pensano affatto”. Occorre, perciò,
“mutare modo di navigazione”21, cioè affidarsi ad una ricerca superiore e più impegnativa
di una semplice “fisica”, perché ambisce ad andar oltre la “phýsis”, cioè la natura. Platone
la chiama “dialettica” e alcuni secoli dopo di lui sarà più comunemente detta “metafisica”.
Aristotele la denomina “filosofia prima”.
Aristotele: anche della natura è possibile una vera scienza; la scienza è sempre
dell’universale
A questo proposito le convinzioni epistemologiche di Aristotele divergono da quelle del
maestro, perché anche della natura ritiene possibile una vera scienza. Con sistematicità
organizza la filosofia come l’enciclopedia del sapere, che comprende le scienze teoretiche,
destinate a soddisfare il puro desiderio di conoscere, le scienze pratiche, il cui fine è l’agire,
e le scienze poietiche, orientate alla produzione artistica e tecnica. La filosofia è scienza in
senso proprio, perché non s’accontenta della constatazione dei fatti e della registrazione dei
dati, ma cerca d’individuare le cause. La scienza, per Aristotele, è in senso eminente
l’esercizio della capacità dimostrativa: con un termine di origine greca possiamo dire che è
“apodittica” (→Apodittico / Anapodittico). Essa ha per oggetto ciò che è necessario, ossia
di ciò che non può essere diverso da quello che è, e si identifica con quel sapere razionale
che, nell’evidenziare le cause e i principi, è caratterizzato da incontrovertibilità e certezza22.
Dal punto di vista logico la capacità dimostrativa del sillogismo si evidenzia nella
coerenza del procedimento deduttivo, cioè nella correttezza formale che lo rende valido, ma
non necessariamente vero. La scienza, però, richiede anche la verità dei suoi asserti, cioè la
loro corrispondenza con ciò che è. Pertanto, “sarà necessario che la scienza dimostrativa si
costituisca sulla base di premesse vere, prime, immediate, più note della conclusione,
anteriori ad essa, e che siano cause di essa”23. Aristotele osserva, infatti, che “è impossibile
che ci sia dimostrazione di tutto: in tal caso si procederebbe all’infinito, e in questo modo,
per conseguenza, non ci sarebbe affatto dimostrazione”24. Quindi l’avvio della
dimostrazione non può essere una dimostrazione, ma deve avvalersi di principi anapodittici
(non dimostrabili), la cui validità il nostro intelletto coglie per via intuitiva, cioè in maniera
immediata. In conclusione, “l’intuizione dovrà essere il principio della scienza”25.
Secondo Aristotele, l’intuizione intellettiva interviene sia nell’induzione (ἐπαγωγή,
epagoghé) che nell’astrazione (ἀφαίρεσις, apháiresis). L’una e l’altra, infatti, si
configurano come un’identico processo logico, con il quale l’intelletto coglie “l’unità al di
là della molteplicità”, rendendo mentalmente universale l’essenza di una cosa, ossia ciò che
è “uno e identico in tutti gli oggetti molteplici”, potendola così applicare, come concetto e
21
Platone, Fedone, 99 b-d, trad. di M. Valgimigli, in Opere complete, cit., vol. 1, pp. 164 s.
v. Aristotele, Etica nicomachea, Z 3, 1139 b 18 ss.
23
Aristotele, Secondi analitici, I (A), 2, 71 b 25, trad. di G. Colli, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza,
1973, vol. 1, p. 262
24
Aristotele, La metafisica, , 4, 1006 a 7-9, a cura di G. Reale, Loffredo, 1968, I, p. 299
25
Aristotele, Secondi analitici, II (B), 19, 100 b, 13-15, cit., p. 373
22
195
come “principio della scienza”, alla pluralità delle sostanze individuali, nelle quali noi la
riconosciamo ontologicamente presente26.
La realtà individuale è, in quanto tale, intellettivamente inesprimibile: “Se non esistesse
nulla al di fuori delle cose singole, non ci sarebbe nulla di intelligibile, ma tutto quanto
sarebbe sensibile, e di nulla vi sarebbe scienza, a meno che non si volesse sostenere che la
sensazione è scienza”. Pertanto “delle sostanze sensibili particolari non c’è né definizione
né dimostrazione, in quanto hanno materia, la cui natura implica la possibilità di essere e di
non essere”. In quanto tali, gli enti particolari sono “ciò che può essere diversamente da
come è”, cioè sono contingenti e non necessari. Quindi “la scienza è sempre
dell’universale”. Questo intenderanno dire anche gli Scolastici medioevali con la formula:
“Scientia non est de singularibus” (non c’è scienza dei singoli dati empirici)27. →
Astrazione; Induzione; Definizione; Principio; Assioma; Postulato; Deduzione; Sillogismo
Questa posizione impedisce ad Aristotele di accedere ad un’adeguata considerazione
epistemologica della storia, nonostante che già con Erodoto e poi soprattutto con Tucidide i
Greci avessero impostato la storiografia come una specifica interpretazione causale delle
vicende umane. Aristotele, infatti, afferma che la storia, poiché è rivolta a ciò che è
“particolare”, è inferiore alla stessa poesia, che “è qualche cosa di più filosofico”, perché
“tende piuttosto a rappresentare l’universale”28. → Storia, Filosofia della
L’epistemologia medioevale
Nel Medioevo si tende a disporre gerarchicamente il sapere, orientandolo verso la sacra
doctrina, cioè la scienza delle cose divine, rivelate da Dio mediante le Sacre Scritture e
sistemate dogmaticamente nella dottrina della Chiesa. Pertanto la teologia è la regina delle
scienze e queste rispetto ad essa sono ancillae; lo è in particolare la filosofia prima o
metafisica. Il filosofo nella sua ricerca sa già dove arrivare, perché, secondo la tradizione
dei Padri della Chiesa, la vera filosofia è il cristianesimo stesso, che si regge sulla fede, ma
cerca di chiarire razionalmente i suoi contenuti. La fede, perciò, diventa inevitabilmente
teologia, cioè fede che richiede intelligenza: fides quaerens intellectum, secondo la formula
cara ad Anselmo d’Aosta, che compare nel titolo di uno dei suoi scritti più noti: Proslogion,
o Fides quaerens intellectum ed ispirata a sua volta da Sant’Agostino.
La riscoperta di Aristotele porta Tommaso d’Aquino ad assimilarne i fondamentali
elementi epistemologici. Anche per lui, infatti, l’intuizione intellettiva ci dà la percezione
immediata dei principi (intellectus principiorum), che poi la scienza sviluppa in forma
mediata o discorsiva con le dimostrazioni (scientia conclusionum). Egli è limpidamente
convinto della scientificità della sacra doctrina. Sulle tracce del grande filosofo greco
ritiene che le varie discipline, nelle quali si divide il sapere, costituiscano una gerarchia
organica, nel cui ambito si dispongono secondo un rapporto di subalternazione, tale per cui
una disciplina di grado inferiore accetta come propri principi le conclusioni della disciplina
dalla quale dipende29. In questo senso, anche la sacra doctrina “procede dai principi noti di
una scienza superiore”, cioè quella di Dio, in cui crediamo. Per questo aspetto essa è simile
alla musica, la quale si basa su principi che derivano dalla matematica, o, per riferirci ad un
esempio per noi più consueto, alla medicina, che si serve delle conoscenze predisposte dalla
biologia. Tuttavia la sacra doctrina è superiore a tutte le altre discipline umane, perché
“non riceve i suoi principi da esse, ma immediatamente da Dio per rivelazione”; invece “di
26
Aristotele, Secondi analitici, II (B), 19, 100 a 1-9, cit., p. 372
Aristotele, La metafisica, rispettivamente B, 4, 999 b, 1-3, cit., I, p. 247; Z, 15, 1039 b 28-29, cit., I, p. 555; B, 6,
1003 a 14, cit., I, p. 258. Vedi Tommaso d’Aquino, De veritate, q. 10, a. 4 e a. 5; Summa theologiae, I, q. 86, a. 1
28
Aristotele, Poetica, 9, 1451 b 6, trad. di M. Valgimigli, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973, p. 211
29
Si consideri, per esempio, ciò che dice Aristotele nell’Etica nicomachea, I, 1-2, 1094a-1094b.
27
196
esse si serve come ancelle” e “può accogliere qualcosa dalle discipline filosofiche, non
perché ne abbia strettamente bisogno, ma per rendere i suoi contenuti più evidenti (ad
maiorem manifestationem)”. La sua superiorità è connessa alla rassicurazione veritativa che
offre, perché “deriva la sua certezza dalla luce della scienza divina, che non s’inganna”30.
→ Teologia
R. Cartesio: la scienza richiede la rigorosa applicazione del metodo matematico
La filosofia continua per secoli ad essere considerata la scienza universale, strutturata nelle
sue varie parti. Così fa Renato Cartesio, che la configura “come un albero, di cui le radici
sono la metafisica, il tronco è la fisica e i rami che sorgono da questo sono tutte le altre
scienze”31. Tuttavia ne auspica un rinnovamento integrale, che si avvalga di un metodo
rigoroso di tipo deduttivo, le cui quattro regole egli deriva dalla matematica e pensa di poter
usare come strumento universale del sapere: si deve partire da una condizione di evidenza,
cioè da idee chiare e distinte; si procede poi, in direzione opposta e complementare,
mediante l’analisi e la sintesi, rispettivamente dal complesso al semplice (definizioni,
assiomi, postulati) e dal semplice al complesso; si conclude infine con una revisione che dia
la certezza di non aver omesso assolutamente nulla nei vari passaggi.
Nell’Ethica more geometrico demonstrata (L’etica dimostrata con procedimento
geometrico) Spinoza con rigorosa coerenza formale mette in atto questo ideale di mathesis
universalis. → Cartesianesimo; Evidenza e certezza; Matematismo
La scienza sperimentale moderna
Nell’età moderna assistiamo ad un importante cambiamento epistemologico della fisica,
dovuto in particolare a Galileo Galilei e perfezionato da Isaac Newton. Essi elaborano il
metodo sperimentale, che realizza un sistematico controllo empirico delle ipotesi e integra
in sé la matematica come strumento necessario a riprodurre con rigore la perfetta regolarità
degli eventi naturali. Infatti, per poter interpretare il mondo correttamente, secondo Galilei
bisogna saperlo “leggere”, nel senso che “la filosofia è scritta in questo grandissimo libro
che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può
intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è
scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure
geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi
è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto”32.
La fisica moderna si va costruendo in forme nuove e autonome dalla tradizione
metafisica. A questo riguardo Newton afferma il principio a cui si atterrà tutta la ricerca
successiva: Hypotheses non fingo (→ Ipotesi). Tuttavia l’inerzia del linguaggio tradizionale
porta lo stesso Galilei a denominarla ancora “filosofia naturale”; infatti, nell’accettare
l’insegnamento presso lo Studio di Pisa, pretende non più solo il titolo di matematico, ma
anche quello di “filosofo”, cioè di fisico. Anche nel 1687 Newton intitola così il suo
capolavoro: Philosophiae naturalis principia mathematica (I principi matematici della
filosofia naturale).
L’impostazione trascendentale di I. Kant
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 1, art. 2 c; art. 5 ad secundum, c
R. Cartesio, I principi della filosofia, Lettera-prefazione all’abate Picot, in Opere, a cura di E. Garin, Laterza,
1967, vol. II, p. 19
32
G. Galilei, Il Saggiatore, in Opere, ed. naz. diretta da A. Favaro, Barbera, 1890-1909, ristampa 1929-39, vol. VI,
p. 232
30
31
197
Il successo del metodo sperimentale e della nuova fisica fa sì che la tradizionale metafisica
incorra nel discredito testimoniatoci da Immanuel Kant. Nella prefazione alla Critica della
ragion pura egli osserva che, diversamente dal passato, in cui la metafisica era considerata
“la regina di tutte le scienze”, “ormai la moda del nostro tempo porta a disprezzarla”; nei
suoi confronti si va imponendo addirittura un “fastidio” e un apparente “totale
indifferentismo”. Tuttavia, precisa, questo fenomeno “non è per certo effetto di leggerezza,
ma del giudizio maturo dell’età moderna che non vuol più lasciarsi tenere a bada da una
parvenza di sapere, ed è un invito alla ragione ad assumersi nuovamente il più grave dei
suoi uffici, cioè la conoscenza di sé, e ad erigere un tribunale che la garantisca nelle sue
pretese legittime, ma condanni quelle che non hanno fondamento [...] e questo tribunale
altro non può essere se non la critica della ragion pura stessa”33. Le pretese infondate, a cui
qui allude Kant, sono appunto quelle della tradizionale metafisica.
Nei Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza (1783) Kant
pone il problema in termini radicali: “È possibile una metafisica?”. Per la matematica e la
fisica, invece, si chiede semplicemente “come” esse siano possibili; infatti, che lo siano è
dimostrato dalla loro effettiva realtà e dal generale consenso che le accompagna, mentre le
infelici condizioni della metafisica, ossia le contrastanti posizioni che da sempre la
caratterizzano, fa dubitare chiunque a ragione della sua possibilità; infatti “non si può
indicare un solo libro, così come si presenta un Euclide, e dire: questa è la metafisica”34.
Il criticismo kantiano si propone di rilevare i criteri di validità e legittimità di ogni sapere
che pretenda di costituirsi come scienza. L’epistemologia a cui dà luogo ha
un’impostazione “trascendentale”, nel senso che essa intende determinare le condizioni
universali e necessarie del conoscere, identificandole con le forme a priori delle nostre
facoltà teoretiche, cioè con le nostre originarie strutture mentali (→ Trascendentale).
Costretto ad adeguarsi ad esse, l’oggetto non può mai risultare nella sua assolutezza come
“cosa in sé”, ma diventa inevitabilmente un “fenomeno”, ossia la realtà in quanto appare a
noi (→ Fenomeno). È questa la dimensione empirica a noi accessibile. La “cosa in sé” resta
un’incognita, un puro “noùmeno”, ossia qualcosa che è semplicemente pensabile (come
dice il termine greco nooúmenon), ma la cui intelligibilità consiste in un concetto vuoto: in
quanto tale, esso non ci fa positivamente conoscere alcunché. La “cosa in sé” è una nozione
limite, che ci premunisce contro le illusorie pretese della tradizionale metafisica:
“trascendente”, la qualifica Kant, perché vorrebbe “sorpassare i limiti della esperienza
possibile” (→ Noùmeno). Egli contrappone alla vecchia una nuova metafisica “critica” e
“scientifica”, concepita come la scienza dei concetti puri e dei principi a priori del
conoscere e dell’agire, rispetto alla quale le sue Critiche sono soltanto una trattazione
propedeutica. → Metafisica
La scienza secondo G. Hegel e l’idealismo
Per Hegel la scienza, per essere tale, deve conseguire una dimensione “speculativa”. Con
questo termine egli qualifica in senso specifico il momento “positivo-razionale” della
razionalità dialettica, nel quale il pensiero, non più astratto, ma concreto, comprende
l’intero nella varietà delle sue determinazioni e nel perfezionamento del suo sviluppo (→
Dialettica; Concreto). Dovendo confrontarsi con la costruzione ormai matura della fisica
moderna, Hegel ne riconosce la funzione propedeutica al successivo impegno speculativo
della filosofia. Infatti “le scienze empiriche non se ne stanno al semplice percepire i
33
I. Kant, Critica della ragion pura, a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, riveduta da V. Mathieu, Laterza,
1971, Pref. alla Ia ediz., pp. 6-7
34
I. Kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica, a cura di P. Carabellese, riveduta da R. Assunto, Laterza, 1972,
§ 4, pp. 57-58
198
fenomeni singoli, ma, pensandovi intorno, elaborano la materia per porgerla pronta alla
filosofia, col trovare determinazioni generali, generi e leggi; e danno così a quel contenuto
del particolare la preparazione perché possa essere accolto nella filosofia. D’altra parte,
costringono per tal modo il pensiero a procedere esso stesso a queste determinazioni
concrete. L’accoglimento di questo contenuto, in cui per mezzo del pensiero vien superata
la persistenza immediatezza e il mero dato, è insieme uno svolgersi del pensiero da sé
stesso”. Perciò la vera scienza è realizzata dalla filosofia, quando diventa scienza dell’Idea
e dell’Assoluto e si fa sistema, perché “un filosofare senza sistema non può essere niente di
scientifico”35.
L’idealismo tenderà sempre a porre in una condizione d’inferiorità le scienze empiriche
rispetto alla speculazione filosofica. Benedetto Croce, in particolare, non riconoscerà ai loro
concetti un’autentica dignità teoretica. Li considererà “pseudoconcetti”, perché a suo
giudizio sono soltanto espressioni della funzione “economica”, rivolta all’utile, della vita
dello spirito, che nulla hanno a che vedere con il vero sapere.
L’epistemologia dell’empirismo e del positivismo
L’empirismo e il positivismo esprimono un netto discredito verso la metafisica. Entrambi si
attendono dall’applicazione del metodo sperimentale non solo l’accertamento delle ipotesi,
ma un verdetto di significanza, nel senso che considerano dotate di senso solo le
proposizioni che rinviano ad una verifica empirica. → Empirismo; Positivismo;
Neopositivismo
Per David Hume soltanto le discipline logico-matematiche, che riguardano il sapere
astratto e si esprimono tramite semplici “relazioni tra idee”, e la fisica, che ha come proprio
oggetto i “dati di fatto” (matters of fact), sono riconoscibili come vere scienze. Oltre ad esse
non c’è altra forma possibile di conoscenza. La metafisica è esclusa proprio perché non
rientra in nessuna di queste due forme. Lo conferma recisamente il filosofo inglese nella
nota conclusione della Ricerca sull’intelletto umano: “Quando scorriamo i libri di una
biblioteca, persuasi di questi principi, che cosa dobbiamo distruggere? Se ci viene alle mani
qualche volume, per esempio di teologia o di metafisica scolastica, domandiamoci:
Contiene qualche ragionamento astratto sulla quantità o sui numeri? No. Contiene qualche
ragionamento sperimentale su questioni di fatto e di esistenza? No. E allora, gettiamolo nel
fuoco, perché non contiene che sofisticherie ed inganni”36.
Secondo Auguste Comte “ogni proposizione che non è strettamente riducibile alla
semplice enunciazione di un fatto, particolare o generale, non può presentare nessun senso
reale e intelligibile”. È ciò che anche il neopositivista Moritz Schlick a sua volta ribadisce:
“Il significato di una proposizione è il metodo della sua verifica”, nel senso che
“l’indicazione delle circostanze, nelle quali una proposizione è vera, equivale perfettamente
all’indicazione del suo senso. E queste condizioni […] debbono in ultima istanza, trovarsi
nei dati di fatto. […] Il senso di una proposizione viene fondamentalmente determinato solo
dal dato, e da nessun’altra cosa”37. → Verificazione, Principio di
L’epistemologia fallibilistica di Ch. Peirce e K. Popper
35
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Introduzione, § 12 e § 14, a cura di B. Croce, Laterza,
1973, vol, I, p. 17 e p. 19
36
D. Hume, Ricerca sull’intelletto umano, XII, III, in Opere filosofiche, vol. II, trad. di M. Dal Pra e E. Mistretta,
a cura di E. Lecaldano, Laterza, 1987, p. 175
37
A. Comte, Discorso sullo spirito positivo, a cura di A. Negri, Laterza, 1985, p. 15;
M. Schlick, Positivismus und Realismus e Meaning and verification, cit. da F. Barone in Il neopositivismo logico,
vol. I, Laterza, 1977, p. 252
199
Alla base dell’epistemologia di Charles Peirce e di Karl Popper c’è una feconda
consapevolezza problematica e critica.
Secondo Peirce la scienza sperimentale applica rigorosamente un metodo “abduttivo”, ossia
un tipo d’inferenza congetturale che muove da eventi problematici e li interpreta come
conseguenze di cause probabili. La conoscenza a cui essa dà luogo è sempre soltanto
probabile e fallibile. Per uno che sa pensare in maniera scientifica un’ipotesi è sempre in
prova e può sempre essere ammessa, a condizione che ne sia possibile il controllo
dell’esperienza.
Popper ripropone un simile atteggiamento problematico. Egli è convinto che la scienza non
sia mai epistéme, cioè un sapere che nel linguaggio di Platone vorrebbe essere definitivo;
esso è, invece, strutturalmente falsificabile, perciò rimane sempre e soltanto ipotesi, o dóxa
(opinione) nel linguaggio antico della filosofia. Le sue teorie, mai rigorosamente
verificabili, possono risultare semplicemente “corroborate”, cioè provvisoriamente non
falsificate. Il nostro sapere, insuperabilmente problematico, ci destina ad una condizione di
fallibilità e al conseguente obbligo di rivedere le convinzioni che incorrono nelle smentite
dell’esperienza. Lo scopo della scienza non è il conseguimento della verità, che rimane
kantianamente un’“idea regolativa”, ma l’elaborazione di teorie sempre più verosimili. Dire
che una teoria è migliore di un’altra significa che “essa appare più vicina alla verità” ed è
questo ciò che intendiamo quando parliamo di “progresso” scientifico. Nella scienza si
confrontano e competono “darwinianamente” varie teorie: hanno il sopravvento quelle che
dimostrano di potersi adattare più efficacemente alle prove dell’esperienza, sopravvivendo
così nella lotta per l’esistenza.
Contro l’epistemologia dei positivisti e neopositivisti Popper sostiene che il loro
induttivismo verificazionistico non è logicamente giustificabile e che nella ricerca effettiva
non esiste l’induzione, ma si procede mediante un metodo ipotetico-deduttivo, cioè
attraverso congetture e confutazioni (→ Induzione; Metodo ipotetico-deduttivo). Infatti le
asserzioni singolari, connesse a constatazioni empiriche, non possono mai convalidare
logicamente teorie universali, perché rimane insuperabile la differenza tra l’esperienza
effettuabile, che è sempre limitata per quanto ricca sia di informazioni, e le potenzialità
infinite che essa non può mai esaurire. Appare, pertanto, rigorosamente insostenibile la
“verificabilità” delle teorie. Una tale constatazione ci porta a riconoscere che esse, invece,
possono essere “falsificate” dall’esperienza. C’è un’evidente asimmetria logica tra
verificabilità e falsificabilità: per garantire la prima occorrerebbe un numero infinito di
conferme, per realizzare una falsificazione è sufficiente un solo fatto negativo che confuti la
teoria.
La falsificabilità, poi, è un “criterio di demarcazione”, che distingue fondamentalmente le
teorie scientifiche (falsificabili) dalle teorie non scientifiche, in particolare quelle che
possiamo qualificare come metafisiche; non può perciò essere usata per determinare la loro
sensatezza, analogamente a ciò che sostiene l’epistemologia positivista a proposito
dell’epistemologia verificazionista. La metafisica non è affatto priva di senso e le sue teorie
razionalmente argomentate si possono capire, criticare e discutere, anche se non possono
essere controllate empiricamente.
Per queste tematiche si invia anche alle voci specifiche: → Fallibilismo; Falsificabilità;
Verosimiglianza; Abduzione; Metodo ipotetico-deduttivo
Thomas Kuhn: normalità e rivoluzione nella scienza
Secondo Kuhn le fasi ordinarie della storia della scienza sono caratterizzate dal fatto che
nella comunità scientifica s’impongono determinati “paradigmi” così definiti: “modelli che
200
danno origine a particolari tradizioni di ricerca scientifica con una loro coerenza”38.
Parafrasando, possiamo descriverli come insiemi più o meno strutturati di assunzioni
teoriche e di modi standardizzati di praticare la ricerca, di realizzare la sperimentazione e di
elaborare e trasmettere il sapere. L’ovvia accettazione di determinati paradigmi costituisce
l’effettiva condizione di una “scienza normale”, vigente in un certo periodo storico. La
“normalità” è rivelata dal fatto che l’impegno della ricerca è prevalentemente rivolto alla
loro applicazione analitica ai fenomeni che sono oggetto di studio. Con il consolidarsi di un
paradigma generalmente si assiste ad una “resistenza al cambiamento”, a causa della quale
esso “non si arrenderà troppo facilmente” di fronte ad eventuali “anomalie” sia empiriche
che concettuali, a cui inevitabilmente prima o poi va incontro39. Agisce la riluttanza ad
accedere a teorie nuove. Siamo di fronte ad un serio “ostacolo epistemologico”, direbbe il
filosofo francese Gaston Bachelard. Volendo menzionare due noti esempi di particolari
ostacoli epistemologici, pensiamo alla millenaria credenza nella perfezione dei cieli, che si
esprimeva nella loro configurazione rigorosamente circolare, o all’idea che solo la quiete e
non il moto sia uno stato naturale dei corpi: all’inizio dell’età moderna esse resero
difficoltose l’accettazione della forma ellittica nella descrizione dei moti planetari e
l’introduzione del principio d’inerzia.
Ora, se è vero che “la scienza normale non ha per scopo quello di trovare novità di fatto o
teoriche e, quando ha successo, non ne trova nessuna”, tuttavia “la ricerca scientifica mette
in luce ripetutamente fenomeni nuovi e insospettati, e continuamente teorie radicalmente
nuove sono escogitate dagli scienziati”40. Una rivoluzione scientifica mette fine ad un
periodo di profonda incertezza; essa, infatti, “richiede una distruzione su larga scala dei
paradigmi e modificazioni fondamentali nei problemi e nelle tecniche della scienza normale
[...] La decisione di abbandonare un paradigma è sempre al tempo stesso la decisione di
accettarne un altro”41. Il passaggio da un paradigma ad un altro ci costringe a vedere il
mondo in maniera completamente nuova, come in una vera e propria “conversione”42. Le
osservazioni empiriche assumono significati differenti nei diversi contesti in cui
avvengono. Secondo Kuhn i paradigmi che storicamente si susseguono sono
sostanzialmente “incommensurabili”; essi esigono un radicale riorientamento gestaltico (→
Gestaltpsycologie) dei fenomeni osservati, in riferimento ai quali non c’è modo di
presumere un’impossibile oggettività e invarianza dei dati, che sarebbero “stabiliti una
volta per tutte” e dei quali si darebbe con i diversi paradigmi una semplice
reinterpretazione. Tuttavia a Popper la tesi dell’“incommensurabilità” dei paradigmi appare
insostenibile, perché interpreta una difficoltà come un’impossibilità; a suo giudizio è
sempre possibile una discussione critica e un confronto, e rimane generalmente valido nella
ricerca il criterio orientativo della verità, per cui è possibile scegliere una teoria rispetto ad
un’altra in base alla sua maggiore verosimiglianza. Nell’ottica di Kuhn, invece, “la
competizione tra paradigmi diversi non è una battaglia il cui esito possa essere deciso sulla
base delle dimostrazioni”43. Le pretese che il nuovo paradigma sia dotato di una maggior
precisione ed abbia la capacità di risolvere più problemi non sono sempre e senz’altro
decisive. È forte la dipendenza delle scelte scientifiche da fattori di natura sociale e
psicologica, da convinzioni filosofiche e religiose, da motivazioni estetiche, cioè il fatto che
una teoria si configuri come più semplice ed elegante rispetto ad un’altra. Poiché, poi, la
38
Th. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, trad. di A. Carugo, Einaudi, 1969, p. 30
op. cit., p. 89
40
op. cit., p. 75
41
op. cit., pp. 92 e 104
42
op. cit., p. 183
43
op. cit., p. 179
39
201
contrapposizione tra paradigmi diversi e alternativi ha come obiettivo la scelta del
paradigma che dovrà guidare la ricerca futura, in riferimento a problemi che nessuno può
pretendere per il momento di risolvere, “una decisione di tal genere può essere presa
soltanto sulla base della fede”44.
Stante questa impostazione, non ha più senso individuare nella scienza un progresso
“verso” qualcosa (l’approssimazione alla verità), ma “a partire da” qualcosa, ossia come un
allontanarsi da stadi primitivi, per tentare di realizzare una più efficace capacità di risolvere
problemi. Secondo Kuhn è possibile individuare un’analogia tra il processo evolutivo delle
teorie scientifiche e quello degli organismi viventi, così com’è stato pensato da Darwin,
cioè non secondo prospettive finalistiche, ma in base al criterio della selezione naturale e
della lotta per la sopravvivenza.
Inoltre in ogni rivoluzione ci sono dei vantaggi, ma anche delle perdite: vecchi problemi
vengono talora eliminati, perché nel nuovo paradigma non hanno la possibilità di essere
formulati; il nuovo paradigma può restringere l’ambito della ricerca rispetto al vecchio
paradigma, perdendo in generalità: per esempio, la dinamica galileiana concentra la sua
attenzione sul moto locale, mentre nella fisica aristotelica la teoria del movimento era più
ampia, poiché essa intendeva per movimento ciò che noi chiamiamo “mutamento”. Se
questo è vero, non ha più senso attribuire alla storia della scienza uno sviluppo cumulativo,
se non all’interno delle singole fasi di scienza normale. In rapporto al succedersi delle fasi
rivoluzionarie rispetto alle precedenti ordinarie non abbiamo criteri univoci per giudicare in
termini di superiorità e inferiorità. In una prospettiva storica complessiva, la scienza non
sembra andare da alcuna parte: non ha alcuna teleologia.
L’epistemologia delle scienze umane, in particolare della storia
W. Dilthey
Tra la fine dell’Ottocento e il Novecento si assiste ad una diffusa reazione critica
all’orientamento riduzionistico del positivismo, che sembrava misconoscere la specificità
del fenomeno umano. Pertanto si vuol elaborare un’epistemologia adeguata alle scienze
umane (denominate talora “scienze dello spirito” o “scienze morali”), che le distingua dalle
scienze naturali.
Wilhelm Dilthey, a partire dalla Introduzione alle scienze dello spirito (1883), intende
dare alla questione della scientificità delle scienze dello spirito un’impostazione di tipo
kantiano, realizzando una “critica della ragione storica”, perché è della storia che egli
soprattutto s’interessa, essendo la storia la dimensione onnicomprensiva della realtà umana.
Pertanto, per attuare il proposito di analizzare le condizioni fondamentali della conoscenza
storica, egli evidenzia la specificità metodologica che distingue le scienze dello spirito dalle
scienze empiriche, perché gli oggetti delle une e delle altre, rispettivamente l’uomo e la
natura, sono distinti e autonomi. Infatti i fenomeni del mondo fisico si ripetono in maniera
uniforme e costante, e sono determinati necessariamente dalle loro cause, la cui conoscenza
assicura la predicibilità degli effetti; invece le oggettivazioni della vita e dell’esperienza
umana (l’Erleben) sono caratterizzate dall’inarrestabile e varia mobilità e unicità degli
eventi (Erlebnisse; → Erlebnis). Le multiformi e complesse realtà storiche (singole
persone, formazioni sociali, istituzioni, civiltà ed epoche) si configurano come “connessioni
dinamiche”, orientate al conseguimento di scopi e alla realizzazione di valori, e perciò sono
dotate di senso. Esse sono contraddistinte da un’irriducibile individualità, perché hanno in
sé il centro che le organizza. Una vera comprensione delle diverse configurazioni storiche è
44
op. cit., p. 190
202
possibile alla sola condizione che si assuma la prospettiva richiesta dall’identità di ognuna,
ossia la sua particolare “visione del mondo” (Weltanschauung). Diversamente da ciò che
avviene con le scienze empiriche, nelle quali il soggetto che le pratica assume un
atteggiamento logico-razionale, cioè esteriore e astratto, per “spiegare” (Erklären) i
fenomeni della natura mediante le loro connessioni causali, con le scienze storico-sociali il
soggetto intende “comprendere” (Verstehen) dall’interno i suoi oggetti, immedesimandosi
in essi e rivivendoli. La psicologia diventa così una condizione fondamentale di
conoscenza.
W. Windelband e H. Rickert
Nello stesso periodo anche la “filosofia dei valori” della cosiddetta “Scuola del Baden” si
rifà al criticismo kantiano nelle proprie argomentazioni contro il positivismo. I suoi
esponenti sono Wilhelm Windelband e Heinrich Rickert. A giudizio di questi autori, la
filosofia, diversamente dalle scienze naturali, il cui interesse riguarda sempre la quaestio
facti, ha come oggetto specifico la quaestio iuris, perché è rivolta non all’essere ma al
dover essere, cioè ai “valori” e ai “giudizi valutativi”. Windelband, in particolare, propone
di distinguere le scienze della natura dalle scienze dello spirito, qualificando le prime come
“nomotetiche”, cioè destinate a rilevare leggi generali e uniformi, e le seconde come
“idiografiche”, cioè orientate ad evidenziare la singolarità e l’unicità degli eventi umani.
Questa distinzione, tuttavia, sia per Windelband che per Rickert non riguarda tanto gli
oggetti, quanto piuttosto i metodi, nel senso che anche nell’ambito della fisica o della
biologia si assume un approccio idiografico quando s’intende studiare nella sua peculiarità
un singolo oggetto; viceversa ci si confronta nomoteticamente con un determinato
comportamento umano quando lo si considera con un’ottica generalizzante. Perciò “il
principio di divisione [delle scienze] è costituito dal carattere formale dei loro fini
conoscitivi. Le une cercano leggi generali, le altre fatti storici particolari: per esprimerci nel
linguaggio della logica formale, il fine delle une è il giudizio generale, apodittico, mentre
quello delle altre è la proposizione singolare, assertoria […] Quest’antitesi metodologica
classifica solo il modo di trattazione e non il contenuto del sapere”45.
M. Weber
Max Weber (1864-1920) ritiene che l’accettazione delle tesi di Dilthey determini
un’ingiustificata frattura nell’ambito generale della scienza; soprattutto non condivide la
convinzione, ancora tutta romantica, che la storia richieda una “comprensione simpatetica”,
ossia la capacità di rivivere il passato, immedesimandosi in maniera intuitiva e sentimentale
nella realtà da comprendere. Egli è convinto che come per le scienze naturali anche per le
discipline storico-sociali s’imponga l’esigenza di una spiegazione causale e tuttavia pensa
che, diversamente dalle prime, queste non possano pretendere di subordinare i propri eventi
a leggi generali e deterministiche. I fatti storici non sono necessari, ma possibili. La
storiografia, perciò, esprime giudizi di “possibilità oggettiva”.
Per essere riconosciuta come “oggettiva”, la possibilità deve fondarsi su fatti accertabili
in base alle fonti documentali e risultare conforme alle “regole empiriche generali”, le quali
comportano, in quanto tali, un sapere “nomologico”, cioè un sapere che fa riferimento a
leggi. Contro la convinzione di Dilthey che gli oggetti della conoscenza storica, in
opposizione all’uniformità e ripetibilità degli eventi fisici, siano caratterizzati
esclusivamente dall’individualità, Weber ritiene che anche nella storiografia sia legittimo
45
W. Windelband, Storia e scienza della natura, in Lo storicismo tedesco, a cura di P. Rossi, UTET, 1977, pp.
319-320
203
l’uso di un pensiero generalizzante. In particolare mette in rilievo il valore strumentale di
quelle generalizzazioni che egli chiama “tipi ideali”, ad esempio i concetti di cristianesimo,
feudalesimo, capitalismo, ecc. Essi non sono fotocopie della realtà, ma costruzioni teoriche,
che, pur derivando per astrazione dalla realtà empirica, ne accentuano idealmente le
caratteristiche essenziali. Considerati nella loro purezza, sono irreali o “utopici”. Il loro
valore è d’ordine euristico e metodologico, perché sono utili nella ricerca: fungono da
modelli esplicativi, con i quali si confronta e si misura la realtà effettiva46.
Nei fatti storici all’oggettività s’accompagna la caratteristica della possibilità, che è
connessa intrinsecamente alla condizione ontologica della storicità. A questo riguardo
Weber pensa diversamente da Benedetto Croce. Per il filosofo italiano gli eventi storici
competono alla libertà umana prima che accadano, quando nella vita pratica si confrontano
tra loro le diverse volontà, ma, una volta accaduti, essi vanno studiati razionalmente nella
loro identità ormai conclusa e definita, e nella conseguente necessità logica che ormai li
riguarda, come intende esprimere il noto adagio: “factum infectum fieri nequit” (è
impossibile che non sia stato ciò che è accaduto), perché l’effettività dei fatti non può
essere annullata. Pertanto, secondo Croce, “la storia dei se” è un inutile trastullo, cioè un
insieme di ragionamenti arbitrari. Weber, invece, ritiene che nella storiografia sia
appropriato il ragionamento condizionale o ipotetico, che è chiamato talora anche
“controfattuale”. Esso consiste in un vero e proprio esperimento mentale. Nella proposta
weberiana esso appare come alternativo alla tradizionale spiegazione causale: “La
considerazione del significato causale di un fatto storico comincerà anzitutto con la
questione seguente: se, escludendolo dal complesso dei fattori assunti come condizionanti,
oppure mutandolo in un determinato senso, il corso degli avvenimenti avrebbe potuto, in
base a regole generali dell’esperienza, assumere una direzione in qualche modo
diversamente configurata nei punti decisivi per il nostro interesse”47. Mentre le scienze
naturali vanno alla ricerca dell’ordine necessario nel quale si succedono i fenomeni e si
avvalgono di un concetto deterministico di causa, nelle scienze umane, invece, si dimostra
adeguata alla comprensione degli eventi che sono oggetto della loro indagine
un’imputazione causale “verosimile” e “probabile”. Nell’interpretazione storica degli eventi
il ragionamento ipotetico ricorre ad un esperimento mentale, che serve ad evidenziare
l’importanza dei fattori causali, cioè a distinguere una “determinazione causale adeguata”
da una semplicemente “accidentale”.
B. Croce
Anche il nostro Benedetto Croce assume una posizione critica verso la cultura positivistica,
rifiutando persino di riconoscere alla natura una qualche autonomia rispetto allo spirito. Ciò
ha come conseguenza uno svilimento delle scienze naturali. Per Croce la vera scienza è la
filosofia, che la sua concezione idealistica identifica con la storiografia. Egli è convinto che
“la vita e la realtà è storia e nient’altro che storia”48 e ogni giudizio sulla realtà è un giudizio
storico, in cui il soggetto è sempre un fatto particolare ed il predicato è un concetto che lo
inquadra in un ordine universale, ne esplicita il senso e con ciò lo giustifica. Croce
denomina la propria filosofia “storicismo assoluto”. → Storia, Filosofia della (Lo
“storicismo assoluto” di Benedetto Croce)
M. Heidegger e H.G. Gadamer
46
Si fa riferimento a M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, a cura di P. Rossi, A. Mondadori, 1974, pp.
107-128
47
M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, cit., p. 223
48
B. Croce, La storia come pensiero e come azione, Laterza, 1966, p. 51
204
La peculiare scientificità delle scienze umane è ribadita dall’importanza che Martin
Heidegger e Hans Georg Gadamer riconoscono all’ermeneutica. Secondo Heidegger il
concreto attuarsi della comprensione si ha nell’interpretazione, che è l’articolarsi stesso del
conoscere nel suo interno sviluppo, con il quale noi ci appropriamo di ciò che andiamo
comprendendo. A questo riguardo si considerino le voci: → Comprendere / spiegare;
Ermeneutica; Circolo ermeneutico
K.R. Popper e G. Hempel
Nel Novecento va proseguendo con una maggior sofisticazione delle analisi il precedente
dibattito sulla questione epistemologica della storia.
Secondo Karl R. Popper il modo di procedere della conoscenza è unico per tutte le
discipline scientifiche, sia per le scienze della natura che per la storiografia: esso consiste
nel metodo per congetture e confutazioni. A mutare di volta in volta nei diversi ambiti della
ricerca sono le tecniche empiriche di prova, ma “la logica della scoperta scientifica” è
sempre la stessa.
Queste tesi epistemologiche sono originalmente riprese da Carl Gustav Hempel nel
saggio La funzione delle leggi generali nella storia (1942). Di questo autore ricordiamo che
contribuì al processo di “liberalizzazione” del movimento neopositivistico.
L’idea essenziale della teoria della spiegazione scientifica descritta da Hempel è che uno
stato di cose (fatti, eventi) E (explanandum) è spiegato se e solo se si può indicare un
insieme di altri stati di cose empiricamente accertati C (cause o condizioni iniziali) e di
determinate regolarità generali L (“leggi di copertura”), tali che E segua logicamente dalla
loro congiunzione. In tale caso C e L sono l’explanans, ossia ciò che spiega il verificarsi di
E. Nella scelta degli eventi da considerare come cause di particolari eventi da spiegare
(effetti) non si procede a caso, ma ci si deve appellare a leggi generali, perché soltanto le
leggi hanno la forza logica di collegare gli eventi “cause” agli eventi “effetti”. Hempel parla
di “leggi di copertura” (covering laws), perché per lui spiegare significa ricondurre un
evento sotto il dominio di leggi generali e una spiegazione prende sempre la forma
argomentativa di un’inferenza logica, che connette determinate premesse (l’explanans),
aventi portata empirica, e una conclusione (l’explanandum). Qualora le leggi impiegate
siano ineccepibili, tale connessione risulta necessaria, l’explanandum appare una
conseguenza logica dell’explanans e le leggi di copertura sono deterministiche (schema
“nomologico-deduttivo”); invece, nel caso in cui siano di tipo statistico, il nesso assume la
forma di uno schema “probabilistico-induttivo”. In riferimento all’unico metodo d’indagine
usato dalle scienze empiriche e dalla storiografia, Hempel così afferma: “Ambedue offrono
un resoconto o spiegazione del loro oggetto solo in termini di concetti generali, e la storia
può ‘afferrare l’individualità unica’ dei suoi oggetti di studio né più né meno di quel che
possano fare la fisica o la chimica. [...] Anche la spiegazione storica, infatti, ha lo scopo di
mostrare che l’evento in questione non era ‘un qualcosa di accidentale’, ma poteva essere
previsto in base a certe condizioni antecedenti o simultanee. L’aspettativa cui si fa
riferimento non è una profezia o una divinazione, ma un’anticipazione scientifica razionale
che si basa sull’assunzione di leggi generali. [...] In alcuni casi le ipotesi generali che
soggiacciono ad una spiegazione storica sono stabilite piuttosto esplicitamente, [... ma] la
maggior parte delle spiegazioni in storia o in sociologia non includono un’esplicita
enunciazione delle regolarità generali che esse presuppongono. [Una delle ragioni è che] le
ipotesi universali in questione sono frequentemente legate alla psicologia individuale o
205
sociale, che in qualche modo si suppone essere familiare a chiunque in base alla propria
esperienza quotidiana; per questo esse vengono tacitamente date per scontate”49.
La filosofia analitica: W. Dray, G. H. von Wright
A partire dagli anni Cinquanta del XX secolo gli autori della cosiddetta “filosofia analitica”
esprimono forti critiche verso l’epistemologia positivistica. In particolare sostengono la
specificità delle scienze umane e, in opposizione alle rigidità della logica formale e delle
sue codificazioni linguistiche, considerano rilevanti e validi i linguaggi che sono
effettivamente praticati nella comunicazione umana.
Coloro che, come il canadese William Dray, sostengono l’autonomia concettuale e
metodologica delle scienze umane, insistono sul fatto che le azioni degli uomini, per essere
comprese, richiedono che se ne individuino i motivi specifici e particolari. La spiegazione
nomologica, che fa riferimento a leggi generali, è considerata astratta e inutilmente
costrittiva, perchè si lascia sfuggire gli aspetti più propriamente “umani” degli eventi
storici, accontentandosi del loro “lato esterno”, come dice R.G. Collingwood. Ai desideri e
alle inclinazioni, agli orientamenti e alle intenzioni che presiedono all’agire umano non è
confacente né appropriato lo schema di spiegazione causale, che invece è valido per gli
eventi naturali, perché esso implica un’uniformità e una costanza che non si riscontrano
negli eventi storici; questi, infatti, per la loro natura specifica non possono essere
considerati come casi particolari di classi di fenomeni aventi caratteristiche simili. Nella
concezione di Dray riaffiorano elementi importanti dello storicismo di Dilthey, in
particolare l’insistenza sull’individualità e unicità degli eventi umani e l’esigenza che lo
storico li “comprenda”, cioè s’immedesimi psicologicamente in essi, per cogliere le ragioni
dell’agire umano. Il termine stesso di “spiegazione” gli risulta legato allo schema logico
causale delle scienze naturali e pertanto non adatto alla storia. Ritiene inoltre che nella
ricostruzione storiografica sia pertinente anche la valutazione degli eventi, divergendo in
ciò da Hempel, che invece la considera un’interferenza di indebiti giudizi di valore, dai
quali si è indotti ad indagare non quel che è realmente accaduto, ma quel che si sarebbe
dovuto fare in determinate circostanze. Di Dray ricordiamo Leggi e spiegazioni in storia
(1957).
Un altro critico della posizione hempeliana è il finlandese Georg Henrik von Wright, che in
alternativa allo schema nomologico causale considera adeguate alla comprensione del
mondo umano le nozioni di intenzionalità e i concetti teleologici, ossia la comprensione
finalistica degli eventi. Di Wright ricordiamo Spiegazione e comprensione (1971).
R. G. Collingwood
Un’interessante figura di storico e filosofo è l’inglese Robin George Collingwood (18891943), che nell’opera postuma The idea of History (1946) difende l’autonomia della scienza
storica contro l’interpretazione riduttiva dell’epistemologia positivistica, della quale critica
l’atteggiamento feticistico e sostanzialmente passivo nei riguardi delle fonti documentali.
La storiografia, infatti, non si riduce a erudizione, il cui risultato sarebbe una semplice
“storia forbici-e-colla”. Il problema dello storico, poi, non è tanto quello di spiegare i fatti,
49
C.G. Hempel, Aspects of scientific explanation and other essays in Philosophy of science, trad. it. di D. Antiseri,
riportato da Epistemologia e storiografia, a cura di P. Masat Lucchetta, La Scuola, 1987, pp. 145-146
A proposito dell’affermazione finale della citazione riportata, si può ben dire che lo storico non produce leggi
specifiche, ma utilizza le leggi più svariate di diretta pertinenza delle diverse discipline scientifiche, come
l’economia, la psicologia individuale e sociale, la sociologia, l’urbanistica, l’epigrafia, ecc., che diventano pertanto
sue scienze “ausiliarie”. La spiegazione di ciò è rinvenibile nella natura “onnivora” della storia: la storia, infatti, si
nutre di tutto, perché tutto può diventare oggetto e materiale d’interesse storiografico.
206
ma di comprenderne il “lato interiore”, cioè i pensieri che ne colgono il senso. Il suo
compito consiste nel “ri-pensare” (re-think) il passato, nel “ri-produrlo”, nel “ri-metterlo in
scena” (re-enact), ricostruendolo dall’interno in una maniera il più possibile verosimile.
Un’efficace storiografia deve ispirarsi al modello dello scienziato baconiano, la cui
diligenza e perspicacia induttiva è dimostrata dall’attiva capacità di far domande e di
sollecitare risposte; infatti “la vera teoria della scienza sperimentale è anche, benché questo
Bacone non lo sapesse, la vera teoria del metodo storico”. Come avviene con la fisica, il cui
compito consiste nel “costringere la natura a rispondere”, così deve essere anche con la
storia, perché “l’attività di far domande è il fattore dominante nella storia, come lo è in ogni
opera scientifica”50.
Collingwood, inoltre, individua nella fiction inquisitiva del romanzo poliziesco un utile
modello per il lavoro dello storiografo. Essa, infatti, procede alla ricostruzione dei fatti
attraverso la valutazione problematica e l’attenta interpretazione degli indizi.
SOCIETÀ CIVILE
L’espressione “società civile” ha una particolare rilevanza nella filosofia di G. Hegel e nella
successiva analisi critica di K. Marx. Per essi, tuttavia, assume un significato diverso da
quello con cui era già stata usata nella tradizione giusnaturalistica. Infatti, mentre Hegel e
Marx rilevano l’antitesi tra la “società civile” e la “società politica” o Stato, nei due secoli
precedenti era stata significativa l’opposizione tra lo “stato civile” o societas civilis e lo
“stato di natura” o societas naturalis. Con l’espressione “stato civile” si designava la
società politica e la si considerava il prodotto dell’artificio umano, consistente in un patto
fondativo dello Stato, con il quale si pensava di garantire quell’ordine pubblico che la
socialità spontanea della natura umana non è in grado di assicurare. Avvenne poi una
complicazione nell’uso di queste espressioni, rilevabile in particolare in J.-J. Rousseau.
Essa fu determinata dall’identificazione dello stato di natura con lo stato selvaggio e quindi
dall’opposizione della società civile allo stato di natura, inteso non solo nel tradizionale
senso filosofico di condizione originariamente universale, ma anche nel senso di condizione
primitiva, priva di cultura. Pertanto all’usuale accezione di società civile, che la identificava
con la società politica, se ne sovrappose una nuova, che la identificava con la società
civilizzata e acculturata.
Una nuova e più complessa applicazione dell’espressione “società civile” è poi presente
nel pensiero di A. Gramsci.
G.W.F. Hegel
Per Hegel la società civile (in tedesco è bürgerliche Gesellschaft: società civile o borghese)
è uno dei momenti dialettici di realizzazione dello Spirito oggettivo, cioè dello Spirito che
si manifesta nell’ambito pubblico delle relazioni umane, storicamente determinate,
integrando in sé oltre agli individui anche le famiglie, le quali non possono esaurire
l’esigenza di socialità dell’uomo. La società civile non è ancora lo Stato, ma è la società
prepolitica, che mediante la divisione del lavoro assicura innanzitutto la produzione e lo
scambio dei beni, soddisfacendo così i molteplici bisogni e realizzando la ricchezza, la cui
distribuzione avviene attraverso la competizione e la concorrenza. Il sistema economico dà
origine alle diverse classi sociali (agricoltori, artigiani e commercianti) e alle corporazioni
50
R.G. Collingwood, Il concetto della storia, Fabbri, 1966, riportato da Il testo filosofico, B. Mondadori, 3/2,
1993, p. 819
207
di mestiere, le quali, pur esprimendo interessi ancora particolari, obbligano comunque gli
individui ad uscire dal loro ambito privato.
Nei Lineamenti della filosofia del diritto (1821) Hegel riconosce l’importanza della
moderna economia politica, che nella congerie e nella contingenza, apparentemente
disordinate, dei fatti riguardanti la produzione e lo scambio dei beni individua l’ordine che
la varietà dei bisogni e l’interdipendenza delle competenze producono, senza che
l’individuo, attento ai suoi egoistici interessi, se ne avveda, come se fosse la “mano
invisibile”, di cui parlava A. Smith, a realizzarlo. L’ordine, tuttavia, vi appare configurato
in una maniera ancora esterna e intellettualistica, perchè la sua vera essenza etica può essere
rivelata soltanto dalla filosofia.
Nella società civile operano anche l’amministrazione della giustizia e la polizia, le quali,
peraltro, dipendono dal potere esecutivo, che è un’articolazione dello Stato.
L’esigenza di una realizzazione etica più elevata e perfetta può essere soddisfatta non
nella società civile, ma solo entro lo Stato, che rappresenta la consapevolezza razionale del
fine, verso cui si indirizza la vita di un popolo. Rispetto alla società civile, lo Stato
provvede a realizzare, ad un livello superiore, l’interesse universale, ossia la ricerca del
bene comune. → Politica (Teorie politiche)
K. Marx
Marx nel saggio giovanile Sulla questione ebraica (1843) oppone alla concezione hegeliana
l’esigenza di una tipica inversione materialistica, perché, a suo giudizio, la funzione storicosociale più importante ed efficace non la realizza lo Stato, che pur si dichiara garante
dell’interesse generale, ma la società civile, nella quale si affermano gli interessi economici
particolari. Infatti l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è solo formale: proclamata
a parole in solenni principi, essa non fa che presupporre e ratificare la sostanziale ed
effettiva disuguaglianza. A questo proposito Marx osserva che, come i cristiani, pur
essendo diseguali in terra, si consolano di essere tutti uguali in cielo, così a coloro che
vivono nella reale diseguaglianza della società civile è data la consolazione illusoria
dell’universale uguaglianza nello Stato. Di fronte alla legge le differenze sociali
determinate dalla nascita, dal ceto, dall’educazione e dalla professione sono dichiarate prive
di significato, tuttavia lo Stato lascia che esse operino. Perciò ognuno vive “una doppia
vita”: “celeste” come “citoyen” nell’ambito dell’istituzione pubblica e “terrena” come
“bourgeois”, cioè come uomo privato proteso ai suoi interessi. Diversamente da come
pensava Hegel, è la società borghese che fa dello Stato un semplice strumento degli
interessi della classe più forte. Quindi l’emancipazione politica non è la forma completa e
perfetta di emancipazione dell’uomo. In Marx la concezione della società civile e dello
Stato rimane coerente nel tempo: nel periodo della sua maturità intellettuale la prima
diventa la “struttura” sociale, mentre il secondo viene a far parte di una complessa
“sovrastruttura”, dipendente dalla struttura. → Materialismo storico
A. Gramsci
Anche nel pensiero che Antonio Gramsci affida ai Quaderni del carcere (pubblicati
postumi tra il 1948 e il 1951 in raggruppamenti tematici e ripubblicati nel 1976 secondo un
criterio cronologico) la nozione di “società civile” è importante, ma essa non coincide con
quella di Marx. Per lui la società civile comprende vari aspetti della sovrastruttura, alla
quale rivolge un interesse prioritario e un’attenzione preminente, perché è nel suo ambito
che il proletariato può diventare consapevole della propria condizione storico-sociale. Egli
vuol evitare in particolare l’inganno dell’economicismo (o economismo, come lo chiama
Gramsci), che, in attesa di un’evoluzione meccanica del sistema economico, lascia inerte la
208
volontà di fronte al compito di sostenere la lotta. L’economismo, infatti, è una forma di
naturalismo deterministico, che non considera l’importanza dei fattori soggettivi né
interpreta correttamente le condizioni oggettive. Le condizioni non sono inesorabili cause,
ma circostanze concrete, che occorre comprendere e assumere con l’intraprendenza di chi
vuol cambiare le cose. L’economismo, inoltre, restringe l’azione del proletariato
nell’ambito dei soli interessi corporativi, impedendogli di accedere ad una vera coscienza di
classe, che apra a prospettive di protagonismo politico.
Nella società civile si sviluppano non solo i singoli rapporti interpersonali, ma
organizzazioni anche complesse e stabilizzate, come i sindacati, i partiti, le associazioni
religiose, la scuola, la stampa, ecc. È nel suo ambito che si realizza l’egemonia di una
classe dirigente. Il concetto gramsciano di “egemonia” introduce un’articolazione che
arricchisce quello tradizionale di “dittatura”, soprattutto nell’uso che Lenin ne aveva fatto.
Lo schema leninista di rivoluzione risultava assai semplificato nella forma di una rapida
presa del potere, con la quale una classe (il proletariato) diventa direttamente dominante ed
egemonica. Nelle nazioni storicamente più evolute le cose non possono essere così
semplici, perché in esse la società civile è molto più articolata e organizzata di quella che
era presente nell’impero zarista. Per costituire in una società sviluppata un nuovo “blocco
storico”, ossia una rinnovata unità organica di struttura e di sovrastruttura, dialetticamente
interconnesse in maniera stabile, occorre impegnarsi in un lavoro di lunga lena, il cui scopo
è la realizzazione di un’efficace egemonia sociale. L’egemonia è la capacità di dirigere
intellettualmente e moralmente, cioè di unificare l’intera comunità. Questo è il vero
obiettivo di un’impresa rivoluzionaria che voglia agire in profondità. A tale scopo è
indispensabile la funzione degli intellettuali. Per Gramsci gli intellettuali non sono i
disinteressati e puri cultori della verità né i rappresentanti dell’alta cultura, ma i “persuasori
permanenti”, che hanno la funzione di garantire il consenso sociale, cioè la compattezza
delle convinzioni e l’efficienza dell’agire. In questo senso sono “organici” alla classe, a
favore della quale cooperano. Essi sono i funzionari della sovrastruttura nei due ambiti nei
quali questa è suddivisa, cioè la società civile e la società politica. Nell’ambito della società
civile presiedono direttamente, come quadri tecnici e funzionali, all’organizzazione
dell’attività economica. Nella dimensione pubblica delle istituzioni ufficiali svolgono, come
ministri, parlamentari, giudici, militari, ecc., una generale funzione, variamente specificata,
di garanzia dell’ordine legale. Ci sono, poi, coloro che più solitamente sono denominati
intellettuali, il cui compito professionale consiste nello sviluppare e sistemare teoricamente
concezioni della realtà che siano consone con gli interessi fondamentali della classe
egemone. → Ideologia
Nella prospettiva della rivoluzione, dalla quale dovrà nascere la società comunista,
l’arduo compito della ricomposizione e del rinnovamento intellettuale e morale spetta ad un
“moderno principe”, che, diversamente dalla figura auspicata dal Machiavelli, non può
essere un individuo, ma un organismo collettivo, nel quale già abbia inizio l’esperienza di
una volontà rinnovata, consapevole e ispirata ad un forte rigore etico. È il partito politico,
nuovo intellettuale organico, il cui compito non si esaurisce nella presa del potere, cioè
nella realizzazione del semplice “dominio”, ma nella determinazione di una nuova
“direzione intellettuale e morale” di tutta la società.
209
STATO
Si è soliti definirlo come l’organizzazione giuridica di una comunità (popolo) in un
territorio. Occorre, tuttavia, rilevare che questa “organizzazione giuridica” comporta di per
sé l’esercizio del potere sovrano e della coercizione legale, cioè, per dirla con le parole di
Max Weber, “il monopolio dell’uso della forza legittima”128. Nella definizione data è questo
l’elemento propriamente “formale” rispetto all’elemento “materiale” costituito dal popolo e
dal territorio.
Pur essendo genericamente applicato anche alle organizzazioni antiche della pólis greca e
della res publica romana, il concetto di Stato è caratterizzato soprattutto da quegli attributi
che la storia politica occidentale ha fatto emergere nell’età moderna attraverso un
plurisecolare processo di dissoluzione della società medioevale. Le teorie hanno
ovviamente accompagnato e sostenuto in forme varie e contrastanti questo travagliato
percorso, che in una tradizionale società di ceti, fondata non su norme generali, ma su una
pluralità di poteri riottosi, ha visto innanzitutto affermarsi il modello delle monarchie
assolute e la teorizzazione del principio di “sovranità”. I sovrani hanno costituito una
propria burocrazia, ossia un corpo di funzionari; si sono impegnati ad unificare la
legislazione; hanno cercato di assicurarsi eserciti stabili; si sono visti costretti a provvedere
alle risorse fiscali in forme più sicure e sistematiche. Inoltre è stato determinante lo
sviluppo economico e sociale della borghesia, la nuova classe emergente, che ha sostenuto i
progetti dei sovrani contro le resistenze tradizionaliste dell’aristocrazia o, in altre situazioni,
si è opposta alle tentazioni della monarchia di mutare l’assolutismo in dispotismo,
favorendo la transizione verso una gestione più partecipata e divisa dei poteri, vincolata
all’istituzione rappresentativa del parlamento. In Inghilterra ciò è avvenuto in maniera
traumatica, ma costruttiva, attraverso le guerre civili del XVII secolo. Si è così realizzato
uno Stato di diritto tendenzialmente liberale, che è diventato un modello di riferimento per
l’Europa. Anche la convinzione della tolleranza interconfessionale è stata acquisita come
un fondamentale principio di corretta e pacifica convivenza. Pertanto allo Stato moderno si
è guardato sempre più come ad uno “Stato laico”, cioè aconfessionale e ideologicamente
agnostico, che è andato equiparando giuridicamente sia i diversi atteggiamenti assunti dai
cittadini nei riguardi della questione religiosa che le varie confessioni e pratiche cultuali (→
Tolleranza). Esso, inoltre, configurato come persona giuridica, titolare di diritti e di
obblighi, ha fatto in modo di essere considerato uno “Stato di diritto”, il cui scopo è quello
di garantire di fronte alla legge l’uguaglianza di tutti i cittadini.
Le trasformazioni sociali, indotte dagli sviluppi economici, e l’avvento di una società di
massa, prodotta dalla rivoluzione industriale, hanno fatto emergere esigenze sempre più
esplicite e diffuse di democrazia formale e sostanziale, secondo un modello che si è andato
confermando nel tempo. → Democrazia
Per ulteriori e più specifiche informazioni si invia alla voce → Politica (Teorie politiche).
Per una distinzione del concetto di Stato dal concetto di “società civile” si veda la voce →
Società civile.
128
M. Weber, Economia e società, Edizioni di Comunità, 1980, IV, p. 9
210
STORIA, Filosofia della
Si parla di filosofia della storia quando c’è un’attenzione rivolta alla generalità delle
vicende umane, accompagnata dall’intenzione di comprenderle secondo un profilo unitario.
Se assume rilevanza la propensione ad attribuir loro un finalismo globale e oggettivo, la
filosofia della storia è per lo più designata come “storicismo”.
L’inadeguata considerazione della storia nel pensiero filosofico greco
Generalmente e in maniera indistinta l’antica cultura greca incluse la storia nella natura,
conferendole un percorso circolare e ripetitivo, in cui le vicende tendevano ad assumere
l’andamento necessario dei processi biologici, nei quali ciò che nasce ha uno sviluppo, una
maturazione, una conseguente decadenza e quindi una fine, per dar poi luogo ciclicamente
ad un successivo riproporsi di identiche forme. Il tempo era cadenzato dai ritmi della natura
e non ci si poneva la domanda sul senso (direzione) dell’esistenza.
Erodoto (484-426 circa a.C.) e Tucidide (460-400 circa a.C.) impostarono la prima
storiografia, intendendola non come una semplice rassegna di fatti (tale è l’originario
significato del greco ἱστορία, historía), ma come un’interpretazione causale delle vicende
umane. Ciò nonostante, i filosofi antichi non espressero un’adeguata epistemologia della
storia. Quando distinsero gli eventi storici da quelli della natura, li considerarono come una
successione di contingenze, che non sottostanno ad una legge razionale. Per Aristotele la
storia è rivolta a ciò che è “particolare” ed è, pertanto, inferiore alla stessa poesia, che “è
qualche cosa di più filosofico”, perché “tende piuttosto a rappresentare l’universale”131. →
Arte
La concezione unitaria della storia umana nel pensiero cristiano
Fu il cristianesimo ad inserire gli eventi storici in un disegno unitario e provvidenziale, cioè
a sottrarli alla pura casualità o all’inesorabilità dei processi naturali. In contrasto con le
tradizioni naturalistiche e la loro concezione ciclica del tempo, che riproponeva
l’avvicendarsi in identiche forme di tutto ciò che accade sotto il dominio indiscutibile della
natura, la fede biblica affermò l’originaria e permanente dipendenza ontologica del mondo
da Dio, assegnò all’uomo un ruolo primario tra le creature e nella creazione stessa
individuò l’inizio di una storia finalisticamente orientata, nella cui prospettiva la fine (τὸ
έσχατον, tò éschaton) coincide con il fine (τέλος, télos), che Dio fin dall’origine aveva
disposto, nel senso che al termine si realizzerà e si rivelerà ciò che l’inizio aveva
annunciato.
La colpa di Adamo non annullò l’originario progetto del creatore; al contrario questo fu
reintegrato in una historia salutis (storia della salvezza), il cui evento centrale di
riferimento doveva essere l’incarnazione stessa del Figlio di Dio, che come “Figlio
dell’uomo” era destinato ad essere “l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la
Fine” di tutta la storia umana132. In rapporto a tale contesto tutti gli accadimenti umani
furono connessi in un’unificante prospettiva di senso, nel cui ambito l’uomo fu destinato ad
essere protagonista. Il tempo fu fatto dipendere dalla sua iniziativa intelligente e
responsabile, che lo ordina e lo guida, e divenne storia. Sulla base di questo schema
Agostino costruì il De civitate Dei (413-430), in cui espose una superba teologia della
storia, che fu poi profondamente assimilata dalla cultura medievale. Egli predispose il
paradigma generale per le successive filosofie della storia, che saranno proposte nel corso
131
Aristotele, Poetica, 9, 1451 b 6, trad. di M. Valgimigli, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973, p.
211
132
Apocalisse, 22, 13
211
dei secoli anche in forme non più trascendentistiche, ma immanentistiche e secolarizzate,
nelle quali la Provvidenza divina sarà sostituita da qualche altra entità (la Ragione, lo
Spirito, l’Umanità, la Nazione, ecc.), ma con la stessa pretesa di cogliere nel divenire degli
eventi un senso globale e oggettivo, finalisticamente orientato. → Provvidenza
Possiamo constatare che nella nostra cultura, anche in tempi di diffusa secolarizzazione
dell’antica fede e dei suoi dogmi, permane l’importanza di questo umanesimo originario,
che attribuisce al nostro impegno progettuale e responsabile la costruzione del mondo.
Lo storicismo vichiano
Nel XVIII secolo Giambattista Vico elaborò una generale filosofia della storia con
l’ambizione di farne una “scienza nuova”, per dar conto del processo di civilizzazione degli
uomini nel corso del tempo. Il risultato fu l’opera intitolata Principi di scienza nuova
d’intorno alla comune natura delle nazioni, pubblicata in tre successive stesure (1725,
1730, 1744). Vico osservò che avrebbe dovuto suscitare meraviglia la scarsa attenzione
prestata dai filosofi ad un tale oggetto, perché “questo mondo civile egli certamente è stato
fatto dagli uomini”, quindi essi “ne potevano conseguire la scienza”. Invece “i filosofi
seriosamente si studiarono di conseguire la scienza di questo mondo naturale, del quale,
perché Iddio egli il fece, esso solo ne ha la scienza”133. Come la geometria, che tuttavia è un
sapere astratto, fu costruita dagli uomini a partire da principi evidenti, così avrebbe dovuto
fare questa “scienza nuova”: procedere secondo uno sviluppo deduttivo da verità
assiomatiche, denominate da Vico “degnità”. Questo voce di origine latina traduce
letteralmente la parola greca ἀξίωμα (aksíoma), che per la sua derivazione da ἄξιος (áxios:
degno), significa “ciò che è degno di considerazione”. Il filosofo napoletano, infatti, ritiene
che nelle varie vicende attraversate nel tempo dai popoli più diversi sia possibile
individuare ciò che hanno di comune, ossia le leggi che presiedono al loro corso secondo un
ordine non effimero né contingente, ma universale e costante. Le “degnità” intendono
evidenziare queste norme interpretative della storia umana.
La storia come scienza, secondo Vico, va realizzata con i contributi che le derivano dalla
filosofia e dalla filologia. Per “filologia” egli intendeva in senso ampio la documentazione
dei fatti del passato. Da essa “viene la coscienza del certo”, cioè di tutto ciò che è possibile
sapere delle vicende dei popoli; e filologi sono “tutti i gramatici, istorici, critici, che son
occupati d’intorno alla cognizione delle lingue e de’ fatti de’ popoli, così in casa, come
sono i costumi e le leggi, come fuori, quali sono le guerre, le paci, l’alleanze, i viaggi, i
commerzi”134. Dalla filosofia, invece, “viene la scienza del vero”, cioè la determinazione
delle cause universali e necessarie, che possono spiegare il senso profondo e non
contingente degli eventi. Nella realizzazione della “scienza nuova” la filosofia e la filologia
sono complementari, perché la storia non è una congerie di semplici fatti, magari
rigorosamente accertati e descritti, ma privi di un senso complessivo che li renda
intelligibili, né può risolversi soltanto nell’individuazione di un senso universale che non
faccia concreto riferimento ai popoli effettivamente esistenti e operanti.
La convinzione dell’invariabilità della natura umana permise a Vico di far emergere la
stretta analogia tra le fasi di sviluppo dell’individuo e quelle attraversate dai popoli nei loro
processi storici: l’età degli dei corrisponde all’infanzia, l’età degli eroi corrisponde alla
maturazione adolescenziale e l’età degli uomini corrisponde allo stato adulto. In esse
maturano e si esprimono in successione le caratteristiche facoltà psichiche: i sensi, la
fantasia e la ragione, per cui “gli uomini prima sentono senz’avvertire, dappoi avvertiscono
133
134
G.B. Vico, La scienza nuova, I, III, a cura di P. Rossi, Rizzoli, 1963, p. 158
G.B. Vico, La scienza nuova, I, II (Degnità X), cit., p. 109
212
con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura”135. Anche le
evoluzioni del carattere umano, della socialità e dello stile di vita procedono secondo i tre
momenti indicati. La storia è un percorso di lento risveglio dall’abbrutimento e
dall’immoralità, che si svolge attraverso l’educazione prodotta dal sentimento religioso, in
particolare dal timore suscitato dagli eventi traumatici della natura. L’istintività è
progressivamente sottoposta a controllo, affiorano il pudore e la pietà, da cui nascono
l’istituzione dei matrimoni e il culto dei morti136. Allo scopo di assicurare l’ordine sociale,
si vanno costituendo gli ordinamenti civili.
La nostra condizione esistenziale rimane, tuttavia, precaria nelle sue realizzazioni, perché
i risultati di civiltà e moralità precedentemente raggiunti possono essere compromessi.
Infatti abbiamo modo di accertare documentalmente la decadenza del mondo classico e il
suo precipitare nella “barbarie ritornata” del Medioevo, dalla quale faticosamente i popoli
andarono progressivamente riprendendosi in un nuovo processo di moralizzazione e
civilizzazione. È la successione di “corsi e ricorsi” storici: il ricorso storico interviene
quando lo scetticismo ha corrotto la filosofia, l’anarchia e le guerre civili hanno prodotto un
generale disordine e la corruzione non è più rimediabile con interventi eccezionali di breve
durata; allora appare inevitabile che al lento e provvidenziale risveglio del sentimento
religioso sia riaffidato il riscatto dalla barbarie.
Vico conferì alla storia un senso unitario e un intrinseco finalismo ricorrendo alla
tradizionale dottrina teologica della provvidenza, che egli derivò soprattutto dalla
riflessione agostiniana. Ritenne di poter elaborare “una teologia civile ragionata della
provvedenza divina”. Secondo questa concezione gli uomini, “tiranneggiati dall’amor
proprio”, apparentemente cercano nelle varie circostanze la propria egoistica utilità, ma ciò
che conseguono, al di là delle loro intenzioni e per la presenza inavvertita della provvidenza
divina, è un risultato d’ordine e di giustizia. In particolare, “l’uomo nello stato bestiale ama
solamente la sua salvezza; presa moglie e fatti figliuoli, ama la sua salvezza con la salvezza
delle famiglie; venuto a vita civile, ama la sua salvezza con la salvezza delle città; distesi
gl’imperi sopra più popoli, ama la sua salvezza con la salvezza delle nazioni; unite le
nazioni in guerre, paci, allianze, commerzi, ama la sua salvezza con la salvezza di tutto il
gener umano”137. In questi sorprendenti e positivi effetti complessivi di azioni, che
individualmente e in prima istanza sono motivate dall’egoismo, consiste ciò che
nell’Ottocento Wilhelm Wundt denominerà “eterogenesi dei fini” e che nella parte
conclusiva della Scienza nuova ci è riproposta in questi termini: “Egli è questo mondo,
senza dubbio, uscito da una mente spesso diversa ed alle volte tutta contraria e sempre
superiore ad essi fini particolari ch’essi uomini si avevan proposti; quali fini ristretti, fatti
mezzi per servire a fini più ampi, gli ha sempre adoperati per conservare l’umana
generazione in questa terra”138. Così, per esempio, dagli impulsi della libidine sortirono i
matrimoni e le famiglie, dalle ambizioni del potere e dalle rivendicazioni scomposte della
libertà nacquero le leggi e si organizzò una condizione di giustizia sociale e civile. →
Eterogenesi dei fini
L’ordine nelle vicende umane è garantito da “una storia ideal eterna, sopra la quale corron
in tempo le storie di tutte le nazioni ne’ loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e
135
ivi, I, II (Degnità LIII), p. 128
È quanto Ugo Foscolo, tra i primi estimatori di Vico, ha voluto riprodurre in versi famosi nel suo carme Dei
sepolcri: “Dal dì che nozze tribunali ed are / dier alle umane belve esser pietose / di se stesse e d’altrui” (vv. 9193)
137
La scienza nuova, cit., I, IV, pp. 165-166
138
ivi, V, p. 590
136
213
fini”139. In tal modo Vico configurò la storia secondo uno schema dualistico di ispirazione
platonica: essa non si esaurisce nei semplici fatti suscettibili di un accertamento filologico,
ma attinge il suo senso da una struttura permanente e normativa, che ne garantisce un esito
complessivo non fallimentare. La “storia ideal eterna”, come il mondo ideale platonico,
trascende la dimensione empirica, alla quale si propone come un modello che molto
imperfettamente noi possiamo tentar di adeguare. Essa, in quanto motivo conduttore di un
piano che nel tempo si realizza, è provvidenzialmente presente nel nostro mondo. La
“scienza nuova” della storia deriva dal progressivo emergere della consapevolezza di
questo piano nel tempo stesso in cui gli uomini lo vanno attuando.
La considerazione illuministica della storia: Voltaire
Secondo la filosofia illuministica la storia è un processo di perfezionamento, di riscatto
dalla miseria e dall’ignoranza, che tuttavia è sempre insidiato dal rischio di essere interrotto
nel suo svolgimento. Pensatori importanti, quali Voltaire e Kant, ne ebbero una visione
problematica, perché, a loro giudizio, il progresso umano non è assicurato da alcun
automatismo; al contrario noi dobbiamo da un lato tener conto delle condizioni oggettive e
ineludibili della natura, nelle quali si svolge e i cui eventi possiamo prevedere e controllare
solo in minima parte, dall’altro siamo eticamente impegnati a prodigarci per la sua
realizzazione, la quale, pertanto, è una possibilità affidata al nostro libero agire. Voltaire,
per esempio, osservò: “Dicono che il mondo vada sempre più affinandosi, se pure
lentamente. Ma il fatto è che, dopo essersi ripulito per un bel po’ di tempo, gli accade pure
di ricadere nel fango: a secoli di civiltà seguono secoli di barbarie. Barbarie che viene poi
vinta, ma può sempre ricomparire: è come l’alternarsi continuo del giorno e della notte”140.
La ragione illuministica si esprime in maniera critica verso un passato che tiene vincolati
gli uomini con i suoi dogmi e le sue superstizioni; perciò s’impegna a favorire la loro
emancipazione mediante un positivo sviluppo della conoscenza e del benessere.
Voltaire realizzò un rinnovamento di ampio respiro della storiografia, ritenendo che la
ricostruzione del passato non si potesse più limitare ad una serie di episodi e vicende
dinastiche, secondo il modello dell’histoire événementielle, cioè della semplice cronaca
minuta, ma dovesse rivolgere il suo interesse alla cultura e alle varie manifestazioni della
vita di un’epoca intera. Con questo intento scrisse il Saggio sui costumi e lo spirito delle
nazioni del 1756. In esso, poi, egli criticò la tradizionale “manomissione teologica”
(mainmise théologique), che era stata recentemente riconfermata dal Discorso sulla storia
universale (1681) del vescovo Jacques-Bénigne Bossuet, il quale, nel riproporre la consueta
interpretazione provvidenzialistica della storia, si era sentito in obbligo di costruire una vera
e propria teodicea, allo scopo di giustificare Dio di fronte alla realtà del male. Una
preoccupazione di tal genere, a giudizio di Voltaire, vanificava la verità oggettiva degli
eventi e alimentava il fanatismo. Sia nel Poema sul disastro di Lisbona (1755) sia nel noto
racconto intitolato Candido (1759) Voltaire considerò un insulto alla sofferenza umana la
dottrina per la quale “tutto è bene”; irrise perciò l’ingenuo ottimismo di Leibniz, per il
quale il nostro è “il migliore dei mondi possibili” (→ Teodicea). La storia è una faccenda
tutta umana e l’unica saggezza possibile è raccolta metaforicamente nella lezione, che alla
fine del noto racconto Candido il protagonista fa propria: “Bisogna che coltiviamo il nostro
orto”, il cui senso consiste nell’invito ad accettare i limiti della nostra condizione e ad
139
ivi, I, IV, p. 169
Voltaire, Dizionario filosofico, a cura di M. Bonfantini, Mondadori (Oscar), 1974, voce “Miracoli”, pp. 485486
140
214
esercitare senza presunzione né disfattismo l’impegno quotidiano per un possibile
miglioramento del mondo.
La considerazione illuministica della storia: Immanuel Kant
Seguendo coerentemente le indicazioni date nella seconda e nella terza Critica, Immanuel
Kant ritenne che nell’interpretazione della storia umana si potesse assumere un’ottica
finalistica, opposta al determinismo con il quale consideriamo la natura. Egli si soffermò su
questa tematica in particolare in due brevi scritti: Idea di una storia universale dal punto di
vista cosmopolitico (1784) e Per la pace perpetua (1795). Affermò che è possibile parlare
di un disegno insito nella storia, facendo un uso regolativo e non costitutivo dei concetti di
fine e di totalità (o unità complessiva, teleologicamente concepita), che consentono di
rintracciare “un filo conduttore” nel corso degli eventi. Emerge così, secondo Kant, l’idea
di un progresso della storia umana, che non va inteso come lo svolgimento predeterminato e
necessario della nostra vita sociale, perché non siamo come le api e i castori; esso, invece, è
come il procedere di un piano possibile, che si realizza secondo un ideale orientativo, al
quale ci ispiriamo nel nostro agire. Come già Vico nella sua “teologia civile ragionata della
provvedenza divina”, Mandeville nella Favola delle api e Smith nella teoria della “mano
invisibile” (→ Vizio), anche Kant scorse nell’agire apparentemente scoordinato dei vari
agenti storici non la condizione di un generale disordine, ma l’opportunità che favorisce
una crescita complessiva, di cui tutti beneficiano. Egli osservò che “singoli individui ed
anche interi popoli non pongono mente al fatto che, pur perseguendo i loro particolari fini,
ognuno a suo modo e spesso in contrasto con gli altri, procedono in realtà inavvertitamente
secondo il filo conduttore di un disegno della natura e promuovono quell’avanzamento che
essi stessi ignorano”141. È ciò che, in riferimento a Vico, abbiamo designato come
“eterogenesi dei fini”.
A questo proposito, inoltre, Kant notò che “la grande artefice natura (natura daedala
rerum)” talora “è denominata destino in quanto si afferma come necessità di una causa
efficiente, che opera secondo leggi sue proprie a noi ignote; ma considerata nella sua
finalità nel corso del mondo, la chiamiamo Provvidenza, in quanto si rivela come profonda
sapienza di una causa più alta rivolta al fine ultimo oggettivo della specie umana e
predeterminante questo corso del mondo”142. Parlare di “provvidenza” potrebbe apparire
temerario e frutto di un pensiero dogmatico; ha, invece, un senso criticamente accettabile,
se lo si connette alla caratterizzazione etica dell’ordine storico, che deriva dalla
consapevolezza del dovere che promana dalla nostra umana razionalità. Kant non affrontò il
problema dell’ordine sociale e della pace secondo un’interpretazione empiristica, ossia in
base alla considerazione dell’universale inclinazione all’utile o del calcolo delle
complessive convenienze, ma secondo le imprescrittibili esigenze dell’imperativo morale,
che con la riformulazione di un noto invito evangelico così recita: “Mirate innanzitutto al
regno della ragion pura pratica e alla sua giustizia, e il vostro scopo vi sarà dato da sé (il
beneficio della pace perpetua)”143. Il progresso, pertanto, va inteso come lo sviluppo della
nostra razionalità, che si realizza in un processo di civilizzazione e tende a far prevalere
universalmente il diritto.
Il grande filosofo tedesco rilevò che nella natura umana c’è un’“insocievole
socievolezza”, ossia la compresenza di aspetti contrastanti, solo apparentemente
141
I. Kant, Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti di filosofia politica, a cura di
D. Faucci, La Nuova Italia, 1990, p. 2
142
I. Kant, Per la pace perpetua, in Scritti di filosofia politica, cit., pp. 115-117. L’espressione latina citata è di
Lucrezio (De rerum natura, V, 234).
143
ivi, p. 147. La citazione interna è del vangelo di Matteo, 6, 34
215
paralizzanti o distruttivi, perché la creatività delle risorse individuali realizza una positiva
condizione generale, di cui tutti possono beneficiare. L’uomo, infatti, “ha un’inclinazione
ad associarsi, […] ma ha anche una forte tendenza a dissociarsi, poiché egli ha del pari in sé
la qualità antisociale di voler tutto rivolgere solo al proprio interesse, per cui si aspetta
resistenza da ogni parte e sa ch’egli deve da parte sua tendere a resistere contro altri. Questa
resistenza eccita tutte le energie dell’uomo, lo induce a vincere la sua tendenza alla pigrizia
e, spinto dal desiderio di onori, di potenza, di ricchezza, a conquistarsi un posto tra i suoi
consoci, ch’egli certo non può sopportare, ma di cui non può neppure fare a meno” 144.
Tuttavia la libertà di ciascuno non è puro arbitrio, perché trova il proprio limite nella libertà
altrui. Nell’ambito della società civile, nella quale si fa valere il diritto a beneficio di tutti,
l’uomo realizza al meglio se stesso e l’antagonismo è inevitabilmente portato ad
autodisciplinarsi. Pertanto, “a subire questo stato di coazione l’uomo, a cui pure la libertà
senza limiti sarebbe così cara, è costretto dalla necessità, e precisamente dalla maggiore di
tutte le necessità, quella di sottrarsi ai mali che gli uomini si recano a vicenda. Le loro
tendenze fanno sì che essi non possano durare a lungo assieme in selvaggia libertà.
Sennonché, nel chiuso recinto della società civile, anche siffatti impulsi danno il migliore
effetto, così come gli alberi in un bosco, per ciò che ognuno cerca di togliere aria e sole
all’altro, si costringono reciprocamente a cercare l’una e l’altro al di sopra di sé e perciò
crescono belli e diritti, mentre gli alberi che in libertà e lontani tra loro mettono rami a
piacere, crescono storpi, storti e tortuosi”. La costruzione di una società civile, in cui valga
universalmente il diritto, è “il più grande problema” della nostra specie, ad affrontare il
quale la natura ci sospinge, ma occorre riconoscere che “una soluzione perfetta di esso è
impossibile: da un legno storto, come è quello di cui l’uomo è fatto, non può uscire nulla di
interamente diritto. Solo l’approssimazione a questa idea ci è imposta dalla natura”145. Kant
riconfermò così la propria consapevolezza dei limiti della condizione umana e l’impegno
illuministico ad evitare ogni fanatismo.
Successivamente nella prima parte della Metafisica dei costumi (1797), dedicata ai
Principi metafisici della dottrina del diritto, Kant teorizzò, in termini consoni con la sua
concezione trascendentale dell’etica, lo Stato liberale, configurandolo come uno Stato di
diritto e come una persona morale, che riassume in sé le molteplici volontà degli individui.
Il diritto deve garantire nella società una coesistenza ordinata e rapporti disciplinati da
norme razionali. La libertà è considerata dal diritto nelle sue manifestazioni esterne,
essendo quella interna di pertinenza dell’agire morale, su cui si intrattiene la seconda parte
dell’opera, dedicata ai Principi metafisici della dottrina della virtù. Il diritto ha la funzione
di tutelare la libertà esterna in base al principio pratico per cui ognuno deve agire in modo
tale che il suo arbitrio possa coesistere con quello di tutti gli altri secondo una legge
universale.
La concezione organicistica della storia nel Romanticismo: J. Fichte e G. Hegel
Nel Romanticismo la riflessione filosofica sulla storia fu sollecitata dal sommovimento
epocale, che coinvolse tutte le nazioni europee. Giambattista Vico fu letto con interesse. Si
elaborarono visioni universali, che riproposero in forme razionalizzate la tradizionale
teologia della storia. La storia umana apparve come un processo teleologicamente orientato
a rivelare progressivamente, in una specie di teofania, lo Spirito universale (Weltgeist) e
infinito, dopo che si è via via manifestato nello Spirito di quei popoli (Wolksgeist), che sono
riusciti ad imporsi agli altri come guide. A giudizio di Fichte e Hegel, questo destino, nel
144
145
I. Kant, Idea di una storia universale …, cit., p.7
ivi, pp. 9-12
216
tempo che essi stavano vivendo, spettava ormai al popolo germanico, sempre più
consapevole della propria superiorità culturale.
Secondo Hegel la storia può sembrare un insieme di fatti contingenti e insignificanti
soltanto in una statica visione intellettiva, che non è in grado di assumere l’ottica della
ragione universale e assoluta. Soltanto la ragione dialettica sa evidenziare la logica
immanente degli eventi umani e la loro teleologia. Perciò “dobbiamo ricercare nella storia
un fine universale, il fine ultimo del mondo, e non uno scopo particolare dello spirito
soggettivo [...] Il punto di vista della storia filosofica non è uno fra i molti punti di vista,
astrattamente prescelto, in modo che in esso si prescinda dagli altri. Il suo principio
spirituale è la totalità di tutti i punti di vista”146.
Il fine della storia è la progressiva realizzazione della libertà dello spirito, che non è
l’arbitrio del singolo, ma coincide con la consapevolezza che il vero interesse consiste nel
bene universale. Soltanto in apparenza gli individui perseguono nella storia le loro personali
ambizioni; in realtà è “l’astuzia della Ragione”147 universale che si serve di essi per attuare i
propri scopi. Anche Hegel riconferma in forma superba la convinzione che nella storia vige
l’“eterogenesi dei fini”.
Lo storicismo positivistico: Claude-Henri de Saint-Simon e Auguste Comte
Il positivismo ottocentesco espresse una grande fiducia negli epocali cambiamenti che la
rivoluzione industriale stava provocando.
Per Claude-Henri de Saint-Simon, di cui citiamo lo scritto intitolato Della riorganizzazione
della società europea (1814), da lui elaborato insieme allo storico A. Thierry, la storia si
configura come una successione di epoche organiche, sostanzialmente stabili, e di epoche
critiche. La possibilità di fuoriuscire da una lunga instabilità, che dalla fine del Medioevo e
dalla riforma protestante aveva portato alla rivoluzione francese, era da lui connessa alla
riorganizzazione sociale e culturale che l’industrializzazione inevitabilmente doveva
produrre. Nella nuova età “positiva”, che si andava aprendo, la società doveva più essere
guidata non più dalle classi oziose ormai al tramonto (clero e nobiltà), la cui scomparsa,
secondo una sua nota parabola del 1819 sugli oziosi e i produttori, non avrebbe procurato
alcun danno, ma dagli scienziati, dai tecnici e dagli industriali, la cui improvvisa ipotetica
perdita avrebbe invece comportato l’immiserimento di tutti.
Anche Auguste Comte, di cui menzioniamo il Corso di filosofia positiva (in 6 volumi,
1830-1842), elaborò una filosofia, che, in connessione all’idea di progresso, esprimeva la
pretesa di cogliere il senso globale e oggettivo della storia. Lo “storicismo” di Comte
presentava somiglianze con quello di Hegel e con la sua dichiarata identità tra razionalità e
realtà, nonostante la diversa impostazione generale delle loro filosofie. Assunse perfino
caratteristiche religiose, pensate tuttavia in una prospettiva d’immanenza: esaltò
romanticamente l’Umanità, identificandola con la tradizione storica del genere umano, e
proclamò che ai suoi “santi”, cioè gli scienziati, dovesse essere tributato il culto della
memoria, secondo un nuovo “calendario positivista”. → Positivismo
Il materialismo storico di Karl Marx
Karl Marx con la teoria del materialismo storico diede la propria interpretazione generale
della storia, nella cui prospettiva l’attuazione del comunismo è determinata dalla dialettica
immanente ai processi economico-sociali del capitalismo industriale. Anche agli occhi di
146
147
G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, I, La Nuova Italia, 1981, pp. 8-9
ivi, p. 97
217
Marx la storia ha un carattere progressivo e si configura come una totalità dotata di un
immanente finalismo. Si consideri la voce → Materialismo storico
La critica allo storicismo contemporaneo di Søren Kierkegaard
Nel periodo romantico ci fu chi andò in controtendenza. Søren Kierkegaard, per esempio,
notò con autentico raccapriccio che si stava pericolosamente profilando il misconoscimento
dell’individuo nei processi storici di massificazione, che andavano preparando i nuovi
tempi. Perciò osservava: “L’esistenza dell’esistente diventa insignificante” e “raramente o
mai si sente qualcuno parlare come se fosse consapevole di essere un singolo uomo
esistente, ma ci si lascia travolgere dalla vertigine panteistica con tutto quel parlare di
milioni e di stati e di sviluppo storico-universale”148. Il suo pensiero era assai lontano dagli
interessi propugnati dalle teorie contemporanee più in voga, in particolare dalle loro
filosofie della storia. Abissale era soprattutto la sua distanza da Hegel. Egli era convinto
che la storia dell’uomo, nei suoi processi collettivi, non sia di per sé la rivelazione
dell’Assoluto (teofania). Tra Dio e l’uomo c’è una differenza infinita, superabile solo per
iniziativa gratuita e imprevedibile di Dio nella dimensione dell’“istante”, vero “atomo
d’eternità” che irrompe nel tempo; in esso “il tempo e l’eternità si toccano [...] Il tempo
taglia continuamente l’eternità e l’eternità continuamente penetra il tempo”149. L’intervento
di Dio nella storia umana non è preordinato da alcunché di naturale e di umano, perché è
puro dono salvifico e grazia, rivolta al singolo nella sua interiorità.
Friedrich Nietzsche: la critica allo storicismo e la prospettiva dell’eterno ritorno
Anche Friedrich Nietzsche si mosse in controtendenza rispetto alla dominante concezione
storicistica. Egli criticò aspramente la pretesa hegeliana di interpretare la storia come un
processo finalisticamente orientato e razionalmente garantito. Nella giovanile seconda
“Considerazione inattuale”, Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874), così si
espresse: “La storia hegelianamente intesa la si è chiamata con scherno il cammino di Dio
sulla terra [...] questo Dio è diventato nei crani hegeliani trasparente e comprensibile a se
stesso [...] sicché per Hegel il vertice e il punto terminale del processo del mondo si sono
identificati con la sua stessa esistenza berlinese. [...Hegel] ha istillato nelle generazioni da
lui lievitate quell’ammirazione di fronte alla ‘potenza della storia’, che praticamente si
trasforma a ogni istante in nuda ammirazione del successo e conduce all’idolatria del fatto
[...] Ma chi ha imparato a incurvare la schiena e a piegare la testa davanti alla ‘potenza della
storia’, in guisa cinesemente meccanica fa da ultimo cenno di ‘sì’ a ogni potenza, sia poi
questa un governo o un’opinione pubblica o una maggioranza numerica [...] Se ogni
avvenimento è la vittoria di ciò che è logico o dell’‘idea’, allora ci si metta subito giù in
ginocchio e si percorra poi inginocchiati l’intera scala dei ‘successi’!”150
La formazione filologica di Nietzsche, poi, non poteva evitare di confrontarsi con
l’imponenza degli studi storici prodotti dalla cultura tedesca del XIX secolo. A questo
riguardo, il suo criterio di giudizio era costituito dal riferimento ai valori vitali: “Solo in
quanto la storia serva la vita, vogliamo servire la storia: ma c’è un modo di coltivare la
storia e una valutazione di essa, in cui la vita intristisce e degenera”151. Egli rilevò tre modi
di fare storia: a) “monumentale”, per chi ha bisogno di modelli da emulare; b) “antiquario”,
148
S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica, parte II, c. 3. § 1, in Opere, a cura di C. Fabro, Sansoni,
1972, p. 430
149
S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, a cura di C. Fabro, Sansoni, 1953, p. 110
150
F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, in Opere complete, a cura di G. Colli e M. Montinari
, Adelphi, 1972, vol. III/1, pp. 327-8
151
ivi, p. 259
218
che è proprio di “colui che guarda indietro con fedeltà e amore verso il luogo donde
proviene”152; c) “critico”, perché “ogni passato merita di essere condannato” e “non è la
giustizia che siede qui a giudizio, ma soltanto la vita”153. Degli studi storici, che i tedeschi
realizzavano con grande dovizia, Nietzsche diede un giudizio impietoso: “Inorridiamo [...]
Il sapere storico sgorga sempre di nuovo da sorgenti inesauribili [...] la memoria apre tutte
le sue porte [...] il sapere viene preso in eccesso, senza fame, anzi contro il bisogno, oggi
non opera più come motivo che trasformi e spinga verso l’esterno, ma rimane nascosto in
un certo caotico mondo interno, che l’uomo moderno designa con strana superbia come
l’‘interiorità’ a lui propria”154. La nostra cultura moderna non è niente di vivo, perché “essa
non è affatto una vera cultura, ma solo una specie di sapere intorno alla cultura”155; “non
caviamo niente da noi stessi; solo riempiendoci e stipandoci di epoche, costumi, arti,
filosofie, religioni e conoscenze estranee, diventiamo qualcosa di degno di considerazione,
ossia enciclopedie ambulanti [...] ‘culturalità’ moderna [...] noi Tedeschi del presente più di
altri popoli abbiamo da soffrire di quella debolezza di personalità e della contraddizione fra
contenuto e forma”156.
Alcuni anni dopo contro ogni concezione finalistica della storia Nietzsche propose l’idea
dell’“eterno ritorno dell’identico”. Essa occupò con forza la sua mente, tanto che se ne
dichiarò “folgorato”, considerandola “il più abissale” dei suoi pensieri. L’interpretazione di
questa teoria non appare agevole, essendo connessa a parole e a immagini suggestive,
presenti soprattutto in Così parlò Zarathustra (1883-85). Non sembra, tuttavia, che la si
debba intendere come una tesi cosmologica, che riproporrebbe concezioni antiche
(pensiamo agli stoici); lo esclude la coerenza con cui Nietzsche sempre si rifiutò di
interpretare la realtà in maniera obiettivistica; ogni teoria, infatti, per lui rispondeva
“genealogicamente” a istanze vitali. Spogliata dal rigoglio di metafore in cui è inserita, essa
corrisponde sostanzialmente al rifiuto della concezione lineare e teleologica del tempo
propria della tradizione occidentale cristiana e di quelle sue versioni laiche, che sono i vari
storicismi, per esempio quello dialettico hegeliano o quello positivistico connesso alla
prospettiva del progresso o quello socialista proteso verso una futura società di giustizia
realizzata. Nello svolgimento progressivo e finalistico del tempo ogni momento è
funzionale ad un senso che sta fuori di esso. Rifiutare questa interpretazione significava,
negli intendimenti di Nietzsche, escludere ogni trascendenza di senso rispetto al momento
che si sta vivendo e pretendere che questo momento abbia un compiuto significato in se
stesso. In sostituzione della figura lineare interviene il circolo, metafora dell’immanenza.
L’attimo, che merita di essere vissuto per se stesso come se fosse eterno, realizza di volta in
volta la struttura del circolo, perché riassume puntualmente in sé e nella compiutezza del
suo significato la totalità del tempo. Soltanto un über-mensch (“oltre-uomo”), tramite la
volontà di potenza, sarà in grado di realizzare nell’“attimo” della decisione creatrice
l’“eterno ritorno dell’identico”, perché dimostrerà di saper attuare il superamento della
condizione d’impotenza nella quale noi ancora ci dibattiamo (“nichilismo passivo”),
rifiuterà l’autorepressione imposta dalla morale, accetterà la libera manifestazione della sua
naturalità e delle forze vitali, valorizzando il corpo e i suoi istinti. Realizzando la
“trasvalutazione dei valori”, egli imporrà le sue proprie interpretazioni al caos della vita e al
mondo, ricreerà l’essere adeguandolo alle sue libere iniziative. Ciò che per noi è la
scimmia, “questo ha da essere l’uomo per il superuomo: un ghigno o una vergogna
152
ivi, p. 280
ivi, p. 284
ivi, pp. 287-8
155
ivi, p. 346
156
ivi, pp. 289-90
153
154
219
dolorosa. [...] Il Superuomo è il senso della terra”157. La volontà di potenza dell’übermensch sarà una redenzione delle cose, perché consisterà nell’accettazione affermativa e
giustificatrice del mondo: ogni “così fu” diverrà “così volli che fosse”, “così voglio” e “così
vorrò”, volendolo “riavere per tutta l’eternità” [...] così come esso è stato ed è, gridando
insaziabilmente: ‘da capo’”158.
Lo “storicismo assoluto” di Benedetto Croce
Benedetto Croce respinse con intransigenza la nozione stessa di “filosofia della storia”,
nonostante la ritrovasse nello stesso Hegel. La dichiarò insostenibile perché essa:
considera la filosofia come una comprensione superiore ed esterna, che pretende di dar
senso alla storia, come un pensiero che integra lo svolgersi degli eventi in una
prospettiva unitaria che lo trascende;
propone una “storia universale”, che considera solo astrattamente la globalità del
percorso, trascurando le effettive vicende e le loro connessioni;
si presenta come un sistema chiuso e definitivo, in cui il processo dialettico si annulla
nell’epilogo di una sintesi finale senza più progressi.
Croce denominò la propria filosofia “storicismo assoluto”, perché corrispondeva alla
“affermazione che la vita e la realtà è storia e nient’altro che storia”159; infatti, tutto ciò che
è, evidenzia un processo perennemente in atto e ogni giudizio di conseguenza è un giudizio
storico. Il dinamismo dialettico dell’essere è di natura spirituale; perciò ogni realtà, per il
semplice fatto di essere pensata, va ricondotta ad una dimensione essenzialmente spirituale.
Così, per esempio, egli si espresse: “Poiché un fatto è storico in quanto è pensato, e poiché
nulla esiste fuori del pensiero, non può avere senso alcuno la domanda: quali siano i fatti
storici e quali i fatti non istorici. Fatto non istorico varrebbe fatto non pensato, e perciò
inesistente; e nei fatti inesistenti non accade mai, che si sappia, d’imbattersi. A un pensiero
storico si congiunge e segue un altro pensiero, e poi un altro, e un altro ancora; e, quanto
lungi navighiamo nel gran mare dell’essere, non usciamo mai dal ben definito mare del
pensiero”160. Qui lo spirito non è la personificazione di un ente divino, ma è la stessa attività
umana nella sua universalità ed eternità; in questo senso esso vive soltanto nei singoli
individui, ma non si riduce ad essi. La realtà è spirito ed è storia, così come la filosofia è
storia: “Il concetto, al quale siamo pervenuti della storia - che non ha fuori di sé i suoi
documenti ma in sé, che non ha fuori di sé la sua spiegazione causale e finale ma in sé, che
non ha fuori di sé ma in sé la ragione del suo determinato configurarsi e il suo ritmo identifica la storia con l’atto stesso del pensiero, che è sempre filosofia e storia insieme” 161.
Pertanto la storia non è una semplice esposizione di fatti accaduti, cioè filologia, ma è la
comprensione concettuale della razionalità in essi immanente, cioè filosofia; inoltre è
sempre storia contemporanea, perché, tramite la riflessione dello storico, rivive nel
presente. In questo senso filosofia e storiografia si identificano: ogni giudizio sulla realtà è
un giudizio storico, in cui il soggetto è sempre un fatto particolare ed il predicato è un
concetto, che lo inquadra in un ordine universale, ne esplicita il senso e con ciò lo
giustifica.
Croce pensò che il proprio storicismo non potesse essere considerato una forma di
metafisica, perché era convinto che aderisse concretamente alla realtà, di cui rilevava il
157
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, in Opere complete, cit., vol. VI/1, 1973,, p. 6
F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, in Opere complete, cit., vol. VI/2, 1968, 56, p. 61
B. Croce, La storia come pensiero e come azione, Laterza, 1966, p. 51
160
B. Croce, Teoria e storia della storiografia, Laterza, 1917, p. 95
161
ivi, p. 103
158
159
220
dinamismo spirituale. Quindi, poiché soltanto nel pensiero filosofico individuava il vero
sapere e rifiutava di riconoscere alla natura fisica una qualche autonomia rispetto allo
spirito, così egli ritenne di poter svilire le scienze naturali, considerandole come semplici
elaborazioni di pseudo-concetti d’ordine pratico-utilitaristico.
Le critiche allo storicismo elaborate da Karl R. Popper
Con il termine “storicismo” Karl R. Popper intese riferirsi ad ogni filosofia che attribuisce
all’insieme delle vicende umane un senso globale e oggettivo, cioè pretende che gli eventi
storici siano necessariamente diretti verso un fine unitario. Egli lo qualificò polemicamente
come “filosofia oracolare” e lo individuò in particolare in Hegel e in Marx.
Sono noti gli scritti nei quali trattò la questione dello storicismo, alla quale collegò anche
quella della democrazia: Miseria dello storicismo (1944) e La società aperta e i suoi nemici
(1945). Sollecitati dagli eventi tragici del ventesimo secolo, essi costituirono un tentativo di
difendere le ragioni della libertà e del pluralismo con argomentazioni d’ordine
epistemologico. Popper ritenne che non sia scientificamente sostenibile l’esistenza di un
senso della storia oggettivo e indipendente dalle nostre interpretazioni e dalla nostra
volontà, perché la storia ha il senso che noi le diamo. Invece “lo storicista non ammette che
siamo noi a selezionare e ordinare i fatti della storia, ma crede che la ‘storia stessa’ e la
‘storia del genere umano’ determini, per effetto delle leggi ad essa immanenti, noi stessi, il
nostro futuro e anche il nostro punto di vista”162. Inoltre, le ambizioni “olistiche” con cui lo
storicismo ci si presenta, nella dichiarata intenzione di comprendere la “totalità” o
l’“intero” della storia, non sono adeguate alle possibilità della scienza, perché “se
desideriamo studiare qualcosa, siamo costretti a sceglierne alcuni aspetti. [...] La
descrizione è sempre necessariamente selettiva”163. Lo storicismo “oracolare”, poi, non
adattandosi ad un approccio limitato ed empirico alla storia, tende a prospettarsela in forme
utopistiche ed estetizzanti, che esprimono il fanatismo di chi s’innamora dei propri sogni di
perfezione sociale. Pretendendo di dominare teoricamente in maniera “totalitaria” gli
svolgimenti storici, si dimostra alquanto corrivo a scambiare una linea di tendenza con una
legge, l’indicazione di un percorso possibile e probabile, che può anche cambiare, con lo
sviluppo di un percorso necessario. Infine, l’interpretazione teleologica dello storicismo
comporta la presunzione di derivare dalla cosiddetta “logica” della storia prescrizioni di
valore, che dallo studio scientifico dei fatti è vano attendersi: “Né la natura né la storia
possono dirci che cosa dobbiamo fare. I fatti, sia quelli della natura sia quelli della storia,
non possono decidere per noi, non possono determinare i fini che ci proporremo di
perseguire. Siamo noi che introduciamo finalità e significato nella natura e nella storia. […]
La storia […] non ha alcun fine o senso, ma noi possiamo decidere di conferirle l’uno e
l’altro”164. Questi rilievi ci ricordano considerazioni simili dell’epistemologia weberiana. →
Valore
Inaccettabili sul piano teoretico, gli storicismi si rivelano seriamente pericolosi sul piano
pratico, quando i loro “interpreti ufficiali” vogliono favorire la realizzazione delle loro
profezie attraverso il fanatismo rivoluzionario e la violenza intollerante contro chiunque si
opponga. Popper contrappose all’atteggiamento rivoluzionario quello riformista. Il primo
nasce da una forma di “estetismo”, che caratterizza chi si lascia prendere dal sogno
utopistico della perfezione, per attuare il quale si dimostra disponibile a legittimare la
violenza dei mezzi. La strategia riformistica, invece, prevede la gradualità degli interventi,
162
K.R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, vol. II, trad. di R. Pavetto, Armando, 1974, p. 353
K.R. Popper, Miseria dello storicismo, trad. di C. Montaleone, Feltrinelli, 1975, p. 77
164
K.R. Popper, La società aperta e i suoi nemici, vol. II, cit., p. 365
163
221
“un passo alla volta, confrontando con cura i risultati previsti con quelli effettivamente
raggiunti”165: è, questo, un procedimento tipicamente sperimentale, che consente di
correggere mezzi e obiettivi rapportandoli alle circostanze concrete e agli esiti
progressivamente conseguiti.
Storia e ontologia nel pensiero di M. Heidegger
Agli occhi di Martin Heidegger lo storicismo è una vistosa rappresentazione del nichilismo,
ossia di quell’oblio dell’Essere, prodotto dall’umanesimo tecnologico della nostra civiltà
(→ Nichilismo). Ecco che cosa afferma il filosofo tedesco a questo proposito ne Il detto di
Anassimandro (1946): “Lo ‘storicismo’ [Historismus] non solo non è superato a tutt’oggi,
ma soltanto ora comincia ad entrar nella fase della sua diffusione e del suo consolidamento.
L’organizzazione tecnica della pubblicità mondiale per mezzo della radio e della stampa
(che è già al suo seguito) costituiscono la forma autentica di predominio dello
‘storicismo’”166 (→ Tecnica). La distorsione prospettica, che Heidegger intendeva
denunciare, riguardava la “volontà di potenza”, con la quale l’uomo moderno è orientato ad
imporsi come “padrone dell’Essere”, invece di custodirne la verità come suo “pastore” (→
Essere), attento al destino storico che esso determina, sapendo che tutti gli enti poggiano sul
suo fondamento (Grund). Dell’Essere non è possibile enunciare una statica presenza,
perché ciò che lo riguarda è sempre un’accadere, un “evento” (Ereignis → Evento), che
costituisce strutturalmente la temporalità. L’Essere si dà nell’evento; si manifesta e si
nasconde al tempo stesso: da ciò il modo epocale del suo darsi, in virtù del quale il suo
presentarsi storico negli enti coincide con il suo assentarsi in se stesso, cioè nel suo mistero.
Heidegger collega il termine tedesco Epoche (epoca) al termine greco ἐποχή (epoché),
intendendo con quest’ultimo non la sospensione scettica o husserliana del giudizio, ma la
sospensione della rivelazione dell’Essere, che ha lasciato trasparire la propria verità nella
fase aurorale della Grecia antica, in vista di possibili nuove apparizioni. La correttezza della
comprensione filosofica è garantita dall’iniziativa stessa dell’Essere e dalla nostra
disponibilità a corrispondere al suo appello mediante un atteggiamento consono: l’“ascolto”
della sua verità, che è da intendersi come suo “dono”. È questo che Heidegger intende
quando parla di Geschick (destino) come origine della Geschichte, ossia della storia. →
Essere; Verità
Sempre ne Il detto di Anassimandro egli si chiede: “A che ci servono le filosofie della
storia costruite con criteri storiografici, quando esse non fanno che abbagliarci con la
raccolta sinottica di dati storiografici, pretendendo di spiegare la storia senza mai pensare i
fondamenti [Fundamente] dei suoi principi esplicativi a partire dall’essenza della storia, e,
questa, a sua volta, a partire dall’essere stesso? Siamo noi veramente gli ultimogeniti che
siamo?”167 Il millenario percorso storico del pensiero metafisico (→ Metafisica) in questo
Occidente, terra del tramonto, non ha necessariamente un esito catastrofico e apocalittico,
perché esso coincide con lo stesso “destino” chiaroscurale della verità dell’Essere, nel suo
disvelarsi e sottrarsi nel proprio mistero. Perciò, noi uomini dell’Occidente e figli della
civiltà tecnologica, possiamo essere “anche, nello stesso tempo, i precorritori dell’aurora di
una ben diversa epoca”168: non dobbiamo far altro che “aspettare l’estremo del mattino
165
K.R. Popper, Miseria dello storicismo, cit., p. 70
M. Heidegger, Il detto di Anassimandro, in Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, 1973, p. 304
167
ivi, p. 303
168
ivi, p. 304
166
222
nell’estremo della sera”; l’importante è che coloro che pensano “restino sulla breccia e
siano presenti al momento giusto”169.
La riflessione di K. Jaspers
Anche Karl Jaspers considerò doveroso confrontarsi con il problema della storia (Origine e
meta della storia, 1959). A suo giudizio la possibilità di un’interpretazione unitaria della
storia è giustificata dall’origine unica dell’umanità e dalla prospettiva unificante della sua
destinazione. La sua riflessione risulta improntata ad un evidente finalismo e sostenuta da
una forte sensibilità metafisica. Il fatto che abbia individuato un senso nella storia non
significa però che ad essa egli abbia assegnato una meta obbligata. La storia ai suoi occhi
rimane comunque problematica, perché è connessa alla pluralità delle concrete situazioni
individuali e sociali degli uomini ed è affidata allo svolgersi della loro libera
comunicazione e a ciò che questa può realizzare.
Nel tentativo di ricostruire un percorso unitario nel nostro passato, Jaspers rilevò il
determinarsi di una svolta (un “periodo assiale”) intorno al 500 a. C., nel processo spirituale
svoltosi tra l’800 e il 200, quando si affermarono le grandi religioni e la riflessione
filosofica dell’Oriente e dell’Occidente: Lao-Tzu e Confucio in Cina, Buddha in India, i
grandi profeti nella terra d’Israele, i filosofi greci. Ecco a questo riguardo alcune sue
significative parole: “Un asse della storia mondiale, supposto che ne esista uno, dovrebbe
essere trovato empiricamente, come un fatto valido, come tale, per tutti gli uomini,
compresi i cristiani. Tale asse dovrebbe essere situato nel punto in cui fu generato tutto
quello che, dopo d’allora, l’uomo ha potuto essere, nel punto della più straripante fecondità
nel modellare l’essere umano; esso dovrebbe essere per l’Occidente, per l’Asia e per tutti
gli uomini senza riguardo a un determinato contenuto di fede, se non empiricamente
cogente e palese, per lo meno così convincente dal punto di vista della penetrazione
empirica, da dar vita a una struttura comune di autocomprensione storica per tutti i popoli.
Questo asse della storia appare dunque situato intorno al 500 a. C., nel processo spirituale
svoltosi tra l’800 e il 200. Lì si trova la più netta demarcazione della storia. Allora sorse
l’uomo come oggi lo conosciamo”170. Per la prima volta una parte ragguardevole
dell’umanità cominciò ad elaborare al di fuori del mito una consapevole intuizione
metafisica dell’essere, colto nella sua totalità come “orizzonte onnicomprensivo” (→
Umgreifende), in cui è inserito e deciso il destino stesso dell’uomo. È individuabile in quei
secoli il tempo in cui l’uomo “pone domande radicali. Di fronte all’abisso anela alla
liberazione e alla redenzione. Comprendendo coscientemente i suoi limiti si propone
obiettivi più alti. Incontra l’assolutezza nella profondità dell’esser-se stesso e nella
chiarezza della trascendenza”171. Con l’esaurirsi dell’interpretazione mitologica del passato
si avviò un’importante fase di civilizzazione e presero piede quei valori riferiti alla
coscienza, alla razionalità e alla spiritualità, nei quali ancora oggi noi ci riconosciamo.
In prospettiva, poi, la caratterizzazione progressiva del mondo contemporaneo come età
della scienza e della tecnica, che fu predisposta dalla civiltà occidentale in un secolare
percorso di ricerca e studio e alla cui prosecuzione sembra essere destinata a partecipare
tutta l’umanità, potrebbe configurare un nuovo periodo assiale. Infatti, “a partire dalla fine
del Medioevo il mondo occidentale creò in Europa la scienza moderna e con essa, dopo la
fine del XVIII secolo, l’era della tecnica, il primo avvenimento interamente nuovo nella
M. Heidegger, La sentenza di Nietzsche: “Dio è morto”, in Sentieri interrotti, cit., p. 194
K. Jaspers, Origine e senso della storia, tr. it. nell’ediz. Comunità, 1965, cit. da U. Galimberti, Il tramonto
dell’Occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers, cit., p. 132
171
ivi, p. 134
169
170
223
sfera spirituale e materiale dopo il periodo assiale” dell’antichità172. Il nuovo percorso
storico può dare un ulteriore impulso all’unificazione dell’umanità, ma rimane ancora
aperto ad un futuro incerto e imprevedibile.
172
ivi, p. 135
224
T
TECNICA
È la forma sostantivata femminile dell’aggettivo “tecnico”, che qualifica ciò che è proprio
di un’arte (τέχνη, téchne). Per tecnica s’intende sia un insieme di regole operative, apprese
mediante l’esperienza e organizzate secondo procedure di efficienza, sia il complesso degli
strumenti, che consentono all’attività lavorativa di intervenire efficacemente sulla natura,
per soddisfare i molteplici bisogni umani (→ Arte; Lavoro; Bisogno). La tecnologia,
invece, è propriamente lo studio e la progettazione delle tecniche.
Il mito di Prometeo: la tecnica è una condizione necessaria del progresso umano
L’antica sapienza greca invitava l’uomo a non voler oltrepassare i limiti imposti dalla
natura: pretenderlo sarebbe stato tracotanza (ὕβρις, hýbris) e follia (ἄτη, áte), cioè
accecamento della mente, che porta sofferenza e tragedia. L’“ordine universale”, asseriva
Eraclito, “è lo stesso per tutti, non lo fece alcuno tra gli dei o tra gli uomini”. Anche l’uomo
ne è parte. Esso “governa tutte le cose”2.
Nonostante l’invito alla cautela, si fa strada la convinzione che, se non vuol correre alcun
rischio, l’uomo rimane il più inetto e il più misero tra i viventi, e che la sofferenza può,
invece, procurargli incalcolabili benefici. Non invano Prometeo aveva pagato duramente il
dono del fuoco agli uomini, perché con esso aveva offerto loro l’opportunità di un possibile
riscatto dalla miseria. Lo fa intendere la ripresa che di questo mito fa Platone nel
Protagora3. Alle origini della storia umana la sconsiderata superficialità di Epimeteo (=
l’imprevidente) aveva fatto sì che delle facoltà e abilità naturali, che egli per conto degli dei
aveva l’incarico di distribuire ai viventi, non rimanesse nulla per l’uomo, il quale pertanto
sembrò destinato ad una triste prospettiva, perché era “nudo, scalzo, senza giaciglio,
senz’armi”. A soccorrerlo intervenne Prometeo (= il previdente), che rubò ad Efesto e ad
Atena il fuoco e l’abilità tecnica. Ciò gli procurò la nota punizione divina, ma per l’uomo fu
la garanzia della sopravvivenza e del benessere; infatti, “unico tra gli animali […] con l’arte
ben presto articolò la voce in parole e inventò case, vestiti, calzari, giacigli e scoprì gli
alimenti che ci dà la terra”. Tuttavia, questa abilità non si dimostrò sufficiente, perché è
vero che gli uomini “cercarono allora di radunarsi e salvarsi fondando città; ma quando
facevan tanto da raccogliersi, si recavano offesa tra loro, appunto perché non possedevano
l’arte politica; sicché di nuovo si disperdevano e perivano”. Fu Zeus a prendere l’iniziativa
per salvarli, inviando Hermes “a portare agli uomini Rispetto e Giustizia, perché fossero
ordinatori della città e vincoli conciliatori di reciproco affetto”.
Il bellissimo mito illustra in maniera efficace la concezione progressiva della storia, che
nei secoli a venire caratterizzerà sempre più la cultura occidentale: essa non è più intesa
come un processo di decadimento da una presunta età felice delle origini, ma come un
2
Eraclito in I Presocratici, Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1975, vol. I,
“Frammenti”, 30, 72, pp. 202 e 212
3
Platone, Protagora, 320 c ss., in I Presocratici, Vol. 2, cit., pp. 899-901
225
percorso di civilizzazione, che l’uomo stesso ha il compito di realizzare con il lavoro
competente e il governo della società. Le varie arti provvedono efficienza ai diversi settori
dell’attività umana, ma esigono un’organizzazione sociale che le orienti a scopi positivi per
tutti. A ciò provvede la politica, che Platone nel Politico, qualifica come βασιλική τέχνη
(basiliké téchne) “arte regia”. Anch’essa, egli dice, come tutte le arti, è tenuta ad evitare gli
estremi, cioè il difetto e l’eccesso, e a individuare “la giusta misura”, perché ciò che fa sia
riconoscibile come “conveniente”, “opportuno”, “dovuto” e quindi risulti “una cosa buona e
bella”; tuttavia, per sua natura, ha la responsabilità generale di organizzare e dirigere
l’impiego di altre particolari competenze, quali la strategia, che abilita a condurre
efficacemente una guerra, la giurisprudenza e la retorica. Infatti, l’acquisizione di queste
tecniche fa sì che si sappia semplicemente come è possibile realizzare determinate cose, ma
non se sia necessario farle né a quale scopo vadano fatte4.
Il problema individuato da Platone permane attuale anche per noi.
La positiva considerazione della tecnica nella filosofia di Aristotele
Aristotele colloca la tecnica o arte tra le virtù dianoetiche, perché comporta, sia come
presupposto che come risultato dell’abilità poietica (relativa al produrre), la conoscenza,
che perfeziona coloro che la conseguono. Come ogni virtù, anche la tecnica deriva
dall’esercizio ripetuto di operazioni produttive, mediante le quali l’uomo acquisisce l’abilità
professionale, cioè la competenza. L’arte, infatti, imita la natura, appropriandosi dei suoi
principi, per proseguirne liberamente il dinamismo creatore e realizzare ciò che essa non
prevede di fare. Infatti “alcune cose che la natura non sa fare l’arte le fa; altre invece le
imita”5. Questa imitazione non è una passiva ripetizione di ciò che è già fatto, ma un’abilità
operativa sostenuta dalla conoscenza, che soltanto l’osservazione intelligente della natura
può dare e che l’uomo è in grado di interpretare mediante concetti universali, applicabili a
nuove situazioni. L’arte, perciò, rivela in chi la possiede un livello di conoscenza superiore
alla semplice routine degli empirici, perché consente di indurre norme generali da ciò che si
osserva e si fa, e rende sempre più consapevoli gli uomini di ciò che possono fare. A questo
riguardo ecco quel che Aristotele afferma: “Gli uomini acquistano scienza e arte attraverso
l’esperienza” e “l’arte si genera quando, da molte osservazioni di esperienza, si forma un
giudizio generale ed unico riferibile a tutti i casi simili. […] Orbene, ai fini dell’attività
pratica, […] gli empirici riescono anche meglio di coloro che posseggono la teoria senza la
pratica. E la ragione sta in questo: l’esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l’arte è
conoscenza degli universali; ora tutte le azioni e le produzioni riguardano il particolare […]
E tuttavia, noi riteniamo che il sapere e l’intendere siano propri più all’arte che
all’esperienza, e giudichiamo coloro che posseggono l’arte più sapienti di coloro che
posseggono la sola esperienza, […] perché i primi sanno la causa, mentre gli altri non la
sanno. Gli empirici sanno il puro dato di fatto, ma non il perché di esso; invece gli altri
conoscono il perché e la causa”6.
L’irresistibile affermazione della tecnica nell’età moderna intende realizzare il dominio
dell’uomo nel mondo
4
Platone, Politico, 304 a; 284 a-b, e; 304 a, trad. di A. Zadro, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni,
Laterza, 1971, vol. 2, pp. 327 e 301-302
5
Aristotele, Fisica, B 8, 199, a 15-16, trad. di A. Russo, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973, vol. 3
6
Aristotele, La metafisica, A 1, 981 a, a cura di G. Reale, Loffredo, 1968, vol. I, p. 104
226
Nell’età moderna diventa sempre più esplicita e sistematica la consapevolezza delle
inesauribili potenzialità di sviluppo della tecnica; questa, infatti, si dimostra sempre più
come il risultato di una scienza organizzata e dotata di un metodo razionalmente valido e
pragmaticamente efficace. La nuova scienza è costitutivamente un sapere operativo.
Agli inizi dell’età moderna lo stesso Giordano Bruno, pur legato ad una cultura
sostanzialmente metafisica e contemplativa, coglie le prospettive dei nuovi tempi. Prende
ruvidamente le distanze dalla tradizionale etica cristiana, alla quale rivolge l’accusa di aver
diseducato i suoi adepti ad un’inerte rassegnazione, invece di favorire in essi un’operante
intraprendenza; perciò qualifica la presunta virtù cristiana come “asinità”. Questo
atteggiamento aspramente critico verso il cristianesimo è presente in particolare nello
Spaccio de la bestia trionfante e nella Cabala del cavallo Pegaseo con l’aggiunta
dell’asino cillenico. A suo giudizio, i cristiani non hanno capito che “gli dei aveano donato
a l’uomo l’intelletto e le mani, e l’avevano fatto simile a loro, donandogli facultà sopra gli
altri animali; la qual consiste non solo in poter operare secondo la natura ed ordinario ma,
ed oltre, fuor le leggi di quella; [...] sono acuiti gl’ingegni, inventate le industrie, scoperte le
arti; e sempre di giorno in giorno, per mezzo de l’egestade, dalla profundità de l’intelletto
umano si eccitano nove e meravigliose invenzioni. Onde sempre più e più per le sollecite ed
urgenti occupazioni allontanandosi dall’esser bestiale, più altamente s’approssimano a
l’esser divino”7.
Francesco Bacone rappresenta al meglio la nuova sensibilità. “Profeta” della scienza
moderna e della sua applicazione tecnologica, egli inserisce il suo progetto innovatore nel
contesto tradizionale della religiosità ebraico-cristiana. È sorretto dalla convinzione che il
progresso scientifico, destinato a migliorare le sorti dell’umanità, rientri nel disegno
salvifico di Dio: “In seguito al peccato, l’uomo decadde dal suo stato d’innocenza e dal suo
dominio sulle cose create. Ma entrambe le cose si possono recuperare, almeno in parte, in
questa vita. La prima mediante la religione e la fede, la seconda mediante le arti e le
scienze”8. Anche la scienza, perciò, è destinata a ripristinare la condizione originaria
dell’uomo, re del creato, perché il suo scopo è l’attuazione del regnum hominis.
Consapevole, tuttavia, di urtare una certa sensibilità tradizionale, che preferisce la
contemplazione all’azione, Bacone ribadisce la finalità pratica del sapere con un’ulteriore
argomentazione: “Può darsi che qualcuno, che dedica alla contemplazione tutto il suo
amore e la sua venerazione, avverta qualcosa di sgradevole in questa continua esaltazione
delle opere. Sappia costui che, così pensando, va contro ai suoi stessi desideri perché in
natura le opere non sono soltanto benefici per la vita, ma anche pegni della verità. Quello
stesso che si richiede giustamente nella religione, che cioè la fede sia dimostrata dalle
opere, vale anche nella filosofia naturale: anche la scienza deve essere dimostrata dalle
opere”9. Ciò significa che l’efficacia e l’efficienza della tecnica confermano la validità
stessa della teoria che la genera.
Per dar conto dell’importanza del nuovo sapere sperimentale, Bacone si affida alla
suggestione dell’utopia, di cui dà conto nella Nuova Atlantide, opera rimasta incompiuta e
pubblicata postuma nel 1627. L’isola del racconto, che nel nome richiama la mitica terra
sprofondata nel mare, della quale aveva parlato Platone, è proposta come la controfigura
ideale dell’Inghilterra. La vita di coloro che l’abitano è totalmente dedita alla scienza
7
G. Bruno, Spaccio de la bestia trionfante, Dialogo terzo, in Dialoghi italiani, a cura di G. Gentile e di G.
Aquilecchia, Sansoni,, 1958, pp. 732-733
8
F. Bacone, La grande instaurazione, Novum Organum, in Scritti filosofici, a cura di P. Rossi, UTET, 1975, p.
795
9
F. Bacone, Cogitata et visa, in Scritti filosofici, cit., p. 391
227
empirica e alla sua applicazione tecnologica. Il successo operativo degli isolani dipende
dalla loro organizzazione comunitaria, collaborativa e sistematica. → Utopia
Nel 1662 Carlo II Stuart, istituendo la Royal Society of London for promoting natural
knowledge, riconosce la validità ideale del progetto baconiano, che il poeta Abraham
Cowley celebra in versi: “Da questi ed altri errori d’antica data, / nei quali incorsero i nostri
errabondi predecessori, / e a guisa degli antichi Ebrei che per molti anni / in deserti pur
piccoli errarono, / Bacone, come Mosè, alfin ci trasse fuori, / oltrepassò l’arido deserto, / e
si fermò sulle soglie della terra promessa e benedetta / e dall’alto del suo ingegno eccelso /
la vide ed additolla a noi”10.
Nel secolo XVIII l’Enciclopedia illuministica contribuisce vistosamente a diffondere la
prospettiva del progresso annunciato da Bacone. Con essa si realizza un’efficace
divulgazione delle conoscenze scientifiche anche ai non specialisti. Il titolo completo
dell’opera esprime significativamente gli intendimenti perseguiti: Enciclopedia o
Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri (28 volumi, di cui 17 di testo e
11 di tavole illustrative). Si tratta di un’autentica impresa collettiva, che è portata a termine
sotto la costante direzione di Denis Diderot, con la collaborazione di molti intellettuali e
con l’apporto informativo della migliore tradizione artigianale, depositaria della cultura
tecnico-operativa.
La convinzione illuministica che sia possibile un vero progresso storico, sostenuto dalle
nuove scienze empiriche e dall’applicazione tecnologica delle loro leggi, è fatta propria dal
Positivismo del XIX secolo, in corrispondenza con il diffondersi in Europa della
rivoluzione industriale. L’entusiasmo per l’evidenza dei risultati conseguiti sembra talora
prendere la mano e ingenerare eccessive aspettative, tanto da suscitare l’amaro sarcasmo di
Giacomo Leopardi sulle “magnifiche sorti e progressive” di un “secol superbo e sciocco”11,
le cui “superbe fole” tendono ad illudere l’uomo, facendogli dimenticare la permanente
precarietà dell’esistenza.
Karl Marx rivela una straordinaria lucidità nel percepire il senso delle trasformazioni
storiche in atto, la cui complessità egli evidenzia mediante un’interpretazione dialettica, che
unisce la consapevolezza dell’alienazione presente, alla quale è costretto il proletariato
industriale, alla positività generale della prospettiva futura. Perciò afferma: “La scienza
naturale si è intromessa tanto più praticamente nella vita dell’uomo mediante l’industria
[ossia il lavoro], e l’ha trasformata, e ha preparato l’emancipazione dell’uomo, pur avendo
dovuto immediatamente condurre a compimento la sua disumanizzazione [→ Alienazione].
L’industria è il rapporto storico reale della natura e quindi della scienza naturale con
l’uomo [...] La storia stessa è una parte reale della storia naturale, della natura che diventa
uomo”12.
H. Bergson: l’onnipresenza della tecnica esige il riequilibrio di “un supplemento d’anima”
I grandi cambiamenti storici stupiscono e talora preoccupano. Henri Bergson, per esempio,
è interessato a rilevare l’universale processo evolutivo del mondo e, in esso, il
protagonismo attivo e consapevole della straordinaria specie umana, la quale sempre più
ampiamente e celermente prende possesso della natura, trasformandola secondo i suoi
desideri. Tuttavia, egli nota, c’è un rischio in questa dinamica onnipresenza della scienza e
della tecnica: esse hanno ingigantito a dismisura l’efficienza fisica dell’umanità; occorre un
Citato in B. Farrington, Francesco Bacone, filosofo dell’età industriale, Einaudi, 1976, p. 35
La ginestra, versi 48 e ss.
12
K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Einaudi, 1980, p. 121
10
11
228
riequilibrio per poter far fronte ad una così esuberante crescita, senza esserne soffocati: “il
corpo cresciuto attende un supplemento di anima”13, ossia un contatto mistico con la fonte
originaria della creazione, conseguibile mediante quella comprensione fondamentale della
vita, che è la metafisica.
M. Heidegger: il dominio del mondo mediante la tecnica si basa sull’oblio dell’essere
(nichilismo)
Martin Heidegger colloca la tecnica al centro della propria riflessione e interpreta il
dominio del mondo, che essa ormai consente, come il compimento storico stesso della
metafisica. La metafisica, infatti, s’impernia sul primato del soggetto, modernamente
tematizzato da Cartesio in poi come il vero sub-jectum, perché è posto a fondamento
dell’essere. In tal modo l’essere è trasformato in oggetto, ossia in ciò che sta di fronte (objectum) alla progettazione umana: “Ogni ente è dunque o oggetto del soggetto o soggetto
del soggetto. [...] Il mondo si muta in oggetto. [...] La Terra si può rivelare solo più come
oggetto della manomissione umana, alla mercé del volere umano [...] Con l’inizio della
lotta per il dominio della Terra, l’epoca della soggettività è spinta verso il suo
compimento”14. La razionalità moderna assume le forme del “pensiero calcolante”, perché
mette il calcolo alla base del progettare e dell’agire, finalizzandolo sempre più
inesorabilmente a dispiegare una logica di possesso e di sfruttamento della Terra e
dell’uomo stesso.
Heidegger osserva che la parola téchne (arte) nel greco antico indicava quel disvelamento del senso delle cose, che avveniva nel processo stesso della loro produzione.
Questa assecondava l’opera della natura e, in quanto póiesis (creazione, produzione),
apparteneva ancora all’ambito della verità, nella quale l’Essere si rivelava.
Etimologicamente, infatti, la “pro-duzione” è “dis-velamento”. Ora invece la tecnica
moderna vede l’esclusiva e totale iniziativa dell’uomo di fronte all’ente, ormai ridotto a un
“fondo” di risorse disponibili ad essere sfruttate. È, questa, un’attività di “pro-vocazione”,
di pretesa dominatrice, nel senso che “il mondo appare come un oggetto, un oggetto a cui il
pensiero calcolante sferra i suoi assalti, ai quali, si ritiene, nulla è più in grado di opporsi.
[...] La potenza della tecnica che dappertutto, ora dopo ora, in una forma d’impiego
qualsiasi incalza, trascina, avvince l’uomo di oggi - questa potenza è cresciuta a dismisura e
oltrepassa di gran lunga la nostra volontà, la nostra capacità di decisione, perché non è da
noi che procede”15.
Per Heidegger questo dominio del mondo è “metafisica compiuta”, perché è nell’essenza
della metafisica lo smarrimento del senso dell’Essere, ottenuto mediante la pretesa di
ridurlo a ente e a cosa. La conseguenza è che così non rimane più nulla dell’Essere e della
sua verità, intesi in senso proprio: promuovendo gli enti nella dimenticanza dell’Essere, la
metafisica realizza il processo storico del nichilismo, che porta all’oblio dell’Essere e della
sua differenza dagli enti (la “differenza ontologica”). → Metafisica; Nichilismo
Nella sua moderna versione soggettivistica, poi, la metafisica è giunta al parossismo della
nietzschiana “volontà di potenza”. Ciò che la tecnica sta realizzando è la riaffermazione
inarrestabile della sua efficienza, che si rivela come produzione di risultati, non di fini. Essa
semplicemente cresce su di sé, avendo ormai smarrito il senso della propria originaria
strumentalità. Heidegger, tuttavia, non conclude con una condanna moralistica della
13
H. Bergson, Le due fonti della morale e della religione, trad. di M. Vinciguerra, in Le opere, UTET, edizione
speciale su licenza delle Presses Universitaires de France e delle Edizioni di Comunità, 1971, p. 581
14
M. Heidegger, La sentenza di Nietzsche: “Dio è morto”, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, 1973, pp. 235236
15
M. Heidegger, Introduzione alla metafisica, trad. it. di G. Masi, Mursia, 1966, p. 13
229
tecnica. L’importante, egli dice, è non assolutizzarla, mantenendosi liberi nei suoi
confronti. Soltanto un “pensiero meditante” può porsi la questione ontologica del senso
della tecnica, che all’uomo si nasconde nel momento stesso in cui si mostra. Così la tecnica
nel suo “mistero” gli appare come un modo del disvelamento dell’Essere e della sua verità.
→ Essere
La prospettiva della filosofia di Heidegger è ontologica, non “umanistica”. Non è
incentrata sull’uomo, anche se l’Essere ha bisogno dell’uomo per rivelarsi, perché non si dà
senza di lui. L’uomo “non è il padrone dell’Essere”, ma gli appartiene. Egli è “il pastore
dell’Essere”16, nel senso che è chiamato a custodirne la verità, la quale dipende soltanto
dall’Essere e dalla sua iniziativa.
Il millenario percorso storico del pensiero metafisico in questo Occidente, terra del
tramonto, non ha necessariamente un esito catastrofico e apocalittico, perché esso coincide
con lo stesso “destino” chiaroscurale della verità dell’Essere, che si disvela e si sottrae nel
suo proprio mistero: “Dovremo un giorno aspettare l’estremo del mattino nell’estremo della
sera”; l’importante è che coloro che pensano “restino sulla breccia e siano presenti al
momento giusto”17, dimostrando disponibilità al mistero dell’Essere e alla sua verità, che
nessuna oggettivazione intellettualistica né alcuna espressione della volontà di potenza può
dominare.
H. Jonas: occorre riequilibrare l’eccedenza minacciosa della tecnica mediante l’etica della
responsabilità
Anche Hans Jonas, come Bergson, vede con preoccupazione il sopravanzamento dell’homo
faber rispetto all’homo sapiens. Su di esso riflette in particolare nell’opera intitolata Il
principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1979). La prospettiva di un
dispiegamento eticamente incontrollato della potenza tecnologica, promossa dalla moderna
utopia baconiana, suscita la fondata paura di una possibile apocalisse, che occorre
fronteggiare adeguatamente. La paura, secondo Jonas, non è di per sé sempre negativa; lo è
quando paralizza e impedisce di agire, ma non quando sollecita a cercare concreti rimedi ai
rischi che si prospettano, così come è positiva la speranza che non sconfina nell’utopismo.
L’uomo tecnologico, non imponendosi alcuna cautela, si rivela come un “Prometeo
scatenato”, che mette a repentaglio il futuro dell’umanità. La morale tradizionale, che si
affidava alle buone intenzioni, non è più sufficiente, perché ci devono riguardare le
conseguenze future del nostro agire. Di esse dobbiamo farci carico sulla base di un nuovo
imperativo etico, che, in assonanza con l’imperativo kantiano, si può così formulare:
“Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza
di un’autentica vita umana sulla terra”. Espresso in forma negativa, esso dice: “Agisci in
modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di tale
vita”18.
Jonas rifiuta la cosiddetta “legge di Hume” (→ Bene, G.E. Moore), la quale vieta di
derivare conseguenze d’ordine prescrittivo dall’analisi ontologica, cioè di passare
dall’essere al dover essere. Al contrario, egli è convinto che occorra riaffermare il finalismo
immanente alle cose, il quale ci impone di considerare come intrinseca legge della vita
esistente nel mondo l’impegno all’autoconservazione. Pertanto, in rapporto a ciò che noi
siamo, dobbiamo assumerci la responsabilità di consentire che nel futuro continui a
sussistere l’umanità. Questa disponibilità positiva alla vita può essere così descritta: “La
responsabilità è la cura per un altro essere quando venga riconosciuta come dovere,
16
17
M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, a cura di A. Bixio e G. Vattimo, SEI, 1975, p. 109
M. Heidegger, La sentenza di Nietzsche, cit., p. 194
230
diventando ‘apprensione’ nel caso in cui venga minacciata la vulnerabilità di
quell’essere”19.
TEMPO
È un termine di derivazione latina (tempus), ma varie parole del nostro vocabolario
dipendono dal corrispondente termine greco χρόνος (chrónos); tra esse: cronometro,
cronologia.
Fin dall’antichità il tempo è considerato un modo di dare ordine al movimento a cui sono
soggette tutte le cose, misurandolo con le ricorrenze periodiche degli astri e il ripetersi delle
stagioni. È ciò che dichiara Anassimandro: “Principio degli esseri è l’infinito… da dove gli
esseri hanno l’origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità: poiché essi pagano
l’uno all’altro la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo”22. La
natura consiste appunto nel formarsi delle cose “secondo l’ordine del tempo”: uscite da un
orizzonte infinito, in cui nulla ha forma, la loro nascita prevede già il destino della morte,
con la quale tutte rifluiscono nell’unità originaria e informe della natura, per lasciar che si
avvicendi la nascita di qualcos’altro.
Le analisi di Platone, Aristotele e Plotino
Per Platone il mondo e il suo movimento non sono un’illusione, come invece aveva ritenuto
Parmenide. Figurandosi miticamente alla sua origine, egli descrive l’opera del divino
artefice, che, guardando all’essere stabile e perfetto, “pensa di creare una immagine mobile
dell’eternità, [...] che procede secondo il numero [cioè la successione di momenti], quella
che abbiamo chiamato tempo”. Il tempo distende nel movimento, secondo le tre dimensioni
di ciò che “era” (passato), “è” (presente) e “sarà” (futuro), l’essere che nell’eternità “è
sempre nello stesso modo immobilmente”23. → Eternità
Per Aristotele il movimento o divenire è la condizione necessaria e oggettiva del tempo, nel
senso che il tempo non si dà senza di esso. Questa condizione, tuttavia, non è sufficiente,
perché occorre qualcos’altro, cioè l’anima, alla quale compete l’attività del numerare, ossia
di cadenzare il trascorrere del movimento.
La mobilità fuggevole del tempo vissuto pone il problema della sua consistenza, perché
“una parte di esso è stata e non è più, una parte sta per essere e non è ancora”24.
L’importanza della condizione soggettiva (l’anima), che lo fa essere intrinsecamente
esperienza vissuta, attirerà nel futuro l’attenzione di Sant’Agostino e Bergson, ma è già
rilevata da Aristotele, che nei suoi riguardi osserva: “Quando noi non mutiamo nulla entro
il nostro animo o non avvertiamo di mutar nulla, ci pare che il tempo non sia trascorso
affatto”. Perciò, il tempo “è il numero del movimento secondo il prima e il poi” e perché
esso si realizzi è necessario il soggetto che lo vive; infatti, “se è vero che nella natura delle
H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, 1990,
p. 16
19
ivi, p. 285
22
Anassimandro, I Presocratici, Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1975, vol. 1, p.
106
23
Platone, Timeo, 37 d- 38 a, trad. di C. Giarratano, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1971,
vol. 6, pp. 385 s.
24
Aristotele, Fisica, IV (), 10, 217 b 34, trad. di A. Russo, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973, vol.
3, p. 99
18
231
cose soltanto l’anima o l’intelletto che è nell’anima hanno la capacità di numerare, risulta
impossibile l’esistenza del tempo senza quella dell’anima”25.
Plotino inserisce nel dinamismo universale della processione dell’essere anche la
formazione del tempo, che nella condizione perfetta dell’Uno “non era ancora”, perché in
quell’origine assoluta c’è solo “eternità”, cioè “vita senza mutamento e tutta intera
simultaneamente”. L’Anima, creando il mondo fisico (la phýsis), ha generato anche il
tempo. Essa “era vogliosa di trasferire ‘in un diverso’ la visione di lassù”, cioè di creare “ad
immagine del superno, il mondo sensibile, [...] e così l’anima ha prima d’ogni altra cosa
temporalizzato se stessa e ha fatto subentrare il tempo in luogo dell’eterno”, perché ciò che
essa fa “non lo presenta se non in momenti successivi: prima l’uno e poi l’altro e poi un
terzo, novellamente, in serie”. Pertanto, come per Platone, anche per Plotino il tempo è
un’immagine mobile dell’eternità: questa è “stabilità e identità e inalterabilità”, il tempo,
invece, è la “vita dell’anima nel suo movimento trascorrente dall’uno all’altro stato” 26.
Come per Aristotele, poi, anche per Plotino il tempo richiede insieme il movimento e
l’anima che lo scandisce.
La meditazione agostiniana
La meditazione sul tempo, che Sant’Agostino svolge nel libro XI delle Confessioni, non
risponde ad una semplice curiosità teoretica, ma si connette all’esperienza di un’anima che
ha vissuto l’inquietudine di un’esistenza errante e poi si è disposta nella prospettiva
speranzosa di un approdo alla pace eterna di Dio. Essa quindi s’allarga a considerare la
condizione universale dell’homo viator (viandante), che vive la provvisorietà di questa vita
nell’attesa di un destino immutabile. L’analisi appare contrassegnata dalla concitazione, che
caratterizza tutta l’opera. Agostino nega recisamente l’identificazione del tempo con il
movimento dei cieli: “Non mi si venga a dire che il tempo è il movimento dei corpi celesti.
Del resto anche quando, per la preghiera di un uomo, il sole si fermò per dargli modo di
condurre il combattimento alla vittoria, il sole era fermo, ma il tempo camminava”27. Qui il
riferimento è al noto episodio biblico di Giosuè28. Aristotele aveva indicato nel movimento
una condizione del tempo, senza tuttavia identificarlo con esso, perché il tempo ne è la
misura. Per Agostino, invece, noi misuriamo per mezzo del tempo anche la durata di ciò
che sta fermo29.
Per comprendere opportunamente che cos’è il tempo, egli assume come sicuro criterio di
riferimento il confronto con l’eternità di Dio, l’immutabile unità del suo essere, in cui nulla
figura come disperso, ma tutto si concentra come un totum simul (tutto insieme), per dire la
cosa con parole di ascendenza plotiniana, che a loro volta si rifanno alla determinazione
parmenidea dell’essere.
L’abilità dialettica e retorica di Agostino fa emergere nell’analisi fenomenologica del
tempo, considerato nella sua rappresentazione più familiare, insospettate aporie, la cui
soluzione si rende necessaria per far procedere il discorso. Il tempo non appare
problematico nell’immediata e ordinaria esperienza, ma, se ci è chiesto che cos’è, subito
intervengono le difficoltà. Infatti, “se nessuno me lo chiede, lo so; se dovessi spiegarlo a chi
me ne chiede, non lo so; eppure posso affermare con sicurezza di sapere che se nulla
passasse, non esisterebbe un passato; se nulla sopraggiungesse, non vi sarebbe un futuro; se
25
ivi, IV (), 11, 218 b 22 s., 219 b 2; 14, 223 a 25 s., rispettiv. a p. 101, p. 103 e p. 113
Plotino, Enneadi, III, 7, XI, a cura di V. Cilento, Laterza, 1973, vol. II, pp. 133-135
Agostino, Le confessioni, XI, 23, trad. di C. Vitali, Rizzoli, 1994, p. 575
28
Giosuè, 10, 12
29
Agostino, Le confessioni, XI, 24, cit, p. 577
26
27
232
nulla esistesse, non vi sarebbe un presente. Passato e futuro: ma codesti due tempi in che
senso esistono, dal momento che il passato non esiste più, che il futuro non esiste ancora?
[...] Se il presente, perché sia tempo, deve tramontare nel passato, in che senso si può dire
che esiste, se sua condizione all’esistenza è quella di cessare dall’esistere?”30 La soluzione
Agostino la trova indicando la sede del tempo nell’anima, che lo vive e lo misura: “Tre
sono i tempi: il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro. Queste
tre forme esistono nell’anima, né vedo possibilità altrove: il presente del passato è la
memoria, il presente del presente è l’intuizione diretta, il presente del futuro è l’attesa”31.
La misura del tempo non consiste in dati oggettivi: posso, infatti, rapportare ciò che è più
breve a ciò che è più lungo, come avviene per i piedi della metrica in poesia o per le sillabe
nell’analisi grammaticale, ma ciò che prima ho indicato come breve ora lo posso
pronunciare più lentamente o ciò che ho indicato come lungo lo posso pronunciare più
rapidamente. La misura del tempo è nell’anima: “L’animo attende, presta attenzione,
ricorda: in modo che quello che attende, attraverso il suo sviluppo nel presente, passi poi
nel ricordo. Chi potrebbe negare che il futuro non esiste ancora? Ma nell’animo vive
l’attesa del futuro. Chi potrebbe negare che il passato non esiste più? Ma nell’animo vive la
memoria del passato. E chi negherà che il tempo presente manca di estensione perché non è
che un punto transeunte? Ma dura l’attenzione attraverso la quale il futuro tende al passato.
Non si può avere dunque un futuro lungo - non esiste ancora -, ma il lungo futuro è la lunga
attesa del futuro; non si può avere un passato lungo - non esiste più -, ma il lungo passato è
il lungo ricordo del passato”. Il tempo è “extensio” o “distensio animi”, è esperienza vissuta
dall’anima, la quale rischia la propria “dissipazione” tra le cose e corre il pericolo di
disperdersi in esse. Perciò Agostino si rivolge a Dio con queste parole: “Più cara che la vita
è la tua grazia”, che è intervenuta “affinché [...] mi raccolga nel seguito dell’Unico,
dimentico del passato, non più rivolto alle cose future e transitorie, ma proteso verso ciò
che mi sta davanti, non in dissipazione, ma in tensione (intentio) di spirito”32. Nel tempo
l’uomo avverte la transitorietà delle cose: “Sorgono e tramontano: nascendo cominciano per
così dire ad essere, e poi vanno crescendo sino alla loro perfezione; giunte ad essa,
invecchiano e muoiono; e se anche non tutte invecchiano, tutte però muoiono. E quando
cominciano ad essere e tendono alla perfezione dell’essere, quanto più rapidamente corrono
all’essere tanto più s’affrettano al non essere. È la loro legge”33. Niente di simile c’è
nell’immutabile eternità di Dio.
Sul tempo nulla di nuovo aggiunge la riflessione medioevale. Di un certo rilievo è, invece,
la questione se il mondo sia eterno o abbia un’origine temporale. I teologi la dibattono
vivacemente, confrontandosi con l’interpretazione averroista dei testi di Aristotele. Su ciò si
veda la voce → Creazione
Il tempo secondo la fisica moderna
Nello studio del moto realizzato dalla meccanica moderna il tempo svolge una funzione
fondamentale come variabile indipendente, costituita da una serie omogenea, teoricamente
reversibile, di istanti, ai quali Isaac Newton applica il calcolo infinitesimale, per conferire
un ulteriore rigore all’analisi dei fenomeni dinamici.
La meccanica newtoniana ritiene di doversi avvalere, oltre che della nozione di tempo
relativo, anche della nozione di tempo assoluto, così come di quelle di spazio assoluto e di
30
ivi, XI, 14, cit., p. 559
ivi, XI, 20, cit., p. 569
32
ivi, XI, 28-29, cit., pp. 585-587
33
ivi, IV, 10, cit., p. 183
31
233
moto assoluto, che saranno oggetto di vivaci contestazioni: rifiutate già dal filosofo George
Berkeley, nell’Ottocento il fisico Ernst Mach le considererà vere e proprie “mostruosità
concettuali”. Newton così le definisce: “Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per sua
natura, senza relazione ad alcunché di esterno, scorre uniformemente. [...] Lo spazio
assoluto, per sua natura senza relazione ad alcunché di esterno, rimane sempre uguale e
immobile. [...] Il moto assoluto è la traslazione di un corpo da un luogo assoluto in un luogo
assoluto”34. Ludovico Geymonat svolge la seguente considerazione, che inserisce in
maniera più diretta e pertinente l’argomento in questione nell’ambito della sistemazione
scientifica newtoniana: “I concetti di tempo assoluto, di spazio assoluto e di moto assoluto
sono nozioni essenzialmente astratte, prive di un corrispettivo diretto nell’esperienza. [...]
esse rappresentano comunque una necessità ineliminabile per la struttura stessa della
meccanica newtoniana; è chiaro infatti che i tre famosi principi della dinamica su cui si
regge l’intera costruzione risulterebbero privi di significato senza un riferimento a tali
nozioni. Che senso avrebbe, ad esempio, asserire che un corpo su cui non agisce alcuna
forza persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, se non si sottintendesse
‘rispetto allo spazio e al tempo assoluti’? [...] Così pure risulterebbe incomprensibile, senza
la specificazione anzidetta, la tesi asserita dal secondo principio, e cioè che una forza
applicata a un corpo gli imprime una accelerazione (risultando ovvio che un moto
accelerato rispetto a un sistema di riferimento può apparire uniforme rispetto a un altro)”35.
Le interpretazioni della filosofia moderna: Th. Hobbes, G.W. Leibniz, gli empiristi
I filosofi dell’età moderna continuano ad interessarsi della questione del tempo e a darne
un’interpretazione che mette in rilievo ora l’oggettività misurabile dei fenomeni ora la
soggettività dell’esperienza vissuta.
Thomas Hobbes, in apparente contrasto con i presupposti realistici del suo materialismo
corporeistico, elabora una gnoseologia fenomenistica. Egli infatti descrive la nostra attività
noetica come un flusso d’immagini o “fenomeni” (in greco φαινόμενα, phainómena), che
realizzano quel mirabile evento dell’“apparire” (φαίνεσθαι, pháinesthai) delle cose nelle
sensazioni e conseguentemente nel pensiero che ne dipende. Fondamentali “fantasmi”, cioè
immagini, riflessi soggettivi dei corpi e del movimento, sono rispettivamente lo spazio
(phantasma rei existentis, quatenus existentis: “rappresentazione della realtà esistente in
quanto esistente” al di fuori di noi) e il tempo (phantasma motus: “rappresentazione del
movimento” nella sua successione)36.
Anche per Gottfried Leibniz lo spazio e il tempo non sono realtà in sé, cioè entità
sostanziali, come sono invece lo spazio e il tempo assoluti teorizzati da Newton, ma
concetti di fenomeni, per quanto ognuno di essi sia “bene fundatum”. Con essi noi
designiamo fenomeni di relazione tra le sostanze, cioè il loro ordine; in particolare con lo
spazio ci riferiamo ai rapporti di coesistenza e con il tempo ai rapporti di successione. Ecco
direttamente le parole del filosofo: “Lo spazio, ben lungi dall’essere una sostanza, non è
neppure un ente. Esso è un ordine, come il tempo, un ordine di coesistenze, come il tempo è
un ordine tra gli esistenti non coesistenti”37. Perciò egli ritiene che la fisica cartesiana, la
quale riduce la natura a estensione e movimento, rimanga su un piano puramente
34
I. Newton, Principi matematici della filosofia naturale, a cura di A. Pala, Definizioni, UTET, 1989, pp. 107-108
L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Garzanti, 1970, vol. II, p. 635
Th. Hobbes, De corpore, II, 7
37
W. Leibniz, Lettera a Nicola Rémond sul suo sistema, luglio 1714, in Scritti filosofici, a cura di D.O. Bianca, 2
volumi., UTET, 1988, vol. II, p. 806
35
36
234
fenomenico e propone che il suo meccanicismo debba essere integrato dalla considerazione
della dimensione metafisica, sostanziale e perciò più vera, delle monadi, nel cui ambito, con
l’emergere della vita e della coscienza, può trovare giustificazione una concezione
finalistica mondo.
Anche John Locke e David Hume criticano la fantomatica entificazione dello spazio e del
tempo, che ne fa qualcosa di distinto dalle particolari esperienze spazio-temporali, nelle
quali gli oggetti sono percepiti uno accanto all’altro e in successione. Perciò spazio e tempo
sono puri nomi, che designano rappresentazioni, derivate per generalizzazione
dall’esperienza dei singoli eventi.
La concezione trascendentalistica di I. Kant
Per Immanuel Kant lo spazio e il tempo sono forme a priori della sensibilità, mediante le
quali il soggetto conoscente recepisce i dati empirici. In se stessi sono “intuizioni pure”,
perché non sono derivati dall’esperienza, ma sono condizioni originarie che consentono al
soggetto di farla. Lo spazio è la forma del senso esterno, con cui noi percepiamo le cose una
accanto all’altra; il tempo, invece, è la forma del senso interno, che ci fa intuire gli eventi in
successione. Tuttavia anche quella del mondo esterno è un’esperienza vissuta, da riportare
alla nostra interiorità, e ciò che è appreso nello spazio è, esso pure, colto da noi in
successione; pertanto il tempo è un’intuizione più fondamentale dello spazio. Kant sostiene
“l’idealità trascendentale” dello spazio e del tempo, perché essi “non sono niente, appena
prescindiamo dalle condizioni soggettive dell’intuizione sensibile, e non possono essere
considerati né come sussistenti né come inerenti agli oggetti in se stessi (senza rapporto con
la nostra intuizione)”; in quanto tali, sono “le condizioni formali a priori di tutti i fenomeni
in generale”, nel senso che “vengono attribuiti alle cose solo in quanto esse appariscono a
noi, sono cioè oggetti della sensibilità”. Tuttavia Kant dichiara anche la loro “realtà
empirica”, perché è mediante essi che la realtà oggettiva del mondo ci è data e nei suoi
riguardi noi siamo in una condizione di recettività38. Le forme dello spazio e del tempo
sono il fondamento epistemologico rispettivamente della geometria e dell’aritmetica,
perché sono necessariamente implicate nei giudizi sintetici a priori, che costituiscono
queste discipline come scienze.
Inoltre, poiché il tempo è la forma universale dell’esperienza sensibile, le varie categorie
nella loro concreta applicazione assumono una caratterizzazione temporale tramite gli
“schemi trascendentali”. Per es. lo schema della categoria di sostanza è la permanenza nel
tempo; lo schema della categoria di causa-effetto è la successione; lo schema dell’azione
reciproca è la simultaneità nel tempo. Per valutare debitamente l’importanza data da Kant
alla dimensione temporale, teniamo conto della prospettiva epistemologica da lui assunta:
egli intende determinare i criteri di scientificità della fisica moderna; ora, nella dinamica
newtoniana i concetti fondamentali di materia, forza e azione reciproca risultano
strettamente legati al tempo, il quale funge da condizione generale della loro concreta
pensabilità.
Georg Hegel: il tempo è “il divenire intuito”
Anche Georg W.F. Hegel tratta del tempo. Nell’ambito del suo sistema esso figura come
una determinazione della natura, ossia là dove l’Idea è fuori di sé, alienata e inconsapevole
di ciò che è. Precisamente il tempo è “il divenire intuito”39. In esso l’esteriorità fa valere
38
I. Kant, Critica della ragion pura, Estetica trascendentale, Sez. I, §§ 3-6, a cura di G. Gentile e G. LombardoRadice, riveduta da V. Mathieu, Laterza, 1971, pp. 71-79
39
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, a cura di B. Croce, Laterza, 1973, vol. I, §§ 258, p. 217
235
tutta la sua potenza negativa e distruttrice: diversamente dal divenire logico e dialettico,
esso non conserva quel che supera, ma lo annulla; ciò che era prima, ora non è più. →
Aufhebung
Il tempo nella fisica in seguito alla crisi della meccanica classica
Dopo la metà del XIX secolo gli sviluppi innovativi della fisica, in particolare della
termodinamica, determinano una progressiva crisi del dominante modello meccanicistico,
che tra l’altro mette in discussione la tradizionale concezione della reversibilità dei
fenomeni fisici, consistente nella teorica disponibilità del tempo ad essere percorso
indifferentemente in un verso o nell’altro (→ Meccanicismo). Infatti, poiché per il secondo
principio della termodinamica, il passaggio del calore da un corpo ad un altro non può
avvenire indifferentemente in entrambi i sensi, si è costretti ad ammettere l’esistenza di
fenomeni naturali irreversibili. La scienza è ormai consapevole che un’energia
indistruttibile non è sempre un’energia disponibile: l’energia meccanica si converte in
energia termica, ma questa, pur conservandosi in base al primo principio della
termodinamica, si degrada con entropia crescente verso una condizione di equilibrio, che ne
impedisce la riutilizzazione.
Nel 1905 Einstein pubblica la teoria della relatività speciale, in base alla quale spazio e
tempo non sono più proprietà assolute del mondo, ma relative all’osservatore: ogni sistema
di riferimento ha il suo tempo e il suo spazio particolari, dipendenti dal suo stato di moto.
Inoltre, l’adozione da parte di Einstein della nozione di continuo tetradimensionale o
cronotopo, elaborata nel 1907-1908 dal matematico H. Minkowski, fa sì che spazio e tempo
siano considerati come un’unica entità non separabile. Siamo ormai lontani dalla
concezione della fisica classica.
Henri Bergson: il tempo spazializzato e la durata
In ambito filosofico la questione del tempo continua a suscitare interesse, ma è affrontata
con intendimenti teoretici diversi da quelli della fisica. È, questo, per esempio, il caso di
Henri Bergson. Nel Saggio sui dati immediati della coscienza (1889) egli affronta il
problema del tempo con un atteggiamento critico verso il riduzionismo positivistico,
distinguendo il tempo della scienza dal tempo della vita, da lui chiamato “durata” (→
Riduzionismo). Rileva che il tempo della fisica è intrinsecamente dominato dal concetto di
spazio: è esteriore, astratto, fatto di momenti uguali e distinti l’uno dall’altro, solo
quantitativamente differenti; è reversibile, perché un esperimento può essere ripetuto un
numero indefinito di volte. E noi, “familiarizzati con l’idea dello spazio, addirittura
ossessionati da essa, l’introduciamo a nostra insaputa nella rappresentazione della pura
successione; giustapponiamo i nostri stati di coscienza in modo da percepirli
simultaneamente, non più uno nell’altro, ma uno accanto all’altro; in breve, proiettiamo il
tempo nello spazio, esprimiamo la durata attraverso l’estensione, e la successione assume
per noi la forma di una linea continua o di una catena, le cui parti si toccano senza
penetrarsi. Questa immagine implica la percezione di un ordine di successione nella durata
e di una sua reversibilità”. Il tempo spazializzato funziona opportunamente per le esigenze
pratiche della scienza e trova la sua rappresentazione concreta nel quadrante dell’orologio
percorso dalle lancette. La durata, invece, è il tempo vissuto, in cui gli istanti sono
qualitativamente diversi e pertanto irripetibili. Perciò talora si dice nel linguaggio comune
che cinque minuti sembrano un’eternità. Niente, poi, si rivive in maniera uguale, perché “la
durata assolutamente pura è la forma assunta dalla successione dei nostri stati di coscienza
236
quando il nostro io si lascia vivere, quando si astiene dallo stabilire una separazione fra lo
stato presente e quello anteriore. [...] come avviene quando ci ricordiamo le note di una
melodia fuse, per così dire, insieme. [...] il loro insieme è paragonabile a un essere vivente
le cui parti, per quanto distinte, si compenetrano per l’effetto stesso della loro solidarietà”40.
Mentre il tempo spazializzato della fisica può essere assimilato ad una collana di perle, tutte
uguali e distinte tra loro, l’immagine della durata è il gomitolo o la valanga, che cresce su
se stessa in forme sempre nuove. La vita spirituale è, infatti, essenzialmente autocreazione e
libertà.
L’analisi fenomenologica ed esistenziale: E. Husserl e M. Heidegger
Anche Edmund Husserl in vari scritti, in particolare nelle lezioni su La fenomenologia della
coscienza interna del tempo (1928), presta attenzione al tempo, descrivendolo
fenomenologicamente così come esso si rivela alla coscienza che lo vive. Per lui, com’era
stato già per Kant, il tempo è la condizione formale che accomuna tutte le esperienze che
viviamo (gli Erlebnisse), caratterizzandole e accompagnandole nel loro fluire. Egli, poi, ci
ripropone in termini rinnovati l’analisi che aveva già fatto Sant’Agostino: la coscienza,
come è intenzionalmente attenta all’attualità di ciò che le scorre davanti nell’immediatezza
dell’esperienza vissuta (“presenza”), così è intenzionalmente rivolta sia al passato, che via
via sprofonda, ma essa tende a trattenere (“ritenzione”), sia al futuro, verso il quale si
protende (“protensione”).
Il tempo gioca un ruolo assai importante nell’analisi fenomenologica dell’esistenza, svolta
da Martin Heidegger in Essere e tempo (1927). La struttura fondamentale che caratterizza
l’Esserci (l’uomo), in quanto “essere-nel-mondo”, è la “cura”, considerata nella duplice
forma del “prendersi cura delle cose” e dell’“aver cura degli altri”. Essa è intrinsecamente
determinata dalla temporalità, soprattutto dal futuro, che è direttamente connesso alla
condizione di “possibilità” dell’esistenza, cioè al suo “progettarsi-in-avanti”. Il futuro,
tuttavia, sorge dal passato e dal presente: è strettamente vincolato al passato, perché
l’esistenza si trova “gettata” nella situazione effettiva che le è data in sorte e corrisponde al
“ci” dell’Esserci; è altrettanto strettamente vincolato al presente, la puntualità del quale
l’Esserci può vivere sia nella “deiezione” [= caduta] dell’esistenza inautentica e banale sia
nell’attimo della “decisione anticipatrice” della morte, da cui dipende il farsi autentico
dell’esistenza. Ognuna delle tre determinazioni del tempo ha un senso soltanto rispetto alle
altre; ciò fa sì che la temporalità, per usare un termine che si rifà direttamente alla lingua
greca, si riveli letteralmente come l’ἐκστατικόν (ekstatikón), cioè “l’originario fuori di sé in
sé e per sé”41.
TEOLOGIA
La teologia è lo studio della realtà divina, che assume forme diverse in relazione a ciò che
viene inteso come Dio o qualificato come divino.
Analogamente alla distinzione tra religione naturale o razionale e religione positiva,
possiamo distinguere una teologia razionale, che fonda e suffraga le proprie tesi soltanto
con le argomentazioni della ragione, e una teologia positiva, qual è per esempio quella
40
41
H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, a cura di P.A. Rovatti, A. Mondadori, 1986, p. 59
M. Heidegger, Essere e tempo, § 65, trad. it. di P. Chiodi, Longanesi, 1970, p. 491
237
cristiana, che si propone di evidenziare e svolgere le ragioni della fede in una rivelazione
storica di Dio.
La teologia razionale è una parte importante della metafisica classica o “filosofia prima”,
ed è già così denominata da Aristotele (→ Metafisica). Come tutta la filosofia anch’essa è
intrinsecamente problematica e critica, e corrisponde all’esigenza di spiegare
metafisicamente il mondo. Ha, perciò, prioritariamente intenti ontologici e cosmologici,
non religiosi. Del Motore Immobile o Atto puro Aristotele parla come della causa prima,
che può spiegare il movimento universale presente in natura. Per questa ragione una
teologia razionale a Blaise Pascal non sembrerà in grado di alimentare la fede. Riferendosi
alla speculazione di Cartesio, con asprezza afferma: “Non posso perdonare a Descartes.
Avrebbe pur voluto, in tutta la sua filosofia, poter fare a meno di Dio; ma non ha potuto
esimersi dal fargli dare un colpetto per mettere in movimento il mondo: dopo di che, non sa
che farsi di lui”54.
Nell’età dell’Illuminismo settecentesco il razionalismo deistico, sulle tracce
dell’insegnamento spinoziano e del pensiero libertino, tenterà di costruire una teologia
esclusivamente razionale, senza dover nulla a presunte rivelazioni, negando anzi la stessa
plausibilità di interventi soprannaturali e miracolosi nella natura e nella storia. → Deismo
Il problema dei possibili rapporti tra la fede e la filosofia nell’ambito del cristianesimo si è
continuamente riproposto nel corso dei secoli. Le soluzioni, che via via sono state date,
hanno spesso indicato positive forme di armonia e di scambievole arricchimento; tuttavia
non sono mancati atteggiamenti estremi, tendenti ad affermare contrapposizioni di tipo
“fideistico” o di tipo “razionalistico”, a seconda che fosse dichiarata inaccettabile
l’autonomia critica della ragione o che, al contrario, tutta la verità fosse ridotta al suo
dominio.
Agli inizi della storia del cristianesimo Giustino (II sec.) e Clemente Alessandrino (II-III
sec.) assumono verso la tradizione filosofica un atteggiamento di disponibilità a
riconoscerne gli elementi validi e veritieri, i “semi del Lógos” divino, di cui tuttavia
rivendicano la proprietà: “appartengono a noi cristiani”55, dicono, perché ciò che hanno
insegnato i Profeti e Cristo è “la sola filosofia sicura ed utile”56. C’è, invece, anche chi,
come Tertulliano, sostiene un profilo d’intransigenza e vede nella filosofia solo una causa
di sviamento. È proverbiale il detto a lui attribuito, che non figura letteralmente nei suoi
scritti, ma corrisponde al suo convincimento che la verità cristiana contrasta con la verità
razionale: “Credo quia absurdum” (credo perché è assurdo). A proposito della resurrezione
di Cristo, ad esempio, afferma: “È certa perché è impossibile” (Certum est quia
impossibile)57.
Sant’Agostino, poi, cerca di conciliare la fede con la ragione, proponendo una circolarità
virtuosa della quale entrambe possano beneficiare. Da un lato afferma: “crede ut intelligas”
(credi, se vuoi capire), perché la fede è il presupposto e la condizione della possibilità
d’intendere; dall’altro rovescia l’invito: “intellige ut credas”, perché, per credere, occorre
comprendere il senso di ciò che si crede e assentire, ossia disporre il pensiero ad aderirvi
(“credere est cum assensione cogitare”); appare ovvio, infatti, che “nessuno crede
[alcunché] se prima non ha pensato che esso esige di essere creduto” (nullus quippe credit
54
B. Pascal, Pensieri, 51, trad. di P. Serini, A. Mondadori, 1976
Giustino, Seconda apologia, cc. 8 e 13, in G. Bosio, Iniziazione ai Padri, SEI, 1966, vol. I, p. 159-161
56
Giustino, Dialogo con Trifone, 8, in G. Bosio, Iniziazione ai Padri, cit., vol. I, p. 144
57
Tertulliano, De carne Christi, 5; v. J. Kelly, Il pensiero cristiano delle origini, cit., p. 188
55
238
nisi prius cogitaverit esse credendum)58. Agostino non riconosce come validi gli
atteggiamenti opposti ed estremi del razionalismo e del fideismo. Esclude ovviamente il
primo, che non lascia spazio alla fede e pretende di ricondurre tutto il conoscibile alla sola
indagine razionale; non ritiene però adeguato alla dignità umana il secondo, perché la
rivelazione divina si attende da noi non un assenso cieco, ma la chiarificazione realizzata
dalla mente, che a sua volta è purificata dalla fede ed è illuminata dal Lógos divino.
Nel Medioevo la teologia cristiana si propone come sacra doctrina, cioè scienza delle cose
divine, rivelate in origine da Dio mediante le Sacre Scritture e poi sistemate e codificate
dalla tradizione dottrinale della Chiesa. Nell’organizzazione universitaria degli studi essa
diventa la regina delle scienze e queste, in particolare la filosofia, nei suoi confronti sono
considerate ancillae. Per i medioevali, infatti, il filosofo cristiano nella sua ricerca sa già
dove arrivare, perché, come sostenevano i Padri della Chiesa, la vera filosofia è il
cristianesimo stesso, che si regge sulla fede, ma cerca di chiarire razionalmente i suoi
contenuti. La fede, perciò, diventa inevitabilmente teologia, cioè fede che richiede
l’intelligenza dei suoi contenuti, fides quaerens intellectum, secondo la formula di
assonanza agostiniana di Anselmo d’Aosta.
Tommaso d’Aquino distingue dalle verità accessibili alla semplice ragione le verità che
soltanto la rivelazione divina ci ha fatto conoscere e la ragione è impegnata a intendere per
quanto può, a illustrare e a giustificare nella loro intrinseca ragionevolezza contro chi le
nega o le misconosce. I loro principi “sono articoli di fede”, che non derivano
dall’autonoma ricerca della nostra mente, perché superano la sue capacità, ma non sono in
contrasto con essa; infatti la riflessione teologica “da essi procede per dimostrare
qualcos’altro, come fa l’Apostolo, che nella I Lettera ai Corinti, 15, 12 ss. dalla
risurrezione di Cristo argomenta a favore della risurrezione di tutti”. Inoltre, se è vero che le
verità rivelate non sono direttamente dimostrabili, si possono tuttavia “smontare i
ragionamenti contro la fede”, procedendo alla loro confutazione59.
Della scientificità della sacra doctrina Tommaso è pienamente convinto per strutturali
ragioni epistemologiche di ascendenza aristotelica. Sulle tracce del grande filosofo greco
ritiene che le varie discipline, nelle quali si divide il sapere, costituiscano una gerarchia
organica, al cui interno si dispongono secondo un rapporto di subalternazione, tale per cui
una disciplina di grado inferiore accetta come propri principi le conclusioni della disciplina
dalla quale dipende60. Anche la sacra doctrina è una scienza, che “procede dai principi noti
di una scienza superiore”, cioè quella di Dio, in cui crediamo. Per questo aspetto essa è
simile alla musica, la quale si basa su principi che derivano dalla matematica61, o, per
riferirci ad un esempio per noi più consueto, alla medicina, che si serve delle conoscenze
predisposte dalla biologia. Tuttavia la sacra doctrina è superiore a tutte le altre discipline
umane, perché “non riceve i suoi principi da esse, ma immediatamente da Dio per
rivelazione”; invece “di esse si serve come ancelle”; in particolare “può accogliere qualcosa
dalle discipline filosofiche, non perché ne abbia strettamente bisogno, ma per rendere i suoi
contenuti più evidenti (ad maiorem manifestationem)”. La sua superiorità è connessa alla
rassicurazione veritativa che offre, perché “deriva la sua certezza dalla luce della scienza
divina, che non s’inganna”62.
Sant’Agostino, De praedestinatione sanctorum, 2, 5, citato da J. Trütsch, La fede, in Mysterium salutis, a cura
di J. Feiner e M. Löhrer, Queriniana, 1968, vol. 2, p. 407
59
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 1, art. 8 c
60
Si consideri, per esempio, ciò che dice Aristotele nell’Etica nicomachea, I, 1-2, 1094a-1094b.
61
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 1, art. 2 c
62
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 1, art. 5 ad secundum, c
58
239
Tommaso non aderisce alla teoria averroista della doppia verità, perché la verità è unica.
Così si esprime nel Commento al De Trinitate di Boezio: “È impossibile che le cose che ci
sono attraverso la fede tramandate divinamente siano contrarie a quelle che ci sono date per
natura [mediante il lume della mente, cioè attraverso la filosofia]. In questo caso
occorrerebbe che o le une o le altre fossero false; poiché sia le une sia le altre ci vengono da
Dio, Dio sarebbe per noi l’autore della falsità: il che è impossibile”. E prosegue: “Se nei
detti dei filosofi si trova qualcosa di contrario alla fede, questo qualcosa non appartiene alla
filosofia, ma è un abuso della filosofia per difetto di ragione”. In questo caso la ragione è
richiamata dalla fede a riesaminare i propri procedimenti e a correggersi63.
Tommaso d’Aquino, Expositio in Boëthium, De Trinitate, a. 3, trad. ital. in N. Abbagnano, Filosofi antichi e
nuovi, Paravia, 1989, pp. 74-75
63
240
U
UNIVERSALI, Il problema degli
Il problema degli universali fu posto sostanzialmente già nell’antichità, fin da quando
Aristotele sottopose a critica la duplicazione del mondo empirico, prodotta dal mondo
ideale di Platone, e denominò “universale” (τὸ καθόλου) il concetto logico, perché di un
determinato ente comporta sempre una rappresentazione essenziale e tipica, applicabile ad
un numero indefinito di possibili casi individuali. Esso può essere o genere (τὸ γένος, tò
génos) o specie (τὸ εῖδος, tò eîdos). → Universale; Genere; Specie; Definizione
Secondo la testimonianza dello stesso Aristotele, il concetto corrisponde all’esigenza
teoretica insita nella ricorrente domanda socratica: “che cos’è?”, intesa a cogliere di un
qualsiasi oggetto la relativa “essenza”. A questa essenza, che consente di poter formulare
una definizione unitaria di molteplici fenomeni empirici, è possibile giungere per
induzione, cioè risalendo dai casi particolari dell’esperienza16. L’intelletto non è in grado di
intuire l’individualità in quanto tale, che invece è affidata alla percezione sensi. Questo
intesero dire anche gli Scolastici medioevali con la formula “Scientia non est de
singularibus” (non c’è scienza dei dati singoli), perché la scienza è solo di ciò che è
universale17. → Scienza (Aristotele)
Storicamente il dibattito sugli universali prese l’avvio da un passo della Isagoge
(introduzione) alle Categorie aristoteliche del neoplatonico Porfirio (233-305) e dai
successivi commenti di Severino Boezio (480-526).
In merito agli universali (generi e specie) Porfirio pose le seguenti questioni: se siano
realtà in sé sussistenti, cioè sostanze o solo espressioni dell’intelletto e, nella prima ipotesi,
se siano corporei o incorporei e se siano separati dalle cose sensibili o immanenti ad esse.
Boezio cercò di risolverle attenendosi ad una posizione intermedia tra aristotelismo e
platonismo: gli universali sotto l’aspetto logico sono il prodotto dell’astrazione intellettiva,
ma sul piano ontologico sono le idee, che sussistono eterne nella mente di Dio come
archetipi della creazione.
Nei secoli XI e XII la controversia sugli universali s’impose come una conseguenza della
riscoperta medioevale della dialettica. Le soluzioni, che furono proposte, emersero con
ovvietà dalle alternative ipotizzate da Porfirio. Tradizionalmente sono ricondotte a due
posizioni: realismo e nominalismo, interpretati in forma estrema o moderata.
Il realismo estremo si rifaceva alla tradizione platonica, particolarmente presente nella
teologia di orientamento agostiniano. Esso riteneva che gli universali coincidano con le
idee in sé sussistenti ab aeterno nella mente di Dio, cioè nel Lógos divino, che
personifica l’iperuranio platonico. Queste idee sono la realtà più vera e perfetta e
costituiscono i modelli che anticipano (sono ante rem) la creazione degli enti finiti, i
quali da essi derivano per imitazione e partecipazione. → Platonismo
Il realismo moderato rinviava alla posizione di Aristotele, per il quale l’unica realtà
concreta e sussistente è quella degli enti individuali, metafisicamente composti di un
16
Aristotele, La metafisica, A, 6, 987 b, 1-3; M, 4, 1078 b, 23-29
Tommaso d’Aquino, De veritate, q. 10, a. 4 e a. 5; Summa theologiae, I, q. 86, art. 1; v. Aristotele, La
metafisica, Z, 15, 1039 b 28-29, cit., I, p. 555; B, 6, 1003 a 14
17
241
principio materiale e di un principio formale o essenza. Ciò che la mente coglie nella
sua attività cognitiva è questa essenza, che essa astrae, formando il concetto. Ad essere
“universale” è propriamente il concetto, perché, in quanto astratto, esso è immateriale e
quindi applicabile ad una molteplicità indefinita di possibili individui, accomunati da
una medesima essenza (generica e specifica). → Aristotelismo
Tommaso d’Aquino, che si adeguò all’ontologia aristotelica, tenne anche conto della
dottrina cristiana della creazione, distinguendo tre diverse condizioni dell’universale:
l’universale ante rem è l’idea archetipica preesistente nella mente creatrice di Dio,
perché “nell’ordine causale gli universali sono le ragioni formali presenti nel Verbo
divino” (secundum ordinem causae universales rerum rationes sunt in Verbo Dei)18;
l’universale post rem è il concetto prodotto dalla mente nella sua attività cognitiva;
infatti “è proprio dell’universale essere astratto dalle realtà singole, poiché l’intelletto
nella sua attività teoretica ne recepisce la conoscenza dalle cose”(“accidit universali ut
a singularibus abstrahatur, inquantum intellectus illud cognoscens a rebus
cognitionem accipit”)19; l’universale in re è l’essenza immanente in ogni cosa, perché,
quando parliamo di universale abstractum, ci riferiamo alla natura stessa di una cosa
(ipsa natura rei), la quale non è presente se non nei singoli enti (“non est nisi in
singularibus”)20.
Il nominalismo estremo di Roscellino e il concettualismo di Abelardo. Secondo
Roscellino gli universali non hanno alcuna consistenza ontologica, perché sono puri
nomi, riducibili a semplici suoni (flatus vocis); per Abelardo, invece, sono soltanto
rappresentazioni mentali (concetti), le quali intendono contrassegnare in forma
generale le condizioni di somiglianza che cogliamo tra gli individui. La realtà effettiva
è necessariamente individuale (“nihil est praeter individuum”).
Prescindendo da eccessive e artificiose distinzioni riguardanti la controversia
medioevale, c’è chi intende collocare Abelardo nell’ambito del realismo moderato.
Infatti, secondo Abelardo, l’universale appartiene alla realtà del discorso (è sermo o
vox significativa), ma ha un intrinseco riferimento alla realtà oggettiva. Per questa sua
funzione significante nella Scolastica posteriore il concetto sarà detto intentio, per
esempio da Tommaso d’Aquino, che abbiamo citato come realista moderato, e da
Guglielmo di Ockham (sec. XIV), il quale tuttavia ne darà un’interpretazione
nettamente nominalistica. Secondo Ockham “qualsiasi universale è una cosa
singolare”, se lo consideriamo in sé come evento della nostra mente, ed “è universale
solo riguardo al suo significato, in quanto è segno di più cose”; inoltre, “nessun
universale è una sostanza; ogni universale è un concetto della mente, che non differisce
dall’atto di intendere”. Esso è un “segno naturale” indicativo di una pluralità indefinita
di realtà individuali, caratterizzate da particolari gradi di somiglianza: “è naturale allo
stesso modo in cui il lamento è segno della malattia o della tristezza o del dolore” ed è
un segno perché svolge la funzione di “stare al posto” (suppositio) delle cose, alle quali
è rivolto per significarle o indicarle. I termini delle varie lingue sono invece dei segni
convenzionali e arbitrari21. → Suppositio
La questione degli universali nell’età moderna
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 55, art. 3 ad primum
ibidem
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 85, art. 2, ad secundum
21
Guglielmo d’Ockham, Summa totius logicae, I, 14-15: cit. da Scritti filosofici, a cura di A. Ghisalberti, Nardini,
Firenze, 1991, pp. 110-112
18
19
20
242
Durante l’età moderna la questione si ripropose nel confronto tra i razionalisti, per i quali
gli universali sono i riflessi delle idee creatrici di Dio, presenti nelle cose e innate
nell’intelletto umano, e gli empiristi, per i quali gli universali sono puri nomi, derivati per
astrazione generalizzante dalle cose. → Innantismo
John Locke, in particolare, affermò che la nostra mente può elaborare soltanto i materiali
originari della conoscenza, cioè le idee semplici, che hanno il loro fondamento e la loro
unica causa nell’esperienza. Antecedentemente all’esperienza la mente è “un foglio
bianco”, in cui nulla è scritto. Pertanto, diversamente da Renato Cartesio e dai platonici di
Cambridge, Locke escluse qualunque forma d’innatismo. Egli osservò che le nostre
percezioni empiriche sono sempre particolari ed è soltanto nel linguaggio che ricorrono
termini generali, con i quali intendiamo riferirci a ciò che di comune cogliamo nei singoli
enti o eventi. È stata la tradizione filosofica ad interpretare questa condizione comune come
la loro essenza. Locke, pertanto, distinse l’essenza “reale” dall’essenza “nominale” e
dichiarò che l’essenza “reale”, anche nella supposizione che sia qualcosa, è inconoscibile,
perché rinvia ad un ipotetico e inverificabile ambito metafisico; noi, comunque, la
denominiamo con un termine unitario, che sintetizza le varie esperienze: è questo termine
l’essenza “nominale”, che corrisponde, per convenzione linguistica, a un’idea generale e
astratta. Diversamente dalla tradizione aristotelica, per la quale l’astrazione coincide con
l’intuizione intellettiva dell’essenza specifica o forma, cioè con il concetto universale,
Locke intese l’astrazione come una semplice generalizzazione, che elimina mentalmente le
concrete condizioni spazio-temporali dagli oggetti dell’esperienza, per conservare ciò che li
accumuna e applicarlo poi mediante il linguaggio a tutti i singoli casi. Il linguaggio ha
un’intrinseca funzione economica, consistente nel sintetizzare con un unico termine una
pluralità di esperienze simili, i cui oggetti sono sempre e soltanto individuali.
Tutta la gnoseologia empiristica riconferma questa concezione nominalistica.
La natura “disposizionale” degli universali secondo Karl Popper
Il problema degli universali si riaffaccia anche nell’epistemologia del Novecento. Secondo
Karl Popper “non c’è nessuna linea netta di divisione fra un ‘linguaggio empirico’ e un
‘linguaggio teorico’: teorizziamo continuamente, anche quando facciamo la più banale
asserzione singolare”. La ragione sta nel fatto che “anche le asserzioni singolari ordinarie
sono sempre interpretazioni dei ‘fatti’ alla luce di teorie”. Perciò i fatti “contengono
universali, e gli universali implicano sempre un comportamento conforme a leggi”. Questo
s’intende, quando si afferma che “tutti gli universali sono disposizionali”. Gli universali,
infatti, designano “disposizioni a comportarsi in un certo modo regolare, o conforme a
leggi”. È ovvio che “le leggi universali trascendono l’esperienza, se non altro perché sono
universali e trascendono qualsiasi numero finito dei loro casi osservabili”, ma si può
facilmente riconoscere che anche “le asserzioni singolari trascendono l’esperienza perché i
termini universali, che normalmente compaiono in esse, implicano disposizioni a
comportarsi in maniera conforme a leggi”. Ci sono naturalmente gradi diversi di
universalità nei termini usati. “Così ‘solubile’ o ‘fragile’ sono chiaramente disposizionali ad
un grado più alto che non ‘sciolto’ o ‘rotto’. Ma talvolta non ci si rende conto che anche
‘sciolto’ o ‘rotto’ sono disposizionali. Nessun chimico direbbe che lo zucchero o il sale si
sono sciolti in acqua, se non si aspettasse di poter riottenere lo zucchero o il sale facendo
evaporare l’acqua. Così ‘sciolto’ indica uno stato disposizionale”. Nel linguaggio gli
universali sono inevitabili. Con essi noi non possiamo pretendere di descrivere condizioni e
modi d’essere essenziali e definitivi, ma soltanto congetturare comportamenti conformi a
leggi, che in quanto tali non sono verificabili, ma solo empiricamente falsificabili. Delle
243
teorie empiriche è possibile dire che “la controllabilità o confutabilità è l’unica cosa che le
distingua, in generale, dalle teorie metafisiche”22. → Falsificabilità
UTOPIA
Il termine è di origine greca e compare per la prima volta nel titolo di un’operetta di
Thomas More del 1516 come nome di un’isola ideale, dove regnano la giustizia e
l’uguaglianza. Composto dalla negazione οὑ (non) e dal sostantivo τόπος (luogo), designa
letteralmente un “non luogo”, un luogo inesistente, come dice anche Platone dello Stato
ideale teorizzato nella Repubblica: “Non credo che esista in alcun luogo della terra. […]
forse nel cielo ne esiste un modello, per chi voglia vederlo”24. → Politica (Teorie politiche):
§ 2. L’utopia platonica e la politica come “arte regia”
L’età moderna, caratterizzata dall’avvio della scienza sperimentale, dalla scoperta di nuovi
continenti, dalla creazione di un’economia capitalistica che demolisce gli antichi rapporti
agricoli, sembra un’età fervida di scritti utopistici, quali appunto l’Utopia di Thomas More,
la Città del Sole di Tommaso Campanella (1602), La Nuova Atlantide di Francesco Bacone
(1627).
L’“Utopia” di Thomas More
Thomas More osserva gli effetti della privatizzazione delle terre agricole inglesi, resa
effettiva dal sistema delle recinzioni (enclosures): espulsione dalle campagne e conseguenti
disoccupazione e miseria dei contadini, ai quali “non resta altra alternativa che darsi al
furto, per finire sulla forca, oppure girovagare mendicando: ma, anche così, vengono gettati
in carcere come vagabondi, colpevoli di andarsene d’attorno senza far nulla, mentre in
realtà nessuno li assume, benché non chiedano di meglio che lavorare”25. Le terre, prima
destinate al lavoro agricolo delle comunità di villaggio, sono ormai adibite all’allevamento
ovino, perché i loro proprietari mirano soltanto al profitto che può provenire dal commercio
della lana. A questo riguardo More nota con caustica ironia che le pecore “son diventate
così fameliche e aggressive da divorarsi addirittura gli uomini e da devastare e spopolare
campi, case e borghi”26. La società inglese è ormai ampiamente degenerata; si assiste ad
“una congiura di ricchi i quali, con il pretesto e in nome dello Stato, non si occupano che
dei loro interessi”, anzi “stabiliscono che questi subdoli sistemi vengano osservati in nome
dello Stato, cioè anche in nome dei poveri, col farli divenire legge!”27. Lo sconforto proietta
il desiderio di giustizia verso l’isola di Utopia, ideale controfigura dell’Inghilterra effettiva.
Per ora soltanto in quel luogo che non c’è regna la virtù, ossia la conformità alla legge
morale prevista dal Creatore e resa immanente alla natura, perché là nessuno s’appropria
arbitrariamente di ciò che è comune e il potere pubblico è lo strumento che promuove
l’uguaglianza dei diritti e il benessere di tutti. Tutte le cariche sono elettive; i beni sono
gestiti comunitariamente; i lavori sono stabiliti e affidati in base alle competenze; è prevista
un’ampia tolleranza religiosa, che esclude sostanzialmente solo l’ateismo, considerato
22
K.R. Popper, Logica della scoperta scientifica, a cura di M. Trinchero, Einaudi, 1970, pp.478-481
Platone, La Repubblica, IX, 592 a-b, trad. di F. Sartori, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, Laterza,
1971, vol. 6, p. 322
25
Th. More, Utopia, a cura di L. Firpo, UTET, 1971, p. 96
26
ivi, p. 95
27
Th. More, Utopia, in antologia a cura di L. Bortone in L’utopia, Loescher, 1974, p. 78, che per il secondo libro
ho preferito all’antica versione di O. Lando, presentata da L. Firpo.
24
244
socialmente pericoloso, secondo la convinzione tradizionale, perché non garantisce
l’osservanza dei principi etici fondamentali. Thomas More è un uomo del Rinascimento. In
quanto tale, considera positivamente le potenzialità della natura umana, tanto da ritenere
che la ragione è in grado di giungere da sola alle soglie della vera religione, che poi la
Rivelazione, perfezionandola, conferma.
La “Città del Sole” di Tommaso Campanella
Tommaso Campanella elabora la sua utopia politico-religiosa in uno scritto del 1602: La
città del Sole, per il quale si ispira direttamente a Platone. Sulla città ideale proietta i
principi teoretici della sua più generale teoria metafisica (→ Rinascimento). Essa, infatti, è
governata nel suo vertice da un sacerdote filosofo, denominato Sole o Metafisico, con il
quale collaborano tre ministri, che funzionalmente rappresentano le tre “primalità”, cioè i
principi universali dell’essere: la potenza, la sapienza e l’amore. Essi sono Pon, titolare
della potenza, che presiede alla gestione dell’ordine pubblico e all’esercito; Sin, incaricato
della sapienza, che si occupa del sapere; Mor, rappresentante dell’amore, che coordina la
formazione delle famiglie e pianifica la procreazione secondo esigenze eugenetiche. Nella
città del Sole è abolita la proprietà privata dei beni, perché l’economia è orientata a
soddisfare i bisogni della comunità. Inoltre, secondo il generale orientamento naturalistico
dell’autore, si prevede che i cittadini seguano la religione naturale in un clima di grande
tolleranza. È escluso soltanto l’ateismo, per la ragione che abbiamo menzionato a proposito
di Thomas More.
La “Nuova Atlantide” di Francesco Bacone
Nella Nuova Atlantide, rimasta incompiuta e pubblicata postuma nel 1627, Francesco
Bacone intende rappresentare con vivace, ma plausibile immaginazione le immense
potenzialità del nuovo sapere sperimentale. L’isola del racconto, che nel nome richiama la
mitica terra sprofondata nel mare, della quale aveva parlato Platone28, è proposta come il
modello di un’Inghilterra proiettata verso un sicuro progresso: la vita della comunità che
l’abita è totalmente dedita all’indagine scientifica e alla sua applicazione tecnologica. Il
centro di tutta l’attività è la Casa di Salomone, “l’occhio, la guida e la luce di questo
regno”29. Il Padre della Casa di Salomone così presenta l’organizzazione: “Fine della nostra
istituzione è la conoscenza delle cause e dei segreti movimenti delle cose per allargare i
confini del potere umano verso la realizzazione di ogni possibile obiettivo”30. La
prospettiva della ricerca è rivolta in ogni utile direzione: esperimenti di coagulazione,
indurimento, refrigerazione e conservazione dei corpi; sviluppi prodigiosi delle arti
meccaniche, ottiche ed acustiche, ecc.. C’è un’ampia disponibilità di strutture e servizi,
come le torri di osservazione degli eventi atmosferici, i luoghi di riproduzione dei fenomeni
meteorologici, gli ambienti di colture varie, gli allevamenti di animali per verificare nuove
possibilità di fecondazione e di incroci, i laboratori di cure mediche e chirurgiche. Tutto ciò
appare una dimostrazione di fantasia “realistica” e ovvia per noi oggi, ma
sovrabbondantemente prodigiosa per gli uomini del Seicento. Una convinzione costante
sottende la prospettiva del grande progresso che l’umanità ha di fronte: occorre assicurare
una sistematica alleanza tra la scienza e la tecnica, perché comune è il loro fondamentale
scopo di soddisfare i desideri umani di salute, ricchezza e potere. Tuttavia il successo della
complessa impresa dipenderà sempre più da un’organizzazione collettiva, anziché da
28
Platone, Timeo, 24 e – 25 d; Crizia
F. Bacone, La Nuova Atlantide, in Scritti filosofici, a cura di P. Rossi, UTET, 1975, p. 833
30
ivi, p. 855
29
245
individui dotati e operanti ognuno per conto proprio. Perciò nella Casa di Salomone tutti i
confratelli si riuniscono spesso “per considerare il lavoro precedente e i risultati, si
preoccupano di compiere su questa base nuovi esperimenti più luminosi e che penetrano più
profondamente dei primi nella natura”31. Ci sono poi “novizi e apprendisti, perché non si
interrompa la successione degli studiosi”32. Ciò che Bacone sembra voler dire è che bisogna
saper organizzare tutte le energie culturali, finanziarie e istituzionali di un popolo
consapevole del proprio destino, perché abbiano successo queste luminose prospettive. Una
rassicurante convalida delle sue speranze sarà data nel 1662 dall’istituzione della Royal
Society of London for promoting natural knowledge, con la quale re Carlo II riconoscerà di
fatto la validità del progetto baconiano. Con questi versi Abraham Cowley accompagnerà la
promettente prospettiva: “Da questi ed altri errori d’antica data, / nei quali incorsero i nostri
errabondi predecessori, / e a guisa degli antichi Ebrei che per molti anni / in deserti pur
piccoli errarono, / Bacone, come Mosè, alfin ci trasse fuori, / oltrepassò l’arido deserto, / e
si fermò sulle soglie della terra promessa e benedetta / e dall’alto del suo ingegno eccelso /
la vide ed additolla a noi”33.
Il socialismo utopistico
Anche i radicali cambiamenti indotti dalla rivoluzione industriale sollecitano una vivace
produzione di utopie, le quali contrappongono alla nuova condizione sociale, caratterizzata
da alienazione e sfruttamento, prospettive di giustizia e uguaglianza. Karl Marx e
Friederich Engels nel Manifesto del partito comunista (1848) citano come rappresentanti di
un socialismo utopistico Robert Owen, Charles Fourier, Claude-Henri de Saint-Simon,
Etienne Cabet34, sottoponendoli ad un confronto critico con il loro socialismo “scientifico”.
A loro riguardo osservano: essi “ravvisano bensì il contrasto fra le classi e l’azione degli
elementi dissolventi nella stessa società dominante, ma non scorgono dalla parte del
proletariato nessuna funzione storica autonoma, nessun movimento politico che gli sia
proprio. […] Non trovano neppure le condizioni materiali per l’emancipazione del
proletariato […] Al posto dell’azione sociale deve subentrare la loro azione inventiva
31
ivi, p. 864
ibidem
citato in B. Farrington, Francesco Bacone, filosofo dell’età industriale, Einaudi, 1976, p. 35.
In Europa, oltre alle effimere accademie italiane dei Lincei e del Cimento e alla Royal Society, che godrà sempre
di grande autonomia, va ricordata la prestigiosa Académie Royale des Sciences, francese, che è costituita nel 1666
dalla monarchia di Luigi XIV con un netto profilo pubblico statale e conseguirà notorietà e prestigio; tra i suoi
membri, ai quali sono riconosciute pensioni vitalizie, figurano anche stranieri, come il fisico olandese Christiaan
Huygens. Citiamo anche l’Accademia berlinese delle scienze, che sarà fondata nel 1700 per iniziativa di Leibniz e
sarà posta sotto la protezione della monarchia prussiana.
34
Robert Owen (1771-1858), industriale tessile inglese, s’impegnò ad organizzare un lavoro di fabbrica dal quale
fossero esclusi i rapporti di sfruttamento; contribuì alla formazione del primo sindacalismo inglese e del
movimento cooperativo; elaborò un progetto, destinato ad un rapido fallimento, di società ideale, denominata New
Harmony, da realizzare negli Stati Uniti nell’ambito di una colonia improntata ad una forte caratterizzazione
comunitaria.
Il francese Charles Fourier (1772-1837) fantasticò su comunità operose e solidali, denominate “falansteri”,
destinati a realizzare la felice condizione sociale che i miti primitivi proiettano alle origini edeniche dell’umanità.
Il francese Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825) manifestò un atteggiamento ottimistico verso la nuova età
“positiva” della scienza e dell’industria, nella quale la società è destinata a non essere più sottoposta alle classi
oziose ormai al tramonto (clero e nobiltà), ma ad essere diretta dagli scienziati, dai tecnici e dagli industriali.
Questa nuova élite (la borghesia) è vista come la guida naturale dei lavoratori e loro alleata verso un progresso
generale. In tal modo, secondo la critica marxiana, si misconoscono gli opposti interessi di classe dell’una e degli
altri. Nello scritto incompiuto Nuovo cristianesimo (1825) Saint-Simon indicò come elemento determinante
dell’etica futura la solidarietà sociale.
Il francese Étienne Cabet (1788-1856) descrisse nel Viaggio in Icaria (1842) un sistema di vita comune ed
egualitaria, che poi tentò di organizzare in una colonia dell’Illinois.
32
33
246
personale; al posto delle condizioni storiche dell’emancipazione, condizioni fantastiche; al
posto del graduale organizzarsi del proletariato come classe, una organizzazione della
società escogitata di sana pianta”35.
Giudizi contrastanti sull’utopia: Ernst Bloch e Karl Popper
Nei confronti delle utopie sociali sono stati espressi giudizi opposti di positivo favore e di
netta riprovazione. Possiamo citare come esempi rispettivamente Ernst Bloch e Karl
Popper.
Secondo Ernst Bloch quel che c’è di più vitale nell’uomo è la tensione verso il futuro: solo
il riferimento alle potenzialità della storia dà al pensiero la solerzia di prospettare modifiche
negli assetti sociali consolidati. Di Bloch ricordiamo Spirito dell’utopia (1923) e Il
principio speranza (1959). Essi attestano che il rapporto tra la realtà e l’utopia è uno dei
problemi centrali della sua filosofia: da un lato l’utopia gli si presenta come una riserva di
speranza, capace d’indurre alla creazione di nuovi e più soddisfacenti modi di vivere,
dall’altro egli manifesta la preoccupazione che l’utopia non risulti evanescente, ma incida
effettivamente sulla disponibilità di riformare le condizioni strutturali della vita sociale
segnate dall’ingiustizia. Secondo Bloch “l’utopia concreta” del presente è il marxismo, nel
quale vanno distinte e insieme connesse una “corrente fredda” e una “corrente calda”, ossia
rispettivamente l’attenzione a non scambiare i desideri per realtà e la volontà di realizzare
nelle potenzialità del reale i desideri umani. L’utopia concreta respinge sia il superficiale
empirismo, che aderisce ai dati senza volerli superare, sia l’esuberanza infondata del
sognatore e l’astratta esaltazione giacobina. → Speranza
Il pensiero di Karl Popper è desumibile da Miseria dello storicismo (1944) e da La società
aperta e i suoi nemici (1945). Sollecitati dagli eventi tragici del ventesimo secolo, questi
scritti costituiscono degli efficaci tentativi di difendere le ragioni della libertà e del
pluralismo contro le allucinate pretese dell’utopia totalitaria, insite in ogni “storicismo”.
Con il termine “storicismo” Popper intende riferirsi ad ogni filosofia che attribuisce
all’insieme delle vicende umane un senso globale e oggettivo, cioè pretende che gli eventi
storici siano necessariamente diretti verso un fine unitario. Egli qualifica polemicamente
una filosofia di tal genere come “oracolare”, individuandola in particolare nel pensiero di
Hegel e di Marx, per i quali la storia è interpretabile sulla base di leggi dialettiche, ad essa
immanenti. Lo storicismo “oracolare” rifugge da un approccio limitato ed empiricamente
critico alla storia, perché pensa di dominarla teoricamente nella sua “totalità”,
prospettandosela in forme utopistiche ed estetizzanti, che esprimono il fanatismo di chi
s’innamora dei propri sogni di perfezione sociale ed è corrivo a scambiare una linea di
tendenza con una legge, l’indicazione di una direzione possibile e probabile, che può anche
cambiare, con lo sviluppo di un percorso necessario. Inaccettabili sul piano teoretico, gli
storicismi si rivelano seriamente pericolosi sul piano pratico, perché i loro “interpreti
ufficiali” si sentono indotti ad imporne la realizzazione attraverso la violenza intollerante
contro chiunque si opponga. → Storia, Filosofia della
35
K. Marx e F. Engels, Manifesto del partito comunista, trad. it. di P. Togliatti, Editori Riuniti, 1974, pp. 106-107
247
V
VERIFICAZIONE, Principio di
Considerato in sé, per ciò che direttamente intende enunciare, questo principio corrisponde
all’esigenza di ritenere valido un asserto empirico, quando se ne constata la corrispondenza
con i dati dell’esperienza. In questo senso ordinariamente si parla di “verifica” delle teorie,
ma, secondo un’analisi epistemologicamente e logicamente rigorosa, nell’ambito
dell’esperienza possibile le teorie scientifiche, che si sottopongono al vaglio del metodo
sperimentale, non sono affatto verificabili, ossia accertabili come vere in maniera
definitiva, ma soltanto falsificabili. Karl Popper si prodigò a favore di un’epistemologia
fallibilistica, secondo la quale rimane insuperabile la condizione di ipoteticità delle teorie
empiriche. → Falsificabilità; Fallibilismo
Il principio di verificazione fu assunto dal movimento neopositivistico addirittura come
criterio di significanza, che Moritz Schlick così formulò: “Il significato di una proposizione
è il metodo della sua verifica”, nel senso che “l’indicazione delle circostanze, nelle quali
una proposizione è vera, equivale perfettamente all’indicazione del suo senso. E queste
condizioni […] debbono in ultima istanza, trovarsi nei dati di fatto. […] Il senso di una
proposizione viene fondamentalmente determinato solo dal dato, e da nessun’altra cosa”23.
Tali enunciazioni non fecero che riproporre ciò che il positivismo ottocentesco aveva già
affermato con le parole di Auguste Comte: “Ogni proposizione che non è strettamente
riducibile alla semplice enunciazione di un fatto, particolare o generale, non può presentare
nessun senso reale e intelligibile”24.
L’assunzione del principio di verificazione comportò la convinzione che le proposizioni
della metafisica siano per definizione senza senso, perché non sono verificabili.
Paradossalmente, però, proprio questo principio, considerato il perno teorico del
neopositivismo, si trovò esposto alla critica deducibile dagli stessi criteri epistemologici
indicati dai suoi propugnatori: fu accusato di dogmatismo metafisico, perché non è
verificabile ed è privo di giustificazione, non rientrando in nessuno dei tipi di proposizioni
ritenute accettabili, né tra le proposizioni analitiche né tra quelle sintetiche. In effetti degli
enunciati generali (principi e leggi) non è possibile dare un riscontro empirico, ossia una
verifica. → Neopositivismo
Anche Karl Popper evidenziò questa critica con lucidità e forza. Di fronte ad essa i
neopositivisti reagirono modificando la posizione sostenuta fino ad allora. Prendendo le
distanze dall’assolutismo teorico precedente, avviarono la fase di “liberalizzazione” del
movimento, che comportò l’abbandono della precedente pretesa di “verificabilità” delle
ipotesi e l’adozione di un orientamento più critico, disponibile ad accettare la prospettiva
più modesta della loro “controllabilità” e “confermabilità” e ad accondiscendere ad una
considerazione probabilistica delle enunciazioni scientifiche. Il nuovo atteggiamento
metodico fu così espresso da Rudolf Carnap: “Se in una serie prolungata di esperimenti di
controllo non si scopre alcun caso negativo, ma, anzi, il numero dei casi positivi via via
aumenta, allora anche la nostra fiducia nella legge aumenta gradualmente. Così, anziché di
23
M. Schlick, Positivismus und Realismus e Meaning and verification, cit. da F. Barone in Il neopositivismo
logico, vol. I, Laterza, 1977, p. 252
24
A. Comte, Discorso sullo spirito positivo, a cura di A. Negri, Laterza, 1985, p. 15
248
verificazione, qui possiamo parlare di conferma gradualmente crescente della legge”26. →
Probabilità; Falsificabilità, Principio di
VERITÀ
La verità, indipendentemente dalle soluzioni che si possono dare agli interrogativi che la
riguardano, si impone assiomaticamente a chiunque come la condizione ineludibile della
validità del pensare e dell’agire. Essa, infatti, è il criterio fondamentale e intrascendibile
della nostra funzione giudicante, rispetto alla quale qualsiasi atteggiamento volontaristico o
fideistico rivela la propria aporeticità. Forte di questa irrefutabile assiomaticità, Baruch
Spinoza con domanda retorica e conseguente risposta scrive nell’Ethica: “Che cosa si può
dare di più chiaro e di più certo – che sia norma della verità – dell’idea vera? Senz’altro,
come la luce manifesta se stessa e le tenebre, così la verità è norma di sé e del falso” (Sane
sicut lux seipsam et tenebras manifestat, veritas norma sui et falsi est)27. La verità è
l’opposto positivo della falsità, che pertanto la presuppone. La ragione, orientata
naturalmente alla verità, non ha alcuna autorità esterna che la possa legittimamente
costringere, perché è competente a giudicare ogni teoria.
Questa tesi è di per sé ovvia nella sua astratta formulazione. Tuttavia, nel concreto
dell’esperienza umana constatiamo ricorrentemente che la verità assoluta e definitiva non è
a disposizione di alcuno. L’autentica ricerca è sempre problematica. La storia, poi,
c’insegna che il frutto del dogmatismo è l’intolleranza.
Il significato della parola “verità” sembra semplice, tanto è banale il quotidiano impiego
che se ne fa. L’uso filosofico, invece, presenta una complessità e una varietà di aspetti, di
cui occorre essere consapevoli.
La verità come rivelazione dell’essere
L’etimologia del corrispondente termine greco ἀλήθεια (alétheia) esprime con l’iniziale α
privativo il venir meno dello situazione in cui la realtà rimane ancora nascosta, perché
sfugge all’osservazione o è soggetta all’oblio: termine, questo, che corrisponde al greco
léthe ed è alla radice del verbo lantháno (mi sottraggo alla vista, sono ignorato). La verità,
infatti, è un evento di rivelazione e scoperta. La fiducia di poter certificare in relazione ad
essa la validità della conoscenza è la condizione fondamentale che dà senso all’indagine
filosofica.
Parmenide nel suo poema Perì phýseos (Sulla natura) assume il tono convinto di un
profeta, che ha il compito di rivelare la verità, alla quale si è introdotti per benevolenza
divina. L’iniziazione è considerata un dono per chi si dimostra disponibile a compiere
l’itinerario richiesto. Sono due gli opposti sentieri della ricerca: c’è il percorso della perfetta
verità, proprio della retta ragione, e c’è quello dell’opinione ingannevole (δόξα, dóxa). Così
li indica al filosofo la dea, che lo introduce sulla via del corretto sapere: “Bisogna che tu
impari a conoscere ogni cosa, / sia l’animo inconcusso della ben rotonda verità / sia le
opinioni dei mortali, nelle quali non risiede legittima credibilità”. La verità rivelata al
filosofo riguarda l’essere, la cui corretta rappresentazione va affidata al pensiero, non ai
sensi. Il pensiero e l’essere sottostanno alle stesse leggi, perché ciò che possiamo pensare e
dire è soltanto l’essere; pertanto “è la stessa cosa pensare e pensare che è: / perché senza
l’essere, in ciò che è detto, non troverai il pensare”; al contrario, “il non essere né lo puoi
26
R. Carnap, Controllabilità e significato, in Analiticità, significanza, induzione, Il Mulino, 1971, p. 157
B. Spinoza, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, II, Scolio alla prop. 43, trad. di Sossio Giametta,
Boringhieri, 1971
27
249
pensare né lo puoi esprimere”: “è un sentiero del tutto inindagabile”. Soltanto i “mortali che
nulla sanno” e sembrano essere “gente dalla doppia testa” non distinguono le proprietà
dell’essere, confondendolo e mescolandolo a capriccio con il non essere, attribuendogli la
molteplicità e il divenire28. → Essere
La tonalità suggestiva della rappresentazione oracolare di Parmenide sembra riproporsi
molti secoli dopo con Martin Heidegger. Anche nelle meditazioni di questo grande filosofo
tedesco del Novecento, soprattutto nel periodo successivo alla svolta (kehre) che imprime
alla propria ricerca, la verità è intesa come “dis-velamento” dell’essere, che si sottrae al
nascondimento e tuttavia nello stesso tempo continua a celarsi nel suo mistero. Questa
rivelazione è frutto dell’iniziativa dell’Essere stesso, non dell’uomo. La filosofia di
Heidegger non è “umanistica”, cioè non è incentrata sull’uomo, anche se l’Essere ha
bisogno dell’uomo per rivelarsi, perché non si dà senza di lui, però l’uomo “non è il
padrone dell’Essere”, ma gli appartiene. L’uomo è “il pastore dell’Essere”29, nel senso che
è chiamato a custodirne la verità, la quale dipende soltanto dall’Essere e dalla sua iniziativa.
Già in Essere e tempo Heidegger rilevava che, “se la verità ha a buon diritto una
connessione originaria con l’essere, il problema della verità finisce per cadere nell’ambito
della problematica ontologica fondamentale”, che appare pertanto primaria rispetto alla
tradizionale maniera di porre la questione gnoseologica. L’uomo, infatti, in quanto Esserci
(Dasein), rivela la propria essenziale condizione di “essere-nel-mondo”, costitutivamente
orientato e aperto all’Essere. In quanto tale, “l’Esserci […] è essenzialmente nella verità”;
e, contrariamente a ciò che spesso banalmente si afferma citando Aristotele, ci vediamo
obbligati a sostenere che “l’asserzione [o giudizio] non è il ‘luogo’ della verità”, ma “la
verità più rigorosa e originaria è il ‘luogo’ dell’asserzione e la condizione ontologica della
possibilità che le asserzioni possano essere vere o false”30.
Heidegger ripensa criticamente la storia della metafisica: essa coincide con il secolare
percorso della razionalità occidentale, che nell’illusione di studiare l’Essere alla maniera
degli enti e delle “cose”, lo scambia con essi, riducendosi ad una fisica. La conseguenza è
che non rimane più nulla dell’Essere e della sua verità, intesi in senso proprio:
promuovendo gli enti nella dimenticanza dell’Essere, la metafisica realizza il processo
storico del nichilismo. Essa concepisce l’Essere come pura “presenza”, ma così la storia
della metafisica è la storia dell’oblio dell’Essere e dell’oblio della sua differenza dagli enti
(la “differenza ontologica”). → Metafisica; Nichilismo
Platone ne fu il primo responsabile, perché, rimosse la concezione della verità come
rivelazione dell’Essere, che si era già affacciata nella fase aurorale della filosofia greca, e la
interpretò come l’esito di un percorso umano (la paidéia descritta nel mito della caverna),
cioè come correttezza e adeguatezza (ὀρθότης, orthótes) della visione intellettiva, i cui
oggetti sono le idee. Il termine “idea” è la trascrizione letterale dell’originaria parola greca
ἰδέα, la cui radice è la stessa del verbo ἰδεῖν (ideîn), che esprime l’atto del “vedere”,
descritto da Platone come qualcosa che è funzionalmente a disposizione dell’uomo 31.
La metafisica raggiunse il suo vertice con la moderna nozione di soggetto, tematizzato da
Cartesio in poi come il centro della ricerca filosofica: pensiamo in particolare alla
“rivoluzione copernicana” di Kant e all’innesto sul suo trascendentalismo della metafisica
Parmenide, “Frammenti”, DK B 1, 8, 2, 6, in I Presocratici, Testimonianze e frammenti, a cura di G.
Giannantoni, Laterza, 1975, vol. I, vv. 28-30, vv. 38-40, vv. 5-7 e vv. 5-6, rispettiv, alle pp. 270, 276, 271, 272
29
M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, a cura di A. Bixio e G. Vattimo, SEI, 1975, p. 109
30
M. Heidegger, Essere e tempo, § 44, trad it. di P. Chiodi, Longanesi, 1970, pp. 327 e 343-344
31
v. M. Heidegger, La dottrina di Platone sulla verità, a cura di A. Bixio riveduta e G. Vattimo, SEI, 1975, pp. 6264
28
250
idealistica. A partire dal cogito cartesiano il soggetto fu inteso come vero sub-jectum, nel
senso che fu posto a fondamento dell’Essere; alla sua presenza l’Essere si trasforma in
oggetto, ossia in ciò che sta di fronte (ob-jectum) alla progettazione umana. La razionalità
moderna mise il “calcolo” alla base del progettare e dell’agire e il “pensiero calcolante”
potè così dispiegare sempre più inesorabilmente una logica di dominio e di sfruttamento
della Terra e dell’uomo stesso. Il dominio del mondo, realizzato mediante la tecnica, è
“metafisica compiuta”. Friedrich Nietzsche, che ha denunciato il nichilismo imminente
nella storia dell’Occidente, non l’ha affatto oltrepassato, ma l’ha portato al suo parossismo,
quando ha indicato nella “volontà di potenza” il fondamento dei nuovi valori. Il trionfo del
“nichilismo” sta nello smarrimento del senso dell’Essere. Soltanto un “pensiero meditante”
può consentire all’Essere di rivelarsi nella sua verità.
La verità come autenticità in opposizione ad apparenza
Spesso, anche nel linguaggio comune, “vero” designa ciò che è reale e autentico in
opposizione a ciò che è di qualità inferiore o, addirittura, apparente, ingannevole, illusorio.
Una tale accezione è presente in Platone, anche se non nella forma estrema con la quale
Parmenide aveva contrapposto all’alétheia la doxa (opinione). Secondo Platone la verità è
la conoscenza che corrisponde alla condizione ontologica del “mondo intelligibile”, che per
la sua perfezione è distinto dal mondo sensibile, ma ne è anche la causa. Il mondo sensibile,
invece, è intrinsecamente imperfetto e incapace di dar conto del suo essere. Perciò vera è la
realtà superiore, che può spiegare quella inferiore. Ai sofisti Platone rimproverò
l’incapacità di assumere la visione di ciò che permane stabilmente e non è insidiato dalla
mutevolezza delle cose, perché è la struttura essenziale e unitaria che sottostà alla cangiante
molteplicità dei fenomeni, il fondamento comune in cui questi possono riconoscersi. Questo
egli intese con la parola “idea”, che originariamente, come abbiamo già rilevato, significa
“ciò che si vede” di una cosa, cioè l’aspetto o forma. Questa forma, però, è riferita non a
quel che è esterno e sta alla superficie di una cosa, ma alla sua realtà più profonda e vera,
che solo l’intelletto può “vedere”. Come sinonimo di idea, poi, interviene anche la parola
ousía, che è l’espressione sostantivale del verbo “essere”, cioè “essenza”. Così, per
esempio, Platone si esprime contro il relativismo di Protagora: “Le cose hanno in se stesse
una lor propria e stabile essenza, non dipendono da noi, né da noi sono tratte in su e in giù
secondo la immaginazione nostra, bensì esistono per se stesse, senz’altro rapporto che con
la loro essenza, così come sono per natura”32. Rispetto alla successiva ontologia
aristotelica, che considera l’essenza come la struttura costitutiva e immanente ad ogni ente,
l’ontologia platonica è caratterizzata invece da una configurazione dualistica, nel senso che
l’essenza, considerata nella sua verità e perfezione, è proiettata al di là del mondo sensibile
in una condizione di trascendenza, da cui le cose sensibili derivano il loro essere in una
misura inevitabilmente inferiore. → Platonismo
La verità come corrispondenza tra ciò che si dice e ciò che è
Una tale accezione, che riguarda direttamente il discorso, fu già usata da Platone, come ci
attesta questa citazione del Cratilo: “Quello che dica gli enti come sono, sarà vero; quello
come non sono, falso”33. Aristotele ne sviluppò poi l’analisi a proposito della proposizione
apofantica, cioè enunciativa o assertiva, la quale consiste nel giudizio che afferma o nega
qualcosa (predicato) di un soggetto (→ Giudizio; Proposizione). La logica aristotelica
32
Platone, Cratilo, 386 e, trad. di L. Minio-Paluello, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1971,
vol. 2, p. 19
33
Platone, Cratilo, 385 b, cit., p. 17
251
esclude gli altri tipi di proposizione, che sono bensì dotati di senso, ma consistono in
preghiere, esclamazioni, comandi, desideri, ecc. In maniera specifica il giudizio enunciativo
è suscettibile di essere vero o falso, perché “il vero e il falso non sono nelle cose [...], ma
solo nel pensiero”34; perciò “sarà nel falso colui che ritiene che le cose stiano in modo
contrario a come effettivamente stanno. [...] Infatti, non perché noi ti pensiamo bianco tu sei
veramente bianco, ma per il fatto che tu sei bianco, noi, che affermiamo questo, siamo nel
vero”35. Quindi i semplici termini di per sé non sono nè veri né falsi, perché la verità è
propria dell’enunciazione, la quale è vera se corrisponde alla realtà, altrimenti è falsa. Un
termine, secondo le dirette parole di Aritostele, “significa bensì qualcosa, ma non indica
ancora alcunché di vero o di falso, se non è stato aggiunto l’essere oppure il non essere, con
una determinazione assoluta o temporale”36. → Realismo
Quando, poi, quel che si dice corrisponde a ciò che si pensa e, almeno intenzionalmente, a
ciò che è nella realtà delle cose, siamo di fronte ad una dimostrazione di veridicità o
veracità, cioè eticamente di sincerità.
La nozione di verità in Tommaso d’Aquino
La riflessione medioevale, in particolare con Tommaso d’Aquino, riprese entrambe le
accezioni del termine “verità”, sia quella ontologica che quella logico-gnoseologica.
Dall’ontologia tomista il verum è indicato tra gli attributi trascendentali, cioè universali,
dell’essere; perciò è perfettamente convertibile o coincidente con l’essere: ens et verum
convertuntur, nel senso che il vero non si aggiunge all’essere dall’esterno, ma ne esprime
un aspetto fondamentale. La verità di un ente consiste nella sua intelligibilità e nella sua
corrispondenza con l’esemplarità dell’idea creatrice presente nella mente di Dio. Infatti, la
norma assoluta della verità è Dio, che è la causa ontologica prima, ossia il principio
creatore da cui tutto deriva. La sua mente non ha l’oggetto al di fuori di sé, perciò conosce
ogni cosa con assoluta trasparenza; l’uomo, invece, cerca la verità e, per conseguirla, si
deve conformare a ciò che oggettivamente gli è esterno.
La teoria tomista della verità si attiene a due fondamentali criteri epistemologici: quello
esemplaristico, di derivazione platonica, secondo il quale gli enti si conformano alle
corrispondenti idee creatrici, e quello realistico, che è direttamente derivato da Aristotele,
secondo il quale la mente si conforma alla realtà che intende conoscere. Nella sua
complessità la teoria è così espressa dalle seguenti formule, nelle quali i due termini
intellectus e res sono intesi come reversibili nel loro reciproco rapporto.
La verità è adaequatio rei et intellectus, cioè risiede nella corrispondenza tra la realtà e
l’intelletto, sia nel senso che è la realtà che si adegua alle idee presenti nell’intelletto
divino sia nel senso che è l’intelletto umano che si adegua alla realtà, perché
“evidentemente una cosa è riferibile di per sé all’intelletto dal quale dipende nel suo
essere, ma accidentalmente all’intelletto dal quale può essere conosciuta” (res […] per
se quidem habet ordinem ad intellectum a quo dependet secundum suum esse; per
accidens autem ad intellectum a quo cognoscibilis est). Ovviamente gli enti naturali
dipendono ontologicamente dall’intelletto di Dio creatore, invece gli enti artificiali
dipendono ontologicamente dall’intelletto umano che li progetta37.
34
Aristotele, La metafisica, E, 4, 1027 b, 25-26, a cura di G. Reale, Loffredo, 1968, I, p. 498
ivi, , 10, 1051 b 4-8, cit., II, p. 59
36
Aristotele, Dell’espressione, 1, 16 a 17-19, trad. di G. Colli, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973,
vol. 1, p. 52
37
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 16, art. 1 c; vedi art. 2, arg. 2 (dove la formula è derivata dal De
definitionibus del filosofo ebreo Isacco, del sec. IX-X); v. De veritate, q. I, a. 1
35
252
“Per conformitatem intellectus et rei veritas definitur”38: la verità è definita sia dal
conformarsi della realtà all’intelletto divino sia dal conformarsi dell’intelletto umano
alla realtà.
L’analisi di Alfred Tarski
A proposito della verità intesa come corrispondenza tra ciò che si dice e ciò che è, possiamo
opportunamente ricordare la rigorosa puntualizzazione del logico polacco Alfred Tarski
(1902-1983): “La definizione di verità, per adeguarsi al modo in cui la intendiamo, deve
implicare la seguente equivalenza:
L’enunciato ‘la neve è bianca’ è vero se e solo se la neve è bianca.
Voglio sottolineare che l’espressione ‘la neve è bianca’ appare fra virgolette nella parte
sinistra dell’equivalenza e senza virgolette nella destra. A destra abbiamo l’enunciato in se
stesso e a sinistra il nome dell’enunciato. Nella terminologia dei logici medioevali,
potremmo anche dire che a destra le parole ‘la neve è bianca’ compaiono in suppositio
formalis [cioè in un senso che indica ciò che è significato dalla formulazione] e a sinistra in
suppositio materialis [cioè in un senso che indica solo la formulazione significante]”39 (→
Senso e significato). Quando si procede all’enunciazione della verità o falsità di un asserto,
il linguaggio si dispone su due livelli: quello del “linguaggio-oggetto” e quello del
“metalinguaggio”, che è di ordine superiore, perché definisce le caratteristiche (in questo
caso la verità o falsità) del linguaggio-oggetto. Solo ricorrendo a questa distinzione si
possono evitare le antinomie, che nascono da quel genere di paradossi, tra i quali notissimo
è quello del mentitore. → Paradosso
La verità come coerenza logica
La coerenza è data dall’accordo della mente con se stessa, ossia dal rispetto del
fondamentale principio logico di non contraddizione, nel quale Aristotele individuò la
garanzia prima di qualsiasi discorso che intenda avere un senso. Non riconoscere questo
principio è come ammettere che, nel momento in cui si afferma qualcosa, si possa nello
stesso senso anche negarlo, ma così non si distingue più una cosa dall’altra: è come pensare
che si sta contemporaneamente dicendo il vero e il falso. La coerenza non riguarda
l’oggetto specifico su cui il ragionamento si svolge, ma soltanto la formale osservanza del
principio di non contraddizione. → Contraddizione, Principio di non
L’attenzione a questa accezione di verità, che la intende come coerenza logica e correttezza
formale del discorso, fu particolarmente presente nella filosofia moderna. Il grande
entusiasmo per la geometria e il metodo deduttivo, da essa rigorosamente applicato,
sospinse in questo senso. Thomas Hobbes, che adottò una concezione nominalistica del
linguaggio, afferma: “Vero o falso sono attributi delle parole, non delle cose […] La verità
consiste nel retto ordinamento dei nomi nelle nostre affermazioni”40. Il linguaggio è lo
strumento operativo con il quale realizziamo la conoscenza: si parte dalle definizioni delle
parole, si procede con le possibili connessioni di queste nelle proposizioni e si prosegue con
i ragionamenti che a loro volta connettono le proposizioni in maniera tale da derivare da
determinate premesse determinate conseguenze logiche. Queste operazioni combinatorie
costituiscono un vero e proprio calcolo; perciò ragionare significa calcolare, cioè
addizionare o sottrarre.
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 16, art. 2 c
A. Tarski, La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica, in Semantica e filosofia del
linguaggio, a cura di L. Linski, Il Saggiatore, 1969, pp. 30-31
40
Leviatano, a cura di G. Micheli, La Nuova Italia, 1976, I, IV, p. 34
38
39
253
Alquanto singolare, poi, fu la concezione di Baruch Spinoza. Anche per lui la verità è
data dalla corrispondenza tra l’idea e la cosa; essa, tuttavia, non va interpretata secondo la
teoria gnoseologica dell’intenzionalità del pensiero in rapporto alla realtà oggettiva. Egli,
infatti, afferma che “l’ordine e la connessione delle idee è identico all’ordine e alla
connessione delle cose” (ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum)41,
intendendo quest’ordine e questa connessione come uno svolgimento causale deduttivo,
tipico del procedimento geometrico (more geometrico demonstrare). Esso caratterizza
egualmente tutti gli infiniti attributi della sostanza divina, in particolare l’attributo del
pensiero e l’attributo dell’estensione, che pertanto procedono in parallelo. Per Spinoza,
quindi, la deduzione è non più solo un procedimento logico, ma ontologico, e la
corrispondenza tra le idee e le cose è comunque assicurata dalla conformità della loro
deduzione.
L’interpretazione trascendentale della verità e gli esiti metafisici dell’idealismo romantico
Immanuel Kant con la sua “rivoluzione copernicana” invertì il tradizionale rapporto tra il
soggetto conoscente e l’oggetto conosciuto, in maniera tale che non è più il soggetto ad
adeguarsi all’oggetto da conoscere (realismo gnoseologico), ma, viceversa, è l’oggetto che
si modella sulle “forme a priori” del soggetto. Perciò la classica definizione della verità:
“adaequatio rei et intellectus” (corrispondenza tra la realtà e la mente), che era solitamente
intesa come un intellectum rei adaequare (far corrispondere la mente alla realtà), andrebbe
invece interpretata come un rem intellectui adaequare (far corrispondere la realtà alla
mente). Questa rivoluzione epistemologica comportò la distinzione tra “fenomeno” e “cosa
in sé”, ossia tra la realtà in quanto appare al soggetto conoscente e la realtà pensata nella
sua assolutezza, a prescindere dalle forme a priori mediante le quali è mentalmente recepita
e organizzata. Ciò indusse Kant a dare un diverso significato all’oggettività della
conoscenza. Per il suo trascendentalismo è “oggettiva” una conoscenza dotata di
universalità e necessità; è “soggettiva”, invece, una conoscenza riferita al singolo soggetto
conoscente. → “Rivoluzione copernicana”
L’idealismo romantico di Fichte abolì la nozione di “cosa in sé” e annullò la possibilità di
riconoscere una realtà diversa e separata dal soggetto trascendentale. In tal modo
contravvenne all’interpretazione che Kant stesso aveva dato del proprio trascendentalismo,
quando si era preoccupato di segnalare che l’idealità delle condizioni a priori della
conoscenza è soltanto formale e si concilia con il “realismo empirico”, secondo il quale i
contenuti cognitivi ci giungono dall’esterno mediante le sensazioni. Per il grande filosofo
dell’Illuminismo nell’esperienza sensibile il soggetto rimane fondamentalmente recettivo
rispetto ai dati, che pertanto attestano l’effettiva alterità dell’oggetto. L’idealismo
romantico, invece, attribuì al soggetto trascendentale un’attività produttrice, assoluta e
infinita, che faceva di lui, ormai non più limitato da qualcosa di esterno, il creatore della
realtà. → Idealismo
Con Hegel, poi, l’idealismo abbandonò il profilo soggettivistico che aveva con J.G.
Fichte, per evidenziare l’intima e unitaria struttura razionale di tutta la realtà nell’Idea. In
tal modo egli ripropose in forma dialettica l’identità parmenidea tra essere e pensare: “Ciò
che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale. [...] Intendere ciò che è, è il compito
della filosofia, poiché ciò che è, è la ragione”42.
B. Spinoza, Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico, II, prop. 7, trad. di Sossio Giametta, Boringhieri,
1971
42
G.W.F. Hegel, Lineamenti della filosofia del diritto, trad. it. di F. Messineo, Laterza, 1974, p. 16
41
254
Solo con “la fatica del concetto”, cioè attraverso la mediazione dialettica e non con
l’illusoria pretesa di far valere un’intuizione immediata, lo Spirito giunge a superare e a
risolvere compiutamente in sé, nella piena coscienza della propria infinità e assolutezza, la
realtà finita, conseguendo così la propria verità, perché “il vero è l’intiero. Ma l’intiero è
soltanto l’essenza che si completa mediante il suo sviluppo. Dell’Assoluto devesi dire che
esso è essenzialmente Resultato, che solo alla fine è ciò che è in verità43. → Dialettica
La concezione pragmatistica della verità
Contro la pretesa del tradizionale razionalismo d’impostazione cartesiana di cogliere la
validità delle nostre idee nella loro evidenza intuitiva, tra l’Ottocento e il Novecento il
“pragmatismo” espresse un orientamento epistemologico secondo il quale il significato di
un concetto è dato da tutte le conseguenze pratiche e le operazioni concrete che da esso
derivano. In diversi suoi rappresentanti si caratterizzò per un sostanziale irrazionalismo e
per l’importanza prioritaria data alla fede e al sentimento. William James ritenne di poter
ridurre la verità di una credenza alla sua utilità psicologica. Invece Charles Sanders Peirce e
John Dewey sostennero che non si potesse rinunciare all’esigenza di una trattazione
razionale dei problemi che l’esperienza sempre suscita. A loro giudizio ciò significava che
la questione della validità e della verità delle nostre convinzioni e ipotesi va risolta con il
metodo sperimentale della verifica, pubblicamente controllabile e confrontabile nelle sue
procedure e nei suoi effettivi risultati. → Pragmatismo
La verità come chiarificazione dell’esistenza
È una concezione che riguarda soprattutto i filosofi che nel Novecento appuntarono la loro
attenzione sull’esistenza, intesa come specifica condizione ontologica dell’uomo. Qui ci
riferiamo in particolare a Karl Jaspers, per il quale la verità può emergere dall’esistenza
stessa, se ne sollecitiamo opportunamente le intrinseche potenzialità metafisiche, connesse
al suo originario orientamento alla trascendenza. Ciascuno di noi, infatti, può cogliere
nell’immanenza della sua propria condizione un rinvio alla totalità dell’essere:
l’Umgreifende, che similmente all’ápeiron di Anassimandro tutto abbraccia come un
orizzonte onni-conglobante, infinito e intrascendibile, inoggettivabile e nascosto (→
Umgreifende). Tutto ciò che costituisce la nostra esperienza naturale e storica può essere
“cifra” della trascendenza dell’essere, il cui mistero non è mai direttamente svelato, ma è
affidato ad un’interpretazione, che nella concreta limitatezza dell’esistenza allude e invia a
ciò che va al di là di essa. La valenza simbolica della “cifra” consiste nel tenere insieme la
duplicità, solo apparentemente contraddittoria, di presenza e assenza, in virtù della quale gli
enti non sono l’essere, ma in essi l’essere rivela la propria trascendenza. In origine, infatti,
il “simbolo” (sýmbolon) era materialmente la metà di una tessera, che combaciava
perfettamente con l’altra parte e consentiva così di riconoscere chi la possedeva. In generale
esso ha la funzione di ripristinare un’unità interrotta, di mettere in comunione ciò che è
stato separato, di stringere il legame che unisce ad una realtà che ci completa. Perciò
occorre pensare la trascendenza e l’immanenza come dialetticamente congiunte nella forma
della “trascendenza immanente” della “cifra”. → Cifra
In questa direzione il pensare diventa una forma di fede, che ci fa consapevoli della nostra
costitutiva incompiutezza e alimenta in noi la convinzione che la verità ci trascende.
Diversamente dalla fede dogmatica delle chiese, soprattutto della chiesa cattolica, la fede
filosofica mantiene un rapporto problematico con la verità. La pluralità delle situazioni, che
G.W.F. Hegel, Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, La Nuova Italia, 1976, § II, p. 15. L’espressione “la
fatica del concetto” appare nella Prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, cit., § IV, p. 48
43
255
riguardano le singole esistenze, permette di intendere la verità come la prospettiva di un
percorso mai concluso, ma tendenzialmente unificante, perché si svolge attraverso la
comunicazione, che gli uomini sono in grado di realizzare tra loro. L’inconcludenza, che
caratterizza l’esito della ricerca, è costitutiva dell’autentico filosofare, che del sapere rivela
l’amore, non il possesso. Essa ci educa ad interpretare positivamente i limiti dell’esistenza
come un rinvio all’essere, che ovunque e sempre ci trascende e nei cui riguardi ci
disponiamo in attesa fiduciosa. → Fede e fideismo (La fede filosofica di Karl Jaspers)
VITA
La biologia, come tutte le altre scienze empiriche, da secoli ha acquisito, mediante
l’applicazione del moderno metodo sperimentale agli oggetti delle sue indagini, una piena
autonomia nei riguardi della tradizionale pretesa enciclopedica della filosofia. Perciò, da un
punto di vista semplicemente storico, qui possiamo ricordare che la filosofia classica ha
identificato la specificità della vita (in greco ζωή, in latino vita) in un movimento spontaneo
e immanente di un organismo materialmente predisposto. Infatti, il vivente, diversamente
dagli altri enti, appare dotato di automatismo, cioè della capacità di muoversi da sé
(αὐτοκίνητος o αὐτόματος, autokínetos o autómatos), nel senso che svolge autonomamente
le sue funzioni, essendone esso il principio e il termine. → Automatismo; Spontaneità
A prima vista ciò sembra in contrasto con il principio generale, enunciato già da
Aristotele: “Tutto ciò che si muove è necessariamente mosso da qualcosa” (“Ἅπαν τὸ
κινούμενον ἀναγκη ὐπό τινος κινεῖσθαι”) e noto nella formulazione latina della Scolastica
medioevale: “Omne quod movetur ab alio movetur”, su cui, tra l’altro, si basa la
tradizionale dimostrazione dell’esistenza di un Motore Immobile assolutamente primo, al
quale si connette causalmente ogni movimento presente nel mondo (→ Causalità, Principio
di). Così invece non è, secondo la precisazione di Tommaso d’Aquino, che riconduce in
questi termini il principio di causalità al principio di non contraddizione: “È impossibile che
sotto lo stesso rapporto e nella stesso modo un ente sia insieme movente e mosso, cioè che
si muova da sé e passi da se stesso dalla potenza all’atto”80. Quindi in ogni determinato
ambito del reale, in cui si dà movimento, c’è un primo motore immobile, perché non è il
tutto a muovere tutto se stesso, cioè ad essere motore e mosso. Anche nei viventi, che sono
definiti come gli enti che muovono se stessi, c’è il principio agente, che è la ψύχή (psyché),
cioè l’anima, e ciò che è mosso, cioè il corpo. L’anima è la causa del movimento vitale al
quale presiede, ma nemmeno essa è la causa prima in senso assoluto, perché ha un inizio e
può agire solo in un positivo contesto di condizioni e concause, che glielo consentono. Per
esempio, la pianta per vivere ha bisogno di un terreno adatto e di un clima confacente. →
Anima
La concezione filosofica, che considera il dinamismo spontaneo e immanente della vita una
realtà peculiare degli organismi che ne sono dotati e, pertanto, irriducibile a semplici
processi fisici e chimici, è detta vitalismo. → Vitalismo
Secondo i filosofi presocratici tutta la natura (phýsis) è originariamente dotata di vita. È,
questa, una concezione ilozoistica, che gli stoici ripropongono nel periodo ellenistico. Per
80
Aristotele, Fisica, VII (H), 1, 241 b 34, trad. di A. Russo, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1973, vol.
3, p. 167; Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 2, art. 3 c
256
essi la divinità è Anima e Lógos del mondo, principio del dinamismo universale. →
Ilozoismo
Platone nel Fedro argomenta a favore dell’immortalità dell’anima, richiamando
l’attenzione su ciò che essa essenzialmente è: il principio della vita, in quanto “è scaturigine
e principio di moto” (→ Immortalità dell’anima). Ora, poiché “ciò che si muove da sé non
può essere che anima”, Platone, tornando nelle Leggi a riconsiderare questo tema in un
ambito universale, dice che tale deve essere soprattutto la natura del principio assoluto, da
cui dipende il governo di tutte le cose, perché “l’anima guida e comanda”, “amministra e
regge”. Ecco la sua affermazione: “Ognuno deve credere che quest’anima è qualche cosa di
più del sole; […] ognuno deve ritenere che è una divinità”81.
Aristotele, poi, fissa per la tradizione successiva la distinzione di tre diversi generi di anima
o principi vitali: vegetativa, sensitiva e razionale (→ Anima; Animazione umana). Egli
attribuisce anche al Motore Immobile la nozione di vita: “Il suo modo di vivere è il più
eccellente: è quel modo di vivere che a noi è concesso solo per breve tempo. E in quello
stato Egli è sempre. [...] Ora, il pensiero che è pensiero per sé, ha come oggetto ciò che è di
per sé più eccellente [...] Ed Egli è anche Vita, perché l’attività dell’intelligenza è vita, ed
Egli è appunto quell’attività. E la sua attività, che sussiste di per sé, è vita ottima ed eterna.
Diciamo, infatti, che Dio è vivente, eterno ed ottimo”82. Quindi precisa che la sua natura
beata è quella dell’“Intelligenza divina”, la quale “pensa se stessa e il suo pensiero è
pensiero di pensiero [nóesis noéseos]”83.
Lo stesso Plotino non disdegnerà di attribuire un Super-Pensiero e una Super-Vita all’Uno
originario84.
VITALISMO
È la concezione filosofica che considera il dinamismo spontaneo e immanente della vita
una realtà peculiare degli organismi che ne sono dotati e, pertanto, irriducibile a semplici
processi fisici e chimici.
Già l’interpretazione ilemorfica dell’aristotelismo individuava nella psyché (anima) il
principio costitutivo del vivente e ad esso immanente, specificamente diverso a seconda che
riguardasse una pianta (anima vegetativa), un animale (anima sensitiva) o un uomo (anima
razionale), ma tale da integrare in sé, secondo l’interpretazione di Tommaso d’Aquino, le
eventuali funzioni vitali di livello inferiore: è ciò che avviene nell’animale e nell’uomo.
Quando si pretende di configurare l’intera realtà del mondo come animata, anche se a
livelli progressivi e di diversa intensità nei vari enti, ci troviamo propriamente di fronte ad
un panpsichismo. È il caso della filosofia di G. W. Leibniz. → Ilozoismo
Il vitalismo di G. Leibniz
Gottfried Leibniz prende le distanze dal meccanicismo cartesiano, ritenendo che il
movimento studiato dalla meccanica sia un semplice fenomeno, ossia una manifestazione
esteriore di qualcosa di più profondo e reale, cioè la forma sostanziale, che denomina
“monade”. Della monade egli elabora una teoria, che lo porta ben oltre l’ilemorfismo
81
Platone, Fedro, 245 c-e, trad. di P. Pucci, in Opere complete, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 1971, vol. 3, p.
244; Leggi, X, 896 c, e, 899 a, trad. di A. Zadro, in Opere complete, cit., vol. 7, pp. 342-345
82
Aristotele, La metafisica, , 7, 1072 b 14-29, II, pp. 243 s.
83
Aristotele, La metafisica, , 9, 1074 b 33-34, cit., II, p. 250
84
Plotino, Enneadi, VI, 8, 16
257
aristotelico, per il quale all’inizio sembrava propendere (→ Monade). Infinite monadi
costituiscono l’universo leibniziano. Il fatto che Leibniz le concepisca come sostanze
semplici, rende problematica la sua concezione della corporeità, che tende a ridursi ad un
semplice fenomeno (pur qualificato come bene fundatum) dell’attività rappresentativa delle
monadi. In tal modo tende inevitabilmente ad una generale concezione idealistica.
Per dar conto dei fenomeni della vita, secondo Leibniz si rivelano sempre più inadeguate
le spiegazioni materialistiche e le semplici nozioni della meccanica. La tradizionale ipotesi
della generazione spontanea dal non vivente al vivente fatica a sostenersi di fronte alle
smentite che provengono da ciò che si va osservando (→ Generatio aequivoca). Leibniz,
infatti, ritiene che la propria concezione vitalistica sia suffragata dagli sviluppi moderni
delle conoscenze biologiche e dalle evidenze che il microscopio ormai consente. Esse
sembrano confermargli la presenza della vita anche là dove la vista ordinaria constata
soltanto materia inerte. Il filosofo tedesco in ciò vede una convalida della “legge di
continuità”, per la quale, com’egli dice nella prefazione ai Nuovi saggi sull’intelletto
umano, “la natura non fa salti” (natura non facit saltus), nel senso che “dal piccolo al
grande e dal grande al piccolo si passa sempre attraverso un termine medio”85 per infiniti
gradi intermedi (→ Continuità, Principio di). Pertanto, contro la teoria biologica
dell’epigenesi, per la quale la generazione costituisce un inizio assoluto dell’individuo,
Leibniz sostiene la teoria della preformazione, secondo la quale la generazione di un
individuo è soltanto sviluppo ed espansione di una forma che già preesisteva in una
dimensione infinitesimale e che a noi comincia ad apparire nelle dimensioni del germe e
dell’embrione. Come la nascita, così anche la morte viene relativizzata. La Monadologia86
esprime la cosa nei termini seguenti: “Non vi è mai generazione in senso assoluto, né morte
perfetta, intesa in senso rigoroso, come separazione dell’anima. E ciò che noi chiamiamo
generazioni sono sviluppi e accrescimenti, come quelle che noi chiamiamo morti sono
involuzioni e diminuzioni” (§ 73; v. § 74). Si può, quindi, affermare che “l’animale o
l’anima non hanno inizio che con il mondo e non hanno fine se non con il mondo stesso” (§
82).
Il vitalismo di H. Bergson
Con il termine “vitalismo” sono talora genericamente designate anche le cosiddette
“filosofie della vita” dell’Ottocento e del Novecento (→ Vita, Filosofie della), nelle quali la
“vita”, comunque sia intesa, costituisce il ricorrente leitmotiv tematico. Tra esse rileviamo
in particolare quella di Henri Bergson, sulla quale intendiamo soffermarci.
La sua teoria evoluzionistica rifiuta esplicitamente sia il meccanicismo, che si avvale di
una spiegazione deterministica dei processi naturali, sia il finalismo, che fa riferimento ad
un disegno preesistente, perché entrambi sembrano presupporre e prefigurare fin dall’inizio
la realtà in tutti i suoi sviluppi. L’evoluzione, invece, è il dinamismo creatore e spontaneo
di un’energia originaria, che continua a sospingere “da dietro” (vis a tergo) verso qualcosa
di nuovo. “La vita, infatti, è tendenza, e l’essenza di una tendenza è di svilupparsi a forma
di ventaglio, creando, in virtù del suo stesso espandersi, direzioni divergenti tra cui si
distribuirà il suo slancio”, cioè “serie divergenti di specie, che si evolveranno
separatamente”87. In questa evoluzione la materia è slancio degradato, che è andato
perdendo l’originaria creatività: in essa la corrente della vita rifluisce, divenendo ostacolo
per lo slancio successivo, come l’onda del mare che, rientrando, frena l’onda che
G.W. Leibniz, Nuovi saggi sull’intelletto umano, Premessa, in Scritti filosofici, a cura di D.O. Bianca, UTET,
1967, vol. II, p. 176
86
G.W. Leibniz, Monadologia, in Scritti filosofici, vol. I, pp. 283-294, cit.
87
H. Bergson, L’evoluzione creatrice, a cura di P. Serini, Mondatori, 1962, p. 139
85
258
sopraggiunge. La corrente, tuttavia, avanza. Constatiamo “uno sforzo per risalire la china
che la materia discende”; esso ci si presenta come “un processo inverso di quello materiale,
creante con la sua sola interruzione la materia”88. → Spontaneità
Bergson intende conferire un profilo unitario alla realtà universale, derivandola da un
unico principio originario. Animato da un consapevole “misticismo”, auspica “una presa di
contatto, e di conseguenza una coincidenza parziale, con lo sforzo creatore manifestato
dalla vita”. E dichiara: “Questo sforzo appartiene a Dio, se non è Dio stesso”89. In questo
slancio vitale (élan vital) l’uomo è invitato ad inserirsi per proseguire la stessa creazione
divina.
Nella teoria del filosofo francese agisce la forza suggestiva delle immagini e delle
metafore. Così, per esempio, descrive il processo evolutivo: “A noi la vita, nel suo insieme,
appare come un’onda immensa che si sia propagata a partire da un centro e che, su quasi
tutta la sua circonferenza, si sia arrestata: in un punto solo l’ostacolo è stato forzato e
l’impulso è passato liberamente. Da per tutto, fuor che nell’uomo, la coscienza ha finito con
l’arrestarsi come in una gola chiusa; solo con l’uomo ha proseguito il suo cammino”90.
VOLONTÀ
Con questo termine non indichiamo l’inclinazione spontanea del desiderio né la tendenza
impulsiva dell’istinto, anche se banalmente il linguaggio ordinario prevede quest’uso e in
ambito filosofico Arthur Schopenhauer nella sua opera maggiore (Il mondo come volontà e
rappresentazione) così denomina l’universale e irrazionale forza creatrice del mondo. Per
“volontà”, invece, intendiamo la facoltà pratica, cioè orientata all’agire, che consente ad un
ente razionale e autocosciente di autodeterminarsi in vista di un qualche bene da perseguire;
perciò è essenzialmente libera.
Analisi dell’atto volontario
Nell’intrinseca complessità dell’atto volontario si esprime, più che in qualunque altro,
l’unità sintetica della persona, che in esso rivela e riflette essenzialmente se stessa, così da
poterne e doverne rispondere. La volontarietà, infatti, è la base della responsabilità morale e
dell’imputabilità giuridica degli atti compiuti. → Persona; Colpa
Nell’atto volontario si possono classicamente distinguere i seguenti momenti:
la deliberazione, cioè l’esame razionale sia dei diversi moventi o motivi, dai quali si è
sollecitati, sia delle alternative pratiche che si è in grado di prospettare;
la risoluzione o decisione, con la quale si scioglie ogni incertezza, procedendo alla
scelta, che esprime in senso specifico e diretto l’intervento della volontà;
l’esecuzione, cioè l’attuazione, di cui la volontà ha sicuramente l’iniziativa, ma non
sempre il totale controllo, perché l’effettiva disponibilità delle condizioni oggettive che
la consentono spesso non dipende da noi.
La volontà non è spontaneità
Henri Bergson ritenne di dover criticare come inadeguata e artificiosa questa semplice
analisi, che già Aristotele aveva fatto, perché non sarebbe in grado di rappresentare
88
ivi, p. 219
H. Bergson, Le due fonti della morale e della religione, trad. di M. Vinciguerra, in Le opere, UTET, 1971, p.
472
90
H. Bergson, L’evoluzione creatrice, cit., p. 239
89
259
l’autentica esperienza della libertà. L’atto libero, a suo giudizio, non è astrattamente
scomponibile in fasi distinte, perché è una sintesi inscindibile di momenti, che si fondono,
uno nell’altro, nell’unità del tempo vissuto o durata. La pretesa di farne l’analisi ne altera
l’essenza; l’analisi, infatti, comporta inevitabilmente una rappresentazione spaziale, che
giustappone, uno accanto all’altro, i nostri stati di coscienza, come se fossero tra loro
esterni. Bergson pertanto afferma: “Si chiama libertà il rapporto tra l’io concreto e l’atto
che compie. Questo rapporto è indefinibile, proprio perché siamo liberi. Infatti, si può
analizzare una cosa, ma non un progresso; si può scomporre l’estensione, ma non la durata.
Oppure, nel caso in cui ci si ostini comunque ad analizzarla, si trasforma inconsciamente il
progresso in cosa, la durata in estensione. Per la sola pretesa di scomporre il tempo
concreto, se ne srotolano i momenti nello spazio omogeneo; al fatto che si sta compiendo si
sostituisce il fatto compiuto, e poiché si è cominciato col fissare in qualche modo l’attività
dell’io, la spontaneità si risolve per noi in inerzia e la libertà in necessità. Perciò ogni
definizione della libertà darà ragione al determinismo”94, nel senso che anche la tradizionale
scomposizione dell’atto libero rende esterni momenti che invece si implicano
reciprocamente dall’interno e si fondono in unità, e così ciò che precede diventa la causa
determinante di ciò che segue. Per Bergson la libera decisione sgorga nella sua sinteticità
originaria e imprevedibile dalla nostra anima. In tal modo egli interpreta la libertà come
pura spontaneità, rischiando però di misconoscere l’immanenza della ragione negli atti
volontari. Spontaneo, infatti, è ciò che non è prodotto deterministicamente dall’esterno;
tuttavia nella sua immediatezza esso esclude la presenza della riflessione mediatrice e si
presenta come un automatismo creativo e sempre nuovo, intrinsecamente cieco. Tale è tutto
l’élan vital (slancio vitale), che produce l’evoluzione del mondo, sospingendola
dinamicamente “da dietro” (vis a tergo) senza alcun finalismo.
Quindi, pur riconoscendo che c’è dell’astrattezza nella serialità dei momenti costitutivi
dell’atto volontario su richiamati, se si considera la concreta realtà dell’esperienza vissuta,
tuttavia essa presenta una sua intrinseca correttezza e plausibilità logica e ideale. →
Spontaneità
La volontà non è libertà d’indifferenza
La descrizione che abbiamo dato dell’atto volontario contrasta ovviamente anche con la
teoria dell’indeterminismo, secondo la quale la condizione ottimale di esercizio della libertà
sarebbe quella designata dagli scolastici medioevali come libertas indifferentiae (libertà
d’indifferenza), consistente nell’indipendenza della volontà dai motivi di una possibile
scelta, nel senso che non sono questi a determinare il suo agire. Questa posizione la si è
voluta descrivere con il noto esempio dell’asino di Buridano95: qualora fosse messo di
fronte a due mucchi uguali di fieno, l’animale sarebbe destinato a morte certa, perché si
troverebbe nell’incapacità di decidere da quale mucchio cominciare. Si può, tuttavia
obiettare che, diversamente dall’animale, l’uomo, posto in una simile situazione, avrebbe
modo di far valere soltanto la propria volontà. Si può inoltre ragionevolmente far osservare
che è proprio nell’adesione ad un motivo piuttosto che ad un altro che si rivela la razionalità
della scelta, altrimenti sembrerebbe che l’agire si affidasse alla semplice casualità.
Ora vogliamo richiamare alcuni momenti significativi della riflessione filosofica del
passato, che hanno contribuito a sviluppare il tema che ci sta occupando.
94
H. Bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, in Opere, 1889-1896, a cura di P.A. Rovatti, trad. di F.
Sossi, A. Mondadori, 1986, cap. III, p. 127
95
L’esempio dell’asino di Buridano sembra derivare dall’uso medioevale di un ragionamento sofistico citato da
Aristotele nel De caelo (II, 13, 295 b 33-34).
260
L’intellettualismo socratico
Per Socrate e Platone la specificità dell’uomo si rivela soprattutto nella facoltà intellettiva;
perciò essi considerano il male come il frutto dell’ignoranza e dell’insipienza. Alla tesi che
la virtù è scienza del bene segue l’altra, apparentemente paradossale, secondo la quale
nessuno fa il male volontariamente. Socrate, per esempio, afferma nel Protagora: “Io so
questo, che nessun sapiente ritiene che l’uomo sbagli di propria volontà e volontariamente
compia atti vergognosi e malvagi, ma sa bene che tutti coloro i quali agiscono in modo
vergognoso e malvagio lo fanno involontariamente”96; infatti “nessuno, sapendo o credendo
che altre possibili azioni siano migliori di quelle che compie, fa le peggiori, mentre
potrebbe compiere quelle migliori. [...] ma non è questo che chiamate ignoranza, avere una
falsa opinione e ingannarsi su cose di grande valore?”97. Il filosofo ateniese sembra restare
legato alla persuasione, che era tradizionale presso i Greci ed è testimoniata da Omero,
secondo la quale la colpa è dovuta allo smarrimento della mente (ἄτη, áte), che induce in
errore, fa perdere il discernimento (φρόνησις, phrónesis) e il senso della misura,
comportando come conseguenza la tracotanza (ὕβρις, hýbris). → Intellettualismo
L’analisi aristotelica
L’analisi, che nell’Etica nicomachea Aristotele fa del comportamento morale, sottopone ad
una considerazione equilibrata gli aspetti della volontarietà e della responsabilità degli atti
umani. Egli ne riconosce esplicitamente l’importanza. “Forzato”, egli dice, “è ogni atto il
cui principio sia fuori di noi e tale che chi lo compie o chi lo subisce non vi cooperi per
nulla”; invece, quando è a noi che si imputa un’azione, “si agisce volontariamente: infatti il
principio del movimento degli organi in siffatte azioni risiede in chi agisce; e avere in sé il
principio di un atto, significa avere la facoltà di farlo o di non farlo”98.
Nel trattato sull’anima si sofferma a descrivere l’agire in riferimento alle motivazioni che
lo sollecitano. Egli distingue due principi del movimento: l’“appetito” (ὄρεξις, órexis),
ossia la tendenza spontanea, che l’uomo ha in comune con gli animali, a soddisfare un
bisogno, e “l’intelletto pratico”, che “ragiona in vista di uno scopo” ed è connesso con
l’appetito, perché “l’intelletto non muove senza l’appetito”; questo, tuttavia, talora “muove
anche contro il ragionamento”. L’uomo nell’agire rivela tutta la sua complessità: se
“l’intelletto è sempre retto”, i desideri non sempre lo sono; “pertanto, quel che muove è
sempre l’appetibile, ma questo può essere un bene reale o un bene apparente”99. L’analisi
aristotelica dell’atto morale può essere così sintetizzata: con la “volontà” (βούλησις,
boúlesis), cioè l’intenzione o il proposito, l’uomo determina razionalmente il fine che
intende conseguire; con la “deliberazione” (βούλευσις, boúleusis) valuta quali mezzi e
azioni siano più opportuni o necessari; con la “scelta” (προαίρεσις, proáiresis) decide
concretamente riguardo ad essi. La volontarietà e le scelte possono anche essere
condizionate dalle abitudini da lui acquisite, che lo predispongono e orientano nell’agire,
ma non ne sono annullate; le stesse abitudini dipendono dagli atti volontari che le hanno
create e di essi egli è responsabile.
L’intellettualismo etico delle filosofie ellenistiche
96
Platone, Protagora, 345 d-e, trad. di F. Adorno, in Opere complete, cit., vol. 5, p. 120
ivi, 358 b-c, p. 135
98
Aristotele, Etica nicomachea,, III (),1, 1110 a 1-18, cit., pp. 49-50
99
Aristotele, Dell’anima, III (), 10, 433 a 9 ss., trad. di R. Laurenti, in Opere, cit.,vol. 4, pp. 184-185
97
261
Il tradizionale orientamento intellettualistico della cultura greca torna a riproporsi nelle
filosofie ellenistiche, secondo le quali l’individuo eticamente realizzato è soltanto il σοφός
(sophós), cioè il saggio o sapiente. → Intellettualismo
Epicuro dichiara: “Nessuno vedendo il male, lo sceglie di per se stesso, ma ne rimane
adescato come fosse un bene rispetto a un male peggiore”100. Gli stoici, a loro volta,
ribadiscono che solo il saggio è in grado di praticare il bene nella sua forma eminente e non
ha bisogno di precetti, perché è in perfetta sintonia con il Lógos, presente ovunque nel
mondo. Anche Seneca sente di dover dire che “solo il sapiente sa amare, solo il sapiente sa
essere amico” (solus sapiens scit amare, solus sapiens amicus est) e invita a riconoscere
che “la vera onestà è propria del sapiente, mentre il volgo ne ha solo simulacri e immagini.
Nessuno sa dimostrare gratitudine, se non il sapiente”. Tuttavia, da buon romano, abituato
più dei greci all’importanza della prassi, aggiunge subito: “Perfino lo stolto lo dimostri
come sa e come può; gli manchi la scienza più che la volontà: il volere non s’impara”
(Stultus quoque, utcumque scit et quemadmodum potest, referat; scientia illi potius quam
voluntas desit: velle non discitur)101.
La problematica esperienza del male morale in Ovidio e in San Paolo
L’intellettualismo non sembra in grado di dar conto della mortificante e problematica
esperienza che il male riserva a chi lo fa consapevolmente. Rileviamo il diverso
atteggiamento del poeta latino Ovidio e del cristiano Paolo di Tarso.
È nota la rappresentazione che nelle Metamorfosi Ovidio ci dà di Medea. Medea precipitò
nella tragedia per aver ucciso i propri figli. Di fronte al misfatto il poeta ne constata
amaramente l’impotenza: “Con la ragione non poteva controllare la folle passione” (ratione
furorem / vincere non poterat). Essa rivolgeva a se stessa queste desolate parole: “Infelice,
se puoi, scuoti dal tuo giovane petto l’ardore che dentro ti si è acceso! Se potessi, sarei più
saggia, ma contro voglia mi porta una forza inattesa, e a qualcosa di ben diverso induce il
desiderio da quel che consiglia la mente: vedo ciò che è meglio per me e lo approvo, ma
faccio mia la scelta peggiore” (excute virgineo conceptas pectore flammas, / si potes,
infelix! Si possem, sanior essem; / sed trahit invitam nova vis, aliudque cupido, / mens aliud
suadet: video meliora proboque, deteriora sequor)102.
Di San Paolo, poi, ricordiamo la drammaticità con la quale nella Lettera ai Romani
descrive l’umana esperienza della colpa, interpretata religiosamente come peccato, e il suo
misterioso incombere sul nostro destino: “Io non riesco a capire neppure ciò che faccio:
infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. [...] c’è in me il desiderio del
bene, ma non la capacità di attuarlo; io non compio il bene che voglio, ma il male che non
voglio”103. È il mysterium iniquitatis, di cui parla nella Seconda lettera ai Tessalonicesi (2,
7).
Intellettualismo e volontarismo nel dibattito teologico del cristianesimo
La centralità che nel cristianesimo hanno i temi del peccato e della grazia divina spiegano
l’importanza che alla volontà ha sempre dato il pensiero teologico. Sulle tracce di San
Paolo si sviluppano in particolare le descrizioni che Sant’Agostino fa innanzitutto della
propria esperienza personale e quindi, assumendo questa come paradigmatica, della
condizione universale dell’uomo. Ricalcando ciò che l’apostolo aveva detto del conflitto
Epicuro, Sentenze, 112, in L’“etica” di Epicuro e il problema del piacere nella filosofia antica, cit., p. 89
Seneca, Lettere a Lucilio, LXXXI, 13
Ovidio, Metamorfosi, VII, vv. 10-21 (traduzione mia)
103
San Paolo, Lettera ai Romani, 7, 15-19, La Bibbia di Gerusalemme, versione della Conferenza episcopale
italiana, EDB-Borla, 1974
100
101
102
262
che agita il cuore umano tra la legge di Dio e la legge del peccato, egli annota: “Lottavano
tra loro, dentro me, due volontà; una vecchia carnale, l’altra nuova spirituale, e nel loro
contrasto la mia anima si disfaceva”104. E testimonia, poi, di una lacerante contraddizione,
che l’aveva attraversato: “Compii molti gesti in cui il volere non implicava il potere, e
invece non facevo ciò che senza confronto mi piaceva di più, che diventava possibile
nell’atto stesso in cui volevo, perché il volerlo realmente significava volerlo efficacemente.
Nel mio caso potere e volere erano una stessa cosa; l’atto stesso della volontà segnava il
principio dell’azione; e ciò non ostante nulla avveniva (ipsum velle iam facere erat; et
tamen non fiebat)”105.
L’interesse, che sulla scia delle riflessioni agostiniane la teologia cristiana nella sua storia
millenaria ha espresso per queste tematiche, si è accompagnato ad un viluppo di aporie e di
problemi mai razionalmente risolti, che nascevano dall’intenzione di far coesistere la libera
e responsabile autodeterminazione dell’uomo e l’imperscrutabile e incondizionata
determinazione divina. Il dibattito si è rivelato drammatico e aspro nelle secolari vicende
delle eresie, che immancabilmente hanno agitato la cristianità: pelagianesimo,
luteranesimo, calvinismo, giansenismo (→ Libero arbitrio).
Anche nel considerare i rapporti interni all’essenza divina tra la facoltà intellettiva e la
facoltà volitiva, i teologi si sono divisi, dando luogo ai due modelli interpretativi
dell’intellettualismo e del volontarismo, che sono così chiamati perché danno
rispettivamente o all’intelletto o alla volontà una preminente rilevanza, considerando l’altra
facoltà in posizione subalterna e strumentale (→ Intellettualismo; Volontarismo).
A prescindere dalla questione che l’uomo riesca esistenzialmente a far coincidere il potere
(posse) con il volere (velle), secondo Agostino spetta alla volontà l’importante compito di
assicurare l’intrinseca unità delle varie funzioni della mente. Infatti, a suo modo
d’intendere, le funzioni passivamente intuitive della memoria e dell’intelletto sono attivate
dalla volontà, che le fa operare insieme e in tal modo consente di realizzare il pensiero. Non
a caso nel derivarla dal verbo cogere (costringere), fa dipendere la cogitatio (pensiero) da
una costrizione volitiva: “Atque ita fit illa trinitas ex memoria et interna visione et quae
utrumque copulat voluntate, quae tria cum in unum coguntur ab ipso coactu cogitatio
dicitur” (E così dalla memoria e dalla visione interna si produce quella trinità, che unisce
l’una all’altra mediante la volontà. Quando questi tre elementi sono costretti [coguntur] in
un solo tutto, questa costrizione (coactus) fa sì che ciò sia detto pensiero [cogitatio]106.
Le inquietudini e i conflitti della volontà, poi, trovano la loro positiva soluzione
nell’amore. Secondo Agostino la motivazione dell’agire è connessa alle dinamiche del
desiderio e della libera volontà, ma è ancor più profondamente sostenuta dalla grazia
divina, che ci consente di sentirci redenti. In tale condizione possiamo anche constatare che
“nella buona volontà sta la nostra pace” (in bona voluntate pax nobis est). Ormai non è più
la concupiscenza a farla da padrona; e non diremo più che “col suo peso ci trascina giù
nelle rovine dell’abisso”. Come gli elementi corporei tendono verso il loro luogo naturale
(“il fuoco tende all’alto, la pietra all’ingiù”), l’anima gravita ormai verso l’oggetto del suo
amore. Perciò, rivolgendosi a Dio, Agostino così continua: “Accesi dal tuo dono siam
portati all’alto, bruciamo e andiamo. Ascendiamo su per le salite del cuore e cantiamo il
cantico delle ascensioni. [...] andando all’insù tendiamo a Gerusalemme, che è pace; [...] Ed
ivi ci darà sede la retta volontà e non vorremo mai altro se non rimanervi in eterno”107.
Sant’Agostino, Le confessioni, VIII, 5, cit., p. 359
ivi, VIII, 8, p. 373
106
Sant’Agostino, De Trinitate, XI, 3
107
Sant’Agostino, Le confessioni, XIII, 7 e XIII, 9, cit., pp. 663 e 667
104
105
263
Tra i teologi rappresentante massimo dell’intellettualismo è Tommaso d’Aquino, il quale da
un lato assimila gli elementi essenziali della filosofia aristotelica, dall’altro tuttavia si vede
costretto a tener conto dei rilievi critici dei teologi francescani, orientati in senso
volontaristico. Egli sostiene le ragioni del primato dell’intelletto, perché il bonum
appetibile, che è l’oggetto della volontà, è evidenziato e giustificato nella sua ratio boni,
ossia in ciò che lo costituisce come bene, dall’intelletto108. Manifesta, però, una sua
consueta tendenza conciliativa, dalla quale è indotto a riconoscere che entrambe “queste
facoltà si implicano reciprocamente nei loro atti: perché l’intelletto comprende che la
volontà vuole e la volontà vuole che l’intelletto intenda. E in maniera simile il bene è
contenuto nell’ambito del vero, perché è qualcosa che l’intelletto ha colto nella sua verità; e
la verità è contenuta nell’ambito del bene, perché è qualcosa di desiderato” (hae potentiae
suis actibus invicem se includunt: quia intellectus intelligit voluntatem velle, et voluntas
vult intellectum intelligere. Et simili ratione bonum continetur sub vero, inquantum est
quoddam verum intellectum; et verum continetur sub bono, inquantum est quoddam bonum
desideratum)109. Per Tommaso il verum e il bonum sono aspetti trascendentali dell’essere,
in rapporto al quale hanno entrambi una perfetta convertibilità o coincidenza
(convertuntur)110, implicandosi conseguentemente anch’essi tra loro. L’intellettualismo
tomista riemerge, tuttavia, nel rilevare che la volontà amorosa, in quanto è sorretta dal
desiderio, esprime la mancanza del bene a cui è orientata. Una volta che questo sia stato
conseguito la volontà s’acquieta e, perciò vien meno. L’intelletto, invece, sopravvive alla
volontà, perché la beatitudine consiste nella fruizione contemplativa di Dio111. A questo
riguardo Tommaso esprime una posizione tipicamente aristotelica. Per Aristotele, infatti, la
pura attività di Dio consiste nel suo essere “Pensiero del Pensiero”, che il filosofo,
esercitando la sapienza, intende imitare112.
L’orientamento tomista è ben rappresentato da Dante Alighieri, il quale, riferendosi alle
intelligenze celesti, così si esprime113:
E dei saper che tutti hanno diletto
Quanto la sua veduta si profonda
Nel vero in che si queta ogni intelletto.
Quinci si può veder come si fonda
L’esser beato nell’atto che vede,
non in quel ch’ama, che poscia seconda [cioè nella volontà, che viene dopo]
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 82, art. 3
Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I, q. 82, art. 4 ad primum
110
v. Tommaso d’Aquino, De veritate, q. I, art. 1; Summa theologiae, I, q. 5, art. 1-3; q. 6, art. 3; q. 11, art. 4; q.
16, art. 3.
111
v. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 3, art. 1-8
112
Aristotele, La metafisica, , 9, 1074 b 33-34; Etica Eudemia, VIII (Θ), 3, 1249 b,17
113
Dante Alighieri, Paradiso, XXVIII, vv. 106-111
108
109
264