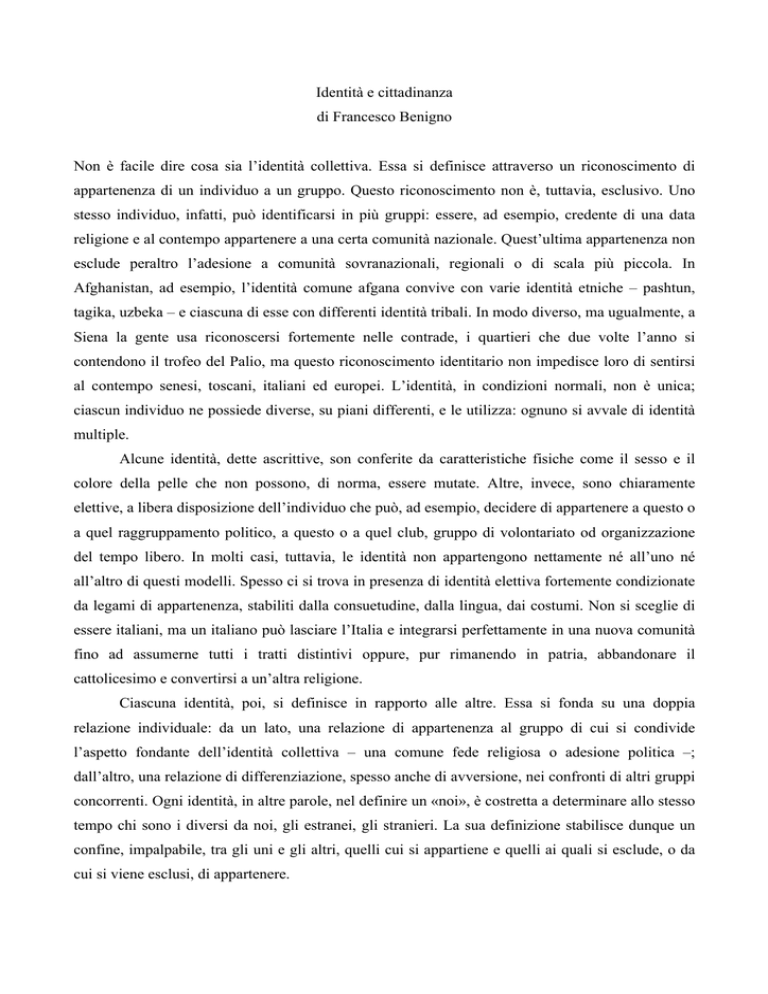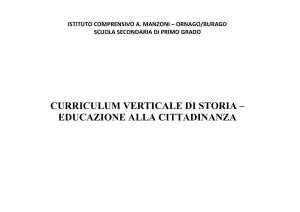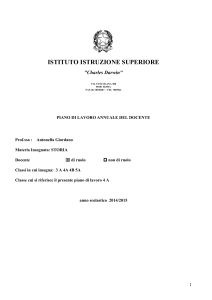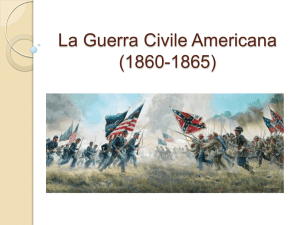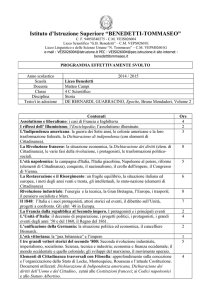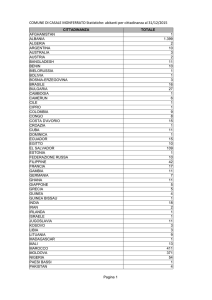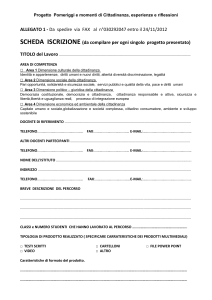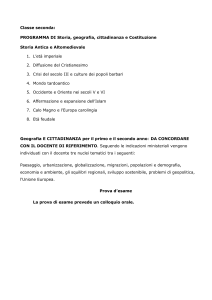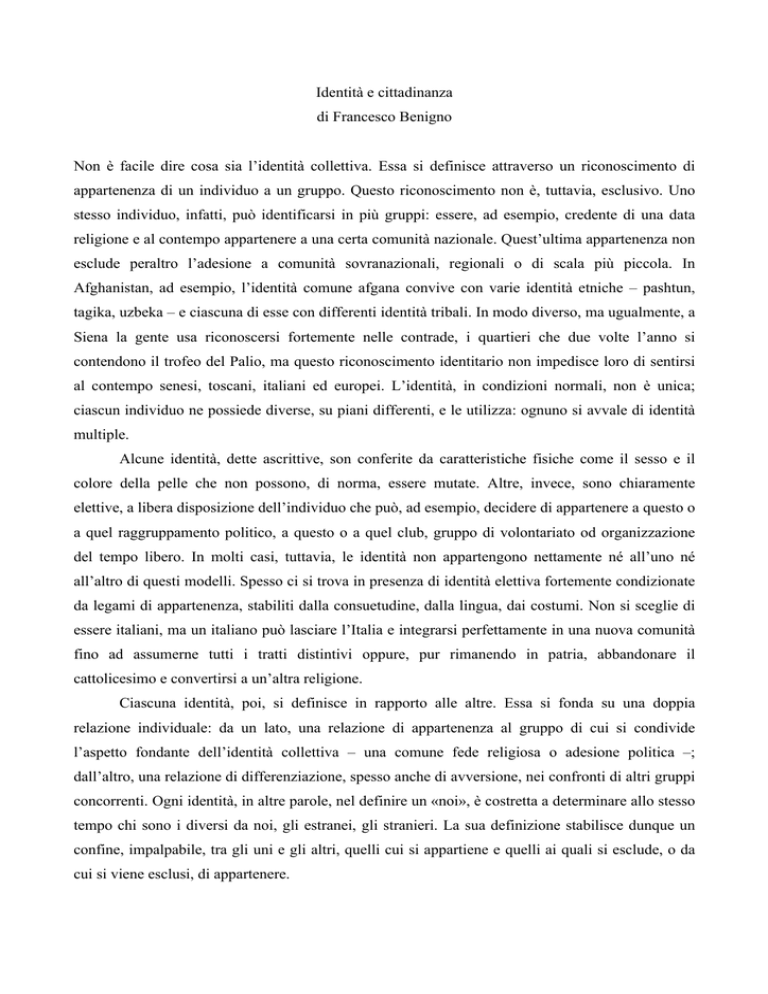
Identità e cittadinanza
di Francesco Benigno
Non è facile dire cosa sia l’identità collettiva. Essa si definisce attraverso un riconoscimento di
appartenenza di un individuo a un gruppo. Questo riconoscimento non è, tuttavia, esclusivo. Uno
stesso individuo, infatti, può identificarsi in più gruppi: essere, ad esempio, credente di una data
religione e al contempo appartenere a una certa comunità nazionale. Quest’ultima appartenenza non
esclude peraltro l’adesione a comunità sovranazionali, regionali o di scala più piccola. In
Afghanistan, ad esempio, l’identità comune afgana convive con varie identità etniche – pashtun,
tagika, uzbeka – e ciascuna di esse con differenti identità tribali. In modo diverso, ma ugualmente, a
Siena la gente usa riconoscersi fortemente nelle contrade, i quartieri che due volte l’anno si
contendono il trofeo del Palio, ma questo riconoscimento identitario non impedisce loro di sentirsi
al contempo senesi, toscani, italiani ed europei. L’identità, in condizioni normali, non è unica;
ciascun individuo ne possiede diverse, su piani differenti, e le utilizza: ognuno si avvale di identità
multiple.
Alcune identità, dette ascrittive, son conferite da caratteristiche fisiche come il sesso e il
colore della pelle che non possono, di norma, essere mutate. Altre, invece, sono chiaramente
elettive, a libera disposizione dell’individuo che può, ad esempio, decidere di appartenere a questo o
a quel raggruppamento politico, a questo o a quel club, gruppo di volontariato od organizzazione
del tempo libero. In molti casi, tuttavia, le identità non appartengono nettamente né all’uno né
all’altro di questi modelli. Spesso ci si trova in presenza di identità elettiva fortemente condizionate
da legami di appartenenza, stabiliti dalla consuetudine, dalla lingua, dai costumi. Non si sceglie di
essere italiani, ma un italiano può lasciare l’Italia e integrarsi perfettamente in una nuova comunità
fino ad assumerne tutti i tratti distintivi oppure, pur rimanendo in patria, abbandonare il
cattolicesimo e convertirsi a un’altra religione.
Ciascuna identità, poi, si definisce in rapporto alle altre. Essa si fonda su una doppia
relazione individuale: da un lato, una relazione di appartenenza al gruppo di cui si condivide
l’aspetto fondante dell’identità collettiva – una comune fede religiosa o adesione politica –;
dall’altro, una relazione di differenziazione, spesso anche di avversione, nei confronti di altri gruppi
concorrenti. Ogni identità, in altre parole, nel definire un «noi», è costretta a determinare allo stesso
tempo chi sono i diversi da noi, gli estranei, gli stranieri. La sua definizione stabilisce dunque un
confine, impalpabile, tra gli uni e gli altri, quelli cui si appartiene e quelli ai quali si esclude, o da
cui si viene esclusi, di appartenere.
Quando il gruppo in cui ci si identifica e da cui si è accettati è una comunità che possiede
diritti collettivi, il farne parte consente a ciascun membro di essa di goderne gli effetti. Si tratta
soprattutto dei diritti che regolano la partecipazione alla vita politica, il potere cioè di concorrere
alle scelte decisive e agli orientamenti collettivi attraverso l’elezione dei propri rappresentanti negli
organi di governo, ma anche, a fronte di una contribuzione, dei diritti di usufruire della difesa
collettiva, dell’istruzione, dell’assistenza e, più in generale, della comune protezione assicurata
dalla legge. Questi diritti, che ci rendono pari agli altri, sono chiamati nella tradizione occidentale
diritti di cittadinanza.
La ragione di questa denominazione è presto detta. La città è sempre stata, nella storia
d’Europa, il luogo in cui più fortemente si sono mantenute tradizioni di libero autogoverno e di
compartecipazione alle scelte comuni. Come recita un proverbio famoso, «la città rende liberi». La
libertà di cui si parla, naturalmente, è una libertà relativa, legata all’immagine specularmente
opposta di una campagna in cui si registra una maggiore dipendenza dal dominio territoriale
signorile. Inoltre, le città sono state storicamente spesso soggette ad altri poteri, quelli di imperatori,
re o signori territoriali. Ciononostante, quell’insieme di regole elaborate nelle tradizioni urbane di
autogoverno hanno costituito una sorta di matrice su cui si è costruito il moderno concetto di
cittadinanza universale.
All’opposto, la mancanza di diritti si configura e si riassume nella tradizione occidentale
nella condizione di esclusione. L’esclusione massima, la mancanza totale di diritti, è data dalla
schiavitù. Lo schiavo è il nemico sconfitto in guerra che ha perduto tutto ed è alla mercè del
vincitore che lo tratta non più da individuo pari a sé ma da cosa; e che perciò lo compra e lo vende
considerandolo alla stregua di un animale da lavoro, un essere destinato ad attività degradanti o
faticose e di cui ci si prende cura solo nella misura in cui costituisce un bene. Il processo di
esclusione totale dei diritti proprio della schiavitù trascina con sé perciò, spesso, un tratto di
deumanizzazione: gli schiavi sono, in altre parole, considerati esseri inferiori, non appartenenti
pienamente al genere umano.
Proprio come la cittadinanza è stata, nel mondo occidentale, la matrice dell’estensione a tutti
degli stessi diritti, in quel processo complesso e graduale che chiamiamo affermazione della
democrazia, così la schiavitù ha costituito la matrice della negazione dell’uguaglianza fra gli esseri
umani, il prototipo e il modello dell’assoggettamento violento e della divisione del mondo sociale in
un dualismo insanabile, tra chi ha potere e chi lo subisce, tra chi è libero e chi è vincolato, tra chi ha
beni e chi possiede solo le sue catene.
Nella visione liberale della storia il progresso della civiltà comporta quasi automaticamente
l’affermazione della democrazia e la progressiva estensione a tutti gli individui dei diritti di
cittadinanza nonché l’altrettanto progressiva eliminazione della schiavitù e di tutte le forme di
demumanizzazione. E tuttavia, chi guardi la storia del Novecento, difficilmente potrà scorgervi solo
l’affermazione trionfante dei diritti universali. Al contrario, mai come nel secolo da poco trascorso,
insieme all’estensione della cittadinanza, di cui l’aspetto più significativo è rappresentato dalle
conquiste del movimento femminile, hanno preso piede forme radicali di esclusione spinte fino allo
sterminio di interi gruppi sociali, etnici e religiosi.
Il lager, il campo creato dai nazisti per i lavori forzati e per realizzare l’osceno disegno di
deliberato massacro dei deportati, e il gulag, il luogo di internamento stalinista destinato alla
distruzione morale e fisica degli oppositori reali o presunti, costituiscono il paradigma di
un’esclusione che, invece di ridursi, è stata, in tempi relativamente recenti, spinta al massimo
livello, fino allo sterminio di massa di coloro che sono considerati, per ragioni ideologiche, nemici,
diversi, stranieri.
Affinché una simile tendenza alla deumanizzazione possa prodursi è necessario un processo
di riduzione dell’identità altrui a una sola dimensione. In tempi normali si piò essere, e si è stati,
insieme buoni tedeschi, devoti ebrei e rigidi conservatori oppure altrettanto buoni russi, benestanti e
accesi socialisti. Accade, però, specie nei momenti di conflitto, che la radicalizzazione della lotta
politica e la sua ideologizzazione comportino un processo di forzosa semplificazione delle identità.
Sono momenti in cui si è riconosciuti, e quindi costretti a riconoscersi, solo in un’unica identità
dominante, sia essa quella di ebreo o di kulako, il piccolo proprietario terriero russo, e in cui si è
giudicati colpevoli per responsabilità attribuite: se si è ebrei non si è tedeschi e si è responsabili di
alcune cose specifiche…, se si è kulaki non si fa parte del popolo russo e si è accusati delle
disgrazie che colpiscono quest’ultimo…
Non si può dire che il fantasma dei regimi totalitari, così spesso esorcizzato, sia del tutto
scomparso dall’orizzonte mondiale nel passaggio al terzo millennio. Di nuovo in tempi recenti la
tendenza all’estensione dei diritti di cittadinanza ha incontrato ostacoli in rinnovati processi di
esclusione razziale, etnico-culturale, religiosa o di altro tipo. E nuovamente si è ucciso in nome
della legittimità dell’eliminazione dell’altro, del nemico spesso fabbricato a partire da idee
preconcette, costruito sullo schiacciamento degli individui in identità collettive confezionate sulla
base di bisogni ideologici e della paura del diverso che non di rado vi si accompagna.
Per una corretta comprensione di questi processi è indispensabile ripercorrere il difficile e
tortuoso cammino storico che ha condotto a una più larga estensione dei diritti di cittadinanza e
insieme a quei drammatici processi di esclusione che turbano ancora la coscienza europea.
Dalla polis greca al comune repubblicano
La storia della cittadinanza europea viene inaugurata dalla polis, propria della Grecia
classica: una libera città Stato, una comunità che si autogoverna. Pur nella varietà delle forme di
rappresentazione dei gruppi sociali, la distinzione fondamentale per i Greci è quella fra cittadini
liberi, i maschi adulti che partecipano alla vita collettiva e che si riuniscono nell’agorà, la piazza al
centro della città, luogo di mercato ma anche di assemblee politiche, e schiavi. Questi ultimi sono
individui catturati in guerra e, per lo più, appartenenti a popoli diversi, detti genericamente barbari.
Con questa espressione i Greci indicano propriamente «coloro che parlano strano», cioè gli
stranieri, i non greci. L’espressione però finisce per identificare le popolazioni ritenute inferiori,
meno civilizzate, caratterizzate da costumi considerati riprovevoli. I barbari schiavizzati sono
guerrieri sconfitti e catturati in battaglia o donne e bambini frutto di razzie. Essi vengono utilizzati
nelle attività più varie, dallo scavo in miniera ai lavori nei campi fino alle incombenze servili nelle
case dei padroni, senza avere alcun diritto di retribuzione o di assistenza. Il padrone di uno schiavo
è, infatti, il detentore assoluto della potestà su di esso: può rivenderlo e mantiene su di lui un diritto
di vita o di morte.
In epoca ellenistica, a partire cioè dalla fine del IV secolo a.C., insieme all’esportazione in
Oriente del modello urbano, si afferma ciò che si potrebbe definire la mercantilizzazione degli
schiavi. Si creano cioè degli empori, centri mercantili in cui la compravendita degli schiavi diviene
un elemento abituale, caratterizzante della dinamica commerciale. Ciò conduce alla creazione di
vere e proprie economie schiavistiche, produzioni basate cioè essenzialmente sull’utilizzo massiccio
di schiavi come principale forza lavoro.
Nella prima Roma antica, anch’essa una città Stato, il diritto di cittadinanza, ciò che fa di un
individuo un civis romanus, è riservato ai maschi adulti membri delle famiglie considerate
discendenti da una gens, una stirpe romana originaria. In epoca repubblicana, gradualmente, più
ampie fasce sociali sono ammesse a godere dei diritti di cittadinanza. Un cittadino ha il diritto e il
dovere di difendere la Repubblica in armi e di accedere alle prerogative politiche che la sua
condizione gli conferisce; può liberamente mettere su famiglia ed esercitare la patria potestà, può
istituire un culto domestico, offrire ospitalità e possedere beni, fra cui schiavi; può anche
manomettere questi ultimi, ossia restituire loro la libertà.
A Roma gli schiavi sono utilizzati, oltre che nelle case delle famiglie agiate come servitori,
nel lavoro dei campi soprattutto nelle grandi proprietà agricole, i latifondi. Alcuni schiavi catturati
in guerra, opportunamente addestrati, lottano fra loro come gladiatori in sanguinosi duelli pubblici
per il piacere della folla che assiste negli anfiteatri alle loro sfide. Le persone istruite che sono
cadute in schiavitù svolgono mansioni delicate, come scrivani, amministratori o, perfino, medici.
Sempre in età repubblicana, il diritto romano di cittadinanza si estende gradatamente alle
popolazioni italiche e poi a quelle delle province. Il momento di svolta si ha in periodo imperiale,
quando, nel 212 d.C., con la Costituzione antoniniana dell’imperatore Caracalla, il diritto di
cittadinanza viene conferito a tutti gli abitanti dell’Impero romano. Da una parte questo atto
sancisce l’uguaglianza formale delle varie componenti della compagine imperiale, ma dall’altra
finisce per far perdere di contenuto reale la cittadinanza romana, che diviene una condizione
comune e non più un privilegio che sancisce peculiari diritti. Esso va perciò considerato parte del
più generale processo di trasformazione dei cives, i cittadini romani, in sudditi.
All’indomani della crisi dell’Impero romano d’Occidente, il rinnovamento del concetto e
delle pratiche della cittadinanza si ha soprattutto a partire dal IX secolo d.C., in parallelo con la
rinascita delle città. Decisiva è in questo senso l’esperienza dei comuni, il fenomeno di
consolidamento delle nuove realtà urbane che si sviluppa a seguito dell’esperienza carolingia e che
ha il suo cuore nell’Italia centro-settentrionale. Il concetto di cittadinanza divine di nuovo sinonimo
di partecipazione attiva alla vita politica. Le forze sociali che danno vita a centri urbani autonomi e
autogovernati si qualificano nuovamente come cives, riprendendo dal mondo antico il legame tra
appartenenza a una comunità e godimento dei diritti politici. Tale appartenenza viene sancita da un
patto o giuramento, una coniuratio, un’associazione tra i principali esponenti della collettività volta
a garantirsi condizioni di pace, anche attraverso la partecipazione alla difesa armata, e di
autogoverno.
In una prima fase, detta del governo consolare, sono membri di famiglie nobili di tradizione
essenzialmente militare a guidare il processo di costituzione e di crescita dei comuni. Esse
egemonizzano le cariche cittadine elettiva, tra cui la principale – quella dei consoli – si rifa alla
terminologia politica della Roma repubblicana.
Col tempo, a partire dal XII secolo, si afferma e si diffonde nella realtà comunale la pratica
di sostituire il governo dei consoli con quello di un podestà, un funzionario eletto e stipendiato,
proveniente da un’altra città. L’istituzione del podestà ha il vantaggio di salvaguardare le libertà
cittadine affidandone il reggimento a un individuo estraneo alle lotte di fazione, che agitano la vita
dei comuni. Il rettore del governo urbano deve essere un uomo di provate virtù, ma soprattutto deve
giurare di rispettare leges et mores, leggi e consuetudini, locali.
L’istituzione del podestà comporta un processo di maggiore formalizzazione delle istituzioni
politiche cittadine, che per tutta la fase precedente erano state gestite in maniera informale, con la
costituzione di statui e la stesura di regole scritte che disciplinano la vita della comunità.
Intorno alla metà del Duecento su questa base si innestano alcune significative
modificazioni. Forze nuove pretendono e ottengono di entrare a far parte attivamente della scena
politica cittadina. Si tratta delle cosiddette società di popolo, associazioni basate su legami di
quartiere, talvolta accomunate anche dall’appartenenza a una stessa confraternita religiosa o a una
medesima corporazione di mestiere. Spesso queste associazioni consolidano la propria comunanza
partecipando alla milizia cittadina nelle file della fanteria. Queste società vivono la propria identità
come naturalmente distinta da quella dei cavalieri, appartenenti alle fasce sociali più elevate e,
quindi, in grado di sostenere gli alti costi di equipaggiamento militare equestre. Essi si federano su
scala cittadina, dando vita a una parte politica, che punta all’estensione dei diritti di cittadinanza.
Prima conseguenza di queste dinamiche è l’affermazione, all’interno del comune, di una
figura di controllo e di controbilanciamento dell’attività del podestà, il capitano del popolo, insieme
autorità di governo e rappresentante di parte. Straniero come il podestà, come lui scelto e
stipendiato, il capitano del popolo deve difendere contemporaneamente gli interessi generali della
città e quelli del «popolo», ovvero delle corporazioni di mestiere in cui esso sempre più si
identifica. I mercanti, che possiedono le risorse finanziarie per rivendicare una maggiore presenza
politica, e i notai, che costituiscono il gruppo professionale preposto alla formalizzazione scritta
delle regole della comunità, sono i gruppi più attivi di un mondo variegato di corporazioni di
mestiere che iniziano a costituirsi formalmente, dotandosi di istituzioni rappresentative e agendo
come corpi sociali in difesa dei propri interessi.
Questo universo composito, che si autodefinisce genericamente come popolo, impone una
regolamentazione più stretta e definita della vita sociale e un allargamento dei criteri di selezione,
unito a un più preciso controllo, di coloro che hanno diritto di partecipare al governo cittadino, di
eleggere e di essere eletti, e che perciò hanno il dovere di pagare le tasse e di difendere in armi la
comunità, ma anche, contestualmente, il diritto di possedere immobili, di iscriversi alle
corporazioni, di intervenire nelle assemblee.
Nel corso del XIII secolo in varie realtà comunali la parte popolare diviene egemone ed
estromette la vecchia nobiltà dalla vita politica cittadina. Nascono i comuni di popolo, esperienze
politiche che ravvivano l’ideale classico della comunità repubblicana liberamente autogovernata da
cittadini dotati di pari diritti. A un rettore eletto, il podestà, è affidata la titolarità del potere civico,
un potere in grado di garantire a tutti i cittadini la libertà originaria, goduta dagli uomini nel
Paradiso terrestre e in seguito sequestrata e poi sempre minacciata dai prepotenti. Attraverso il
controllo delle pratiche diplomatiche e dei patti che regolano l’aggregazione di nuovi membri nel
corpo civico, le regole del vecchio comune vengono riscritte e si afferma una nuova concezione
della repubblica, e cioè della «cosa pubblica condivisa», corpo sociale autogovernato e – insieme –
sistema bilanciato di interessi.
Questa concezione repubblicana della cittadinanza rappresenta nella storia europea un vero e
proprio inizio delle pratiche democratiche di partecipazione alla vita collettiva e si collega non
casualmente, fra Tre e Quattrocento, alla riscoperta dei valori della democrazia repubblicana antica,
greca e romana, promossa dalla cultura umanistica.
Comuni, signorie, Stati territoriali
In difesa delle libertà repubblicane conquistate nei comuni vengono varate legislazioni dette
antimagnatizie. I magnati o «grandi» sono coloro che, per eccesso di ricchezza e di influenza
politica o perché notoriamente avversi alla parte popolare, sono considerati sostenitori di tendenze
oligarchiche e ostili al governo di popolo. Essi sono colpiti alla fine del XIII secolo da speciali
provvedimenti che prevedono la loro espulsione dalla vita della città, la privazione dei diritti politici
e non di rado la confisca dei beni e l’esilio. Questa stretta antimagnatizia non ha, tuttavia, lunga
durata. Con il tempo, l’esigenza dei principali comuni di ampliare il proprio territorio, il contado, e
l’emergere del potere di alcune grandi famiglie mercantili, generalmente in grado di acquisire anche
titoli nobiliari, danno luogo a una nuova stagione politica, orientata, tra forti conflitti, in senso
oligarchico.
In molte realtà comunali si afferma l’influenza di una famiglia preponderante, come i
Visconti a Milano o i Medici a Firenze, che talvolta senza immediatamente abolire le strutture di
governo repubblicane, le svuotano e le orientano verso un restringimento della partecipazione
politica. In altre realtà il potere di un signore si afferma definitivamente, stravolgendo o
trasformando le vecchie istituzioni rappresentative di ispirazione democratica.
Fra Tre e Quattrocento repubbliche come Firenze e Venezia vengono definendosi come veri
e propri Stati territoriali, inglobando anche altre realtà comunali, un tempo libere, e dominandole.
Con la pace di Lodi (1454) l’Italia dei comuni e delle signorie appare ormai definitivamente
tramontata e al suo posto si afferma un sistema di Stati territoriali variamente composti: a fianco di
repubbliche sempre più chiaramente oligarchiche, come Genova e Venezia, persistono città Stato, a
regime repubblicano o signorile, e regni che mantengono al loro interno una forte presenza di poteri
urbani, come Milano. Questo processo di ridefinizione dei poteri territoriali italiani segue del resto
una fondamentale tendenza europea all’affermazione di Stati territoriali di maggiore ampiezza,
quelli delle grandi monarchie, che si contenderanno l’egemonia nel corso dell’età moderna.
Tramontata l’epoca della democrazia comunale, durante l’antico regime europeo, la
maggioranza della popolazione delle monarchie dinastiche così come delle repubbliche oligarchiche
viene esclusa dai processi decisionali che determinano le principali scelte politiche e che sono
riservate a élite molto ristrette. Ciò non significa, tuttavia, che essa sia privata del tutto di forme di
partecipazione politica.
Ancora una volta è la città il luogo in cui si mantengono vive tradizioni di
corresponsabilizzazione e di autogoverno. Nella realtà tedesca, in particolare, traendo vantaggio
dall’intrinseca debolezza dell’istituzione imperiale, molte città mantengono prassi di larga
autonomia politica e di partecipazione delle rappresentanze dei corpi sociali alle scelte del governo
urbano.
Nelle repubbliche oligarchiche, come Genova e Venezia, la scelta degli amministratori
pubblici fino alla massima carica, quella di doge, dal latino dux, capo, ha luogo attraverso complessi
meccanismi che prevedono sempre un processo di selezione dei soggetti eleggibili. Ciò avviene –
nelle repubbliche, ma anche nelle maggiori città degli Stati monarchici – attraverso la verifica di
una serie di attitudini, basate su un misto di competenza e di considerazione sociale, che variano a
seconda delle cariche in palio. Per gli incarichi più elevati è richiesta l’appartenenza alla nobiltà
civica, e cioè, concretamente, l’iscrizione in liste alle quali si è ammessi solo se maschi adulti
appartenenti a determinate famiglie detentrici di titoli nobiliari. Poi, attraverso procedure miste di
elezione, sorteggio o scelta da parte delle autorità in carica, si seleziona una lista di candidati dalla
quale sono estratti a sorte i nomi degli amministratori.
Questi complicati sistemi permettono il mantenimento, anche nel quadro delle formazioni
statali monarchiche, di uno dei fondamentali diritti di cittadinanza, quello di scegliersi i propri
amministratori. I sovrani cercano a più riprese, e con alterna fortuna, di limitare queste prassi nei
loro domini e di imporre alla guida delle città funzionari di nomina regia. Nella maggioranza dei
casi quello che riescono a ottenere è la compresenza, a fianco del mantenimento parziale di prassi
elettive, di una figura politica rilevante di esclusiva scelta sovrana, che generalmente è anche il
titolare del comando militare locale.
Un secondo diritto di cittadinanza che si mantiene in ambito urbano è quello della selezione
di coloro che aspirano a far parte della comunità e, quindi, a godere delle prerogative connesse, tra
cui il privilegio di essere giudicati in un tribunale cittadino senza essere portati dinanzi a un giudice
esterno.
Con il tempo, nel corso dei secoli XVI e XVII, la tendenza prevalente è quella di un
restringimento dei diritti di cittadinanza solo alle fasce sociali organizzate in corporazioni di
mestiere e ai nobili, cui vengono riservati i principali incarichi di governo. Le aristocrazie cittadine
tendono anzi a rinchiudere sempre più i propri ranghi, facendo del controllo delle risorse locali un
esercizio riservato e precluso agli estranei, e cioè non solo ai non cittadini ma anche ai nuovi nobili
e ai recentemente arricchiti.
Forme dell’esclusione: servitù e schiavitù
Se nelle città si mantengono, pur nell’ambito di una chiara tendenza alla restrizione degli
accessi al potere, forme di compartecipazione che coinvolgono le rappresentanze delle corporazioni
di mestiere, nei piccoli centri e in campagna il dominio si esercita in forme più dirette e non di rado
oppressive. Tutti i signori feudali che possiedono terre abitate, in general, possono far leva sui diritti
che il titolo feudale concede loro in termini di amministrazione, esercizio della giustizia, monopoli
economici, imposizione di lavoro obbligato (corvées), per massimizzare i propri redditi a scapito
della popolazione. In Europa occidentale la tendenza a basarsi sui diritti feudali per consolidare un
dominio sociale spinto fino alla prevaricazione e all’oppressione è contenuta dalle tradizioni delle
comunità, dagli statuti, dalla possibilità di accedere alla giustizia regia e dall’esempio delle città
Stato libere o di quelle direttamente dipendenti dalla Corona. Viceversa, nell’Europa dell’Est, in
tutta l’area posta ad oriente del fiume Elba, si manifesta in età moderna la tendenza al
rafforzamento del potere feudale.
Questo processo, detto dagli storici rifeudalizzazione o «secondo servaggio», consiste nella
rinegoziazione dei rapporti relativi tra le comunità e i loro signori: un processo che vede i poteri di
questi ultimi rafforzarsi nei secoli XVI e XVII, imponendo nuove forme di soggezione espresse sia
da un aggravio del lavoro obbligato nelle terre padronali, sia dalla formalizzazione di patti agrari
sfavorevoli ai lavoratori. Tale ondata di prevaricazioni, che puntano a rendere i contadini totalmente
dipendenti, si spinge fino a forme di intervento e di sorveglianza padronale su aspetti della vita
familiare e a privazioni delle libertà elementari. I cosiddetti servi della gleba, coloro che sono
soggetti a forme di contratto consuetudinario con un signore per il lavoro coatto in certe tenute,
sono vincolati alla terra, non possono cioè abbandonare quel territorio e recarsi a lavorare altrove.
Ciò detto, la condizione servile non va confusa con quella degli schiavi. I servi hanno il
diritto alla proprietà, possono effettuare operazioni di mercato e, al di là della prestazione di corvées
nei domini signorili, sono liberi di vendere la propria forza lavoro anche altrove. Se impiegati
stabilmente da un signore, ricevono uno stipendio in denaro o in natura, vale a dire in derrate
agricole. Possono, sia pure con limitazioni, fare testamento ed ereditare. Soprattutto, i loro diritti e i
loro doveri non sono decisi d’arbitrio dal padrone ma da tradizioni consuetudinarie collettive.
Queste ultime possono anche essere eluse o stravolte dal potere signorile, ma a rischio di rivolte
contadine.
Gli schiavi, invece, sono totalmente alla mercè del loro padrone e, in pratica, non hanno una
vita propria. Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, la loro presenza si mantiene in
quanto ammessa da molti Stati romano-barbarici e dalla Chiesa cattolica, che consente la schiavitù
purché inflitta a non credenti. Per questa ragione, con la conversione progressiva delle popolazioni
europee, le aree di reclutamento forzoso degli schiavi rimangono i Balcani (la parola sclavus deriva
da slavus, slavo) e soprattutto il Mediterraneo, area di diffusione della religione islamica.
Lungo le aree del conflitto che contrappone il mondo occidentale cristiano dapprima agli
arabi e poi alla potenza ottomana, la schiavitù prospera, da una parte e dall’altra. Nei porti del
Mediterraneo, dove il commercio degli schiavi controllato da veneziani e turchi è fiorente, non è
infrequente imbattersi nei cosiddetti rinnegati, gente che ha abbandonato la propria religione per
conquistare una condizione di libertà. Per gli altri, per coloro che non vogliono tradire la propria
fede, non resta che tentare di farsi riscattare, cioè ricomprare la libertà con denaro procurato da
parenti o da amici. Le procedure di riscatto, trattate da intermediari o da specifiche organizzazioni –
nel mondo cristiano da particolari confraternite o da specifici ordini religiosi, come i mercedari –
costituiscono una particolare pratica commerciale, fiorente lungo le frontiere e nelle aree dove si
pratica la pirateria, soprattutto nel Mediterraneo meridionale.
Un particolare caso, durante l’età moderna, è rappresentato dalla penisola iberica. Qui le
popolazioni di razza araba immigrata e di religione musulmana vengono assoggettar e con la
violenza nel corso di quel processo di ricristianizzazione in armi (XI-XIII secolo), conosciuto come
reconquista, cioè riconquista militare del territorio. L’ultimo regno arabo musulmano è quello di
Granada, occupato dall’esercito castigliano nel 1492.
La costruzione, a seguito del matrimonio, avvenuto nel 1469, di Isabella di Castiglia e di
Ferdinando d’Aragona – i cosiddetti re cattolici – di una dinastia che si propone come braccio
armato della Santa Sede e che abbraccia nei suoi domini quella che sarà poi chiamata Spagna, pone
il problema di quei sudditi di razza araba e di religione musulmana – i moriscos – che sono stati
convertiti con la forza al cattolicesimo e che sono sospettati di continuare a professare
nascostamente la propria fede. Parallelamente, un crescente atteggiamento di sospetto si manifesta
nei confronti degli ebrei, anche di quelli convertiti, detti marrani, invisi alla popolazione per la loro
agiatezza e per le tradizioni commerciali e usurarie che mantengono. I marrani sono oggetto di
persecuzioni da parte dell’Inquisizione e cadono non di rado vittime di tumulti popolari mentre
l’espulsione degli ebrei, accusati di essere uccisori e negatori di Gesù Cristo, viene decisa nel 1492.
Si diffonde così una vera e propria ideologia del sangue puro, che identifica in moriscos e
marrani i portatori di sangue impuro, differente da quello castigliano. Non si tratta solo di opinioni.
Si fissano regolamenti che, ad imitazione delle tecniche utilizzate per provare la nobiltà,
prescrivono la necessità di dimostrare di non avere antenati moriscos e marrani per assumere
determinati incarichi pubblici. Questi regolamenti o statuti di limpieza de sangre, letteralmente
pulizia del sangue, diffusi a livello locale, vengono trasformati in legge nel 1536 e da quel momento
vengono accolti anche dalla Chiesa cattolica. Si giunge così, all’inizio del XVII secolo,
all’espulsione anche dei moriscos da Castiglia e Aragona.
Questo tema della differenza di razza, mescolato con quello della diversa religione, si
ripropone con la conquista spagnola del Nuovo Mondo. I conquistadores iberici, proseguendo
idealmente la reconquista nei nuovi territori americani, assoggettano militarmente e culturalmente
le popolazioni locali, distruggendone il modo di vita e i costumi tradizionali. Lo sterminio dei
cosiddetti indios, e cioè delle popolazioni autoctone, ha proporzioni enormi. Si calcola che la
popolazione del vicereame della Nuova Spagna, all’incirca l’attuale Messico, passi lungo il XVI
secolo da venticinque a un milione di abitanti. Questo vero e proprio genocidio non è tuttavia il
prodotto di piani preordinati, ma dello stravolgimento completo dell’universo materiale e mentale
delle popolazioni locali. Conto questa distruzione si leva la protesta di Bartolomé de Las Casas
(1474-1566), frate domenicano e primo sacerdote ordinato in America. Per Las Casas gli indios,
diversamente da ebrei e musulmani, sono uomini che non hanno ricevuto la buona novella, non
hanno cioè saputo nulla di Cristo fino a quel momento. Compito dei sudditi del Re cattolico è
dunque quello di convertirli e di inglobarli pacificamente nei domini spagnoli.
La posizione di Las Casas, tuttavia, non è maggioritaria. Per la più parte degli spagnoli gli
indios sono barbari, individui inferiori da colonizzare perché incapaci di provvedere a se stessi. La
particolare forma di dominio feudale diffuso nelle Americhe successivamente alla conquista,
l’encomienda, risente di queste concezioni. Gruppi di indios vengono affidati a un colono che li
utilizza nel lavoro dei campi o in miniera in condizioni di semi-schiavitù, privandoli sia di
remunerazioni sia della possibilità di accedere al mondo del lavoro.
Lungo il corso del XVI secolo, in sostituzione degli indios, ormai praticamente scomparsi in
tutto l’arcipelago delle Antille, vengono importati da spagnoli e portoghesi schiavi africani, catturati
o comprati lungo le coste occidentali del Continente nero. Si inaugura così la tratta transatlantica
negriera, cui di dedicano per lungo tempo mercanti genovesi, olandesi, tedeschi e in seguito francesi
e inglesi. Il traffico degli schiavi africani ha dimensioni enormi. Stime accreditate valutano da 10 a
15 milioni gli schiavi trasferiti in America lungo quattro secoli: un commercio grazie al quale si
sviluppano cospicue ricchezze e interi comparti economici di città come Nantes, Liverpool,
Bordeaux. I mercanti di schiavi, infatti, con i proventi della vendita degli esseri umani, comprano in
America prodotti coloniali, che rivendono successivamente al ritorno in Europa. La tratta
transatlantica è all’origine di una delle più importanti trasformazioni razziali dell’umanità e cioè la
formazione delle grandi comunità di razza nera in America meridionale (Brasile e Caraibi) e
settentrionale (Stati Uniti).
Emancipazione e segregazione alle soglie del mondo contemporaneo
L’importanza dell’esistenza della schiavitù e della servitù non sta solo nelle sue dimensioni
reali. Essa è stata al contempo, in Europa, la pregnante figura simbolica dell’oppressione. Uno dei
motivi portanti dell’ondata di rivoluzioni che sconvolge le monarchie europee intorno alla metà del
Seicento è infatti quello della contrapposizione tra libertà, la «libertà degli antichi», oppressa nelle
età successive, e schiavitù. Lo schiavo diviene così il simbolo del suddito senza diritti e senza
difese, oppresso dal dispotismo assoluto di un signore fattosi tiranno. Si stabilisce così un nesso,
forte e potente, tra la cittadinanza piena, il godimento dei diritti naturali – il diritto alla sicurezza e
al possesso dei beni – prima che politici, e la condizione di libertà.
Nel clima di critica all’assolutismo montante nel corso del XVIII secolo, anche la schiavitù
in quanto tale prende, quindi, a essere contestata. In particolare, durante la seconda metà del
Settecento cresce la protesta contro l’inumanità della tratta transatlantica degli schivi, stipati nelle
stive delle navi come bestie, in catene, che muoiono durante il viaggio in percentuali spaventose, da
parte dei settori più avvertiti e attenti dell’opinione pubblica europea, specie francese e inglese. A
seguito di queste pressioni, nel 1770 viene sancita l’abolizione della schiavitù nei territori
metropolitani di Francia, Gran Bretagna e Portogallo ma non nelle colonie. Bisogna attendere la
Rivoluzione francese per vedere proclamata, con i diritti universali dell’uomo, l’abolizione
generalizzata della schiavitù. Al pari di quest’ultima, anche la servitù della gleba viene ritenuta
sempre più, dall’opinione pubblica europea, una condizione inaccettabile Ciò contribuisce a
spingere lo zar Alessandro II di Russia a proclamare nel 1861 la sua abrogazione. I servi, ora
formalmente liberi, non sono però equiparati giuridicamente alle altre classi sociali e
l’emancipazione non è accompagnata da una distribuzione delle terre in grado di dare loro
autonomia economica.
Un quadro diverso presentano, invece, gli Stati Uniti, dove gli Stati del Sud si rifiutano di
abolire la schiavitù, dato che la loro economia si fonda essenzialmente sul lavoro degli schiavi nelle
piantagioni. Essa vi rimane, così, fiorente sino al 1861, allo scoppio della guerra civile, causata dal
tentativo di alcuni Stati meridionali di proclamare la secessione dall’Unione a seguito dell’elezione
del presidente abolizionista Abraham Lincoln (1861-65).
La sconfitta degli Stati secessionisti porta ad emendamenti nella Costituzione, che
aboliscono la schiavitù (1865) e che riconoscono alla popolazione di colore i diritti di cittadinanza
(1866), pur non comportando tuttavia, parallelamente, un’uguaglianza effettiva tra bianchi e neri.
Al contrario, anche per reazione al rigido controllo militare e amministrativo imposto dagli Stati del
Nord nel periodo della cosiddetta Ricostruzione (1865-77), fioriscono negli Stati del Sud i primi
movimenti razzisti, tra cui il famigerato Ku Klux Klan,, che proclamano la superiorità della razza
bianca, esercitano la violenza attraverso il linciaggio fisico e rivendicano il diritto alla segregazione
razziale, l’idea che i neri debbano vivere in zone separate, a loro concesse, e non possano accedere
se non per lavoro ai luoghi e ai servizi riservati ai bianchi. Su tale impostazione si realizza un
compromesso tra il governo statunitense e le classi dirigenti degli Stati meridionali sconfitti. SI
stabilizza così, in tredici Stati del Sud, il regime segregazionista, destinato a sopravvivere fino alla
metà del XX secolo. Non si tratta solo di due diverse qualità di vita e di due squilibrate tipologie di
servizi sociali ma di una separazione culturale profonda, che punta a negare ai discendenti degli
schiavi neri, i cosiddetti afroamericani, i diritti politici, formalmente garantiti, ma in pratica rifiutati,
e soprattutto l’integrazione sociale. Scuole, trasporti e altri servizi pubblici sono infatti rigidamente
divisi, decretando così l’esistenza di una società con due popolazioni distinte e due diversi livelli di
vita.
Problemi differenti ma non meno complessi pone nel frattempo il rapporto della nazione
statunitense con gli indigeni esistenti nel Nord America prima della colonizzazione europea, i
cosiddetti pellerossa. Soprattutto a seguito della scoperta di importanti giacimenti di oro in
California si scatena, attorno alla metà del XIX secolo, una vera e propria corsa alla colonizzazione
dell’Ovest. L’espansione a Ovest limita fortemente le arre non coltivate da cui traggono
sostentamento, mediante la caccia, le tribù indigene. Respinte dai coloni bianchi in aree sempre più
limitate del territorio, esse vengono in seguito, dal 1850 al 1880, costrette, da una serie di campagne
militari, in zone delimitate, le cosiddette riserve, dove vengono rinchiuse e controllare da
un’apposita amministrazione governativa. La reazione in armi degli indiani dà vita a un’epopea,
quella western, che contribuisce non poco a costruire l’immagine di sé del nuovo popolo
statunitense.
Questi conflitti, relativi agli Stati Uniti, vanno inquadrati nel più generale sommovimento
creato dalle idee promosse dalla Rivoluzione francese. La liberazione dall’oppressione viene infatti
da allora in poi coniugata con l’idea dell’uguaglianza di tutti gli uomini e con il concetto di popolo
nazione. Si creano cioè dei linguaggi, strettamente interconnessi, che consentono di esprimere
l’ansia di liberazione crescente in diverse situazioni di discriminazione e di oppressione razziale,
nazionale, religiosa e sociale.
Un caso esemplare è quello dell’America latina dell’Ottocento. La prima rivolta, insieme
razziale e nazionale, è non casualmente quella degli schiavi neri e mulatti, cioè di razza mista
bianca e nera, di Haiti, che, guidati da Toussaint l’Ouverture, il «giacobino nero», danno vita nel
1804, dopo anni di lotta, alla prima repubblica afroamericana. Nel 1810 inizia in Paraguay,
Messico, Argentina e Venezuela la lotta per l’indipendenza della Spagna, caratterizzata
dall’iniziativa dei creoli, i discendenti dei colonizzatori europei che, essendo nati nelle colonie,
vengono discriminati dal governo nell’accesso alle carriere e alle cariche pubbliche. La reazione
militare della Spagna porta a una radicalizzazione delle posizioni e alla presenza tra gli insorti
anche di neri, indios e meticci, di razza mista bianca e india. Leader rivoluzionari come Simón
Bolívar (1783-1830) si schierano apertamente per l’abolizione della schiavitù e la redistribuzione
delle terre. Nel corso di un decennio l’intera America latina si sottrae al dominio spagnolo, dando
luogo a una serie di Stati indipendenti, mentre il Brasile dichiara a sua volta l’indipendenza dal
Portogallo nel 1822.
La lotta contro l’esclusione sociale
Uno degli aspetti più importanti della storia europea del XIX secolo è lo stretto nesso che si
viene a costituire tra la rivendicazione per l’allargamento dei diritti politici, e cioè essenzialmente,
la richiesta di una Costituzione e della democrazia, e la rivendicazione sociale, cioè la richiesta di
condizioni migliori di vita e di lavoro, da parte delle classi lavoratrici. Queste due problematiche
strettamente interconnesse vengono agitate in un’epoca – l’Ottocento – di affermazione dello Stato
nazione e di rivendicazioni di indipendenza da parte delle nazioni senza Stato. Questione
democratica e questione sociale devono quindi misurarsi e talora scontrarsi con la questione
nazionale.
È in questo intreccio di diritti richiesti e rifiutati, di aspirazioni conclamate e contestate, di
rivendicazioni avanzate e negate che di formano le identità collettive tipiche del mondo moderno:
identità nazionali, anzitutto, spesso connotate fortemente da una religione dominante; di razza,
anche, specie in ragione dell’estendersi della spinta alla colonizzazione da parte delle potenze
europee; identità di classe, soprattutto, a seguito essenzialmente della rivoluzione industriale e della
creazione della nascita del moderno lavoro operaio; identità di genere, infine, a seguito della
crescente consapevolezza, da parte delle donne, della propria condizione di subalternità e di
esclusione da un mondo egemonizzato dagli uomini.
È negli anni Trenta del XIX secolo che la questione dell’allargamento dei diritti di
cittadinanza a fasce sociali sino ad allora escluse si inizia a porre con forza, sia in Francia sia in
Inghilterra. In Francia, a seguito della Rivoluzione di luglio scoppiata a Parigi, le cosiddette «tre
gloriose giornate» del 27, 28 e 29 luglio 1830, il regime prettamente reazionario di Carlo X (182430) viene travolto, dando luogo a una monarchia costituzionale, la Monarchia di luglio. Il nuovo
sovrano, Luigi Filippo d’Orléans (1830-1848), membro di una famiglia che ha parteggiato per la
Rivoluzione, crea un sistema censitario, che si regge sull’appoggio delle classi agiate e possidenti.
Egli deve però fronteggiare un’opposizione democratica e repubblicana che rivendica
l’allargamento delle basi rappresentative del sistema di governo e, concretamente, un’estensione del
diritto di voto. Sono i setaioli di Lione, ribellatisi nel 1831 e poi, di nuovo, nel 1834, a dare avvio a
una tradizione democratico-insurrezionale che coinvolge ampi settori del mondo artigianale e il
nascente mondo operaio degli opifici industriali.
Artigiani e operai si ritrovano da allora in poi più volte fianco a fianco sulle barricate: nella
rivolta che sconvolge Parigi nel 1848, provocando la caduta della Monarchia di luglio e l’avvento
della Seconda Repubblica (1848-1852); e di nuovo nel 1871, quando, a seguito della sconfitta
dell’esercito di Napoleone III da parte delle truppe prussiane e della caduta del Secondo Impero
(1852-70), essi danno vita all’esperienza insurrezionale della Comune, un’autogestione in armi
della municipalità parigina su basi democratico-egualitarie duramente repressa dalla nuova
dirigenza della nascente Terza repubblica. Li muove l’esperienza decisiva della Rivoluzione
francese e l’allargamento straordinario della discussione politica che essa ha provocato.
Il coinvolgimento di ampi strati della popolazione in comitati, sezioni, club, e la
politicizzazione delle organizzazioni di mestiere e di quartiere ha creato una forte e diffusa
aspirazione democratica, rivendicata da gente per cui l’uguaglianza non è più un mito ed è divenuta,
almeno per una fase, una pratica politica; gente per cui il diritto di espressione, di parola, di
riunione ha smesso di essere una teorica possibilità a disposizione di ristrette élites ed è divenuta
consuetudine. Pur sconfitta, la Rivoluzione ha trasmesso un’eredità di partecipazione e di
solidarietà, alimentata nelle società di mutuo soccorso e nelle associazioni democratiche e
socialiste.
Anche in Inghilterra, negli stessi anni, il mondo del lavoro è in fermento. Qui, prima di ogni
altro paese la rivoluzione industriale ha creato le basi materiali per una presa di coscienza di una
condizione di classe, accomunando masse di individui di diversa provenienza in immensi opifici
dove, insieme a una vita di lavoro in comune, maturano sentimenti di fratellanza e la coscienza di
comuni interessi. L’opinione pubblica inglese è resa sensibile da un fiorire di organizzazioni
filantropiche sulle sofferenze e le condizioni di vita spesso disumane dei moderni «schiavi delle
macchine», i lavoratori dell’industria. Sono però gli stessi operai a prendere l’iniziativa di difendere
i propri diritti, costituendo le prime organizzazioni sindacali. L’arma che essi si danno, assieme alle
forme del mutuo soccorso, è essenzialmente quella dello sciopero. Attraverso questo strumento si
può bloccare la produzione, mettendo il proprietario degli impianti in difficoltà e inducendolo così a
un innalzamento dei salari o a una riduzione dell’orario di lavoro.
Ciò che rende la protesta operaia particolarmente pericolosa agli occhi delle classi dirigenti,
e perciò suscettibile di repressione violenta, è il fatto che sin dall’inizio essa mescola le
rivendicazioni più tipicamente salariali, volte a un miglioramento delle condizioni di lavoro, a
richieste di carattere politico, incentrate su due assi: in primo luogo la rivendicazione al diritto di
riunione, di associazione, di comizio e di sciopero, in breve, alla possibilità di far politica non come
individui ma come gruppo sociale, come classe; in secondo luogo, la denuncia dell’esclusione dalla
rappresentanza politica attraverso il voto, riservato solo ai benestanti e possidenti.
Richieste come quella del suffragio universale, avanzata in Inghilterra nel 1836 dalla Carta
del popolo, non sono accolte; ma con il tempo il sistema elettorale si viene gradualmente
allargando, prima nel 1867 e poi nel 1884-85, includendo alla fine tutti i maschi adulti dotati di
reddito minimo. Allo stesso tempo, dopo il 1872, il voto, che prima era palese, espresso in modo
manifesto, diviene segreto, tutelando così le rivendicazioni politiche dei più deboli e indifesi. Anche
in altri paesi il sistema censitario viene gradatamente abbandonato in favore del suffragio universale
maschile. In Italia, ad esempio, dopo un allargamento del censo nel 1882, vi si arriva nel 1912.
Il progressivo allargamento del suffragio maschile pone in evidenza l’esclusione del voto
delle donne. Già durante la Rivoluzione francese la questione era stata posta da Marie-Olympe de
Gouges (1748-93), che aveva inviato petizioni all’Assemblea costituente per promuovere
l’estensione alle donne del voto e la promulgazione di una Dichiarazione dei diritti della donna e
della cittadina. L’attivismo della de Gouges era stato però visto con sospetto dalla dirigenza
giacobina, che non aveva esitato a processarla, accusandola di attività controrivoluzionaria, e a
condannarla alla ghigliottina.
La difficoltà delle donne a far valere l’idea di una parità dei diritti civili con gli uomini è
mostrata da un altro episodio, meno tragico del precedente ma non meno paradossale. Quando nel
1840 si riunisce a Londra il congresso antischiavistico mondiale, due intellettuali americane,
Lucretia Mott ed Elizabeth Cady Stanton non vengono ammesse ai lavori in quanto donne. Mott e
Stanton non si perdono d’animo e otto anni dopo organizzano la Convenzione di Seneca Falls, che
può essere considerata l’atto di nascita del movimento per l’eguaglianza tra i sessi. Le partecipanti a
quell’assiste denunciano il controllo maschile sulle proprie scelte e chiedono per le donne la parità
civile con gli uomini e l’emancipazione giuridica ed economica.
Il movimento per il voto alle donne, detto suffragista, è molto forte tanto negli Stati Uniti
quanto in Inghilterra. Le attiviste del movimento femminile, dette suffragette, organizzano
agitazioni, comizi, scioperi della fame, subendo arresti e condanne, e influenzando
progressivamente la pubblica opinione. In conseguenza di ciò, le donne inglesi ottengono il diritto
di voto nel 1918, quelle americane nel 1920. Prima di loro, tuttavia, prima nazione al mondo,
l’Australia, un’ex colonia britannica, riconosce alle proprie donne il voto nel 1903, appena ottenuta
l’indipendenza.
Il rosso e il nero
Nella seconda metà del XIX secolo il movimento operaio comincia a dotarsi di strutture
stabili di organizzazione, di forme di coordinamento internazionale e di un’ideologia unificante,
quella del socialismo. Tra le varie forme di socialismo si impongono con il tempo le idee di Karl
Marx, che fanno della rivendicazione democratica e sociale il volano di un profondo mutamento,
destinato a cambiare completamente il colto della società attraverso la socializzazione dei mezzi di
produzione, una profonda trasformazione in senso egualitario delle strutture sociali e delle norme
giuridiche, una radicale democratizzazione della vita associata.
Tale mutamento viene rimandato a un futuro indeterminato, al momento della presa del
potere delle masse popolari attraverso un’insurrezione generale, la rivoluzione, che spazzerà via le
resistenze borghesi alla costruzione della società socialista. Questa rivoluzione futura si nutre
essenzialmente di storia e cioè di ricordi mitizzati delle rivoluzioni passate: proprio come durante la
Rivoluzione francese la borghesia ha scalzato la prepotenza aristocratica, così la rivoluzione
proletaria frantumerà l’egemonia borghese.
L’enorme successo degli ideali socialisti nel secondo Ottocento è dovuto alla capacità del
marxismo di divenire una dottrina che sostiene la liberazione degli esclusi e degli emarginati, delle
enormi masse operaie urbanizzate, degli intellettuali a disagio per il piatto conformismo di gran
parte delle classi dirigenti, di una parte significativa dei contadini poveri e senza terra. Soprattutto,
il marxismo, collegandosi alle più influenti e prestigiose correnti intellettuali del tempo, si propone
come un’interpretazione scientifica della storia e della società contrapponendosi al socialismo
utopistico del primo Ottocento.
La potente analisi economica marxiana delle trasformazioni sociali indotte dall’avvento
della società capitalistica offre una forte base a questa presunzione di lettura oggettiva
dell’evoluzione storica e all’illusione che ne deriva di porsi in qualche modo dalla parte di
trasformazioni già segnate, di un corso di cose nelle grandi linee prevedibile, e di interpretare e
utilizzare a proprio vantaggio le leggi della storia. Soprattutto, il poter avanzare una lettura della
storia universale basata sul concetto di classe, consente all’ideologia marxista di proporsi come
veicolo di fratellanza dei popoli, di un universalismo proletario che invita gli oppressi a unirsi e a
battersi per la costruzione di un mondo migliore.
Non vi è mai stata, prima del socialismo marxista, alcuna ideologia, se non di natura
religiosa, in grado di muovere così potentemente enormi masse di persone. Come nel caso delle
religioni, anche il socialismo propone una trasformazione collettiva veicolata da una fede salvifica,
e come le religioni indica la via della salvezza in un percorso collettivo, comunitario. Il socialismo
che sarebbe venuto avrebbe sanato i più dolorosi mali scoiali, estirpando definitivamente
l’oppressione, la sopraffazione dell’uomo sull’uomo, lo sfruttamento del lavoro altrui e il
dispotismo. Al posto di una società ingiusta, nutrita di disparità e di disuguaglianze, si sarebbe
realizzata una società in cui a ciascuno sarebbe toccato contribuire al bene collettivo a seconda delle
sue possibilità e in cui a ciascuno sarebbe stato dato secondo il suo bisogno.
In attesa di questo radicale cambiamento, tuttavia, i movimenti socialisti si organizzano in
strutture di partito nazionali che si muovono nel solco delle tradizioni solidaristiche del movimento
operaio, organizzando una rete di società di mutuo soccorso, costruendo e difendendo le
organizzazioni sindacali, lottando per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di salario,
battendosi per l’allargamento della democrazia e l’estensione a tutti i cittadini dei diritti politici. Il
modello di organizzazione socialista, i riti, i canti, i colori – l’uso del colore rosso come simbolo di
lotta, della falce e martello incrociati come emblema dell’unione di operai e contadini – replicati in
tutto il mondo in infinite varianti, danno l’illusione del superamento delle barriere nazionali entro
un nuovo orizzonte internazionale.
L’internazionalismo socialista, la costruzione di un sentimento di solidarietà che oltrepassa i
confini nazionali suscita, insieme a entusiastiche adesioni, profonde avversioni nei settori sociali
più tradizionalisti e retrogradi, legati al tradizionalismo cattolico e al legittimismo monarchico che
si era illuso, nell’età della Restaurazione, di poter annullare le conquiste della Rivoluzione francese.
A fianco di quegli strati sociali che avversano il socialismo vedendo in esso l’avvento di un
movimento ateo, sovvertitore dell’ordine sociale voluto da Dio, sorgono tuttavia nuovi gruppi
sociali che si identificano con nuove concezioni, il cui punto di partenza è costituito dal moderno
concetto di nazione e dall’ideologia del razzismo.
Il razzismo trova una sua prima enunciazione teorica nell’opera dell’intellettuale francese
Joseph Arthur Gobineau (1816-1882) che, nel suo Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane, per
primo teorizza la discendenza della razza bianca dall’antica popolazione ariana, la sua superiorità
rispetto alla razza gialla e a quella nera, l’importanza della purezza razziale per mantenere le virtù
caratteriali connaturate al sangue. Il nazionalismo crescente nel corso del XIX secolo, esacerbato,
tra l’altro, in Francia, dalla sconfitta militare subita a opera dei prussiani nel 1870-71, costituisce un
terreno fertile per la diffusione di queste idee, che si pongono in diretto antagonismo con
l’universalismo e l’internazionalismo tipici del movimento socialista. Occasione dello scontro è, in
Francia come altrove, la presenza di un gruppo che racchiude tutti gli elementi per suscitare
l’avversione delle forze reazionarie: gli ebrei. Questi ultimi presentano molteplici requisiti di
«diversità»: in non appartenere al cristianesimo, e anzi l’essere da sempre accusati di aver causato
la morte di Gesù Cristo; il mantenimento di un’identità a parte, mai assimilata integralmente in
alcuna cultura nazionale; la forte coesione internazionale delle varie comunità sparse in tutto il
mondo: la condizione sociale abbiente, ma soggetta al marchio d’infamia di essere fondata sulla
pratica dell’usura, attività parassitaria che sfrutta il lavoro altrui.
Non è perciò un caso se il più importante conflitto politico che vede contrapposte, durante la
Francia della Terza Repubblica, forze democratiche e socialiste alla destra clericale, reazionaria e
militarista, ha come protagonista un ebreo, il capitano Alfred Dreyfus, condannato ingiustamente
nel 1894 da un tribunale militare alla deportazione a vita per aver divulgato segreti militari. Nuove
prove che evidenziano l’infondatezza delle accuse a Dreyfus vengono accantonate e si arriva a
falsificare dei documenti pur di provarne la colpevolezza. La sinistra socialista, radicale e
democratica, attiva una possente mobilitazione a favore di Dreyfus: celebre l’articolo dello scrittore
Emile Zola dal titolo J’accuse, io accuso. Su un fronte contrario si raccoglie la Francia razzista,
xenofoba e nazionalista. Dreyfus, alla fine, molti anni dopo, nel 1906, è scagionato e reintegrato nel
suo grado ma la sua vicenda evidenzia anche agli occhi dei contemporanei in modo eloquente la
contrapposizione che è destinata ad aprirsi nel cuore dell’Europa.
La nuova ideologia razzista trova in Germania il terreno più propizio alla sua diffusione. Qui
essa si lega a una lettura biologica della società influenzata dalle teorie dell’evoluzione di Charles
Darwin; qui si diffonde l’idea di affidare alla scienza il compito di proteggere la razza dalla sua
possibile degenerazione; qui l’idea della razza si fonde con una mitologia delle origini ariane del
popolo tedesco e del suo «storico» compito. Dopo la sconfitta nella Prima guerra mondiale,
l’ideologia razzista trova nel sentimento nazionalistico ferito un potente alleato, e nuovi adepti nei
reduci tornati dal fronte, nei disoccupati creati dalla crisi economica postbellica, nei ceti che si
sentono minacciati dalla crescente forza del movimento operaio. L’antisemitismo diviene, per
questi settori sociali, un vero e proprio collante. Gli ebrei, immaginati come i tessitori di una
congiura internazionale ai danni della razza ariana, e dipinti come i recipienti immondi di tutti i vizi
sociali più detestabili, divengono i facili bersagli del nuovo razzismo, diffusosi a macchia d’olio in
tutto l’Est europeo.
Per concludere
La prima e per molto tempo l’unica rivoluzione vincente socialista e proletaria si verifica in
Russia. Il partito bolscevico che la realizza sotto la guida di Nikolai Lenin (1870-1924) si distacca
però molto rispetto alla tradizione socialista. Con il suo successore, Josif Stalin (1879-1953) il
partito dà vita, infatti, a una vera e propria dittatura che porta all’abolizione delle fondamentali
libertà civili. Nel frattempo, in Germania, sfruttando la crescente paura del movimento comunista
internazionale, il Partito nazionalista tedesco dei lavoratori, fondato da Adolf Hitler (1889-1945)
riesce a raccogliere circa un terzo dei consensi elettorali. L’ideologia nazista costituisce una ripresa
organica delle precedenti teorie razziste e antisemite, riorganizzate e inquadrate nell’aspirazione a
una società totalmente purificata da un punto di vista razziale, il Terzo Reich, capace di risollevare
finalmente l’orgoglio mortificato del popolo tedesco. Il partito nazista, che per certi aspetti mima il
modello socialista nelle strutture organizzative, in certe forme rituali e nell’uso del colore – in
questo caso il nero, simbolo di volontà di lotta fino alla morte, per altri aspetti è un partito
completamente nuovo, con la sua struttura militaresca e rigidamente gerarchica, l’esaltazione del
capo carismatico, il Führer, il culto della violenza assiduamente praticata contro ebrei, sindacalisti,
socialisti. In parte questi tratti sono ripresi dall’esperienza del fascismo, il regime autoritario creato
da Benito Mussolini (1883-1945) in Italia nel 1921, caratterizzato dall’annullamento delle più
elementari garanzie democratiche come la libertà di riunione e di associazione, dal controllo
poliziesco sulla stampa e sull’informazione, dalla persecuzione degli avversari politici, dalla
riproposizione continua di una retorica nazionalistica e guerrafondaia.
Il disprezzo per i diritti umani e le pratiche collettive di violenza caratterizzano anche il
regime nazista che, divenuto anch’esso regime nel 1933, si dedica come il fascismo alla
cancellazione di ogni libertà e all’indottrinamento del popolo tedesco attraverso la propaganda e un
fitto e ben organizzato reticolo associativo. La novità nazista rispetto al fascismo è data dalla
radicalità del progetto di rinnovamento della società tedesca e dalla forza dell’ideologia razzista,
che costituisce il vero e proprio nocciolo duro del regime hitleriano. Durante la Seconda guerra
mondiale, con l’espansione in Europa orientale e l’occupazione di territori abitati da milioni di
ebrei, i nazisti costruiscono una gigantesca macchina organizzativa per la deportazione di massa
degli ebrei, insieme ad altri gruppi discriminati come gli zingari, gli omosessuali, i disabili e gli
oppositori politici. Gran parte di essi viene raccolta in campi di concentramento, i lager, e obbligata
a lavori forzati in condizioni di estrema sofferenza. Più tardi, nel 1942, i lager vengono attrezzati
con camere a gas, che consentono di uccidere gli ebrei deportati da tutt’Europa secondo un lucido
piano di annientamento, la soluzione finale, che prevede l’eliminazione totale del popolo ebraico. Si
calcola che un numero tra cinque e sei milioni di ebrei muoiono sterminati nei campi di
concentramento.
Negli anni Trenta, quindi, ideologie molto diverse producono effetti simili, cancellando
completamente i diritti civili che la tradizione occidentale aveva faticosamente conquistato. Milioni
di persone sono schiavizzate e messe a morte senza processo, senza le più elementari garanzie. Se
nel caso dell’ideologia nazista tale conclusione appare come la conseguenza della prospettiva
razzista che la anima, lo stalinismo, il «socialismo realizzato», appare un risultato mostruoso se
paragonato al sogno di una società più giusta per cui milioni di persone avevano lottato e in cui
avevano creduto.
Con la vittoria delle forze alleate nella Seconda guerra mondiale si creano di nuovo le
condizioni per una ripresa delle lotte per i diritti civili. Tuttavia, ciò vale solo per il mondo
occidentale. In molti altri casi, invece, le conquiste democratiche sono viste dai paesi del Terzo
mondo come espressione di una cultura dominante e irrispettosa delle tradizioni culturali «altre»,
alimentando reazioni di fondamentalismo sempre più esasperate.