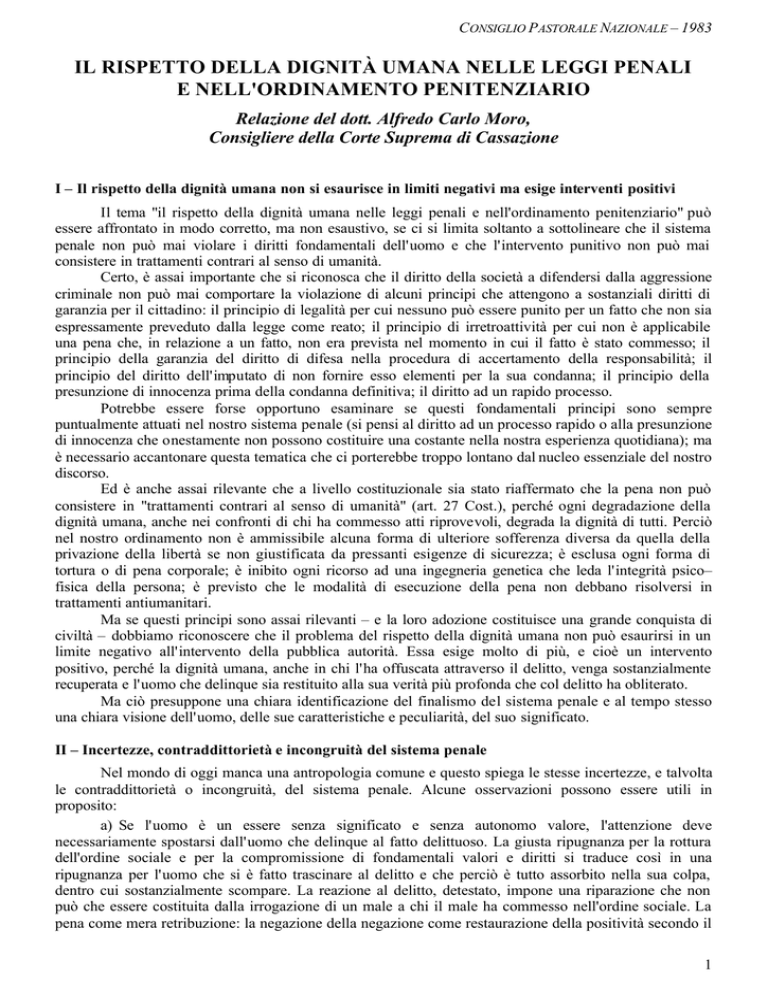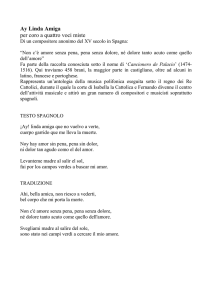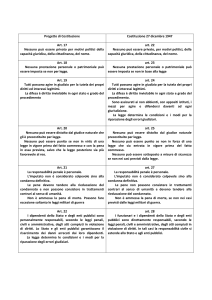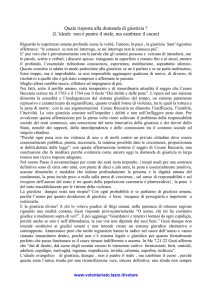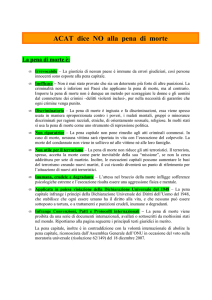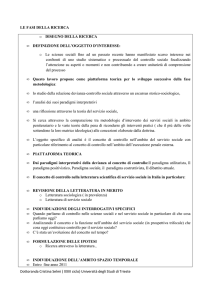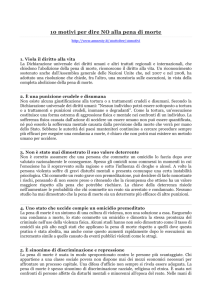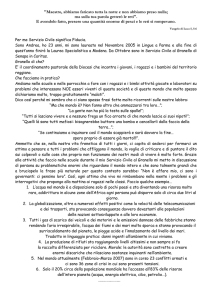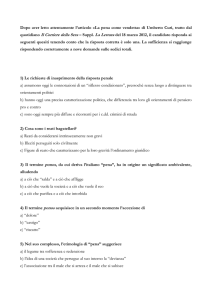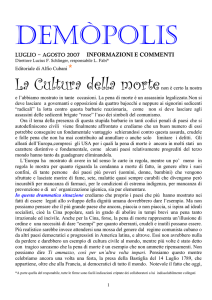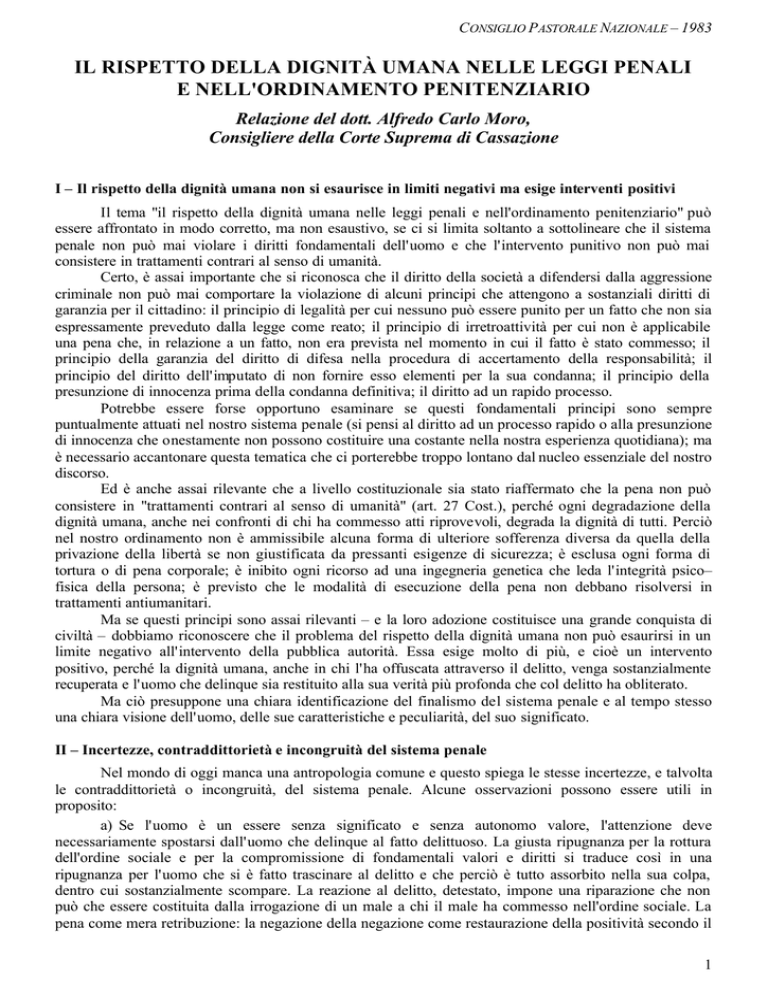
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA NELLE LEGGI PENALI
E NELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Relazione del dott. Alfredo Carlo Moro,
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
I – Il rispetto della dignità umana non si esaurisce in limiti negativi ma esige interventi positivi
Il tema "il rispetto della dignità umana nelle leggi penali e nell'ordinamento penitenziario" può
essere affrontato in modo corretto, ma non esaustivo, se ci si limita soltanto a sottolineare che il sistema
penale non può mai violare i diritti fondamentali dell'uomo e che l'intervento punitivo non può mai
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Certo, è assai importante che si riconosca che il diritto della società a difendersi dalla aggressione
criminale non può mai comportare la violazione di alcuni principi che attengono a sostanziali diritti di
garanzia per il cittadino: il principio di legalità per cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto dalla legge come reato; il principio di irretroattività per cui non è applicabile
una pena che, in relazione a un fatto, non era prevista nel momento in cui il fatto è stato commesso; il
principio della garanzia del diritto di difesa nella procedura di accertamento della responsabilità; il
principio del diritto dell'imputato di non fornire esso elementi per la sua condanna; il principio della
presunzione di innocenza prima della condanna definitiva; il diritto ad un rapido processo.
Potrebbe essere forse opportuno esaminare se questi fondamentali principi sono sempre
puntualmente attuati nel nostro sistema penale (si pensi al diritto ad un processo rapido o alla presunzione
di innocenza che onestamente non possono costituire una costante nella nostra esperienza quotidiana); ma
è necessario accantonare questa tematica che ci porterebbe troppo lontano dal nucleo essenziale del nostro
discorso.
Ed è anche assai rilevante che a livello costituzionale sia stato riaffermato che la pena non può
consistere in "trattamenti contrari al senso di umanità" (art. 27 Cost.), perché ogni degradazione della
dignità umana, anche nei confronti di chi ha commesso atti riprovevoli, degrada la dignità di tutti. Perciò
nel nostro ordinamento non è ammissibile alcuna forma di ulteriore sofferenza diversa da quella della
privazione della libertà se non giustificata da pressanti esigenze di sicurezza; è esclusa ogni forma di
tortura o di pena corporale; è inibito ogni ricorso ad una ingegneria genetica che leda l'integrità psico–
fisica della persona; è previsto che le modalità di esecuzione della pena non debbano risolversi in
trattamenti antiumanitari.
Ma se questi principi sono assai rilevanti – e la loro adozione costituisce una grande conquista di
civiltà – dobbiamo riconoscere che il problema del rispetto della dignità umana non può esaurirsi in un
limite negativo all'intervento della pubblica autorità. Essa esige molto di più, e cioè un intervento
positivo, perché la dignità umana, anche in chi l'ha offuscata attraverso il delitto, venga sostanzialmente
recuperata e l'uomo che delinque sia restituito alla sua verità più profonda che col delitto ha obliterato.
Ma ciò presuppone una chiara identificazione del finalismo del sistema penale e al tempo stesso
una chiara visione dell'uomo, delle sue caratteristiche e peculiarità, del suo significato.
II – Incertezze, contraddittorietà e incongruità del sistema penale
Nel mondo di oggi manca una antropologia comune e questo spiega le stesse incertezze, e talvolta
le contraddittorietà o incongruità, del sistema penale. Alcune osservazioni possono essere utili in
proposito:
a) Se l'uomo è un essere senza significato e senza autonomo valore, l'attenzione deve
necessariamente spostarsi dall'uomo che delinque al fatto delittuoso. La giusta ripugnanza per la rottura
dell'ordine sociale e per la compromissione di fondamentali valori e diritti si traduce così in una
ripugnanza per l'uomo che si è fatto trascinare al delitto e che perciò è tutto assorbito nella sua colpa,
dentro cui sostanzialmente scompare. La reazione al delitto, detestato, impone una riparazione che non
può che essere costituita dalla irrogazione di un male a chi il male ha commesso nell'ordine sociale. La
pena come mera retribuzione: la negazione della negazione come restaurazione della positività secondo il
1
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
concetto di Hegel (il reato è negazione del diritto, la pena è negazione del reato, quest'ultimo è pertanto
negazione della negazione); la pena come espressione definitiva e solenne dell'odio suscitato dalla
commissione del delitto, poiché è moralmente giusto odiare i criminali, secondo la concezione dello
Stephen. Tutte queste sono espressioni di una comune supervalutazione della colpa oggettiva e di questa
sostanziale indifferenza per il colpevole.
Né si tratta di teorie ormai desuete: il riaffiorare di tendenze – anche nel mon do cattolico – per il
ripristino della pena di morte indica che ancora è assai viva la tentazione di vedere tutto il sistema penale
come uno strumento della collettività contro chi ha violato le regole, di attribuire a questo sistema un
carattere passionale e irrazionale.
b) Se l'uomo è un mero prodotto biologico (il "mostro" lombrosiano) o un mero prodotto sociale;
se è necessitato al delitto da condizioni personali particolari o dalla pressione della situazione sociale; se
pertanto nessuna responsabilità gli può essere attribuita – e quindi nessun autentico recupero morale è
possibile – l'intervento penale non può che consistere in una accentuazione del terrorismo penale (perché
solo il disgusto della sofferenza collegata alla pena, eliminerà l'incentivo alla ricerca delle soddisfazioni
connesse con il delitto) e ad una segregazione sempre più ferrea dalla società, anche a tempo
indeterminato, affinché questa possa essere adeguatamente difesa. Ma la tematica della difesa sociale
comporta di necessità una supervalutazione della società ed una ipovalutazione del singolo uomo; una
accettazione che i diritti individuali vanno sacrificati di fronte a quelli della collettività; una
considerazione dei singoli uomini come meri mezzi per fini sociali.
III – Per gli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione il valore supremo della vita sociale è la persona
umana
Per la coscienza sociale che si è affermata nel nostro paese con il patto costituzionale, la
valutazione dell'uomo – e quindi dell'intervento penale quando esso uomo abbia violato con il delitto
fondamentali valori, della convivenza – è sostanzialmente diversa.
Tale visione non emerge soltanto dall'art. 27 – che afferma che le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e che anzi devono tendere alla rieducazione del condannato, il che
comporta ovviamente la esclusione della pena di morte – ma principalmente dal collegamento di questo
articolo con gli art. 2 e 3 della Carta costituzionale che, come è stato detto, sono la chiave di volta di tutto
il nostro sistema costituzionale, evidenziando la filosofia politica su cui deve basarsi la nostra comunità.
Riconoscono questi articoli che valore supremo della vita sociale è la persona umana e che le
realtà collettive, politiche e sociali – e lo stesso Stato – sono mezzi e valori strumentali per realizzare il
pieno sviluppo di essa: ammettere che lo Stato possa annientare la persona, anziché reintegrarla nel
tessuto comunitario recuperandola innanzi tutto a se stessa, significherebbe tornare a ideologie per cui i
valori collettivi e impersonali (società, nazione, razza, classe, stato e simili) sono i valori supremi e quindi
i fini verso cui deve essere diretta ogni attività politica, mentre l'individualità umana deve essere trattata
come mero strumento per servire quel fine.
La nostra Costituzione riconosce anche che ogni uomo – anche se debole, se non compiutamente
sviluppato, se apparentemente insignificante, se fisicamente e psichicamente o moralmente degradato –
ha sempre una sua dignità umana che deve essere rispettata e che impegna anzi la comunità tutta a
rimuovere quelle condizioni negative che rendono di fatto difficile l'esplicazione della sua piena umanità.
Anziché dividere l'umanità in "uomini e non", in uomini e sottouomini, la carta dei valori della
nostra comunità afferma che tutti hanno una eguale dignità e solennemente proclama non solo la libertà
dallo Stato (e cioè dai soprusi ed arbitri dei pubblici poteri) e la libertà nello Stato (riconoscendo sfere di
autonomia ai privati) ma anche la libertà attraverso e per mezzo dello Stato, impegnando gli organi della
Repubblica ad agevolare il superamento di tutti quei condizionamenti di fatto che impediscono
concretamente lo sviluppo della persona umana. Non può, perciò, lo Stato rinunciare a questo recupero
individuale e sociale e imboccare scorciatoie che si risolvono in una soppressione, o anche solo in una
emarginazione totale, di un essere umano.
Ed è importante sottolineare che la Costituzione chiama a questo compito di recupero non solo i
suoi organi istituzionali, ma tutti i cittadini a cui non solo vengono riconosciuti diritti, ma che sono anche
impegnati ad adempiere inderogabili doveri di solidarietà. È una norma, questa, dell'art. 2, troppo
trascurata e dimenticata, mentre costituisce anch'essa una delle idee forza della nostra convivenza, poiché
2
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
l'istituzione pubblica sarebbe sostanzialmente impotente a realizzare questo compito, gigantesco e
ambizioso, di aiutare le persone a ritrovarsi, se non potesse contare sulla collaborazione spontanea, nella
fraternità, di tutti i consociati.
IV – I principi costituzionali sono singolarmente coincidenti con alcuni principi cristiani
Questi principi, su cui si radica tutto il nostro assetto costituzionale, appaiono singolarmente
coincidenti con alcuni principi cristiani, troppo spesso dimenticati anche nel popolo di Dio:
a) per il cristiano ogni uomo ha un valore, perché ogni essere umano è immagine di Dio e
redimibile attraverso Cristo. La sua umanità può essere offuscata dal peccato, ma mai del tutto soppressa.
E l'impegno cristiano sta proprio nell'aiutare l'emergere di quanto di positivo è sempre esistente, anche se
nascosto, nella natura umana. Nella pedagogia di Dio non esiste il concetto di irreversibile
irrecuperabilità, perché ogni essere può sempre misteriosamente rispondere al richiamo d'amore.
b) per il cristiano i parossismo del desiderio di vendetta, come risposta al parossismo di sofferenza
da altri imposto, non può essere legittimato. Il male non si vince con il male, la morte con la morte. E
questo non solo e non tanto perché il cristiano è sempre chiamato al perdono, ma principalmente perché la
spirale del male può essere rotta solo innestando la spirale del bene. L'ottimismo del cristiano non si
radica su una ottusa negazione del male o su una incomprensione della realtà della vita, ma sulla certezza
che per vie misteriose la vita finisce sempre con il trionfare. La Sapienza ci assicura che "l'impresa
dell'empio passa come ombra e come notizia fugace, come una nave che solca l'onda agitata, del cui
passaggio non si può trovare traccia né scia della sua carena nei flutti".
c) per il cristiano ogni vita ha significato, perché la vita nella sua globalità ha significato. Dio
continua incessantemente ad operare nella Storia malgrado le insufficienze e i tradimenti umani e ripete
quotidianamente all'uomo il suo invito a corrispondere al suo dono di amore e ad essere fedele
all'impegno di collaborazione alla creazione attraverso la costruzione di una vita umana più giusta. Il
rispetto della vita nasce proprio da questo riconoscimento della vita come valore, da questo impegno a
conservare, assistere, migliorare la vita, perché la negatività assoluta, e cioè il male, è proprio il
distruggere, nuocere, ostacolare la vita.
d) per il cristiano la solidarietà tra tutti gli appartenenti al popolo di Dio è una realtà. E la sua
solidarietà non si realizza soltanto nella salvezza, ma è anche solidarietà nel peccato e nella redenzione,
Nessuno è del tutto esente dal peccato, nessuno può sentirsi puro e intemerato, per cui la rottura della
comunità fraternale non è mai esclusivamente addebitabile all'altro, ma in qualche modo anche a noi,
quanto meno perché colpevoli di omissioni. Il recente Sinodo – che ha fortemente proposto alla coscienza
cristiana non solo il tema del peccato individuale, ma anche quello del peccato collettivo – costituisce un
forte richiamo a sentirci corresponsabili di tanti fallimenti umani; ad avvertire anche la nostra
responsabilità per il male che è nel mondo; a sentirci chiamati ad assumerci in carico il peccatore per un
comune cammino di riconciliazione; a scoprirci non come la comunità degli onesti e dei sani che espunge
da sé – attraverso le mille forme di pratica scomunica – il reprobo, ma come comunità che vuole arrivare
alla pienezza accettando la non comunione che si cerca di far divenire comunione e "compatendo" il
peccatore non dall'alto di una farisaica integrità ma "patendo insieme" una comune agonia che solo può
portare alla comune salvezza.
V – La formula costituzionale "rieducazione" (della pena) nel linguaggio cristiano è riconciliazione
con Dio, con gli uomini e fra uomini
In questo quadro va determinata la funzione della pena.
Sono necessarie alcune brevi osservazioni:
a) il tema della funzione della pena è stato un tema costante nella riflessione umana ed esso si è
sostanzialmente articolato secondo due ottiche: una che guarda al passato, l'altra che guarda al futuro.
Seneca diceva "nam, ut Plato ait, nemo prudens punit, quia peccatum est sed ne peccetur". Non è certo il
caso di esaminare in questa sede le varie teorie sulla pena: da quella retributiva etica a quella retributiva
giuridica; da quella che affida alla pena la funzione di prevenzione generale, a quella che sottolinea
invece la funzione di prevenzione speciale; da quella che punta attraverso la pena all'emenda del reo e alla
sua rieducazione a quella che vede nella pena – o meglio nella misura di sicurezza – uno strumento di
3
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
profilassi sociale. È solo da sottolineare come tutte le teorie elaborate hanno una parte di verità che non
può essere trascurata, anche se ogni assolutizzazione di una di queste teorie non appare appagante. E
bisogna riconoscere che una seria e completa determinazione della funzione della pena non può che
ancorarsi ad una pluralità di motivi che si integrano tra loro.
b) ma per non rimanere in un discorso astratto è necessario esaminare quale è il fondamento della
pena per il nostro ordinamento costituzionale, perché da una esatta identificazione della portata della sua
definizione, deriva necessariamente la linea di tendenza da seguire sia nella previsione della tipologia
delle pene e delle condotte meritevoli di esse, sia la determinazione delle modalità esecutive della pena
stessa. Ora deve rilevarsi come la formula costituzionale, secondo cui la pena deve tendere alla
rieducazione del condannato, implica di necessità:
1. che si ripudia l'idea di vendetta quale criterio ispiratore della pena e quindi della sofferenza come fine
a se stessa;
2. che si ripudia pure l'idea che l'intervento penale è solo in funzione di una difesa della società, con la
conseguenza della ammissibilità di qualunque manipolazione dell'uomo pur di garantire l'ordinato
svolgersi della vita sociale;
3. che, adoperando il termine "rieducazione" e non quello di "risocializzazione", si intende sottolineare
come l'obiettivo da perseguire non è un meccanico adeguamento del punito a quelli che sono i valori
correnti, attraverso un'opera di condizionamento, ma è piuttosto quello di ricostruire una personalità,
il cui procedimento di crescita umana si è in qualche momento inceppato, e con esso la capacità di
scoprire in sé il valore e significato della propria umanità più autentica;
4. che si riconosce perciò che vi sono dei valori non da imporre ma da proporre; che è sempre possibile
un processo educativo e cioè un aiuto a crescere e ad accettare la realtà in sé e nei rapporti con altri;
che l'uomo può mutare e liberarsi; che può realizzarsi una riconciliazione non formale, ma sostanziale
tra società e condannato;
5. che, se la pena deve tendere alla rieducazione, non possono trovare posto nell'ordinamento né forme
di "terrorismo penale" né forme di "clementismo giustificatorio" che toglie responsabilità al singolo
per riversare tutte le colpe sulla società. Se è giustificata la reazione ad una antica tendenza che
riteneva l'uomo unico ed esclusivo responsabile di tutti i suoi atti, senza riconoscere che può essere
influenzato da situazioni esistenziali in cui si è trovato a vivere, non appare giustificata l'opposta
tendenza che considera la società responsabile di tutti i mali di cui soffrono gli individui e di tutti i
comportamenti che da essi possono essere posti in atto. La fallacia dell'antico atteggiamento non
giustifica l'erroneità di questa seconda posizione, che rende l'uomo irresponsabile, perché gli toglie
quella parte di libertà che gli resta e lo abbassa al livello di "robot"; che totalmente giustificandolo lo
conferma nel suo atteggiamento antisociale; che riconoscendo l'uomo solo come prodotto meccanico
di condizionamenti sociali pone le premesse per la sua "manipolazione" da parte di chi si erga a
demiurgo; che esclude ogni diretto aiuto in attesa della totale palingenesi. In realtà la pena è anche
una risposta al bisogno (che non è solo nella società, ma anche nel singolo che ha commesso il reato)
di giustizia e cioè di riaffermazione dei valori violati in sé prima che nella società; deve anche essere
la riaffermazione e il ristabilimento della superiorità del volere sociale rispetto al volere privato,
affinché si comprenda che non si ha bene privato fuori del quadro del bene comune.
c) Nel linguaggio cristiano la formula espressa dalla Costituzione può essere tradotta come lo
strumento che tende alla riconciliazione. Una riconciliazione in primo luogo con Dio, ma anche una
riconciliazione con i fratelli, attraverso un cammino di conversione in cui la persona umana è ricondotta
alla sua verità più profonda e, con il conseguimento dell'autentica libertà, resa capace di vivere secondo le
esigenze della propria dignità e dell'indispensabile e costruttivo rapporto con gli altri.
È da sottolineare come una autentica riconciliazione tra gli uomini implica un cammino di
conversione che non può essere unilaterale, ma che deve necessariamente essere compiuto insieme sia da
chi ha violato le regole sociali sia dall'intera comunità, resa cosciente delle insufficienze strutturali e
culturali che hanno quanto meno facilitato l'insorgere della tendenza al delitto.
VI – Il nostro sistema sanzionatorio è del tutto coerente con i principi costituzionali?
4
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
Se questa è la funzione tipica della pena, il primo problema da affrontare è quello se il sistema
sanzionatorio, previsto dal nostro ordinamento sostanziale, è coerente con questo disegno.
Anche qui è opportuna qualche breve osservazione.
a) Non sembra innanzitutto coerente con il precetto costituzionale – anche se non può ritenersi
incostituzionale – l'orientamento seguito dall'ordinamento di privilegiare tra le varie, possibili misure
sanzionatorie quella detentiva, ritenuta la più normale risposta al reato. E ciò appare particolarmente
preoccupante, perché assistiamo negli ultimi anni ad una perversa tendenza a criminalizzare una infinità
di comportamenti in quanto si sopravvaluta l'effetto dissuasivo della sanzione penale e si sottovaluta la
possibilità di ricorso a norme di incoraggiamento e di incentivazione per ottenere lo spontaneo
adempimento, da parte del cittadino, delle norme di comportamento utili alla civile convivenza.
È vero che gli ultimi provvedimenti di depenalizzazione hanno tentato di invertire questa
tendenza, ma deve riconoscersi che il legislatore è stato assai timido, e sostanzialmente restio, nel
trasformare molti reati in illeciti amministrativi e ad operare per una de–criminalizzazione di tanti
comportamenti. Comunque resta il fatto che in alternativa alla pena detentiva vi è solo, per pochi casi, la
pena pecuniaria che ha più carattere afflittivo che recuperativo e rieducativo.
Né sembrano perseguire un fine rieducativo le pene sostitutive introdotte nel nostro ordinamento
della legge n. 689 del 1981 (peraltro per casi assai limitati) perché esse abbandonando del tutto a se stesso
il condannato, ignorano qualsiasi opera di sostegno e di aiuto per un suo effettivo recupero e prevedendo
solo un intervento di controllo degli organi di polizia.
In realtà è venuto il momento di riconoscere che la detenzione carceraria, specie per reati di
limitata rilevanza sociale e che comportano pene brevi, anziché facilitare l'opera di rieducazione la rende
estremamente più difficile, quando non costituisce addirittura una forma di confermazione nel ruolo
delinquenziale del soggetto. E questo non solo e non tanto perché – come è stato detto – il carcere è la
scuola del delitto, se non l'università del crimine, in quanto nel carcere la criminalità organizzata fa opera
di ampio proselitismo e perché nel carcere si realizzano forme di collegamento delinquenziale che
diventano poi operative al momento della riconquista della libertà, quanto principalmente per motivi più
profondi:
• perché per lo più il soggetto che pone in essere comportamenti penalmente sanzionati è soggetto in
difficoltà ed alla ricerca di una sua identità e un suo ruolo: la etichettatura di delinquente e la sua
segregazione, insieme ad altri egualmente etichettati, può comportare una spinta addizionale al delitto
in quanto il soggetto si comincia a pensare come delinquente e ad organizzare il suo comportamento
in conformità;
• perché la segregazione del condannato dalla società non porta con sé la preoccupazione di rimuovere
le cause che stanno all'origine del comportamento criminoso, con la conseguenza che al termine
dell'espiazione della pena – essendo rimasto immutato il rapporto delle società e delle istituzioni nei
suoi confronti – il nuovo impatto con la vita sociale non può che riprodurre, spesso in modo
aggravato, la situazione di conflitto preesistente;
• perché questo avviene specialmente per i soggetti meno forniti di mezzi economici e meno provveduti
culturalmente che vedono per lo più annullata definitivamente la possibilità di un adeguato
reinserimento sociale, non avendo autonome risorse su cui contare.
Sarebbe perciò necessario identificare forme sanzionatorie alternative alla detenzione, che non si
risolvano però solo in sanzioni pecuniarie o in privazioni limitate della libertà personale (libertà
controllata in qualche modo) ma che piuttosto impongano l'adempimento di obblighi positivi a favore
della società (per esempio svolgimento di servizio civile presso organismi di volontariato): ciò eviterebbe
l'emarginazione carceraria e nel contempo ricollegherebbe la riconciliazione a fatti concreti di servizio
alla comunità consentendo una effettiva opera di sostegno all'opera rieducativa e una crescita del soggetto
all'interno del contesto sociale. Un maggior sforzo di inventiva – ed una maggiore adattabilità alle
necessità attuali – dovrebbero spingere in questa direzione.
b) Non sembra coerente col disegno costituzionale neppure la sostanziale fuga dalla sanzione che
oggi caratterizza l'intero sistema penale. Specie se si pone in evidenza il fatto che questa fuga dalla
sanzione è accompagnata, in modo sempre più massiccio, dal ricorso ad una sanzione anticipata rispetto
alla condanna, attraverso una carcerazione preventiva anche prolungata.
5
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
Bisogna infatti riconoscere che è ormai del tutto occasionale l'esecuzione di una pena a seguito di
regolare condanna: tra prescrizioni, provvedimenti di amnistia ed indulto, premi assai sostanziosi ai
cosiddetti pentiti, duplicazione della sospensione condizionale della pena, gioco della prevalenza delle
attenuanti sulle aggravanti, adozione delle varie misure alternative alla detenzione, assai scarsa è la
concreta probabilità che il condannato sconti effettivamente la pena conseguente al suo delitto.
Quel che appare incoerente non è tanto la rinuncia dello Stato alla esecuzione della pena detentiva
quanto il fatto che un simile "clementismo" alluvionale è del tutto occasionale e non finalizzato in alcun
modo né è accompagnato da alcun concreto aiuto al condannato, perché ritrovi la sua umanità.
In realtà l'uomo che ha posto in essere comportamenti penalmente responsabili viene abbandonato
a se stesso e alle sue difficoltà o, per meglio dire, al gruppo di solidarietà criminale, che resta l'unico a
continuare ad occuparsi concretamente di lui. Con il che il processo e la pena, sia pure scontata in misura
ridotta, hanno un valore pedagogico soltanto negativo, perché risultano espressione di ipocrisia,
debolezza, impotenza.
Emblematica appare la gestione giudiziaria della sospensione condizionale della pena, divenuta,
nell'accezione comune, un diritto per chi si vede irrogata una pena nei limiti di legge; utilizzata come
mera espressione di un potere indulgenziale, anche nei confronti di soggetti per i quali una indagine di
personalità si concluderebbe con una prognosi di non recidività, solo se alla sospensione si
accompagnasse un periodo di prova sostenuta da un concreto aiuto risocializzante; applicata con un
automatismo che prescinde da ogni garanzia e al di fuori di ogni controllo e assistenza al soggetto.
Nel contempo però si va accentuando la tendenza a utilizzare la carcerazione preventiva come
anticipazione di pena e come strumento di esemplarità e di prevenzione generale. Il che appare scorretto
sul piano costituzionale, perché finisce col violare la presunzione di innocenza; pedagogicamente
controproducente, perché la sanzione anticipata appare un puro arbitrio quando alla carcerazione
preventiva segua una assoluzione o l'applicazione di un indulto; inutile sul piano rieducativo dato che
questo periodo non può essere utilizzato per forme di sostegno alla ricostruzione della personalità, anche
perché appare difficile ottenere la collaborazione di un soggetto che non si sente ancora riconosciuto
colpevole.
c) Non del tutto coerente con il disegno costituzionale appare il sistema del doppio binario
adottato dal nostro codice, secondo cui, in alcuni casi, alla pena viene aggiunta una misura di sicurezza
non patrimoniale. Non è infatti facilmente comprensibile una duplicazione di sanzione avente
sostanzialmente analoga natura; assurdo, per i semi–imputabili, la esecuzione prima della pena e poi della
misura curativa; discutibile la indeterminatezza temporale della misura di sicurezza aggiunta alla pena,
perché si risolve sostanzialmente in una accentuazione a tempo indeterminato del carattere repressivo
della pena.
d) Non sembra neppure che il fine rieducativo possa essere effettivamente perseguito attraverso
l'applicazione obbligatoria delle pene accessorie che proiettano a lungo, alcune volte permanentemente, le
conseguenze della condanna. Per questo molto opportunamente il progetto di riforma della parte generale
del codice penale prevede "l'eliminazione dell'automatismo delle pene accessorie ed il carattere di
perpetuità dell'interdizione dai pubblici uffici ed ha reso possibile l'applicazione solo di alcune delle
privazioni che costituiscono questa sanzione accessoria semplificandone e riducendosi altresì l'elenco"
(dalla relazione). Ma la riforma si è persa nelle secche dell'attività parlamentare.
e) Perplessità – sulla congruità dell'attuale sistema penale – non possono non sorgere in relazione
alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, specie a seguito dell'inasprimento di esse effettuato
con la legge antimafia.
Non si discute qui l'opportunità politica delle previsioni in una situazione di aggressione sempre
più accentuata e arrogante della criminalità organizzata allo Stato: in una situazione di forte
emarginazione – in cui può essere messa in serio peri colo la stessa specifica esistenza di una convivenza
democratica – si possono comprendere forme di difesa, anche se non perfettamente ortodosse. Ma non
può non rilevarsi come ancora una volta le insufficienze complessive del sistema penale impongano di
imboccare scorciatoie non coerenti con i principi e suscettibili di ulteriori dilatazioni.
Il ricorso a misure di prevenzione legate più al sospetto di una attività criminosa che ad un
effettivo accertamento delle responsabilità dell'individuo: l'applicazione conseguente di misure
fortemente affilittive e ben poco rieducative (si pensi al soggiorno obbligato in comuni con meno di 5.000
6
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
abitanti che comporta solo una sorta di "morte civile"; si pensi al sequestro di beni anche appartenenti a
terzi, quando si presume che di essi abbia la disponibilità diretta o indiretta l'inquisito), tutto ciò non può
non essere guardato con preoccupazione, perché rischia di alimentare una tendenza che privilegia la
difesa sociale sul recupero del deviante, perché fa risorgere antiche e non accettabili tendenze alla
previsione dei cosiddetti reati di sospetto che consentono un intervento sanzionatorio, anche al di fuori di
quelle garanzie ritenute essenziali per l'irrogazione di una pena.
VII – Anche il sistema penitenziario sembra non sempre idoneo alla finalità rieducati va della pena
Anche il sistema penitenziario non sembra sempre del tutto idoneo ad assicurare quella funzione
della pena che così limpidamente è delineata dalla Costituzione. Non è certo possibile esaminare
compiutamente in questa sede un tale tema in tutte le sue implicanze, ma alcune osservazioni di fondo
devono essere fatte.
a) Il precetto costituzionale, secondo cui la pena non può consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità, può considerarsi sufficientemente attuato per quanto riguarda la posizione delle
istituzioni preposte al settore carcerario. Ma può affermarsi – con tranquilla coscienza – che nel mondo
carcerario la dignità della persona del condannato sia sempre salvaguardata dalla aggressione di soggetti
diversi da quelli istituzionalmente preposti alla sorveglianza? È purtroppo di comune conoscenza che nel
microcosmo carcerario la violenza del più forte sul più debole è purtroppo assai frequente. È la violenza
fisica che arriva non infrequentemente alla uccisione del ristretto in carcere (13 omicidi nell'80; 15
omicidi nei primi undici mesi dell'81); è la violenza sessuale assai diffusa specie nei confronti dei soggetti
più giovani con effetti dirompenti per una personalità spesso assai fragile; è la violenza psichica che
corrompe i soggetti meno provveduti da parte di soggetti o fortemente politicizzati o organicamente
inseriti in potenti associazioni criminali che possono perciò utilizzare tanto le minacce che le lusinghe,
per imporre la propria supremazia e costituire situazione di assoluta e indefinita dipendenza.
Non può non leggersi con profondo turbamento il dato che nel 1980 vi sono stati 40 suicidi tra i
detenuti e nel 1981, per alcuni mesi, ben 39 suicidi. Il che impone di riconoscere che se l'istituzione
carceraria non pratica direttamente trattamenti inumani, non è però in grado di evitare che, nell'ambito di
questa situazione di coercizione personale, i trattamenti inumani siano da altri praticati. Non costituisce
tutto ciò una pesante condanna di un sistema penitenziario nel suo complesso che finisce, al di là delle
intenzioni, con l'abbandonare chi gli è affidato, con l'esclusivo compito di rieducarlo, al sopruso del più
forte? Il recluso così, anziché trovare nella pena una occasione per un recupero di eticità, trova in essa
solo l'occasione di una ulteriore abiezione. E questo vale non solo per chi riceve il sopruso, ma anche per
chi lo fa, perché costui trova anche nella istituzione carceraria la conferma alla convinzione che nella vita
la violenza, l'utilizzazione degli altri per il proprio piacere, il disprezzo per l'altrui personalità sono la
legge fondamentale dei rapporti umani, e l'unica vincente.
b) Un tema particolarmente delicato è quello del rapporto tra sicurezza carceraria – rieducazione e
umanizzazione della pena.
Non può non riconoscersi che nelle carceri esistono soggetti detenuti che presentano un altissimo
rischio di pericolosità per gli altri detenuti e per la società (basta ricordare quanto abbiamo or ora detto). È
certamente necessario in questi casi distinguere tra precetto di umanità della pena – che deve trovare
applicazione anche nei confronti di questi soggetti – e precetto rieducativo che può essere effettivamente
perseguito solo quando, anche attraverso il decorso del tempo, la forte carica di aggressività si è venuta
decantando. Non si può infatti, in questi casi, né ricorrere a quegli strumenti rieducativi che sarebbero
utilizzati da questi soggetti solo per sottrarsi alla pena o per commettere nuovi reati, né eliminare la pena,
in quanto non in grado di realizzare la rieducazione, perché la sanzione diviene, anche nella sua semplice
funzione afflittiva, un mezzo per pervenire ad una situazione personale del soggetto che consenta di
svolgere in qualche modo la funzione rieducativa. Il problema vero è, in questo caso, quello di assicurare
modi umani di esecuzione della pena; di ricercare sempre, tra una pluralità di possibili sistemi per
conseguire un certo livello di sicurezza, quello che meno comprime gli spazi residuali di libertà del
condannato; di consentire qualche forma di controllo (attraverso il magistrato di sorveglianza?)
all'esercizio della discrezionalità amministrativa, nella determinazione della pericolosità del soggetto e
nella conseguente sua destinazione a istituti di massima sicurezza.
7
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
c) Bisogna anche riconoscere che al di là delle affermazioni di principio contenute nella legge di
riforma dell'ordinamento penitenziario – la cui filosofia appare del tutto condividibile – la realtà
esistenziale della condizione di vita del detenuto non appare tale da consentire effettivamente un adeguato
processo rieducativo del condannato. Ancora una volta dobbiamo lamentare l'esistenza di una perversa
tendenza legislativa che si accontenta di elaborare provvedimenti normativi assai raffinati nella
identificazione dei principi, ma che si disinteressa poi di predisporre strumenti adeguati, perché questi
principi possano essere calati nella realtà della vita.
Anche la legge penitenziaria è un triste esempio di queste "leggi manifesto" di cui è afflitta la
nostra vita istituzionale, di queste buone intenzioni elaborate dal legislatore (sempre più "uomo dei fini" e
sempre meno "uomo dei mezzi") di cui è lastricata la via dell'inferno della nostra realtà comunitaria. È per
esempio importante che l'art. 5 e l'art. 6 determinino in modo adeguato le caratteristiche degli edifici
penitenziari, sottolineando che devono essere tali da accogliere un numero non elevato di detenuti; ma è a
tutti nota la pesante discrasia tra le previsioni normative e la realtà per esempio del carcere
dell'Ucciardone o di Poggioreale.
È da sottolineare favorevolmente la norma dell'art. 10 che prevede la possibilità del detenuto di
passare un certo tempo della sua giornata all'aperto, ma non si può ignorare che – come ha riferito un
magistrato di sorveglianza – molti detenuti restano volontariamente nelle proprie celle per evitare, in un
carcere insicuro, i pericoli degli spostamenti. È sicuramente rieducativa la possibilità di svolgere attività
di istruzione (art. 19), ma non può non segnalarsi che alcune commissioni esaminatrici universitarie si
sono rifiutate di recarsi negli istituti penitenziari per consentire a detenuti–studenti di sostenere gli esami.
È importante la previsione del lavoro come strumento rieducativo ma sappiamo che esso è spesso
inutilizzabile per le insufficienti disponibilità di lavoro interno e per la tipologia di questo lavoro, spesso
improduttivo e avente connotazioni e modalità di esecuzione tali da non potersi ritenere né rieducativo né
risocializzante. È fondamentale la norma (art. 42) che fissa come criterio di massima la destinazione in
istituti prossimi alla residenza della famiglia, sia per assicurare un sostegno recuperativo sia per
consentire di mantenere significativi rapporti con il proprio ambiente di vita, ma sappiamo anche che la
norma è spesso elusa per ragioni organizzative, senza che al detenuto sia data la possibilità di reclamare
per un effettivo controllo sulla decisione amministrativa. Può essere assai utile la norma che impone la
separazione dei detenuti sulla base della tipologia del reato e dell'osservazione di personalità, ma
sappiamo anche che l'arcipelago delle strutture penitenziarie previsto è rimasto sulla carta.
Sono solo alcuni esempi, ma significativi, di quanta distanza esista fra affermazione di principi e
loro concreta attuazione.
d) È certo da sottolineare con estremo favore la tendenza a trasformare la esecuzione della pena
non in una mera attività custodialistica, ma in un procedimento individualizzato di trattamento finalizzato
alla rieducazione. Il regime dei permessi e del lavoro all'esterno nonché le misure alternative della
detenzione (affidamento al servizio sociale – semilibertà e licenze – liberazione anticipata) sono il segno
concreto di questa tendenza. Ma qualche osservazione deve anche in questo settore essere fatta.
• È necessario che tutte queste misure siano adottate nell'ambito di un preciso piano di recupero del
soggetto e non solo come ulteriore espressione di quella tendenza meramente "clementizia" di cui
abbiamo già parlato o peggio come "operazione sfollamento" di fronte alla ingovernabilità degli
istituti superaffollati, abdicando così di fatto all'obiettivo primario che con la pena si intende
perseguire.
• È essenziale che le prescrizioni per l'affidamento in prova, e il programma di trattamento per
l'ammesso al regime di semilibertà, abbiano non solo o non tanto contenuto di controllo e di garanzia,
quanto piuttosto valore di guida per facilitare effettivamente il positivo reinserimento del condannato.
Il che implica di necessità un coinvolgimento del soggetto primario dell'azione di recupero, poiché il
processo educativo non può essere mai eteronomo, ma esige l'attiva collaborazione del soggetto da
rieducare. Avviene invece per lo più che le prescrizioni e i programmi siano predisposti a tavolino e
imposti al soggetto, che finisce così con il non vederli come un serio impegno personale ad uscire
dalla situazione problematica in cui si trova. Così come avviene che le linee programmatiche, anziché
essere ampie e flessibili, come sarebbe opportuno che fossero, siano rigide e particolareggiate, astratte
e non proporzionate alle effettive forze del soggetto.
8
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
•
È indispensabile, perché la funzione rieducativa possa essere compiutamente espletata attraverso le
misure alternative, che anche la comunità esterna al carcere faciliti la funzione di reinserimento o
quanto meno non la ostacoli. Non sembra per la verità che la situazione sia in questo settore
particolarmente appagante, perché le strutture di servizio sociale degli Enti locali sono spesso o
inesistenti o inefficienti; perché le possibilità di lavoro per il detenuto sono assai scarse; perché la
comunità tutta non sempre comprende il significato di quest'opera di risocializzazione e tende ad
emarginare ancora il soggetto stigmatizzato dalla pena; perché spesso la comunità, che riceve il
soggetto in trattamento, è comunità diversa da quella di origine – perché l'istituto carcerario in cui è
ricoverato è lontano – e da ciò nascono diffidenze e pregiudizi; perché la disinformazione operata
dalla stampa – che ha sottolineato con particolare puntualità e compiacimento i casi di fallimento,
tacendo su quelli in cui il recupero si è verificato ha creato un allarme sociale in nome della difesa dei
"buoni" dai pericoli che vengono dai "cattivi" e ciò costituisce un effettivo e drammatico ostacolo ad
accettare tendenze di umanizzazione della pena e di recupero del deviante e con esse ogni possibilità
di gestione non meramente burocratica e clementizia di queste misure.
VIII – Necessità del rapporto tra carcere e società
Quest'ultima osservazione impone un maggiore approfondimento di un tema essenziale per la
rieducazione del condannato e cioè quello del rapporto tra carcere e società. Anche qui è necessario
procedere solo per brevi accenni, data la vastità e complessità del tema.
a) La comunità tende molto spesso a ritenere che il problema della criminalità non la riguardi
direttamente né nel momento genetico del delitto, né nel momento recuperativo del deviante. Il tema della
criminalità è visto solo come l'esigenza della comunità dei "buoni" di essere adeguatamente tutelata, con
ogni mezzo, dalla aggressione di coloro che non ne condividono valori e norme di comportamento. Si
ritenga il delinquente un "mostro" o lo si ritenga un prodotto sociale – ma di una società astratta, fatta da
"altri" e che "altri" devono difendere – gli uomini che compongono la comunità concreta non si ritengono
assolutamente coinvolti in questo problema. E perciò l'intervento nei confronti della criminalità deve
essere esclusivamente dei "politici" per la prevenzione; della polizia e della magistratura per la
repressione; dei tecnici per la risocializzazione.
Ma una società astratta non esiste, essendo la comunità fatta sempre ed esclusivamente da una
somma di esseri umani che in modo diverso, ma egualmente incidente, creano le comuni condizioni di
vita (si pensi alla mancata assistenza nei con fronti dei soggetti in difficoltà, specie se minori; si pensi alla
costruzione di un costume e di una cultura che incentivizzano o no comportamenti devianti). Ed il
controllo sociale che riduce l'area della criminalità è costituito non solo o non tanto dal controllo
istituzionale, oltre tutto assai difficile in società complesse come quelle attuali, ma principalmente in quel
controllo spontaneo che viene esercitato dai gruppi sociali nei quali ciascuno è costantemente inserito: la
critica, la censura e l'aiuto da una parte e il consiglio, l'esempio, l'incoraggiamento dall'altra sono
altrettanti mezzi che, nel reticolo dei rapporti interpersonali nei quali ciascuno è calato, consentono di
controllare il comportamento e di spingere o inibire certe azioni.
Né può trascurarsi che la devianza minorile – che costituisce spesso il momento genetico della
criminalità adulta – è sempre espressione di un insufficiente o interrotto processo educativo, la cui
responsabilità non cade solo sulla famiglia, ma anche sul più vasto ambiente sociale che è restato del tutto
indifferente di fronte alla situazione di disagio espressa dal minore, anche con il suo comportamento.
E l'integrale recupero del condannato non può ovviamente avvenire se la comunità, a cui
appartiene, lo segrega e lo emargina durante l'esecuzione della pena e gli si mostra ostile o indifferente
quando rientra nella vita sociale, con nessun problema risolto, ma anzi con un sovraccarico di problemi
conseguenti alla detenzione.
È perciò indispensabile che la comunità tutta senta come suo il problema della prevenzione e del
recupero della criminalità e che perciò attivamente coadiuvi le strutture istituzionali in questa opera,
abbandonando il deleterio meccanismo della delega deresponsabilizzante per tutti
b) Ma ciò comporta innanzi tutto che l'Ente locale, e le sue strutture di servizi, sappiano
adeguatamente rispondere anche a questi compiti di prevenzione e recupero della devianza.
La filosofia che è alla base dell'attribuzione al comune, singolo o associato, di rilevanti compiti in
materia di assistenza alle famiglie dei detenuti, di assistenza post penitenziaria, di interventi a favore dei
9
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
minorenni (D.P.R. n. 616 del 1977) si radica proprio sulla considerazione che solo nella più ristretta
comunità di base è possibile avvertire l'insorgere del bisogno, individuare con tempestività le risposte alle
esigenze della persona, realizzare le opportune strutture di sostegno, chiamare le persone a collaborare.
Purtroppo non sempre questa filosofia è stata ben compresa. Infatti:
• molto spesso l'attribuzione di queste competenze è stata letta solo come una forma di decentramento
amministrativo dei servizi e non come lo spostamento di una funzione politica, nel senso più nobile
della parola, per risolvere alla radice i problemi dei cittadini e della qualità della vita comunitaria, il
che è più facile nel ristretto ambito sociale;
• i tradizionali mali di una assistenza di tipo burocratico e clientelare non sono svaniti nel passaggio
dagli Enti nazionali a quelli locali, ma se mai si sono accentuati per una insufficiente cultura
dell'intervento e per la sostanziale impreparazione degli operatori in questi settori di avanguardia, che
richiedono grande capacità professionale e creativa;
• la pressione di una comunità ostile a sentire come suo il problema del recupero del deviante ha portato
i Comuni, da una parte a vedere l'intervento in termini di versamento esclusivo di un sussidio
economico e dall'altra a porsi spesso in polemica con l'amministrazione penitenziaria, rifiutando
l'inserimento di istituti carcerari nel proprio territorio, il che ha comportato difficoltà nella
smobilitazione dei grandi istituti carcerari inidonei ad assicurare una vita umana ai detenuti;
• il D.P.R. n. 616 è stato letto dagli Enti locali come l'attribuzione di un compito esclusivamente di
assistenza post–carceraria, senza tener conto del fatto che ogni forma di assistenza post–carceraria
non può non iniziare al momento stesso in cui inizia l'esecuzione. Senza una attività di formazione
professionale, di avvio al lavoro, di assistenza durante la detenzione è difficile impostare un serio
reinserimento non traumatico nella comunità alla fine del periodo di detenzione. È del resto per questo
che l'ordinamento penitenziario fa riferimento alla partecipazione esterna per l'opera di
risocializzazione, delineando così non solo un carcere che guarda fuori delle sue mura per trovare
termini di riferimento, ma anche ad un mondo esterno che sappia guardare al carcere non come un
momento di totale segregazione, ma come una occasione per ripiegarsi sulla situazione di un suo
membro ferito sulla strada di Gerico della vita.
Purtroppo questa collaborazione non è facile perché la gestione delle carceri è divenuta
particolarmente calda per motivi di sicurezza; perché una vecchia cultura delle funzioni degli Enti locali
rende difficile la comprensione di questa funzione nuova e qualificante; perché la dimensione dei
Comuni, e le loro difficoltà finanziarie, rendono poco agibili queste nuove attribuzioni.
c) Se l'Ente locale, con le sue strutture profondamente rinnovate, deve prendersi carico dei
problemi dei detenuti, ciò esso potrà fare solo se, dietro l'espressione organizzatoria e istituzionalizzata
del Comune, vi è una comunità viva che sa effettivamente interessarsi dei problemi dei suoi membri. Il
che significa non tanto avere un atteggiamento tollerante e benevolo nei confronti del deviante; significa
anche e soprattutto esprimere quella attenzione particolare fatta di aiuto a comprendere, e al tempo stesso
di controllo e sostegno, per recuperare chi ha bisogno di essere aiutato a maturare un atteggiamento
critico rispetto alle sue originarie scelte delinquenziali ed a risolvere rilevanti problemi di personalità. Ma
ciò la comunità non può fare delegando questo compito solo ad alcuni soggetti particolarmente
vocazionati.
Il volontariato, come gli stessi cappellani, non possono assumere su di loro tutti i compiti che sono
propri della intera comunità; e la comunità civile e la comunità religiosa non può ritenersi assolta da ogni
impegno in questo settore, solo perché alcuni dei suoi membri, nell'indifferenza se non nell'ostilità degli
altri, si preoccupa di quest'opera fondamentale di riconciliazione. Perché l'opera di questi benemeriti
operatori possa avere reale successo è indispensabile che vi sia un retroterra che li appoggia e sostiene;
che ne coadiuvi l'azione con iniziative concrete; che si apra all'accoglienza del deviante, ritessendo quella
rete di relazioni strutturanti di cui l'isolato uomo di oggi – pur nel formicolio dei grandi agglomerati
urbani – ha un assoluto bisogno.
Mai come oggi è necessaria una lettura molto diversa del termine assai abusato di partecipazione,
perché questa espressione non può e non deve significare solo un controllo da parte del cittadino della
funzionalità delle istituzioni o la possibilità di far più facilmente pervenire le proprie istanze alle
istituzioni o peggio ancora la possibilità di rivendicare sempre nuovi diritti o di penetrare così nella stanza
dei bottoni.
10
CONSIGLIO PASTORALE NAZIONALE – 1983
Partecipare significa essenzialmente chiamare tutti a collaborare al disegno comune, coinvolgere
ciascun consociato nel comune compito di sviluppo delle singole personalità, realizzare una più fitta e
penetrante rete di rapporti intersoggettivi non meramente formali.
Significa superare la cultura del disimpegno, dell'utilitarismo, della negatività della chiusura
egoistica che tanti danni ha prodotto nel nostro paese. Significa vivere l'esigenza di condividere in pieno
la condizione umana dei soggetti più deboli della nostra società; di superare le barriere dell'egoismo che
condannano tanti esseri umani alla impotenza e alla marginalità; di considerare la propria vita e la propria
storia saldate con la vita e la storia degli altri; di abbandonare le categorie del profitto e del tornaconto
personale che sembrano costituire le uniche coordinate su cui si svolge la vita sociale; di riscoprire
l'attenzione per l'altro, accettato per quello che è e non per quello che può dare.
Ha detto un filosofo russo che delle tre istanze della rivoluzione francese sono state realizzate
quelle di libertà ed eguaglianza, ma che questo è il momento di realizzare quella della fraternità senza la
quale le prime due resterebbero solo proclamate e non concretamente vissute.
L'impegno di tutti oggi deve essere in questa costruzione di una reale fraternità per superare il
deserto di solitudine in cui ci tocca vivere; per rifondare una vita a dimensione umana; per assicurare così
non solo una effettiva dignità umana ai nostri fratelli ma anche una autentica dignità umana anche a
ciascuno di noi.
11