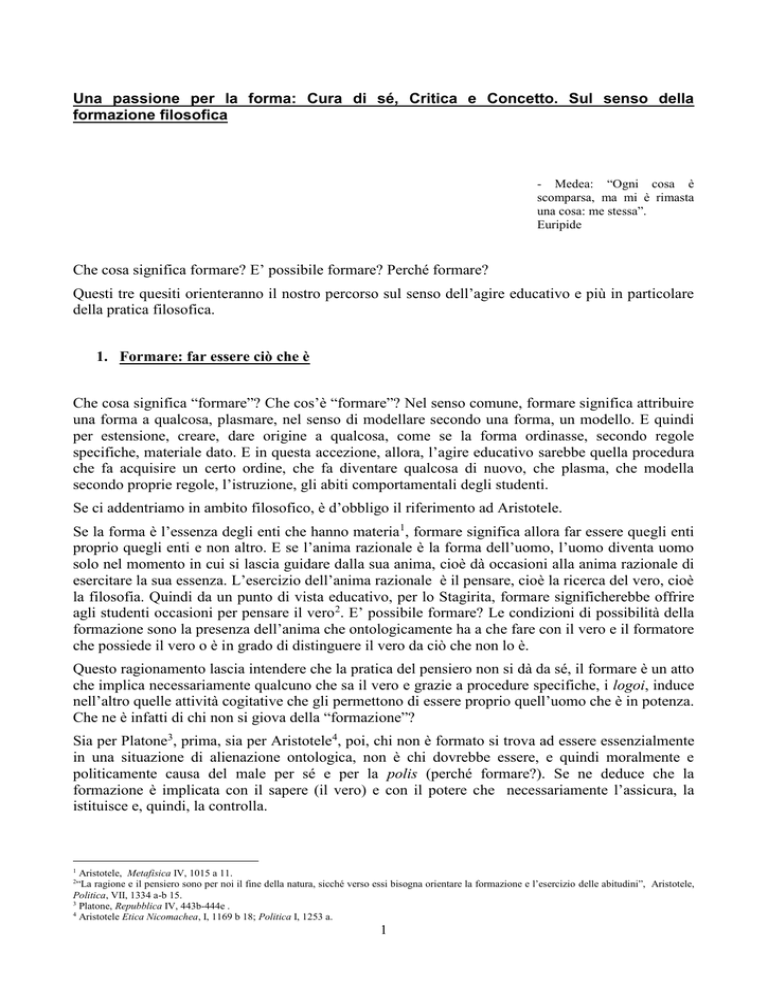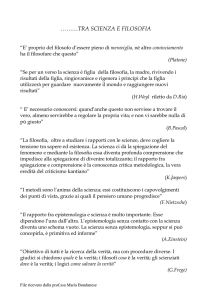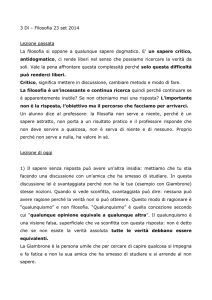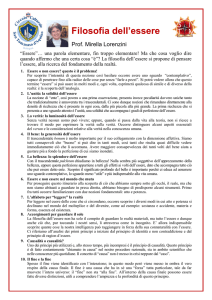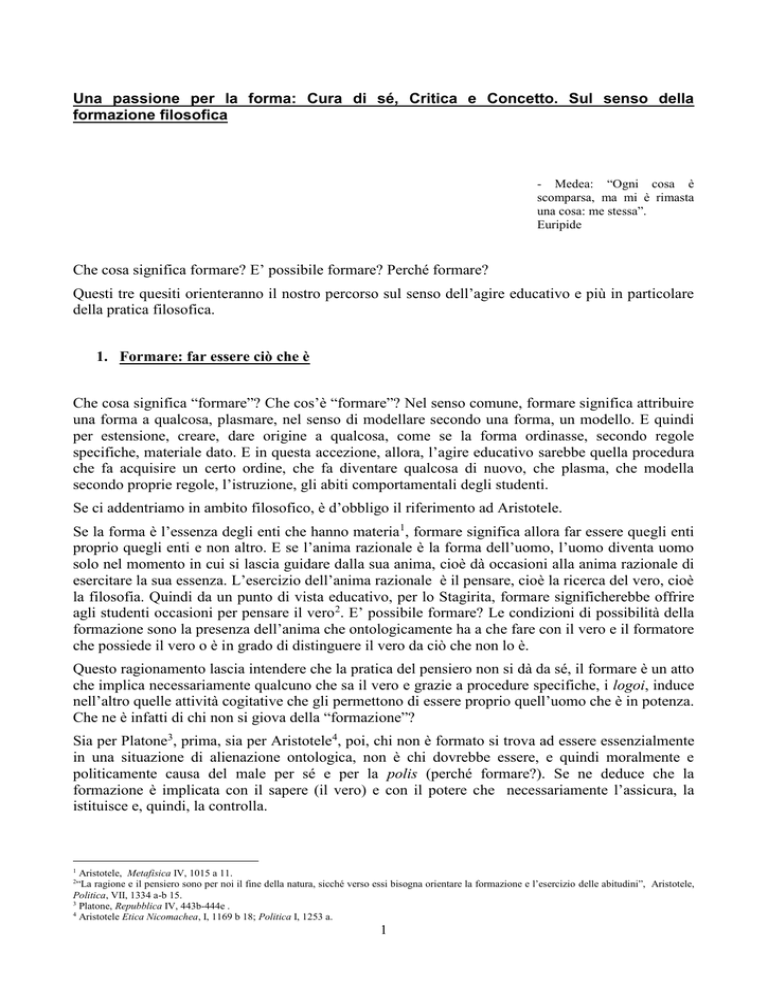
Una passione per la forma: Cura di sé, Critica e Concetto. Sul senso della
formazione filosofica
- Medea: “Ogni cosa è
scomparsa, ma mi è rimasta
una cosa: me stessa”.
Euripide
Che cosa significa formare? E’ possibile formare? Perché formare?
Questi tre quesiti orienteranno il nostro percorso sul senso dell’agire educativo e più in particolare
della pratica filosofica.
1. Formare: far essere ciò che è
Che cosa significa “formare”? Che cos’è “formare”? Nel senso comune, formare significa attribuire
una forma a qualcosa, plasmare, nel senso di modellare secondo una forma, un modello. E quindi
per estensione, creare, dare origine a qualcosa, come se la forma ordinasse, secondo regole
specifiche, materiale dato. E in questa accezione, allora, l’agire educativo sarebbe quella procedura
che fa acquisire un certo ordine, che fa diventare qualcosa di nuovo, che plasma, che modella
secondo proprie regole, l’istruzione, gli abiti comportamentali degli studenti.
Se ci addentriamo in ambito filosofico, è d’obbligo il riferimento ad Aristotele.
Se la forma è l’essenza degli enti che hanno materia1, formare significa allora far essere quegli enti
proprio quegli enti e non altro. E se l’anima razionale è la forma dell’uomo, l’uomo diventa uomo
solo nel momento in cui si lascia guidare dalla sua anima, cioè dà occasioni alla anima razionale di
esercitare la sua essenza. L’esercizio dell’anima razionale è il pensare, cioè la ricerca del vero, cioè
la filosofia. Quindi da un punto di vista educativo, per lo Stagirita, formare significherebbe offrire
agli studenti occasioni per pensare il vero2. E’ possibile formare? Le condizioni di possibilità della
formazione sono la presenza dell’anima che ontologicamente ha a che fare con il vero e il formatore
che possiede il vero o è in grado di distinguere il vero da ciò che non lo è.
Questo ragionamento lascia intendere che la pratica del pensiero non si dà da sé, il formare è un atto
che implica necessariamente qualcuno che sa il vero e grazie a procedure specifiche, i logoi, induce
nell’altro quelle attività cogitative che gli permettono di essere proprio quell’uomo che è in potenza.
Che ne è infatti di chi non si giova della “formazione”?
Sia per Platone3, prima, sia per Aristotele4, poi, chi non è formato si trova ad essere essenzialmente
in una situazione di alienazione ontologica, non è chi dovrebbe essere, e quindi moralmente e
politicamente causa del male per sé e per la polis (perché formare?). Se ne deduce che la
formazione è implicata con il sapere (il vero) e con il potere che necessariamente l’assicura, la
istituisce e, quindi, la controlla.
1
Aristotele, Metafisica IV, 1015 a 11.
“La ragione e il pensiero sono per noi il fine della natura, sicché verso essi bisogna orientare la formazione e l’esercizio delle abitudini”, Aristotele,
Politica, VII, 1334 a-b 15.
3
Platone, Repubblica IV, 443b-444e .
4
Aristotele Etica Nicomachea, I, 1169 b 18; Politica I, 1253 a.
2
1
Ma il soggetto che deve appropriarsi delle forme non è egli stesso già condizionato da una serie di
norme, (forme), che definiscono le sue possibilità in generale? Infatti un conto è sostenere che il
soggetto deve essere in grado di far sue le forme e ciò significa che queste ultime sono già là,
esterne e lontane al soggetto, ma, al tempo stesso, conformi alla sua natura ontologica, per cui
compito del soggetto è quello di farle proprie per diventare ciò che è; un altro è sostenere che le
forme decidono anticipatamente su chi è il soggetto e ciò significa che sono “certe forme” e non la
sua situazione ontologica a decidere del soggetto.
Se, schematicamente, la ricostruzione è corretta, la questione si complica cioè chiede che si
approfondisca la dimensione antropologica e che ci si inoltri nell’ontologia sociale. La domanda che
si impone è allora questa: “Che vuol dire che la formazione è implicata con il sapere e con il potere?
Mi farò guidare dalla riflessione di Foucault perché è il filosofo che con più insistenza ha posto al
centro delle sue analisi i legami tra il sapere e il potere.
2. Formare: produrre corpi docili
In Sorvegliare e punire5 Foucault argomenta che le società moderne sono “disciplinari”, cioè
fondate su sistemi di saperi fortemente specializzati e strettamente connessi e, proprio in ragione di
questo, la disciplina non può riferirsi ad una istituzione unica o ad un apparato deputato al controllo
perché è un meccanismo di potere che attraversa tutti gli ordini istituzionali, è una tecnologia che
tatticamente si avvale di ogni livello e ambito sociale: il manicomio, gli ospedali, le prigioni, le
scuole, le fabbriche…. In una conferenza del 1976 pronunciata presso la Facoltà di Filosofia di
Bahia a proposito del concetto di disciplina Foucault diceva che:
“La disciplina è il meccanismo di potere con cui riusciamo a controllare gli elementi più sottili del
corpo sociale, a raggiungere gli stessi atomi sociali, cioè gli individui. Tecniche di
individualizzazione del potere. Come sorvegliare qualcuno, come controllarne la condotta, il
comportamento, le attitudini, come intensificare la sua prestazione, moltiplicare le sue capacità,
come collocarlo nel posto in cui sarà più utile: ecco cos'è, per me, la disciplina”6.
Se la disciplina è meccanismo del potere, occorre chiedersi che cosa sia il potere. Il potere è un
rapporto di forze. Dove si esercita il potere? “Il potere”, dice Foucault, “si è addentrato nel corpo,
esso si trova esposto nel corpo stesso”7. Il potere è essenzialmente realtà effettuale cioè si esercita.
Per esercitarsi deve istituire un sistema di regole, che operando su spazi materiali ne determina il
significato. In altri termini, il potere, in quanto esercizio, produce il suo spazio e in esso definisce le
cose: pone i fatti e ne determina la verità. I discorsi disciplinari, il dire il vero, non sono, come
direbbe Heidegger, il lasciare che le cose appaiono alla luce così come esse sono, ma è una
produzione di un sapere che deve rendere riconoscibile il potere, deve svelare le sue regolarità e le
sue norme. Deleuze8, leggendo Foucault, sintetizza in altri termini: “Se sapere consiste
nell’intrecciare il visibile e l’enunciabile, il potere ne è la causa presupposta; ma inversamente il
potere implica il sapere come quella biforcazione, differenziazione, senza la quale non passerebbe
all’atto”. Ogni dispositivo ha il suo regime di luce, la maniera in cui essa cade, si diffonde
distribuendo il visibile e l’invisibile, facendo essere o meno l’oggetto che non può esistere senza di
esso. Allo stesso modo ogni dispositivo ha il suo regime di enunciati che definisce una scienza, per
esempio la psichiatria, un genere letterario o un movimento politico.9
5
M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1976.
Archivio Foucault, n 3, "Le maglie del potere 1981", Milano, Feltrinelli, 1998, p. 162.
7
M. Foucault, Microfisica del potere, Einaudi, Torino, 1977, p. 138.
8
G. Deleuze, Foucault, Cronopio, Napoli, 2002.
9
“ Non esiste relazione di potere senza correlativa costituzione di un campo di sapere, né di sapere che non supponga e non costituisca allo stesso
tempo relazioni di potere”. M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit,. p. 31.
6
2
Foucault sostiene che il potere, esprimendo una funzione produttiva, esercita la sua potenza non
annullando ciò che lo avversa e lo compromette, ma riducendolo a sé, emendando e integrando
l'"eccesso" sino a renderlo strutturante per le strategie che lo compongono 10. Siffatte strategie
consistono in tecniche e tecnologie che non riflettono tracotanza centrando tutto sull'obbligazione
fisica, è vero invece, che penetrano il corpo introducendo nello stesso un' anima che lo assoggetta,
minimizzando l'intervento di una forza deterrente e violenta e comunque esterna. Lo spessore di
quest'anima non è sostanziale; è l'esito di articolazioni ed effetti di un potere che genera coscienze
alterando e costituendo le fisiologie dei corpi dall'interno. Tuttavia, se pur priva di sostanza,
Foucault attribuisce all'anima la struttura terminale della signoria che il potere esercita sul corpo che
da questa è agito. L'uomo è abitato e condotto all'esistenza da questo elemento. L'anima, prigione
del corpo: “Non bisognerebbe dire che l'anima è un'illusione, o un effetto ideologico. Ma che esiste,
che ha una realtà, che viene prodotta in permanenza, intorno, alla superficie, all'interno del corpo,
mediante il funzionamento di un potere che si esercita su coloro che vengono puniti in modo più
generale su quelli che vengono sorvegliati, addestrati, corretti, sui pazzi, i bambini, gli scolari, i
colonizzati, su quelli che vengono legati ad un apparato di produzione e controllati lungo la loro
esistenza (...) Quest'anima reale e incorporea, non è minimamente sostanza; è l'elemento dove si
articolano gli effetti di un certo tipo di potere e il riferimento di un sapere, l'ingranaggio per mezzo
del quale le relazioni di potere danno luogo a un sapere possibile, e il sapere rinnova e rinforza il
potere”11.
È evidente, a questo punto, che l’ontologia sociale di Foucault capovolge il discorso della
formazione che abbiamo impostato. Infatti affermando che il potere non solo assoggetta i corpi con
la costituzione di un'anima, ma ha necessità di produrre i saperi che definiscono concetti che
rendono conoscibile questa realtà, psiche, soggettività, verità, coscienza ecc.., la formazione (che
cos’è la formazione?) diventa il dispositivo “delle strategie pedagogiche con cui l'educazione attraverso le pratiche scolastiche - forma i soggetti.”12 E’ il dispositivo che forma il soggetto, è la
natura del potere che rende il soggetto proprio quel soggetto tramite forme specifiche. Il soggetto è
quindi sottoposto ad una manipolazione, ad una “formazione” che lo rende docile e sottomesso al
potere, governamentalizzato13. In questo senso la prigione, fungendo da analogia per i dispositivi di
potere, non è l'espressione deterrente della forza della legge, che priva della libertà chi la legge la
infrange, ma in realtà fabbrica anime in corpi infami: “La mia ipotesi è che la prigione è stata, sin
dall'origine, legata ad un progetto di trasformazione degli individui. Si crede in genere che la
prigione fosse una sorta d'immondezzaio dove ammassare criminali, i cui inconvenienti si sarebbero
all'uso rivelati tali da indurre a dirsi che bisognava riformare le prigioni e farne uno strumento di
trasformazione degli individui. Non è vero: i testi, i programmi, le dichiarazioni d'intenzione stanno
là, sin dall'inizio; la prigione doveva essere uno strumento altrettanto perfezionato della scuola,
della caserma dell'ospedale, ed agire con precisione sugli individui (...) Il fallimento è stato
immediato, e lo si è registrato quasi contemporaneamente al progetto stesso. Fin dal 1820 si consta
che la prigione, lungi dal trasformare i criminali in gente onesta, non serve che a fabbricare nuovi
criminali o a sprofondarli ancora di più nella criminalità. La prigione fabbrica i delinquenti, ma i
delinquenti sono in fondo utili, dal punto di vista economico come da quello politico14 .
10
11
Maglietta, Morfologie del potere e società disciplinare in Foucault: l'impossibile personalismo in politica, in www.cooperweb.it/focusonline
M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit, p. 33.
12
A. Mariani, Foucault: per una genealogia dell'educazione, Liguori, Napoli, 2000, p. 17.
“Con questa parola “governamentalità” intendo tre cose: 1) l’insieme costituito dalle istituzioni, procedure, analisi e riflessioni, calcoli e tattiche
che permettono di esercitare questa forma molto specifica sebbene molto complessa di potere che ha per bersaglio la popolazione, per forma principale di sapere l’economia politica, per strumenti tecnici essenziali i dispositivi di sicurezza. 2) La tendenza, che in tutto l’Occidente non ha smesso di
condurre, e da molto tempo, verso la preminenza di questo tipo di potere, che si può chiamare il governo, su tutti gli altri: sovranità,
disciplina, ecc., il che ha condotto da una parte allo sviluppo di tutta una serie di apparati specifici di governo e dall’altra allo sviluppo
di tutto un insieme di saperi. 3)11 processo, o piuttosto il risultato del processo attraverso il quale lo Stato di giustizia del Medio Evo, diventato nel
XV e XVI sec. Stato amministrativo, si è trovato a poco a poco «governamentalizzato»”. Foucault, Poteri e strategie, Mimesis, Milano, 1999, p. 65.
14
M. Foucault, Microfisica del potere, cit, p. 121.
13
3
Il diagramma15, esposizione dei rapporti di forza che costituiscono il potere, connette visibile ed
enunciabile rendendo possibile l'ordine di un discorso panottico, così come il diagramma illumina
il rapporto tra Ragione e Follia alterato all'alba della modernità da un Cogito che percepisce la
s-ragione come l'anti-ragione, come l'altro da sé da recludere ed espellere. L’internamento non ha
alcuna motivazione medica, è un atto di potere “è un’istanza dell’ordine monarchico e borghese che
si organizza in Francia in questa stessa epoca”16. La Follia non compare d’un colpo; essa prende
figura clinica e si forma tramite la concomitanza di ordini discorsivi eterogenei, che entrano in
collusione tra loro e vicendevolmente si condizionano e si forzano.17
Il potere, produttore di anime che incorpora in “nature dementi”, spiega la nascita della psichiatria e
il moltiplicarsi degli oggetti che appartengono alla Follia: “Queste figure immemorabili, che il
potere mette in gioco, sono eventi disciplinari: discipline, poiché in esse si struttura il sapere;
discipline perché rendono docili e impiegano corpi ed anime”18.
Da ciò consegue che il diagramma, come formalizzazione della teoria dei poteri, è leggibile nel
dato che il folle, il malato, il detenuto, il militare, lo scolaro, sono dei corpi che vengono attanagliati
da un'anima che non scelgono, da forme che preesistono alla loro, parlanti un linguaggio composto
da parole che da questi si lasciano dire. Il diagramma fonda la condizione umana: l'uomo, in
definitiva, è solo una tragica comparsa all'interno di un copione già scritto, in un ordine simbolicosemantico - le forme - che già denomina il mondo, significante in un universo già significato. Colui
che sa il vero, che dice il vero, si muove in un ambito di potere: “ la verità non è al di fuori del
potere, né senza potere (…). La verità è di questo mondo, essa è prodotta grazie a molteplici
condizioni. E vi detiene effetti obbligati di potere. Ogni società ha il suo regime di verità, la sua
politica generale della verità”.19 E’ il diagramma che produce realtà, “produce campi di soggetti e
rituali di verità”.20 Rispondiamo in questo modo alle altre domande che ci hanno guidato: è
possibile formare? Perché formare?
Ciò che rende possibile la formazione è un corpo reso docile da un’anima che è “l'ingranaggio per
mezzo del quale le relazioni di potere danno luogo a un sapere possibile, e il sapere rinnova e
rinforza il potere”21. Il formatore è l’agente, a volte inconsapevole, del potere che necessita di corpi
docili per potersi esercitare. La docilità del corpo si ottiene con le discipline intese come metodi di
addestramento, di cura del corpo e di impiego del tempo, sono “vera e propria arte del corpo
umano” reso tanto più utile quanto più è docile22. Il potere disciplinare che si dà tramite il formatore
ha come caratteristica cruciale quella di addestrare e allo stesso tempo di “specificare le moltitudini
confuse”, analizzandole fino a che non ottiene le “singolarità necessarie e sufficienti”, ovvero le
“piccole cellule separate” dell’identità individuale.23 Se prendiamo l'analisi foucaultiana sulla
Conduite des écoles chrétiennes o sul Traité sur les obligations des frères des Écoles chrétiennes di
Jean-Baptiste de La Salle, la nostra lettura sulla formazione risulta corretta. Infatti la scuola si
presenta come una organizzazione disciplinare e di addestramento fondata sulla regolamentazione
spazio-temporale delle varie attività scolastiche: ad ogni allievo un posto assegnato; la funzione dei
banchi e delle aule; il rapporto di dominio tra maestro e allievo; l'economia dei tempi di
apprendimento e di ricreazione; la categorizzazione e l'unificazione di allievi con lo stesso livello di
competenze; la ripartizione di valori e meriti; l'esame e la valutazione con i rispettivi premi e
castighi.24 Tutto questo trasforma i corpi e li rende docili al potere che passa attraverso di essi. Ma il
discorso del potere, come abbiamo più sopra ricordato, non è costrizione violenta (o non soltanto
15
G. Deleuze, Foucault, cit., p. 55.
M. Foucault, Storia della follia in età classica, Rizzoli, Milano, 1976, p. 73.
Ivi, pp. 118-119.
18
S. Natoli, Vita buona, vita felice, Feltrinelli, Milano, 1990, p. 80.
19
M. Foucault, Microfisica del potere, cit., p. 25.
20
M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit, p. 212.
21
Ivi, p. 33.
22
Ivi, p. 150.
23
Ivi, p. 186.
24
A. Mariani, Foucault: per una genealogia dell'educazione, cit., p. 47.
16
17
4
questo) o pura ideologia. È produzione di sapere e sua applicazione dal corpo dei soggetti singoli a
quello - macroscopico - della società.25
La questione si fa quindi più complessa. Il soggetto è solo un correlato alienato dei dispositivi di
sapere e potere al cui interno il soggetto attinge ed esaurisce la sua identità imposta, esterna al di
fuori della quale non esiste altra salvezza che non nella follia, nel crimine o nella letteratura?
Se il potere produce “forme” di verità, è possibile concepire un potere della verità che non sia più o
non solo, verità di potere, che sia invece una verità che sgorga da linee di fuga, come le
chiamerebbe Deleuze, di resistenza, anziché da linee integrali di potere? In altre parole il destino
dell’uomo è già tutto giocato dal dispositivo sociale? E’ possibile pensare una formazione che
“deformi” i corpi docili?
Di nuovo Foucault a fare strada.
3. Formare: circo-scrivere o la cura di sé
I dispositivi - dice Deleuze26, leggendo Foucault - hanno come componenti linee di visibilità, di
enunciazione, linee di forza, linee di soggettivazione, di fenditura, linee di incrinatura, di frattura
che si intrecciano e si aggrovigliano tutte. Se il dispositivo è questo insieme multilineare, composto
da linee di diversa natura, ciò induce a pensare che questa “matassa”27 non circoscrive sistemi
omogenei, l’“oggetto”, il “soggetto”, il “linguaggio”, ecc., ma segue direzioni, traccia processi in
perenne disequilibrio. Ogni linea è soggetta a variazioni, è biforcante: gli oggetti visibili, gli
enunciati dicibili, le forze di potere in esercizio, i soggetti, in continua tensione, in continuo
“divenire molteplice”. In particolare Foucault, a partire dagli anni Ottanta, studiando le tecniche di
esistenza morale messe in atto dai Greci e dai Romani, approfondisce la questione del soggetto in
relazione ai dispositivi, scoprendo che il soggetto si forma, storicamente, non solo in una dinamica
di assoggettamento, che implica un rapporto a una serie di codici, prescrizioni, norme, “forme”, che
lo governamentalizzano, ma anche in un più generale processo di critica. In altri termini, il
“soggetto-individuo emerge sempre e solo nel punto in cui si incrociano una tecnica di dominazione
e una tecnica di sé”28. Questo significa che il processo di soggettivazione non svela un soggetto
astorico la cui essenza implica un’originaria libertà che, tramite forme opposte al potere, riesce a
far-essere, non pone un soggetto universale sulle cui pratiche riflessive si autofonda, ma tematizza
un soggetto che si “circoscrive”29 a partire da processi sociali di normalizzazione, di alienazione.
Questa “circo-scrizione” di sé ha luogo all’interno di dispositivi storicamente dati, che precedono ed
eccedono il soggetto e che quindi definiscono i limiti del “circo-scrivere” stesso; e d’altra parte, per
la natura del dispositivo stesso, questa “circo-scrizione” definisce, a sua volta, i limiti dei dispositivi
aprendo le porte ad altri.30 Nelle parole di Deleuze,31il processo di soggettivazione si dà all’interno
Questo non significa che la formazione neghi l’intelligenza dei soggetti, significa, piuttosto che piega l’intelligenza ad un certo tipo di forme, anzi
le intelligenze diventano uno degli strumenti fondamentali per rafforzare le forme di un dispositivo. Essere formati in un dispositivo, quindi, non
significa non essere intelligenti, significa mettere l’intelligenza al servizio del dispositivo stesso.
26
G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo, Cronopio, Napoli, 2007, p. 20.
27
Ivi, p. 11.
28
F. Gros, Nota del curatore, in M. Foucault, Ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 473.
29
M. Foucault, L’uso dei piaceri, Feltrinelli, Milano, 1984, p. 33.
30
“Un’azione, per essere detta morale, non deve limitarsi a un atto o a una serie di atti conformi a una regola, à una legge o a un valore. Se è vero che
ogni azione morale implica un rapporto con il reale in cui si compie e un rapporto con il codice cui si riferisce, è vero altresì che essa implica un certo
rapporto con se stessi, e questo rapporto non è semplicemente coscienza di sé, bensì costruzione di sé come soggetto morale: un processo in cui
l’individuo circoscrive la parte di sé che costituisce l’oggetto di questa pratica morale, definisce la propria posizione in relazione al precetto cui
ottempera, si prefigge un certo modo d’essere che varrà come compimento morale di sé, e, di conseguenza, agisce su se stesso, comincia a conoscersi,
si controlla, si mette alla prova, si perfeziona, si trasforma. Non c’è singola azione morale che non si riferisca all’unità di una condotta morale. Non
c’è condotta morale che non richieda la costituzione di sé come soggetto morale. E non c’è costituzione del soggetto morale senza dei modi di
soggettivazione e senza un ascetica o delle pratiche del sé che li sostengano. Una azione morale è indissociabile da queste forme di attività su se
stessi”. Ibidem
25
5
di un dispositivo: esso “deve farsi, nella misura in cui il dispositivo lo lascia o lo rende possibile. E’
una linea di fuga. Sfugge alle linee precedenti, se ne fugge. Il Sé non è né un sapere né un potere. E’
un processo di individuazione che si esercita su gruppi o su persone e si sottrae ai rapporti di forza
stabiliti come pure ai saperi stabiliti: una sorta di plusvalore (…). Ciò che si soggettivizza non sono
solo gli uomini nobili, quelli che secondo Nietzsche dicono « noi i buoni…», ma anche in altre
condizioni, gli esclusi, i cattivi, i peccatori, oppure gli eremiti, le comunità monastiche o anche gli
eretici: tutta una tipologia di formazioni soggettive all’interno di dispositivi mobili. E dappertutto
grovigli da sciogliere: produzione di soggettività che sfuggono ai poteri e ai saperi di un dispositivo
per reinvestirsi in quelli di un altro, sotto nuove forme che ancora devono nascere”. Alla
governamentalizzazione è associata la questione inversa del “come non essere governati in questo
modo, in nome di questi principi, in vista di tali obiettivi e attraverso tali procedimenti”32. In altre
parole ancora, se è vero che un regime di verità, decide a priori le forme di “come io posso essere”,
è altrettanto vero che non potrà mai costringere del tutto queste forme, cioè il soggetto non è deciso
meccanicisticamente dai dispositivi di potere e sapere, sebbene questi forniscano l’orizzonte per
ogni agire del soggetto. Il soggetto si “circo-scrive” grazie all’esercizio della critica che può esistere
solo in relazione a qualcosa di diverso da sé: “è strumento, mezzo per un avvenire o una verità che
non conoscerà e che non sarà, essa è uno sguardo su un campo in cui intende mettere ordine senza
poter dettar legge”33. Il soggetto, tramite la critica, mette in discussione un regime di verità che, in
quanto tale, assoggetta, cioè governamentalizza, ma mettere in discussione dispositivi di verità
significa anche mettere in dubbio la verità su di sé, cioè dar conto di sé, prendersi cura di sé. Se
forme di soggettività non alienate sono possibili ciò è dovuto, allora, all’esercizio di pratiche
critiche che riflettono sui modi e sulle condizioni in cui avviene l’assoggettamento, che
coraggiosamente spingono il soggetto a “dire la verità”- parresia - su se stesso, mettendo a
repentaglio ogni sua intelligibilità e riconoscibilità.
Che cosa vuol dire, allora, formare in questo nuovo contesto? Cosa rende possibile la formazione?
Perché formare?
Formare significa de-assoggettare i corpi docili, significa costruire occasioni in cui il soggetto si
“circo-scriva”, cioè possa “resistere” alla governamentalizzazione. Ciò è reso possibile dalla
irriducibilità del soggetto alla normalizzazione dei dispositivi del potere e del sapere e dalla messa
in atto di pratiche critiche che rendono il soggetto “libero”. Formare diventa, pertanto, un agire
etico-politico diretto alla liberazione di sé e dell’altro. Infatti poiché prendiamo sempre parte, siamo
“gettati”, direbbe Heidegger, in relazioni di potere “dobbiamo sempre praticare un’etica della
libertà su un duplice fronte: quello della nostra libertà dal governo di tutti e di ciascuno, e quello
della libertà degli altri dal potere irreversibile che potrebbe esercitarsi pure attraverso di noi,
anche se non ce ne rendiamo conto”34.
La questione rimanda ad una complessità ulteriore. Che cosa significano le espressioni “dire la
verità” e “critica” in un contesto già dato? Se l’esercizio critico e veritativo che Foucault guadagna
analizzando le tecniche discorsive e morali del mondo greco-romano non possono declinarsi nelle
nostre relazioni sociali, in quanto storicamente diverse, siamo inseriti in altri dispositivi, che valore
possono avere tali “forme” di soggettivazione per la nostra “liberazione”? Che cosa vuol dire deassoggettare oggi i nostri corpi docili? Quale ruolo può giocare la pratica filosofica? Quale il senso
della pratica filosofica nella modernità “liquida”, nella globalizzazione dei dispositivi tecnici delle
società del controllo?
Cercheremo di rispondere alle questioni che si sono imposte partendo sempre da Foucault ma
trovando sostegno nelle riflessioni di Deleuze e di Baumann.
G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo,.cit., p. 17-20, mia sottolineatura.
M. Foucault, Illuminismo e critica, Donzelli, Roma, 1997, p. 37.
33
Ivi., p. 35.
34
O. Marzocca, Perché il governo, Manifestolibri, Roma, 2007, p. 201.
31
32
6
4. Foucault: dire la verità e critica
4.1 Dire la verità
Per Foucault la verità indubbiamente esiste, così come esiste il potere di condizionamento e quello
di dominazione. Il problema verte sulle loro relazioni, sul loro intrecciarsi. Infatti, come abbiamo
detto sopra, non si dà né potere che incontri resistenza, né libertà che non si opponga a un qualche
potere. Di conseguenza risultano capaci di dire la verità i soggetti che sono liberi, cioè inseriti in
una certa rete di pratiche di potere contro cui resistono. Discorso e verità35 scandaglia, in un tempo
storico ristretto, il mondo greco-romano, le interdipendenze tra dispositivi di potere e verità.
Nell’accezione positiva, quella che a noi interessa, dire il vero in greco si dice parresiazestai . La
parresia è una specie di attività verbale in cui il parlante ha uno specifico rapporto con la verità
attraverso la franchezza, una certa relazione con la propria vita attraverso il pericolo, un certo tipo
di relazione con se stesso e con gli altri attraverso la critica (autocritica o critica di altre persone), e
uno specifico rapporto con la legge morale attraverso la libertà e il dovere. Più precisamente, “la
parresia è un’attività verbale in cui un parlante esprime la propria relazione personale con la verità,
e rischia la propria vita perché riconosce che dire la verità è un dovere per aiutare altre persone (o se
stesso) a vivere meglio. Nella parresia il parlante fa uso della sua libertà, e sceglie il parlar franco
invece della persuasione, la verità invece della falsità o del silenzio, il rischio di morire invece della
vita e della sicurezza, la critica invece dell’adulazione, e il dovere morale invece del proprio
tornaconto o dell’apatia morale. Questo, in linea generale, è il significato positivo della parola
parresia nella maggior parte dei testi greci in cui essa ricorre, dal V secolo a.C. al V secolo d.C”36.
Negli scritti di Platone, Socrate appare nel ruolo del parresiastes. Infatti discute costantemente per
strada con gli ateniesi e, come viene fatto notare nell’Apologia, rivela loro la verità, esortandoli ad
avere cura della saggezza, verità e perfezione delle loro anime. Allo stesso modo, nell’Alcibiade
maggiore, Socrate assume nel dialogo un ruolo parresiastico. Mentre gli amici e gli amanti di
Alcibiade lo lusingano, nel tentativo di ottenere i suoi favori, Socrate rischia di provocarne le ire
quando lo conduce all’idea che prima di governare Atene e di diventare più potente del re di Persia,
prima che sia capace di prendersi cura di Atene, deve imparare a prendersi cura di sé. La parresia è
così associata al tema della cura di sé (epimeléia eautou) a tal punto che venne considerata dalle
scuole ellenistiche essenzialmente come una techne di guida spirituale per l’“educazione
dell’anima”.
Il ruolo filosofico, secondo Foucault, richiedeva tre tipi di attività parresiastica, tutti strettamente
connessi: 1) nella misura in cui il filosofo doveva scoprire e insegnare certe verità circa il mondo, la
natura ecc., egli assumeva un ruolo epistemico; 2) nel prendere posizione verso la città, le leggi, le
istituzioni politiche, assumeva un ruolo politico; 3) l’attività parresiastica comportava anche la
necessità di pensare la natura delle relazioni tra la verità e il proprio stile di vita, tra la verità e
un’etica e un’estetica del sé. Da queste lezioni è possibile aggiungere un’altra caratteristica
fondamentale e cioè che “la riflessività del sé è sempre sollecitata da un altro, è cioè attraverso il
discorso di qualcun altro che si è indotti a riflettere su di sé”37. In altri termini il gioco parresiastico
si dà nella relazione con l’altro, “l’interlocutore di Socrate deve stabilire una qualche prossimità”38,
in particolare il filosofo si prende cura della narrazione dell’altro permettendogli di soggettivarsi
nella verità. In questo rapporto con Socrate, l’interlocutore è condotto dal discorso socratico a dar
conto di sé. Render conto di sé, della propria vita, del proprio bios, non significa autoaccusarsi,
denunciare le proprie colpe, ma essere “capaci di mettere in luce una relazione tra il discorso
35
M. Foucault, Discorso e verità, Donzelli, Roma, I ristampa, 1997.
Ivi, pp. 9-10.
37
J. Butler, Critica della violenza etica, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 167.
38
M. Foucault, Discorso e verità, cit., p. 63.
36
7
razionale, il logos, che si è in grado di usare, e il modo in cui si vive”39. La parresia, così come essa
appare nel campo dell’attività filosofica nella cultura greco-romana, è “una pratica”, che cerca di
modellare le specifiche relazioni che gli individui intrattengono con se stessi. Più precisamente il
criterio decisivo per identificare un parresiartes è nell’armonia che in lui si realizza tra il logos e il
bios. Infatti, dopo la crisi della democrazia ateniese, l’obiettivo della parresia non è di persuadere
l’assemblea, ma di convincere qualcuno della necessità di prendersi cura di sé e degli altri; e ciò
significa che egli deve “cambiare la sua vita”, i logoi parresiastici costringono a modificare il sé,
spingono al processo di soggettivazione. Questo tema del cambiamento di vita, della conversione,
diviene molto importante dal IV secolo a.C. agli inizi del cristianesimo. E’ un tema essenziale alle
pratiche filosofiche parresiastiche. Naturalmente la conversione non è qualcosa di completamente
diverso dal cambiamento di opinione che un oratore, usando la parresia, vuole indurre quando
chiede ai suoi concittadini di svegliarsi, di rifiutare ciò che fino ad ora hanno accettato, o di
accettare ciò che fin qui hanno respinto. Ma nella pratica filosofica la nozione del cambiare
atteggiamento assume un significato più generale ed esteso, poiché non è più soltanto questione di
modificare le proprie opinioni o convinzioni, ma è questione di cambiare il proprio stile di vita, il
rapporto di sé con gli altri, e degli altri con se stessi.
Queste pratiche parresiastiche, come dimostra Foucault, implicano un complesso insieme di legami
tra la verità e il sé. Non solo infatti si presume che esse forniscano all’individuo la conoscenza di sé,
ma è questa conoscenza di sé che si suppone possa garantire l’accesso alla verità e a ulteriori
conoscenze: “Il circolo che comporta la conoscenza della verità a proposito di se stessi come
presupposto per poter conoscere la verità in generale è caratteristico della pratica parresiastica a
partire dal IV secolo, ed è stato uno dei luoghi problematici del pensiero occidentale, presente per
esempio in Cartesio o in Kant”40. Possiamo quindi sostenere che il diventare soggetto chiede giochi
discorsivi di verità, contestualizzati e promossi all’interno di una relazione di cura, una relazione
formativa in cui ci si espone all’altro. Tale esposizione garantisce, perché induce un cambiamento,
la scoperta della verità, quel processo di “circo-scrizione” di sé che mette in crisi il dispositivo di
forze che normalizza, che aliena, che rende i corpi docili. E’ proprio in Ermeneutica del soggetto41
che Foucault ribadisce tale ipotesi: “Insomma, nella verità, e nell’accesso a essa, c’è qualcosa che
realizza il soggetto stesso, che realizza l’essere stesso del soggetto, o che lo trasfigura. Credo che si
possa dire, in breve, che mai, per la spiritualità, un atto di conoscenza, in sé e di per sé, potrebbe
riuscire a dare accesso alla verità se prima non sia stato preparato, raddoppiato, portato a compimento da una certa trasformazione del soggetto non dell’individuo, ma del soggetto stesso nel suo
essere di soggetto”. E questa “trasfigurazione” avviene in un contesto interlocutorio, in una cornice
di atti pratici agiti dal filosofo per e nei confronti di qualcun altro, in vista della liberazione di sé.
Ma Foucault sottolinea che questa pratica di verità non è più della modernità. Infatti la storia della
verità è entrata nella sua epoca moderna solo il giorno in cui si è ammesso che è la conoscenza, e la
conoscenza solamente, a consentire l’accesso alla verità e a fissare le condizioni in base alle quali il
soggetto può avere accesso ad essa: quel che consente di avere accesso alla verità è diventata la
conoscenza stessa, ed essa sola. A partire, cioè, dal momento in cui il filosofo (o lo scienziato, o
anche solo chi cerca la verità), è diventato capace di riconoscere la verità, e ha potuto avere accesso
ad essa, in se stesso, e in virtù dei suoi soli atti di conoscenza, senza che da lui si esiga più
nient’altro, ovvero senza che il suo essere di soggetto debba essere modificato o alterato in alcun
modo. Ciò non significa, naturalmente, che la verità possa essere ottenuta senza condizioni, solo che
ormai si tratta di condizioni che appartengono a due ordini che non hanno più nulla a che fare con la
cura di sé. Da un lato vi sono, infatti, le condizioni interne dell’atto conoscitivo e delle regole che
esso deve rispettare per avere accesso alla verità. Si tratta delle condizioni formali, delle condizioni
oggettive, delle regole formali del metodo, della struttura dell’oggetto da conoscere. Dall’altro lato,
39
Ibidem.
Ivi, p.70
41
M. Foucault, Ermeneutica del soggetto, cit., pp. 19-21.
40
8
invece, vi sono condizioni di carattere estrinseco. Si tratta di condizioni come la formula secondo
cui “è necessario non essere folli per conoscere la verità.”42 Ma si tratta anche di condizioni
culturali, come quella che dice che per aver accesso alla verità bisogna aver fatto degli studi, aver
ricevuto una determinata formazione, far parte di una comunità scientifica in cui vige un certo
consenso. A partire da un tale momento, ovvero a partire dal momento in cui è diventato possibile
dire che “così com’è, il soggetto risulta in ogni caso capace di verità”, da quando cioè l’essere del
soggetto non è più rimesso in questione dalla necessità di avere accesso alla verità, Foucault
sostiene che siamo entrati in un’altra età della storia dei rapporti tra la soggettività e la verità. Per
come ormai essa appare, la verità non è più capace di salvare il soggetto.
Se definiamo, seguendo Foucault, la spiritualità come la forma che possiedono quelle pratiche che
postulano che il soggetto, così come esso è, non è capace di verità, ma che la verità, come e in
quanto tale, è capace di trasfigurare e salvare il soggetto, potremo allora dire che l’età moderna dei
rapporti tra soggetto e verità è iniziata il giorno in cui abbiamo stabilito come postulato che, così
come esso è, il soggetto è capace di verità, e che la verità, così com’è, non è capace di salvare il
soggetto. Siamo ben lontani da quando Filodemo usava l’espressione “to di’allelon sozesthai” per
riferirsi alle pratiche parresiastiche: “salvarsi gli uni con gli altri”. Infatti la parola sozesthai,
salvarsi, nella tradizione epicurea, significava procurarsi l’accesso alla vita buona, bella e felice.
Nella salvezza del singolo, gli altri hanno un ruolo decisivo, in quanto agenti necessari della
scoperta della verità circa se stesso e quindi aiutarlo alla conquista della vita buona.43
Perché mai è così importante il sapere su di sé? Perché genera una trasfigurazione in termini di
libertà? Foucault risponderebbe rifacendosi a Plutarco e a Epitteto: se si è in grado di discernere
esattamente che cosa si è, chi si è, adottando un atteggiamento di continua sorveglianza rispetto a
tutte le nostre rappresentazioni, allora si sta fermi su se stessi, si sta ancorati su di sé e non si sarà in
balia di altro. Per saper-si e mantenere la circo-scrizione di sé ci si dovrebbe comportare verso se
stessi come “un artigiano, o un artista che –di tanto intanto- si ferma , esamina quello che sta
facendo, si ripete le regole dell’arte e le rapporta al lavoro fin qui compiuto”44.
Proviamo a rispondere alla domanda che ci ha guidato: Che cosa significa “dire la verità” in un
contesto dato?
Gli scritti foucaultiani insistono che dire la verità è un’operazione di resistenza, una modalità di
opposizione al contesto alienante e in quanto tale conduce ad un de-assoggettamento. L’antichità
greco-romana trova nella cura di sé la condizione della trasfigurazione necessaria per accedere alla
verità con esiti di liberazione, la modernità invece trova nella sola conoscenza la condizione di
verità, ma non generando esiti di salvezza.
Se in epoca moderna il soggetto è capace di verità, ma tale verità non è più un sozesthai, che ne è
della liberazione del soggetto? Non è l’epoca moderna l’epoca della Riforma, dell’affermazione del
diritto naturale, della rivoluzione scientifica e più in generale dell’affermazione di una cultura che
vuole l’uomo uscire da uno stato di minorità?
42
M. Foucault, Storia della follia in età classica, cit., p.70.
M. Foucault, Discorso e verità, cit, p. 76.
44
Ivi, p. 110.
43
9
4.2 Critica
Per rispondere agli interrogativi che si sono evidenziati dobbiamo fare riferimento ai brevi scritti in
cui Foucault si confronta con Kant: Illuminismo e critica. Una lezione su “Che cos’è
l’Illuminismo?” di Kant45.
Una prima definizione generale del concetto di critica è la seguente: “l’arte di non essere
eccessivamente governati”.46 Foucault sostiene che di fronte al grande processo di
governamentalizzazione, caratteristico della società europea occidentale, che si impone a partire dal
XVI sec., si faccia strada un atteggiamento critico che può essere espresso nella formula “come non
posso essere governato in questo modo”. Espressione storica di questa rivendicazione emancipativa
sono: la messa in discussione del magistero della Chiesa e un ritorno alla Scrittura; messa in
discussione del governo e dell’obbedienza da esso pretesa con l’opposizione di diritti universali a
cui qualsiasi governo dovrà sottomettersi; messa in discussione del principio d’autorità e
l’affermazione di nuovi criteri di verità. Se la governamentalizzazione designa la pratica di
assoggettamento mediante meccanismi di potere e di verità, la critica designa il movimento
attraverso cui il soggetto si riconosce il diritto di interrogare la verità nei suoi effetti di potere e di
sapere; la critica è l’arte “dell’indocilità ragionata”47.
Foucault ritiene che il concetto di critica da lui concepito possa accostarsi non tanto al concetto di
critica kantiana quanto a quello di Aufklärung48dello stesso filosofo. Infatti, a parere di Foucault,
Kant caratterizzerebbe l’Aufklärung in rapporto a uno stato di minorità nel quale sarebbe tenuta, in
maniera autoritaria, l’umanità; inoltre definirebbe questa minorità come un’incapacità dell’umanità
di servirsi del proprio intelletto senza la direzione di un altro; infine, ed è l’aspetto per Foucault più
significativo, questa incapacità è pensata attraverso una correlazione tra un’autorità che esercita un
eccesso di potere e dall’altra qualcosa che ha a che fare con una mancanza di coraggio (sapere
aude). Secondo Foucault, tra Aufklärung e critica nel sistema kantiano esisterebbe uno scarto49.
Infatti la critica sarà quella che dirà al sapere: “sai bene fin dove sei in grado di sapere? (…) la
critica dirà, in sostanza, che la nostra libertà è messa meno in gioco da ciò che affrontiamo, con più
o meno coraggio, che dall’idea che ci facciamo della nostra conoscenza e dei suoi limiti”50. Questo
scarto sarebbe all’origine delle due grandi tradizioni critiche fra le quali si è divisa la filosofia
moderna. Da un lato Kant ha fondato quella tradizione filosofica che solleva il problema delle
condizioni alle quali è possibile una conoscenza vera, l’ “analitica della verità”51; dall’altro lato è
stata fondata un’altra tradizione critica che domanda “qual è il campo attuale delle esperienze
possibili? Qui non è in gioco un’analitica della verità; si tratta di ciò che si potrebbe chiamare
un’ontologia del presente, un’ontologia di noi stessi”52. E’ in questa seconda accezione che si gioca
la liberazione del soggetto, che, a mio parere, si può accostare alla pratica parresiastica: è
l’Aufklärung che fonda pratiche di liberazione, di resistenza al potere. Cerchiamo di spiegare.
Lo stesso Foucault in Ermeneutica del soggetto sembra suggerirci che la situazione romana sia
quella alla quale può essere avvicinata maggiormente la condizione dell’uomo contemporaneo.
Nella romanità dei primi due secoli dopo Cristo, la dimensione limitata e controllabile dello spazio
pubblico ‘locale’, tipica della pòlis, è stata riassorbita dalla dimensione ‘globale’ del sistema
imperiale. Perciò, l’uomo che riflette sulla sua condizione riconosce che nell’accedere alla vita
45
Contenuto in M. Foucault, Poteri e strategie, cit.
M. Foucault, Illuminismo e critica, cit., p. 38.
Ivi., p. 40
48
“Quel che Kant descriveva come Aufklärung, è esattamente ciò che intendevo descrivere come critica.” Ivi., p. 41.
49
Foucault si rende conto che si potrebbe facilmente dimostrare che per Kant il vero coraggio di sapere invocato dall’Aufklärung consiste nel
riconoscere i limiti della conoscenza e che l’autonomia è ben lontano dall’essere opposta all’obbedienza ai sovrani, tuttavia rimarca come per Kant la
critica ha come compito originario, “come prolegomeni ad ogni Aufklärung presente e futura, di conoscere la conoscenza”. Ivi , p. 43.
50
Ivi, p. 42.
51
M. Foucault, Una lezione su “Che cos’è l’Illuminismo?” di Kant, cit., p. 126.
52
Ibidem.
46
47
10
politica dovrà fare i conti con una quantità di relazioni imprevedibili, rischiose, fortemente
gerarchizzate. Seneca, rivolgendosi a Lucilio, funzionario imperiale in Sicilia, gli ricorda le ragioni
che gli permettono di comportarsi bene nell’esercizio della sua carica: egli riesce in questo scopo
poiché si preoccupa costantemente di accompagnare allo svolgimento della sua funzione l’otium e
le lettere, ovvero un tempo libero di riflessione dedicato a se stesso. È questo tempo libero lo strumento che gli consente di porre un limite all’esercizio del suo potere. È l’otium — dice Foucault —
a tener lontano l’individuo dal “delirio di presunzione di un potere che risulta debordante rispetto
alle sue funzioni reali. Tutta la sovranità che esercita, questo tipo di individuo la colloca in se
stesso, all’interno di sé, o più esattamente entro un rapporto di sé con se stesso”53. In questo senso la
cura di sé si configura come una “critica vissuta di ogni potere totalizzante. Essa implica
necessariamente l’esigenza della limitazione del potere”.54 La cura di sé è un riflettere su di sé, sulle
proprie possibilità di resistenza in relazione ad un’interrogazione del presente.
L’Aufklärung pone a problema l’attualità: “Che cosa accade oggi? Che cosa accade ora? E che
cos’è questo “ora” all’interno del quale noi tutti siamo, e che definisce il momento in cui scrivo?”55.
La domanda dell’ Aufklärung verte su ciò che questo presente è, su ciò che ha attualmente senso per
una riflessione filosofica. Pertanto “dire la verità” e “critica” sono strategie de-assoggettanti
fortemente irrelate ai dispositivi di potere-sapere. Noi apparteniamo a dei dispositivi e agiamo in
essi. In ogni dispositivo bisogna distinguere ciò che siamo, la normalizzazione, e ciò che possiamo
divenire, il nostro divenire altro. In ogni dispositivo “dobbiamo districare le linee del passato
recente e quelle del prossimo futuro: ciò che appartiene all’archivio e ciò che appartiene all’attuale
(…) non predire, ma essere attenti allo sconosciuto che bussa alla porta”56. La filosofia allora viene
intesa come quella pratica discorsiva con la sua propria storia che problematizza, nella forma della
“critica” e del “dire la verità”, l’attualità. L’attualità è ciò che viene interrogata “in quanto evento,
come avvenimento di cui la filosofia deve dire il senso, il valore, la singolarità filosofica e in cui
deve trovare a un tempo la propria ragione d’essere e il fondamento di ciò che dice” 57. A questo
punto possiamo intendere meglio le parole che Foucault può pronunciare circa il valore delle analisi
storiche della “critica” e “del dire la verità”: “L’analisi dell’archivio comporta dunque una regione
privilegiata, che è al tempo stesso vicina a noi, ma differente dalla nostra attualità ed è il bordo del
tempo che circonda il nostro presente, che lo sovrasta e lo indica nella sua alterità; è ciò che sta
fuori di noi e ci delimita. La descrizione dell’archivio sviluppa le sue possibilità (e la padronanza
delle sue possibilità) a partire dai discorsi che hanno appena cessato di essere nostri; la sua soglia di
esistenza è instaurata dalla frattura che ci separa da ciò che non possiamo più dire, e da ciò che cade
fuori della nostra pratica discorsiva; incomincia con l’esterno del nostro linguaggio; il suo luogo è
lo scarto delle nostre pratiche discorsive. In questo senso vale come nostra diagnosi. Non perché ci
permetta di fare il quadro dei nostri tratti distintivi e di tracciare in anticipo la figura che avremo in
futuro. Ma ci distacca dalle nostre continuità; dissipa quella identità temporale in cui amiamo
contemplarci per scongiurare le fratture della storia; spezza il filo delle teleologie trascendentali; e
laddove il pensiero antropologico interrogava l’essere dell’uomo o la sua soggettività, essa fa
brillare l’altro e l’esterno. Così intesa, la diagnosi non stabilisce la constatazione della nostra
identità mediante il meccanismo delle distinzioni. Stabilisce che noi siamo differenza, che la nostra
regione è la differenza dei discorsi, la nostra storia la differenza dei tempi, il nostro io la differenza
delle maschere”58. In ogni dispositivo dobbiamo districare le linee del passato recente e quelle del
futuro prossimo: ciò che appartiene all’archivio e ciò che appartiene alla diagnosi. In altri termini
l’analisi dell’archivio di ciò che siamo stati, serve a far luce su ciò che potremo essere.
53
M. Foucault, Ermeneutica del soggetto, cit., p. 337.
O. Marzocca, Perché il governo, cit, . p.201.
55
M. Foucault, Una lezione su “Che cos’è l’Illuminismo?” di Kant, cit, pp. 115-116.
56
G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo, cit., p. 29.
57
M. Foucault, Una lezione su “Che cos’è l’Illuminismo?” di Kant, cit, p. 117.
58
M. Foucault, L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1971, p. 152.
54
11
Se abbiamo guadagnato, dunque, che il dire la verità e l’esporsi con la critica permettono al
soggetto di contrapporsi ai dispositivi di potere e sapere e che l’analisi dell’”archivio” ci permette di
prendere in considerazione le nostre maschere, i nostri possibili divenire altro, si impone nella sua
crucialità la seguente domanda: in quale dispositivo abitiamo? Quale lo spazio per il nostro divenire
altro, per le nostre differenze?
Con tali questioni ci avviciniamo al problema del senso della pratica filosofica. Per descrivere il
dispositivo in cui abitiamo mi farò aiutare dalle riflessioni di Deleuze e Baumann.
5. L’ontologia dell’attualità: società del controllo e modernità liquida
5.1 La società del controllo: Deleuze
Deleuze, proseguendo le analisi di Foucault, sostiene59 che stiamo entrando nelle società di
“controllo” che non sono più esattamente disciplinari. Foucault ha situato le società disciplinari tra
il XVIII e XIX secolo; esse raggiungono l’apogeo all’inizio del XX secolo, procedendo
all’organizzazione dei grandi ambienti di internamento60. L’individuo non fa che passare da un
ambiente chiuso all’altro, ognuno con le sue leggi: prima la famiglia, poi la scuola (“non sei più in
famiglia”), poi la caserma (“non sei più a scuola”), poi la fabbrica, di tanto in tanto l’ospedale,
eventualmente la prigione, l’ambiente di internamento per eccellenza. Foucault ha analizzato molto
bene il progetto ideale dell’ambiente di internamento, particolarmente manifesto nella fabbrica:
concentrare, ripartire nello spazio, ordinare nel tempo; comporre nello spazio-tempo una forza
produttiva che dia un risultato superiore alla somma delle forze elementari. Ma Foucault era anche
consapevole della brevità di questo modello successivo alle società di sovranità, i cui fini e funzioni
erano tutt’altri (prelevare piuttosto che organizzare la produzione, decidere della morte piuttosto che
gestire la vita)61, si era instaurato progressivamente e sembra che si debba a Napoleone la grande
conversione da una società all’altra. Ma le discipline, a loro volta, conosceranno una crisi a
vantaggio di nuove forze che lentamente guadagneranno terreno, fino a precipitare dopo la Seconda
Guerra mondiale: le società disciplinari erano già qualcosa del nostro passato, qualcosa che stavamo
smettendo di essere. Deleuze denuncia una situazione di crisi generalizzata di tutti gli ambienti di
internamento, carcere, ospedale, fabbrica, scuola, famiglia. I ministri competenti non fanno che
annunciare delle riforme ritenute necessarie. Riformare la scuola, riformare l’industria, l’ospedale,
l’esercito, il carcere; tuttavia queste istituzioni sono finite, sono a più o meno breve scadenza. Si
tratta, a parere di Deleuze, di gestire la loro agonia e di tenere occupata la gente fino
all’insediamento delle nuove forze che bussano alla porta. Sono le “società di controllo” che stanno
sostituendo le società disciplinari. E’ solo il caso di citare le incredibili produzioni farmaceutiche, le
formazioni nucleari, le manipolazioni genetiche, i nuovi macchinari bellici.
Quale differenza passa tra le società disciplinari e quelle del controllo? Deleuze risponde
affermando che “i diversi internati o ambienti di internamento attraverso cui passa l’individuo sono
variabili indipendenti: si presume che ogni volta si ricominci da zero, ed un linguaggio comune a
tutti questi ambienti esiste, ma è analogico. Mentre i diversi controllati sono variazioni inseparabili,
che formano un sistema a geometria variabile il cui linguaggio è numerico (che non significa
necessariamente binario). Gli internamenti sono stampi, dei calchi distinti, ma i controlli sono una
modulazione, qualcosa come un calco autodeformante che cambia continuamente, da un istante
all’altro, o qualcosa come un setaccio le cui maglie divergono da una zona all’altra.” 62 Nelle società
59
G. Deleuze, Pourparler, Quodlibet, Macerata, 2000.
Si veda di M. Foucault, La storia della follia in età classica. Nascita della clinica e Sorvegliare e punire, cit.
61
M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit, in particolare Parte prima, Supplizio.
62
G. Deleuze, Pourparler, cit., p. 236.
60
12
disciplinari non si faceva che ricominciare (dalla scuola alla caserma, dalla caserma alla fabbrica),
mentre nelle società di controllo non si finisce mai con nulla, in quanto l’impresa, la formazione, il
servizio sono gli stati metastabili e coesistenti di una stessa modulazione, di uno stesso
“deformatore universale”63. Le società disciplinari hanno due poli: la firma che indica l’individuo, e
il numero o matricola che indica la sua posizione in una massa. Per le discipline non esiste
incompatibilità tra i due poli, perché il potere è allo stesso tempo massificante ed individualizzante,
cioè rende individuo coloro sui quali si esercita, e modella l’individualità di ciascun membro. 64
Nelle società di controllo, viceversa, la cosa essenziale non è più né una firma né un numero, ma
una “cifra”: la cifra è un lasciapassare, mentre le società disciplinari sono regolate da parole
d’ordine (sia dal punto di vista dell’integrazione che della resistenza). Il linguaggio numerico del
controllo è fatto di cifre che contrassegnano l’accesso all’informazione65 o il diniego. Non si ha più
a che fare con la coppia massa-individuo. Gli individui sono diventati dei “dividuali”66 e le masse
dei campioni, dati, mercati o “banche”. Forse è il denaro che esprime al meglio la distinzione tra le
due società, poiché la disciplina si è sempre rapportata a monete stampate che racchiudevano l’oro
come valore di riferimento, mentre il controllo rinvia a scambi fluttuanti, a modulazioni che come
cifra fanno intervenire una percentuale delle differenti monete. La vecchia talpa monetaria è
l’animale degli ambienti di internamento, mentre quello delle società del controllo è il serpente.
Siamo passati da un animale all’altro, dalla talpa al serpente, nel regime in cui viviamo, ma anche
nella nostra maniera di vivere e nei nostri rapporti con l’altro. L’uomo delle discipline era un
produttore discontinuo di energia, mentre l’uomo del controllo è piuttosto ondulatorio, messo in
orbita, su un fascio continuo.
Le vecchie società di sovranità manovravano macchine semplici: leve, pulegge, orologi; mentre
le recenti società disciplinari erano invece dotate di macchine energetiche, con il rischio passivo
dell’entropia e il pericolo attivo del sabotaggio; le società di controllo operano con macchine di un
terzo tipo, macchine informatiche e computer, il cui pericolo passivo è l’interferenza e quello attivo
la pirateria e l’introduzione di virus67. È una mutazione già molto nota che Deleuze riassume così:
“il capitalismo del XIX secolo è concentrazionario, orientato alla produzione, e di proprietà. Erige
la fabbrica a luogo di internamento, dato che il capitalista è proprietario dei mezzi di produzione,
ma anche, eventualmente, di altri ambiti concepiti per analogia (l’appartamento dell’operaio e della
sua famiglia, la scuola). Quanto al mercato, la sua conquista avviene sia attraverso una
settorializzazione, sia attraverso la colonizzazione, sia ricorrendo all’abbattimento dei costi di
produzione. Ma, nella situazione attuale, il capitalismo non è più orientato alla produzione, che
spesso relega nelle periferie del terzo mondo, persino nelle forme di produzione complesse come il
tessile, il metallurgico o il petrolifero. È un capitalismo di iperproduzione. Non compra più materie
prime né vende più prodotti finiti: compra prodotti finiti o assembla pezzi staccati. Vuole vendere
63
Ibidem.
M. Foucault in Poteri e strategie chiama questa tecnica di potere “potere pastorale”. Non si trattava più di condurre gli uomini alla salvezza
nell’aldilà, ma di garantirla in questo mondo. E in tale contesto la parola salvezza assume significati diversi: salute, benessere (cioè ricchezza
sufficiente, livello medio di vita), sicurezza, difesa dagli imprevisti. In alcuni casi questa forma di potere veniva esercitata dall’apparato statale o
comunque da un’istituzione pubblica, come la polizia (non dobbiamo dimenticare che nel XVIII secolo la forza di polizia non venne istituita solo per
garantire la legge e mantenere l’ordine o per aiutare i governi nella lotta contro i nemici, ma per assicurare servizi urbani, igiene, salute e tutte le
misure necessarie per l’artigianato e per il commercio). In altri casi il potere veniva esercitato da iniziative private, enti assistenziali, benefattori e in
genere filantropi. Ma anche le vecchie istituzioni, come la famiglia, vennero mobilitate in questo periodo e assunsero funzioni pastorali. Il potere
pastorale veniva inoltre esercitato da strutture complesse quali la medicina, che comprendeva iniziative private con la vendita delle prestazioni
secondo i principi dell’economia di mercato, ma anche istituzioni pubbliche come gli ospedali. Proprio il moltiplicarsi degli scopi e degli agenti del
potere pastorale ha indirizzato il sapere sull’uomo con due funzioni: una, globale e quantitativa, rivolta alla popolazione, l’altra, analitica, rivolta
all’individuo. Questo significa che il potere di tipo pastorale, che per secoli — per più di un millennio — era stato legato a un’istituzione religiosa ben
definita, si diffuse improvvisamente nell’intero corpo sociale e trovò sostegno in un gran numero di istituzioni. E al posto di un potere pastorale e di
un potere politico, più o meno legati tra di loro, più o meno rivali, si ebbe una “tattica” individualizzante che caratterizzava una serie di poteri: quelli
della famiglia, della medicina, della psichiatria, dell’educazione e dei datori di lavoro.
65
J. Rifkin, L’era dell’accesso, Mondatori, Milano, 2000.
66
G. Deleuze, Pourparler, cit., p. 237.
67
F. Carlini, Internet, Pinocchio e il gendarme, Manifestolibri, Roma, 1996.
64
13
servizi e vuole comprare azioni. Non è più un capitalismo per la produzione, ma per il prodotto,
cioè per la vendita o per il mercato. Pertanto è essenzialmente dispersivo, e la fabbrica ha ceduto il
posto all’impresa. La famiglia, la scuola, l’esercito, la fabbrica non sono più ambienti analogici
distinti che convergono verso un proprietario, sia esso lo Stato o un potere privato, ma le figure
cifrate, deformabili e trasformabili di una stessa impresa che ha solo dei gestori.”68
L’impresa è il nuovo dispositivo dell’assoggettamento. Il servizio vendite è diventato il centro o
l’“anima” dell’impresa: “apprendiamo così che le imprese hanno un’anima; la novità più terrificante
di tutte. Il marketing è ora lo strumento del controllo sociale e forma la razza impudente dei nostri
padroni”69. Il controllo è a breve termine e a rapida rotazione, ma anche continuo e illimitato,
mentre la disciplina era di lunga durata, infinita e discontinua. L’uomo non è più l’uomo rinchiuso,
ma l’uomo indebitato. È vero che il capitalismo ha mantenuto come sua costante l’estrema miseria
dei tre quarti dell’umanità, troppo poveri per il debito, troppo numerosi per l’internamento: il
controllo non dovrà solo affrontare la cancellazione delle frontiere, ma le esplosioni delle periferie,
delle baraccopoli o dei ghetti.
Con estrema lucidità, Deleuze sostiene che non c’è bisogno di ricorrere alla fantascienza per
concepire un meccanismo di controllo che ad ogni istante dia la posizione di un elemento in
ambiente aperto, animale in una riserva, uomo in un’impresa (collare elettronico). Félix Guattari,
dice sempre Deleuze, immaginava una città in cui ciascuno potesse lasciare il proprio
appartamento, la propria via, il proprio quartiere, grazie a una personale carta elettronica (dividuale)
capace di rimuovere questa o quella barriera, ma, d’altro lato, che la carta potesse essere respinta il
tale giorno, o a una tale ora; quello che conta non è la barriera, ma il computer che individua la
posizione di ciascuno, lecita o illecita, e opera una modulazione universale.
La descrizione di Deleuze è una sorta di “ontologia dell’attualità” della società del controllo, che
descrive ciò che si sta già installando al posto degli ambienti di internamento disciplinare. Come
Foucault, infatti, anche Deleuze è convinto che siamo all’inizio di qualcosa: “Nel regime delle
prigioni: la ricerca di pene «sostitutive», almeno per la piccola delinquenza, e l’utilizzo di collari
elettronici che impongono al condannato di rimanere a casa in certe ore. Nel regime dell’istruzione:
le forme di controllo continuo e l’azione della formazione permanente sulla scuola, il corrispondente abbandono di ogni ricerca nelle Università, l’introduzione dell’ «impresa» a tutti i livelli di
scolarità. Nel regime ospedaliero: la nuova medicina «senza medico né malato» che si apre a malati
potenziali e soggetti a rischio, non dimostra affatto un progresso verso l’individuazione, come si
dice, ma sostituisce al corpo individuale o numerico la cifra di una materia «dividuale» da
controllare. Nel regime dell’impresa: i nuovi modi di trattare il denaro, i prodotti e gli uomini che
non passano più per la vecchia forma-fabbrica. Sono esempi molto limitati, che tuttavia permettono
di comprendere meglio che cosa si intenda per crisi delle istituzioni, vale a dire l’insediamento
progressivo e diffuso di un nuovo regime di dominazione. Molti giovani pretendono stranamente di
essere «motivati», richiedono stage e formazione permanente; sta a loro scoprire di che cosa
diverranno servi, così come i loro antenati hanno scoperto, non senza dolore, la finalità delle
discipline. Le spire di un serpente sono ancora più complicate del sistema di tunnel di una talpa”70.
Quale conseguenza sul nostro modo di vita? Deleuze dice che è venuta meno la fiducia nel mondo:
“abbiamo completamente smarrito il mondo, ne siamo stati spossessati”71. Avere fiducia nel mondo
vuole dire suscitare eventi, per piccoli che siano, che sfuggano al controllo, mostrare il coraggio
della parresia e dell’Aufklärung, agire la capacità di resistenza, de-assoggettarsi. Non è il caso né di
avere paura né di sperare, bisogna cercare nuove armi, nuove forme parresiastiche, porre con forza
l’interrogativo dell’Aufklärung: “Che cosa accade oggi? Che cosa accade ora? E che cos’è questo
68
G. Deleuze, Pourparler, cit., pp. 238-239.
Ivi, p. 239.
70
Ivi p. 240.
71
Ivi, p. 233.
69
14
«ora» all’interno del quale noi tutti siamo, e che definisce il momento in cui scrivo?”. La riflessione
su di sé, insomma, è completa ed efficace solo se l’uomo libero si sforza di percepire l’insieme dei
rapporti in cui è immerso. Si tratta di divenire consapevoli della “relazione che sussiste tra gli dei,
gli uomini, il mondo, le cose del mondo, da un lato, e noi dall’altro”72 . In questo modo, l’individuo
si pone al di sopra di se stesso, non per astrarsi dalla situazione in cui è, ma al contrario per poter
ridiscendere in essa con la visione adeguata del fatto che egli è solo “un punto nel sistema generale
dell’universo”73 . Ciò che, in ogni caso, distingue questo da ogni altro sapere è il fatto che esso non
produce semplicemente descrizioni, ma si traduce immediatamente in prescrizioni, “poiché il nostro
stesso modo di essere soggetti ne risulta (...) trasformato”, è un diventare-altro. Esso, insomma, ha
un valore e un senso poiché tende immediatamente alla elaborazione di un ethos, a un’etopoiesi74.
5.2 La modernità liquida: Bauman
Anche il contributo di Bauman può essere letto come un’ontologia dell’attualità. In particolare
vorrei soffermarmi su quello che accade alla vita dei singoli. In Modernità liquida75 il sociologo
passa in rassegna molteplici aspetti della “liquefazione” di quelle che Foucault chiamerebbe società
disciplinari. Tra gli aspetti su cui insiste maggiormente è la perdita della sicurezza. Già Deleuze
aveva fatto luce su quest’ambito sostenendo come il modello dell’impresa sia diventato il modello
di de-formazione universale. Anche Bauman rileva che per effetto della più ampia libertà del
capitale globale, il lavoro non rappresenta più un aspetto della condizione umana da cui è possibile
ricavare certezze e sicurezze76 e “ciò non può non sortire , sotto molteplici profili effetti
disastrosi”77. Bauman sostiene che quello che Mills avrebbe definito un problema enorme il declino
dell’industria locale, per effetto dell’apertura a un mercato globale che cerca forza lavoro sempre
meno costosa e più flessibile, è diventato la norma: “I lavori sicuri in aziende sicure sembrano
ormai un ricordo del passato; né esistono specializzazioni ed esperienze che, una volta acquisite,
possano garantire un posto di lavoro certo e, soprattutto, duraturo”78. Ciascuno di noi avverte in
prima persona l’ansia dell’incertezza, se è vero che, grazie alla rapida e agevole mobilità del
capitale globale, “nessuno può sentirsi davvero insostituibile: né chi è già stato licenziato, né chi ha
il compito di licenziare altri. Anche la posizione più privilegiata può rivelarsi meramente
temporanea e «fino a ulteriore comunicazione»”79 . Se i protagonisti della modernità solida, delle
società disciplinari, vivevano la monotonia e la passività che discendono dall’esatta conoscenza di
quel che sta per accadere, gli uomini e le donne della modernità liquida vivono uno stato di apatia e
di passività che nasce dalla consapevolezza che tutto può cambiare, da un momento all’altro, per
ragioni al cospetto delle quali sono assolutamente impotenti.
La “liquidità” significa, allora, che non si può più confidare nel fatto che ciò che accade oggi si
ripeta domani; o che le persone che incontriamo oggi siano le stesse che incontreremo domani. Il
motivo dominante la politica della vita diventa l’accaparrarsi subito quel che è disponibile
nell’immediato. Date le condizioni della modernità liquida, è tutt’altro che irragionevole puntare sul
massimo godimento, nel tempo più breve possibile. Al posto della gratificazione differita si afferma
la gratificazione istantanea, al punto che le cose del mondo interessano nella sola misura in cui sono
disponibili all’istante, in un sistematico usa-e-getta che non ha alcun riguardo per il futuro:
“Condizioni economiche e sociali precarie addestrano uomini e donne (o insegnano loro attraverso
72
M. Foucault, Ermeneutica del soggetto, op. cit., p. 207.
Ivi, p. 245.
74
Ivi, pp. 208-210.
75
Z. Bauman, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002.
76
Per questo tema si veda anche U. Beck, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro, Einaudi, Torino, 2000.
77
Z. Bauman, Modernità e olocausto, Il Mulino, Bologna, 1992, p.97.
78
Z. Bauman, Modernità liquida, cit, p. 187.
79
Ivi, pp. 187-188.
73
15
la dura esperienza) a percepire il mondo — il mondo intero, ivi inclusi gli altri esseri umani —
come un contenitore pieno di oggetti smaltibili, oggetti monouso”80. In ultima istanza, la modernità
liquida sottopone la convivenza tra gli uomini a una continua sperimentazione: “Poiché i
coinvolgimenti di oggi ostacolano le opportunità del domani, quanto più leggeri e superficiali essi
sono, tanto minore è la probabilità che arrechino danni”81. Anche l’amore è diventato liquefatto. La
relazione d’amore andrà rimpiazzata da “relazioni tascabili” che sono “l’incarnazione
dell’istantaneità e della smaltibilità”82 . Si tratta, come è evidente dall’espressione di Bauman, di
relazioni a cui i partner prendono parte per il tempo (e nella misura) in cui ne traggono un valore
d’uso. Non appena l’altro cessa di essere utile, basterà buttarlo via, come si fa con i fazzoletti di
carta sporchi. La convivenza umana si liquefà, e l’Altro assume lo status di un qualsiasi oggetto che
ci troviamo in tasca: materiale di scarto, di cui sbarazzarci. Non è un caso se, in questo scenario, il
sociologo si rifà all’ Uomo senza qualità di Robert Musil. La liquefazione del legame che sta alla
base della convivenza umana, afferma Bauman, fa emergere gli inediti contorni del “Mann ohne
Verwandtschaften: l’uomo senza legami. Costui è il tipico abitante della nostra società liquidomoderna”83 .
La modernità liquida si traduce in una politica della vita che guarda a ciò che è transitorio, più che
duraturo; all’immediato più che al lungo termine; all’utilità, prima di qualsiasi altro valore. Essa
tende a dissolvere il legame tra ciascuno di noi, e ci induce a diventare individui, ovvero a tentare di
perseguire, ciascuno per conto proprio, una certa misura di sicurezza. La modernità liquida
distrugge tutte le forme solide della modernità solida, crea la sensibilità di un mondo in cui non c’è
più alcuna via di fuga e si è costretti instancabilmente a riflettere sui possibili effetti a distanza di
ogni corso d’azione immediato. La politica della vita della modernità liquida, a sua volta, dà luogo
a una società di individui che devono affrontare il problema di attribuire senso a una vita spogliata
di ogni certezza o fiducia. Si tratta di individui che non si possono quasi permettere di guardare
oltre ciò che è immediato, a portata di mano, transitorio; individui che devono badare a “lasciare
aperte quante più opzioni possibili”84, ben sapendo che le azioni di oggi potranno essere dimenticate
l’indomani. La modernità liquida crea individui che sono incredibilmente ansiosi, alla disperata
ricerca di una fonte di certezze, e del tutto incapaci di trovarne una (o se la trovano, come
suggeriscono gli eventi dell’undici settembre, questa offre loro la fiducia necessaria a tentare di
distruggere i simboli della produzione globale dell’ansia). Di qui “il curioso paradosso del nostro
tempo per cui la crescente consapevolezza dei pericoli che abbiamo di fronte si accompagna a una
crescente impotenza a prevenirli o ad alleviare la gravità del loro impatto”85.
Bauman osserva che “il vero problema dell’attuale stato della nostra civiltà è che abbiamo smesso
di farci delle domande”86. E’ il problema della mancanza dell’interrogazione dell’Aufklärung,
direbbe Foucault, che se non esercitato, rappresenta una minaccia gravissima per la realizzazione
delle possibilità umane ancora inedite. L’essere umano, per Bauman, è umano proprio perché sa
interrogare la realtà attuale, intravedendo in essa delle possibilità ancora inedite. Ora, se è vero che
la società attuale ha smesso di interrogarsi su se stessa, ne segue che le potenzialità nascoste degli
esseri umani, la capacità di “circo-scriversi”, di diventare soggetti, rischiano di rimanere per
sempre nella penombra prefigurando un futuro di assoggettamento senza precedenti. C’è un altro
quesito, però, che assilla Bauman: perché la società di oggi ha smesso di autointerrogarsi?
Una ragione sta nel fatto che, nella politica della vita liquido-moderna, tutto ciò che oltrepassa la
sfera del Sé non rappresenta un problema di cui la gente comune si dovrebbe preoccupare. Nella
modernità liquida, infatti, perde visibilità il legame tra i problemi personali e le questioni di
80
Ivi, p. 188.
Ivi, p. 189.
82
Z. Bauman, Amore liquido: sulla fragilità dei legami affettivi, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 31.
83
Ivi, p. V.
84
Z. Bauman, la società individualizzata: come cambia la nostra esperienza, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 187.
85
Ivi, p. 234.
86
Z. Bauman, Dentro la globalizzazione, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 8.
81
16
interesse pubblico. Ciascuno deve massimizzare le opportunità di cui dispone, sviluppando le
proprie personali attitudini e abilità. Non si avverte più l’esigenza di stringere legami permanenti
con gli altri, per il semplice fatto che l’identità dell’Altro si esaurisce nel suo valore d’uso: qualche
cosa da consumare, e poi da gettare via. La gente comune ha smesso di interrogarsi sulla realtà,
sostiene Bauman, perché questa, sotto il profilo esperienziale, non pone particolari problemi: “A
furia di sentirsi ripetere di essere padrone del proprio destino, l’individuo ha ben pochi motivi di
accordare una «rilevanza topica» (…) a qualsiasi cosa si opponga all’essere risucchiata nell’ambito
dell’interesse personale e regolata dagli strumenti propri di una visione egocentrica”87. E’ per
questo che i soggetti della modernità liquida si sentono sempre più pervasi da una minaccia globale
di fronte a cui si sentono impotenti. 88
Si rapportano con il mondo con la stessa attenzione, cura e preoccupazione di un turista89. E i
turisti non hanno bisogno di fare domande, una volta che gli aerei partono in orario, dopo gli
opportuni controlli, l’albergo è pulito e accogliente, il cibo è almeno decente e gli abitanti del luogo
appaiono felici. Se i turisti possono viaggiare per scelta, “non tutti i viaggiatori, tuttavia, si
muovono perché preferiscono il moto alla stasi o perché vogliono andare dove stanno andando”.
Alcuni “sono in movimento perché vi sono stati spinti, dopo essere stati in primo luogo sradicati
spiritualmente da un posto che non prometteva nulla, da una seduzione o propulsione, una forza
troppo potente, e spesso troppo misteriosa, perché le si possa resistere”90. Per il sociologo, costoro
sono i vagabondi della globalizzazione rappresentati emblematicamente dalla figura del richiedente
asilo, sono gli scarti umani della globalizzazione. Persone che, grazie alla libertà di movimento,
sono cacciate dai luoghi che abitavano per essere custodite nei campi profughi, laddove nessuno
vorrebbe mai andare91.
Se la modernità solida aveva fatto soffrire soprattutto le classi lavoratrici, la globalizzazione e
la modernità liquida colpiscono più di tutti gli “asilanti”, coloro che sono trattati come scorie
dell’umanità. Vi sono delle differenze, però, tra la sorte dei lavoratori di ieri e degli asilanti di oggi.
I primi erano oggetto di un interesse che dimostrava, in qualche modo, la convinzione che tutti gli
esseri umani avessero una loro dignità intrinseca92. A partire da questo assunto, sarebbero sorti
movimenti politici capaci di prefigurare una condizione alternativa, in cui uomini e donne si
impegnassero in una prassi orientata a liberare l’umanità dalla sofferenza. Uomini e donne potevano
aderire personalmente a questa prassi, perché si potevano “convertire” nella valuta comune della
lotta per sconfiggere l’umiliazione e per sprigionare le potenzialità umane ancora inedite.
Per le figure emblematiche della sofferenza umana di oggi, gli asilanti, le cose non stanno
così. I turisti non hanno motivo per fare causa comune con chi soffre le conseguenze della
globalizzazione e della modernità liquida. È probabile, anzi, che gli uni non si imbatteranno mai
negli altri. Chi soffre viene confinato lontano dallo sguardo del turista, per essere deportato nei
campi profughi o negli altri luoghi destinati alle “scorie”. Il turista potrà imbattersi in uno di loro
soltanto se tenteranno di ribellarsi o, magari, perché saranno chiamati ad “aggiungere colore”,
facendo da sfondo folkloristico, ai suoi viaggi; in ogni caso, la loro presenza sarà mediata,
estetizzata, fondamentalmente snaturata93. Asilanti da un lato, turisti dall’altro non hanno alcuna
87
Z. Bauman, Modernità liquida, cit, p. 33.
Su questo tema si veda anche il testo di Benasayag, Shmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano, 2005, in cui si sostiene la tesi che
viviamo in un epoca segnata dalle passioni tristi. Questa espressione appartiene a Spinoza e non si riferisce tanto alla tristezza che genera pianto o
sofferenza, ma a quella che deriva dalla impotenza e disgregazione, una tristezza prodotta dalla delusione e dalla perdita di fiducia. L’atteggiamento
di chi cura deve discostarsi da una clinica puramente sintomatica, fondata sulla classificazione (vedi ICD-10 o il DSM guida alla classificazione delle
sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali), per intraprendere un percorso, probabilmente difficile perché diventato inconsueto, finalizzato a
sviluppare la capacità negli individui, di costruire o ricostruire i legami .
89
Z. Bauman, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna, 1999, cap. I.
90
Z. Bauman, Dentro la globalizzazione, cit, pp. 102-103.
91
Z. Bauman, Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, 2005.
92
L’analisi di Bauman non appare così disincantata e radicale come quella di Foucault e di Deleuze a cui mi sento più vicino. Infatti nei suoi scritti a
volte le analisi sociologiche dell’attualità, che per certi versi sono impietose come quelle dei filosofi a cui facevo riferimento, si richiamano poi a
principi astorici, a verità universali, a concetti che si presume non abbiano alcuna relazione con il dispositivo in cui si sono creati.
93
Z. Bauman, Le sfide dell’etica, Feltrinelli, Milano, 1996.
88
17
possibilità di entrare in dialogo, di tradurre le rispettive esperienze in significati condivisi, di
assumere una prassi comune. I turisti volano qua e là per il mondo, con loro crescente
soddisfazione, scambiando qualche parola di circostanza con le persone (altri turisti) in cui hanno
occasione d’imbattersi; gli asilanti, sull’altro versante, non dispongono di alcuna possibilità per far
sentire la propria voce.
Bauman, di fronte a questa nuova stratificazione sociale, si appella alla critica, al necessario
interrogarsi sul mondo e lo fa tramite la Arendt : “il mondo non è degli uomini solo perché è
popolato da esseri umani, e non diventa più umano solo perché vi risuonano echi di voci umane,
ma solo quando diviene oggetto di discussione”94.
Discutere del mondo, diventa la nuova forma del coraggio dell’Aufklärung, diventa una nuova
forma di resistenza, diventa una forma di cura di sé e dell’altro, se è vero che “il dialogo veramente
umano si differenzia da un semplice scambio di opinioni per il fatto che il piacere per l’altro e per
quello che si sta dicendo permeano ogni cosa”95. Entrare in dialogo con l’altro significa esporsi,
rendere conto di sé, prendersi cura di sé e del mondo. Ritorniamo alle questioni che avevamo posto
più sopra.
Che cosa vuol dire de-assoggettare oggi i nostri corpi docili? Quale il senso della pratica
filosofica nella modernità liquida, nella globalizzazione dei dispositivi tecnici delle società del
controllo?
6. De-assoggettare nella società del controllo
Se accettiamo le analisi di Deleuze e Bauman, il dispositivo attuale è, schematicamente,
leggibile nella condizione degli asilanti, da un lato, e dei turisti, dall’altro: questi sono dei corpi che
vengono attanagliati da un'anima che non scelgono, dalla forma dell’impresa che preesiste alla loro,
parlante il linguaggio del marketing che da questi si lascia dire. La docilità dei loro corpi è ottenuta
con la macchina potentissima della comunicazione di massa, dell’informazione capillare che
annienta le distanze spazio-temporali del mondo e aumenta la distanza “fra” i corpi rendendoli
“superflui”; tende, inoltre, ad annullare la capacità di interrogarsi sul mondo – si sa tutto e
velocemente quello che deve essere saputo - ed è fonte generativa di continuo disagio psichico che
si manifesta in un’alternanza di stati onnipotenti e narcisistici da un lato, e dall’altro con stati di
profonda apatia ed impotenza, che hanno come esito l’impossibilità di creare legami. Il dispositivo
del controllo rende soli gli uomini, delegittima la “comunità inoperosa”96 e crea un sapere sempre
più tecnico e sofisticato a cui si demanda ogni scelta: c’è sempre più bisogno di controllo perché
aumenta sempre di più l’incertezza. E’ l’incertezza amplificata nei corpi degli asilanti e letta dai
turisti come minaccia prima della propria esistenza, non riuscendo a scorgevi il medesimo volto, la
medesima condizione di esistenza. Solitudine, saperi tecnici, incertezza, impotenza, incapacità di
autointerrogarsi, mancanza di legami (passioni tristi), logica dell’usa-e-getta, continuo stato di
liquefazione: questi sembrano i tratti del dispositivo del controllo.
Il soggetto, tuttavia, come abbiamo già guadagnato, non è solo un correlato alienato dei dispositivi
di sapere e potere al cui interno attinge ed esaurisce la sua identità imposta, (il turista, l’indebitato,
il lavoratore flessibile, ecc.) esterna, al di fuori della quale non esiste altra salvezza che non
nell’essere asilanti, o vivere nelle banlieues. Se è vero, infatti, che un regime di verità, decide a
priori le forme di “come io posso essere”, è altrettanto vero che non potrà mai costringere del tutto
queste forme, cioè il soggetto non è deciso deterministicamente dai dispositivi di potere e sapere,
94
Citazione contenuta in Z. Bauman, La nuova condizione umana, Vita e pensiero, Milano, 2004, p. 145.
Ivi, p. 146.
96
J L. Nancy, la comunità inoperosa, Cronopio, Napoli, 2003. Il filosofo francese propone un'idea della comunità come un fisico “stare insieme”.
Nancy ripropone la grande questione della comunità, della relazione. La comunità, come essere in comune, è l'esistenza stessa. La sua stessa
determinazione ontologica. La comunità non ha nessun attributo spirituale. Il contatto e la relazione viaggiano attraverso i corpi. Attraverso la carne
del mondo. Il gesto, il contatto, la voce. E il soggetto stesso, in questa chiave, è un luogo di incrocio dei corpi.
95
18
sebbene questi forniscano l’orizzonte per ogni agire del soggetto. Il soggetto tramite la critica può
mettere in discussione un regime di verità che in quanto tale assoggetta, cioè governamentalizza, e
mettere in discussione dispositivi di verità significa anche mettere in dubbio la verità su di sé, cioè
dar conto di sé, prendersi cura di sé. Se forme di soggettività non alienate sono possibili, ciò è
dovuto all’esercizio di pratiche critiche che riflettono sui modi e sulle condizioni in cui avviene
l’assoggettamento, che coraggiosamente spingono il soggetto a “dire la verità” su se stesso,
mettendo a repentaglio ogni sua intelligibilità e riconoscibilità. Quindi, se il discorso che abbiamo
condotto fin qui è corretto, il de-assoggettamento è possibile proprio in ragione del processo di
soggettivazione che trova linee di fuga, di resistenza al dispositivo. Trovare linee di fuga significa
essenzialmente analizzare l’archivio per scoprire ciò che siamo stati ed esercitare l’interrogazione
sul presente: “ Che cosa posso vedere e che cosa posso dire oggi”? Ciò significa “pensare il passato
come esso si condensa nel dentro, nel rapporto con sé (c’è un Greco in me, o un cristiano….)
pensare il passato contro il presente, resistere al presente, non per un ritorno ma «a vantaggio, spero
di un tempo a venire» (Nietzsche), e cioè rendere il passato attivo e presente al fuori, affinché
accada finalmente qualcosa di nuovo e il pensare giunga sempre al pensiero. Il pensiero pensa la
propria storia (passato), ma al fine di liberarsi da ciò che pensa (presente) e poter finalmente
«pensare altrimenti»”.97 Pensare significa sperimentare, problematizzare. Il sapere, il potere e il sé
sono la triplice radice di una problematizzazione del pensiero: “prendendo il sapere come problema,
pensare significa innanzitutto vedere e parlare, ma il pensare si attua nel fra, nell’interstizio o nella
disgiunzione tra il vedere e il parlare. Significa ogni volta inventare l’intreccio, scagliare ogni volta
una freccia da una parte all’altra, far scintillare un bagliore di luce nelle parole, far sentire un grido
nelle cose visibili. Pensare significa far arrivare il vedere al suo limite, e il sapere al suo, in modo
che essi costituiscano il limite comune che li rapporta l’uno all’altro separandoli.”98 Pensare, in altre
parole, significa creare concetti con i quali interrogare le lenti che “abbiamo in dotazione” per
guardare il mondo e le pratiche discorsive che gli danno voce. Pensare significa scoprire le fratture
della “bolla” in cui viviamo e descriverne i limiti perché il “pensare altrimenti” sia possibile.
Se poi prendiamo il potere come problema, “pensare significa produrre singolarità, lanciare i dadi.
Dicendo colpo di dadi, diciamo che il pensiero viene sempre dal fuori (…). Il colpo di dadi esprime
infatti il più semplice rapporto di forze o potere, quello che si viene a stabilire tra singolarità uscite
a caso. (…) il fuori è precisamente la linea che re-incatena incessantemente i colpi tirati a caso, in
un misto di aleatorietà e di dipendenza. Il pensare assume quindi nuove figure: lanciare singolarità;
reincatenare i colpi; e inventare ogni volta le serie che vanno dalle vicinanze di una singolarità a
quelle di un’altra.” 99 Pensare, in funzione del potere, è sempre un atto creativo fatto con concetti
che interrogano l’orizzonte di forze in cui siamo gettati e che determina le nostre singolarità, il
nostro essere folli, turisti o asilanti. Pensare è l’invenzione di altre possibili singolarità che possono
emergere dal diagramma o che rimangono sospese nel fuori, le “singolarità selvagge”100.
Pensare in funzione del Sé significa pensare il soggetto come “macchina desiderante”101.
“Desiderare consiste in questo: fare dei tagli, lasciare scorrere certi flussi, operare dei prelievi sui
flussi, tagliare le catene che sposano i flussi. (…) Il desiderio non dipende da una mancanza,
desiderare non è mancare di qualcosa, il desiderio non rinvia ad alcuna legge, il desiderio produce
(...) E’ rivoluzionario (…) perché costruisce delle macchine capaci, inserendosi nel campo sociale,
di smuovere il tessuto sociale”102. Pensare in funzione del sé significa nuovamente un’opera
97
G. Deleuze, Foucault, op. cit., p. 158.
Ivi, p. 155.
99
Ibidem.
100
M. Foucault, L’ordine del discorso, Einaudi, Torino, 1970, p. 28.
101
“Le macchine desideranti sono macchine binarie (…) sempre una macchina accoppiata con un’altra. La sintesi produttiva, la produzione di
produzione, ha una forma connettiva: «e», «e poi»…C’è sempre una macchina produttrice di un flusso., ed un’altra ad essa collegata, che opera
un’interruzione, un prelievo di flusso (…) E siccome la prima è a sua volta collegata ad un’altra rispetto alla quale si comporta come interruzione o
prelievo di flusso, la serie binaria è lineare in tutte le direzioni. (…) una connessione si stabilisce sempre con un’altra macchina.” G. Dleuze F.
Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino, 1975, p. 7.
102
G. Deleuze F. Guattari, Macchine desideranti, Ombre Corte, Verona, 2004.
98
19
creativa che chiede concetti nuovi per la potenza del desiderio che viene repressa e assoggettata dai
dispositivi del potere e del sapere. Significa offrire possibilità di circo-scrizioni di sé, mai definitive,
mai astoriche e sempre in relazione all’altro. Significa trovare vie di fuga, smuovere il dispositivo
che rende impotenti. Significa interessarsi e riconoscere le condizioni e le possibilità indefinite di
trasformazione del soggetto. Significa resistere. Resistere oggi potrebbe significare un agire della
vigilanza, della presa di distanza, della critica. Resistere significa collocarsi in un’etica
dell’immanenza, cioè in un agire che cerca di circo-scrivere un ordine all’interno della vita, un
ordine immanente, non retto da valori trascendenti o condizionato da norme sociali, che chiede una
presenza continua dell’altro. De-assoggettarsi potrebbe voler dire collocarsi in un’etica della vita:
“Si dirà della pura immanenza che essa è UNA VITA, e null’altro (...) una vita è l’immanenza
dell’immanenza, l’immanenza assoluta: essa è potenza e beatitudine complete”103
6.1 Un agire per amore della vita
Parlare di un’etica della vita vuol dire collocarsi in un agire che si oppone non solo alla
politicizzazione del biologico ma anche alla biologizzazione del politico “che fa della
conservazione riproduttiva della vita l’unico progetto fornito di legittimità universale”104, che vuol
dire potere assoluto sulla vita, sui corpi ridotti ad assemblaggi di organi in opposizione ai “corpi
senza-organi” o “macchine desideranti” di Deleuze e Guattari. L’etica richiesta è quella delle
passioni felici capace di dar voce alla potenza della vita: “la vita grida alla morte, però la morte non
è più quel troppo-visibile che ci toglie le forze, bensì è la forza invisibile rivelata dalla vita, stanata
e mostrata nel grido. La morte è giudicata dal punto di vista della vita, e non l’inverso, di cui tanto
ci si compiace”.105Assecondare la potenza della vita significa seguire la logica della nascita che
piuttosto che rinchiudere la nuova vita, annullandola, all’interno dello stesso corpo – il corpo della
madre – la nascita rovescia ciò che sta dentro il ventre materno nel mondo. Non in-corpora ma espone il nuovo all’esistenza e nel momento in cui è tagliato il cordone ombelicale e ripulito dal
liquido amniotico, il nuovo nato è situato in una differenza irriducibile rispetto a tutti quelli che
l’hanno preceduto, nei confronti dei quali risulta necessariamente estraneo, straniero, asilante: il
mondo è diventato altro. La nascita rivela la frattura, la linea di fuga da cui può scaturire un nuovo
sé, un nuovo modo di resistere: “l’unico modo, per la vita, di differire la morte non è quello di
conservarsi tale, magari nella forma immunitaria della protezione negativa, bensì di rinascere
continuamente in guise diverse”106. E’ in virtù del semplice “venire al mondo” che l’uomo si
costituisce come nuovo inizio: reca in sé la capacità d’agire, cioè la capacità miracolosa di aprire
nuovi orizzonti di possibilità107.
Approfondiamo il discorso con l’aiuto della riflessione arendtiana.
Per la Arendt l’azione libera viene presentata come risposta esistenziale al dato di fatto della nascita
o come risposta alla natalità. Dunque l’uomo agisce perché è un essere natale, non mortale, perché
la sua vita da avvento biologico inserito nel ciclo di nascita e morte della natura, può trasformarsi in
un intervallo di tempo, con un inizio e una fine, in una storia. E ciò avviene quando si abbandona la
preoccupazione dominante per la propria vita e si passa alla sfera pubblica dell’esporsi agli altri.
Ogni azione entrando in modo del tutto inatteso in collisione con altre iniziative comporta
ripercussioni non dominabili, che innescano catene di conseguenze che sfuggono totalmente alle
intenzioni e al controllo degli attori. Ed è proprio contro questi esiti imprevedibili che i dispositivi
di sapere hanno reagito negando sia la specificità sia la libertà dell’azione e la sua origine, per
giungere all’estremo con il nazismo: “annientando la nascita, i nazisti ritenevano di riempire il
G. Deleuze, L’immanence: une vie…., in « Philosophie », n 47, 1995, p.4, citato in R. Esposito, Bios, cit., p. 211.
R. Esposito, Bios, Einaudi, Torino, 2004, p. 160.
G. Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione, Quodlibet, Macerata, 1995, p. 88.
106
R. Esposito, Bios, cit,, p. 199.
107
H. Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano, 1989, pp. 128-129.
103
104
105
20
vuoto originario, di distruggere il munus e così di immunizzarsi definitivamente dai suoi traumi”.108
L’azione libera, secondo la Arendt, è stata tradita, deformata dal modello dell’operare cioè dalla
logica dei mezzi-fini, proponendo un potere in cui l’agire veniva trasformato nella sicura relazione
tra chi comanda e chi obbedisce. L’azione è rischiosa e instabile ma fa delle imprese umane eventi
inaspettati, miracoli, in cui l’iniziativa umana si afferma per l’energia di legame insita nell’agire
insieme di un gruppo. Che cosa significa agire insieme?
Agire insieme è per la Arendt parola, gesto visto e udito, dialogo, scambio di prospettive sul mondo.
Vedere ed esperire il mondo nella sua realtà come qualcosa che è comune a molti che li separa e li
unisce e si mostra ogni volta diversamente ad ognuno ed è possibile solo se i molti ne parlano tra
loro e si scambiano opinioni. Solo nel parlare insieme si forma la realtà come ciò di cui si parla,
nella sua oggettività visibile da tutte le parti. Vivere in un mondo e parlarne con altri sono la stessa
cosa109.
Che cos’è l’azione? L’azione rappresenta propriamente l’atto del dare inizio, il momento del rischio
e dell’avventura, è una nascita. Ma l’azione non è sufficiente senza il discorso. Infatti, il discorso
completa la struttura dell’azione nel momento in cui rivela il “chi” dell’azione, cioè fa dell’azione
non solo l’irruzione della novità imprevedibile, ma l’evento in cui un singolo fa la sua apparizione
cioè comunica se stesso, e non abilità, opere, qualità, agli altri. Questa rivelazione implica
necessariamente la presenza di altri perché il “chi” è l’esserci reale e concreto di un uomo e di una
donna, la sua presenza sulla scena del mondo. Sussiste una tensione e complementarità tra agire e
discorso, tensione tra individualità coraggiosa che si rivela nell’azione e la pluralità delle voci e
degli sguardi degli altri che rendono tangibile e reale l’atto, sottraendolo al controllo del singolo e
inserendolo in una storia che gli permette di essere ricordato, complementarità perché l’inizio
lasciato a se stesso diventa autoaffermazione, forza, violenza e la parola se non racconta una storia
cambia statuto, non è più un accadere, ma “cosa” poetica o semplice strumento di comunicazione.
Di nuovo chiediamo: che cosa significa agire?
Agire significa compiere un’azione non al fine di ma per amore di. Nell’azione l’uomo libero da
ogni determinazione interiore o esteriore è interessato al solo compimento “virtuoso” del principio
che lo ispira, agisce non per utilità personale ma per “ amore del mondo”: “l’amore non si dirige
mai verso questa o quella proprietà dell’amato (…) ma nemmeno ne prescinde in nome dell’insipida
genericità (…) esso vuole la cosa con tutti i suoi predicati, il suo essere tale qual è. Esso desidera il
quale solo in quanto è tale.”110
L’azione libera, innovativa, discorsiva, agonale che riscatta l’uomo dalla mancanza di significato
della vita biologica è dunque legato alla nascita che espone alla pluralità e più in particolare al fatto
che uomini diversi e unici hanno la possibilità di incontrarsi in uno spazio di visibilità in cui
apparire gli uni agli altri, in cui essere riconosciuti: l’esporsi è un dar conto di sé, è un prendersi
cura. Quindi quando la Arendt parla di “spazio pubblico”, “spazio politico”, “spazio
dell’apparenza”, usa locuzioni diverse per riferirsi alla stessa nozione. Spazio politico, dice la
Arendt, non è un pezzo di terra ma lo spazio che c’è tra individui, l’infra che lega l’uno all’altro, ma
al tempo stesso li separa e li protegge da molte cose che hanno in comune, lingua, religione, storia,
usanze e leggi. Quindi lo spazio pubblico è la condizione di possibilità dell’essere insieme, è il
trascendentale della politica. Non solo, lo spazio pubblico oltre ad essere luogo dell’individuazione
del “chi”, del riconoscimento dell’identità, è anche l’ambito in cui la realtà del mondo si disvela:
“ogni cosa che appare in pubblico può essere vista e udita da tutti. Per noi ciò che appare, ciò che è
visto e sentito da altri e da noi stessi costituisce la realtà” 111. Questo significa affermare
risolutamente che essere ed apparire coincidono: lo spazio pubblico non solo è il trascendentale
108
R. Esposito, Bios, cit., p. 194.
H. Arendt, Vita activa, cit., p.4.
110
G. Agamben, La comunità che viene, Boringhieri, Torino, 2001, p. 10.
111
H. Arendt, Vita activa, cit., p. 37.
109
21
dell’agire politico, ma è la condizione stessa della realtà che necessita di essere confermata dalla
pluralità delle voci umane: è una politica dell’immanenza. Fare in modo che il mondo non venga
dissolto e dimenticato è l’unico scopo dell’essere insieme sulla scena pubblica, il solo modo che
non reifica l’agire plurale degli uomini nella costruzione di una comunità: quella della Arendt è una
“comunità inoperosa” che non persegue nessun compimento se non l’essere in comune grazie al
mondo e per amore del mondo. Questo spazio non possiede le caratteristiche solide e ben delineate
che connotano forme politiche ed istituzionali concrete. Questo spazio, dice la Arendt, è
“potenzialmente ovunque le persone si raccolgono insieme, ma solo potenzialmente non
necessariamente e non per sempre”112 . La politica non è una proprietà del passato perché
potenzialmente è ovunque, e le sue epifanie più veritiere privilegiano quei momenti in cui si
interrompono i rapporti di dominio: i soviet, l’insurrezione di Budapest, la Primavera di Praga, la
rivolta studentesca, episodi di disobbedienza civile, la Resistenza.
L’agire plurale e libero di una “comunità inoperosa”, che si prende cura del mondo e di tutte le sue
ri-nascite chiede a ciascuno la capacità di giudizio, la capacità di dire il vero, la capacità di
interrogare. Giudicare vuol dire pensare ed esprimere ciò che si fa, ossia parlarne, dare un nome alle
cose e alle persone indicando responsabilità proprie e altrui, prendendo posizione rispetto a ciò che
accade113. Il giudizio può richiederci lo sforzo di capire coloro con cui non solo non condividiamo i
punti di vista, ma possiamo per di più trovarli disgustosi come nel caso Eichmann. Il disaccordo
non ci esenta dalla responsabilità di capire ciò che rifiutiamo, semmai aumenta questa
responsabilità. Giudicare per la Arendt di Banalità del male114 significa condividere la potenziale
tragedia che è presente nelle circostanze in cui è esercitata la responsabilità umana ed è portata al
suo limite. Ciò aiuta a spiegare il motivo per cui la Arendt associa la facoltà del giudizio alla dignità
umana. Il caso Eichmann è doppiamente importante per il giudizio: per prima cosa indica
l’incapacità di pensare e giudicare di Eichmann, di distinguere il vero dal falso, il bello dal brutto,
nella critica situazione in cui era coinvolto; secondariamente evidenzia il problema della
comprensione retrospettiva, della possibilità di giudicare il significato del caso Eichmann da un
punto di vista vantaggioso, liberatorio. L’incapacità di giudicare implica conseguenze nefaste per il
mondo. Infatti senza i giudizi che rendono intelligibile il mondo lo spazio delle apparenze
collasserebbe, la nascita annientata e l’altro reso superfluo. Il giudizio deve essere libero e la
condizione della sua autonomia consiste nella capacità di pensare. Resistere ai dispositivi del potere
significa esercitare il giudizio costantemente per amore del mondo: è “l’aspro esercizio del resistere
mantenendo la propria posizione tra le onde sferzanti del passato e del futuro” 115. Il caso Eichmann
è ancora una volta paradigmatico perché testimonia, come già abbiamo detto, una assenza di
pensiero ma anche una radicale incapacità di esercitare il giudizio non appena vengono meno i
principi e i valori trasmessi dalla tradizione. La banalità del male che coincide con la rinuncia
dell’individuo alla responsabilità del giudizio e con la resa ai dispositivi di potere e sapere deve
costringere gli uomini moderni a fronteggiare una realtà imprevedibile senza fare appello a quelle
potenze etiche che generavano i codici normativi di comportamento. L’affrancamento dal peso
esteriore della tradizione e dai vincoli del passato accresce certamente la libertà ma accentua, come
dimostra il caso Eichmann, il carico di responsabilità che gli viene imposto così dirompente rispetto
ai codici morali tradizionali, o come direbbe Foucault, ai saperi disciplinari.
Il pericolo maggiore è infatti l’astensione del giudizio, la banalità del male; il pericolo è che
quando la posta è in gioco il singolo si arrenderà alle forze del controllo piuttosto che esprimere un
giudizio autonomo. Fino a quando continueremo a distinguere, ad interrogare l’attualità, fino a
quando continueremo a scegliere la nostra compagnia nulla sarà perso. Particolarmente significative
mi sembrano le parole della Arendt : “coloro che non collaborarono (…) credo si siano chiesti fino
112
Ivi, p. 146.
H. Arendt, Vita activa, cit., pp. 4-5.
114
H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano, 2003.
115
H. Arendt, Tra passato e futuro, Garzanti, Milano, 1991, p. 37.
113
22
a che punto avrebbero potuto restare in pace con se stessi se avessero commesso certi atti, e che
abbiano quindi preferito non commetterli. Non perché in questo modo il mondo sarebbe cambiato in
meglio, ma perché solo a questa condizione essi potevano continuare a vivere restando se stessi (…)
per dirla in termini estremi: si rifiutarono di uccidere non perché ubbidivano rigorosamente al
comandamento “non uccidere”, ma piuttosto perché non volevano convivere con un assassino. Il
presupposto per formarsi questo tipo di giudizio non è un’intelligenza altamente sviluppata o un
senso morale estremamente differenziato, ma semplicemente l’abitudine a convivere senza
infingimenti con se stessi, a trovarsi in quel silenzioso colloquio tra sé e il proprio io che da Socrate
e Platone in poi siamo soliti chiamare pensiero (…) i migliori saranno coloro che sanno per lo meno
questo: che finché viviamo, siamo condannati a convivere con noi stessi, qualunque cosa
accada”.116 Noi possiamo mantenere noi stessi nel presente e sperare nel futuro solo riflettendo sulla
miracolosità della libertà umana così come si è presentata nei momenti particolari del passato.
Senza la possibilità di giudicare saremmo sopraffatti da una sensazione di insignificanza del
presente e costretti a disperare per il futuro. Lo studio della storia del passato, nelle indicazioni
arendtiane e foucaultiane, insegna che esiste anche la possibilità di un nuovo inizio. Appare chiaro
dunque che solo il contesto della natalità, del nuovo inizio, permette di guardare al male non come
ad una caduta, ad una perdita d’essere, ma come all’ammonimento, a misurarsi con la tensione
interna a una realtà a cui si dice di si o di no. Su cosa si fonda tale tensione interna?
E’ il corpo
6.2 Il corpo
Ciò che la nascita e-spone nel mondo sono i corpi i corpi su cui si esercita la vita e sui quali si
esercita il potere: “luogo del desiderio e della vulnerabilità fisica, luogo di una dimensione pubblica
a un tempo esposta e assertiva. La perdita e la vulnerabilità sono conseguenze del nostro essere
corpi socialmente costituiti, fragilmente uniti agli altri, a rischio di perderli, ed esposti agli altri,
sempre a rischio di una violenza che da questa esposizione può derivare”.117
Ciascuno di noi è costituito dalla vulnerabilità del proprio corpo. L’apertura alla socialità verso cui
il nostro essere soggetti desideranti ci direziona è, contemporaneamente, esposizione alla possibilità
di subire violenza e alla perdita. Il lutto è un enigma: esso si sottrae alla dimensione della scelta così
come l’assenza dolorosa che avvertiamo non cade sotto il dominio della nostra decisione. L’enigma
rivela la nostra dipendenza dal rapporto con gli altri, rapporto che dà forma alla nostra persona. Ciò
che viene perduto non è un ente, ma questo legame aperto che partecipa della nostra costituzione:
“Se il mio destino non è né prima né dopo separabile dal tuo, allora questo «noi» è attraversato da
una relazionalità cui non possiamo facilmente opporci; oppure possiamo anche opporci ad essa, ma
a costo di negare ciò che di fondamentale c’è nella condizione sociale della nostra formazione”118.
La condizione corporea dà voce a due diverse aspirazioni: la prima è la protezione dell’autonomia
del sé, l’altra riguarda invece ciò che dell’autonomia è condizione e cioè la socialità originaria in
cui i nostri corpi ci collocano, la quale implica mortalità, vulnerabilità, sentimenti come la rabbia e
la passione, dipendenza dalle relazioni. Già dalla nascita la nostra incarnazione dipende totalmente
dalla cura asimmetrica dei genitori. Solo poi acquistiamo autonomia. Questo essere “noi stessi al di
fuori di noi stessi non può che derivare dalla vita corporea, dalla sua vulnerabilità e dal suo essere
esposta (…) Il corpo implica mortalità, vulnerabilità, azione: la pelle e la carne ci espongono agli
sguardi degli altri, ma anche al contatto e alla violenza, e i corpi ci espongono al rischio di diventare
agency e strumento di tutto questo” 119. Negare questa dimensione di primaria dipendenza, di
relazione, di non voluta prossimità, significa compromettere l’autonomia stessa di sé, la sua
possibilità di circo-scrizione e diventare strumento inconsapevole di violenza sui corpi degli altri.
116
H. Arendt, La responsabilità personale sotto la dittatura, in A.A. V.V., Oltre la politica, Bruno Mondadori, Milano, 1996, pp. 123-124.
J. Butler, Vite precarie, Meltemi, Roma, 2004, p. 40.
118
Ivi, p. 45.
119
Ivi, pp. 45-46.
117
23
Questa ha una ricaduta politica importante: la comunità deve essere pensata come il luogo in cui
“siamo simili solo perché viviamo una stessa condizione separatamente, impensabile senza
differenze”120. La violenza è l’evento che rivela la nostra vulnerabilità originaria nella forma più
terribile: consegnati alla volontà altrui senza alcun controllo 121. Dobbiamo prestare ascolto alla
vulnerabilità, alla carne macellata, deformata, slabbrata messa così ben in luce da Bacon. Il pittore
vide nelle carcasse degli animali appesi in macelleria la sua sagoma e quella dell’uomo, vide la
condizione attuale in cui l’uomo vive, ma ciò non lo ha mai portato alla disperazione perché è
riuscito a vedervi altre possibilità: la potenza dei legami. Ciò che chiamiamo “io” è in origine,
relazione di dipendenza: “credo che l’altro in me sia chiamato in causa nel processo stesso della mia
costituzione, e che l’estraneità a me stessa sia, paradossalmente, l’origine del mio legame etico con
gli altri. Non conosco completamente me stessa, perché parte di quello che io sono è la traccia
enigmatica dell’altro”122. La vulnerabilità corporea che mi consegna agli altri corpi
disorientandomi, permette di recuperare “la nostra responsabilità collettiva per la vita corporea
l’uno dell’altro”123. Il corpo, in altre parole, è “aperto alla ferita. Non c’è però nessuna necessità nel
vulnus che il termine menziona, bensì solo potenzialità di una ferita sempre incombente e legata alla
contingenza. (…) la stessa potenzialità lo consegna però anche alla cura e all’ontologia relazionale
che ne decide il senso”124.
De-assoggettare significa quindi interrogare i corpi che siamo, i legami che danno luogo alla
nostra estraneità e a quella dell’altro. Il corpo rivela che “l’unica esperienza etica (che, come tale,
non può essere compito né decisione soggettiva) è di essere la (propria) potenza, di esistere la
(propria) possibilità; di esporre, cioè, in ogni forma la propria amorfia e in ogni atto la propria
inattualità”125. Il male consiste invece nel decidere di “restare in debito di esistere (…) oppure (…)
di guardare alla potenza stessa, che è il modo più proprio di esistenza dell’uomo, come a una colpa
che occorre in ogni caso reprimere”.126 Il riferimento è qui a Spinoza. Sulla linea di Deleuze si può
dire che l’Etica127 traccia il ritratto “dell’uomo del risentimento, per il quale ogni felicità è un’offesa
e che fa dell’impotenza e della miseria la sua unica passione” 128. Il dispositivo del potere delle
società del controllo ha bisogno della tristezza delle anime per imporsi, così le anime tristi hanno
bisogno del potere per sopravvivere e propagarsi. Ciò che unisce il dispositivo del potere e le anime
tristi è l’odio alla vita, il risentimento verso il potere della vita di creare infiniti modi di esistenza,
sempre cangianti. Le anime tristi incontrano altri corpi o modi esistenti che non concordano con
loro e tendono a decomporle, a distruggerle. Le anime gioiose invece incontrano corpi con cui
accordarsi. Nel primo caso la potenza del corpo è tutta immobilizzata e non può far altro che
reagire; nel secondo caso, invece, la potenza è in espansione, si compone con la potenza dell’altro.
La gioia aumenta la nostra capacità di agire, la tristezza la diminuisce: “ciò che è prodigioso nel
corpo come nella mente: questo insieme di parti viventi che si compongono e che si depongono
secondo leggi complesse. L’ordine di queste cause è dunque un ordine di composizione di rapporti,
che affetta all’infinito la natura intera”129.
A questo punto possiamo tentare di rispondere alle questioni originarie, avendo guadagnato che
la loro formulazione presupponeva una concezione metafisica del soggetto e della verità, mentre il
percorso che abbiamo tracciato chiede che esse siano collocate storicamente in relazione al
diagramma che abitiamo: Che cosa significa formare e perché formare nella società del controllo?
120
Ivi, p. 48.
G. Agamben in Quel che resta di Auschwitz, Boringhieri, Torino, 1998. sostiene che il campo è la verificazione assoluta della politica nazista
che, nelle parole di Goebbels, era appunto “l’arte di rendere possibile ciò che sembrava impossibile” e per questo nel campo il gesto più proprio
dell’etica heideggeriana, il rendere possibile l’esistente, rimane ineffettuale, per questo “ l’essenza della morte è sbarrata all’uomo”. La violenza sui
corpi arriva all’estremo: è possibile produrre cadaveri.
122
J. Butler, Vite precarie, cit, p. 69.
123
Ivi, p. 51
124
A. Cavarero, Orrorismo, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 42.
125
G. Agamben, La comunità che viene, cit., p. 40.
126
Ibidem.
127
B. Spinoza, Etica, traduzione italiana di G. Durante, Neri Pozza, Vicenza, 2006, parte quarta.
128
G. Deleuze, Spinoza filosofia pratica, Guerini e Associati, Milano, 2004, p. 37.
129
Ivi, p. 29.
121
24
E’ possibile formare nella società liquida?
7. Formare nella società del controllo: alcuni spunti per una didattica della filosofia.
Le risposte alle questioni “segnavia” sono per lo più inscritte nel percorso seguito, quindi ora si
richiede una fase sistematica che raccolga gli esiti del pensiero e che tuttavia non dimentichi
opportuni approfondimenti anche di natura didattica. Vorrei inoltre sottolineare la spinta etica
sottesa a questo sentiero: “come praticare un agire formativo diretto alla liberazione di sè e
dell’altro”. Questa pratica di libertà, a mio parere, chiede da parte del docente una riflessione
epistemologica sulla disciplina, e una riflessione sul ruolo che gioca la scuola nella formazione.
Tale riflessione ha portato alla luce, dal mio punto di vista, la funzione “governamentalizzante”
dell’istituzione scolastica che si serve, quindi, del sapere disciplinare filosofico - nella forma
manualistica in cui i filosofi, i temi, i concetti e la storia sono ridotti a pacchetti di informazione
predigerita che deve essere solo ripetuta - per la formazione di corpi docili, anche all’insaputa e
contro la volontà del docente stesso. Parimenti ha evidenziato la natura parresiastica e critica del
filosofare che mal si addice ad un sapere preconfezionato e ipersemplificato.
Mi sono chiesto più volte da docente come “non essere governato in questo modo” per non essere
strumento inconsapevole di un dispositivo che genera persone la cui intelligenza è piegata ad un
iperadattamento sociale130.
La via che ho imboccato vuol collocarsi al di là della disputa, in ambito di didattica della filosofia,
tra il cosiddetto metodo storico e il metodo per problemi131: per resistere, per de-assogettarsi non
conviene porre in termini escludenti la storia della filosofia e la filosofia teoretica; penso sia più
utile guardare alla filosofia con l’occhio dell’archivista di Foucault e della Arendt o dell’angelo
della storia di Benjamin132, per rintracciare le forme che siamo stati e quelle che possiamo essere.
Cercherò, quindi, di ripercorrere in modo stringente lo sviluppo del discorso fin qui condotto
evidenziando anche le possibili ricadute didattiche.
a) La lettura che abbiamo fatto di Foucault ci permette di sostenere che il concetto di
formazione è essenzialmente ambivalente. Da un lato la formazione è il dispositivo
disciplinare delle strategie pedagogiche con cui l'educazione - attraverso le pratiche
scolastiche - forma i soggetti
rendendoli docili e sottomessi al potere,
governamentalizzati; dall’altro, i dispositivi, avendo come componenti, linee di
soggettivazione, fanno sì che il soggetto si formi, storicamente, non solo in una
dinamica di assoggettamento, la governamentalizzazione, ma anche in un più generale
processo di critica: alla governamentalizzazione è associata la questione inversa del
“come non essere governati in questo modo”. Quindi, in questo caso, formare significa
de-assoggettare i corpi docili, significa costruire occasioni in cui il soggetto si “circoscriva”, cioè possa “resistere” alla governamentalizzazione. Ciò è reso possibile dalla
irriducibilità del soggetto alla normalizzazione dei dispositivi del potere e del sapere e
dalla messa in atto di pratiche critiche che rendono il soggetto “libero”. Formare diventa,
pertanto, un agire etico-politico diretto alla liberazione di sé e dell’altro. Infatti, poiché
prendiamo sempre parte a relazioni di potere, dobbiamo sempre praticare un’etica della
libertà su un duplice fronte: quello della nostra libertà dal governo di tutti e di ciascuno,
e quello della libertà degli altri dal potere irreversibile che potrebbe esercitarsi pure
130
Oltre agli studi di Foucalt, particolarmente interessanti sono le osservazioni del fisico R. Sheldrake sui campi morfici. Ad un osservatore attento
non sfugge l’importanza che può avere tale ipotesi in ambito educativo e clinico. Infatti, se è vero che i campi morfici si rinforzano attraverso la
ripetizione e la memoria cumulativa, i modelli di attività diventano sempre più abituali e conducono, pertanto, a comportamenti difficili da
modificare. Attraverso la ripetizione, i modelli che il campo morfico organizza diventano sempre più probabili, cioè sempre più abituali Il che vuol
dire che un’educazione basata sull’accettazione passiva di regole, atteggiamenti di obbedienza e scarsa criticità, e mancante di creatività personale
porta necessariamente alla costruzione di comunità sociali impaurite, tristi e senza linee di fuga. R. Sheldrake, L'ipotesi della causalità formativa, Red
Edizioni, Como, 1998.
131
F. Bianco, Insegnamento della filosofia: metodo “storico” o metodo “zetetico”?, <Paradigmi>, VIII, 1990, 23, p. 397.
132
W. Benjamin, Le tesi sulla storia, in Angelus Novus saggi e frammenti, trad. di R. Solmi, Einaudi, Torino, 1981, tesi 9, p. 80.
25
attraverso di noi, anche se non lo vogliamo.
b) L’analisi dell’archivio ha messo in luce che formare, come pratica etico-politica di
libertà, è reso possibile con il “dire la verità” e con la “critica”. Il diventare soggetto
chiede giochi discorsivi di verità, la parresia, contestualizzati e promossi all’interno di
una relazione di cura, una relazione formativa in cui ci si espone all’altro. Tale
esposizione garantisce, perché induce un cambiamento, la scoperta della verità, quel
processo di “circo-scrizione” di sé che mette in crisi il dispositivo di forze che
normalizza, che aliena, che rende i corpi docili. Questa “trasfigurazione”, intesa come
cura di sé, avviene in un contesto interlocutorio, in una cornice di atti pratici agiti dal
filosofo “per” e “nei” confronti di qualcun altro, in vista della liberazione di sé. La
modernità segna una grossa cesura con l’antichità greco-romana, infatti il soggetto “così
com’è” risulta in ogni caso capace di verità, per cui il cambiamento, la trasfigurazione
come condizione d’accesso alla verità non è più richiesta. Tuttavia la modernità non
rinuncia alla pratica di libertà e inventa il suo movimento, la critica, attraverso il quale il
soggetto si riconosce il diritto di interrogare la verità nei suoi effetti di potere e di sapere.
La critica diventa l’arte “dell’indocilità ragionata”. In questo senso la cura di sé si
configura come una “critica vissuta di ogni potere totalizzante. Essa implica
necessariamente l’esigenza della limitazione del potere”.133 La cura di sé, nella
modernità, diventa un riflettere su di sé, sulle proprie possibilità di resistenza in
relazione ad un’interrogazione del presente.
Dal punto di vista della didattica ciò significa assumere una scala di valori che indichi
quali forme d’archivio scegliere e quali significati attribuire agli eventi, nel nostro caso i
valori che guidano sono le pratiche di libertà. La relazione con i valori, come sosteneva
Weber134, è inevitabile e condizione di conoscenza: vi è sempre una pluralità di modi di
conoscere la realtà, sono, cioè, possibili riferimenti a schemi valutativi diversi. Una volta
assunta questa prospettiva, si tratta di analizzare e di ricostruire storicamente come si
sono date le forme di soggettivazione all’interno dei dispositivi. L’analisi dell’archivio
filosofico comporta, come sostiene Foucault, una regione privilegiata in quanto è al
tempo stesso vicina a noi, ma differente dalla nostra attualità, è ciò che circonda il nostro
presente differenziandosene. Questo permette di collocarci tra passato e futuro su quella
forza diagonale di un ideale parallelogramma di forze “avente un’origine nota
[l’incontro tra il passato e il futuro], una direzione determinata dal passato e dal futuro,
ma un termine illimitato, [che] è l’immagine perfetta dell’attività del pensiero” 135. Fare
analisi dell’archivio significa porre al centro della propria pratica didattica l’analisi dei
testi dei filosofi, perché con gli studenti si “veda”, di prima mano, come si sono posti i
problemi, quali concetti sono stati creati per poter comprendere la realtà in questione e
quali pratiche discorsive sono state usate per individuare le linee di fuga di cui parla
Deleuze. La centralità del testo e il suo accesso diretto, nella pratica didattica, non è mai
fine a se stessa, ma è quel lavoro faticoso del pensiero sul pensiero perché si
acquisiscano quegli strumenti specifici del filosofare con cui interrogare gli archivi che
siamo stati in direzione della nostra attualità, degli archivi che saremo. Si interrogano gli
archivi nelle opere dei filosofi per districare le linee del passato e quelle del futuro per
rintracciare le forme di soggettivazione possibili. L’analisi dell’archivio serve per
mettere allo scoperto le tecnologie del sé non perché modelli da imitare, ma perché
dotati di forza ideale e quindi esempi di liberazione sempre possibili.
c) Da a) e da b) segue che la formazione come agire etico-politico di libertà richiede una
133
O. Marzocca, Perché il governo, cit., p. 201.
M. Weber, Il metodo delle scienze storico sociali, a cura di P. Rossi, Einaudi, Torino, 1958, p. 90.
135
H. Arendt, Tra passato e futuro, cit., p. 35.
134
26
prassi filosofica animata dall’Aufklärung che ponga a problema l’attualità: “che cosa
accade oggi? Che cosa accade ora? Qual è il dispositivo che abitiamo? Noi apparteniamo
a dei dispositivi e agiamo in essi. In ogni dispositivo bisogna distinguere ciò che siamo,
la normalizzazione, e ciò che possiamo divenire, il nostro divenire altro. In ogni
dispositivo “dobbiamo districare le linee del passato recente e quelle del prossimo
futuro: ciò che appartiene all’archivio e ciò che appartiene all’attuale (…) non predire,
ma essere attenti allo sconosciuto che bussa alla porta”136. La filosofia allora viene intesa
come quella pratica discorsiva con la sua propria storia che problematizza, nella forma
della “critica” e del “dire la verità”, l’attualità. L’attualità è ciò che viene interrogata “in
quanto evento, come avvenimento di cui la filosofia deve dire il senso” 137. Interrogando
l’attualità con le analisi di Deleuze e Bauman, il dispositivo attuale è, schematicamente,
leggibile nella condizione degli asilanti, da un lato, e dei turisti, dall’altro: questi sono
dei corpi che vengono attanagliati da un'anima che non scelgono, dalla forma
dell’impresa che preesiste alla loro, parlante il linguaggio del marketing che da questi si
lascia dire. La docilità dei nostri corpi è ottenuta con la macchina potentissima della
comunicazione di massa, con la strumentazione tecnica sempre più incontrollabile, con
l’informazione capillare che annienta le distanze spazio-temporali del mondo e aumenta
la distanza “fra” i corpi rendendoli “superflui”. Viviamo nell’epoca che tende ad
annullare la capacità di interrogarsi sul mondo – si sa tutto e velocemente quello che
deve essere saputo-, il che è fonte generativa di continuo disagio psichico manifestantesi
in un’alternanza di stati onnipotenti e narcisistici da un lato e dall’altro con stati di
profonda apatia ed impotenza che hanno come esito l’impossibilità di creare legami. Il
dispositivo del controllo rende soli gli uomini, delegittima la comunità inoperosa e crea
un sapere sempre più tecnologico a cui si demanda ogni scelta, anche etica: c’è sempre
più bisogno di controllo perché aumenta sempre di più l’incertezza. E’ l’incertezza
amplificata nei corpi degli asilanti e letta dai turisti come minaccia prima della propria
esistenza, non riuscendo essi a scorgevi il medesimo volto, la medesima condizione di
esistenza. Solitudine, saperi tecnici, incertezza, impotenza, incapacità di autointerrogarsi,
mancanza di legami (passioni tristi), logica dell’usa-e-getta, continuo stato di
liquefazione: questi sembrano i tratti del dispositivo del controllo.
d) Formare ad una prassi filosofica nell’epoca della “liquidità” significa non solo
interrogare l’attuale, esercitare l’ Aufklärung, ma anche creare concetti adeguati alla
diagnosi per resistere ai dispositivi alienanti, vuol dire pensare. Pensare significa trovare
linee di fuga, significa essenzialmente analizzare l’archivio per scoprire ciò che siamo
stati ed esercitare l’interrogazione sul presente: “cosa posso vedere e cosa posso dire
oggi”? Ciò significa “pensare il passato come esso si condensa nel dentro, nel rapporto
con sé (c’è un Greco in me, o un Cristiano….) pensare il passato contro il presente,
resistere al presente, non per un ritorno ma «a vantaggio, spero di un tempo a venire»
(Nietzsche), e cioè rendere il passato attivo e presente al fuori, affinché accada
finalmente qualcosa di nuovo e il pensare giunga sempre al pensiero. Il pensiero pensa la
propria storia (passato) ma al fine di liberarsi da ciò che pensa (presente) e poter
finalmente «pensare altrimenti»”.138 Pensare significa sperimentare, problematizzare. Il
sapere, il potere e il sé sono la triplice radice di una problematizzazione del pensiero.
Pensare, in altre parole, significa creare concetti con i quali interrogare le lenti che
“abbiamo in dotazione” per guardare il mondo e le pratiche discorsive che gli danno
voce. Pensare significa scoprire le fratture della “bolla” in cui viviamo e descriverne i
limiti perché il “pensare altrimenti” sia possibile. Pensare è l’invenzione di altre possibili
136
G. Deleuze, Che cos’è un dispositivo, cit., p. 29.
Ibidem.
138
G. Deleuze, Foucault, cit., p. 158.
137
27
singolarità che possono emergere dal diagramma o che rimangono sospese nel fuori, le
“singolarità selvagge”. Pensare è un’opera creativa che chiede concetti nuovi per la
potenza del desiderio che viene repressa e assoggettata dai dispositivi del potere e del
sapere. Significa offrire possibilità di circo-scrizioni di sé, mai definitive, mai astoriche e
sempre in relazione all’altro. Significa trovare vie di fuga, smuovere il dispositivo che
rende impotenti. Significa interessarsi e riconoscere le condizioni e le possibilità
indefinite di trasformazione del soggetto. Significa resistere. Formare alla filosofia
significa educare al concetto, a quelle forme create dal filosofare che possono permettere
la resistenza.
E’ doveroso quindi approfondire nella direzione del concetto.
7. 1 Il concetto
Il riferimento sarà a Deleuze e Guattari di Che cos’è la filosofia?
La filosofia è l’arte di porre dei problemi adeguati e di sviluppare dei concetti attraverso i quali tali
problemi possono essere risolti. Da questo punto di vista, i concetti sono utili solo nella misura in
cui ci permettono di designare dei problemi specifici. Essi ci devono permettere di delimitare e
definire delle situazioni che sono esse stesse singolari139. La “creazione” filosofica non va intesa
come creazione ex nihilo, ma come uno sforzo volto a estrarre dal sensibile i punti singolari nei
quali la costituzione di un fenomeno viene decisa. Da questo punto di vista, in quanto creati, i
concetti sono i concetti del sensibile stesso. I concetti sono i prodotti in risposta a specifici eventi
che accadono nel mondo. I concetti, scrive Deleuze, non sono già fatti, non stanno ad aspettarci
come fossero corpi celesti140. Non sono oggetti di contemplazione. Il pensiero non è neppure
impegnato in un processo di riflessione. In altre parole, pensare, per Deleuze, non equivale a
rivolgere il proprio sguardo verso se stessi, esplorare la ricchezza delle idee innate. Pensare
filosoficamente non significa neppure riflettere sui vari campi precostituiti del sapere. Ma pensare
significa produrre concetti che rinviano a problemi specifici. I concetti sono “atto di pensiero”141, e
“devono essere in rapporto con i nostri problemi, con la nostra storia e soprattutto con i nostri
divenire”142. In altre parole il concetto è l’atto creativo specifico con cui la filosofia da un lato
interroga la realtà dei dispositivi che abitiamo, e dall’altro configura “la costellazione di un evento a
venire”143, le forme emancipative di soggettivazione. La filosofia, sostiene Deleuze, non è
comunicativa, non più di quanto sia contemplativa o riflessiva: essa è per sua natura creatrice e per
questo rivoluzionaria in quanto non smette di creare nuovi concetti. La sola condizione “è che essi
abbiano una necessità e un’estraneità, cosa che hanno nella misura in cui rispondono ai problemi
reali. Il concetto è ciò che impedisce al pensiero di essere una semplice opinione, un parere, una
discussione, una chiacchiera.”144
Rientrano nei concetti della filosofia anche ciò che Deleuze e Guattari chiamano “personaggi
concettuali”. L’Amico è uno di questi personaggi, a dire il vero un personaggio fondante e decisivo
per la storia intera del pensiero occidentale. E’ un’invenzione greca. È infatti la filosofia greca che
per prima presenta l’immagine del filosofo come “amico” del concetto. Filosofo è chi si trova
rispetto alla verità nella posizione del reclamante e perfino dell’amante.
Tra il filosofo e la verità, c’è qualcosa che assomiglia a un’affinità naturale, o a una predisposizione
reciproca che, sin dall’inizio, Deleuze vuole porre in questione. Deleuze insisterà sul fatto che non
siamo naturalmente propensi a pensare. Pensare non è qualcosa che emerge dal dentro, in modo
spontaneo. Il filosofo non è l’amico della verità. Egli è forse l’amante della verità. Deleuze intende
139
G. Deleuze F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, Einaudi, Torino, 2002, p. XIII.
Ivi, p. XI.
141
Ivi, p. 11.
142
Ivi, p. 17.
143
Ivi, p. 21.
144
G. Deleuze, Pourparler, cit., p. 181.
140
28
l’amore in un modo proustiano145, cioè crede che sia basato su una certa opacità e impenetrabilità
tra l’amante e l’amato e che esiga un’incessante decifrazione dei segni prodotti dall’amato. Il
pensiero genuino presuppone qualcosa come una cattiva volontà (una mauvaise volonté che non
deve essere confusa con una volonté méchante) e una certa discordia. La realtà del mondo, l’altro, a
cui la filosofia è sempre rivolta come oggetto d’amore, non è mai trasparente, mai intelliggibile e
richiede un’interrogazione, una decifrazione continua, una cura costante perché i volti del mondo
non collassino, perché il nuovo sia sempre possibile.
Ogni creazione di pensiero presuppone la costituzione di ciò che Deleuze chiama “immagine” o
“piano” e che non possono essere confusi con i concetti che vengono prodotti come risultato di tale
costituzione146. I concetti sono eventi e il piano è l’orizzonte degli eventi, il serbatoio o la “riserva
degli eventi puramente concettuali: non è l’orizzonte relativo che funziona come limite, cambia a
seconda dell’osservatore e ingloba stati di cose osservabili, bensì è l’orizzonte assoluto,
indipendente da ogni osservatore e tale da rendere l’evento come concetto indipendente da uno stato
di cose visibili in cui si effettuerebbe”147.
Deleuze sostiene che un concetto possiede sempre la verità che gli spetta secondo le condizioni
della propria creazione, secondo la relazione che ha con il piano. Il piano di immanenza è
l’immagine del pensiero, l’immagine che esso si dà di cosa significhi pensare, orientarsi nel
pensiero. L’immagine del pensiero è ciò che il pensiero può rivendicare di diritto e “ciò che il
pensiero rivendica di diritto (…) è il movimento infinito (…). Se il ‘volgersi verso…’ è il
movimento del pensiero verso il vero, in che modo il vero potrebbe evitare di volgersi verso il
pensiero? (…) Tuttavia non si tratta di una fusione, ma di una reversibilità, di uno scambio
immediato (…) tra l’uno e l’altro non c’è che una piega. In questo senso si dice che pensare ed
essere sono una sola e stessa cosa.(…) il piano di immanenza ha due facce, in quanto Pensiero e in
quanto Natura”148.
Il piano di immanenza è unico e tuttavia il nostro piano non è quello dei Greci, non si tratta né della
stessa immagine del pensiero né della stessa materia dell’essere. Il piano è l’oggetto di una
specificazione infinita, “che lo fa apparire come Uno-Tutto solo nel caso specificato di volta in
volta dalla selezione del movimento”149. Se è così, è del tutto inutile volere giudicare un pensiero,
chiedersi se questo o quel filosofo ha ragione o torto. Possiamo soltanto delineare il suo piano,
adottarlo noi stessi, oppure costituirne un altro.
Questa tesi stabilisce che, dietro o sotto ogni insieme di concetti che costituiscono un pensiero, vi è
qualcosa che assomiglia a un’intuizione, una comprensione pre-concettuale e pre-filosofica che
orienta tale pensiero. In altre parole, sembra sempre esserci qualcosa di prefilosofico nel cuore della
filosofia, qualcosa che, inoltre, segnala le condizioni interne della filosofia. Se la filosofia infatti
inizia con la creazione dei concetti, l’immagine del pensiero corrisponde al luogo dove tale pensiero
ha origine. Essa designa l’orizzonte dal quale esso pensa, e dunque qualcosa che assomiglia al suo
im-pensato: “è l’immagine del pensiero a guidare la creazione dei concetti. Essa è come un grido,
mentre i concetti sono dei canti”150.
Il non-fiolosofico si trova nel cuore della filosofia forse “più della filosofia stessa, il che significa
che la filosofia non può limitarsi ad essere compresa solo in maniera filosofica o concettuale, ma si
rivolge per sua essenza, anche ai non-filosofi”151. Il concetto, proprio perché in relazione al piano
d’immanenza, comporta altre due dimensioni: quella del percetto e quella dell’affetto.
“I percetti non sono percezioni, sono pacchetti di sensazioni e di relazioni che sopravvivono a
145
G. Deleuze, Marcel Proust e i segni, Einaudi, Torino, 1986, cap. II.
G. Deleuze F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, cit, p. 25.
147
Ivi, p. 26.
148
Ivi, pp. 27-28.
149
Ivi, p. 29.
150
G. Deleuze, Pourparler, cit., p. 197.
151
G. Deleuze F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, cit, p. 31.
146
29
coloro che li provano. Gli affetti non sono sentimenti, sono divenire che travalica colui che passa
attraverso loro”152. E’ proprio da docente universitario che Deleuze si rende conto che la filosofia
necessita anche di una comprensione non filosofica che opera per percetti ed affetti: “era come una
camera di eco, un circuito dove un’idea ritornava come se prima fosse passata attraverso diversi
filtri”153. La filosofia è la creazione di concetti, ma tale creazione avviene sullo sfondo di
un’intuizione, o di un’immagine di ciò che significa pensare. In altre parole, la filosofia inizia con i
concetti, ma si trova istituita o stabilita attraverso un piano, che essa estrae, per così dire, in modo
intuitivo e che risulta essere pre-concettuale. Il piano di immanenza, proprio perché pre-filosofico e
non opera per concetti, implica una sorta di “sperimentazione a tentoni, e il suo tracciato ricorre a
mezzi poco confessabili, poco razionali e ragionevoli: come il sogno, i processi patologici, le
esperienze esoteriche, l’ebbrezza o gli eccessi”154.
La filosofia si ritrova a gestire una situazione complessa: acquisire una consistenza tramite i
concetti e i personaggi filosofici, senza perdere l’infinito in cui il pensiero è immerso, il piano di
immanenza. La filosofia presenta tre elementi: il piano pre-filosofico che deve tracciare
(immanenza), i personaggi filosofici che deve inventare (insistenza) e far vivere e i concetti che
deve creare (consistenza). Se il concetto è una soluzione, “le condizioni del problema filosofico
devono stare sul piano di immanenza che esso presuppone ( a quale movimento indefinito rinvia
nell’immagine del pensiero?) e le incognite del problema nei personaggi concettuali che esso
mobilita (quale personaggio precisamente?).”155
Quali sono le condizioni per filosofare? “Una pura sociabilità come ambito di immanenza”, cioè
una “voglia di comunità”156 che si oppone alla “sovranità imperiale e che non implica alcun
interesse preventivo (…); un certo piacere di associarsi”, cioè l’essere avvezzi ai legami, alle
passioni gioiose; “un gusto per lo scambio di opinioni”, un parlare del mondo, una cura per il
mondo.157 La filosofia non è un piacevole commercio dello spirito, frutto di una sociabilità
disinteressata che si alimenta di conversazioni democratiche, capace di generare un’etica alla
comunicazione, ma la filosofia è creazione di concetti, cioè capacità di resistere: “non ci manca
certo la comunicazione, anzi ne abbiamo troppa; ci manca la creazione. «Ci manca la resistenza al
presente». La creazione di concetti fa appello di per sé a una forma futura, invoca una nuova terra e
un popolo che non esiste ancora”158. La filosofia come arte di creazione del concetto resiste alla
nuda vita, alla schiavitù, all’intollerabile, alla vergogna, al presente. La filosofia si riterritorializza
sul concetto. Il concetto è infatti territorio e proprio per questo ha una forma passata, presente e
futura. La filosofia moderna si “riterritorializza” sulla Grecia come forma del proprio passato, così
come la filosofia contemporanea si “riterritorializza” sulla filosofia moderna come forma
dell’avvenire.
Deleuze concepisce, quindi, la filosofia come una logica del molteplice. Infatti creare concetti
significa “costruire una regione del piano”, un territorio, “aggiungere una regione alle precedenti,
esplorare una nuova regione (…). Il concetto è un composto, un consolidato di linee, di curve”159. O
come dice Lipman160, il “pensiero multidimensionale” mira ad un equlibrio tra cognitivo e affettivo,
tra percettivo e concettuale, tra fisico e mentale, tra ciò che è governato da regole e ciò che non lo è.
Una didattica della filosofia che assume le riflessioni di Deleuze come principi del proprio agire
conduce necessariamente a porre come centrale l’analisi dei concetti. Se è vero infatti che la natura
della filosofia è essenzialmente creativa - crea concetti - allora insegnare filosofia comporterà una
152
G. Deleuze, Pourparler, cit., p. 182.
Ivi, p. 185.
154
G. Deleuze F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, cit, p. 32.
155
Ivi, p. 71.
156
Z. Bauman, Voglia di comunità, Laterza, Roma Bari, 2001.
157
G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, cit, p. 80.
158
Ivi, 102.
159
G. Deleuze, Pourparler, cit., p. 195.
160
M. Lipman, Educare al pensiero, Vita e Pensiero, Milano, 2003, p. 220.
153
30
pratica concettuale. La filosofia è conoscenza per concetti e ogni concetto rinvia ad un problema
senza il quale il concetto non avrebbe senso, pertanto l’insegnamento della filosofia non può
risolversi in un’analisi della varietà dei concetti espressi, ma deve mettere l’accento sui problemi
che alimentano e indirizzano la creazione dei concetti. Se non si opera in questa direzione il sapere
filosofico resta indeterminato, astratto e molto difficile da apprendere e da praticare. Occorre, nella
pratica didattica mostrare come ogni concetto sia in funzione di un problema e come al mutare di
questo avvenga una variazione del concetto stesso. Dunque ogni concetto ha la verità che gli spetta
in relazione alle condizioni della sua creazione. Formare una mentalità filosofica significa rendere
avvezzi ai movimenti filosofici: comprendere come un concetto appaia e svanisca, cambi di piano o
il piano, il problema muti, perda delle componenti o ne acquisisca delle nuove o si trasformi in base
al nuovo contesto.161 Accanto all’analisi dei concetti in funzione dei problemi, la pratica didattica
dovrà anche fermarsi sull’ambiente dove vengono creati i concetti e sulle condizioni della loro
creazione, cioè dovrà fermarsi anche sul piano. Infatti nell’atto della creazione il pensiero instaura
un piano che corrisponde all’immagine del pensiero e tale immagine mette in chiaro ciò che il
pensiero può rivendicare di diritto. Il piano di immanenza, come abbiamo visto più sopra, deve
essere considerato pre-filosofico: “prefilosofico non significa qualcosa che preesiste, ma qualcosa
che non esiste al di fuori della filosofia, benché questa lo presupponga. Sono le sue condizioni
interne. Il non-filosofico si trova nel cuore della filosofia”162. Se ci rifacciamo, come
esemplificazione a Cartesio, il problema fondamentale è: “Da cosa cominciare per poter
determinare la verità come certezza soggettiva assolutamente pura?”163 In riferimento a tale
problema è costruito il cogito. Cartesio crea, quindi, un piano ove non vi è presupposto nulla di
oggettivo, ma vi sono presupposti soggettivi (tutti sanno cosa significhi pensare, tutti hanno la
possibilità di pensare, tutti vogliono il vero) , il suo tentativo è quello di raggiungere l’oggettività
partendo appunto da questo piano, l’oggettività dovrà nascere dal piano sottostando alle regole
dettate dal problema gnoseologico, e da ciò che spetta di diritto al pensiero in un piano siffatto. Tale
immagine del pensiero è il discorso del rappresentante, il parlare per gli altri, ed è a tutti gli effetti
un atteggiamento pre-filosofico, pre-concettuale, inviluppato più in un sentimento che nella
razionalità.
Oltre al concetto, al problema e al piano l’analisi d’archivio deve comprendere anche i personaggi
concettuali. I personaggi concettuali operano a tutti gli effetti i movimenti che descrivono il piano
del filosofo e intervengono nella creazione stessa dei concetti. I personaggi concettuali non devono
essere confusi con i personaggi di un dialogo, o con personaggi storici, non sono neppure
determinazioni empiriche, sociali e psicologiche, sono irriducibili a tipi psicosociali. Pensiamo al
personaggio dell’Idiota in Cartesio164. L’Idiota vuole il piano privo di oggettività, ed allo stesso
tempo l’Idiota si configura per la mancanza di oggettività, esso stesso istaura il piano, lo desidera a
tutti i costi, col rischio di annullare il mondo della conoscenza; poi enuncia il cogito, tutte le
conoscenze dovranno riferirsi al cogito per assurgere a verità. Il personaggio concettuale più che
rappresentare il filosofo, lo attraversa.
Si comprende come tale didattica sia complessa, problematica e di difficile pratica vista, soprattutto,
in relazione al mondo istituzionale. Ma credo che il vantaggio che arreca, cioè rendere il sapere
filosofico vicino alla vita e tale da creare nuovi concetti, nuove forme possibili di liberazione, sia
tale da poter correre il rischio di praticarla.
Occorre mostrare agli studenti come si pensa e perché si pensa. Pensare è una lotta contro il caos.
Bisogna istaurare un piano d’immanenza che tagli il caos per dare dei movimenti possibili al
pensiero: “Il piano d’immanenza è come un taglio del caos, e agisce come un setaccio. Il caos, in
realtà, non è tanto caratterizzato dall’assenza di determinazioni quanto dalla velocità infinita con cui
queste si profilano e svaniscono: non è un movimento dall’una all’altra, ma al contrario
“Ogni concetto ha sempre una storia, ma una storia a zigzag, che può attraversare altri problemi o disporsi su piani diversi. In un concetto si
trovano spesso parti o componenti di altri concetti, che rispondevano ad altri problemi e supponevano altri piani”.161 Che cos’è la filosofia?, cit. p. 8.
162
Ivi, p. 31.
163
Ivi, p. 17.
164
Ivi, p. 51.
161
31
l’impossibilità di un rapporto tra due determinazioni, poiché l’una non appare senza che l’altra sia
già scomparsa. […] Il caos rende caotica e scioglie nell’infinito ogni consistenza [consistenza
concettuale]. Il problema della filosofia è di acquisire una consistenza, senza perdere l’infinito in
cui il pensiero è immerso”165. La lotta più dura, dunque, risulta essere quella contro l’opinione.
Perché se è vero che il caos minaccia il pensiero rendendo difficile la determinazione, è anche ciò
che dona e alimenta movimenti infiniti, offre al pensiero possibilità illimitate, al contrario
dell’opinione, che porta un pensiero preconfezionato, predigerito, in cui si nascondono tecniche di
potere atte ad imporre modelli di senso e stili di vita: il dispositivo. Avere un pensiero filosofico
significa anche demistificare tali forme e indicare linee di fuga. La spinta che immagino dovrebbe
muovere il docente di filosofia è quella di mostrare ai suoi studenti che il pensiero filosofico ha
sempre a che fare con la vita, che i concetti hanno a che fare con modi d’esistenza e viceversa.
Evidenziare questo collegamento tra concetto e vita, significa cogliere il carattere gaio della
filosofia, significa comprendere che la filosofia è, come afferma Spinoza, una riflessione sulla vita
non sulla morte.
In filosofia si crea per resistere. C’è, quindi, un profondo legame tra i segni, gli eventi, i concetti,
appunto, e la vita. E’ la potenza della vita non-organica quella che sta al fondo del concetto: “Si dirà
della pura immanenza che essa è UNA VITA, e null’altro (…) una vita è l’immanenza
dell’immanenza, l’immanenza assoluta: essa è potenza e beatitudine complete”166.
La filosofia come creazione di concetti ha riportato in primo piano la vita.
e) Riprendendo il discorso con le nuove acquisizioni, possiamo dire che la resistenza come
creazione di concetti oggi vuol dire collocarsi in un’etica dell’immanenza, cioè in un agire che
cerca di circo-scrivere un ordine all’interno della vita, un ordine immanente, non retto da
valori trascendenti o condizionato da norme sociali, che chiede una presenza continua
dell’altro. Se infatti il mondo della modernità liquida è quello dei corpi sventrati, martoriati,
fatti a pezzi dipinti da Bacon, allora formare alla filosofia significherà chiedersi come “non
essere governati in quel modo”, significherà interrogare i corpi che siamo, significherà non
astenersi dal giudizio, significherà creare concetti nuovi per un avvenire altro. Il dispositivo
che abitiamo e contro cui facciamo filosofia chiama un avvenire che sia capace di prendere in
seria considerazione le parole di Spinoza su “quanto può un corpo”, sulla sua natura. Infatti, se
è possibile pervenire alla propria forma solo attraverso l’esperienza del limite, ciò significa
che occorrerà lasciare ciò che eccede la nostra condizione. E la filosofia in quanto pratica
dell’interrogare e del creare concetti insegnerà a darsi la forma, a circo-scriversi. Darsi la
forma diventa questione cruciale. Infatti ogni esistenza, come sostiene Spinoza, o ha la forza
di esistere, la potenza, oppure perisce. Ma si può perire anche perché, non interrogando la
propria natura, non si pone alcun limite all’espandersi della forza: si cade in quella colpa che i
Greci hanno chiamato hybris. Circo-scriversi, darsi una forma, prendersi cura di sé è
imprescindibile se non si “vuole cadere sotto la tirannide (…) soprattutto oggi in cui, crollate
le mura della città, i confini si sono fatti più incerti, e le leggi che li presidiavano sempre più
fragili (…). Più i confini territoriali si allentano, più urgente diventa dare confini a se
stessi”167. Non solo. Prendersi cura di sé, “dare pensiero al corpo”168, significa riscattare
l’agire, che nella modernità liquida è limitato al button pushing, essenziale nella logica della
produzione ma che rende i nostri corpi superflui, cioè cose. Oggettivare l’altro e noi stessi
significa macchiarci della colpa metafisica:169 tollerare e non essere in grado di far nulla
rispetto a malvagità e violenza fatte subire ad altri. Ciò significa essere figli di
165
Ivi, p. 33.
G. Deleuze, L’immanence: une vie…., in « Philosophie », n 47, 1995, p.4, citato in R. Esposito, Bios, op. cit., p. 211.
167
U. Galimberti, La casa di psiche, Feltrinelli, Milano, 2005, p. 410.
168
Espressione usata da Elsa Stagnaro, danzaterapeuta argentina che lavora ad Udine e a cui devo tanto, non solo da un punto di vista affettivo, ma
anche intellettuale.
169
K. Jaspers, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, Raffaello Cortina, Milano, 1996, p. 21.
166
32
Eichman.170Prendersi cura di sé significa riconoscere che la vulnerabilità corporea che mi
consegna agli altri corpi disorientandomi, mi permette altresì “la nostra responsabilità
collettiva per la vita corporea l’uno dell’altro”171.
La vulnerabilità dei nostri corpi chiede una pratica della cura172che si declina nella capacità di
ascoltare e rispondere all’altro che mi disorienta, che si attua nella capacità di creare legami
non animati da passioni tristi, che non mi separa dal mondo, bensì mi prepara in vista degli
eventi del mondo. Cura di sé non è invito all’inazione, ma l’esatto contrario, è ciò che ci
costituisce come soggetti agenti: “anziché isolarci dalla comunità umana, essa emerge come
ciò che ci articola ad essa nel modo più esatto, poiché il rapporto privilegiato e fondamentale
con se stesso, deve permettergli (al soggetto) di scoprire se stesso come membro di una
comunità umana che, a partire dai legami più stretti, quelli del sangue, si estende all’intera
specie” .173 Formare alla filosofia vuol dire costituirsi come “punti di resistenza”174 nella
deriva del mondo ma anche punti di apertura per nuove comunità. Formare alla filosofia vuol
dire resistere alla stupidità. La stupidità è l’incapacità di creare concetti, è l’incapacità di
interrogarsi e farsi vivere nelle forme già date dei dispositivi. La stupidità si contrasta
nell’esercizio rischioso del pensiero che non vuole accontentarsi di soluzione note. Infatti il
fallimento del pensiero non è l’errata adeguazione del pensiero allo stato delle cose, ma la
rinuncia all’interrogazione della attualità che assicura la necessità di ciò che dà da pensare.
Pensare non è un fatto psicologico e non può essere ridotto alla consacrazione del
riconoscibile e del riconosciuto, si tratta invece di un’arte creativa, di resistenza e della
risposta ad una necessità in mancanza della quale siamo preda della stupidità, della banalità
del male. Formare alla filosofia, da ultimo, significa essere presi da una passione per la forma,
riconoscere che le forme abitano la nostra attualità sia nelle individuazioni realizzate, sia in
quelle a venire. Formare alla filosofia significa contrastare la tristezza che non rende
intelligenti; portare a riconoscere che i cattivi incontri impediscono di pensare, mantengono
nel torpore, nell’inerzia, nella stupidità. Invece deve favorire la gioia, l’affetto prodotto dalle
affezioni con corpi il cui rapporto si compone con il nostro. La gioia è un affetto, come la
tristezza, quindi una variazione e la variazione continua è la nostra condizione di essere
esposti agli incontri, agli altri corpi. Pensare spinti dalla gioia significa saper fare il maggior
numero possibile di incontri convenienti, cioè capaci di aumentare la nostra potenza di vita.
Per diventare meno stupidi e contrastare il torpore che lascia in balia degli incontri, serve
prendere come punto di partenza la gioia. Questa è la filosofia: difendersi dai cattivi incontri,
dalla tristezza, da ciò che ci rende stupidi e impotenti.
Praticando la filosofia, la critica, si acquista libertà: quando e se abbiamo prodotto molti
concetti, prodotti della gioia e della forza di esistere, possiamo creare forme libere di
soggettivazione. Formare filosoficamente significa creare un abito mentale che porti i soggetti
a poter “scegliere la propria compagnia tra gli uomini, le cose, i pensieri; nel presente come
nel passato”175. Significa discutere del mondo per amore del mondo: il soggetto resistente è
ancora inventore di senso. Fare resistenza significa affermare la propria differenza, significa,
nelle parole di Amleto, poter “rimettere in sesto il mondo”, significa produrre nuova
soggettività come espressione di eccedenza di vita, correndo il rischio della sconfitta.
Un frammento postumo di Nietzsche mi pare possa chiudere e ad un tempo aprire nuovamente
questa riflessione: “Se rimaniamo dentro di noi, come possiamo crescere e diventare più
ricchi! Per nutrirci ci è necessario, più di ogni altro cibo, il piacere delle cose straniere. Il
gusto dell’uomo è necessario per il nostro nutrimento”176. Come a dire che la posta in gioco
170
G. Anders, Noi figli di Eichman, Giuntina, Firenze, 1995.
J. Butler, Vite precarie, Meltemi, Roma, 2004, p. 51.
L. Mortari, La pratica dell’aver cura, Bruno Mondadori, Milano, 2006.
173
F. Gros, Note del curatore, cit p. 485.
174
S. Natoli, Guida alla formazione del carattere, Morcelliana, Brescia, 2006, p. 82.
175
H. Arendt, Tra passato e futuro, cit., p. 289.
176
F. Nietzsche, Frammenti postumi – Autunno 1880, in Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari , Adelphi, Milano, vol. V, tomo I, pp. 483-484.
171
172
33
passa attraverso i nostri corpi, vulnerabili e stranieri a noi stessi; corpi che portano, dalla
nascita, l’enigma di altri corpi. Attendere al corpo, interrogarlo, avere passione per le forme,
sembra essere l’opera della nostra resistenza.
34