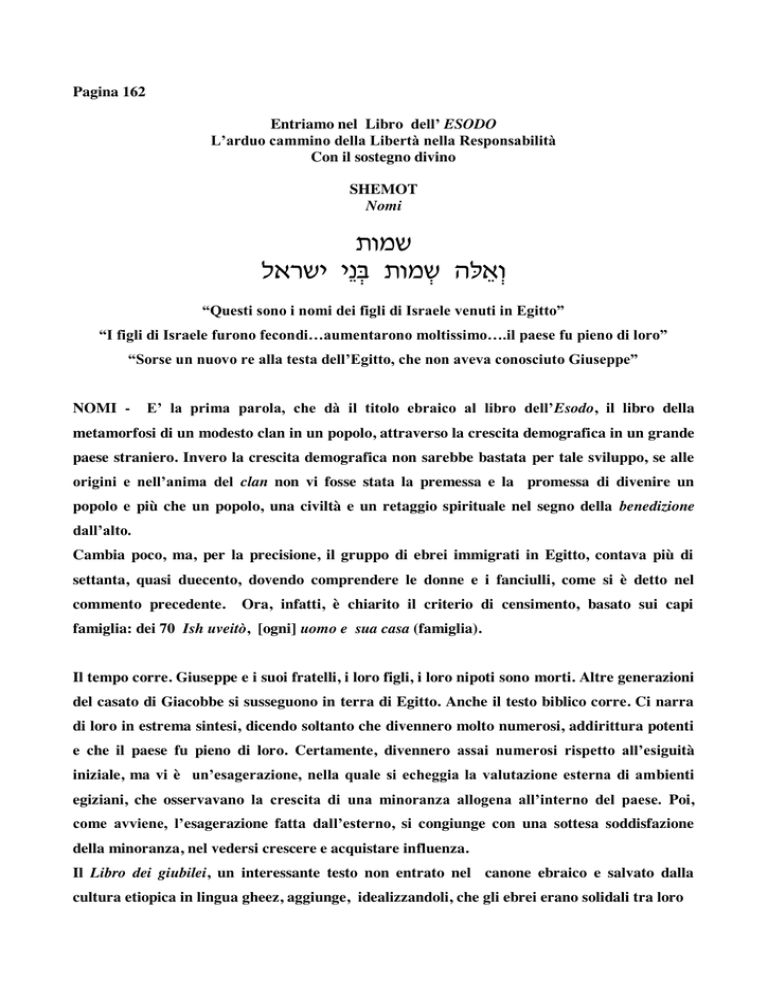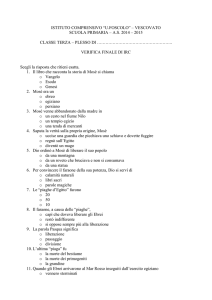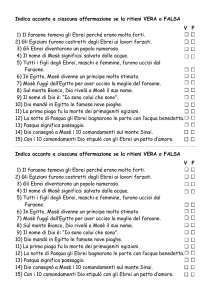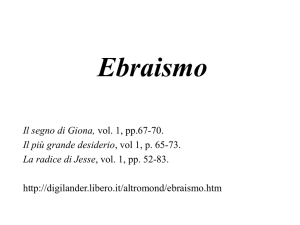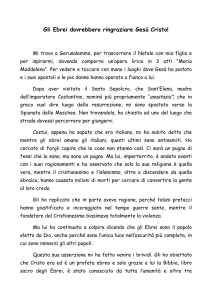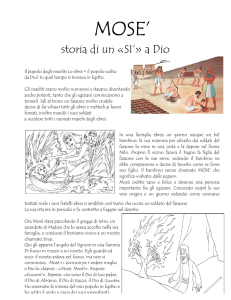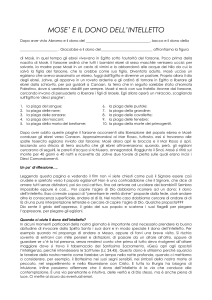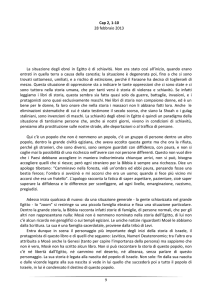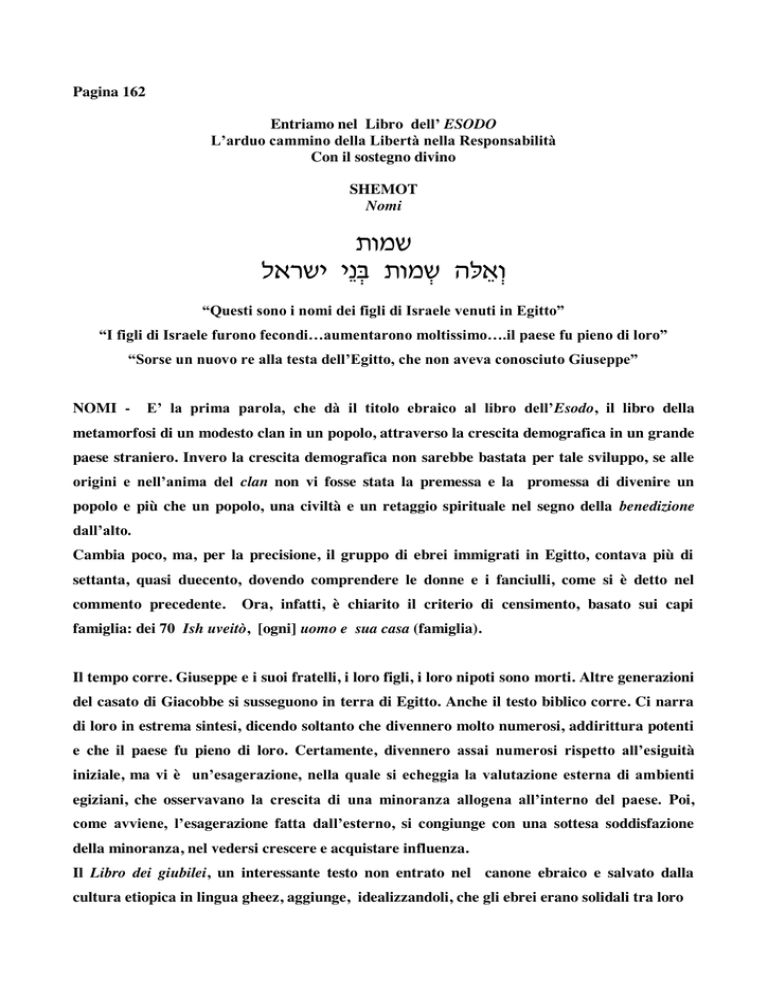
Pagina 162
Entriamo nel Libro dell’ ESODO
L’arduo cammino della Libertà nella Responsabilità Con il sostegno divino
SHEMOT
Nomi
“Questi sono i nomi dei figli di Israele venuti in Egitto”
“I figli di Israele furono fecondi…aumentarono moltissimo….il paese fu pieno di loro”
“Sorse un nuovo re alla testa dell’Egitto, che non aveva conosciuto Giuseppe”
NOMI -
E’ la prima parola, che dà il titolo ebraico al libro dell’Esodo, il libro della
metamorfosi di un modesto clan in un popolo, attraverso la crescita demografica in un grande
paese straniero. Invero la crescita demografica non sarebbe bastata per tale sviluppo, se alle
origini e nell’anima del clan non vi fosse stata la premessa e la promessa di divenire un
popolo e più che un popolo, una civiltà e un retaggio spirituale nel segno della benedizione
dall’alto. Cambia poco, ma, per la precisione, il gruppo di ebrei immigrati in Egitto, contava più di
settanta, quasi duecento, dovendo comprendere le donne e i fanciulli, come si è detto nel
commento precedente.
Ora, infatti, è chiarito il criterio di censimento, basato sui capi
famiglia: dei 70 Ish uveitò, [ogni] uomo e sua casa (famiglia).
Il tempo corre. Giuseppe e i suoi fratelli, i loro figli, i loro nipoti sono morti. Altre generazioni
del casato di Giacobbe si susseguono in terra di Egitto. Anche il testo biblico corre. Ci narra
di loro in estrema sintesi, dicendo soltanto che divennero molto numerosi, addirittura potenti
e che il paese fu pieno di loro. Certamente, divennero assai numerosi rispetto all’esiguità
iniziale, ma vi è un’esagerazione, nella quale si echeggia la valutazione esterna di ambienti
egiziani, che osservavano la crescita di una minoranza allogena all’interno del paese. Poi,
come avviene, l’esagerazione fatta dall’esterno, si congiunge con una sottesa soddisfazione
della minoranza, nel vedersi crescere e acquistare influenza.
Il Libro dei giubilei, un interessante testo non entrato nel canone ebraico e salvato dalla
cultura etiopica in lingua gheez, aggiunge, idealizzandoli, che gli ebrei erano solidali tra loro
Pagina 163
e si volevano fraternamente bene. Anche questa è una credenza diffusa tra i non ebrei circa
gli ebrei
e va bene se gli ebrei, nel compiacersene, mettano in atto tanta concordia e
solidarietà, non dimenticando la concentrica solidarietà umana. Il libro dei Giubilei, su cui
tornerò, è pubblicato negli Apocrifi dell’Antico Testamento a cura di Paolo Sacchi, in edizione
UTET.
Gli storici delineano un contesto politico generale, fatto non solo di una maggioranza egiziana
e di una minoranza ebraica, ma di una più larga immigrazione e infiltrazione di popolazioni
venute dall’Est, estesa al punto di occupare posizioni di potere e finanche di esercitare il
potere regio con una dinastia di origine straniera. Il gruppo più forte di queste popolazioni e
il nome saliente che designa la grande immigrazione-infiltrazione è HYKSOS. Nelle fonti
egizie, compare anche un altro nome di elementi allogeni, HABIRU, che si èipotizzato potersi
riferire agli Ivrim, gli ebrei. Secondo altri, la radice HBR simile a HVR indica degli associati,
dei federati (confrontare con l’ebraico ebraico Hevrah) o gruppi e bande di soldati mercenari
o dipendenti pagati per altre prestazioni, che a volte avanzavano pretese o si ribellavano.
Può essere che nella sopravvalutazione biblica del numero e dell’influenza dei discendenti di Giacobbe entri la sensazione data dal contestuale afflusso di altre popolazioni venute da Est,
con le quali c’erano elementi di affinità. Si ritiene che il faraone, a fianco del quale Giuseppe
ebbe un importante ministero, fosse della dinastia Hyksos. E’ allora pensabile che la dinastia Hyksos si fosse integrata nell’Egitto, si identificasse in un Egitto pluriculturale e agisse, o
ritenesse di agire, per il suo bene. Gli ebrei, nel solco dell’integrato Giuseppe, facevano probabilmente lo stesso. Dovevano essersi integrati, perfino assimilati, in notevole misura,
nella società e civiltà egiziana, pur conservando certe loro caratteristiche, tra cui, in gran
parte, l’onomastica e l’importante elemento della lingua ebraica. Vi erano probabilmente
matrimoni misti di ebrei e di egiziani, come risulta da un esempio recato nel capitolo 24 del
Levitico, ma si veda, in contrario, più in là, il commento di Rashì a pp. 172 - 173.
Non
dimenticarono l’ebraico e si può ritenere che fossero, in gran parte, bilingui, tra l’ebraico e la lingua egizia. Le successive esperienze storiche della diaspora ebraica nel mondo antico,
medievale e nel mondo moderno dall’emancipazione ad oggi aiutano, per presumibili analogie, a rappresentarci la situazione degli ebrei in Egitto; tanto più che lo stesso Egitto,
più tardi, in epoca ellenistica, divenne un primario centro della diaspora. La loro principale
occupazione era rimasta la pastorizia ma altri lavori si erano aggiunti, come dimostrano le
Pagina 164
abilità dimostrate durante l’esodo, e più tardi si diedero anche alla professione militare, come nella colonia di Elephantina.
Cambiano
le condizioni dal favore dei primi faraoni ai provvedimenti oppressivi di
successivi sovrani faraoni.
Nella
sofferenza della collettiva schiavitù, giunge il soccorso
divino, con la scelta delle guide, la liberazione e la rivelazione.
Nel XVI secolo avanti l’era cristiana avvenne la riscossa nazionale egizia contro gli Hyksos.
Sull’onda lunga della ristabilita fisionomia originale egizia si emarginarono le minoranze
allogene, tra cui doveva spiccare la discendenza di Giacobbe. Le sue ricchezze, quali che
potessero essere, facevano gola allo Stato e a privati egizi. Le loro braccia, come tutte le
braccia da adibire a lavoro non rimunerato, con poca spesa di mero sostentamento, in
società ad economia schiavistica, apparvero un facile ingrediente da sfruttare per la politica
di imponenti lavori pubblici dei nuovi Faraoni, con costruzione di nuove città. Lo farà,
analogamente, da parte ebraica, il re Salomone, sottoponendo a lavori obbligatori per
progetti edilizi ed urbanistici i discendenti di popolazioni non ebraiche rimaste in terra di
Israele (emoriti, ittiti, perizei, hivvei, gebusei) e continuarono a farlo i successori: ce lo dice il
primo libro dei Re al capitolo 9.
Tuttavia, contemporaneamente, i primi grandi re di Israele
promossero competenze per importanti servizi tra le popolazioni del paese e fra stranieri di
fuori del paese.
Il Faraone spiega il piano persecutorio al suo popolo, si direbbe per convincere l’opinione pubblica alla svolta politica verso una minoranza, e siamo edotti dalla campagna antiebraica
negli anni ’30 – ’40 del Novecento, di qualcosa di simile, per meglio comprendere il discorso del sovrano agli egiziani, che si potevano stupire delle restrizioni a carico di una gente che
conoscevano, che viveva tra loro oppure in zona contigua a loro, avendo elementi di vita in
comune. Così è reso, in sintesi, nella Torah: <<Ecco, il popolo di Israele è più numeroso e più
potente di noi. Orsù, agiamo con saggezza (scaltrezza, previdenza) nei suoi riguardi, affinché,
moltiplicandosi non accada che, accadendo una
guerra, si unisca ai
nostri
nemici
e
combatta contro di noi e salga (fuori) dal paese>>. In questa sorta di avviso o di proclama, il
faraone esprime la preoccupazione per
il pericolo di una massa straniera, quale quinta
colonna, che si sollevi in appoggio a un esercito straniero dall’interno del paese nel corso di
Pagina 165
una guerra. L’Egitto combatteva frequenti guerre contro altre potenze ed il pericolo, se adottiamo il punto di vista del governo egiziano, poteva effettivamente sussistere, ma ciò fa
pensare che già con questa massa straniera, non integrata, non corressero buoni rapporti,
mentre la florida condizione degli ebrei, da secoli in Egitto indurrebbe a pensare che non
avessero propositi ostili od eversivi e che anzi fossero interessati a concorrere alla difesa del
paese in caso di attacco esterno.
essere di favorirne
Ad ogni modo, temendoli, la soluzione avrebbe potuto
l’emigrazione, ma l’ultima parte del periodo rende problematico il
discorso, perché il faraone si preoccupava anche che gli ebrei uscissero dal paese.
vuol dire?
Che
A nemico che fugge non si fanno ponti d’oro? Un’ipotesi è che si trattasse della provincia di Goshen, dove gli ebrei, per decisione di Giuseppe e autorizzazione del suo
faraone, si erano insediati: cioè
che, uscendo da quella provincia, dove erano stanziati,
potessero dilagare in tutto l’Egitto. Ma, poco prima, il testo biblico ha detto che gli ebrei
erano divenuti potenti e che <<il paese fu pieno di loro>>.
Quale paese fu pieno di loro?
Solo Goshen, dove all’inizio dovevano essere una minoranza e dove stavano diventando la
maggioranza? Oppure il complesso dell’Egitto, dove, uscendo dalla zona assegnata, si stavano
spargendo? Una tesi, per spiegazione storica, è che l’Egitto era impegnato, con operazioni di stazionamento e talora di guerra, nel controllo della terra di Canaan (a Timnah si conserva
bene il resto archeologico di un tempio egizio), dove probabilmente c’erano ancora, tra i ribelli al dominio egiziano, degli ebrei non emigrati in Egitto (già lo si è detto nei commenti a
parashot precedenti), sicché una massa di ebrei fuoriusciti dall’Egitto, in cerca di una patria
indipendente, si sarebbe unita alla resistenza indigena o a nuove ondate di popolazioni
asiatiche che, traversando la terra di Canaan, tendevano a penetrare in Egitto.
Il Libro dei giubilei narra, a questo proposito, di un Mamekeron, re di Canaan, che riuscì ad
uccidere in battaglia un re egiziano ed inseguì gli egiziani tentando di entrare nel grande
paese, ma fu fermato dal rafforzamento dell’Egitto sotto un nuovo faraone.
Il testo biblico è conciso e dall’esternazione regia del temuto pericolo
passa al
provvedimento del lavoro coatto nel settore edilizio (durissimi lavori di malta e di mattoni),
con costruzione di nuove città, e in altri settori produttivi, tra cui l’agricoltura.
L’assoggettamento al lavoro coatto
è organizzato con una amministrazione di appositi
funzionari, saré missim
Vaiasimu alav saré missim
E stabilirono su di esso (sul popolo dei figli di Israele) funzionari dei missim
Pagina 166
Il singolare di questo sostantivo è mas, che indica una tassa, un tributo,
oppure una imposizione di lavoro
In Francia si chiamava corvée, una prestazione di lavoro dovuta dagli umili ai signori feudali.
Dunque il governo egiziano risolve il pericolo della massa straniera togliendole libertà di
movimenti, controllandola strettamente e
obbligatorio.
Dal
sfruttandola
piano politico – militare si passa
economicamente con il lavoro
alla riduzione in servitù e alla
convenienza economica nello sfruttamento del lavoro coatto per lo Stato.
Malgrado la riduzione in condizioni miserevoli, la popolazione ebraica aumentava per la
forte natalità. Questa avrebbe potuto convenire all’Egitto, ora che gli ebrei erano asserviti e strettamente controllati,
per crescita di manodopera a basso costo, come avveniva nelle
piantagioni dell’America al tempo dello schiavismo, per il valore economico dell’uomo ridotto in schiavitù.
Invece il
governo faraonico torna a preoccuparsi per il gran numero degli
ebrei e passa dalla politica di sfruttamento umano, per convenienza economica, alla politica
genocida di annientamento con l’ordine dato alle levatrici ebree di eliminare alla nascita i maschi, lasciando vivere le femmine. L’apparente clemenza verso la metà femminile del popolo si sarebbe risolta, entro non molto tempo, nella scomparsa del popolo stesso, come
identità etno-culturale, per la fine dei congiungimenti tra ebrei. Questa era già una soluzione
finale, in capo a una generazione o due, del problema ebraico. Anzi la tradizione dice che
coniugi cominciarono già ad astenersi dai rapporti sessuali per non far nascere bambini
destinati alla soppressione. La soluzione finale hitleriana reca luce per lo scioglimento della
contraddizione che c’è nella formula schiavizzazione più genocidio: schiavizzare gli adulti atti
al lavoro e sopprimere i bambini insieme a tutti i non abili, quindi una schiavizzazione a
tempo, buona per una generazione. Questa cosa è nettamente contraria al puro disegno
economico dello schiavismo normale e tradizionale, che invece alleva i bambini, come gli
animali, per perpetuare il patrimonio. Nel caso hitleriano ci sono due spiegazioni dell’ assurdo economico: l’elemento psicologico dell’odio di razza e la connessa deliberazione di far presto per risolvere la questione ebraica in pochi anni, durante il trambusto della guerra
mondiale.
L’ordine dato alle levatrici ebree, che si chiamavano Shifrah e Puah, di eliminare
i connazionali maschi alla nascita, suppone, nell’ottica del faraone, un condizionamento
degli ebrei oppressi alla collaborazione nell’oppressione ed eliminazione dei loro fratelli. E’ un problema serio che si pone nella storiografia della shoah, ed il comportamento
intelligentemente renitente delle due donne suona, in contrario, a prova di una capacità di
Pagina 167
resistenza e di fratellanza tra gli oppressi. Al rimprovero del faraone (o di suoi funzionari)
per aver lasciato in vita i maschi esse risposero vantando la robustezza delle donne ebree che
partoriscono prima di aver bisogno del loro intervento.
Sicché il faraone rinuncia alla
soppressione immediata in sala parto e ordina che ogni neonato maschio ebreo sia gettato nel
Nilo.
E’ a questo punto che nasce Moshè, l’uomo destinato alla liberazione del popolo ebraico, da
Amram e Jokheved (i nomi dei genitori compaiono nella successiva parashah Vaerà), e viene
posto dalla madre, dopo tre mesi dalla nascita, in un cesto spalmato di pece e bitume, sulla
riva del Nilo. Lo affida alla sorte ed alla provvidenza, che si fa strada attraverso chi meno si
sarebbe potuto immaginare, la principessa di Egitto, figlia del Faraone, venuta con le sue
ancelle a prendere un bel bagno nel fiume allora salubre e non inquinato. La figlia del re è la
prima a disobbedirgli. Vede un cesto galleggiare, se lo fa portare da un’ancella, lo apre, vede
un bel bambino e capisce che è un bambino degli ebrei, affidato alla buona sorte.
Vatered bat parò lirhoz al haieor
Vatterè et hatevah
Vatishlakh et amatah vattikahea
Vatiftah vattirehu et haieled
La principessa lo dà da allattare ad una donna ebrea, che, guarda caso, è la mamma,
appostata trepidamente nelle vicinanze, grazie al provvido accorrere della figlia Miriam,
vigile nei paraggi per seguire il fratellino. Quando il fanciullo esce dalla prima infanzia, la
madre lo conduce alla principessa, che lo aveva evidentemente richiesto. La figlia del
Faraone lo adotta, gli mette nome Moshè dalla radice ebraica hoshia, che vuol dire salvare
perché è stato salvato dalle acque. Tale è la spiegazione che la Torah dà del nome, congrua
con la salvezza del fanciullo dalle acque in lingua ebraica, ma alla luce dell’egittologia, essendo la principessa egiziana, il nome Mosè è riconducibile ad un vocabolo egiziano che
vuol dire figlio o ragazzo: un ragazzo, un figlio per antonomasia, che la principessa ha
adottato ed ha educato a corte. Il termine mose si trova, come suffisso, in celebri nomi egizi,
Pagina 168
quale Tutmosi, nome portato da ben quattro faraoni di una dinastia regnante in un tempo
precedente, non di molto, rispetto alla nostra vicenda. Il Libro dei giubilei ci dà il nome della
principessa egiziana: Tarmut, o Termuti. Da questa fonte lo prese, nell’opera Antichità
giudaiche, Giuseppe Flavio. Il Libro dei giubilei narra inoltre che il padre di Mosè (chiamato
Enbaram, invece che Amram, come attestato nella Torah) proveniva da Hebron in terra di
Canaan. Sarebbe cioè stato uno degli ebrei rimasti là, o discendente di ebrei venuti in Egitto
in una ondata migratoria successiva rispetto al tempo di Giuseppe e di Giacobbe. Sempre
secondo il Libro dei giubilei, sarebbe stato il padre a dare istruzione a Mosè e addirittura a
introdurlo a corte.
In una comparazione di racconti leggendari, la salvezza del bambino dalle acque ricorre per
altri grandi personaggi dell’antichità, in particolare il re Sargon, fondatore della dinastia
accadica, vissuto molto prima della nostra vicenda. La leggenda ha precedenti ed analogie, ma
è bene ambientata nello scenario egiziano, con centralità del Nilo e della Corte, e si staglia
nella situazione del popolo ebraico oppresso, quando nasce e cresce avventurosamente il
liberatore per vie della provvidenza. Del resto, anche dalla storia recente, emergono casi di
bambini salvati in circostanze eccezionali di nascondiglio, di esposizione, di consegna dai
genitori o da altri a persone che ne hanno avuto cura. La salvezza di Mosè per cura della
figlia del Faraone e la sua educazione a corte, proprio in un periodo di persecuzione degli
ebrei, pone il problema dell’identità e della biografia dell’uomo che riveste un ruolo centrale nel Pentateuco e nella caratterizzazione religiosa del popolo ebraico.
La tesi estrema, balenante dall’antichità, ripresa da studiosi moderni e resa famosa nel
mondo della cultura da Sigmund Freud nell’opera Der Mann Moses und die monotheistische
Religion, in edizione italiana Mosè e il monoteismo (Milano, Pepe Diaz, 1952, e successive) è
che Mosè fosse un egiziano
postosi a capo degli ebrei.
Comincio da una storiella per
alleggerire il tema, prendendola da André Chouraqui nel libro Mosè (edizione Marietti): un
rabbino chiede a uno scolaretto chi fosse la mamma di Mosè. Lo scolaretto, il solito malizioso
Pierino, risponde che la mamma di Mosè era la principessa egiziana. Il rabbino lo corregge,
dicendogli che la principessa lo ha trovato nella cesta sul fiume. E Pierino gli replica:
<<Signor Rabbino, questo è quello che ha raccontato la principessa>>. Ma la principessa
poteva trovare altre scuse e, identificandosi nella salvatrice di un bambino ebreo, avrebbe
comunque compiuto una bella sfida e un merito non da poco. Barzelletta a parte, la teoria
secondo cui Mosè fosse un egiziano è dovuta, per quanto ne sappiamo, allo scrittore
Pagina 169
egiziano Manetone del terzo secolo avanti l’era cristiana, al tempo di quei sovrani Tolomei, che condussero campagne di guerra in Eretz Israel,
prelevando
schiavi altri ebrei e
portandoli in Egitto. Ne ho parlato nel numero 21-24, a. XVI (2008) di “Hazman Veharaion –
Il Tempo e L’Idea”, a proposito del profeta Joel e dell’analisi fatta dal biblista Marco Treves, per la datazione del libro di Joel.
Secondo Manetone, scrittore e storico egiziano di età ellenistica, ostile agli ebrei, che
costituivano nello stesso Egitto una ampia comunità,
Mosè sarebbe stato un sacerdote di
Heliopolis, degenere e rinnegato, che capeggiò una rivolta di reietti, di negri e di lebbrosi.
Gli ebrei sarebbero stati appunto dei lebbrosi, in una rappresentazione dell’ebreo come
qualcosa di ammorbante e repellente.
Con ben altro, ma strano intento, di intellettuale
ebreo moderno , la teoria del Mosè egiziano fu ripresa da Sigmund Freud nell’ultimo e contestato libro, Mosè e il monoteismo, di cui egli stesso negli ultimi giorni si dolse, perché
aveva tolto al suo popolo, tanto perseguitato dai nazisti, perfino il suo eroe, per giunta
accusando gli ebrei di averlo ucciso, secondo lo schema psicanalitico dell’inconscio patricida. Mosè, per noi, era e resta ebreo, ma vera, e ben credibile, è la sua acculturazione egiziana,
la sua privilegiata integrazione a corte (anche in Germania, prima dell’emancipazione,
c’erano fortunati ebrei di corte, trattati in altro modo degli ebrei umili). Fino alla piena
maturazione della sua personalità come guida e profeta di Israele, l’ebreo Mosè è stato anche
un egiziano, insomma un ebreo egiziano, per quel fenomeno di identità composita, che è
largamente esteso e comprovato nei nostri tempi. Gli ebrei in Egitto, prima della persecuzione
e forse anche dopo, erano alquanto integrati in quella società e cultura. Lo era, almeno, una
parte di loro. La stessa tradizione ebraica, con dei midrashim al riguardo, informa delle
esperienze di Mosè come egiziano di alto rango e la leggenda dell’educazione ricevuta dalla
principessa egiziana ovviamente lo implica. Al capitolo 11, versetto 3 di Esodo (successiva
parashah Bo) si legge che l’uomo Mosè era (considerato) molto grande in Egitto tanto dai cortigiani del Faraone come dal popolo:
ָה ִאיש מ ֶֹשה גָדול ְמאֹד בּ ְֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים
וּב ֵעינֵי ָה ָעם
ְ בּ ְֵעינֵי ַע ְב ֵדי ַפרעֹה
Il filosofo ebreo Filone di Alessandria, nella Vita di Mosè, afferma che questi fu iniziato alla
filosofia simbolica degli antichi egizi. Filone, lui stesso vissuto in Egitto (tra il I secolo a.C. ed
il I d.C.), da intellettuale ebreo a contatto con la storia culturale del paese, ha fornito con ciò
sensibili indicazioni sulla relazione che può esservi stata tra Mosè e la sapienza egiziana. Di lì
Pagina 170
a poco,
Stefano, un esponente del movimento ebraico sorto intorno a Joshua di Nazaret,
accusato di blasfemia e di eversione davanti al Sinedrio, tenne un riepilogo della storia
ebraica fino ad un certo punto condivisibile da ogni ebreo. In questo discorso, parlando di
Mosè, Stefano disse che <<venne istruito in tutta la sapienza degli egiziani>> (Atti degli
apostoli, capitolo 7, versetto 22). Queste complementari affermazioni, della Torah, di Filone
e di Stefano,
hanno servito di orientamento quando, dal Rinascimento in poi,
si sono
sviluppati gli studi sull’antico Egitto (Egittologia) e quando, in parallelo, si è cominciato a
voler intendere la Bibbia con una analisi storica, critica, filologica. Si ricostruivano così le
relazioni tra il ruolo fondante di Mosè nell’evoluzione dell’Ebraismo e certe premesse che lo
stesso Mosè assorbiva da ambienti della sapienza egizia, di cui era partecipe. Al
netto
contrasto tra la rivelazione monoteistica del monte Sinai e la mitologia politeista degli egizi si
venne sostituendo un quadro più articolato
della religione egiziana,
dove spiccavano,
differenziandosi dalle forme popolari, circoli sapienziali dotati di una visione dell’unità cosmica e la selezione di una divinità che eccelleva sulle altre. Il faraone Aknaton, campione
di una tale tendenza,
tentò di imporre il culto della divinità solare, reprimendo riti e
credenze popolari. Dopo la sua morte il tentativo fallì e si tornò al politeismo, ma permasero,
o fiorirono, in cenacoli esoterici di iniziati, suggestive ideazioni di misteri e concezioni di
una pervasiva energia
divina, a vero fondamento dell’essere.
Questi grandi concetti
splendevano in brevi iscrizioni, sulla piramide di Sais e nel Tempio di Iside, personificazione
divina della Madre Natura: <<Io sono tutto ciò che è, che è stato e che sarà, e nessun mortale
ha sollevato il mio velo>>. Con le dovute differenze,
rivelatosi, come sapete e presto vedremo,
racchiuso nel tetragramma
vi si è collegato il nome del Dio
a Mosè col significato supremo dell’Essere,
יהוה
Le differenze vertono sul soggetto di questo essere, se sia un’entità impersonale, che si identifica con la totalità dell’essere (tutto ciò che è) oppure un soggetto personale, un Io
divino, che trascende e crea la natura, e che interviene nella storia, liberando gli ebrei
dall’Egitto, o chiamando distruttivi imperi a punirli;
il Dio che fa delle scelte, il Dio che dà
delle disposizioni precise, come è nelle parole dello Shemà, tratte dal Deuteronomio. Questo
Dio, distinto (qadosh) e legislatore, è propriamente il Dio di Mosè, ma la differenza con cui
spicca non esclude affatto il contatto, sulla base ontologica
dell’essere, con scuole della
sapienza egizia. Il Dio che si rivela a Mosè sul Sinai è pur sempre il Dio misterioso,
Pagina 171
impenetrabile, lo El mistatter di Isaia e di cui parlano i grandi misteri egizi. Va inoltre detto
che l’altra rappresentazione, del Dio identificato con la sostanza del tutto, diversa dalla
linea maestra della Bibbia, si teorizza nella filosofia di Baruch Spinoza,
affiora in altri
pensatori ebrei, come Mordekai Kaplan, ed è soffusa, misticamente e poeticamente, nel
hassidismo.
Secondo certi studiosi, che riprendevano il racconto di Manetone, Mosè sarebbe stato lui
stesso un egiziano, che riprendeva, in certo senso, con successo, il tentativo di Aknaton,
mettendosi a capo degli schiavi ebrei, in una operazione doppiamente rivoluzionaria: perché
abbatteva la fede negli altri dei, imponendo la fede in un unico Dio, e perché guidava la
ribellione di una massa di schiavi contro il potere costituito della grande monarchia egiziana.
Il filo di questa tesi, secondo cui Mosè era egiziano, è arrivato a Sigmund Freud, che vi ha
aggiunto il dramma dell’uccisione di Mosè per mano degli ebrei, reagenti alla sua severa
autorità, nella logica del complesso di Edipo che porterebbe il figlio all’ idea di eliminare il
padre. La Torah parla di rivolte e di dolori cagionati a Mosè dal suo popolo, ma non
ovviamente, di uccisione di Mosè, giunto vecchissimo a veder dall’alto del monte la terra promessa. La Torah ci dà i nomi dei suoi genitori ebrei, del fratello Aronne, della sorella
Miriam.
Mosè non si è messo a capo di una generica massa di schiavi, ma di un popolo, il
suo popolo, che era stato reso schiavo. Che poi un’altra moltitudine di egiziani o di altre
popolazioni gli si sia unita (lo dice Esodo, 12, v. 38) è un significativo fatto di
umana
convergenza, ma l’evento centrale è stato un riscatto nazionale, guidato da un condottiero della nazione.
Che Mosè fosse etnicamente ebreo, sebbene di cultura largamente egizia,
anche
lo ha creduto
l’ebraista cristiano del Seicento John Spencer, autore della monografia De legibus
Hebraeorum ritualibus et eaurum rationibus
e della dissertazione De urim et thummim.
Secondo Spencer, Mosè ha tratto dalla sapienza egiziana non soltanto un elemento teologico
ma anche precetti rituali. Lo stesso Maimonide, di cui Spencer teneva assai conto, attribuisce
l’origine di determinati precetti ad un divino criterio pedagogico, per senso dell’opportunità, in rapporto ai tempi e alle circostanze ambientali. Le circostanze ambientali erano quelle del
vicino Oriente, erano di quell’epoca, erano specialmente dell’Egitto. Spencer è stato uno dei
molti studiosi, in un complesso plurisecolare del sapere, all’incontro di egittologia e di ebraistica.
Per sapere di più intorno a questa tematica, segnalo il libro Mosè l’egizio, edito
Pagina 172
da Adephi (Milano, 2007), di Jan Assmann, professore tedesco di egittologia all’Università di Heidelberg.
Mosè è stato egiziano come Teodoro Herzl è stato austroungarico e di cultura tedesca. L’uno e l’altro sono stati grandi ebrei, in esistenze fuori della terra di Israele ma volti all’acquisto di questa terra per il loro popolo. Come Herzl è cambiato e ha organizzato il movimento sionista
nel prender coscienza delle persecuzioni cui era soggetto il popolo ebraico nel suo tempo,
con un particolare impatto del caso del capitano Dreyfus, seguito da giornalista a Parigi, così
Mosè allorché, uscito dall’ambiente dorato della Reggia, si imbatte nel maltrattamento di un fratello ebreo, fatto da un sorvegliante egiziano, episodio rivelatore della situazione. L’ebreo di corte, personalmente al riparo dalla persecuzione, compie il gesto isolato, eccezionale per
quanto ne sappiamo, di resistenza con la forza, colpendo a morte l’aguzzino del fratello. Non è visto, ma la denuncia gli viene quando il giorno dopo torna sul luogo e vede due ebrei
litigare tra loro, altro episodio che gli chiarisce il degrado della situazione: nell’impossibilità di
difendersi
dai
persecutori,
i
connazionali
nell’atteggiamento del giorno prima Mosè
arrivano
a
picchiarsi.
Come
già
mette in atto un precetto che insegnerà da
condottiero, per ispirazione del Signore lungo il cammino dell’Esodo: Al titeallem, Non
disinteressarti, non puoi non curartene. Rimprovera quello dei due che gli pare abbia torto o
forse quello che aveva la meglio nel confronto fisico: <<Perché batti il tuo compagno?>>
Lamma takkè reekha?
Il violento, rimproverato, gli chiede con quale autorità si ingerisca e se voglia uccidere anche
lui come ha ucciso l’egiziano. Mosè è così al corrente che la cosa era risaputa. Lo è venuto a
sapere anche il faraone, che voleva punirlo mortalmente
e Mosè, fuggendo, giunge in terra
di Midian. Il commentatore medievale Rashì, sulla scorta di precedenti fonti narrative, ha
individuato l’aguzzino egiziano, ucciso da Mosè, e l’ebreo maltrattato, indicando il motivo al fondo dell’episodio: l’ebreo maltrattato sarebbe il marito di Shelomit, figlia di Divrì, di cui si
pala nel capitolo 24 del Levitico, come madre ebrea del ragazzo bestemmiatore messo a
morte, il cui padre era invece egiziano, sicché il frutto del congiungimento misto sarebbe
appunto così tristo. Ebbene l’egiziano, di cui si parla nel Levitico, sarebbe questo aguzzino, ucciso da Mosè, il quale non era marito di Shelomit, regolarmente sposata con un ebreo,
l’ebreo bastonato e vendicato da Mosè. Questo crudele egiziano, invaghitosi di Shelomit,
Pagina 173
avrebbe con un pretestuoso ordine allontanato il marito e, venuto in casa, avrebbe giaciuto
con lei, ignara di far l’amore con un altro uomo, entrato slealmente nel talamo. Quando poi il marito ha scoperto l’inganno e l’oltraggio, avrebbe osato rivoltarsi contro l’egiziano, che, profittando della sua posizione di
quando è sopravvenuto Mosè.
sorvegliante dei lavoratori ebrei, lo stava bastonando
Nei due ebrei che più tardi litigavano, Rashì, sulla scorta del
trattato talmudico Nedarim, ha individuato Datan ed Aviram, i futuri protagonisti della
contestazione e rivolta contro Mosè ed Aronne, alleati di Korah, di cui si parla nella parashah
intitolata a quest’ultimo, in Numeri, capitolo 16. La prima individuazione ci mostra un
risvolto di cupidigia ed abuso al livello privato nella storia della persecuzione egiziana, ma
soprattutto tende a smentire che ci potessero essere matrimoni misti con gli egiziani, come io
stesso ho desunto, a pagina 163, da questo caso, preso come un caso qualsiasi, indicativo di un
fenomeno sociale. Secondo questa versione, la madre del ragazzo bestemmiatore, nato da
quell’abuso del sorvegliante, era legittima moglie di un ebreo così umiliato, e non aveva
sposato un egiziano ma era stata da lui oltraggiata. Ebbene, sia la prima che la seconda
individuazione rispondono ad un criterio esegetico ed omiletico, per cui tutti i fili narrativi si
congiungono e tutti i personaggi si ritrovano, a sostegno di una tesi di omogeneità di popolo e
di religione.
Abbiamo già osservato questo criterio a proposito dell’agnizione della figlia di Dina in Osnat, creduta figlia del sacerdote Potiphera, divenuta moglie di Giuseppe (si torni,
se vi interessa, alla pagina 128 di questo commento della Torah).
Mosè recepì elementi della cultura egiziana, sviluppandoli da ebreo, e non deve essere stato il
solo tra gli ebrei colti. Mosè appariva un distinto egiziano, tanto che quando, fuggendo, ripara
nel paese di Midian e difende, cavallerescamente, le figlie di Reuel o Itrò al pozzo, le ragazze
riferiscono al padre: <<Un uomo egiziano ci ha difeso dalla violenza dei pastori ed ha anche
attinto per noi ed abbeverato il gregge>>.
Ish mizrì hizilanu miiad haroim
E lì, tra i midianiti, Mosè trova una dimora, trova moglie, Zipporah figlia di Reuel o Itrò,
come Giuda aveva fatto tra i canaanei, senza perdersi. Genera da lei i due figli, Ghershom e
Pagina 174
Eliezer. E lì, dall’esimio suocero sacerdote di Midian, apprende altre cose, assorbe elementi
di un’altra cultura e spiritualità nel suo animo di ebreo acuto ed intenso.
Mosè è un ebreo di Egitto, che, nella persecuzione dei fratelli ebrei, ricupera la pienezza
dell’identità originaria ebraica, senza perdere l’involucro della formazione egiziana, ma nel
contempo lottando contro il governo egiziano per la liberazione del suo popolo,
procede
verso la maturazione della sua vita, nella nuova stazione di Midian.
Il Signore Iddio, che pensa come attuare il deliberato soccorso al sofferente popolo ebraico,
studia e sceglie quest’uomo solitario, questo ebreo particolarmente intriso di cultura e di
modi egiziani, questo ebreo non schiavo, ricercato come assassino di un egiziano, quest’uomo atipico, di confine, ma intrepido sul confine. Il Signore Iddio lo individua, lo segue, lo fissa,
lo sceglie, attende il momento di farlo suo e di farlo veramente se stesso. Ed ecco un giorno,
mentre
pascola il gregge del suocero, come aveva fatto Giacobbe in Haran, il Dio di
Abramo lo sorprende e gli parla dal roveto ardente: “Mosè Mosè”. E Mosè, al pari di
Abramo dice “Eccomi - Hinneni”, espressione di una presenza oblativa, che si offre, scandita
in risposta alla chiamata dell’Assoluto, in attento ascolto. Si deve togliere i calzari, perché il terreno sul quale sta è suolo sacro: adamat qodesh. Su quel suolo, in quella solitudine, il Dio
trascendente instaura un rapporto con un uomo trovato adatto, più di quanto lui pensa di
essere nella sua stupita modestia. Il Dio trascendente si presenta, in prima persona alla
seconda persona, umana, che gli sta davanti, dicendogli i precedenti atavici del rapporto e
viene all’ora urgente dell’ oggi: <<Io sono Iddio di tuo padre, Dio di Abramo, Dio di Isacco,
Dio di Giacobbe. Ho considerato la condizione di avvilimento del mio popolo in Egitto, ho
accolto il loro grido …… Voglio scendere a salvarlo dalla mano degli egiziani, traendolo da
quel paese per farlo salire ad una terra fertile e spaziosa, in un paese stillante latte e
miele……. Quindi va’, perché io ti incarico, quale mio delegato al Faraone>>.
Anokhi Elohé avikha et zaakatam shamati
Veered lehazilu mijad Mizraim
Veattah lekhah veeshlahakhà el Paroh
Pagina 175
E’ un incarico sorprendente, impegnativo che richiede ardimento e fiducia. Perché il Signore
Iddio non parla direttamente lui al Faraone? Perché agisce per gli uomini attraverso uomini.
Gli deve parlare Mosè, e se non si ritiene capace per un difetto di pronuncia, che egli sta
esagerando per schivarsi, vada col fratello Aronne. La morale è che il Faraone deve imparare
ad avere un interlocutore del popolo che sta opprimendo e disprezzando; e
questo popolo
deve imparare a vedere in un suo rappresentante l’uomo capace di affrontare il Faraone. Il
rapporto lo vuole tenere con il popolo che ha deciso di liberare e con cui stringerà un patto,
nel solco del patto di Abramo. La liberazione bisogna conquistarsela, facendosi arditi. Non
deve bastare a
Mosè avere ucciso un egiziano in difesa di un solo fratello. Deve affrontare il Faraone in difesa
di tutto il proprio popolo.
Mosè chiede a Dio il suo nome, perché immagina gli venga chiesto per primi dai connazionali,
quando andrà a dir loro di avere incontrato la divinità. Ciò fa pensare che il senso religioso
degli ebrei si fosse illanguidito, che avessero perso la chiara nozione di Dio, tanto da dover
chiedere come Dio si chiamasse.
Il nome è biblicamente importante per ogni uomo ed anche
per il Signore Iddio. Ma il nome, nel fissare la designazione di un individuo, lo limita, lo fissa
su un segno vocale, e invece Dio è illimitato. Il Signore allora si qualifica come l’ Essere per
eccellenza: <<Io sono quello che sono>>, detto, con la forma verbale ebraica, in una tensione
dinamica, in una progressione al futuro: <<Io sarò quello che sarò>>, che vado ad essere
Ehjié asher Ehjié
Abbiamo visto l’affinità relativa di questa definizione teologica con le iscrizioni egizie sul fulcro ontologico dell’essere. Ad altezza spirituale e intrinsecamente filosofica.
Si dice, ed è
così, che la Bibbia non è una filosofia, ma l’Unità divina, che la ha ispirata, non disdegna la filosofia, che è integrità e profondità di pensiero. Martin Buber, filosofo, ha insistito che la
Bibbia non è filosofia. Certo, lo sappiamo, basta leggerla per rendersene conto. La Bibbia non
è filosofia, ma parla pure ai filosofi che la commentano con elementi filosofici, come fecero
Filone giudeo alessandrino e la sua scuola. La Bibbia non è filosofia ma, in certe parti, la
sottende e la ispira, magari la provoca e la sfida ma la ispira. E questa autodenominazione
Pagina 176
del Signore, centrata sul concetto dell’essere, essere per eccellenza, essere assoluto, ha
precisamente di filosofico l’asserzione del Fondamento ontologico, per di più in tensione
dinamica al futuro, che conferisce all’essere la proprietà del divenire.
Il Signore Dio suggerisce a Mosè la prima limitata e introduttiva richiesta da fare nell’arduo approccio al Faraone: la richiesta, in suo nome, di concedere un congedo per un cammino di
tre giorni nel deserto, onde compiere un rito ed un sacrificio a Dio. Sarebbe già un importante
conseguimento, per un periodo di libertà, di aggregazione, di ritrovamento del culto con
coscienza nazionale e religiosa.
Il Signore avvisa Mosè che la prima missione non avrà
successo, ma è egualmente necessaria come inizio dell’offensiva. Ci vorrà ben altro, ma ormai
il piano divino entra in azione. Il Signore avvisa Mosè che il Faraone ha il cuore duro, anzi
che lui stesso indurirà il cuore del Faraone. Il Signore lo dice, per la conoscenza che ne ha,
assumendosi la responsabilità di come sono fatti certi uomini di potere, e non solo di potere.
Ma l’ardua missione deve cominciare. L’ardua missione comincia con tutte le possibili difficoltà. Riesce addirittura controproducente, perché per tutta risposta vengono aggravati i
lavori coatti degli ebrei e gli stessi ebrei si risentono contro Mosè ed Aronne.
La missione ha bisogno di diversi mezzi e il Signore, oltre a suggerire le parole, provvede
Mosè di una efficacia in gesti dimostrativi di potenza e autorevolezza, come stendere il
bastone e farne sortire un serpente, prendere il serpente per la coda e trasformarlo di nuovo
in bastone. Mosè e Aronne si cimenteranno in tali
prodigi, competendo
con i maghi
dell’Egitto, perché in quell’antico tempo prescientifico, ed ancora a lungo nei secoli,
si
credeva di potere influire sulla materia attraverso gesti e formule di magia. C’erano i maghi, erano presi sul serio, molti credevano ai loro sortilegi, c’era una forte immaginazione che li
accompagnava. Vi erano anche abilissimi trucchi del mestiere, in una sorta di tecnica della
magia. E’ stata lunga la strada evolutiva per passare dall’illusoria scorciatoia di gesti e
formule allo studio e agli esperimenti di tecnologie e di applicazioni scientifiche,
comprendendo le strutture della materia e i modi per le trasformazioni. Del resto, anche nel
passato coesistevano con la magia e la taumaturgia le tecnologie razionali o sapientemente
manuali, così come tuttora, nell’umana complessità, coesistono con le scienze e le tecnologie residui di magia e taumaturgia.
L’Ebraismo, proprio con la legislazione mosaica, ha proibito la magia, ma ha creduto nella
possibilità di eventi ed atti prodigiosi, se operati da Dio o da uomini pii, veramente ispirati da
una energia divina, come nel caso di Mosè e Aronne, come segni (otot) visibili, tangibili e
Pagina 177
percepibili,
del sostegno divino. La stessa Torah mette in guardia dalla magia dei
pervertitori, riconoscendo oggettivamente che ci sanno fare.
Nel congedarlo, il Signore
ribadisce a Mosè l’uso della verga per il compimento di miracoli, a complemento di quello che dirà, insieme con Aronne, al Faraone:
Et hammatteh hazeh tikkahbeiadekha
Asher taaseh bo et haotot
Questa verga prenderai nella tua mano e con essa opererai dei prodigi.
D’altronde anche la magia degli altri popoli si connetteva a forme di religiosità.
Mosè, dopo l’incarico ricevuto dal Signore, rientra a Midian, comunica al suocero di voler
tornare in Egitto dal suo popolo e il venerabile suocero gli dice <<Lekh le Shalom>>, una
bella espressione biblica, che userà più tardi il profeta Eliseo. Mosè Prende con sé la moglie e
i due figli, caricandoli affettuosamente sull’asino. Durante il viaggio è colpito una sorta di malore e sta per morire, ma il male si risolve con l’atto energico di Zipporah, che, presa una
selce, circoncide il figlio, non è detto quale, credo il minore Eliezer, forse Ghershom (o
Ghershon) già era circonciso. Pare che il Signore lo abbia colpito per aver trascurato la milà
del bambino e ci pensa, con cuore ardito di madre (che donne nella Bibbia), Zipporah, la
quale con quel sangue del bambino rafforza il vincolo coniugale. Tanto più rimarchevole è il
gesto di questa donna, che non è nata ebrea.
Il Signore informa Aronne dell’arrivo del fratello e glielo manda incontro. I due fratelli saranno strettamente uniti e complementari nell’impresa.
Il Faraone, come il Signore aveva predetto, rifiuta il permesso di un congedo al popolo,
disconosce il Dio degli ebrei, aggrava il rigore del trattamento nei loro confronti.
accusano Mosè ed Aronne di aver peggiorato la loro condizione,
Gli ebrei
e Mosè, travagliato come
sarà spesso nella sua missione, chiede a Dio: <<O Signore perché hai fatto del male a questo
popolo? Perché mi hai inviato per questo (per fare questa cosa) ?>>
Adonai, lama hareota laam hazzè, lama ze shlahtani?
Pagina 178
Il Signore lo rincuora, esortando ad aver fiducia nella sua azione in tempi lunghi: <<Vedrai
cosa sto per fare al Faraone>>.
La storiografia individua i due
Faraoni oppressori degli ebrei in Ramses o Ramesse II, un
altro suffisso Mese Mose (circa 1304-1237 avanti l’era cristiana, o secondo altri computi, circa
1279-1212) e nel figlio Meneptah o Merneptah, regnante tra gli anni trenta e gli anni venti del
tredicesimo secolo, o alla fine del tredicesimo secolo. Siamo comunque, verosimilmente, nel
tredicesimo secolo avanti l’era cristiana.
Il Libro dei giubilei, più volte citato in questa derashah, è uno dei testi, considerati apocrifi,
non riconosciuti ufficialmente dalle autorità rabbiniche e non entrati nel corpus o canone del
Tanakh, composto in un certo ambiente, in una delle scuole di pensiero dell’Ebraismo tardo antico, nel secondo secolo avanti l’era volgare. Si chiama così perché divide la cronologia della
storia ebraica ed universale in giubilei, cioè cinquantennî. E’ una parafrasi della Torah, dall’inizio di Bereshit, creazione del mondo, al capitolo 12 di Shemot, Esodo, con varianti ed
aggiunte. Ma non comincia da Bereshit bensì dalla rivelazione del Signore a Mosè, al quale, in
retrospettiva, un angelo, scriba del Signore, racconta tutti gli accadimenti precedenti e svela
squarci del futuro, con severa predizione dell’esilio. Fu scritto originariamente in ebraico, ma
l’originale si è perso. Il testo più completo è in lingua gheez, la stessa lingua dotta dei Beta Israel di Abissinia. E’ inserito nel canone della Chiesa cristiana copta, che ci ha conservato
questo testo fortemente giudaico, con punte di vero esclusivismo, come a proposito dei
sichemiti uccisi da Ruben e Levi, che vengono nel libro apprezzati, perché gli ebrei non si
dovevano mescolare con stranieri. Il Libro dei giubilei era letto dagli esseni ed è stato
ritrovato, in parte, tra i loro rotoli di Qumran.
Il testo è pubblicato, tra gli Apocrifi dell’Antico Testamento, in edizione UTET, Torino, 2006, a
cura di Paolo Sacchi, con la cooperazione di traduttori ed esegeti.
**
La haftarah è tratta dall’inizio del libro di Geremia, quando egli, a somiglianza di Mosè, cerca
di esimersi dalla missione che Dio gli affida. Il Signore dice a Geremia di averlo scelto come
profeta, che parlasse alle genti, prima ancora che nascesse. Lo straordinario annuncio, nel
segno della predestinazione, non poteva non scuoterlo, e Geremia, turbato, cerca di sottrarsi
Pagina 179
al ruolo che dall’alto gli si impone, adducendo l’età immatura e l’inesperienza: “Ahimé, mio Signore, ma ecco io non so parlare, perché un ragazzo son io”.
Aah Adonai innè lo jadati dabber ki naar anokhì
Il Signore lo rassicura, assegnandogli un incarico addirittura di costruire e di demolire, di
piantare e di
distruggere mediante le parole che gli ispirerà, esortandolo quindi a non
temere le genti cui si dovrà rivolgere, e gli fornisce la visione del ramo di mandorlo, simbolo,
per la fioritura precoce in primavera, della vigile prontezza nel capire, nel dar messaggi,
nell’agire. Così Geremia inizia la sua missione di profeta, invero più triste di quella di Mosè, perché
Mosè guiderà
il popolo alla liberazione, nel cammino verso la terra promessa, dove si
costituirà una società ebraica ed uno stato ebraico, mentre Geremia profetizzerà nel tragico
periodo dell’invasione babilonese, esortando a sottomettersi al potere straniero del re Nabucodonosor e sarà accusato di cedimento e di tradimento. Mosè guida all’uscita dall’esilio, mentre Geremia profetizza il nuovo esilio, al di là del quale il Signore libererà
nuovamente il suo popolo.
Ad ogni modo, i grandi spiriti di Israele, con le rispettive
generazioni, nelle diverse sorti e dei diversi compiti, si succedono e si collegano lungo la
continuità della tradizione, nella storia del popolo e dell’idea. Shabbat Shalom,
Bruno Di Porto