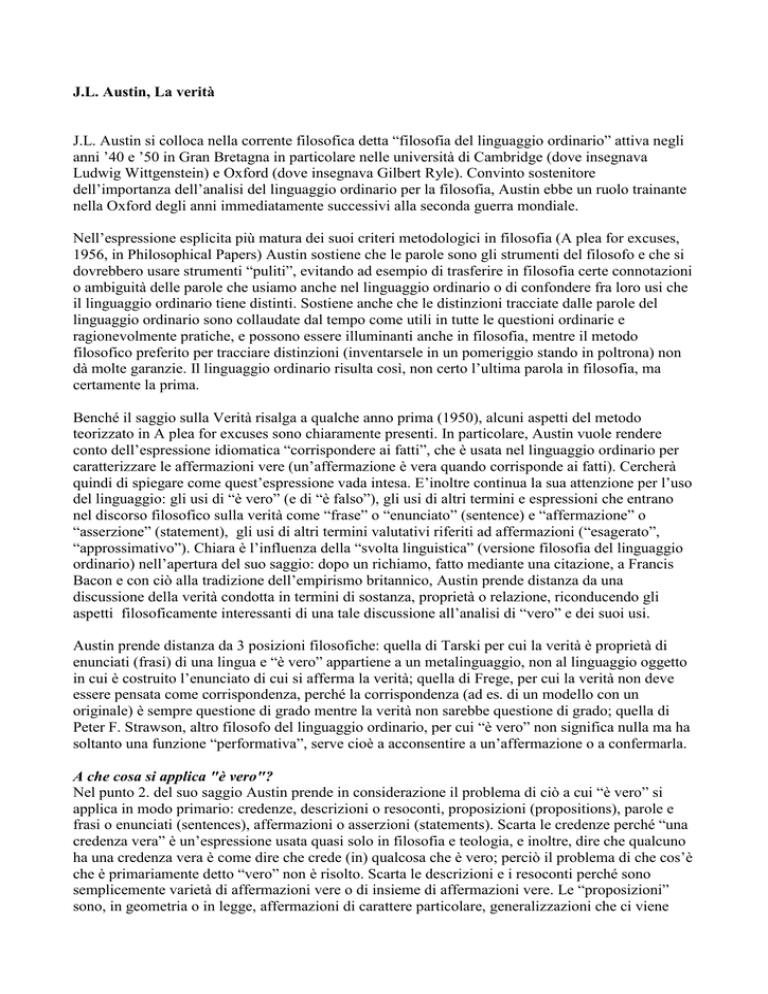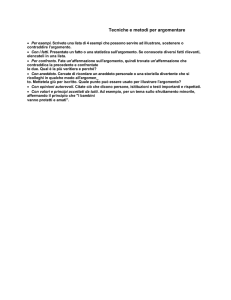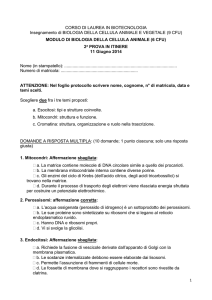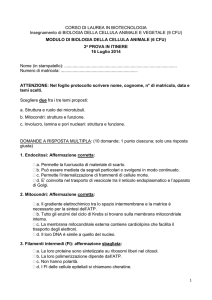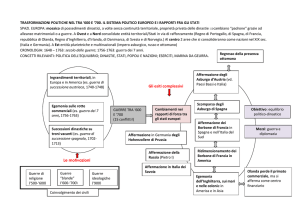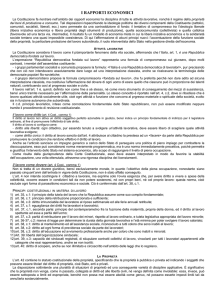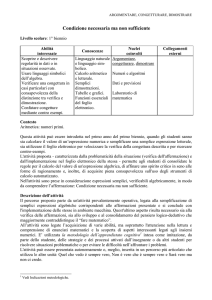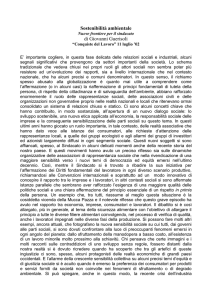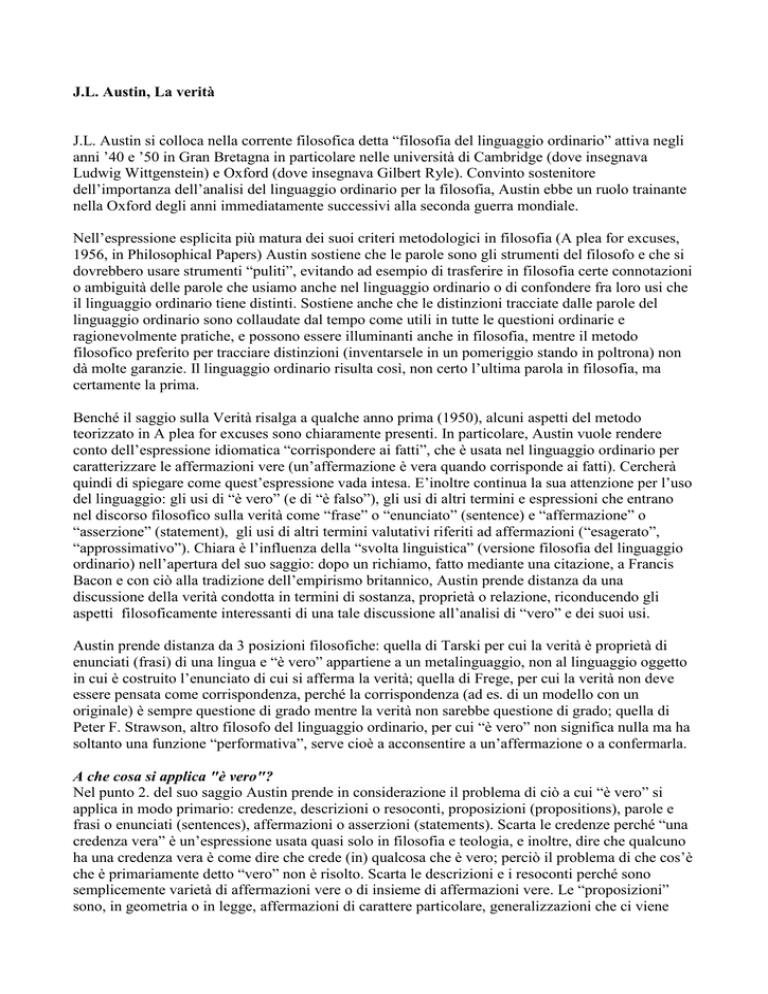
J.L. Austin, La verità
J.L. Austin si colloca nella corrente filosofica detta “filosofia del linguaggio ordinario” attiva negli
anni ’40 e ’50 in Gran Bretagna in particolare nelle università di Cambridge (dove insegnava
Ludwig Wittgenstein) e Oxford (dove insegnava Gilbert Ryle). Convinto sostenitore
dell’importanza dell’analisi del linguaggio ordinario per la filosofia, Austin ebbe un ruolo trainante
nella Oxford degli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale.
Nell’espressione esplicita più matura dei suoi criteri metodologici in filosofia (A plea for excuses,
1956, in Philosophical Papers) Austin sostiene che le parole sono gli strumenti del filosofo e che si
dovrebbero usare strumenti “puliti”, evitando ad esempio di trasferire in filosofia certe connotazioni
o ambiguità delle parole che usiamo anche nel linguaggio ordinario o di confondere fra loro usi che
il linguaggio ordinario tiene distinti. Sostiene anche che le distinzioni tracciate dalle parole del
linguaggio ordinario sono collaudate dal tempo come utili in tutte le questioni ordinarie e
ragionevolmente pratiche, e possono essere illuminanti anche in filosofia, mentre il metodo
filosofico preferito per tracciare distinzioni (inventarsele in un pomeriggio stando in poltrona) non
dà molte garanzie. Il linguaggio ordinario risulta così, non certo l’ultima parola in filosofia, ma
certamente la prima.
Benché il saggio sulla Verità risalga a qualche anno prima (1950), alcuni aspetti del metodo
teorizzato in A plea for excuses sono chiaramente presenti. In particolare, Austin vuole rendere
conto dell’espressione idiomatica “corrispondere ai fatti”, che è usata nel linguaggio ordinario per
caratterizzare le affermazioni vere (un’affermazione è vera quando corrisponde ai fatti). Cercherà
quindi di spiegare come quest’espressione vada intesa. E’inoltre continua la sua attenzione per l’uso
del linguaggio: gli usi di “è vero” (e di “è falso”), gli usi di altri termini e espressioni che entrano
nel discorso filosofico sulla verità come “frase” o “enunciato” (sentence) e “affermazione” o
“asserzione” (statement), gli usi di altri termini valutativi riferiti ad affermazioni (“esagerato”,
“approssimativo”). Chiara è l’influenza della “svolta linguistica” (versione filosofia del linguaggio
ordinario) nell’apertura del suo saggio: dopo un richiamo, fatto mediante una citazione, a Francis
Bacon e con ciò alla tradizione dell’empirismo britannico, Austin prende distanza da una
discussione della verità condotta in termini di sostanza, proprietà o relazione, riconducendo gli
aspetti filosoficamente interessanti di una tale discussione all’analisi di “vero” e dei suoi usi.
Austin prende distanza da 3 posizioni filosofiche: quella di Tarski per cui la verità è proprietà di
enunciati (frasi) di una lingua e “è vero” appartiene a un metalinguaggio, non al linguaggio oggetto
in cui è costruito l’enunciato di cui si afferma la verità; quella di Frege, per cui la verità non deve
essere pensata come corrispondenza, perché la corrispondenza (ad es. di un modello con un
originale) è sempre questione di grado mentre la verità non sarebbe questione di grado; quella di
Peter F. Strawson, altro filosofo del linguaggio ordinario, per cui “è vero” non significa nulla ma ha
soltanto una funzione “performativa”, serve cioè a acconsentire a un’affermazione o a confermarla.
A che cosa si applica "è vero"?
Nel punto 2. del suo saggio Austin prende in considerazione il problema di ciò a cui “è vero” si
applica in modo primario: credenze, descrizioni o resoconti, proposizioni (propositions), parole e
frasi o enunciati (sentences), affermazioni o asserzioni (statements). Scarta le credenze perché “una
credenza vera” è un’espressione usata quasi solo in filosofia e teologia, e inoltre, dire che qualcuno
ha una credenza vera è come dire che crede (in) qualcosa che è vero; perciò il problema di che cos’è
che è primariamente detto “vero” non è risolto. Scarta le descrizioni e i resoconti perché sono
semplicemente varietà di affermazioni vere o di insieme di affermazioni vere. Le “proposizioni”
sono, in geometria o in legge, affermazioni di carattere particolare, generalizzazioni che ci viene
proposto di accettare sulla base di argomenti; in filosofia si intende per “proposizione” il significato
o senso di un enunciato o famiglia di enunciati” ma non è certo il senso di un enunciato ciò che
normalmente diciamo essere vero o falso. Le parole o le frasi sono dette vere non se considerate di
per sé, come elementi di sistema linguistico o strutture prodotte dalle sue regole, ma solo in quanto
usate da una certa persona in una certa occasione. Cioè in quanto affermazioni, o asserzioni (in
inglese Austin usa il termine “statement”). Rimaniamo così con le affermazioni come unico
candidato veramente plausibile. Un’affermazione è qualcosa che viene fatto e farla è un evento
storico, il proferimento da parte di un certo parlante di certe parole (o un certo enunciato) rivolte a
un uditorio con riferimento a una situazione storica.
Una definizione di "è vero"
Nel punto 3. del suo saggio Austin passa a chiedersi quando un’affermazione è vera. Qui si
confronta con la risposta, intuitivamente attendibile “Quando corrisponde ai fatti”. La accetta, ma
ritiene necessarie una serie di precisazioni – che ammontano alla sua spiegazione di che cosa sia per
un’affermazione essere vera.
In particolare Austin distingue due tipi di “convenzioni” in base alle quali le nostre affermazioni
funzionano e in relazione alle quali possono essere dette vere o false.
Le convenzioni descrittive correlano l’enunciato (sentence) con tipi di situazione da trovarsi nel
mondo.
Le convenzioni dimostrative correlano l’affermazione (statement) con la situazione storica da
trovarsi nel mondo.
Un’affermazione è detta vera quando la situazione storica a cui è correlata dalle convenzioni
dimostrative è di un tipo con cui l’enunciato usato nel farla è correlato dalle convenzioni descrittive.
A commento di ciò possiamo dire che l’essere un’affermazione vera è per Austin qualcosa che
coinvolge due livelli diversi del linguaggio, quello dell’enunciato (sentence) e quello del suo uso
per fare un’affermazione (statement): di un enunciato-tipo possiamo capire a quale tipo di
situazione è collegato dalle convenzioni descrittive della lingua, ma solo se l’enunciato è usato
effettivamente, e per fare un’affermazione o asserzione, scattano le convenzioni dimostrative che
collegano l’affermazione a una situazione storica, e sappiamo di quale situazione storica si dice che
è di quel tipo, e sappiamo, anche, quale situazione storica dovremmo andare a guardare per
controllare se è proprio così. La “corrispondenza” fra parole e fatti è piuttosto una corrispondenza
fra tipi di situazione (cui giungiamo a partire dalle convenzioni descrittive riguardanti gli enunciati)
e situazioni storiche (cui giungiamo a partire dalle convenzioni dimostrative, riguardanti le
affermazioni).
Vari aspetti nella teoria austiniana della verità rimangono oscuri. In particolare è un po’ misterioso
il suo uso della nozione di “convenzione”, non tanto per le convenzioni descrittive (che si rifanno al
luogo comune della convenzionalità della lingua) quanto per le convenzioni dimostrative. Queste si
applicano ad aspetti verbali (indicali, dimostrativi, tempo del verbo…) ma anche ad aspetti non
verbali (gesti ostensivi), e inoltre, “scattano” solo in virtù del fatto (che non è in alcun modo
convenzionale) del proferimento dell’enunciato (con funzione di affermazione). Dice Austin in una
nota che per quanti espedienti dimostrativi verbali noi possiamo usare, deve sempre esserci
un’origine non verbale per le coordinate dimostrative della nostra affermazione, la quale è data dal
punto (spazio-temporale) in cui essa viene proferita. Un’ipotesi è che Austin tenda a considerare
“convenzionale”, in rispetto all’etimologia, tutto ciò che è oggetto di accordo intersoggettivo. In
effetti che un certo nostro gesto o emissione verbale si riferiscano proprio a una certa situazione,
benché segnalato in varie maniere, è in ultima analisi sempre connesso a un convergere o convenire
su un certo referente da parte di parlante e (almeno alcuni) riceventi.
Riguardo alla nozione, che pure ritiene legittima, di “fatto”, Austin rifiuta l’uso, per certi versi
plausibile, per cui “fatto” sarebbe semplicemente sinonimo di “affermazione vera”. Accettare
quest’identificazione equivale a ricadere in una teoria coerentista della verità, mentre, Austin
ritiene, la verità è sempre questione di 2 elementi o livelli a confronto. Rifiuta inoltre la tendenza,
comune fra i teorici della verità come corrispondenza, a voler trovare per ogni affermazione vera il
suo “fatto” esattamente corrispondente. In questo modo si sovrappopola il mondo di doppi delle
nostre affermazioni e si è indotti a introdurre “fatti generali”, “fatti negativi” e così via.
Della “corrispondenza” ai fatti, Austin sostiene che è puramente e assolutamente convenzionale, e
che non implica rispecchiamento o isomorfismo di sorta. Un’immagine, una copia, una fotografia
non sono mai vere fintanto che sono riproduzioni: sono accurate o verosimili, fedeli all’originale,
non vere di esso. Su questo punto Austin sembra dunque dare ragione a Frege che aveva rifiutato la
verità come corrispondenza per non assimilare le affermazioni a immagini, le quali corrispondono a
ciò che riproducono in modo più o meno fedele. Austin condivide il punto riguardo alle immagini
ma non la sua applicazione alle affermazioni, che possono essere dette corrispondere ai fatti in un
senso diverso da quello in cui delle immagini possono riprodurre oggetti, eventi o stati di cose.
Peraltro, Austin accetterà anche che la verità delle affermazioni sia, contro Frege, questione di
grado.
Critiche alla tesi della superfluità logica di "è vero"
Nel punto 4. del suo saggio Austin inizia a affrontare la questione della supposta ridondanza o
superfluità logica di “è vero”. Prende in considerazione l’idea che dire che un’asserzione è vera non
sia fare alcuna ulteriore asserzione o altrimenti detto, che dire di una proposizione che è vera sia
semplicemente asserirla mentre dire che è falsa è semplicemente asserire la sua contraddittoria. “E’
vero” sarebbe quindi logicamente superfluo, nel senso che non contribuirebbe in alcun modo alle
condizioni di verità dell’enunciato in cui compare, le quali continuerebbero ad essere le stesse
condizioni di verità dell’enunciato (o proposizione) che è detto essere vero. Austin nota che mentre
l’affermazione che S fa riferimento al mondo o a una parte qualsiasi di esso, ad esclusione di se
stessa, cioè dell’affermazione che S, l’affermazione che l’affermazione che S è vera fa riferimento
al mondo o a una qualsiasi parte di esso che include l’affermazione S (anche se di nuovo ad
esclusione di se stessa, cioè dell’affermazione che S è vera). L’affermazione che l’affermazione che
S è vera può far riferimento a qualcosa a cui l’affermazione che S non può far riferimento. Certo, le
due affermazioni sono vere insieme e false insieme (purché l’affermazione che S sia considerata
come fatta e sia stata verificata: altrimenti l’affermazione che l’affermazione che S è vera non
avrebbe le carte in regola…). Ma ciò potrebbe non essere sufficiente per ritenere che significhino lo
stesso. Un secondo argomento contro la superfluità logica di “è vero” si basa sull’osservazione che
tale tesi confonde la falsità con la negazione (in quanto si trova a dover trattare anche “è falso”
come logicamente superfluo). Ma un’asserzione negativa ed una positiva sono in realtà sullo stesso
piano, ambedue si riferiscono direttamente al mondo, non ad affermazioni sul mondo, mentre
l’affermazione che una certa affermazione è falsa si riferisce a quell’affermazione.
Un ulteriore argomento contro la superfluità logica di “è vero” è portato nel punto 5. del saggio, in
cui Austin considera “è vero” come parte di una famiglia di termini usati per valutare la correttezza
delle affermazioni (“vago”, “approssimativo”, “fuorviante”, “generico”…), la quale comunque è
questione di gradi e di dimensioni.
Se "è vero" non è logicamente superfluo, se quindi l'affermazione che l’affermazione che S è vera è
a pieno titolo un'affermazione, che deve "corrispondere ai fatti", a quale fatto corrisponde? Austin
ammette che l’essere un’affermazione vera non è un fatto in senso stretto…: la relazione che si
asserisce esistere fra l’affermazione che S e il mondo, quando si dice che l'affermazione che S è
vera, è infatti puramente convenzionale, e con ciò non è indipendente dalla volontà e dal pensiero
del soggetto (che avrebbe potuto per es. usare altre convenzioni descrittive). Austin propone tuttavia
di considerarla un fatto e di chiamarla un "fatto debole" (soft fact).
Il punto 6. del saggio introduce il tema della "fallacia descrittiva", cioè di quell'errore comune in
filosofia - almeno a detta di molti filosofi di ambito analitico nella prima metà del Novecento - per
cui si tendono a prendere tutti gli enunciati dichiarativi come affermazioni o descrizioni vere/false,
distorcendone, in certi casi, la reale funzione comunicativa. Calcoli, giudizi di valore, enunciati
performativi come "io prometto che..." (che non descrivono un'azione del soggetto enunciatore, ma
servono ad eseguirla), sono fatti usando enunciati dichiarativi ma non sono affermazioni, almeno
non in senso stretto. Non è loro compito "corrispondere ai fatti". In questo spirito Austin confronta
inoltre "è vero" con "è probabile", sostenendo che l'una e l'altra sono espressioni che usiamo per
fare affermazioni riguardo ad affermazioni, ma in situazioni di tipo diverso; quando è appropriato
affermare che una certa asserzione è vera è fuori luogo affermare che è probabile che le cose stiano
così, e viceversa. Questo paragrafo del saggio ha presumibilmente lo scopo di contestualizzare il
giudizio di verità/falsità fra altri tipi di giudizio che noi diamo quanto alla correttezza degli
enunciati che usiamo, nelle circostanze e per gli scopi in cui li usiamo. Non esiste soltanto il
giudizio secondo verità/falsità, ma molteplici modi di valutare ciò che diciamo, ciascuno dei quali
tiene conto a suo modo di fatti…
La proposta di Strawson, discussa nel punto 7., che “è vero” benchè superfluo logicamente, possa
non dire ma fare qualcosa di più che l’affermazione cui è applicato, cioè confermarla o concederla,
sembra collocarsi anch'essa in linea con le critiche alla "fallacia descrittiva" che Austin ha fatto sue
nel punto 6.; ma Austin rifiuta quest'estensione del discorso. Egli sostiene, contro Strawson, che il
fatto che l’affermazione che l’affermazione che S è vera sia spesso un modo per confermare o
concedere che S, non mostra che essa non sia allo stesso tempo anche un’affermazione riguardo ad
S. Un enunciato può cioè essere “performativo”, nel senso che il suo proferimento può costituire
un’azione, ma nello stesso tempo essere un’affermazione vera o falsa. Austin è propenso a ritenere
che dicendo "L'affermazione che S è vera" noi stiamo facendo un'affermazione, e che la funzione
principale di “è vero” sia affermare che fra certe parole e il mondo si dà una relazione del genere di
quella specificata nel punto 3. del suo saggio.
Da “La verità” a “Come fare cose con le parole”
Nel dibattito con Strawson sulla verità Austin si trova davanti ad un utilizzo della nozione di
“enunciato performativo” da lui stesso introdotta nel suo lavoro precedente “Le altre menti” (1946).
L’enunciato performativo è un enunciato che sembra descrivere qualcosa, ma in realtà non lo
descrive bensì serve ad eseguire un’azione. Nel parlare di enunciati performativi Austin si riferisce
soprattutto a enunciati contenenti un verbo d’azione alla prima persona del presente indicativo
attivo, che sembrano descrivere un’azione del soggetto, ma in realtà servono ad eseguirla (ovvero
contribuiscono a una sua esecuzione esplicita). Nel modo in cui Strawson aveva usato la nozione di
performatività era insita l’idea di un’alternativa fra due usi del linguaggio mutuamente esclusivi,
quello assertivo o descrittivo, vero/falso, non costitutivo di azioni ma espressione per eccellenza
della funzione cognitiva teoretica, e quello performativo, felice/infelice (ovvero ben riuscito/non
ben riuscito, appropriato/inappropriato), non vero/falso, bensì costitutivo di azioni e con ciò
strumento della prassi. Di fronte al caso di “è vero” Austin si accorge che non era nel suo progetto
di analisi dei performativi dare adito a questo tipo di interpretazioni. Dal desiderio di riqualificare la
sua nozione di enunciato performativo nasce il progetto di “Come fare cose con le parole”.
In “Come fare cose con le parole” ci viene presentata una dicotomia fra “constativi” (enunciati
veri/falsi, che dicono e non fanno) e “performativi” (enunciati che non sono veri/falsi, che non
dicono semplicemente qualcosa ma fanno qualcosa). Non si tratta come una lettura superficiale
potrebbe far pensare della tesi del volume. Ma della negazione della tesi (come in una
dimostrazione per assurdo). Infatti Austin vuole mostrare che costruire la relazione fra affermazioni
e performativi come mutuamente esclusiva è assurdo e che una volta riconosciuta l’esistenza di
enunciati performativi, bisogna invece trarne la conseguenza più radicale che il linguaggio è azione.
Che il linguaggio deve essere descritto e studiato in quanto azione. E ciò senza eccezione:
l’affermazione, supposto veicolo della conoscenza teoretica, è anch’essa un atto linguistico, ha
condizioni di felicità o buona riuscita, realizza una procedura convenzionale che ha effetti
convenzionali, ed è l’oggetto di giudizio nella dimensione della corrispondenza ai fatti
(verità/falsità, ma anche approssimazione, esattezza, vaghezza, generalità…) proprio in quanto atto
linguistico effettivamente eseguito, cioè (essenzialmente) in relazione agli scopi del parlante che
l’ha fatta e di quello che poi la giudica, i quali rendono pertinenti standard di valutazioni diversi.
La compresenza di livelli già notata in “La verità” per quanto riguarda il giudizio di verità/falsità
che sarà anche veicolo di un atto di conferma, ma è comunque un “dire” che si dà nel caso specifico
una certa relazione fra parole e mondo, diventa oggetto di una teorizzazione più sistematica, la
compresenza dei livelli dell’atto locutorio (atto di dire qualcosa) e illocutorio (atto di fare qualcosa
nel dire qualcosa).
Infine, in sintonia con “La verità”, il capitolo 11 di “Come fare cose con le parole” descrive
l’affermazione (statement) come atto linguistico e in particolare atto illocutorio (sullo stesso piano
di atti quali: promessa, ordine, nomina, stima, scusa…), proponendone alcune condizioni di felicità,
suggerendo mediante esempi il variare degli standard nel giudizio relativo alla corrispondenza ai
fatti, e sostenendo, più in generale, che per tutti i tipi di atti allocutori esistono due livelli di
giudizio: uno che conferma o disconferma la validità della procedura seguita e del suo effetto
convenzionale (felicità/infelicità), l’altro, logicamente successivo, che valuta quanto è stato
detto/fatto alla luce dei fatti, decidendo se era o non era la cosa giusta da dire/fare in quelle
circostanze e per quegli scopi. A questo secondo livello di giudizio appartiene il giudizio di
verità/falsità.