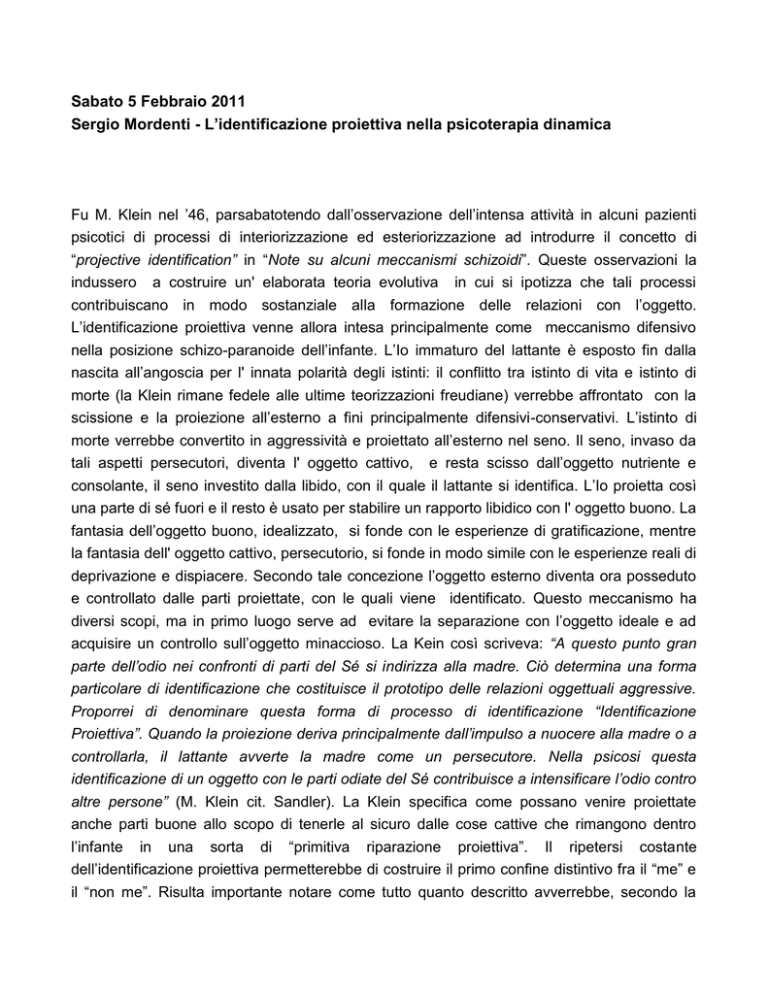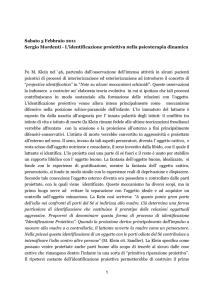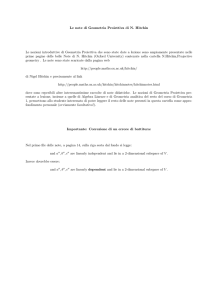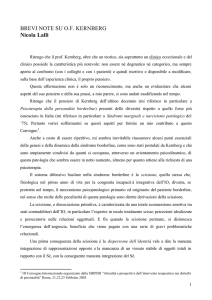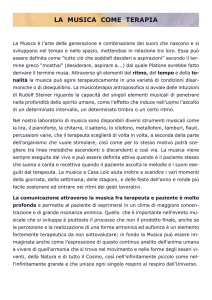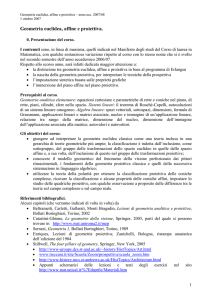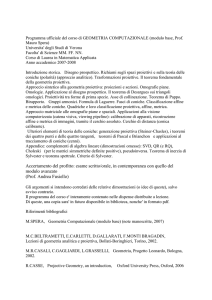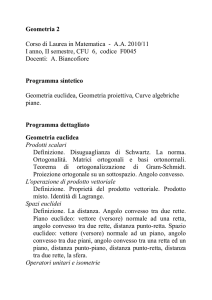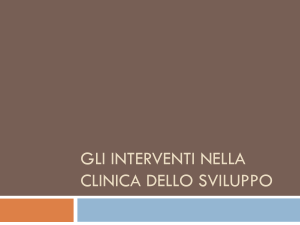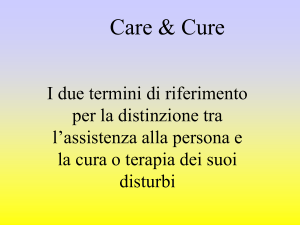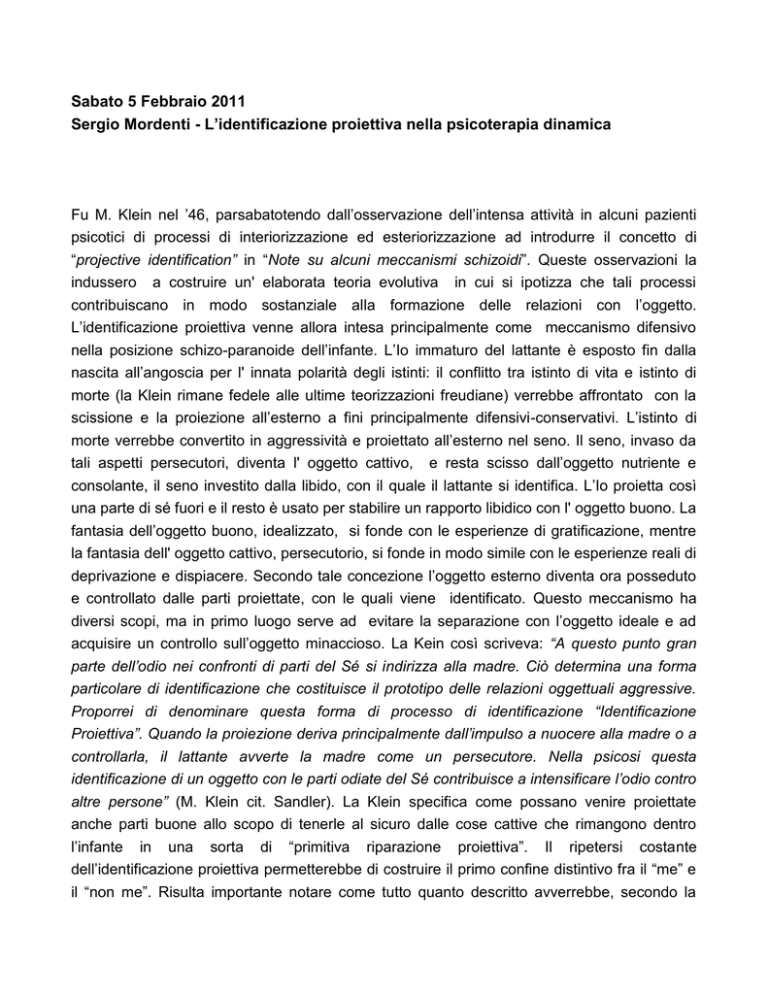
Sabato 5 Febbraio 2011
Sergio Mordenti - L’identificazione proiettiva nella psicoterapia dinamica
Fu M. Klein nel ’46, parsabatotendo dall’osservazione dell’intensa attività in alcuni pazienti
psicotici di processi di interiorizzazione ed esteriorizzazione ad introdurre il concetto di
“projective identification” in “Note su alcuni meccanismi schizoidi”. Queste osservazioni la
indussero a costruire un' elaborata teoria evolutiva in cui si ipotizza che tali processi
contribuiscano in modo sostanziale alla formazione delle relazioni con l’oggetto.
L’identificazione proiettiva venne allora intesa principalmente come meccanismo difensivo
nella posizione schizo-paranoide dell’infante. L’Io immaturo del lattante è esposto fin dalla
nascita all’angoscia per l' innata polarità degli istinti: il conflitto tra istinto di vita e istinto di
morte (la Klein rimane fedele alle ultime teorizzazioni freudiane) verrebbe affrontato con la
scissione e la proiezione all’esterno a fini principalmente difensivi-conservativi. L’istinto di
morte verrebbe convertito in aggressività e proiettato all’esterno nel seno. Il seno, invaso da
tali aspetti persecutori, diventa l' oggetto cattivo, e resta scisso dall’oggetto nutriente e
consolante, il seno investito dalla libido, con il quale il lattante si identifica. L’Io proietta così
una parte di sé fuori e il resto è usato per stabilire un rapporto libidico con l' oggetto buono. La
fantasia dell’oggetto buono, idealizzato, si fonde con le esperienze di gratificazione, mentre
la fantasia dell' oggetto cattivo, persecutorio, si fonde in modo simile con le esperienze reali di
deprivazione e dispiacere. Secondo tale concezione l’oggetto esterno diventa ora posseduto
e controllato dalle parti proiettate, con le quali viene identificato. Questo meccanismo ha
diversi scopi, ma in primo luogo serve ad evitare la separazione con l’oggetto ideale e ad
acquisire un controllo sull’oggetto minaccioso. La Kein così scriveva: “A questo punto gran
parte dell’odio nei confronti di parti del Sé si indirizza alla madre. Ciò determina una forma
particolare di identificazione che costituisce il prototipo delle relazioni oggettuali aggressive.
Proporrei di denominare questa forma di processo di identificazione “Identificazione
Proiettiva”. Quando la proiezione deriva principalmente dall’impulso a nuocere alla madre o a
controllarla, il lattante avverte la madre come un persecutore. Nella psicosi questa
identificazione di un oggetto con le parti odiate del Sé contribuisce a intensificare l’odio contro
altre persone” (M. Klein cit. Sandler). La Klein specifica come possano venire proiettate
anche parti buone allo scopo di tenerle al sicuro dalle cose cattive che rimangono dentro
l’infante in una sorta di “primitiva riparazione proiettiva”. Il ripetersi costante
dell’identificazione proiettiva permetterebbe di costruire il primo confine distintivo fra il “me” e
il “non me”. Risulta importante notare come tutto quanto descritto avverrebbe, secondo la
Klein, esclusivamente “nella fantasia” interna del bambino. La Klein non ritiene infatti che
l’Identificazione Proiettiva produca una modificazione nell’oggetto reale.
Questa possibilità comincerà a farsi strada gradualmente, grazie ad alcuni analisti ancora di
area kleiniana, in particolare la Heiman, Racker, Grinberg, i quali osservarono come non solo
le fantasie proiettive potessero produrre una deformazione significativa nell’immagine esterna
del soggetto investito da tali fantasie (in linea con la visione classica di transfert), ma anche
come l’analista ricettivo a tali proiezioni si potesse identificare con la rappresentazione del sé
presente in quel momento nella fantasia del paziente. Tale identificazione era in grado di
produrre determinati effetti sulla controtraslazione. Si arrivò così anche a ritenere che l' uso
del controtransfert potesse arricchire in modo sostanziale la possibilità di comprensione da
parte dell’analista di quanto sta avvenendo nel paziente.
In seguito Bion, concependo le proiezioni non più sull’oggetto ma direttamente nell’oggetto
esterno, modificherà in maniera sostanziale la visione operativa ed interpretativa
dell’identificazione proiettiva. Alla fine degli anni ’50 tale visione gli permise concretamente di
formulare il concetto di Contenitore.: “Una delle conseguenze di questo processo consiste nel
fatto che, proiettando le parti cattive (incluse le fantasie e i sentimenti cattivi) in un seno
buono (un oggetto comprensivo), il bambino sarà in grado –per quanto glielo consente il suo
sviluppo- di introiettare le stesse parti in una forma più tollerabile, una volta che esse siano
state modificate dall’attività di pensiero dell’oggetto (rêverie) .. […] la madre, con la sua
capacità di rêverie, trasforma le sensazioni spiacevoli associate al -seno cattivo- e da sollievo
al bambino che può reintroiettare l’esperienza emotiva modificata e mitigata, cioè
reintroiettare un aspetto non sensuale dell’amore della madre”.(W.R.Bion cit da Sandler) La
madre, che si prende cura del bambino attenta e tollerante verso i bisogni, il malessere, la
rabbia, come pure verso l’amore del bambino, comunica via via il messaggio rassicurante che
è capace di “contenere” questi sentimenti e di rispondervi, a tempo opportuno, con tatto e
competenza. In tal modo il bambino impara che il suo malessere non è disastroso, e
interiorizzando la funzione di contenimento della madre (mediante identificazione o
introiezione) acquisisce una fonte interna di forza e benessere. Tale concetto, in particolare
all’interno delle teorizzazioni delle relazioni d’oggetto, ma non esclusivamente, fu alla base di
un radicale mutamento nella visione della relazione terapeutica tra paziente ed analista.
L’identificazione proiettiva divenne un’importante forma di interazione tra paziente e
terapeuta, sia nella terapia individuale che nei gruppi (in particolare qualora questi si trovino
in stati di particolare funzionamento regredito a forme primitive dell’esistere). Una forma
particolare di comunicazione che porta, come spiega ancora Bion, a sentirsi “… manipolato
come se [si] stesse recitando una parte, non importa quanto difficile a riconscersi, nella
fantasia di qualcun altro” ... “l’identificazione proiettiva non è solamente una fantasia, ma la
manipolazione di una persona da parte di un’altra; pertanto è un’interazione interpersonale”,
“…è come avere un pensiero che non è nostro” (Bion 1959, cit da Ogden).
L’identificazione proiettiva viene sempre più intesa come fondamentale strumento di lavoro
terapeutico che trae fondamento ed origine nel primo rapporto del bambino con la madre:
“Facendo ricorso all’identificazione proiettiva egli [il neonato] si procura la possibilità di
studiare le proprie sensazioni attraverso l’effetto che esse producono nella personalità in cui
egli le ha proiettate. Se gli viene negato tale ricorso, o perché la madre è incapace di fungere
da magazzino delle sue sensazioni o perché l’odio e l’invidia non permettono al soggetto che
la madre eserciti tale funzione, allora ciò che segue è la distruzione del legame tra neonato e
seno e una grave compromissione della tendenza alla curiosità, la sola tendenza mediante la
quale può forgiarsi ogni ulteriore nozione” (cit. Ogden, Bion 1959). Sempre più si intende
l’identificazione proiettiva come particolare forma di relazione e di transfert presente durante i
primitivi stati di sviluppo infantile e nel rapporto con gli psicotici gravi.
Anche D. Winnicott viene influenzato da tale clima teorico; è evidente infatti che, pur non
utilizzando spesso il termine di identificazione proiettiva, pare esserne suggestionato. Se ne
sentono gli echi in lavori come Interferenza e rispecchiamento (1961, 1971), nel concetto di
holding da parte dell’ambiente (1945), in Odio nel controtransfert (1947), tutti lavori in cui
veniva posto al centro del lavoro analitico il controtransfert per la comprensione del transfert e
dei vissuti profondi di relazione con l’oggetto. Fondamentale diviene, secondo tali visioni,
fornire al paziente un setting terapeutico in cui il paziente possa sentirsi libero di esplorare
spontaneamente e concretamente, cioè attraverso la ri-attualizzazione dell’esperienza, il
proprio ambiente interpersonale (interiorizzato), mantenendo la sicurezza di un’interiorità
privata in cui poter ripiegare. Detto anche con i termini di M. Khan: “Nel corso di un riuscito
trattamento della regressione, il paziente è in grado di rinunciare alla propria fede nelle
modalità difensive del falso-Sé (necessario a tutelare il fragile vero Sé legato al fragile
oggetto buono interiorizzato), mediante il trasferimento sull’analista del ruolo di “curatore” o di
“scudo protettivo” del vero Sé”.
Inevitabilmente vengono a questo punto a modificarsi anche la considerazione e l'
utilizzazione di alcuni tra i più fondamentali strumenti tecnici analitici, come l’interpretazione.
M. Balint ben specifica come il terapeuta-analista debba ben guardarsi dall’interpretare.
Proprio in considerazione delle proiezioni ed identificazioni del paziente è preferibile invece
“accettare”, “sentire insieme”, “tollerare” e “sopportare insieme” al paziente i sentimenti contro
cui questo lotta e che sta chiedendo al terapeuta-mamma di riconoscere. “ L' analista è meno
avido di “comprendere” tutto immediatamente e, in particolare, di organizzare e di cambiare
con delle interpretazioni corrette tutto ciò che è “sgradevole”; di fatto è più tollerante verso le
sofferenze del paziente, ed è capace di sopportarle -cioè di ammettere la sua relativa
impotenza- invece di accanirsi ad “analizzarle” fino a farle sparire per dimostrare la sua
onnipotenza terapeutica (cit. Ogden, Balint, 1968).
Ancora di più Searles, riferendosi a quanto ha compreso nel proprio lavoro con pazienti
schizofrenici, chiarisce l’importanza che ha per il terapeuta la disponibilità a sperimentare
aspetti dei sentimenti del paziente: “Il paziente acquista un Io più forte […] attraverso
l’identificazione con un terapeuta che è in grado di sopportare e di integrare, nel suo Sé più
ampio, un tipo di rapporto che soggettivamente viene vissuto come non umano, un rapporto
in cui egli è un oggetto parziale, qual è quello che il paziente cerca di stabilire e ha bisogno di
avere con lui” (cit. Ogden, Searles, 1963). In questo passaggio Searles ci illustra come il
paziente schizofrenico viva in uno stato di immaturità affettiva relazionale propria anche di
altri pazienti in stato di regressione e tipica peraltro di diverse fasi di molte analisi e terapie, in
cui il paziente entra in relazione secondo bisogni e modalità profondamente primitive ma che
sono necessarie a mutarne il corso. Sottolinea inoltre, dal punto di vista del terapeuta, che:
“… il terapeuta, oltre a ricevere la proiezione, deve trasformarla e integrarla nella propria più
ampia personalità e rendere questa integrazione pronta per la reinternalizzazione da parte del
paziente”.
Malin e Grotstein in modo ancora più esplicito e pregnante arrivano a definire la terapia come:
il lavoro di modificazione degli oggetti interni del paziente mediante l’elaborazione
dell’identificazione proiettiva del paziente verso il terapeuta che dovrà accettare tali proiezioni,
amalgamarle con il proprio sé e favorirne successivamente la reinternalizzazione da parte del
paziente. L’interpretazione non viene del tutto rifiutata, ma è concepita per lo più come una
“modalità” attraverso la quale il paziente può essere aiutato ad osservare le proprie proiezioni
per come queste sono state ricevute e “riconosciute” dall’analista.
L’ evoluzione descritta porta addirittura R. Langs a proporre una rilettura del modello analitico
classico, nella quale l’analista veniva concepito come “uno schermo” per le proiezioni del
paziente, arrivando ora invece a formulare il ruolo dell’analista come di “contenitore” per i
contenuti patologici del paziente, con il quale entra pienamente in una partecipazione più
attiva e condivisa.
Infine un attenzione particolare va riservata al lavoro di Ogden, il quale dedica
all’identificazione proiettiva uno spazio centrale nella relazione e nel lavoro terapeutico con i
pazienti schizofrenici e non solo. Scrive: “L’identificazione proiettiva non è un concetto metapsicologico. I fenomeni che essa descrive esistono nel regno dei pensieri, dei sentimenti e del
comportamento, non nel regno delle ipotesi astratte sull’attività della mente” “[…] stati d’animo
che riguardano le fantasie inconsce di una persona (il proiettante) sono fatte proprie ed
elaborate da un’altra persona (il ricevente); ovvero indica il modo in cui una persona fa uso di
un’altra persona per sperimentare e contenere un aspetto di se stessa, attraverso una
fantasia inconscia di liberarsi di una parte di sé (compresi oggetti che erano stati interiorizzati)
desiderata o compromessa e di controllarla in un'altra persona,”. Per Ogden l’identificazione
proiettiva rappresenta il collegamento tra il mondo intrapsichico ed il mondo sensibile. Non
rappresenta però solo la strada maestra nel rapporto terapeutico con il paziente grave, ma è
presente e visibile anche in tutte le altre forme di relazione, dove però rimarrà maggiormente
relegata sullo sfondo. L’identificazione proiettiva, essendo stata una delle prime forme di
unione tra madre e bambino, finirebbe per rimanere presente in forma stratificata nella vita
psichica e di relazione del soggetto. Permanendo, secondo Ogden, come substrato
inconscio che integra in maniera non disturbante anche le modalità adulte di funzionamento
predominante. Ogden considera conferma di questo il fatto che permane in tutti noi una
qualche aspettativa inconscia che l’altra persona conosca precisamente quello che stiamo
provando. Non ci rassegnamo mai completamente al fatto di essere soli con i nostri pensieri e
sentimenti. L’identificazione proiettiva rimarrebbe perciò parte di ogni relazione di transfert
dell’analizzando, anche ben integrato, con il proprio analista, influenzando il modo in cui
l’analista entra in contatto con lui. Ogden aggiunge che: “quelli che considerano
l’identificazione proiettiva “un meccanismo fondamentalmente psicotico” (Maisner, 1980)
confondono ciò che è primitivo con ciò che è psicotico. La diffusione dei confini dell’Io e il
considerare l’oggetto come un’estensione del Sé sono caratteristici degli stati psicotici, ma
trovano anche posto all’interno di una gerarchia di modalità di relazione proprie della
personalità sana.” (Ogden).
Nonostante l’ampia e diversificata visione ed uso teorico e tecnico dell’identificazione
proiettiva, all’interno della comunità psicoanalitica è possibile mettere in evidenza alcune linee
teoriche e distinguere delle fasi, diversamente concepite e riconosciute.
C’è concordanza sull’idea che l’identificazione proiettiva parta da una fantasia inconscia
potente e concreta di riuscire a mettere nell’altro una parte di sé, indesiderabile o amata,
come anche veri e propri oggetti interni (esternalizzazione, espulsione ) e questo soprattutto
con finalità protettive e di controllo. Questa primitiva forma di relazione rappresenta sia uno
stato normale nello sviluppo dell’infante sia una residua forma di relazione operante
principalmente nelle patologie più gravi, in primis nella schizofrenia. Forma di relazione e
comunicazione che non è possibile si instauri in assenza di interazione interpersonale.
L’identificazione Proiettiva è un ponte tra fenomeni intrapsichici ed interpersonali che modifica
le sensazioni nella realtà esterna del qui ed ora della relazione. Attraverso una pressione
relazionale sul ricevente che avvertirà in sé, senza la possibilità di un’iniziale facile
consapevolezza, una riduzione della propria libertà personale, in particolare del pensiero, si
produce il desiderio di agiti contro-proiettivi. Il ricevente avverte con vari gradi di intensità
“uno stato di invasione” irritante, angosciante, avvilente e comunque un sentimento vicino a
quello espulso dal proiettante. Maggiore sarà la violenza e forza delle proiezioni e pressione,
maggiormente difficile sarà per il ricevente rendersi consapevole di essere sottoposto ad
identificazione proiettiva. La consapevolezza di questo diviene necessaria però per avviare il
processo di “psicologizzazione” ovvero di trattamento metabolico, digestivo, che consente al
paziente la “reinternalizzazione” successiva delle proprie parti proiettate, ora trasformate.
L’aspetto della reinternalizzazione che molto si ispira alle idee di Bion ed ai contributi di
Winnicot sullo sviluppo della diade madre-bambino, rappresenta il punto maggiormente
controverso e dibattuto all’interno della comunità psicoanalitica. Viene trasversalmente
riconosciuta l’utilità del concetto di identificazione proiettiva nell’approcciare pazienti in stato
di funzionamento primitivo o fortemente regrediti, ma ci si divide sulla possibilità di accettare
una circolarità così imponente di elementi e simboli tra gli attori della relazione.
Ogden, riprendendo Bion, scrive:“Partendo dalla prospettiva dell’identificazione proiettiva, si
comprende che nel processo terapeutico il paziente affida al terapeuta e gli forza dentro un
aspetto di sé che non è stato in grado di integrare o di utilizzare al fine di una crescita
psicologica. Ed il ruolo del terapeuta diviene quello di rendere disponibile al paziente, per la
re-internalizzazione, la stessa cosa con cui il paziente aveva iniziato, ora lievemente
modificata dal fatto di avere “riposato” nel terapeuta” (Bion, 1967).
A questo punto è legittimo porsi una domanda: come è identificabile e riconoscibile
l’identificazione proiettiva rispetto ad una proiezione di transfert ?
Classicamente il transfert rappresenta una distorsione della rappresentazione di un oggetto
attuale sulla base dell’esperienza avuta nel rapporto con un oggetto precedente; i sentimenti
nei confronti dell’oggetto attuale sono alterati secondo i sentimenti originati nella relazione
precedente ( Freud, 1912a, 1914a, 1915d, cit da Ogden). Il transfert è quindi concettualizzato
come un evento intrapsichico che può essere definito senza fare riferimento al modo in cui
quell’evento influisce sulla struttura della personalità di un'altra persona o da questa viene
contagiato. Allo stesso modo, il controtransfert è solitamente visto come un evento
intrapsichico, che si genera nell’analista per influenza del transfert e che è considerato come
la distorsione della prospettiva e dei sentimenti dell’analista verso il paziente, a causa dello
spostamento e della proiezione, sul paziente, di sentimenti sorti in relazioni precedenti: “Il
controtransfert è una relazione transferale dell’analista verso un paziente” (cit. Ogden,
Greenson, 1967). Entrambi gli aspetti sono di natura squisitamente intrapsichica e
influenzano la relazione attuale. In entrambi i casi i confini dell’Io di entrambi gli attori sono
piuttosto chiari e definiti. Nell’identificazione proiettiva, pur rappresentando anch’essa un
aspetto del transfert, il terapeuta viene maggiormente arruolato in maniera inconscia dal
paziente per la messa in atto interpersonale di un segmento del proprio mondo interno e dei
propri oggetti interni. E questo implica la sensazione di una pressione relazionale intensa che
difficilmente può essere immediatamente e semplicemente “compresa” ma viene percepita
attraverso un faticoso percorso di auto analisi e anche, utilmente, di supervisione, co-visione
con colleghi, esterni al necessario coinvolgimento relazionale esistente tra quel paziente e
quel terapeuta. Come più volte ribadito l’identificazione proiettiva, col suo relativo
coinvolgimento transferale e controtransferale, è tipico delle terapie con pazienti gravi. Nella
terapia, invece, di pazienti nevrotici con relativo buon funzionamento, spesso vi è una
pressione minima sul terapeuta a partecipare a una rappresentazione interpersonale del
transfert, cui corrisponde la presenza sia di un’incompleta differenziazione tra il Sé e
l’oggetto, sia di desideri inconsci di controllare e influenzare il terapeuta dall’interno. In queste
circostanze, il rapporto del terapeuta con l’esperienza del paziente è di tipo empatico
(Ogden), si tratta cioè di “condividere” e “comprendere” cognitivamente e affettivamente lo
stato psicologico del paziente, ma quest’ ultimo è riconosciuto e sentito come una persona
completa e distinta.
La sostanziale differenza tra queste forme di transfert poggia principalmente sulla fantasia
proiettiva inconscia del paziente in merito a ciò che “sta facendo” all’analista ed al
conseguente livello di pressione interpersonale presente tra i soggetti che partecipano alla
relazione.
Ogden più di altri si è interessato all’identificazione proiettiva come strumento concreto di
lavoro con pazienti schizofrenici, ricercando una teorizzazione complessiva e complessa del
funzionamento di questo fenomeno. Partendo dalla visione bioniana di identificazione
proiettiva, egli integra e mutua altri concetti che meglio permettono di spiegare, secondo lui,
la fenomenologia schizofrenica. Come spiegato da Bion l’identificazione proiettiva
rappresenta la principale forma di legame e comunicazione tra la madre ed il bambino. La
madre, sensibile e coinvolta con il bambino, “presta” la propria strutturazione e maturità
affettiva per riconoscere ed elaborare le esperienze sensoriali grezze del bambino (elementi
beta) in esperienze maggiormente elaborate, digerite, reinternalizzabili (elementi alfa) che
divengano così utilizzabili per l’esperienza ed il pensiero conscio ed inconscio del bambino.
La percezione diviene in questo modo esperienza significativa in quanto trasformata in
simboli, disponibile per l’elaborazione di pensieri, sogni, fantasie, memorie ecc… Se tale
processo di elaborazione non avviene, l’esperienza sensoriale tendenzialmente verrà
evacuata dal bambino attraverso l’identificazione proiettiva in quanto dirompente la fragile
struttura interna. Qualora la madre rifiuti di ricevere tali proiezioni, quando addirittura non
divenga lei stessa proiettiva nei confronti del bambino per propria struttura e necessità
personali, produce un “attacco al legame” che svuota le sensazioni e i pensieri del bambino di
qualsiasi significato potessero avere avuto in precedenza. In tal modo impedisce anche
l’interiorizzazione di “un apparato per pensare i pensieri” sempre più complesso e stabile,
sostituito invece da un “ipertrofico apparato per l’identificazione proiettiva”. Su questo punto
però Ogden contesta la visione di Bion. L'identificazione proiettiva, in assenza della
disponibilità materna a ricevere le proiezioni, non potrebbe né potenziarsi né radicarsi. Infatti
le fantasie primitive poggerebbero comunque su aspetti simbolici che non possono crearsi in
assenza della disponibilità originaria materna di “pensare i pensieri del bambino”, e d'altra
parte difficilmente possono ritenersi indipendenti ed innati. Perciò Ogden ricorre all' ipotesi di
un meccanismo operante prima dell’identificazione proiettiva. Si rifà alle alle idee di Grotstein,
che vede lo schizofrenico eccessivamente fragile e sensibile per motivi costituzionali agli
stimoli, e perciò in uno stato conflittuale interno di continua emergenza che lo obbliga ad
erigere difese rigide e premature. Tale funzionamento è chiamato “repressione connotativa”,
intendendo con ciò una sostanziale impossibilità di elaborazione evolutiva dell’esperienza e
dell' interesse verso il mondo come verso se stesso da parte dello schizofrenico. Ogden lo
definisce stadio della “non esperienza”, precedente l’identificazione proiettiva. Egli ricerca, in
definitiva, una teoria complessiva della schizofrenia che integri lo stato conflittuale
intrapsichico tra pulsioni con quello della capacità di generare significato psicologico. Questa
teoria è finalizzata non solo alla comprensione ma anche alla clinica della schizofrenia.
Ogden concepisce quattro stadi distinti e progressivi, in cui le conquiste evolutive raggiunte
nel corso di uno stadio gettano le basi per quello successivo:
1. lo stadio della non-esperienza
2. lo stadio dell' identificazione proiettiva
3. lo stadio dell’esperienza psicotica
4. lo stadio del pensiero simbolico.
La principale caratteristica dello stadio della non esperienza nello schizofrenico è che, da un
punto di vista emotivo, ogni esperienza viene esperita dal soggetto come equivalente l’una
all’altra. Tutte le cose, le persone, i luoghi e i comportamenti sono fra loro intercambiabili. L'
esperienza non può essere vissuta in quanto è assente la possibilità di attribuirvi un
significato. In questo modo il conflitto interno viene ridotto enormemente ma non
completamente eliminato. Se si mette infatti a disposizione del paziente un recettore
disponibile a contenere le sue evacuazioni, gli si permetterà di evolvere allo stadio
dell’identificazione proiettiva. Il cambiamento è riconoscibile per l’instaurarsi di una pressione
interpersonale piuttosto violenta e disturbante a carico del terapeuta che gli renderà difficile
trovare in sé la libertà di pensare e sviluppare fantasie sul paziente. Tale pressione è
completamente assente nello stadio precedente. In questa fase il terapeuta dovrà garantire
prioritariamente i confini del setting e la regolarità e costanza della sua presenza al paziente,
trasmettendogli un senso di affidabilità e sicurezza del “contenitore”. Questo lavoro
permetterà al paziente, “contenuto” e protetto, di iniziare a sperimentare una gamma un po’
più vasta di stati d’animo, proiettati in modo violento per il desiderio di distruggere la propria
neonata capacità di fare esperienza e di pensare, che però ora coesiste col desiderio di
usare il terapeuta per creare esperienza e per strutturare il pensiero. Il terapeuta è vissuto
come un oggetto che è parzialmente separato, nel quale le parti del Sé possono essere
messe e tolte. Il conflitto interno al paziente viene esteriorizzato e percepito dal terapeuta
come attacchi interpersonali feroci rivolti al pensiero che tentano di minare la sua capacità di
pensare e far pensare. Le ripetute identificazioni proiettive adeguatamente elaborate e
contenute avvicineranno al terzo stadio in cui compare la capacità di sviluppare pensieri
embrionali che non debbano essere immediatamente “scacciati” in un’altra persona. E’
ancora prevalente una sostanziale indefinitezza dei confini dell’Io con un funzionamento
disgregato, specialmente nelle aree dell’integrazione e dell’esame di realtà e dove prevale
ancora il processo primario. Questo terzo stadio è fondamentale per l’instaurarsi in modo
prevalente del processo dell’equazione simbolica, dove sensazioni e pensieri acquistano il
valore di veri e vividi oggetti concreti al proprio interno. Un mondo questo ancora frammentato
e colmo di oggetti distorti in maniera bizzarra. La parola acquisisce una primitiva possibilità
transizionale di creare rappresentazioni e cominciare a comunicare e organizzare
l’esperienza psicotica. Anche il terapeuta, seppur ancora soggetto ad attacchi, rimanendo
per il paziente un contenitore parzialmente separato, può cominciare a rispondere al paziente
in modo un po’ più empatico. Il rapporto terapeutico “è per molti aspetti paragonabile al
rapporto madre-bambino descritto da Winnicott (1958) durante la fase di sviluppo, quando il
bambino impara a giocare da solo in presenza della madre.” (Ogden). In questo terzo stadio il
paziente è più floridamente psicotico ma più “vivo ed umano”, la prima impressione di un
peggioramento clinico, soprattutto se paragonato alla maggiore “tranquillità” degli stadi
precedenti, è perciò fuorviante. In questo stadio infatti, a differenza di quanto succedeva
precedentemente, il terapeuta viene percepito e considerato come una persona che può
essere d’aiuto di fronte a esperienze che incutono timore, piuttosto che solamente un
ricettacolo in cui poter scaricare le proprie parti non volute. Si arriva infine allo stadio così
detto del pensiero simbolico, dove il paziente aumenta la propria capacità di contenere i
pensieri e i sentimenti, diminuendo proporzionalmente e in modo significativo il ricorso
all’identificazione proiettiva come modalità di comunicazione e difesa, e diventando inoltre
possibile per il terapeuta la verbalizzazione più frequente di interpretazioni che un tempo egli
manteneva “silenti”.
Bibliografia:
J. Sandler “Proiezione, identificazione, identificazione proiettiva” ed.Bollati Boringhieri
Thomas H Ogden “La identificazione proiettiva e la tecnica psicoterapeutica” ed. Astrolabio
Hanna Segal “Introduzione all’opera di Melanie Klein” ed. G.Martinelli & s.a.s. Firenze
Donald W. Winnicot “Dalla pediatria alla Psicoanalisi” ed. G.Martinelli & s.a.s. Firenze
Kenneth Wright “Bion e oltre” ed. Funzione Gamma
PAGE \* MERGEFORMAT11