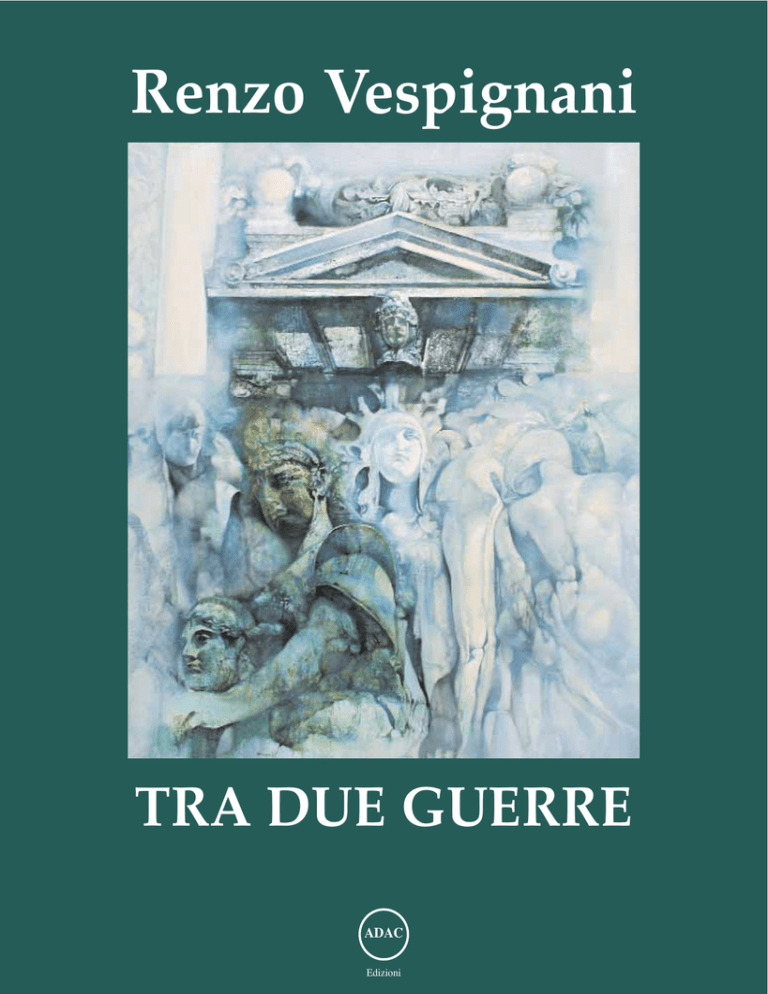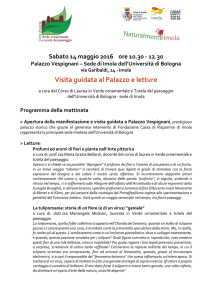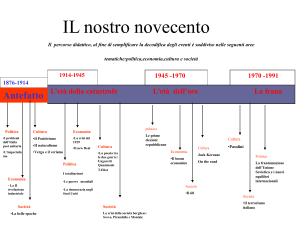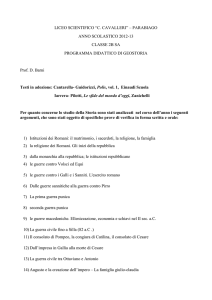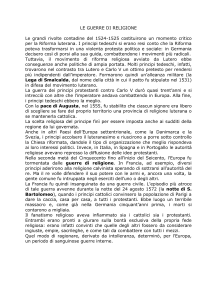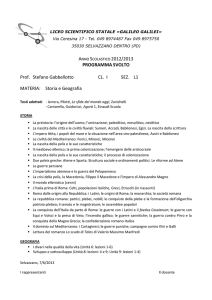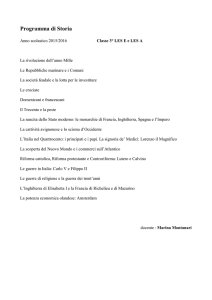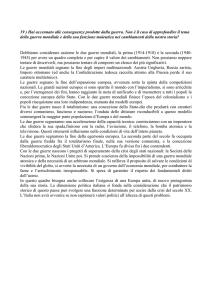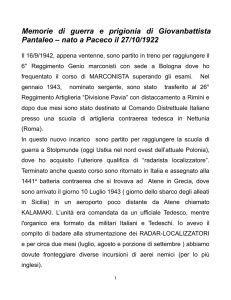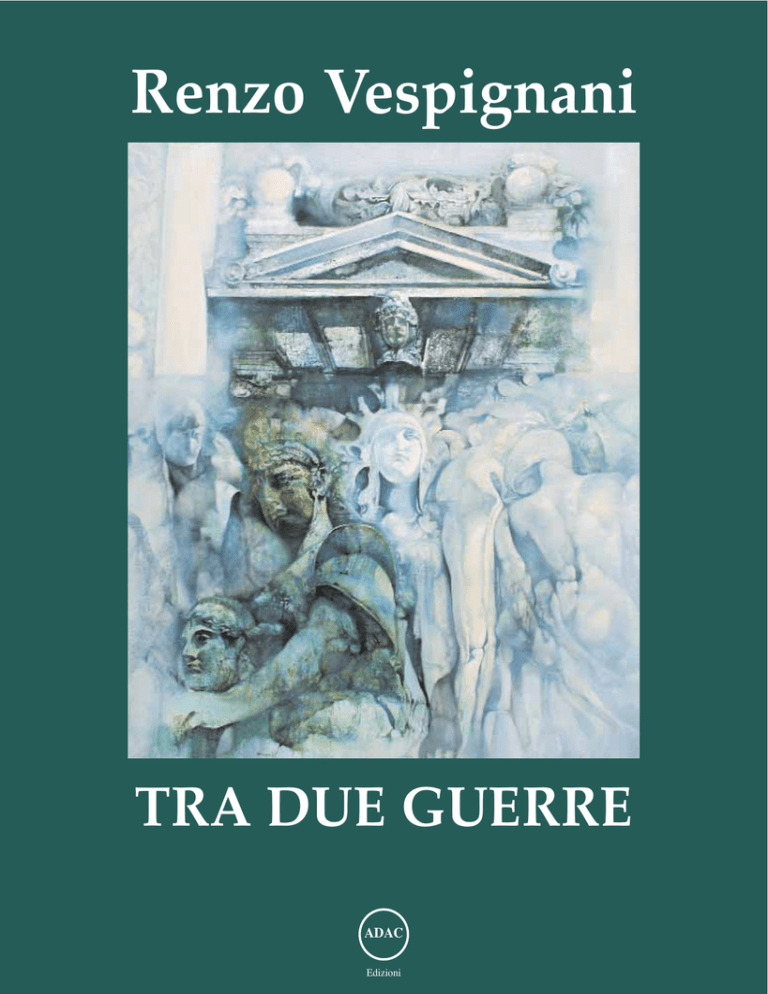
Renzo Vespignani
TRA DUE GUERRE
ADAC
Edizioni
Renzo Vespignani
TRA DUE GUERRE
in copertina:
Renzo Vespignani
I volti della patria, 1975
Fotografie:
Ut Orpheus Edizioni S.r.l.
Progetto grafico e impaginazione:
Micaela Bonavia
Renzo Vespignani
Tra due guerre
Massa, Palazzo Ducale, 25 aprile - 2 giugno 2006
Esposizione a cura di Massimo Bertozzi
Conferenza inaugurale di Philippe Daverio
Provincia di Massa-Carrara
Presidente
Osvaldo Angeli
Assessore alle Politiche Culturali
Lara Venè
Comune di Massa
Sindaco
Fabrizio Neri
Vice Sindaco, delegato
alla Memoria e alla Resistenza
Stefano Alberti
Associazione
Diffusione Arte Cultura
Presidente
Adriano Primo Baldi
Consiglieri
Noris Amadelli
Ardilio Cianassi
Ione Mantovani
Piero Selmi
Coordinatrice
Rina Cianassi
Relazioni esterne
Giuseppe Stafforini
Archivio Luporini
Annalisa Pedrazzi
Grafica e uff. Roma
Micaela Bonavia
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara
Presidente
Alberto Pincione
ANPI - Sezione Provinciale
di Massa
Presidente
Ermenegildo Della Bianchina
Collaboratori
Enrico Bellei
Laura Fasolo
Mara Gozzoli
Alfredo Guidi
Giovanni Lodi
Cristina Margeri
Giulia Redaelli
Sebbene siano passati trent’anni da quando Renzo Vespignani realizzò la mostra Tra due guerre,
che siamo lieti di ospitare al Palazzo Ducale di Massa, e ulteriori trent’anni ci separino dalla
fine della guerra e dalla caduta del fascismo, gli orrori che qui vediamo dipinti non smettono
di suscitare la nostra commozione per quello che è stato e di rafforzare il nostro impegno affinché tutto questo non si ripeta.
Quando ogni anno celebriamo, nel mese di aprile, la Festa della Liberazione, non possiamo
infatti dimenticare che la primavera del 1945 arrivò dopo un inverno durato più di vent’anni,
e non possiamo fingere di non sapere come quell’inverno, iniziato nell’ottobre del 1922, si era
manifestato e poi concretizzato.
Non possiamo dimenticare cioè quella lunga stagione di aggressioni alla democrazia e alla
convivenza civile, in cui alla lotta politica e al confronto delle idee si sostituì la pratica della
violenza, l’intimidazione dell’avversario, l’assalto alle sedi di organizzazione e di discussione
politica, la distruzione degli organi di informazione.
Ricordare tutto ciò è non solo utile, ma anche doveroso, dal momento che troppo vediamo riaffiorare, nel confronto politico quotidiano, il germe dell’intimidazione e della prevaricazione,
mentre dovrebbe essere chiaro per tutti che la libera espressione del pensiero è un connotato
irrinunciabile della democrazia, e non può in nessun caso prescindere dal rispetto, civile oltreché politico, dell’avversario.
La mostra di Vespignani, che così bene denuncia la ferocia ma anche la stupidità della guerra,
aveva rappresentato trent’anni fa una preciso richiamo a non dimenticare e a non rimuovere la
vergogna che ogni uomo non può non sentire per tutti i massacri perpetrati in nome di una
pretesa superiorità, di razza, di religione, di cultura.
Riproposta oggi vuole essere una risposta alle tante pretese revisioniste, che vorrebbero
riscrivere la storia per cancellare colpe e responsabilità, e perfino negare che tutto questo sia
veramente successo. Siamo infatti convinti che l’esigenza, giusta e doverosa, di riconsiderare
con animo più distaccato i tragici avvenimenti che hanno segnato la lotta per la libertà e la
democrazia, non possa davvero spingersi fino al punto di falsare il giudizio storico, morale
e politico su quello che fu, da qualunque punto di vista lo si guardi, un conflitto fra umanità
e barbarie.
La mostra è così un omaggio a tutte le vittime di quell’immane catastrofe e un riconoscimento
alla memoria di quanti, istituzioni e associazioni partigiane, ma anche singoli cittadini, hanno
continuato, anno dopo anno, a ricordare quegli avvenimenti, a commemorare i morti, ad
ammonire noi tutti sulla pericolosità dell’oblio e dell’indifferenza.
Vuole essere dunque un impegno a non dimenticare, ma anche a rammentare ai più giovani, e
più in generale a coloro che non hanno vissuto quella stagione dolorosa della nostra storia,
quanto sia pericoloso abbandonare la strada del confronto pacifico, e praticare comportamenti
aggressivi e violenti nei confronti di altri popoli, altre civiltà, perdendo di vista il rispetto per i
valori fondamentali dell’uomo, che sono la libertà e l’uguaglianza, ma anche il sacrosanto
diritto alla diversità.
Fabrizio Neri
Sindaco di Massa
Osvaldo Angeli
Presidente della Provincia di Massa-Carrara
Ritengo importante che la mostra di Renzo Vespignani Tra due guerre venga inaugurata al
Palazzo Ducale di Massa il 25 aprile, come monito verso tutte le guerre e come significativa
iniziativa di pace. Questo ciclo di opere è stato esposto nel 2004 al Complesso del Vittoriano
di Roma a sessant’anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine, nell’ambito delle manifestazioni
«Noi Ricordiamo – Memoria, Resistenza, Liberazione 1944-2004».
Oggi, a due anni di distanza, e in occasione del sessantesimo della proclamazione della
Repubblica, la Provincia di Massa-Carrara ha deciso di rendere omaggio a un grande maestro
della pittura italiana esponendo questa mostra con una presentazione di Massimo Bertozzi e
una conferenza di Philippe Daverio.
Vespignani è un artista, sì, ma non meno è un intellettuale di grande rigore che non riesce a
dimenticare anche a distanza di anni le nefandezze della guerra, le menzogne, gli inganni, i
silenzi e le ipocrite giustificazioni di chi consapevolmente fingeva di non sapere. Nei quadri
esposti emergono drammaticamente le sofferenze degli oppressi e l’arroganza di carnefici,
che, stravolgendo l’idea di patria in delirante supremazia razziale, hanno scatenato una inimmaginabile violenza di massa. La tragedia della guerra supera i confini di ogni paese e coinvolge tutti i regimi, così come il culto del capo carismatico e l’uso violento e prevaricante del
potere apre la porta alle peggiori aberrazioni e al disprezzo dei più elementari valori umani.
Queste opere ci chiedono di esaminare la storia fuori dall’influenza di passioni e interessi di
parte, opere che gridano l’orrore degli uomini e il loro dolore. Un grido che Piero Calamandrei
ha impresso in un’epigrafe che mi colpì da adolescente: «Noi non volemmo morire, noi non
vogliamo essere morti. Col sangue dato da Dio, firmammo un patto sacro, costituito di libertà,
di lavoro, di pace. Voi che ancora vivete non tradite questa legge giurata, datevi mano, aprite
come volemmo le porte dei millenni nuovi. Fate la liberazione». È sicuramente utile leggere
l’eloquente e documentato saggio di Gaspare e Roberto De Caro contenuto in questo volume
e meditare sul numero dei morti e dei massacri che hanno insanguinato l’Europa in nome
della forza e del potere. Vespignani non ha mai smesso di pensare a quelle mostruosità e,
come ricordano nei loro saggi Eugenio Riccòmini e Lorenza Trucchi, ha sentito il bisogno di
continuare a denunciare le violenze di un’Europa impazzita. Il collezionista modenese Franco
Fabbi ha consentito a Vespignani la realizzazione di questo ciclo pittorico che non si può certo
dire commissionato per speculazioni di mercato. Ringrazio la Provincia di Massa-Carrara, e
per essa lo storico dell’arte Massimo Bertozzi, per aver dato seguito ad una proficua collaborazione tra l’associazione Adac di Modena, che rappresento, e l’assessorato alla cultura della
Provincia di Massa-Carrara la quale, sempre con un intervento di alto profilo culturale di
Philippe Daverio, ha recentemente realizzato nell’ambito di questa collaborazione una
grande mostra di Sandro Luporini.
Tornando a questa esposizione, Tra due guerre, e prima di concludere, c’è ancora una piccola
cosa che vorrei sottolineare. Renzo Vespignani era guidato dal talento, ma ha avuto come
grandi consiglieri lo studio, l’osservazione, la coscienza e l’onestà intellettuale. Ha rifiutato la
finzione e l’ipocrisia in diverse fasi della sua vita. Il nostro compito di operatori dovrebbe
essere guidato dalla stessa onestà. Le nostre scelte pesano sulla formazione delle coscienze, e,
se sbagliate, non solo non educano, ma possono, nel tempo, produrre irreversibili danni. Se
uno dei compiti della cultura è quello di educare alla convivenza e allo spirito critico, abbiamo
tutti il dovere di denunciare alle nuove generazioni gli orrori prodotti dalle guerre. Non possiamo non vedere che nelle più diverse parti del mondo l’inizio del nuovo millennio è ancora
intriso di violenza, di sopraffazioni e di ingiustizie.
Adriano Primo Baldi
Presidente Adac (Associazione Diffusione Arte Cultura)
«[...] È una storia tra le due guerre, ma non tutta quella storia: mancano dalla scena il
popolo, la sua avanguardia, le sue rivoluzioni. Qui è soltanto plebe trasferita da un teatro di
guerra a un altro, da un’illusione a un’altra; una sfocata proiezione di membra piagate, di
foto formato tessera. È martirio e morte: la morte, dopotutto, resta evento completo e inequivoco, il solo che il potere dei monarchi, dei poliziotti, dei poeti guerrieri, non è riuscito a
defraudare della sua qualità interamente umana. [...]
Si può dire che tutto il mio lavoro non aggiunge niente a Reich, a Thayer, a Diks, a Nolte;
niente che già non si sappia sui processi di trasformazione del cittadino in terrorista, sui
modelli famigliari che sublimano la logica degli Einsatzgruppen. E veramente, nella direzione del saggio, la pittura non può scoprire o spiegare quanto la parola. A meno che non
rappresenti (renda presente) ciò che la parola allontana. I suoi “segnali” possono colpire
quella zona della nostra coscienza che è appena sfiorata dalla informazione scritta. I dati
scientifici, i documenti e le schede, possono diventare sulla tela “caldi” come organismi
viventi. La immagine plastica sconvolge quel tanto di pacifico (o pacificato) che è nella
comunicazione critica: una cosa è dire sangue, un’altra vederlo. Il sangue che intride la terra
sotto i fucilati di Goya è appena sgorgato, e spiega e complica la storia con veemenza ineffabile; strappa l’accaduto da un contesto di fatti appiattiti e omologati, gli restituisce il
senso dell’azzardo disperato, del guasto irreparabile. Torna a sorprenderci. Definire la
natura di questa sorpresa, la sua qualità di notizia totalmente nuova ed essenziale, significa
spiegare il perché e la necessità del dipingere.»
Renzo Vespignani, Tra due guerre
Roma, maggio 1975
Sommario
15
Renzo Vespignani: Tra due guerre
17
Renzo Vespignani
Nota biografica
19
Tra due guerre
di Renzo Vespignani
23
Tra due necessità
Ricordare e dipingere
di Massimo Bertozzi
27
Marmo e sangue
Due parole su Vespignani, e sul dipingere la guerra
di Eugenio Riccòmini
31
Pessimismo esistenziale e coscienza critica nella pittura di Renzo Vespignani
di Lorenza Trucchi
35
La sacra infamia: promemoria sul deprecato tabù della guerra
di Gaspare De Caro e Roberto De Caro
Il ciclo Tra due guerre
Schede critiche di Gaspare De Caro e Roberto De Caro
53
Il sangue è il vino dei popoli forti
73
La pupilla del regime
109
Gli attributi del potere
143
Il sudore e la gloria
167
Mythus
INDICE DELLE OPERE
206
Opere della collezione Fabbi
207
Altre opere riprodotte nelle schede critiche
Renzo Vespignani: Tra due guerre*
Renzo Vespignani dipinse il ciclo Tra due guerre tra il 1972 e il 1975. Attualmente queste opere
sono quasi tutte raccolte nella collezione Fabbi. Esposte poi con qualche variante in Italia e
all’estero, vennero presentate per la prima volta nel 1975 alla Galleria d’Arte Moderna di
Bologna, in occasione delle celebrazioni del trentennale della Resistenza. Nello stesso anno
Vespignani dedicò al ciclo anche un volume omonimo (Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, Torino),
che ebbe una seconda edizione nel 1976 corrispondente alla raccolta Fabbi. Il ciclo, secondo il
percorso indicato dall’autore, è diviso in cinque sezioni: Il sangue è il vino dei popoli forti; La
pupilla del regime; Gli attributi del potere; Il sudore e la gloria; Mythus. Ciascuna sezione è qui preceduta da una scheda a cura di Gaspare De Caro e Roberto De Caro e da una silloge di motti e
citazioni scelti dallo stesso Vespignani per i volumi ricordati. All’interno di ciascuna scheda,
nella relativa sezione, si riproducono, oltre agli 80 quadri della raccolta Fabbi, anche le opere
non comprese in questa, ma presenti nella mostra del 1975 e nella prima edizione del citato
volume.
Tra due guerre, scrive Vespignani, è innanzitutto «una storia per immagini da Serajevo a
Norimberga […], una riflessione sul fascismo e sulla cultura delle masse piccolo-borghesi, che
cementano nel buio, come il popolo delle termiti, la loro città-prigione». Ma è anche viaggio in
nulla consolatorio attraverso gli orrori del primo Novecento, richiamo al dovere di una memoria né selettiva né indulgente, presa di coscienza delle responsabilità dell’arte e delle specifiche
possibilità della pittura, del suo insostituibile ruolo di Instrument der Erkenntnis, di strumento
di conoscenza, come scrisse Dieter Ruckhaberle in occasione dell’esposizione berlinese del
1976. Alta storiografia figurativa, programmaticamente lontana dai nefasti turgori della pedagogia civica, Tra due guerre disincrosta e scopre il filo feroce e resistente che lega «la strage filantropica» del ’14-’18 agli abissi della Shoah, il Mito della Nazione al Mythus della Razza: è il
doppio filo dei valori e dei simboli lungo il quale il Dominio spaccia ai dominati il proprio
sogno, secondo la stringente definizione che Simone Weil ha dato del Potere. Indagando a
fondo il tema, senza indulgere a facili accomodamenti, e respingendo la categoria sfuggente e
in ultima analisi assolutoria dell’inintelligibilità del Male, Vespignani si assume con forza la
responsabilità morale del giudizio e della scelta, interpretando magistralmente e con rara onestà intellettuale l’ineludibile lascito etico e politico di Hannah Arendt.
* Ad eccezione dello scritto di Massimo Bertozzi, il presente volume ripropone, per gentile concessione,
testi e immagini tratti da Renzo Vespignani, Tra due guerre, Ut Orpheus, Bologna 2004: catalogo della
mostra tenuta a Roma, nel Complesso del Vittoriano, tra il 24 marzo e il 25 aprile 2004, con scritti di
Gaspare De Caro - Roberto De Caro, Eugenio Riccòmini e Lorenza Trucchi; e, per un commento a ciascuna sezione, da Gaspare De Caro - Roberto De Caro, Renzo Vespignani: «Tra due guerre». Schede critiche,
Adac - Ut Orpheus, Modena - Bologna 2004.
Il testo riportato in questa pagina, la successiva nota biografica su Renzo Vespignani, le tavole sinottiche
degli 80 quadri della raccolta Fabbi integrate dalla riproduzione di altre 21 opere a pieno titolo appartenenti al ciclo stesso e l’indice delle opere sono a cura di Gaspare De Caro e Roberto De Caro.
15
Renzo Vespignani
Nota biografica
Renzo Vespignani nasce a Roma il 19 febbraio 1924 da Guido e Ester Molinari. Bisnipote di
Virginio – famoso architetto, cui si devono tra le altre cose la ricostruzione della Basilica di San
Paolo, l’erezione dell’obelisco di piazza del Popolo e la Scalinata della Dataria al Quirinale –
dopo la morte del padre, stimato medico chirurgo e cardiologo, è costretto giovanissimo a trasferirsi con la madre nella zona proletaria di Portonaccio, adiacente al quartiere San Lorenzo.
Nel 1943, in una Roma traumatizzata dai bombardamenti, inizia a disegnare e affida a un diario le proprie riflessioni. Nel 1945 espone nella sua prima personale alla Galleria «La
Margherita» e comincia a collaborare a varie riviste letterarie con scritti, illustrazioni e disegni
satirici. Nel 1948 la Galleria «Hugo» di New York gli dedica una mostra: a 24 anni è già un artista internazionalmente noto e Oskar Kokoschka lo raccomanda al Ministero per gli Affari
Esteri per una borsa di studio per la Francia, definendolo «uno dei migliori disegnatori contemporanei». Tra i massimi incisori italiani del secolo, a partire dagli anni ’50 Vespignani
lavora anche a scenografie cinematografiche e teatrali per Elio Petri, Francesco Rosi, Luigi
Squarzina, Luchino Visconti. Nel 1956 fonda insieme ad altri artisti, architetti, letterati, registi
Città aperta, rivista problematicamente rivolta alla cultura urbana, in aperta polemica con un
movimento neorealista che dopo Umberto D – ultimo, estremo e doloroso gesto sovversivo di
quel Vittorio De Sica così importante punto di riferimento per Vespignani – aveva tradito la
lucida intransigenza dell’indagine sociale per rientrare nei ranghi innocui e premianti del dissenso compatibile. A partire dalla fine degli anni ’60 comincia a dipingere per grandi cicli:
Imbarco per Citera (1969), sulla crisi del ceto intellettuale; Album di famiglia (1971), acuta indagine del quotidiano; Tra due guerre (1972-1975), «una storia per immagini da Serajevo a
Norimberga». Nel 1982 si reca per la prima volta negli Stati Uniti. Nel 1985 espone a Roma, a
Villa Medici, oltre cento opere nella mostra Come mosche nel miele, ciclo dedicato a Pier Paolo
Pasolini. Nel 1991, sempre a Roma, a Palazzo delle Esposizioni, antologica di 124 opere, tra le
quali il ciclo Manhattan Transfer, sull’insostenibile delirio esistenziale dell’American Way of Life.
Nello stesso anno espone alla Galleria «Gregory» di Roma 250 fotografie nella mostra Un
romano a Manhattan. Sempre in stretto rapporto con poesia e letteratura, Vespignani pubblica
ed espone più volte cicli per le opere di Henri Alleg (giornalista che denunciò nel libro La
Question, del 1958, l’uso della tortura da parte dell’esercito francese in Algeria), Belli,
Boccaccio, Eliot, Kafka, Leopardi, Majakovskij, Porta, Villon: un elenco assolutamente eloquente della radicalità del suo impegno morale e civile. Nel 1999 viene eletto Presidente
dell’Accademia Nazionale di San Luca e nominato Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica.
Muore a Roma il 26 aprile 2001.
17
Tra due guerre*
di Renzo Vespignani
Una storia per immagini da Serajevo a Norimberga non può non essere, in larghissima parte,
una riflessione sul fascismo e sulla cultura delle masse piccolo-borghesi, che cementano nel
buio, come il popolo delle termiti, la loro città-prigione. Questa cultura è un glutine di stati
d’animo puerili, di umiliazioni e di solitudini antiche. Hitler pensava a se stesso quando scriveva che «la natura della maggioranza è femminea, e giuoca sempre tra due poli, uno negativo
e uno positivo, amore e odio, diritto o ingiustizia, verità o bugia». E meglio di tutti profitterà
di quel bisogno di giustizia e di verità, leggendovi un’utile (per lui) disposizione al rifiuto
della ragione, all’arroganza vendicativa, alla violenza sul «diverso». Certo i compiti più
ingrati, da macellaio, questa massa glieli affiderà restando nel privato auto-compassionevole
e mite. (Scomponendo l’orrore ci si accorge che è fatto di atomi di arrendevolezza, di lealtà
cameratesca, di onorabilità, di filiale rispetto.) Una struttura caratteriale, peraltro, che stinge
ben al di là dei ceti medi, e filtra nel sottosuolo delle masse popolari con la ovvietà del senso
comune. Per quanto spiacevole, non mi pare che si possa smentire l’affermazione di Reich,
secondo la quale «il fascismo come movimento politico si differenzia da altri partiti reazionari
per il fatto che viene sostenuto e diffuso dalle masse umane»; e che «non è, come si crede
generalmente, un movimento puramente reazionario, ma costituisce un amalgama tra emozioni ribelli e idee sociali reazionarie».
Naturalmente «qualcosa» o «qualcuno» dovrà agire sull’inerme e sul frustrato, perché possa
conquistare gradualmente un adattamento psicologico al ruolo di assassino o di complice.
Assai prima dei fatidici anni venti, in Italia, piove su questo terreno di cultura «battericamente
inerte» il reagente di una cultura superiore e solenne, organicamente elaborata da letterati,
filosofi, poeti, artisti, smaniosi di temprare la coscienza nazionale. È una cultura cripticamente
fascista: almeno nella misura in cui bergsonismo, neoromanticismo, misticismo, decadentismo, creano il culto dell’eros e della santa violenza patriottica. Affermando il diritto della poesia a farsi politica, ovvero il diritto della politica a realizzare una romanità da biblioteca, gli
«araldi della patria» premono in realtà l’acceleratore dell’imperialismo; che sarà cinico, dilettantesco e spiritualista. Assai prima di Marinetti, fu Corradini a intravvedere nella moderna
guerra meccanizzata una estetica e una morale purificatrici. Senonché, nella prosa e nelle
immagini di questi profeti, il dramma della guerra ha il candore zuccherino della statuaria
cimiteriale. Alla maniera di Sacconi, tra capitelli corinzi e colonne rostrate, avanza un popolo
di guerrieri nudi, efebici e insieme corrucciati, trascinandosi dietro le spose, i figli, le madri, le
giovenche, come in una migrazione biblica. È un popolo di costruttori, di santi, di navigatori,
non di emigranti e di cafoni prosciugati dalla pellagra. L’Italia alfabetizzata, quella che fortunosamente ha realizzato l’unità, si appresta a realizzare gli italiani: vagheggia per loro un
destino da fregio ellenistico (rivisitato da Dossena). L’espansionismo a danno dei barbari
avrebbe unito il Nord al Sud, il ricco al povero, col suggello del sangue sparso in comune. Ai
braccianti sarebbe toccata la terra come ai legionari di Roma, a compensare il trionfo sui
Teutoni, sui Cimbri, sui Cartaginesi. Già nel ’90 l’esercito era il cuore della nazione: non si deve
aspettare Mussolini per cantare di guerra civilizzatrice, con vanghe, libri e moschetti.
* Il presente testo è stato pubblicato per la prima volta nel catalogo della mostra Tra due guerre, organizzata dalla Galleria d’Arte Moderna del Comune di Bologna tra il 18 giugno e il 27 luglio 1975.
19
La bramosia di un grande destino, implica il disprezzo della idea parlamentare. L’Italia dei
Rastignac, dei Morasso, dei Turiello, dei Federzoni, sogna di superare all’indietro questa rappresentanza di avvocatucoli di provincia, modellando l’idea di un autoritarismo da secolo
augusteo; odia il paziente pragmatismo del «ragionier» Giolitti, e pavimenta la strada alla
mistica del condottiero; misura «la vita in termini di letteratura, la letteratura in termini di
azione», e non passerà molto perché si dica che «è necessario vincere ma ancora più necessario combattere».
Dunque si cerca di rompere il silenzio degli spiriti, dando fiato alle trombe della nevrastenia
nazionale. A rileggere questa letteratura, che non è solo dilettantesca o giornalistica, si
rimane stupefatti dalla terminologia lampeggiante, dallo scialo di evocazioni macabre e di
turgori millenaristici. Che diventasse il gergo della piccola borghesia era inevitabile. Se il
significato sfuggiva, la musica degli esametri restava: essa faceva letteralmente esplodere di
entusiasmo i ceti acculturati da un paio di generazioni, la minuta burocrazia degli scrivani e
degli uscieri comunali, dai ruoli ancora informi. Era una fonte di luce viva nella penombra
delle mortificazioni quotidiane, quasi un poetare collettivo. Le orazioni di D’Annunzio che
preludevano alle sanguinose spallate sul fronte dell’Isonzo, sono tipiche di una rettorica che
sodomizza l’ignoranza o l’antica cultura etnocentrica del popolo italiano: incomprensibili
perché zeppe di Leonidi, di Cornelie, di Cesari, di grifi e fiere rampanti, di allusioni omeriche e virgiliane, o forse solamente perché dette nell’italiano dei Lincei, fungevano da viatico
per il supremo olocausto. Battaglioni di analfabeti, mangiati dai pidocchi, si vedevano trasformati nella legione tebana.
Se il mio ciclo s’apre con alcuni ritratti di D’Annunzio, non è dunque in omaggio al gusto,
oggi diffusissimo, dei revivals nostalgici. Il personaggio, «avido di recitare la propria biografia», dà inizio ad una avventura culturale che dalla casa di Andrea Sperelli, «teatro di perfettissime emozioni», conduce alle Fosse Ardeatine; a una scena assai diversa, certamente, ma
congegnata dallo stesso «delicato istrione», dallo stesso «abilissimo apparecchiatore»; solo
orribilmente sfigurato e incrudelito dalla vecchiaia.
Una latinità liberty, poi novecentesca, si sfascia sotto le bombe: bandiere e trofei, tronchi marmorei e vecchie foto, sorrisi, vestiti di seta, uniformi sudicie e ventagli di piume, il ricordo del
cielo nella prima sera di guerra, sono i rottami di un progetto, nella sua essenza, paranoico.
Al pittore non resta che raccoglierli e tentare di classificarli.
Un materiale ostile, ai fini della restituzione plastica. Per tre anni ho vissuto insieme a spettri
che avevano la fragilità, l’odore vagamente ripugnante e uggioso dei vecchi documenti; tutte
le mie cognizioni di pittore, trapassandoli, si sono scomposte come un fascio di luce all’uscita
di un cristallo sfaccettato. Pertanto, queste tele registrano la resa dell’autore-demiurgo-arbitro
di forme ad un tema «impossibile»: la storia assunta dalla ragione, impersonalmente. Era un
prezzo da pagare: sapevo fin dall’inizio che non avrei potuto tirare, tra me e i grandi cimiteri
della patria, il confine invalicabile di una linea purissima.
È una storia tra le due guerre, ma non tutta quella storia: mancano dalla scena il popolo, la sua
avanguardia, le sue rivoluzioni. Qui è soltanto plebe trasferita da un teatro di guerra a un altro,
da un’illusione a un’altra; una sfocata proiezione di membra piagate, di foto formato tessera.
È martirio e morte: la morte, dopotutto, resta evento completo e inequivoco, il solo che il
potere dei monarchi, dei poliziotti, dei poeti guerrieri, non è riuscito a defraudare della sua
qualità interamente umana. Ammetto il pessimismo decadente del racconto. Ma ho dovuto
rileggere troppo D’Annunzio per arrischiarmi a cantare il volo di una Nike, anche se di una
Nike operaia.
Si può dire che tutto il mio lavoro non aggiunge niente a Reich, a Thayer, a Diks, a Nolte;
niente che già non si sappia sui processi di trasformazione del cittadino in terrorista, sui
modelli famigliari che sublimano la logica degli Einsatzgruppen. E veramente, nella direzione
del saggio, la pittura non può scoprire o spiegare quanto la parola. A meno che non rappresenti (renda presente) ciò che la parola allontana. I suoi «segnali» possono colpire quella
zona della nostra coscienza che è appena sfiorata dalla informazione scritta. I dati scientifici,
i documenti e le schede, possono diventare sulla tela «caldi» come organismi viventi. La
immagine plastica sconvolge quel tanto di pacifico (o pacificato) che è nella comunicazione
20
critica: una cosa è dire sangue, un’altra vederlo. Il sangue che intride la terra sotto i fucilati
di Goya è appena sgorgato, e spiega e complica la storia con veemenza ineffabile; strappa
l’accaduto da un contesto di fatti appiattiti e omologati, gli restituisce il senso dell’azzardo
disperato, del guasto irreparabile. Torna a sorprenderci. Definire la natura di questa sorpresa, la sua qualità di notizia totalmente nuova ed essenziale, significa spiegare il perché e
la necessità del dipingere.
Roma, maggio 1975
21
Tra due necessità
Ricordare e dipingere
di Massimo Bertozzi
«Dov’eri tu, o mio Signore, quando io soffrivo, dov’eri
quando il mio cuore era nel fango?»; «Io ero lì, nel fango».
(Santa Caterina da Siena)
A piedi nudi e col sangue agli occhi Renzo Vespignani esplora le profondità dell’abisso.
Trent’anni dopo la catastrofe, quando il ciclo Tra due guerre fu realizzato, così come ancora oggi,
dopo altri trent’anni, la sua pittura è lì a dire dove sprofondarono le magnifiche sorti e progressive della nostra civiltà.
Perché una cosa è chiara, il nemico non fu un estraneo. Non venne da fuori. Era cresciuto in
mezzo a noi, parlava la stessa lingua; aveva letto gli stessi libri e diceva di professare gli stessi
valori. Eppure fu empio e malvagio. Senza pudore e senza vergogna, dissennato e paranoico.
Partorito da una civiltà che aveva illuminato il mondo e che ora, spaventata dal futuro, accecava i suoi stessi figli.
La catastrofe insomma non venne da sola. Ci fu chi la preparò e chi la lasciò venire, per interesse o per rassegnazione; ci fu soprattutto chi era destinato a subirla. Perché quando la storia
ammannisce il banchetto possono cambiare i commensali, ma a pagare il conto sono sempre
gli stessi.
«Dio è con noi», proclamava l’arroganza blasfema del nazismo. «Se Dio esiste, perché tutto
questo?», sembra chiedersi Vespignani, affidando alle immagini l’ultimo pensiero del martire
delle Fosse Ardeatine, del Partigiano impiccato, dell’ebreo bruciato a Treblinka, del vicino di
casa rimasto sotto le macerie del bombardamento di San Lorenzo.
E la domanda, vecchia come l’uomo, che già leggiamo nel libro di Giobbe, «Se c’è Dio, da
dove il male?», sembra trovare la stessa risposta suggerita da Hannah Arendt: il male vive
banalmente in mezzo a noi, ci cammina accanto, e perciò si deve temerlo senza farsi accecare
dalla paura, bisogna imparare a conoscerlo per tenerlo a bada, isolarlo per non farlo crescere
e prevalere.
E per Vespignani la pittura è a tutti gli effetti uno strumento di conoscenza.
Pur utilizzando un linguaggio formale di forte impatto espressivo, nel tratto concitato e nella
linea contorta, come nella composizione drammatica e mossa, la sua pittura scansa la caduta
espressionista e prende così le distanze da ogni elaborazione sentimentale della realtà. Qui è la
realtà ad essere crudele e violenta non le immagini che la raccontano. I colori si spengono e si
sfaldano, macerati essi stessi dal dolore che gli tocca esprimere, perché la brutalità che
abbiamo di fronte non ha davvero bisogno di essere esasperata.
Per questo credo che si sia troppo insistito sull’ascendenza espressionista della pittura di
Vespignani. E a torto si sono anche individuate ispirazioni e analogie con i tedeschi, Georg
Grosz e Otto Dix in particolare, perché i temi della denuncia e della condanna morale del
potere sono solo un momento delle intenzioni poetiche di Vespignani, ma soprattutto perché
né lo stile corrosivo del primo, né la visione allucinata del secondo hanno mai fatto parte del
suo bagaglio formale.
Per quanto terribile possa apparire l’immagine, la pittura che la sostiene è misurata, composta
e laconica, perché di fronte al dolore anche un’altra sola parola può essere di troppo, e allora
Vespignani sente che non c’è bisogno di incedere nell’orrido o di scivolare nel grottesco, per
23
tracciare i contorni di una condizione umana che deve riflettere, nella sua essenza fisica e mentale, gli aspetti morali e sociali di un mondo che è stato ingiusto e dissoluto prima di diventare
violento e distruttivo.
Insomma la pittura deve testimoniare, e anche commuovere, ma non per questo deve ammantarsi di commozione. Soprattutto se come in questo caso, si tratta di testimoniare non un
dolore fisico e contingente, ma il ricordo di una pena infinita. Vespignani si dispone così ad un
atteggiamento analitico, che non vuol dire distaccato, per recuperare una realtà che non ha
davvero alcun bisogno di essere enfatizzata dall’urlo espressionista, perché ha già in sé una
carica emozionale sconvolgente, che la rende efficacemente espressiva, senza che ci sia bisogno di esasperarne la rappresentazione artistica.
Ogni dipinto di questo ciclo ha così i toni amari di una cronaca raccontata da un punto di vista
sofferto, e che tuttavia si sforza di rimanere neutrale, senza enfasi e senza cinismo, depurata da
ogni approccio idealista, che per questo si affida a una figurazione asciutta e ad una narrazione
concisa, dove ogni deformazione ha valore espressivo senza diventare caricatura, confidando
su una franchezza di linguaggio che sconvolge ed emoziona, senza cercare la volgarità ma
anche senza scansarla ad ogni costo.
Ecco così la creazione di immagini solide, rette da una saldezza organica delle figure che si stagliano nell’indeterminatezza dei contesti. Ecco la macerazione del colore, a dire la cancrena
fisica della carne ma anche la putrefazione morale dei simboli del potere. Vespignani sa di
dover mostrare le ferite della guerra senza dover riaprirle e allora gli tocca tenere aperte le
ferite della pittura, perché l’immagine possa rivendicare tutta la sua autonomia, senza rompere il fragile equilibrio che c’è tra lo sdegno morale e le motivazioni civili del furore.
La pittura deve restituire identità agli oggetti, alle manette dei torturati e alle scarpe dei trucidati, ma anche ai guanti dei carnefici, connotandone la funzione, ma logorandoli fin quasi allo
sfaldamento, come cose sottratte alla distruzione e all’oblio, recuperate direttamente dal
magma ancora incandescente di una eruzione appena placata.
La pittura si arriccia e si impasta, il segno articola le forme senza badare a definire i contorni,
l’immagine è drammatica, penosa e crudele, eppure tutto ciò non attenua minimamente quel
senso di felicità del dipingere, che a questi quadri conferiscono le superfici morbide e accoglienti, tela o cartone che siano, e la sobria eleganza del colore che si è depositato al posto giusto e nei toni giusti, come una naturale secrezione della fantasia.
L’impianto corporeo delle figure di Vespignani non sopporta in ogni caso di essere destrutturato; la carica espressiva dell’immagine ha bisogno di energia interiore quanto di compostezza
formale, per cui non può davvero disporsi alla forzatura, alla deformazione, alla caricatura,
ma deve cercare piuttosto nel rapporto fra la figura e lo spazio circostante, il terreno dove
allentare quel po’ di rigidità che inevitabilmente si annida nella retorica compositiva dei pieni
e dei vuoti.
Di fronte alla crudezza delle immagini che gli interessa evocare, Vespignani sente che qualunque foga espressionista rischierebbe davvero la caduta retorica, del già fatto e del già visto, e
allora chiede alla pittura di essere misura a se stessa. Ed ecco allora che la pittura richiama l’attenzione sul particolare ma è reticente sui contesti. Nonostante la macerazione delle carni e
l’abbrutimento dei volti la pittura non macera i colori e non abbrutisce le forme. Tutto si riduce
all’essenziale, come se dopo aver composto il quadro Vespignani lo scuotesse, come si fa con
un albero, da cui si vuole far cadere tutto quello che è posticcio, morto o moribondo, e lasciare
al suo posto solo la parte buona, essenziale, necessaria.
Si vorrebbe, e si dovrebbe, dire quale carica di sensazioni e di emozioni erompe dalla semplicità a cui Vespignani costringe la sua pittura: dalla vacua decadenza del salotto di D’Annunzio
al volto alieno di Papini, dall’innocenza dei bambini costretti a giocare con le maschere a gas
alla putrefazione, morale oltreché fisica, del volto di Rockefeller, di contro alla profonda tristezza del volto di chi Si arrende, a Malaga, a Varsavia, a Stalingrado o non importa dove, ma
limitiamoci a guardare fra i tanti «attributi del potere», quasi tutti feroci e militaristi, l’incongruenza di un Impermeabile, dipinto davvero con niente, con poca ombra – ma quante vibrazioni di grigio in quell’ombra! – e bruciato da tanta luce, ridotto ad essere il guscio vuoto di un
corpo mutilato, inespressivo e finalmente inoffensivo.
24
Renzo Vespignani realizza il ciclo Tra due guerre negli stessi anni in cui Elsa Morante scrive La
Storia, e in entrambi c’è la stessa intenzione: di dipingere e scrivere per tutti, perché è di tutti
che qui si parla. La storia è stata essenzialmente un eccidio di innocenti, e ha colpito soprattutto coloro che subiscono impotenti le conseguenze di decisioni che ignorano, così come la
guerra colpisce soprattutto gli inermi, che una guerra non sanno affrontarla dal momento che
non riescono neanche a concepirla.
Ma se per Elsa Morante la storia è «uno scandalo che dura da diecimila anni», Vespignani non
può non registrare il soprassalto di crudeltà ammannitoci dalla storia nel secolo scorso. Un
secolo cominciato in ritardo, e male, finito, e molto peggio, in anticipo.
Un secolo che si apre e si chiude a Serajevo. Ma cos’è che separa il gesto individuale, ancorché
violento e regicida, di un giovane nazionalista serbo, dal martirio inflitto alla città bosniaca
ottant’anni dopo dalla ferocia razzista dei militaristi serbi? Non la violenza, che c’è sempre
stata, non l’odio per il nemico, che alimenta tutte le guerre, quanto il tentativo di annientare il
diverso nell’unica cosa che altrimenti ce lo rende simile, e quindi fratello, la sua umanità.
Il segno terribile che ha squarciato la nostra civiltà in quell’età della catastrofe, che è stato il
periodo fra le due guerre mondiali, è proprio questo tentativo di disumanizzare l’individuo,
negandone l’identità, cancellandone l’immagine, distruggendone il corpo.
Ed è sul corpo dell’uomo che Vespignani misura la ferocia del potere, la mistica della violenza,
gli orrori della guerra.
Un corpo dilaniato dalle bombe, asfissiato dai gas, bruciato nei forni, putrefatto nelle fosse
comuni, al punto da far credere a molti che non solo non potesse essere più misura della bellezza, ma che non fosse più nemmeno raffigurabile.
Ma Vespignani è fra quanti non credono che la pittura possa essere autosufficiente, che possa
cioè riassumere in se stessa, nei suoi valori formali e cromatici, ogni possibilità espressiva e
tutta la carica emozionale dell’immagine.
Perché è convinto che questi corpi, così come la pittura che ce li rende presenti, debbano passare attraverso lo strazio macerante della decomposizione e dello sfaldamento, per alimentare
quel sentimento di pietà che rende sopportabile la memoria. Perché occorre mettere al sicuro
almeno i morti dalla ferocia della storia, prima di poter aspirare ad una ricomposizione formale, che se non potrà essere la resurrezione della carne possa almeno aspirare al salvamento
morale dell’immagine.
25
Marmo e sangue
Due parole su Vespignani, e sul dipingere la guerra
di Eugenio Riccòmini
Piaghe, ferite purulente o rinsecchite, stracci macchiati di sangue e velati di terriccio, di resti
umani esumati, capestri stretti dal peso d’un corpo, fiori che appassiscono accanto alle foto
in bianco e nero sul luogo d’un eccidio, cappotti militari in pelle dagli ampi risvolti, frustini
da cavallerizzo, guanti anch’essi in pelle, mutande di pizzo che s’ammainano su glutei femminili tenuti stretti con finto pudore, e vessilli in bacheca, e decorazioni; e ancora piaghe, e
ferite in fretta ricucite come dopo un’autopsia, e cinturoni borchiati, e mostrine, e stivali; e il
vate della lussuria e della guerra fra i suoi alani, e la casacca dell’arciduca in bacheca, prima
di tutto quel primo macello, e corpi ignudi di reclute in posa ginnica, e gli stessi corpi riversi
e ulcerati sulla trincea, e quelli dei loro simili, poi, anch’essi a terra dopo la raffica, contro
l’intonaco sbrecciato dal piombo; e la Patria impassibile e marmorea, con l’elmo crestato e il
peplo candido, nuovamente fidiaco, e deltoidi e tricipiti di atleti anch’essi di marmo lustro e
non ancora scalfito dal tempo, fra lo strepito acclamante di volti eccitati, oscenamente scomposti; e così via. Per tre anni, fino alla primavera del 1975, Renzo Vespignani ha convissuto
con centinaia di immagini fotografiche, antiche e recenti, che illustravano o documentavano
aspetti, ora tronfii ora penosi, e sempre sciagurati e senza consolazione, delle due grandi
guerre d’Europa. Aveva davanti agli occhi i volti superbi di chi, quelle guerre, le aveva invocate e attese, fremendo; e di chi tremando e bestemmiando le aveva subite. Aveva davanti
agli occhi i marmi superbi dei monumenti, e le case sventrate dalle esplosioni, e come denudate. Si accostavano, in quelle immagini, la polita superficie statuaria degli eroi, dei ginnasti, e i grumi informi delle giubbe dei fucilati. Da quella lunga ed emozionata meditazione
visiva, e dal continuo rileggere testi di quegli anni, ufficiali e pomposi o anche alatamente
ispirati, oppure sgrammaticati e senza speranza, sono nati questi dipinti, a decine. Riuniti in
una mostra itinerante, furono esposti in varie città del nostro continente, al di qua e al di là
del muro che allora lo divideva. Con grande successo di pubblico, dicono le cronache; ma
anche senza visibile effetto sulle tendenze dell’arte di quegli anni, volta a tutt’altro e clamoroso genere di spettacolo; proprio allora si stava costruendo e assemblando, tanto per ricordare, la grande macchina del Centro Pompidou, nel cuore della vecchia Parigi; e a Vienna, e
altrove, Nitsch scandalizzava gli astanti con le sue macellerie. E la figurazione stava già preparandosi a far ritorno in scena in pompa magna e con non poco clamore; ma privilegiando
calcolate ingenuità, tra i modi primitivi e quelli infantili, tenendosi ben discosta da ogni esibizione di professionale destrezza; quasi a voler dire che, per far pittura, non c’è alcun bisogno d’esser pittori.
Come viatico a tutto quel suo lavoro pittorico, Vespignani stilò di suo pugno due o tre pagine,
senza alcuna nota filologica, senza neppure un accenno a dichiarazioni di principio, o di parte.
Ed è bene pubblicarle di nuovo, ora che ci si trova ancora di fronte a quel suo lavoro assieme
così personale e datato, eppure senza tempo preciso; come senza tempo, perché efficaci in
qualsiasi momento, sono sia l’amarezza per le condizioni tragiche della vita umana, sia lo stupore ammirato per l’efficacia del dipingere. In quelle poche righe, così strettamente legate ai
temi e ai modi di questi dipinti, Vespignani tracciava la storia d’una emozione profonda e
profondamente vissuta; e confessava la difficoltà di farne narrazione con i mezzi della pittura,
che in ogni caso (sì: anche in Grünewald, anche nei fucilati di Goya) aprono gli occhi alla bellezza. «Sapevo fin dall’inizio», scriveva, «che non avrei potuto tirare, tra me e i grandi cimiteri
della patria, il confine invalicabile d’una linea purissima».
27
Nelle righe di chiusura di quel testo, il pittore rammentava anche le tante pagine narrative, storiche, apologetiche, celebrative, critiche di cui s’era nutrito, e che avevano accompagnato quei
suoi tre anni di lavoro. Rendeva loro il dovuto omaggio, e ne riconosceva l’insostituibilità,
come fonti d’informazione, come documenti, come luoghi di maturazione del pensiero. Ma
aggiungeva che la parola scritta avvolge gli eventi fisici, inevitabilmente, in un’aura più tersa;
che le parole, si potrebbe aggiungere, seguono un loro paratattico disporsi, analogo alla consequenzialità del ragionare, del dedurre, dell’argomentare. E che per contro la «necessità del
dipingere» (così, appunto, diceva) persegue altri fini: alla ragione del dire oppone, o affianca,
quella non meno forte del vedere, del far vedere di colpo, e senza pausa, e tutto d’un tratto la
evidenza ottica, e fisica, di ciò che è, di ciò che accade.
Di certo, sotto l’urgere delle emozioni di quei tre anni di convivenza con l’orrore e la stupidità,
Vespignani non aveva alcuna voglia di far teoria, né tanto meno d’impancarsi a far da professore d’estetica. Gli era chiaro, certo, che quella sua «necessità del dipingere» iniziava a farsi
manifesta, almeno, dagli uri di Lascaux, dai bisonti di Altamira, fino alle incoronazioni napoleoniche di David, agli spaccapietre di Courbet, alle sue donne nude assopite, e fino anche al
tremolio del sole tra le ninfee dello stagno di Giverny. Ma sapeva che quella lunghissima
vicenda s’era d’un tratto interrotta con l’affermarsi della civiltà industriale, della fotografia,
del cinema; e con l’affermarsi delle avanguardie. Pensava, con ogni probabilità, che tutte
quelle riproduzioni di Guernica allora appese al muro d’ogni adolescente in vena di ribellione,
o anche solo insofferente del presente stato delle cose, indicassero non più che un’opinione,
magari anche ferma e di certo ben motivata; anche se la celeberrima tela di Picasso intratteneva, a ben vedere, un rapporto solo simbolico e perdipiù elegantemente stilizzato con lo spessore fisico della distruzione, della sofferenza, della morte.
Di certo Vespignani non aveva la minima intenzione di stare fuori dal suo tempo, in qualche
zona marginale. Voleva proprio starci in mezzo. E infatti, nel suo studio, s’era circondato di
prodotti dell’industria visiva: centinaia di fotografie, di manifesti cinematografici, di cataloghi
di musei, di mostre. Maneggiava ogni giorno i ritratti in posa del vate, del duce, dei volti anonimi degli arditi e degli squadristi in camicia nera, dei balilla in foto di gruppo, della borghesia in parata o in vacanza, dei signori ariani bellissimi e sinistri nell’uniforme maschia e sontuosa, belli e virili come le statue degli stadi, dei nuovi fori italici mediterranei; e a quelle foto
si mischiavano, senza distinzione, quelle della città ferita dalle incursioni, dei corpi ridotti a
fagotti di cenci, appena estratti dai calcinacci, dei polsi rattrappiti entro la stretta dei legacci,
delle carni segnate dalla stella di Davide.
Ma quella era, appunto, la messe ancora da cogliere; era solo l’oggetto della sua impresa pittorica. Erano figure, certo, ma non ancora pittura. O così gli pareva; secondo, ovviamente, l’idea
che della pittura s’era fatto, facendola ogni giorno. E non è affatto facile, nel giro di poche
parole, o frasi, far cenno di ciò che intendeva Vespignani, quando parlava del suo mestiere; in
tempi (i suoi, i nostri: è lo stesso) in cui l’arte del dipingere sfugge a qualsiasi possibile definizione, su cui tutti ci si possa intendere. È ben difficile, intanto, collocare la sua attività entro
qualche cassetto chiaramente etichettato: perché, se è fin troppo trasparente la sua matrice
ideale e perfino politica, essa non corrisponde peraltro ad alcuna tendenza stilistica, o semplicemente del gusto. Tanto per dire: la sua raffinatissima sapienza pittorica sta parecchio a disagio entro le maglie di quel nuovo tentativo di realismo, in debito verso Picasso e verso la
Brücke, che Togliatti approvava, sia pure un poco obtorto collo, e che durò fin che durò, per
qualche anno. E i rapporti con la pittura dei progressisti americani, come Ben Shan ed altri, un
poco s’avvertono, e un poco no: perché, nelle sue cose giovanili, e soprattutto negli splendidi
disegni delle periferie romane, si tratta d’affinità di tema, e assai meno di stile, di lingua.
Vespignani, insomma, cammina per proprio conto; e ciò si vede benissimo in tutte queste tele.
Ed è, in tempi di totale e indistinguibile cosmopolitismo, pittore del tutto italiano. Una siffatta
definizione non gli sarebbe piaciuta, forse. Ma non c’è, in essa, alcun accenno ai sacri confini.
Della tradizione pittorica italiana, dei grandi maestri come di quelli quasi dimenticati,
Vespignani (e qualche altro, con lui: ma tutti senza conclamata fama) trascinava senza apparente sforzo, nell’oggi, una invidiabile destrezza di mano, una facilità, una sprezzatura da stupire. Sono le qualità nostre: un poco eccessivamente esibite, forse, come l’abilità dei giocolieri,
28
degli acrobati; ma, un tempo, tutti i pittori stranieri ne restavano stupefatti, e si mettevano in
viaggio, e valicavano le Alpi per apprendere quella magia, quel segreto. Quella magia, ecco,
Vespignani l’ha appresa sostando lungamente in qualche aula d’accademia, e imparando poco
a poco il mestiere; che mai si finisce d’imparare.
E così, di fronte al martirio e alla ferocia e alla brutalità del nostro tempo, Vespignani si mette
all’opera come un maestro antico chiamato a dipingere martirii antichi, antiche ferocie. Mette
in campo ogni suo sapere, ogni sottigliezza del disegno, ogni brivido delle tinte. E studia, come
sempre s’è fatto, parte a parte ogni dettaglio della sua composizione. E infatti molte di queste
tele sono studi d’un panneggio, d’un torso, d’una testa su un fondo lasciato incompiuto. E poi,
come sempre s’è fatto, congegnava attentamente il montaggio d’ogni parte, eliminando e
aggiungendo, rifinendo e completando o lasciando zone appena sfiorate dal pennello. Così
facendo, certo, gli restavano nell’occhio il taglio moderno delle fotografie da cui era partito, la
loro mimetica verità, o l’accentuazione plastica che la pellicola registra, impressionata dalla
luce. Non si trova quindi, in questi dipinti, la solenne calma della luce degli stanzoni d’accademia; ma piuttosto l’aggressività e la flagranza dell’immagine da rotocalco, dello scatto improvviso dell’obbiettivo che fruga un frammento di realtà. È su questa realtà che Vespignani, da pittore di anche nefande squisitezze, medita e riflette. Da essa, e da ciò che dell’esistenza umana
rivela, trae succhi pittorici di avvelenata raffinatezza. E fa aggallare su queste tele, assieme
all’infamità e all’orrore, assieme all’aspro sapore dell’annullamento e della sconfitta, la fragile
vittoria del dipingere.
Bologna, 20 gennaio 2004
29
Pessimismo esistenziale e coscienza critica
nella pittura di Renzo Vespignani
di Lorenza Trucchi
«L’Io si sceglie». Questa norma di Louis Lavelle1 è particolarmente pertinente per Renzo
Vespignani, artista esistenzialista per eccellenza.
A venti anni Vespignani voleva diventare scrittore (il manoscritto di un suo libro di racconti
scomparve tra le macerie della sua casa durante il bombardamento di San Lorenzo) e questo
perché sebbene già dipingesse con innata perizia, «la realtà» gli sembrava impenetrabile, e
l’arte bugiarda, come si muovesse in una stanza immersa nel buio, e sconosciuta».2 Ma il suo
modo di guardare e, quindi, di capire e dipingere senza menzogne, cambia d’improvviso.
Ancora nel Diario Vespignani ne precisa le circostanze e perfino la data esatta: «Il 19 luglio,
quando, cancellato da una nuvola lattiginosa di calcina, il cortile mi apparve deformato da una
luce arcana. Uscivo dalla cantina in un vuoto fulgente, e incespicavo, il viso levato al cielo…
Lentamente mettevo a fuoco la strada, il cortile, e più lontano, dov’era stata la Basilica di S.
Lorenzo, in una specie di fiamma bianca e allungata, il sole. Da quel giorno la realtà, sempre
più spesso, cominciò a ferirmi come un’annunciazione».
Vespignani non parla dunque laicamente di scoperta né metafisicamente di rivelazione, bensì
di annunciazione. Una buona novella ma anche una chiamata che mentre lo elegge e lo fa idoneo al compito del dipingere gli indica un cammino perigliosissimo quanto irrinunciabile. È
in questo impatto fulmineo e lacerante tra la morte che lo circonda e la vita che forsennatamente pulsa nel suo giovane corpo, tra l’oscurità della inconsapevolezza e la luce della consapevolezza abbagliante fino alla ferita, che egli sceglie per sempre il proprio destino di uomo
e di artista.
A ripercorrere l’iter di Vespignani, sia pure a tappe successive come suggerisce l’andatura
ciclica del suo lavoro, ci si avvede quanto egli possieda la cognizione del dolore. Un seme
amaro nato con la sua stessa vocazione all’arte, che non ha cercato di estirpare ma all’opposto ha nutrito e coltivato con lucida determinazione. Lavoratore indefesso ha impegnato il
suo raro talento, la sua prodigiosa perizia tecnica, la sua acuminata intelligenza a documentare, evocare, persino esaltare privilegiandola su ogni altra, la dimensione tragica dell’esistenza fino a farci percepire il vuoto e il nulla che ci circonda. L’indissolubile unità dell’esistenza e dell’esistente che si avverte nella sua opera fa di lui uno dei rari e più autentici artisti
dell’esistenzialismo laico che, come è noto, si è espresso più attraverso l’arte, la letteratura, il
teatro, che non attraverso compendi dottrinali, giacché come afferma Simone De Beauvoir,
«se la descrizione dell’essenza dipende dalla filosofia propriamente detta, solo il romanzo (e le
opere d’arte) consentono di evocare nella sua realtà completa, singolare, temporale, il sorgere
originale dell’esistenza».3
Questa coscienza della congenita ed invincibile solitudine dell’uomo fa anche dell’impegno
politico di Vespignani un fatto prima di tutto umano, privato, vissuto dal di dentro: la sua pittura di storia è autobiografia, è «testimonianza di come ci sentiamo». Assieme a questa componente di confessione, di diario spietato, l’altra componente primaria dell’arte di Vespignani
è la presenza invadente, ossessiva del corpo, che egli sente ed analizza con impietosa pietà.
Non sembri un gioco di parole che tale è il suo cannibalismo linguistico, quel modo di possedere con il colore e più con il segno, l’immagine dell’uomo tanto spesso offesa, snaturata,
martoriata.
Vespignani non crede al riscatto trascendente del dolore, tutto per lui si compie ed esaurisce
nella materia, nella vita biologica, semmai come ha detto a proposito delle illustrazioni per le
31
Metamorfosi di Kafka, crede nella capacità di adattamento, di riorganizzazione in forme
«diverse», ad un ipotetico, traslato ricongiungimento al mondo animale e vegetale. Ma è
chiaro che il destino di Gregorio Samsa resta una mera speranza (o menzogna?) poetica. Ben
più spesso esibisce lo spettacolo della morte con crudezza e questo cedere e corrompersi del
corpo è tanto più terrificante per quanto la morte è provocata dalla cieca violenza, dalla folle
crudeltà. Esempi di questa morte innaturale si hanno soprattutto in tre cicli. Quello giovanile
detto del Portonaccio, dedicato in prevalenza alle vittime e ai disastri del bombardamento di
San Lorenzo, quello intitolato Tra due guerre, oggetto di questa mostra e quello ispirato all’omicidio di Pasolini, forse il più spietato, che segna di fatto la spaccatura di Vespignani con la sua
città pur tanto amata: «Nel ’79 Roma sembrò tornare quella del dopoguerra… Tutto somigliava al tempo della mia giovinezza, ma tutto era diverso: le passioni non bruciavano per
migliorare il mondo, ma per cauterizzare una immensa delusione».4 Una delusione connessa
con l’impegno politico come confessa con dolente ironia: «Che ridere, che tenerezza, ricordare
certe discussioni sui massimi sistemi: la responsabilità dell’artista, la moralità del suo linguaggio specifico, la natura della sua intellettualità. E, mamma mia, ve lo ricordate? il vecchio imperativo dell’impegno sociale».5 Di fatto di questa delusione Vespignani aveva precocemente
dato conto con l’Imbarco per Citera (1967-’69), ispirato al famoso capolavoro di Watteau, un
affresco sontuoso e macabro tra dolcevita e contestazione o come è stato definito «il gran ballo
finale di una generazione impegnata». Per questo suo embarquement l’artista adotta colori inusitati – rossi di fiamma e rosa aurorali, blu zaffiro, note di verdi crudi e gialli squillanti, frammisti a ogni sorta di neri e lividi bianchi – ed una sintassi alleggerita quasi impressionista, che
tramuta la tragica denuncia in una aggraziata commedia, innocente nella sua ferocia.
Personalmente considero l’Imbarco per Citera dal ritmo così leggero e lieve che mirabilmente
Testori ha definito «un passo di danza, un volo di funebri farfalle», unico e magistrale, tale da
trovare una collocazione di primissimo piano nella pittura figurativa della seconda metà del
Novecento, accanto, pur nella totale divergenza delle motivazioni ideologiche e nella diversità
sintattica, al gruppo di opere, altrettanto agili, fragranti e comunicative, che David Hockney
dedicò al tema delle piscine e dei giardini, accorpabile sotto il titolo A Bigger Splash, dal film
che Jack Hazan consacrò al pittore inglese.
Dopo un intervallo riservato alla sfera del privato, ritratti della madre, dei figli, della moglie e
dipinti, disegni, studi consacrati alla propria immagine spinti sino allo scandaglio minuzioso
e ossessivo di ogni parte e frammento del viso e del corpo (Rapporto sull’autore, 1968-’71),
Vespignani torna ad occuparsi dei mali della guerra e della violenza. Lo fa ora non in maniera
diretta, da involontario testimone, come in giovinezza né da allarmato spettatore come accadrà nel ciclo pasoliniano allorché si cala in una realtà disumanizzata e feroce alla quale corrisponde l’elementarietà dei sentimenti e la brutale riduttività delle azioni e dei gesti, bensì per
la prima volta da storico, sia pure salutarmente di parte. Si tratta dunque di «Una storia tra le
due guerre, ma non – come egli stesso dichiara – di tutta quella storia: mancando nella scena il
popolo, la sua avanguardia, le sue rivoluzioni». Protagonista è «soltanto plebe trasferita da un
teatro di guerra a un altro, e da un’illusione a un’altra. […] È martirio e morte: la morte, dopotutto, restando l’evento completo e inequivoco, il solo che il potere dei monarchi, dei poliziotti,
dei poeti guerrieri, non è riuscito a defraudare della sua qualità interamente umana».6 Ed
ancora a giustificare con la consueta lealtà il pessimismo letterario del racconto Vespignani
precisa: «ho dovuto rileggere troppo D’Annunzio per arrischiarmi a cantare il volo di una
Nike, anche se di una Nike operaia».7 Non sta a me indagare sulla esattezza storica della tesi
che l’artista propone ed illustra nel ciclo Tra due guerre. Tesi peraltro non nuova e sotto molti
aspetti corretta, secondo la quale alla base della ideologia fascista vi sia una «cultura superiore
e solenne, organicamente elaborata da letterati, filosofi, poeti, artisti, smaniosi dì temprare la
coscienza nazionale».8 In altre parole «bergsonismo, neoromanticismo, misticismo, decadentismo» creando «il culto dell’eroe e della santa violenza patriottica» sarebbero movimenti culturali «cripticamente fascisti». Ecco così alternarsi e mischiarsi: eleganze floreali e rovine espressioniste, vestiti di seta e uniformi, ventagli di piuma e carni martoriate. Un materiale contraddittorio e mutevole, difficile da gestire, persino ostile, che Vespignani affronta con l’audacia e
il coraggio del torero nell’arena. Del resto alla fine quello che su tutto emerge e tutto travolge
32
e pianifica è ancora una volta la morte, non solo quella più diretta delle vittime della guerra,
dei bombardamenti, degli atroci campi di sterminio dove sono ammassati dei poveri cristi
«senza divinità», ma la morte che subdolamente si annida nelle immagini algide, persino apollinee, dedicate agli apparati del potere, ai suoi miti e ai suoi riti. L’incubo del vero, esibito e
morbosamente dettagliato, talvolta si fa quasi insostenibile, ma Vespignani non ci dà tregua,
soprattutto non si dà tregua. Autentica è la sofferenza dell’autore che traspare da tutto il ciclo
talché si resta sedotti da quel suo saper vivere così a lungo e ossessivamente a tu per tu con i
propri personaggi, con i propri spettri, ben sapendo fin dagli inizi che il prezzo da pagare è
alto: quello, come ha confessato, «di non poter tirare tra se stesso e i grandi cimiteri della
patria, il confine invalicabile di una linea purissima».9
Da un punto di vista linguistico il ciclo non ha connotazioni o riferimenti precisi. Del resto
abbandonati i grandi modelli, così amorevolmente studiati in giovinezza, Rembrandt, Goya e
il più familiare Fattori (soprattutto per quel che attiene il breve momento delle marine e delle
spiagge caratterizzate da un pigro aprirsi di bianchi parasoli ), Vespignani si è creato una lingua tutta sua seppure volutamente contaminata, dove alterna l’ossessione analitica e dettaglistica a momenti più impetuosi e liberatori. Così anche in Tra due guerre, di volta in volta, a
seconda che il tema lo richieda, eccolo indulgere sia all’ornato floreale e al ricalco dei fregi marmorei dell’Altare della Patria sia ad un nitore apollineo che si deforma nelle prospettive impossibili e nei primi piani di efebici eroi (L’Italia di marmo) sia infine cimentarsi in alchimie e ricette
materiche e gestuali che si riconnettono alle già provate ricette dell’Informale. Comunque
anche in questo ciclo resta di fondamentale importanza la componente grafica. Che Vespignani
sia più un disegnatore che un colorista è cosa risaputa. Io stessa agli inizi degli anni Cinquanta
scrissi che il suo segno corrispondeva a quello di Wols. Era cioè il sensibile sismografo della
sua stessa esistenza. Ma mentre il pittore tedesco, proseguendo la lezione di Klee, badava
soprattutto al perpetuo sommovimento della vita organica e più che «creare si lasciava avvenire», Vespignani restava un implacabile diarista. Disegnare significava allora soprattutto
comprendere «non solo i profili, le linee, i colori ma il senso vero degli uomini e del loro paesaggio». Un compito che è restato costante e appassionato fino all’ultimo, tanto da fare della
sua ampia e mirabile opera grafica un eccezionale documento esistenziale del nostro passato.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Louis Lavelle, La conscience de soi, Grasset, Paris 1933.
Renzo Vespignani, Diario 1943-1944, Carte Segrete, Roma 1991.
Simone De Beauvoir, Littérature et métaphysique, in Les Temps Modernes, 1, 7, avril 1946.
Renzo Vespignani, Come mosche nel miele, Catalogo della Mostra omonima, Villa Medici, Roma 1951.
Ivi.
Renzo Vespignani, Tra due guerre, in questo stesso volume.
Ivi.
Ivi.
Ivi.
33
La sacra infamia:
promemoria sul deprecato tabù della guerra
di Gaspare De Caro e Roberto De Caro
Ed ecco, uscì un altro cavallo, rosso, e a colui che stava sopra fu dato il
potere di togliere la pace dalla terra e di far sì che gli uomini si
sgozzassero fra di loro e gli fu consegnata una grande spada.
(Apocalisse, 6,4)
Quando il Secondo Cavaliere, tornato a confutare la grande illusione, ebbe completato l’opera,
lasciò dietro di sé oltre 50 milioni di morti, 35 milioni di feriti, 3 milioni di dispersi.
Scomparvero 20,6 milioni di sovietici, 11,8 di cinesi, 6,8 di tedeschi, 5,8 di polacchi, 3 di giapponesi, 1,5 di jugoslavi, 600.000 francesi, 455.000 italiani, 400.000 inglesi, 300.000 statunitensi
e centinaia di migliaia di persone di altre nazionalità.1 Il Secondo Cavaliere non aveva portato solo morte, aveva anche generato il frutto maturo della Modernità: la dimostrazione
ostensiva del genocidio burocratico, il deserto morale della «mentalità del solving problem»2
nell’irresistita fascinazione medusea del Potere sul Sapere – sulla scienza e sulla tecnologia.
Ma Auschwitz3 e Hiroshima, apici di strutture mostruose,4 entrambi efferati prodotti finali di
programmi di sterminio ramificati e diversificati, non esaurirono affatto possibilità ed esiti
di quelle strutture e di quei programmi. Da una parte, anche se è difficile prenderne
coscienza, l’orrenda reiterazione di Nagasaki va oltre Hiroshima e la dottrina della guerra
preventiva nella specie di un delirante monito ai sovietici: essa ostenta protervamente, senza
necessità di ulteriore appello, l’inesistenza di limiti all’esercizio di un potere assoluto e criminale. Dall’altra, pressati dall’avanzata dell’Armata Rossa sul fronte orientale, i tedeschi
evacuano i Lager e costringono i superstiti, stremati dalla inumana detenzione, a trasferirsi
ad ovest, verso la Germania. Almeno un terzo dei 750.000 prigionieri sottoposti a questa
ulteriore tortura furono uccisi o morirono di stenti durante le «marce della morte», quando i
tedeschi avevano già perso ogni speranza di vittoria. L’ossessione della Endlösung, la «soluzione finale», non si attenuò neanche di fronte alle difficoltà logistiche della ritirata, all’oggettiva convenienza strategica, così come aveva quasi sempre finito per far premio sulle esigenze di sfruttamento schiavistico nell’agricoltura e nell’industria bellica e civile del Reich.
E se non si poteva più usufruire dell’efficienza del modello fordista applicato al progetto
genocida,5 si poteva però ripiegare sulle forme più arcaiche, comunque efficaci, delle esecuzioni sommarie e delle privazioni, che avevano già dato buona prova di sé prima che la
Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung mbH (Società tedesca di lotta contro i
parassiti) coronasse le migliori aspettative dei gerarchi nazisti fornendo alla fabbrica dello
sterminio immense dosi di Zyklon B.
Le cifre della politica di annientamento nazista sono spaventose: 2.250 Testimoni di Geova,
9.000 omossessuali, 270.000 malati di mente, 500.000 zingari, 1 milione e 50.000 tra detenuti
politici, ‘asociali’ e internati militari nei campi di concentramento, 3,3 milioni di prigionieri di
guerra sovietici, tra i 5 e i 6 milioni di ebrei,6 di cui almeno i due quinti fucilati o lasciati morire
nei ghetti. Circa 11 milioni di esseri umani furono cancellati dalla faccia della terra secondo un
progetto che si andò perfezionando durante il corso della guerra, ma le cui linee erano state
inesorabilmente tracciate e rese pubbliche ben prima dell’invasione della Polonia, quando
Hitler veniva armato e assecondato quasi unanimemente dai governi stranieri, nonché internazionalmente omaggiato, come in occasione delle olimpiadi berlinesi del 1936, quasi un anno
35
dopo l’approvazione delle leggi di Norimberga sulla purezza della razza che privarono gli
ebrei dei diritti civili e di cittadinanza. Il Führer non era isolato: tutti sapevano e consentivano.
Del resto, pur dotato di sufficiente creatività personale, condivideva con zelo imitativo modelli
ecumenicamente apprezzati: se certamente subì la fascinazione di Mussolini e Stalin (il primo
per l’audacia putschista e l’uso dichiarato dell’omicidio politico, il secondo per le grandiose
visioni genocide7), l’idea di rinchiudere «gli agitatori di stirpe giudaica in campi di concentramento»,8 che cominciò a coltivare fin dal 1921, gli veniva dai durissimi concentration camps in
cui all’inizio del Novecento i britannici rinchiusero e perseguitarono nell’Orange e nel
Transvaal le famiglie dei coloni boeri. Egli stesso lo ricordò anni dopo in un discorso pubblico:
«I campi di concentramento non sono stati inventati in Germania, ma dagli Inglesi per spezzare con questi mezzi la spina dorsale di altri popoli».9 Il Drang nach Osten, la devastante conquista di Lebensraum ad est, di spazio vitale nella terra degli Untermenschen, i sottouomini da
eliminare o schiavizzare, si configurava per i nazisti, anche sotto il profilo giuridico, come un
ennesimo episodio di colonizzazione dell’imperialismo europeo; ma personalmente Hitler
prediligeva piuttosto la «conquista del West» come archetipo di espansione e genocidio dei
nativi: «la lotta che muoviamo ai partigiani – spiegava nel 1942 – è paragonabile a quella che
veniva mossa agli Indiani dell’America del Nord».10 Hitler d’altronde conosceva la storia,
almeno quella che poteva servirgli, e sapeva quanto facilmente si perdoni qualunque cosa ai
vincitori: «Chi parla ancora, oggi, del massacro degli armeni?» sentenziò il 22 agosto del 1939
in un discorso rivolto ai comandanti in capo delle forze armate del Reich per incitarli al rapido
sterminio dei polacchi. Quel massacro era stato rapidamente archiviato e il nuovo ordine
accettato perché, aggiunse, «il Mondo crede soltanto ai successi».11
C’era poi chi si organizzava in proprio, senza camere a gas: «A primeggiare per efferatezze
sono soprattutto le bande ustascia dello Stato “indipendente” croato, il satellite più feroce del
Terzo Reich. 487.000 serbi ortodossi, 27.000 zingari, all’incirca 30.000 ebrei, nonché migliaia di
comunisti» furono vittime del regime di Ante Pavelic,
´ «fondato sull’amalgama di devozione
cattolica e di fanatismo nazionalista […]. Gravi le collusioni della Chiesa […]. Come ormai è
accertato, i francescani si macchiano in quelle terre di innumerevoli delitti, uccidendo, incendiando case, saccheggiando villaggi; il clero croato invita a sgozzare non solo i serbi, ma anche
gli ebrei».12 E Pio XII, more solito, taceva.13
L’immensa tragedia non si concluse con la cessazione delle ostilità. Venne la stagione della vendetta. Lo sterminio proseguì. È abbastanza noto che a partire dal gennaio 1945, terrorizzati dall’incalzare delle truppe sovietiche, i tedeschi della Polonia e della Prussia Orientale fuggirono a
piedi verso la costa baltica per cercare di imbarcarsi. Si calcola che circa un milione di persone
morirono di freddo, patimenti e sevizie. Inoltre, in osservanza dell’articolo 13 del protocollo di
Potsdam, nell’inverno di quello stesso anno venne «effettuato il trasferimento in Germania dei
tedeschi rimasti in Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria». Circa 14 milioni di persone furono spostate ad ovest in condizioni disperate e altri 2,1 milioni di tedeschi morirono. Alcune di queste
comunità abitavano da secoli le regioni evacuate.14 Molto meno noto è cosa ne fu dei prigionieri.
Alla fine degli anni Ottanta, dopo oltre quattro decenni di insabbiamenti, silenzi e bugie e a
seguito di una rigorosa ricerca, lo scrittore canadese James Bacque, coadiuvato da due coraggiosi
colonnelli dell’esercito statunitense,15 fece luce sul destino dei militari tedeschi, ma anche di molti
civili, detenuti nei campi francesi e americani nell’immediato dopoguerra:
Alla fine del 1945, sulla maggior parte del fronte occidentale il tuono dell’artiglieria era stato
sostituito dal rumore di milioni di paia di stivali trascinati dalle colonne di tedeschi in marcia
stancamente verso i campi alleati. […] Le rese in massa nell’ovest contrastavano fortemente con
le ultime settimane sul fronte orientale dove le unità superstiti della Wehrmacht combattevano
ancora contro l’Armata Rossa avanzante, per permettere al maggior numero possibile di camerati
di sfuggire alla cattura da parte dei russi. […] Dal punto di vista tedesco questa strategia consegnava milioni di soldati tedeschi nelle mani che essi credevano più pietose degli Alleati occidentali, sotto il supremo comando del generale Dwight Eisenhower. Tuttavia, dato l’odio feroce e
ossessivo del generale Eisenhower non solo per il regime nazista ma anche per tutto quanto fosse
36
tedesco, questo credo risultava nel migliore dei casi un azzardo disperato. Più di cinque milioni
di soldati tedeschi nelle zone americana e francese erano costretti nei campi, molti letteralmente
spalla a spalla. Il terreno attorno a loro presto divenne una palude di sporcizia e malattie. Esposti
alle intemperie, mancando anche delle più primitive strutture sanitarie, sottonutriti, i prigionieri
cominciarono presto a morire di fame e malattia. A partire dall’aprile 1945, gli eserciti americano
e francese annientarono con indifferenza circa un milione di uomini, per la maggior parte nei
campi americani [circa il 75%].16 Mai erano avvenute simili crudeltà sotto il controllo della autorità militare degli Stati Uniti, sin dai tempi degli orrori della prigione di Andersonville, amministrata dai confederati, durante la guerra civile americana. Per più di quarant’anni, questa tragedia senza precedenti è rimasta nascosta negli archivi alleati.17
Anche la sorte dei 7 milioni di profughi sopravvissuti agli eccidi del nazismo in molti casi fu
terribile. A cominciare da quella che toccò a 100.000 ebrei superstiti, costretti a restare in
Germania «sovente in caserme dell’esercito tedesco, come il campo di Hohne, detto di BergenBelsen, e in ex KZ [Konzentrationslager], come Dachau». Gran parte di loro per tutto il 1945 e
anche oltre (l’ultimo di questi campi di ‘transito’ chiuderà nel 1952) dovettero rimanere nel
paese dei carnefici sia perché le comunità originarie erano state completamente distrutte e non
vi era possibilità di rientro nelle nazioni di provenienza, sia perché leggi draconiane sull’immigrazione avevano chiuso le porte della Palestina, del Canada, degli Stati Uniti. Nei campi
alleati gli ebrei dovettero subire l’ignominia di essere trattati da criminali: sottoposti a coprifuoco, sottoalimentati, spesso lasciati con la divisa del Lager, in caso di proteste venivano
repressi dalla polizia tedesca, esplicitamente autorizzata, che, come è facile immaginare,
sovente si mostrava ostile. «I rapporti tra l’esercito americano e gli ebrei peggiorarono a tal
punto» che nell’agosto del 1945 dovette intervenire il presidente Truman e incaricare di un’indagine Earl G. Harrison, «preside della facoltà di Diritto dell’Università della Pennsylvania e
rappresentante presso il Comitato interministeriale dei rifugiati», il quale fu perentorio: «Allo
stato attuale delle cose, stiamo trattando gli ebrei come hanno fatto i nazisti, salvo che non li
sterminiamo. Sono ammassati in gran numero in campi di concentramento sotto la sorveglianza del nostro esercito, che ha preso il posto delle truppe SS».18
Peggio ancora, se possibile, andò ai superstiti dell’Armata Rossa, i quali nella gerarchia dei Lager
del Reich occupavano, tra i prigionieri di guerra, «il rango più basso».19 Essi avevano già dovuto
subire la furia del Rassenkrieg, la guerra razziale, che come si è detto ne portò alla morte 3,3
milioni: un elevatissimo numero, legato alle «Direttive per il comportamento delle truppe in
Russia» emanate dal Dipartimento dello Stato maggiore della Wehrmacht prima dell’operazione
«Barbarossa». Ai militari tedeschi si ordinava «un intervento energico e spietato contro agitatori
bolscevichi, partigiani, sabotatori, ebrei e la totale eliminazione di ogni resistenza attiva e passiva».20 Per gli Untermenschen sovietici non doveva esserci scampo. Nei Lager la disparità di trattamento tra le diverse nazionalità fu enorme: «il tasso di mortalità tra i prigionieri sovietici arrivò
quasi al 60%, mentre quello dei circa 100.000 prigionieri americani nello stesso sistema di internamento e spesso persino alloggiati negli stessi campi era del 4%».21 Nel famoso Stalag XVII, «un
campo di prigionia completamente ‘normale’, […] dei circa 4.000 sottufficiali americani complessivamente solo quattro persero la vita, il che corrisponde ad un tasso di mortalità di uno su 1.000,
nello stesso campo tra i sovietici ne moriva uno ogni 10».22 Ebbene, questa gente che aveva attraversato il calvario della guerra e dei campi di concentramento e di sterminio ora doveva fare i
conti con l’insaziabile crudeltà di Stalin, il quale fin dall’agosto del 1941 «aveva definito quanti
erano caduti in mano tedesca come traditori della patria o collaborazionisti, che al loro ritorno
avrebbero subito rappresaglie non solo in prima persona, ma anche nelle loro famiglie»23 e decretato che «i parenti dei soldati dell’Armata Rossa» che si fossero lasciati «prendere prigionieri»
non avrebbero ricevuto «alcun sostegno o aiuto da parte dello Stato».24 Nonostante le notevoli
divergenze di valutazione sulle cifre e i destini dei reduci sovietici,25 risulta «chiaramente che la
metà degli ex prigionieri e dei lavoratori civili ebbe a soffrire le rappresaglie più disparate»,
almeno fino all’amnistia del 1957, che tuttavia non comportò una loro «piena riabilitazione […].
Il “marchio di Caino” […] rimase fino all’epoca della perestrojka e caratterizzò così per decenni
la vita di queste “vittime di due dittature”».26
37
Poi ci furono le rappresaglie e gli eccidi a fini geopolitici, come quelli titoisti contro gli italiani
nel maggio-giugno del 1945 in Venezia Giulia, Istria e Dalmazia, terre che tra il 1941 e il 1943
avevano conosciuto gli orrori nazifascisti, vertice di un ventennio di brutale dominio dello
Stato italiano. Migliaia di persone morirono nelle foibe carsiche o nei campi di prigionia sloveni e croati e non solo esponenti fascisti e responsabili di crimini di guerra, come affermato
ufficialmente da Belgrado, ma anche numerosi cittadini comuni italiani e slavi, partigiani,
comunisti dissidenti, membri dei comitati di liberazione nazionale. Insomma, chiunque si
opponesse alle ambizioni annessioniste della «nuova» Jugoslavia.27
Il grande massacro non veniva dal nulla. L’«inutile strage» del ’14-’18 ne aveva gettato le solide
basi. E non solo perché per la prima volta sperimentò su scala continentale contro i corpi senza
difesa di milioni di uomini, al fine esplicito della massima distruzione, la devastante sinergia
di Scienza, Industria e Arte militare (inclusi i prodigi della chimica dei gas). Ma soprattutto
perché in seguito l’establishment delle democrazie occidentali si guardò bene dal legittimare il
dibattito etico su quanto era avvenuto. La guerra ancora una volta non fu disonorata, come
aveva inutilmente auspicato Maupassant dopo gli orrori del conflitto franco-prussiano. Al
contrario, fu esaltata. I suoi valori – il patriottismo, il nazionalismo, il militarismo, l’eroismo, la
virilità – non furono messi in discussione dai vincitori e tantomeno dai vinti.28 In effetti, per gli
interessi degli Stati e dei ceti dominanti che ne garantivano il funzionamento e ne rivendicavano la proprietà, quella strage non fu affatto «inutile», liberò i tesori ancora inespressi della
«civiltà superiore», come la chiama chez nous la Bocca della Verità. I 13 milioni di individui
strappati alla vita (oltre il «doppio rispetto al totale dei caduti in tutti i conflitti di rilievo svoltisi tra il 1790 e il 1914» in Europa29) erano in larga parte contadini e operai che in nome delle
rispettive patrie vennero costretti dai relativi parlamenti a massacrarsi a vicenda.30 Un salasso
terapeutico fortemente voluto dal Capitale e infatti del tutto consono ai suoi interessi: la lotta
di classe era vinta, il pacifismo distrutto,31 l’internazionalismo bandito. D’altra parte la Grande
Guerra fu anche la causa scatenante della rivoluzione in Russia e, come avrebbe sostenuto
Simone Weil, non fu affatto una buona causa.32
C’erano dunque, alla fine del primo conflitto mondiale molte condizioni perché la grande illusione che l’inutile strage fosse stata l’ultima si rivelasse appunto un’illusione. Tra le forze che
concorsero a smentirla, soffocando il tabù della guerra, santificando la carneficina e preparando gli animi alla reiterazione, la trahison de clercs diede il suo peculiare, applaudito contributo mitopoietico. Anche gli intellettuali cominciarono allora a diguazzare nel fango della
Schuldfrage, dove lo sterminio è orribile solo se lo perpetrano gli altri. La seconda volta però si
vide ancora meglio a che cosa serva una Schuldfrage: a riconoscere e datare il Peccato Originale
così da cancellare collusioni e complicità pregresse, nonché a separare l’Atrocità mostruosa dei
colpevoli dalla Ritorsione riparatrice degli innocenti. I magistrati fecero di conseguenza il
dover loro, agli intellettuali spettò di acclarare l’ortogenesi del Male e la Filosofia non mancò
all’appello. Sviluppando la diagnosi intuitiva di Norimberga, l’assioma che identificava il
delitto contro l’umanità con la peculiare inumanità del colpevole, Theodor W. Adorno e gli
studiosi ispirati da lui elaborarono una teoria tesa a dimostrare che i movimenti fascisti erano
costituiti da individui antidemocratici dai «forti impulsi aggressivi sottostanti», attirati dalla
possibilità di coniugare la propria «aggressività con la violenza autorizzata contro gruppi
esterni stigmatizzati ideologicamente».33 Coniarono pertanto il concetto di «personalità autoritaria»,34 che avrebbe spiegato in chiave psicologica la veemente attitudine alla violenza di questi specifici soggetti. Tale dottrina, in realtà priva «di riscontri empirici» ma «in confortante
consonanza con i desideri subconsci della platea accademica»,35 contribuiva ad accreditare
l’accomodante visione di episodica estraneità del fenomeno nazifascista alla cultura e alla storia delle società europee e godette quindi sin dalla sua formulazione e per lungo tempo di
molta fortuna. Fino a che il sociologo Zygmunt Bauman, a partire dagli studi di Raul Hilberg
sullo sterminio degli ebrei in Europa durante il nazismo e dagli esperimenti di Stanley
Milgram e Philip Zimbardo,36 non la mandò definitivamente in pezzi, mostrandone la natura
38
grottescamente tautologica: «Per Adorno e i suoi colleghi il nazismo fu crudele perché
furono crudeli i nazisti, e i nazisti furono crudeli perché le persone crudeli tendevano a
diventare naziste».37 La teoria della «personalità autoritaria» non solo non spiegava nulla,
ma era decisamente contraddetta dai risultati della ricerca storica.38 Si trattava invece molto
più seriamente di indagare quella che Primo Levi aveva con grande severità definito «zona
grigia»39 – l’area dell’ambiguità, del compromesso, della collaborazione, attiva o passiva, con
il Potere –, di spiegarne le cause, comprenderne i meccanismi. Ne risultò che il Male ha la
faccia feriale della normalità, come aveva detto Hannah Arendt, che «la novità più terribile
rivelata dall’Olocausto e da ciò che si era appreso sui suoi esecutori non era costituita dalla
probabilità che qualcosa di simile potesse essere fatto a noi, ma dall’idea che fossimo noi a
poterla fare».40 D’altra parte, nella vicenda apparentemente incomprensibile della collaborazione degli ebrei al progetto del proprio annientamento, Bauman mise in rilievo «la capacità
del potere moderno, razionale, burocraticamente organizzato, di promuovere azioni che
sono funzionalmente indispensabili ai propri scopi, sebbene si trovino in stridente contrasto
con gli interessi vitali degli attori».41 Questo è un punto chiave. La capacità dello Stato di
indurre gli individui ad agire contro se stessi è un tratto specifico della modernità. La coercizione è incessante e estremamente duttile, esprimendosi secondo evenienza e necessità,
trasformandosi funzionalmente anche all’interno di uno stesso programma di persuasione.
La potente macchina della propaganda interventista messa in moto dalla Prima guerra mondiale diede un esempio su larga scala dell’opportunità di associare funzionalmente il consenso delle vittime alla coercizione, scatenando entusiastiche adesioni di volontari pronti a
difendere i sacri seppur mobili confini della Patria, anche se la maggior parte dei persuasi,
una volta giunti sulla Marna o nel mattatoio carsico, ebbero bisogno di stimoli complementari per confermarsi nella volontà di uscire dalle trincee e opporre i propri corpi alle mitragliatrici. Comunque nella circostanza la «zona grigia» si dimostrò essenziale terreno di cultura dei processi autodistruttivi: i carabinieri addetti a fucilare sul posto gli indecisi e le
patriottiche esortazioni al sacrificio – soprattutto da parte di chi «alla fronte» non ci sarebbe
comunque andato – erano denti del medesimo vampiro, dissetato dalla cooperazione gratuita ma non innocente di infiniti complici. In Im Westen nichts Neues di Remarque è il professore di greco che un anno dopo l’altro spinge i diletti allievi a farsi scannare: carnefice non
meno efficiente e irrinunciabile dei cannoni francesi, senz’altra paga che l’ebbrezza dei propri irresponsabili miti, proprio come gli scienziati dell’Olocausto si esalteranno poi alle
luminose visioni dell’eugenetica.
Nelle moderne società democratiche, la «zona grigia» ha nella delega politica, nell’obbedienza
afasica e servile mascherata da volontà sovrana, il corrispettivo generale del processo di deresponsabilizzazione individuale analizzato da Bauman a proposito del rapporto tra modernità
e Olocausto: «nel contesto moderno non si scorge alcun segno di superamento dell’antico conflitto, delineato da Sofocle, tra legge morale e legge della società. Esso tende, semmai, a divenire più frequente e più profondo, mentre la sorte sembra favorire le pressioni societarie alla
soppressione della morale».42 Di questo conflitto occorre avere piena consapevolezza, tanto
più quando i Custodi del gregge tornano ad evocare l’Apocalisse, ad armare il braccio della
giustizia infinita perché si abbatta su milioni di uomini. Nessuno può dichiararsi innocente per
delega se il Secondo Cavaliere e il suo Blitzkrieg si reincarnano nel programma eugenico della
democrazia universale e nell’ecatombe preventiva; nessuno può assolversi per incompetenza
da quando il XX secolo ha recitato la sua lezione feroce: «Auschwitz si trova in fondo alla
strada di chi accetta che siano altri a rispondere al posto suo».43 Del resto è vero che l’assunzione individuale di responsabilità non è gratuita:
In molte occasioni comportarsi moralmente significa assumere un atteggiamento definito per
decreto come antisociale o sovversivo dai poteri esistenti e dall’opinione pubblica (sia essa apertamente dichiarata o semplicemente espressa dall’azione o dall’inazione della maggioranza). In
questi casi la promozione del comportamento morale comporta la resistenza all’autorità societaria e un’azione mirante all’indebolimento della sua presa. Il dovere morale deve contare sulla
propria fonte originaria: la fondamentale responsabilità umana verso l’«altro».44
39
Non è un dramma nuovo e non sono nuovi gli interrogativi sull’adeguatezza della risposta
individuale allo strapotere delle armi e alla sanguinaria determinazione di chi ne dispone. Ma
chi ha vissuto il conflitto tra legge morale e legge della società negli anni atrocemente didattici
del XX secolo ha detto in proposito quanto deve bastare agli uomini di buona volontà:
l’impotenza in cui ci si trova in un certo momento, impotenza che non deve mai essere considerata definitiva, non può esentare dal rimanere fedeli a se stessi, né scusare la capitolazione
davanti al nemico, qualunque maschera assuma. Il nemico capitale rimane l’apparato amministrativo, poliziesco e militare, qualunque sia il nome di cui si fregi: fascismo, democrazia o dittatura del proletariato. E non è il nemico che abbiamo di fronte, perché lo è solo nella misura in cui
è quello dei nostri fratelli, ma è il nemico che dice di essere il nostro difensore e fa di noi degli
schiavi. Il peggior tradimento possibile, in qualunque circostanza, consiste sempre nell’accettare
di sottostare a questo apparato e di calpestare in se stessi e negli altri, per servirlo, tutti i valori
umani.45
1
2
3
Per i dati cfr. Roberto Finzi - Mariella Bartolotti, Storia, III, Verso una storia planetaria, Zanichelli,
Bologna 1990, pp. 1686 s.
Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, il Mulino, Bologna 1992, p. 53 n.
«Auschwitz, l’enorme campo in Polonia che associa lo sfruttamento del lavoro e l’eliminazione,
diventa l’emblema di un potere che utilizza e sistematicamente fagocita le “razze inferiori”. Simbolo
della brutalità organizzata, forma estrema del potere assoluto, il Lager nazista è caratterizzato da un
cinismo smisurato, come attesta il riciclaggio di singole parti del corpo degli stessi cadaveri. Della sua
efficienza disumanizzante si giova, in larga misura, il capitalismo tedesco: colossi come la IG Farben,
d’intesa con le SS, lucrano altissimi profitti» (Francesco Soverina, Pluralità e unità degli olocausti: gli
ebrei, e le altre vittime, in AA.VV., Olocausto/Olocausti. Lo sterminio e la memoria, a c. di Francesco
Soverina, prefazione di Luigi Cortesi, Odradek, Roma 2003, p. 23: un libro di utili messe a fuoco). Ad
Auschwitz morirono più di 1 milione di persone, in massima parte ebrei.
40
4
5
6
7
8
Sul tema cfr. Angelo D’Orsi, Se questa è storia. Auschwitz e Hiroshima macerie della modernità; Cesare
Pianciola, Auschwitz e Hiroshima, eredità del secolo, entrambi in AA.VV., Olocausto/Olocausti..., cit., pp.
171-188 e 189-198.
Un modello non solo in senso tecnico-organizzativo: fu anche questione di analoga Weltanschauung.
Violentissima fu infatti la campagna stampa contro gli ebrei condotta negli anni ’20 da Henry Ford,
antisemita dichiarato. Il Dearborn Indipendent, periodico di sua proprietà, rilancia negli USA la mistificazione dei Protocolli dei Savi Anziani di Sion. La campagna abbonamenti è affidata alla catena dei venditori di auto Ford, la tiratura è di circa 300.000 copie. «Gli articoli antisemiti del settimanale vengono
raccolti nel volume The International Jew (L’ebreo internazionale). La sua tiratura raggiunge il mezzo
milione di copie e il volume è tradotto in 16 lingue fra cui tedesco, russo, spagnolo. Più avanti nel
tempo una edizione abbreviata sarà sistematicamente diffusa dalla propaganda nazista […]. Ford non
si limita a far pubblicare testi antisemiti: assolda detectives per scoprire dove abbia sede e da chi sia formato il comitato segreto dei Savi di Sion; invia in Mongolia un emigrato russo in cerca dell’immaginario originale ebraico dei Protocolli». Il debito ideologico del nazismo nei confronti del filantropico istitutore della Ford Foundation non sarà ignorato: Hitler conserverà sempre una sua fotografia sul
tavolo, «anche dopo che Ford avrà abbandonato la militanza antisemita» (Roberto Finzi,
L’antisemitismo. Dal pregiudizio contro gli ebrei ai campi di sterminio, Giunti, Firenze 1997, p. 74). Del resto
Hitler era pieno di ammirazione per i grandi interpreti dell’American Dream e sapeva all’occorrenza
premiare i loro servigi. Il 28 giugno del 1937 a Berlino conferì solennemente a Thomas J. Watson, presidente dell’IBM – senza la cui tecnologia lo Stato tedesco sarebbe andato incontro a paralisi durante
la guerra e lo sterminio nei campi non avrebbe certamente potuto avere luogo con così devastante efficacia – la Croce al merito dell’aquila tedesca con stella, la medaglia «più prestigiosa di cui si potesse
fregiare un non tedesco». Watson, amico di Roosevelt e presidente della Camera di commercio internazionale, era stato premiato «per il dono prometeico della tecnologia delle schede perforate che
aveva consentito al Reich di raggiungere straordinari livelli di efficienza sia nel programma di riarmo
sia nella guerra contro gli ebrei». Egli andava molto fiero della medaglia e la esibì un po’ ovunque in
quegli anni, ma il 6 giugno 1940, obtorto collo, dovette riconsegnarla. In una lettera del 1937 indirizzata
a Hjalmar Schacht, ministro nazista dell’Economia, Watson chiarisce bene i termini ideologici
dell’«alleanza tra l’IBM e i nazisti»: «il mondo avrebbe dovuto “nutrire una profonda comprensione
per il popolo tedesco e per gli scopi che esso si è prefisso sotto il comando di Adolf Hitler”» (cfr. Edwin
Black, L’IBM e l’Olocausto, Rizzoli, Milano 2001, pp. 158 e 56, passim). Il numero che marchiava i prigionieri nei Lager tedeschi non era solo un elemento decisivo nel processo di disumanizzazione delle vittime: era innanzitutto una necessità gestionale. La lettura delle schede perforate per mezzo delle macchine IBM fu la prima applicazione della tecnologia computistica al controllo sociale di massa e si
mostrò straordinariamente efficiente. L’era del silicio è anche figlia dei campi di sterminio, così come i
progressi della genetica.
Sui problemi relativi alle stime cfr. Francesco Soverina - Emilia Taglialatela, Valutazioni numeriche delle
vittime, in AA.VV., Olocausto/Olocausti..., cit., pp. 230-234.
«[…] i nuovi dati che emergono dall’aggiornamento costante della ricerca storiografica sul regime
sovietico sottolineano con forza due elementi. Il primo è il ruolo diretto e personale esercitato da Stalin
nella formulazione dei criteri repressivi e nella verifica della loro applicazione […]. Il secondo elemento è quello del meccanismo delle “quote”. A partire dalla collettivizzazione forzata dei primi anni
Trenta, il centro del regime sovietico impartisce alle amministrazioni periferiche degli obiettivi da raggiungere in termini di detenuti e giustiziati per ciascuna delle categorie da colpire: controrivoluzionari, kulaki, ma anche dal 1937 “nazionalità della diaspora”, cioè minoranze nazionali legate a Stati
stranieri. In base a queste direttive centinaia di migliaia di famiglie vengono deportate e recluse (per i
bambini è previsto l’internamento in appositi orfanotrofi da approntare per l’occasione), il capofamiglia condannato alla pena capitale. Il nemico della rivoluzione viene quindi individuato secondo meri
criteri di appartenenza etnica (con un’estensione automatica delle sue colpe ai familiari) e il terrorismo repressivo è utilizzato esplicitamente come test di efficienza della macchina statale, all’interno di
un quadro di pianificazione e di colossale ingegneria sociale» (Giovanni Gozzini, Capire Auschwitz: la
ricerca e l’insegnamento, in AA.VV., Olocausto/Olocausti..., cit., pp. 44 s.).
Adolf Hitler, Rathenau und Sancho Panza, in Völkische Beobachter, 13 marzo 1921, cit. in Gozzini, op.
cit., p. 43.
41
9
10
11
12
13
14
15
16
Discorso pronunciato dal Fuehrer al Palazzo dello Sport di Berlino il 30 gennaio 1941, Roma, s.i.t., 1941, p. 6,
cit. in Gozzini, op. cit., p. 43 n. La filantropa inglese Emily Hobhouse pubblicò nel 1901 un Report of a
Visit to the Camps of Woman and Children in the Cape and Orange River Colonies, che «venne prontamente
tradotto in tedesco e fu in seguito ripreso dalla propaganda sia nazista che sovietica» (ibid.).
Adolf Hitler, Conversazioni segrete ordinate e annotate da Martin Bormann durante il periodo più drammatico
della seconda guerra mondiale (5 luglio 1941 – 30 novembre 1944), Richter, Napoli 1954, p. 660 (8 agosto
1942), cit. in Gozzini, op. cit., p. 43.
Cit. in Marco Impagliazzo, Una finestra sul massacro. Documenti inediti sulla strage degli armeni (19151916), Guerini e associati, Milano 2000, p. 11. Lo sterminio ordinato dal governo turco riguardò soprattutto gli armeni, «ma la tragedia» colpì «tutte le comunità cristiane dell’impero, talvolta in maniera
sostanziosa […]. Quel che è avvenuto in Turchia è un tragico episodio di pulizia etnica, come è successo molte volte nel tramonto dell’impero ottomano. La storia dei Balcani è contrassegnata da tali
episodi volti a creare Stati omogenei e su base cristiana. In Anatolia succede proprio il contrario. […]
questa pagina buia della storia del Novecento […] vide la scomparsa di più di un milione di persone
e lo sconvolgimento totale del quadro politico-sociale in cui quelle popolazioni erano immerse da
secoli. Prima del 1915, infatti, i cristiani in Anatolia costituivano il 30% circa della popolazione; dopo
la guerra solo l’1%!» (ivi, pp. 17 s.).
Soverina, op. cit., pp. 27 s.
Non «può essere sottovalutato il fatto che la mancata denuncia dell’Olocausto si lega pure al silenzio
del Vaticano sui “genocidi locali” in Polonia e Croazia che hanno preceduto la “soluzione finale”. I
silenzi della Chiesa come delle Potenze alleate, le complicità e la collaborazione di parte non trascurabile delle società europee hanno facilitato il compito dei nazisti, degli ustascia, dei miliziani slovacchi,
delle Croci frecciate ungheresi, delle guardie baltiche e ucraine, dei fascisti francesi e dei repubblichini
italiani» (ivi, p. 29). Su Pio XII cfr. Giovanni Miccoli, I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda
guerra mondiale e Shoa, Rizzoli, Milano 2000; John Cornwell, Il papa di Hitler. La storia segreta di Pio XII,
Garzanti, Milano 2000; inoltre, dopo la recentissima apertura degli archivi vaticani relativi al periodo
che va dal 1922 al 1939, stanno emergendo nuovi documenti a conferma di quanto Pio XII fosse informato sulla natura e i progetti del nazismo (cfr. Marco Politi, Pacelli sapeva, in la Repubblica, 20 febbraio
2003). Sulla questione croata cfr. Marco Aurelio Rivelli, L’Arcivescovo del genocidio. Monsignor Stepinac,
il Vaticano e la dittatura ustascia in Croazia 1941-1945, Kaos Edizioni, Milano 1999.
I dati in John Keegan, La Seconda guerra mondiale, Rizzoli, Milano 2002, pp. 596-598.
Philip S. Lauben e Ernest F. Fisher, noto storico militare, entrambi distaccati in Germania nel biennio
’45-’46 e testimoni diretti degli avvenimenti.
«La percentuale di morte dei prigionieri comunicata riluttantemente dai francesi e dagli americani
dagli anni ’50 fino agli anni ’90 ai tedeschi timidamente indaganti era così ridicolmente bassa da risultare inferiore a quella dei civili nello stesso periodo di tempo. Questa straordinaria notizia – che gente
affamata che dormiva in buche di fango avesse una mortalità più bassa di quella dei civili che mangiavano ogni giorno nelle case – non colpì gli osservatori tedeschi. Essi ignorarono superficialmente
l’evidenza che stava davanti ai loro occhi» (James Bacque, Gli altri Lager. I prigionieri tedeschi nei campi
alleati in Europa dopo la 2a guerra mondiale, Mursia, Milano 1993, p. 183). Ma i tedeschi non volevano
ricordare: «Forse l’aneddoto più cocente sulla volontà di dimenticare dei tedeschi venne raccontato da
un ex prigioniero, Johannes Heising, che ha scritto un libro sulle sue esperienze nel campo di
Remagen. Dopo la pubblicazione del libro, Heising stava parlando, nel 1991, con un altro prigioniero
di Remagen, Franz-Josef Plemper, che gli ricordò qualcosa che egli non aveva descritto nel libro: una
notte, gli americani avevano seppellito con i bulldozer uomini vivi nelle loro buche di terra. Plemper
gli descrisse la scena: “Una notte nell’aprile del 1945, fui risvegliato di colpo dal mio sopore nella pioggia e nel fango da strazianti grida e da forti lamenti. Balzai in piedi e vidi in distanza (circa 30-50 metri)
i fari di un bulldozer. Vidi poi che il bulldozer stava avanzando attraverso la folla di prigionieri stesi
a terra. Aveva davanti una lama che tracciava una strada nel terreno. Non so quanti dei prigionieri
finirono sepolti vivi nelle loro buche. Non fu più possibile rendersene conto. Odo ancora chiaramente
le grida di ‘Assassino!’”. E allora Heising ricordò…». La medesima morte dei soldati iracheni nel conflitto del 1991, quando i blindati statunitensi li seppellirono vivi nelle trincee scavate nel deserto: «Il
furente dibattito sui soldati iracheni sepolti vivi sotto la sabbia dai carri armati americani nelle trincee
e nei bunker del Kuwait ha costretto l’America a chiedersi quante vittime abbia fatto la guerra del
42
17
Golfo Persico e se le sue truppe si siano macchiate di atrocità. Messa di fronte alla realtà del conflitto –
esso non è stato quella operazione chirurgica sperata da Bush – la superpotenza ha mosso per la prima
volta serie critiche ai suoi militari per il loro operato contro l’Iraq. A Fort Riley nel Kansas, dove è di
stanza la prima divisione motocorazzata che nella sua avanzata sotterrò nel deserto migliaia di nemici
o feriti o intrappolati, la protesta è stata particolarmente emotiva. Il Pentagono ha subito cercato di rassicurare la popolazione. “Nessuna atrocità” ha dichiarato il portavoce Williams. “Non c’è modo indolore di morire in battaglia”. “I caduti iracheni potrebbero essere stati centomila” ha aggiunto la Dia, il
suo servizio segreto. […] Gli ufficiali della ‘grande rossa’ [la prima divisione motocorazzata dell’esercito U.S.A., soprannominata ‘The Big Red One’ e divenuta famosa durante la Seconda guerra mondiale] non si sono mostrati pentiti dell’accaduto. “Fu più facile per gli iracheni nelle trincee e nei
bunker arrendersi prima di venire sepolti vivi che per gli iracheni bombardati dagli aerei o colpiti dalle
cannonate nelle loro postazioni o nelle città”» (L’America sbigottita dalla strage nel deserto, in la
Repubblica, 14 settembre 1991). La medesima morte di Rachel Corrie, pacifista statunitense di ventiquattro anni, assassinata a Gaza da un bulldozer dell’esercito israeliano che l’ha sepolta sotto un
cumulo di terra e detriti mentre cercava di ostacolare con il proprio corpo la distruzione di una casa
palestinese: una morte tutt’altro che rara nei territori occupati, solo che gli uccisi palestinesi non hanno
di norma né nome né volto (cfr. Enrico Franceschini, Schiacciata dal bulldozer, ivi, 17 marzo 2003).
Ernest F. Fisher, Prefazione a Bacque, op. cit., p. 13. Lo sterminio per fame dei prigionieri tedeschi, tra i
quali numerosi le donne, i vecchi e i bambini, avvenne in piena sovrapproduzione alimentare. Inoltre
fu costantemente impedito alla Croce Rossa di consegnare le ingenti scorte di cibo di cui era dotata,
che rimasero quindi inutilizzate. In Francia, nei 1.600 «bagnes de mort lente», spesso i prigionieri
sopravvissero solo grazie alla generosità dei civili, «principalmente contadini e abitanti dei villaggi»,
anche se esercitarla non era certo facile: «Sembra che sotto i francesi siano aumentate le fucilazioni a
caso, sebbene entrambi gli eserciti cercassero di nascondere i fatti e i dati possano risultare distorti. In
ogni modo, il rapporto del tenente colonnello Barnes in aprile, “27 morti per cause non naturali”, era
largamente superato in una notte dagli ufficiali francesi ubriachi, che, a Andernach, guidarono la loro
jeep attraverso il campo ridendo e gridando mentre sparavano sui prigionieri con i loro mitragliatori
Sten. Le perdite: 47 morti e 55 feriti. Un ufficiale francese rifiutò il permesso alla Croce Rossa tedesca
di dar da mangiare ai prigionieri su un treno nonostante il rifornimento fosse stato già concordato tra
la Croce Rossa e il comandante francese del campo. Le guardie francesi di un campo, sostenendo di
aver notato un tentativo di fuga, uccisero a fucilate dieci prigionieri nei loro recinti. […] Nel 108°
Reggimento di Fanteria la violenza raggiunse tali limiti che il comandante militare della regione, il
generale Billotte, su suggerimento del comandante del reggimento, tenente colonnello de
Champvallier, che aveva rinunciato a cercare di disciplinare i suoi uomini, raccomandava che il reggimento venisse sciolto. I treni che trasferivano i prigionieri dalla Germania Federale in Francia erano
talmente terribili che gli ufficiali responsabili avevano ordini permanenti di evitare soste nelle stazioni
francesi, per timore che i civili potessero vedere come venivano trattati i prigionieri. […] In questi
campi di prigionia appare il primo accenno del futuro coinvolgimento americano nella guerra del Viet
Nam. I francesi affamarono deliberatamente alcuni tra i prigionieri per costringerli a servire “volontariamente” nella loro Legione Straniera. Molti dei legionari che combatterono in Viet Nam erano tedeschi consegnati dagli americani ai francesi nel 1945 e 1946» (ivi, pp. 98 s., 117). Dopo questo addestramento, il generale De Gaulle avrebbe impiegato con pari ferocia l’esercito francese in Indocina e in
Algeria. Nei 200 campi statunitensi in Germania, semplicemente vigeva la pena di morte per i civili
che intendevano aiutare i prigionieri: «Fu solo un giorno dopo la fine della guerra, l’8 maggio 1945,
che il Governo Militare di Eisenhower dichiarò che dar da mangiare ai prigionieri tedeschi era un crimine capitale per i civili tedeschi. […] Eisenhower aveva già raccomandato ai capi di Stati Maggiori
riuniti a Washington che l’esercito non nutrisse i milioni di prigionieri di guerra, ma che se ne lasciasse
il compito ai tedeschi, sebbene egli dubitasse che fossero in grado di farlo. Che ci fosse una chiara
intenzione dietro a questi ordini apparentemente contrastanti, era chiaro a tutti i soldati in Germania
a quel tempo» (ivi, p. 170).
Sui campi inglesi e canadesi non c’è ancora chiarezza, ma pare non ci siano «tracce di simili atrocità.
Alcune scarse prove» indicherebbero che i prigionieri rimasero in buona salute, «eccetto circa 400.000
trasferiti agli inglesi dagli americani nel 1945. Molti di questi erano morenti quando vennero trasferiti». In effetti, «quando l’esercito canadese chiese l’importante monografia di Phillimore (sui prigio-
43
18
19
20
21
22
23
24
25
nieri tedeschi in mano inglese) al governo britannico, ottenne un rifiuto, perché era definita “ancora in
uso”. Praticamente niente sul trattamento di milioni di prigionieri tedeschi in mano a canadesi e
inglesi in Europa rimane negli archivi di Ottawa e di Londra. Il Comitato Internazionale della Croce
Rossa a Ginevra, che recentemente ha aperto i suoi archivi a due scrittori che facevano ricerche sui
campi nazisti, ha rifiutato di concedermi di fare ricerche negli stessi archivi sui prigionieri di guerra
nei campi inglesi e canadesi. L’ICRC mi ha rifiutato ripetutamente di vedere lettere sull’argomento,
nonostante le mie richieste fossero trasmesse dall’esercito canadese e dalla Croce Rossa canadese. Sia
gli inglesi che i canadesi sapevano quanto si stava facendo nei campi americani. Gli inglesi furono
testimoni delle atrocità in almeno un campo. Solo il governo canadese ha protestato una volta» (ivi,
pp. 16 s.). Dopo l’uscita del volume in Canada, nel 1989, una trentina di case editrici negli USA si rifiutarono di pubblicarlo per il mercato statunitense, fino al 1991. Gli storici del Pentagono respinsero le
accuse e contestarono il numero dei morti e il metodo statistico che aveva consentito a Bacque di stabilirlo. Tuttavia i dati di base non poterono essere messi in discussione e generarono un duro scontro
dietro le quinte tra le diplomazie di Germania, Francia e Stati Uniti, con l’avvio di un’inchiesta riservata. Anche perché, come scrisse Ennio Caretto (Un milione di tedeschi morì nei Lager alleati, in la
Repubblica, 23 febbraio 1992) «sulla serietà del lavoro di Bacque, estremamente documentato, ci sono
pochi dubbi». Di recente il quotidiano inglese The Guardian ha infranto «un mito propagato ad arte per
decenni», come afferma Sherman Carroll, Director of Public Affairs della Medical Foundation for the
Care of Victims of Torture, cioè «l’idea secondo cui la Gran Bretagna non usò la tortura durante la
Seconda Guerra mondiale e subito dopo». Dagli abissi degli archivi statali, nonostante «i tentativi di
bloccare lo scoop del giornale» da parte della Difesa, sono emersi foto e documenti riguardanti il centro di detenzione di Bad Nenndorf, un’ex stazione termale nei pressi di Hannover, dove tra il 1945 e il
1947 il War Office britannico portò avanti un programma di torture «sui sospetti comunisti per carpire
informazioni sui sovietici» e su «nazisti, ex SS, industriali che avevano fatto fortuna sotto Hitler». 372
uomini e 44 donne finirono nelle mani dei carnefici, talvolta ricevendone la morte: «Il segreto è rimasto gelosamente custodito negli archivi perché, annotò già allora un ministro a Londra, meno persone
possibile “devono sapere che le autorità britanniche si sono comportate in un modo che ricorda i lager
nazisti”» (Stefania Di Lellis, I lager inglesi della Guerra fredda: un segreto svelato dopo 60 anni, ivi, 4 aprile
2006). Joachim Fest, «massimo storico tedesco vivente e miglior biografo di Hitler, commenta scosso
le rivelazioni del Guardian […]: “la guerra libera gli istinti del Male: è la madre di ogni crudeltà. […]
muri e barriere che i paesi civili erigono per limitarsi crollano spesso davanti a emergenze presunte o
reali. E si passa a metodi sempre uguali. Nessuna nazione è al riparo da certi ordini dall’alto. […] Gli
Occidentali nella Guerra Fredda non erano diversi o migliori rispetto agli uomini dall’altra parte. […]
Guai a una società e a un sistema di valori che vuole difendersi tradendo i suoi principi”» («Un’orribile
risposta ai gulag di Stalin», intervista di Andrea Tarquini a Joachim Fest, ivi). Quasi l’avesse ascoltato,
qualche ora dopo il ministro della Difesa John Reid, che si era appena rifiutato di rispondere alle
domande del Guardian sui Lager di Sua Maestà, constatava la necessità democratica di cambiare i
principi per non infrangerli e dettava alle agenzie una requisitoria contro lacci e lacciuoli della
Convenzione di Ginevra, definendola «un impedimento all’azione delle truppe britanniche» e proponendo di cambiare «alcune regole» «troppo antiquate» che «ostacolano l’Occidente», in specie, of
course, quelle riguardanti il «trattamento dei prigionieri, gli attacchi preventivi e gli interventi per fermare le crisi umanitarie» (Gran Bretagna: ministro della difesa propone modifica Convenzione di Ginevra, in
www.corriere.it, 4 aprile 2006).
Joël Kotek - Pierre Rigoulot, Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio: la tragedia del
Novecento, Mondadori, Milano 2002, pp. 358 s.
Barbara Stelzl-Marx, Prigionieri di guerra sovietici nel Terzo Reich, in AA.VV., Olocausto/Olocausti…,
cit., p. 113.
Ivi, p. 116.
Ivi, p. 120.
Ibid.
Ivi, p. 126.
Ordine n. 270 del Comando generale dell’Armata Rossa (ivi, p. 128 n.).
«Secondo Viktor Zemskov, fino al 1° marzo 1946 due milioni di reduci sovietici passarono nei campi
del Nkvd [Ministero degli interni sovietico], che vennero chiusi solo nel 1947. Di questi cittadini sovie-
44
26
27
28
29
30
tici ‘filtrati’ il 57,8% venne rilasciato e mandato a casa, il 19,1% richiamato nell’esercito, il 14,5% assegnato ai battaglioni di lavoro del Commissariato del popolo per la difesa (Nko), il 6,5 messo a disposizione del Nkvd, mentre un ulteriore 2,1% si trovava ancora a quella data nei punti di raccolta. A conclusioni diverse giungono Nikolaj Tolstoj e lo storico sovietico in esilio Aleksandr Nekric. Essi fanno
riferimento ad un numero complessivo pari a 5,5 milioni di displaced persons rimpatriate fino al 1947:
di queste circa il 20% venne condannato a morte o a 25 anni di detenzione nei campi, dal 15 al 20%
ricevette pene detentive da cinque a dieci anni, il 10% venne deportato per almeno 6 anni in Siberia, il
15% degli ex lavoratori forzati inviato in zone inospitali, dal 15 al 20% ottenne il permesso di ritornare
a casa e il rimanente 15–20% morì durante il viaggio verso casa o riuscì a fuggire» (ivi, pp. 128 s.).
Ivi, p. 128.
Cfr. Gianni Oliva, Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell’Istria, Mondadori, Milano
2002. Il problema in Italia della memoria delle «foibe» – tra coloro che negano, coloro che giustificano
e coloro che ne fanno oscena moneta di scambio – è specchio di un più generale fenomeno politico
internazionale che vede trattare le tragedie della storia secondo le proprie convenienze: negazionismo
e riduzionismo riguardano tutti, non solo i neonazisti. Ad ogni buon conto, per i negazionisti di ogni
sorta vale quanto detto da Primo Levi: «Chi nega Auschwitz è quello stesso che sarebbe pronto a
rifarlo» (la frase è tratta da un’intervista-testimonianza raccolta da Emanuele Ascarelli in Ritorno ad
Auschwitz, documentario girato nel 1982 da Daniel Toaff per la trasmissione RAI Sorgente di vita in
occasione di una visita di Levi al campo. La trascrizione integrale dell’intervista, con una nota introduttiva di Ascarelli, in Il racconto della catastrofe. Il cinema di fronte ad Auschwitz, a c. di Francesco
Monicelli e Carlo Saletti, Cierre Edizioni, Verona 1988, pp. 91-101). Per i riduzionisti vale quanto
scritto da James Bacques: «L’eufemismo è il primo passo verso l’atrocità» (op. cit., p. 189).
George L. Mosse in Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti (Laterza, Roma-Bari 1990) ha ricostruito la genesi e lo sviluppo del «Mito dell’Esperienza della Guerra»: «Il lutto era generale. Eppure,
diversamente da come ci si potrebbe attendere, questo tema non avrebbe dominato incontrastato la
memoria della prima guerra mondiale. Un sentimento d’orgoglio si mescolava spesso al lutto: il sentimento di aver avuto parte in una nobile causa, e di aver sofferto per essa. […] Furono i ricordi di quei
reduci che nella guerra scorgevano elementi positivi – e non quelli di coloro che rifiutarono la guerra
– che vennero generalmente adottati dalle rispettive nazioni come veridici e legittimi […]. Il compito
consolatorio fu adempiuto ad un livello pubblico oltreché privato; e ciò in nome della rievocazione
della gloria piuttosto che dell’atrocità della guerra, del suo senso e della sua finalità piuttosto che della
sua tragedia. Coloro che si occupavano dell’immagine e della perduta attrattiva della nazione lavorarono alla costruzione di un mito volto a cancellare l’orrore della morte in guerra. […] La realtà dell’esperienza della guerra giunse a trasformarsi in quello che potremmo chiamare il Mito dell’Esperienza
della Guerra, che guardava al conflitto come ad un evento carico di senso, positivo, e anzi sacro.
Questa visione della guerra si sviluppò (ma non esclusivamente) nei paesi sconfitti, dove ve n’era un
così pressante bisogno. […] Dopo il conflitto, il culto del soldato caduto divenne un elemento centrale
della religione del nazionalismo, ed ebbe la sua maggiore influenza politica in nazioni che, come la
Germania, avevano perso la guerra, e che la transizione dalla guerra alla pace aveva portato sull’orlo
del caos. Grazie al mito che giunse a circondarla, l’esperienza della guerra fu innalzata nel regno del
sacro» (pp. 6-8).
Ivi, p. 3. «[…] nella campagna contro la Russia (la più cruenta fino al 1914) Napoleone perse 400.000
uomini, ovvero una cifra inferiore di circa 600.000 unità a quella dei caduti su entrambi i lati del fronte
durante la battaglia della Somme nel 1916 (una battaglia peraltro nient’affatto risolutiva). Il più
grande conflitto dell’Ottocento – la guerra franco-prussiana (1870-71) – vide 280.000 morti francesi,
mentre i prussiani caduti in battaglia furono 44.780» (ivi, pp. 3 s.).
Naturalmente in termini assoluti il paragone delle perdite tra ufficiali e truppa è improponibile. Ma
in termini relativi è assai significativo e di qualche ulteriore interesse per quanto riguarda l’Italia: pur
se «l’adesione alla guerra delle classi colte italiane fu probabilmente maggiore nel 1915-18 che non
nel 1940-43», tuttavia «anche nella grande guerra, l’ardore guerresco di quella parte dell’élite fondamentale per assicurare l’efficienza militare fu straordinariamente flebile. Nel 1915-18, l’assenza relativa del corpo degli ufficiali di carriera dell’esercito dal campo di battaglia produsse un tasso di morti
complessivo del 7,7 per cento, un sacrificio di sangue pari alla metà di quello di tutti gli italiani mobilitati, e a meno di un terzo di quello degli ufficiali di carriera tedeschi, il cui tasso di mortalità nel
45
31
1914-18 raggiunse un vertiginoso 24,8 per cento». Il «terrore disciplinare del regio esercito nel 191518» e il «disastroso» «grado di attenzione per la condizione delle truppe» erano un trattamento riservato sostanzialmente ai poveri, soprattutto ai contadini (2/3 della fanteria e 90% dei caduti): «Le
unità languirono per mesi nelle trincee, in mezzo al fango e agli escrementi, dato che non esisteva un
adeguato sistema di rotazione. Furono le malattie a uccidere quasi il 30 per cento dei circa 500.000
morti al fronte […], rispetto a meno del 10 per cento dell’esercito tedesco, nonostante le privazioni
patite da quest’ultimo a causa del blocco alleato. Per i vertici militari, gli uomini in trincea valevano
meno delle bestie da soma. Un mulo morto, notò un ufficiale subalterno, costava denaro e quindi
richiedeva “verbali su verbali, inchieste. Quando muore un soldato è molto più semplice, un frego
nel ruolino e la notizia schematica nel rapportino giornaliero”». Ma la ferocia delle élite italiane non
aveva davvero limiti e la rassegnazione con cui i poveri contadini dovettero subire il proprio sterminio nella «guerra dei signori» fu anche oggetto di scherno: «Il consulente di psicologia militare di
Cadorna, padre Agostino Gemelli, celebrò con singolare ottusità il carattere che egli ascriveva ai soldati-contadini italiani: “rozzi, ignoranti, passivi, hanno subito […] l’influenza della vita militare
senza ribellione, senza resistenza”» (le citazioni e i dati sono tratti da MacGregor Knox, Alleati di
Hitler. Le regie forze armate, il regime fascista e la guerra del 1940-1943, Garzanti, Milano 2002, pp. 173
ss.). Ma non era affatto ottusità quella dell’illustre biologo, dell’illuminato promotore in Italia della
psicologia applicata, del fondatore e rettore (fino al 1959, anno della morte) dell’Università Cattolica
di Milano: era razzismo. Sul numero del 5 agosto 1924 della rivista Vita e pensiero, di cui era direttore,
scrisse: «Un ebreo, professore di scuole medie, gran filosofo, grande socialista, Felice Momigliano, è
morto suicida. I giornalisti senza spina dorsale hanno scritto necrologi piagnucolosi. Qualcuno ha
accennato che era rettore dell’Università Mazziniana […]. Ma se insieme con il Positivismo, il
Socialismo, il Libero Pensiero e con il Momigliano morissero i Giudei che continuano l’opera dei
Giudei che hanno crocifisso Nostro Signore, non è vero che al mondo si starebbe meglio? Sarebbe una
liberazione ancora più completa se, prima di morire, pentiti, domandassero l’acqua del Battesimo».
Il sant’uomo sciorinò il suo dotto repertorio anche a propositò delle leggi razziali. Il 9 gennaio 1939,
chiamato all’Università di Bologna per la commemorazione di Guglielmo da Saliceto, così parlò a
professori e studenti: «Tragica senza dubbio, e dolorosa, la situazione di coloro che non possono far
parte, e per il loro sangue e per la loro religione, di questa magnifica patria; tragica situazione in cui
vediamo, una volta di più, come molte altre nei secoli, attuarsi quella terribile sentenza che il popolo
deicida ha chiesto su di sé e per la quale va ramingo per il mondo, incapace di trovare la pace di una
patria, mentre le conseguenze dell’orribile delitto lo perseguitano ovunque e in ogni tempo»
(entrambi i testi in Rosetta Loy, La parola ebreo, Einaudi, Torino 2002, pp. 54 s.). Al riguardo De Felice
commenta: «Dopo un simile saggio della prosa di padre Gemelli non potrà certo meravigliare il
sapere che Farinacci, su “Il regime fascista” del 10 gennaio, si precipitasse a proclamare tutto compiaciuto Non siamo soli e facesse un vero panegirico del discorso bolognese del Gemelli e, neppure due
mesi dopo, chiedesse addirittura a Mussolini di nominare quest’“uomo veramente nostro”
all’Accademia d’Italia». Ma il Duce rispose: «No – non è ancora maturo» (in Renzo De Felice, Storia
degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino 1961, p. 372 e 373 n.). La «magnifica patria» ebbe
però modo di risarcire il francescano di tanta crudele ingratitudine e tra l’altro gli intitolò a Roma il
Policlinico della Facoltà di Medicina e Chirurgia del «Sacro Cuore», ufficialmente istituita nel 1958
grazie agli sforzi di questo «strenuo difensore della vivisezione», per il quale era «ovvio che gli esperimenti» dovessero «turbare le funzioni vitali degli animali e causare in essi sensazioni dolorose»,
senza del resto turbare altri, poiché dove «non v’è partecipazione della coscienza non v’è dolore» (cfr.
www.geocities.com/notarianni_gabriele/recapiti_sacro_cuore.htm).
«Il pacifismo non riuscì mai a sfondare davvero, a divenire cioè parte del credo delle classi medie, e
neppure delle classi inferiori. Nell’intero periodo tra le due guerre, in nessun momento riuscì a diventare una forza politicamente potente, né a conquistarsi l’adesione di una parte considerevole della
popolazione» (Mosse, op. cit., p. 219). Giova ricordare che quando nel 1930 venne diffuso All Quiet on
the Western Front – mirabile omaggio ai vinti, monumento della cultura antimilitarista alla pietas e alla
pace del regista e reduce statunitense di origine ebraica Lewis Milestone, nato nel 1895 a Chisinau, in
Bessarabia, e vissuto in gioventù a Odessa – la Repubblica di Weimar lo mise immediatamente al
bando su pressioni della destra «perché tale da costituire una minaccia all’ordine interno e all’immagine della Germania nel mondo» (ivi, p. 220). Im Westen nichts Neues, il romanzo di Erich Maria
46
32
33
34
35
36
Remarque da cui era tratto il film, fu invece dato alle fiamme dai nazisti all’Università di Berlino, il 10
maggio 1935, insieme a tutte le sue opere. Un caso di «continuità delle istituzioni». È anche bene ricordare che il protagonista del film, Lew Ayres, avendo preso sul serio il messaggio pacifista di Remarque
e Milestone, nel 1942 rifiutò di arruolarsi e la MGM patriotticamente lo licenziò.
Non sembra che in proposito ci sia molto da aggiungere o da togliere ai giudizi espressi da Simone
Weil sin dal 1933: «La Costituzione sovietica ha avuto la stessa, identica sorte della Costituzione del
1793: proprio come Robespierre, Lenin ha abbandonato le sue dottrine democratiche per costituire il
dispotismo di un apparato di Stato centralizzato, ed è stato di fatto il precursore di Stalin, come
Robespierre lo fu di Bonaparte. La differenza sta nel fatto che Lenin, il quale aveva, del resto, già da
lungo tempo preparato questo dominio dell’apparato statale costituendo un partito fortemente centralizzato, deformò successivamente le proprie dottrine per adattarle alle necessità del momento. Così
non fu ghigliottinato, e funge ora da idolo per una nuova religione di Stato. La storia della
Rivoluzione russa è tanto più sconvolgente in quanto la guerra vi costituisce costantemente il problema centrale. La rivoluzione fu compiuta contro la guerra, da parte di soldati che, sentendo l’apparato governativo e militare sfasciarsi sopra di loro, si affrettarono a scrollarsi di dosso un giogo intollerabile. […] I bolscevichi fecero allora appello alla lotta contro l’imperialismo; ma era la guerra stessa,
e non l’imperialismo, a essere in questione, e loro per primi se ne accorsero quando, una volta al
potere, si videro costretti a firmare la pace di Brest-Litovsk. Il vecchio esercito era allora a pezzi e Lenin
aveva ripetuto, con Marx, che la dittatura del proletariato non poteva comportare né esercito, né polizia, né burocrazia permanenti. Ma le armate bianche e il timore di interventi stranieri non tardarono a
mettere la Russia intera in stato d’assedio. L’esercito fu allora ricostituito, venne soppressa l’elezione
degli ufficiali, e trentamila ufficiali del vecchio regime furono reintegrati nei quadri; la pena di morte,
la precedente disciplina, la centralizzazione furono ristabilite. Parallelamente, la burocrazia e la polizia vennero ricostituite. Si sa ormai abbastanza bene ciò che in seguito questo apparato militare, burocratico e poliziesco ha fatto del popolo russo. La guerra rivoluzionaria è la tomba della rivoluzione
[…]. Un paese avanzato, in caso di rivoluzione, non incontrerebbe le difficoltà che nella Russia arretrata rappresentano la base del barbaro regime di Stalin; ma una guerra di una certa ampiezza ne
susciterebbe altre perlomeno equivalenti. A maggior ragione una guerra intrapresa da uno stato borghese non può che trasformare il potere in dispotismo, e l’asservimento in assassinio. Se la guerra
sembra talvolta un fattore rivoluzionario, ciò avviene solo perché costituisce un autentico banco di
prova del funzionamento dell’apparato statale. Al suo contatto, un apparato male organizzato si sfascia. Ma se la guerra non finisce subito e senza contraccolpi, o se il disfacimento non è stato troppo
radicale, ne consegue solo una di quelle rivoluzioni che, secondo la formulazione di Marx, perfeziona
l’apparato statale anziché abbatterlo» (Simone Weil, Riflessioni sulla guerra, in Sulla guerra. Scritti 19331943, a c. di Donatella Zazzi, Nuova Pratiche Editrice, Milano 1988, pp. 35-37).
Christopher R. Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia, Einaudi, Torino
1999, p. 172.
Cfr. Theodor W. Adorno - Else Frenkel-Brunswik - Daniel J. Levinson - R. Nevitt Sanford, The authoritarian
personality, Harper & Brothers, New York 1950; ed. it. La personalità autoritaria, Edizioni di Comunità,
Milano 1973.
Bauman, op. cit., p. 213.
Nel 1974 Stanley Milgram, uno psicologo statunitense della Yale University, pubblicò i risultati di una
ricerca sperimentale per comprendere i meccanismi dell’obbedienza (Obedience to Authority: An
Experimental View, Harper & Row, New York; ed. it. Obbedienza all’autorità, Bompiani, Milano 1975).
Ignari volontari furono indotti dalla mera autorità di uno pseudo-medico a operare per il bene della
scienza infliggendo dolore tramite elettricità a un attore-vittima, il quale reagiva – coerentemente con il
presunto graduale aumento d’intensità delle scosse – prima con lamenti, poi con urla e richieste d’aiuto,
infine con un terrificante silenzio. I due terzi dei partecipanti all’esperimento smisero solo dopo aver
somministrato il massimo grado di elettricità, smentendo quanto previsto dalla quasi totalità degli
«individui maschi della classe media» e dei «competenti e rispettati professionisti della psicologia a cui
Milgram chiese quali sarebbero stati i probabili risultati degli esperimenti […]»: essi si mostrarono
«sicuri che il 100 per cento dei soggetti avrebbe rifiutato di cooperare via via che cresceva la crudeltà
delle azioni da compiere, e che la prova sarebbe stata interrotta in una fase relativamente precoce»
(Bauman, op. cit., p. 215). Gli esperimenti condotti a Stanford da Philip Zimbardo (Craig Haney - W.
47
37
38
Curtis Banks - Philip G. Zimbardo, Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison, in International Journal of
Criminology and Penology, I (1973), pp. 69-97) riguardavano il comportamento di un gruppo di individui
‘normali’, casualmente suddivisi in prigionieri e secondini e invitati a comportarsi come tali. Il divieto
per le ‘guardie’ di esercitare qualunque violenza fisica non bastò ad impedire la precipitosa sospensione
dell’esperimento, dopo una sola settimana sulle due previste, per evitare che i ‘prigionieri’ subissero
irreparabili danni psico-fisici. «L’improvvisa trasformazione di amabili e gentili ragazzi americani in
individui simili a mostri del tipo di quelli che presumibilmente dovrebbero trovarsi solo in luoghi come
Auschwitz o Treblinka è terrificante. Ma è anche sconcertante. […] l’orgia di crudeltà da cui Zimbardo e
i suoi colleghi furono colti di sorpresa scaturiva dal contesto sociale e non dalla malvagità dei partecipanti. Se i ruoli dei soggetti dell’esperimento fossero stati invertiti, il risultato complessivo non sarebbe
cambiato. Ciò che importava era l’esistenza di una polarità, e non chi ne occupava gli estremi […]. A
quanto sembra, il punto principale della questione sta nella facilità con cui la maggior parte delle persone scivola nel ruolo che richiede la crudeltà o quantomeno la cecità morale, purché quel ruolo sia stato
debitamente rafforzato e legittimato da un’autorità superiore» (Bauman, op. cit., pp. 230 s.). Ma in tutti
questi esperimenti ci sono stati anche «casi, relativamente rari, in cui gli individui hanno trovato la forza
e il coraggio di resistere agli ordini dell’autorità e, avendoli giudicati contrari alle proprie convinzioni, si
sono rifiutati di eseguirli […], esattamente come hanno fatto quei pochi, dispersi e solitari individui che
sfidarono un potere senza limiti e scrupoli, e rischiarono la morte tentando di salvare le vittime
dell’Olocausto» (ibid.). «Non importa quante persone abbiano preferito il dovere morale alla razionalità dell’autoconservazione, ciò che importa è che qualcuno l’abbia fatto. Il male non è onnipotente. È possibile resistergli.
La testimonianza di coloro che effettivamente gli hanno opposto resistenza scuote la validità della logica
dell’autoconservazione. Mostra ciò che essa è, in ultima analisi: una scelta. Ci chiediamo quante persone
debbano sfidare questa logica affinché il male sia ridotto all’impotenza. Esiste una soglia magica di resistenza al di là della quale la tecnologia del male cessa di funzionare?» (ivi, p. 280).
Per un impressionante riscontro storico dei risultati degli esperimenti di Milgram e Zimbardo e delle
analisi di Bauman cfr. Browning, op. cit., pp. 174-184.
Bauman, op. cit., p. 213.
«La particolare importanza del libro non era data dalle sue specifiche affermazioni – praticamente
tutte furono in seguito messe in discussione e confutate –, ma dalla sua individuazione del problema
e dalla strategia di ricerca che ne derivava. […] Come suggerisce il titolo del libro, gli autori cercarono
la spiegazione del regime nazista e delle atrocità che ne seguirono nell’esistenza di un particolare tipo
di individuo: una personalità incline all’obbedienza con i forti e alla brutalità senza scrupoli, spesso
crudele, con i deboli. Il trionfo dei nazisti doveva essere stato un esito dell’insolita accumulazione di
personalità del genere. Ma gli autori non spiegano né desiderano spiegare perché ciò accadde. Essi
evitano accuratamente l’analisi di tutti gli eventuali fattori sovraindividuali o extraindividuali che
potessero produrre la personalità autoritaria; né si preoccuparono della possibilità che tali fattori possano provocare un comportamento autoritario in individui altrimenti privi di una personalità autoritaria. […] Il modo in cui Adorno e il suo gruppo articolarono il problema era importante non tanto per
come venivano distribuite le colpe, ma per l’ottusità grazie alla quale tutto il resto dell’umanità ne
usciva assolto. Il punto di vista di Adorno divideva il mondo in due parti: i protonazisti congeniti e le
loro vittime. Veniva così soppressa l’oscura e sgradevole idea che molte persone gentili possano
diventare all’occorrenza crudeli. Il sospetto che anche le vittime possano perdere buona parte della
propria umanità sulla strada verso la perdizione fu bandito con una tacita proibizione, che arrivò a
toccare l’assurdità nel ritratto dell’Olocausto fatto dalla televisione americana» (ivi, pp. 213 s.).
Bauman si riferisce, e non a caso, allo sceneggiato televisivo Holocaust, prodotto negli Stati Uniti alla
fine degli anni Settanta e trasmesso anche in Germania e in Francia. Il serial, che ottenne un colossale
successo di pubblico, suscitò numerose reazioni indignate soprattutto da parte dei superstiti a causa
della versione edulcorata dello sterminio che ne risultava. Tuttavia l’opera rispondeva alle medesime,
superiori esigenze della teoria di Adorno, così come, un quarto di secolo dopo, Schindler’s List di
Steven Spielberg, che con la sua crudezza avrebbe sì soddisfatto le attese di molti dei superstiti, ma al
quale, come indica Annette Wieviorka, si attaglia perfettamente l’analisi di Alvin H. Rosenfeld: «Fa
parte dell’ethos americano il fatto di porre l’accento sulla bontà, l’innocenza, l’ottimismo, la libertà, la
diversità e l’uguaglianza. E allo stesso ethos appartiene anche il fatto di sminuire o di negare i lati bui
e crudeli della vita e di sostituirli accentuando il potere salvifico dell’atteggiamento morale e dei
48
39
40
41
42
43
44
45
mezzi collettivi di Redenzione. L’americano preferisce pensare in modo positivo e affermativo. La
visione tragica è, dunque, antitetica alla visione americana del mondo, che vuole che gli uomini trionfino rispetto alle avversità e non continuino a rimuginare le loro pene» (The Americanization of the
Holocaust, in Thinking about the Holocaust after half a century, Indiana University Press, Bloomington e
Indianapolis 1997, p. 123). Nel suo L’era del testimone (Raffaello Cortina, Milano 1999) – testo importante per capire il fenomeno dell’«americanizzazione dell’Olocausto» e da cui è tratta la citazione di
Rosenfeld – Wieviorka opportunamente aggiunge: «Il problema è che tale visione non coincide affatto
con quella che si forma lo storico allorché studia il genocidio degli ebrei» (pp. 131 s.). È interessante
rilevare che le legittime aspettative del popolo circa la propria educazione ispirarono qualche anno
dopo a Spielberg un’analoga operazione di sistemazione storico-didattica di un altro genocidio. Nel
1997, sempre sulla scorta della traiettoria aperta da un serial televisivo di grande successo – Radici,
diretto da Marvin Chomsky, lo stesso di Holocaust! – e forte del suo ruolo dominante e autorizzato
di guru hollywoodiano, il filantropico regista concepirà a beneficio delle masse una nuova, assai
riposante vulgata della tratta atlantica e della conseguente schiavitù dei neri d’America. In Amistad
– una storia «vera», ça va sans dire, accaduta nel 1839 – si forniranno subliminalmente all’uomo della
strada le nozioni necessarie per liberarsi definitivamente, e «più non dimandare», del problema
dello sterminio degli afroamericani: i cattivi risulteranno essere gli europei latini (spagnoli e portoghesi), gli africani stessi, sempre in guerra tra di loro, gli schiavisti arabi e i cinici abolizionisti; i
buoni gli anglosassoni: gli inglesi (campioni della lotta alla schiavitù) e soprattutto il popolo degli
Stati Uniti, le cui superiori virtù civiche e morali – cioè i principi costituzionali dei padri fondatori
e il corso normale della giustizia nel paese dove il Bene, nonostante tutto, non può che trionfare –
riusciranno in nome della libertà a prevalere e successivamente, si lascia capire, anche a sconfiggere
i residui schiavisti locali (non per mezzo degli infidi abolizionisti, s’intende – ché magari sono pure
pacifisti –, ma attraverso una carneficina dura ma giusta). Spielberg naturalmente sapeva quel che
faceva e nel film si concederà l’ammiccante vezzo di far pronunciare all’ex presidente degli Stati
Uniti Quincy Adams (buono) l’apoftegma programmatico ispiratore del progetto: «in un’aula di tribunale, chi racconta la storia migliore vince». L’operazione ebbe la sua efficacia nel rispondere
all’incessante esigenza dei ceti dominanti U.S.A. di plasmare l’immaginario collettivo con sempre
nuovi prodotti stupefacenti, ma non fu certo paragonabile al successo ottenuto con Schindler’s List,
nonostante la collaborazione della critica, che offrì spesso una sponda all’ambiguità del suo patriottismo metonimico. Da noi Irene Bignardi non afferrò il concetto e giudicò il film un tentativo «nobile
[…], generoso e spettacolare» di raccontare «un episodio fondamentale della storia dell’abolizionismo» e di denunciare «l’ipocrisia della legge bianca» (la Repubblica, 13 marzo 1998. Va detto che il 4
settembre successivo per Bignardi il film era già diventato «generoso ma retorico»). Spielberg completò il compito edificante e assolutorio l’anno seguente, con Saving Private Ryan, trasferendo sul
«campo dell’onore» le sue mirate parabole patriottiche.
Al concetto di «zona grigia» Levi dedicherà un capitolo del suo ultimo, fondamentale lavoro, I sommersi e i salvati – pubblicato da Einaudi nel 1986, un anno prima della morte – che egli stesso definì «un
libro politico […], un libro morale» (Risa Sodi, Un’intervista con Primo Levi [1987], in Primo Levi.
Conversazioni e interviste 1963-1987, Einaudi, Torino 1997, p. 237).
Bauman, op. cit., p. 212.
Ivi, p. 173.
Ivi, p. 268.
Gozzini, op. cit., p. 56.
Bauman, op. cit., p. 268.
Weil, op. cit., p. 39.
49
Renzo Vespignani
TRA DUE GUERRE
Schede critiche
di Gaspare De Caro e Roberto De Caro
Il sangue è il vino dei popoli forti
L’insistenza di Vespignani sul ciclo Tra due guerre – a brevissima distanza la mostra bolognese del
1975 e le due edizioni torinesi dell’omonimo volume – testimonia l’importanza che il pittore
dovette attribuire alla riflessione sul passato della nazione, su caratteri e costumi di vertici e di
masse nel momento di un nuovo grande Ritorno all’Ordine dopo le convulsioni degli anni Sessanta. Per un artista della sua generazione e delle sue esperienze ed esigenze politiche, osservatore attento e amaro – come testimonia assiduamente la sua opera grafica – di un trentennio di
trasformazioni sociali che non cambiano la natura ultima delle cose e di adeguamenti istituzionali che riflettono e alimentano la miseria delle coscienze, la riflessione sul fascismo non può
essere una questione di archiviazione storiografica. Infatti, se rende omaggio agli storici cui
apparentemente è in debito di categorie interpretative – il fascismo come fenomeno piccolo-borghese, di dannunzianesimo diffuso –, perché chiamerebbe la pittura a sconvolgere «quel tanto di
pacifico (o pacificato) che è nella comunicazione
critica»1 se non per testimoniare la persistenza del
passato nei drammi del presente? perché parlerebbe di «guasto irreparabile» se non per includere
nel bilancio un presente senza speranza? Del resto
I. Gabriele D’Annunzio, 1973
II. Vittoriale, 1973
Vespignani eccede esplicitamente e giustamente di cronologia e di senso l’angustia di quelle
categorie, più icastiche che storiograficamente esaustive. A ragione vede nello scorcio del
XIX secolo i prodromi dei «fatidici anni venti», nel classicismo mortuario di Sacconi l’anticipazione degli stilemi di Mussolini. Aveva un bel protestare don Benedetto che la sua generazione era stata carducciana e non dannunziana: se si considera quanto il terreno di cultura
«battericamente inerte» degli italiani ancora da fare si abbeverasse alla linfa massonica e razzista, al tronfio antiquariato vaticinante del professore di Bologna, e aggiungiamoci pure il
torbido sobbollire della «grande proletaria» nella cucina romagnola di Mariù, se ne ammet-
53
terà la confluenza nell’epitome dannunziana suggerita da Vespignani,
che pertanto dopo tutto risulta
anche buona storiografia.
Analogamente per quanto riguarda la
dilatazione che Vespignani impone
alle nozioni di «struttura caratteriale»
e di «cultura delle masse piccolo-borghesi», largamente travalicante l’accezione sociologica. Di questa cultura
che è «un glutine di stati d’animo puerili, di umiliazioni, di solitudini antiche» beneficiano certamente «i ceti
acculturati da un paio di generazioni,
la minuta burocrazia degli scrivani e
degli uscieri comunali, dai ruoli
ancora informi»; ma se la struttura
caratteriale che ne deriva «stinge ben
al di là dei ceti medi, e filtra nel sottosuolo delle masse popolari», non se
ne separano affatto i piani alti della
società. Le madri dell’Intervento di
Vespignani non sono piccolo-borghesi, sono dame appena uscite da
alcove dannunziane e nessuna moglie
di scrivano comunale potrebbe dotare
III. Le madri dell’Intervento, 1972
il suo bimbo di una così lussuosa
divisa da piccolo bersagliere: la mitologia guerriera, le facinorose allocuzioni interventiste di quel «radioso maggio» e di quelli a
venire, la «rettorica che sodomizza l’ignoranza» sono dotazione comune, in alto e in basso. Le
spese però non saranno ripartite con altrettanta equità. Ritorno alla terra, Le reliquie dell’Isonzo,
Caporetto, Piave dicono come e a chi tocchino comunque i premi dell’epopea.
Vespignani evoca nell’immagine di Giovanni Papini, dal quale deriva il titolo della sezione, il
ruolo di una cultura che, affiancata didatticamente alla putredine morale del dannunzianesimo,
«misura “la vita in termini di letteratura, la letteratura in termini di azione”» e «pavimenta la
strada alla mistica del condottiero». A lastricare quella strada tuttavia lavorò parecchia manovalanza, non solo la rigatteria vitalistica di Papini con ovvio destino mistico: la completezza del
quadro sembra legittimare una chiosa. Non pare trascurabile infatti, per equità e perché il tema
ha qualche diritto di attualità, il contributo di quello che amò chiamarsi «interventismo democratico»: Gaetano Salvemini, tanto per fare un nome, ma andrebbero altrettanto bene Leonida
Bissolati o i preti modernisti alla Romolo Murri o i repubblicani di Romagna o Piero Jahier, per
non trascurare i poeti. Senza contare le democratiche oscenità belliciste che Salvemini scrive
durante la battaglia interventista e durante la guerra, che non andrebbero comunque dimenticate, non ha nulla da invidiare alla tipologia cui Vespignani fa riferimento l’identikit dei capi di
un nuovo «partito socialista rivoluzionario» che Salvemini disegna nel 1914: «uomini di animo
semplice ma potente, unilaterali e convinti, che sappiano odiare ed amare barbaramente, che
abbiano una visione apocalittica della vita». E, tanto per fare anche lui un nome, dice Benito
Mussolini, l’«uomo necessario».2 Con democratici così, che bisogno c’era di reazionari?
1
2
Le citazioni di Renzo Vespignani dal suo articolo Tra due guerre, in questo stesso volume.
Gaetano Salvemini, Rinascita socialista, in L’Unità, 1° maggio 1914, ora in Id., Movimento socialista e
questione meridionale, a cura di Gaetano Arfè, in Opere, IV, II, Feltrinelli, Milano 1968, p. 553.
54
IV. Le reliquie dell’Isonzo, 1973
VI. Piave, 1974
V. Caporetto, 1974
VII. L’Altare della Patria, 1972
55
…Morte, mutilazioni, malattie, stragi, distruzioni… gli orrori della guerra sono altresì una cosa di una
suprema bellezza morale: sono l’animo umano che li supera.
Enrico Corradini
Nessuna più grande liberazione oso sognare per ora alla mia patria, e nessuna più grande conquista le
auguro che quella della coscienza del male parlamentare.
Giuseppe Prezzolini
Il sangue è il vino dei popoli forti; il sangue è l’oblio di cui hanno bisogno le ruote di questa macchina
che vola dal passato al futuro.
Giovanni Papini
O beati quelli che più hanno, perché più potranno dare, più potranno ardere.
Beati quelli che hanno vent’anni, una mente casta, un corpo temprato, una madre animosa.
Beati quelli che disdegnarono gli amori sterili per essere vergini a questo primo e ultimo amore.
Beati i puri di cuore, beati i ritornanti con le vittorie, perché vedranno il viso novello di Roma, la fronte
ricoronata di Dante, la bellezza trionfale d’Italia.
Gabriele D’Annunzio
Io vi immagino, miei valorosi, forti e impetuosi come il torrente che, rotto gli argini, straripa travolgendo tutto quello che trova sotto le sue mani.
il Duca d’Aosta, comandante della III Armata
D’ora innanzi il vostro grido sarà l’alalà, col quale Achille aizzava i cavalli alla battaglia.
Il barbarico hip! sarà sostituito dalla dolce e sonora esclamazione latina eja! A Pola quando tutte le
bombe saranno lanciate, ogni equipaggio, prima di riprendere la via del ritorno, lancerà il grido tra i
fuochi di sbarramento.
Gabriele D’Annunzio
(ai suoi equipaggi prima del bombardamento di Pola)
L’avanzata è quella cosa
che si fa muovendo il passo:
come è bello dietro un sasso
veder gli altri ad avanzar.
canzonetta anonima
56
4. La reliquia di Serajevo
8. I volti della patria
1. Gabriele D’Annunzio
2. Il salotto del poeta
5. Allegoria interventista
9. Museo militare
6. Palazzo di giustizia
3. Papini
7. Ritorno alla terra
57
10. Italia
1. Gabriele D’Annunzio
1975, olio su cartone, cm 102 x 146
59
2. Il salotto del poeta
1975, olio, cm 213 x 153
3. Papini
1973, olio su cartone, cm 97 x 143
60
61
4. La reliquia di Serajevo
1973, tecnica mista, cm 100 x 140
63
5. Allegoria interventista
1975, olio su tela, cm 97 x 195
65
6. Palazzo di giustizia
1975, olio su tela, cm 132 x 93
66
7. Ritorno alla terra
1974, olio, cm 162 x 97
67
8. I volti della patria
1975, olio su tela, cm 140 x 162
9. Museo militare
1975, olio, cm 100 x 140
68
69
10. Italia
1975, olio su cartone, cm 99 x 143
71